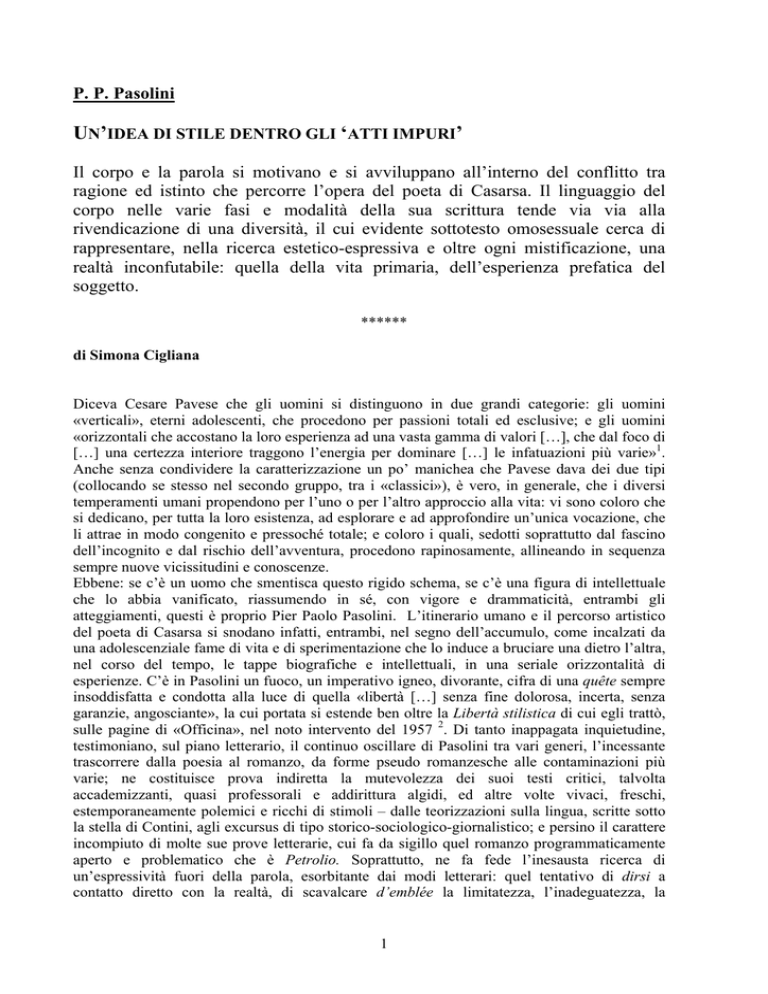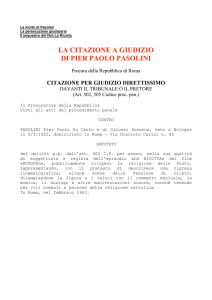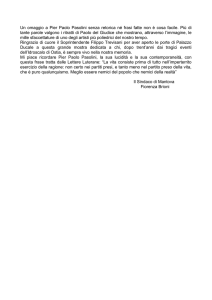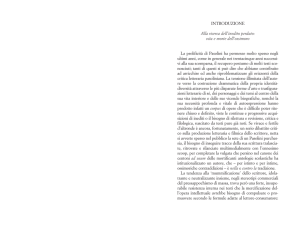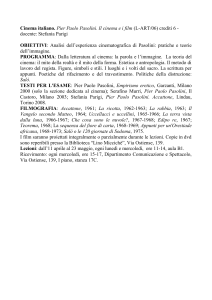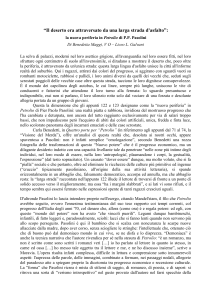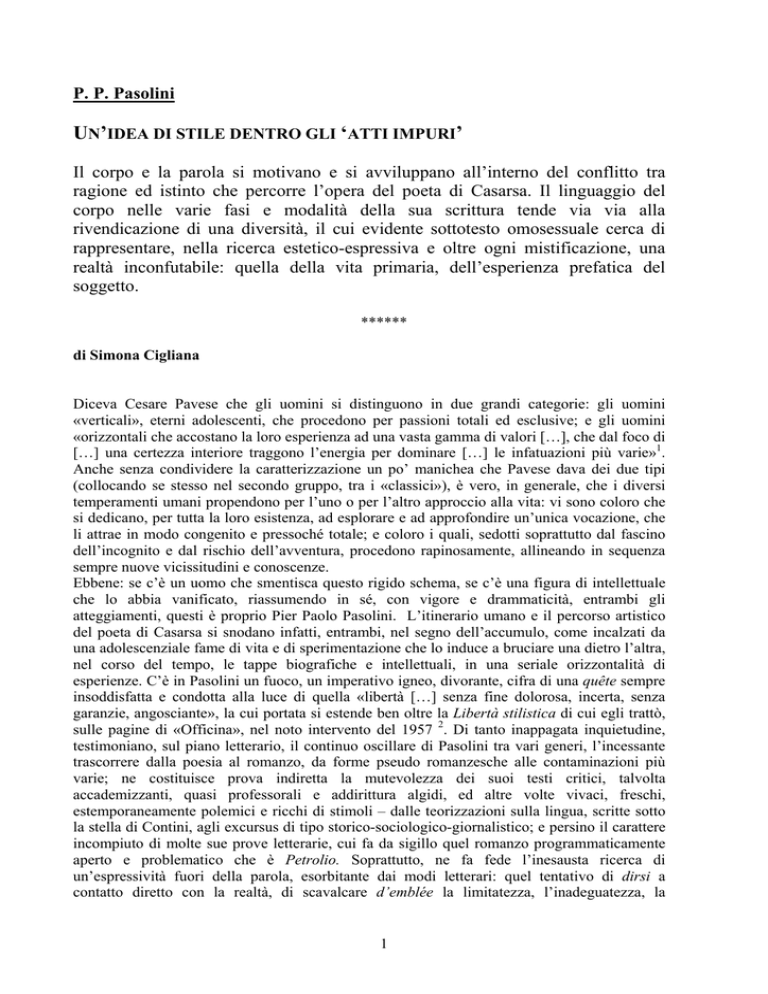
P. P. Pasolini
UN’IDEA DI STILE DENTRO GLI ‘ATTI IMPURI’
Il corpo e la parola si motivano e si avviluppano all’interno del conflitto tra
ragione ed istinto che percorre l’opera del poeta di Casarsa. Il linguaggio del
corpo nelle varie fasi e modalità della sua scrittura tende via via alla
rivendicazione di una diversità, il cui evidente sottotesto omosessuale cerca di
rappresentare, nella ricerca estetico-espressiva e oltre ogni mistificazione, una
realtà inconfutabile: quella della vita primaria, dell’esperienza prefatica del
soggetto.
******
di Simona Cigliana
Diceva Cesare Pavese che gli uomini si distinguono in due grandi categorie: gli uomini
«verticali», eterni adolescenti, che procedono per passioni totali ed esclusive; e gli uomini
«orizzontali che accostano la loro esperienza ad una vasta gamma di valori […], che dal foco di
[…] una certezza interiore traggono l’energia per dominare […] le infatuazioni più varie»1.
Anche senza condividere la caratterizzazione un po’ manichea che Pavese dava dei due tipi
(collocando se stesso nel secondo gruppo, tra i «classici»), è vero, in generale, che i diversi
temperamenti umani propendono per l’uno o per l’altro approccio alla vita: vi sono coloro che
si dedicano, per tutta la loro esistenza, ad esplorare e ad approfondire un’unica vocazione, che
li attrae in modo congenito e pressoché totale; e coloro i quali, sedotti soprattutto dal fascino
dell’incognito e dal rischio dell’avventura, procedono rapinosamente, allineando in sequenza
sempre nuove vicissitudini e conoscenze.
Ebbene: se c’è un uomo che smentisca questo rigido schema, se c’è una figura di intellettuale
che lo abbia vanificato, riassumendo in sé, con vigore e drammaticità, entrambi gli
atteggiamenti, questi è proprio Pier Paolo Pasolini. L’itinerario umano e il percorso artistico
del poeta di Casarsa si snodano infatti, entrambi, nel segno dell’accumulo, come incalzati da
una adolescenziale fame di vita e di sperimentazione che lo induce a bruciare una dietro l’altra,
nel corso del tempo, le tappe biografiche e intellettuali, in una seriale orizzontalità di
esperienze. C’è in Pasolini un fuoco, un imperativo igneo, divorante, cifra di una quête sempre
insoddisfatta e condotta alla luce di quella «libertà […] senza fine dolorosa, incerta, senza
garanzie, angosciante», la cui portata si estende ben oltre la Libertà stilistica di cui egli trattò,
sulle pagine di «Officina», nel noto intervento del 1957 2. Di tanto inappagata inquietudine,
testimoniano, sul piano letterario, il continuo oscillare di Pasolini tra vari generi, l’incessante
trascorrere dalla poesia al romanzo, da forme pseudo romanzesche alle contaminazioni più
varie; ne costituisce prova indiretta la mutevolezza dei suoi testi critici, talvolta
accademizzanti, quasi professorali e addirittura algidi, ed altre volte vivaci, freschi,
estemporaneamente polemici e ricchi di stimoli – dalle teorizzazioni sulla lingua, scritte sotto
la stella di Contini, agli excursus di tipo storico-sociologico-giornalistico; e persino il carattere
incompiuto di molte sue prove letterarie, cui fa da sigillo quel romanzo programmaticamente
aperto e problematico che è Petrolio. Soprattutto, ne fa fede l’inesausta ricerca di
un’espressività fuori della parola, esorbitante dai modi letterari: quel tentativo di dirsi a
contatto diretto con la realtà, di scavalcare d’emblée la limitatezza, l’inadeguatezza, la
1
corruzione delle parole, che porterà Pasolini a percorrere le strade del teatro, del cinema e
perfino, occasionalmente, del disegno e delle arti visive.
Questa inesausta sperimentazione di sempre nuovi mezzi trova tuttavia senso e continuità in
virtù di alcune tensioni costanti, che conferiscono alla traiettoria pasoliniana profondità e
baricentro, e una dimensione di singolare “perpendicolarità”. Tra le più evidenti di esse, vi è la
fame di giustizia, che si palesa in un impegno politico insofferente ad ogni ortodossia di
partito; una profana religiosità, che si nutre del senso, profondo e panico, della sacralità della
vita e dell’unicità dell’esperienza; una solidarietà nei confronti dei diseredati che trae
ambiguamente alimento sia dall’ideologia sia dal sentire e che, muovendo dalla «luce» di
persuasioni razionali, si dirama fin sul piano delle emozioni e degli istinti: «nel cuore –
appunto –, e nelle buie viscere»3.
Prima di tutto, prepotente, c’è però un bisogno di autenticità, un desiderio spasmodico di
conquistare, sul duplice fronte della vita e della militanza intellettuale, una dimensione di verità
integrale, che annichilisca fino il sospetto di ogni finzione4: un bisogno atavico, fanciullesco, al
tempo stesso religioso e narcisistico, il cui adempimento Pasolini sente continuamente
minacciato e corroso dall’inautenticità che avanza su tutti i fronti. In primo luogo, acutamente,
sul fronte della letteratura, che, costretta com’è a servirsi di parole, assomma in sé diversi
livelli di artificio: quello della lingua – che è portato di classe e stratificazione di distorsioni;
quello della lingua letteraria, sistema di finzioni, codice astratto e “mandarino” per eccellenza;
e quello generato, sul versante della produzione creativa come su quello della sua fruizione,
dall’incipiente trionfo del consumismo, che riduce e vanifica, in una prospettiva di «tolleranza
repressiva»5, il valore ontologicamente scandaloso di ogni verità, intima e collettiva. Di fatto,
Pasolini aveva compreso, con molto anticipo sui contemporanei, quanto sia impossibile, oggi,
consistere nell’autenticità, persino e soprattutto in ambito poetico6. C'è in lui – già implicito
nelle prime poesie in friulano –, non solo il rifiuto della convenzionalità della lingua, ma
soprattutto, più volte in seguito ribadito, il rigetto verso quella convenzionalità globale – frutto
della mercificazione che coinvolge ogni cosa, anche i prodotti e le mode letterarie –, di cui, fin
dagli anni ’50, egli ebbe più che un presentimento, destinato a precisarsi col tempo fino a
raggiungere la consapevolezza che ogni tentativo di espressione, nell’orizzonte della
modernità, finisce con l’essere ridotto a merce, e tanto più quanto più miri ad esprimere una
sua ingenua verità.
La ricerca letteraria di Pasolini si snoda dunque tutta, sin dagli esordi poetici in friulano, come
costretta nella trappola di questo contrasto, che, con il passare degli anni, diventerà sempre più
stringente, fino a configurarsi come lacerazione: in lui permane, fortissima, da una parte, la
coscienza della propria vocazione letteraria; dall’altra, matura una sorta di ripudio per la
letteratura. Egli sa che sono finiti i tempi del letterato di professione e il sistema letterario è
ormai un’appendice funzionale della società dei consumi. Di qui, il senso di perdita o di
fallimento che si legge in certe parti della sua opera, il letterario forzare la letteratura verso
modalità di comunicazione ultra letterarie; di qui, anche, le intemperanze e i furori pedagogici,
polemici e declamatori di tanto Pasolini: del poeta quanto del pubblico teorizzatore del valore
maieutico della contraddizione. A questa aporia, resa più stringente dalla convinzione,
elaborata lucidamente attorno alla metà degli anni ’60, in corrispondenza con la “svolta” verso
il teatro, che la verità – qualsiasi verità – si possa più esperire che concettualizzare, far balenare
come insight più che spiegare a parole- Pasolini rispose con la propria biografia, con un furore
di compromissione che ha il valore, prima che di confessione pubblica, di testimonianza7. Più
volte, a ragione, la critica ha sottolineato che l’opera di Pasolini è interamente autobiografica:
sviluppa e affabula idee, polemiche, idiosincrasie, odi ed amori, la volontà di essere artista e di
affermare se stesso come essere nella storia. Un po’ meno di frequente, ci si è soffermati
invece sul fatto che in essa, soprattutto, Pasolini è teso a confessare la propria omosessualità, a
inalberarla come una bandiera, parla della propria urgenza di esprimerla 8. Ebbene, il valore di
una tanto urgente necessità di confessione è da ravvisarsi soprattutto nel fatto che la
2
rivendicazione della diversità rappresenta un modo per manifestare, al di là delle mistificazioni
che la sovrastruttura di parole produce, una realtà inconfutabile: quella della vita,
dell’esperienza prefatica che si patisce nel corpo.
Alla luce della pervasiva matrice autobiografica e della vocazione sperimentale della sua
produzione, dunque è invalsa spesso la tendenza di leggere tutta l’opera di Pasolini come un
unicum in cui si declinano, in varie forme, le sfaccettature di alcune ossessioni dominanti; e
perfino di guardare alla parabola pasoliniana come una sola, vasta azione di militanza
intellettuale, che si snoda simile ad un duplice ciclo affrescato: da una parte la vita che scorre
senza riposo, attraverso le polemiche, i processi, le provocatorie prese di posizione, l’impegno
civile e sperimentale, verso una conclusione tragica, più volte prefigurata; dall’altra, l’opera
che prolifera senza sosta, allineando tentativi ed esperimenti e conferendo rilievo figurale ad un
flusso di idee e di affetti radicati nella biografia.
È un’immagine suggestiva, che ha il merito di essere in sintonia con una specifica modalità
dell’immaginario pasoliniano, principalmente per quel che riguarda il cinema. Tuttavia,
occorre ricordare che, se la compromissione biografica risponde certamente, in Pasolini, ad
alcune pulsioni di natura personale (alle quali non sarà stato estraneo il desiderio di esorcizzare
il peso di una condizione ancora sentita come colpa), d’altra parte, in rapporto con l’ideologia
e con il linguaggio, sullo sfondo della realtà sociale e culturale di quegli anni e alla luce di
quanto fin qui esposto, essa equivale anche al recupero di una verità assoluta e “naturale”,
anteriore al pensiero e alle forme: verità legata al corpo ed ai suoi bisogni, e perciò antiintellettuale e provocatoria, in senso umano e quasi evangelico; verità irriducibile in parole,
consustanziale al nucleo oscuro e profondo della psiche: dunque irrevocabile e ineludibile. Da
questo punto di vista, l’ostensione della omosessualità finisce col rispondere, nell’intenzione
pasoliniana, oltre che a motivazioni di ordine psicologico e anche ideologico, civile e politico,
ad una istanza etica, che lo scrittore, fino alle ultime prove, cercherà di rendere visibile e attiva
nelle scelte formali del suo operare artistico.
Nell’ottica engagé di Pasolini, infatti, l’arte non può essere che militante e pedagogica9: non
può che dire cose riguardanti la realtà effettuale del mondo e della vita per provocare nel
pubblico un mutamento di prospettiva. L’arte, che non può mentire sui contenuti, dovrà però
saper essere veritiera anche sul piano dello stile: dovrà trovare forme e parole capaci di farsi
latrici di una sostanza di verità. «La posizione [di Pasolini] – come fece notare Dante Della
Terza già molti anni or sono – è press’a poco la seguente: in un momento letterario di
coesistenza di stili, uno scrittore che abbia una posizione militante e che voglia tradurre la
realtà del suo mondo non in documento, ma in prospettiva, non deve rendere conto del suo
modo di sentire la realtà, che è presupposto, ma deve dosare la carica di energia stilistica
sufficiente per trasformare la realtà in movimento e porla così in prospettiva».10 Dalla ricerca
di modi capaci di inverare questa istanza di natura etico-politica, procede, precocemente, la
rivendicazione pasoliniana di una «libertà stilistica» fuori dai canoni avanguardistici e persino
novecenteschi, nella tensione verso modalità espressive che riflettano l’ «amore fisico e
sentimentale per i fenomeni del mondo, e amore intellettuale per il loro spirito, la storia»11:
come l’intervento del ’57, su «Officina» argomenta, in ambito teorico, per quel che riguarda la
ricerca letteraria.
Con gli anni, il tentativo di redimere l’arte dal suo portato di classe e di farla accedere fin nella
sua essenza – lo stile – ad una dimensione testimoniale di verità si tradurrà nel ricorso sempre
più insistito a mezzi espressivi capaci, come dicevamo, di oltrepassare la convenzionalità e la
limitatezza delle parole nella rappresentazione figurale delle lacerazioni emotive e degli orrori
che si patiscono nella carne e nello spirito, in una lettura che, alla ubris divina, sostituisce la
ubris della storia. Gli studi danteschi e la meditazione su Auerbach12 non furono certo estranei
a questa scelta. Essa, una volta chiaritasi all’autore nelle sue motivazioni profonde, lo condurrà
a confrontarsi con i linguaggi del teatro e del cinema, in ambiti, cioè, che sembrano offrirgli la
concreta possibilità di conciliare verità e forma, passione e ideologia, astrazione e vita in modi
3
stilizzati e complessi, affidando il suo messaggio alla creaturale fisicità degli interpreti, al loro
inerme essere “corpo”.
I segni inequivocabili del conflittuale rapporto di Pasolini con la lingua, il rammarico per la sua
impurità, per la sua impossibilità di testimoniare l’adamitica scoperta di sentimenti
ingenuamente sofferti, emergono sin dagli esordi poetici in lingua friulana, che, già sotto una
costellazione di valori assoluti, muovono alla ricerca di un linguaggio puro. È una lingua
edenica, il friulano delle Poesie a Casarsa? In parte. È comunque una lingua che, mentre si fa
linguaggio della confessione intima, risuona come riverbero di un parlare lontanissimo,
perduto, quello appunto di una aurorale universalità di sentire, ormai scomparsa, che l’epigrafe
in provenzale apposta nel ’54 a La meglio gioventù, nell’entusiasmo suscitato dalla prospettiva
di pubblicazione nella «Biblioteca di Paragone» di Sansoni, non fa che evidenziare. L’illusione
di una perfetta fusione tra poesia e vita che il friulano, in quanto lingua romanza e “originaria”
evoca, colloca questa poesia autobiografica, sin dal primo verso, in un mondo letterariamente
opposto ad ogni popolaresca immediatezza: l’uso di quella lingua friulana, miscidata delle
parole di tanti luoghi, continuamente reinventata e riscoperta, lungi dal riattualizzare la vita di
un popolo, di avvicinarlo all’autore, enfatizza il pathos di una distanza, la condizione di
soggetto sradicato e senza più dimora dell’io parlante, che la evoca per la sua natura di lingua
sacra e materna, della memoria e della perdita.13
Inoltre, la poesia di Pasolini non celebra, come quella di Jaufré Rudel, l’ «amor de loinh» 14.
Ciò che offre a Rudel materia di canto e di esaltazione – l‘inattingibilità dell’oggetto d’amore –
è per Pasolini occasione di sofferenza, e il sentimento amoroso, che nell’immaginario
trobadorico concede spesso il primato alla contemplazione, è al contrario in lui sovente arso da
accensioni di sensualità inappagata. Lo stereotipo è dunque rovesciato e l’aura letteraria stride
con l’urgenza di un desiderio che il friulano stenta a ridire: quella lingua non può restituire
verità alle figure dei giovinetti e alle accensioni del poeta se non respingendole in un passato
morto, verso una idealizzazione mitica e sepolcrale nella quale si trova implicato anche il sé
«donzel», l’io adolescente del poeta ormai cresciuto.
Sappiamo anche che negli anni Quaranta, mentre attende a queste poesie, Pasolini lavora al
progetto di due romanzi, che saranno poi recuperati, come le Poesie a Casarsa, a metà degli
anni Cinquanta, e che rimarranno inediti fino all’82: Atti impuri e Amado mio.15 Anch’essi, in
parallelo alla ricerca poetica, rimandano ad un programma di scrittura che già fa perno
sull’autobiografia e che trova il suo maggiore scoglio nell’impossibilità di addivenire ad una
soddisfacente soluzione stilistica: lo scrittore, il cui fine è quello di sbozzare una sorta di
autoritratto che renda conto del suo percorso di crescita e di individuazione nonché del
manifestarsi e del maturare della vocazione poetica – del suo ingresso nel mondo reale e,
insieme, del processo attraverso il quale è cresciuto come soggetto di parola –, si confronta per
la prima volta con il proprio mondo poetico, con le proprie ambizioni e con i propri mezzi e
rimane come impigliato nel nodo cruciale che, sul suo orizzonte, sin da ora stringe in maniera
inestricabile biografia, verità e ricerca stilistica.
Le principali difficoltà incontrate dal giovane Pasolini nei due romanzi – scritti in lingua, come
la Prefazione stesa contemporaneamente – riguardano infatti proprio l’omosessualità, «verità»
ontologica alla cui enunciazione egli non può sfuggire, pena il fallimento dell’ancora
adolescenziale progetto di autoindividuazione. In particolare in Atti impuri, l’immaturità dei
mezzi espressivi, il passaggio continuo tra la prima e la terza persona, con la tendenza ad
utilizzare la terza persona per la parte centrale delle memorie riservando la prima persona al
diario propriamente detto, forniscono indizi preziosi del laborioso e, da un certo punto di vista,
fallimentare processo di sperimentazione formale cui Pasolini sottopose il suo brogliaccio,
oscillando tra intenzione diaristica e volontà di redenzione romanzesca, tentato dall’esemplarità
della confessione e, al tempo stesso, impossibilitato a renderla se non in forma mediata, mentre
lo sviluppo della narrazione è a sua volta intralciato dall’invasività dell’istanza personale. In
4
Atti impuri si condensa insomma tutta una tormentata dialettica tra reale e immaginario, che si
struttura nel contrasto tra autenticità della confessione e verità della finzione: da una parte, la
diagnosi della propria omosessualità; dall'altra, il processo di mitizzazione di cui essa vuole
essere oggetto.
Nel secondo romanzo, Amado mio, Pasolini sceglierà la terza persona, puntando decisamente
verso il romanzo. Nell’assenza di ogni residuo di forma-diario, il progetto autobiografico
diviene più coerente, poiché l’esperienza dell’autore-protagonista si propone chiaramente come
vicenda esemplare e si proietta, nello stesso tempo, sullo sfondo dell’affresco sociale e
geografico del Friuli. Ma anche questa volta si ripresenta l'opposizione tra biografia e sua
trasfigurazione narrativa: essa trapela non più sul piano grammaticale, nella fluttuazione del
pronome che individua il soggetto della narrazione, come in Atti impuri, bensì attraverso le
allegorie e le citazioni erudite e letterarie che hanno il fine di proiettare la biografia del
protagonista alter ego dell’autore su uno scenario aulico. L’esperienza si distanzia e sublima
nella citazione, cerca legittimità nell'oggettivazione mitica e dignità in una maschera esemplata
sul calco preesistente di personaggi appartenenti ad altri romanzi e poemi. La verità è costretta
a celarsi sotto due livelli di finzione: la maschera mitico-letteraria e l’elaborazione romanzesca
16
, mentre il nucleo più imbarazzante e scandaloso dell’autobiografia finisce per risultare
edulcorato e disinnescato del suo potenziale sovversivo.
Profondamente scontento del risultato, proprio a causa delle soluzioni ibride alle quali si è
sentito costretto e che non corrispondono ad alcuna delle ambizioni iniziali, Pasolini, nella
Prefazione di cui sopra si diceva, affronta, dissimulandolo nel topos tradizionale della
«sincerità e della «ipocrisia» dell’autore, il problema cruciale con il quale si è trovato a fare i
conti a proposito della scabrosa tematica omosessuale che lo riguarda da vicino e che è materia
delle due opere. Egli sottolinea, parlando del protagonista di Amado mio, che, quando si tratta
di compiere un atto o di pronunciare una parola estrema, noi stabiliamo dei limiti molto diversi
nella vita reale e nella finzione narrativa:
Quanti moralisti saranno pronti ad accusarmi, e avranno ragione, perché, se Desiderio non sono
io, se non mi somiglia, tuttavia l’ho pensato e l’ho fatto vivere nel momento della mia vita in
cui più mi sono approssimato a lui. Però Desiderio finisce col racconto; e io continuo […] per
la china per cui Desiderio era sceso tanto in fondo. Ma la vita, tanto più pallida di un racconto, è
anche tanto più colorita, c’è sempre un'estrema prudenza che trattiene sull’orlo delle avventure
estreme; non so se nei confronti di Desiderio io posso vantarmi o no di avere posseduto una
simile prudenza. 17
Il dilemma del narratore consiste insomma in un problema di «prudenza»: deve censurarsi ed
essere reticente oppure è bene che partecipi all'imprudenza del suo personaggio e si arrischi a
“dire tutto” o a dire comunque “troppo”? E il fallimento è causato dalla eccessiva reticenza o
da un eccesso di trasparenza dei personaggi? Pasolini pensa che, per riscattare la materia, la
biografia debba proiettarsi e trasfigurarsi in una forma letterariamente compiuta, e che la verità,
per poter essere detta, debba sublimarsi nel linguaggio, diventare stile:
Non so se gli argomenti così scabrosi di questi due racconti siano sufficientemente necessari e
oggettivati; suppongo addirittura che qualcuno, se io dicessi il nome del peccato… forse non
leggerebbe nemmeno la prima pagine del libro [...]. Ora l’ “esperienza” e il “dio” che finiscono
e finiranno, prima o poi, per stremare Desiderio e Paolo, restano in ombra di fronte all’evidenza
del normale. La luce dello scandalo è sempre troppo forte 18.
Il problema, appunto, è, prima di tutto, stilistico: dire tutto implicherebbe uno scivolamento
verso la confessione, uno slancio non stilizzato verso l'esperienza reale e il narratore
rischierebbe di tradire il suo progetto artistico per eccesso di verità. D’altra parte, il filtro
narrativo rischia di rendere artificiosa e inautentica la trasfigurazione letteraria delle vicende
5
biografiche. A dare carattere più drammatico all’anfibologia, sta il fatto che l’autore non può –
né vuole –, prescindere dalla propria esperienza di vita, sostanza di verità e materia di
ispirazione -, e che dunque la soluzione estetica, qualsiasi essa sia, non può eludere questo
problema, che si configura come una vera e propria impasse: dire l’indicibile senza scadere
nella confessione, in un linguaggio esteticamente risolto che non tradisca la verità.
Colpisce come, sin da queste prime prove, il problema centrale della ricerca pasoliniana si
ponga in termini tanto chiari, sostanziandosi nel nodo che stringe esperienza biografica e
biografia intellettuale, vitalismo e ricerca letteraria, e che, di qui a breve, annetterà anche
l’aspetto della militanza civile. Colpisce anche come già, in questi testi, si prefigurino soluzioni
poi adottate in anni a venire. Di fatto, il solo modo per evitare i pericoli della confessione e per
ritrovare, al massimo della stilizzazione, l’esemplarità dell'autobiografia, sarebbe quello di far
luogo all'irruzione del reale nello spazio della rappresentazione non soltanto a livello
dell'enunciato ma anche a livello dell'enunciazione. E così, proprio in Atti impuri, la diversità
del protagonista diviene palese in occasione della rappresentazione di una commedia da lui
stesso composta, una «favola drammatica» intitolata I fanciulli e gli elfi, nella quale il
«segreto», dissimulato sotto forma allegorica, emerge oltre le parole. È come se il teatro si
prefigurasse fin da questi anni come luogo in cui l’indicibile può essere rivelato rappresentando
la sostanza della verità senza scadere nella banalità di una confessione.
Cercando di evadere dalla strettoia, nel primo periodo romano, nei “cartoni” che sono
all’origine della raccolta Alì dagli occhi azzurri, Pasolini addotterà un tono insolentemente
ironico, nel quale traspare l’intenzione di liquidare in maniera netta l’io autobiografico e quella
specie di congruenza che ancora esisteva in Atti impuri tra l’autore, il narratore e il
personaggio. Avviatosi poi decisamente verso l’obbiettivazione narrativa, nei romanzi di
borgata della metà degli anni ’50, Ragazzi di vita e Una vita violenta, egli tornerà, come nelle
poesie friulane, ad affidare al linguaggio il compito di realizzare l’alchimia tra autobiografia ed
invenzione. Qui, la mimesi linguistica, con la rude risonanza dalla calata romanesca, pur
facendosi garante dell’ingenuità e della verosimiglianza dei personaggi, mira a distanziare,
riflettendolo in uno specchio famigliare e straniante, il bruciante portato dell'esperienza
personale. E tuttavia l’istanza biografica insidia ancora l’equilibrio stilistico della narrazione,
manifestandosi in alcuni episodici cedimenti sentimentali: intrusioni di verità che
compromettono l’impianto neorealista dell’esperimento.
Nel frattempo, in concomitanza con la pubblicazione delle Ceneri di Gramsci, di cui è stato
evidenziato l’aspetto teatrale e «la quasi strenua … volontà di esibizione»19, si avvia anche
quella cruciale riflessione sullo stile le cui implicazioni superano di gran lunga l’ambito
letterario. Nell’intervento sulla Libertà stilistica, Pasolini, interrogandosi intensamente sulla
propria storia di scrittore, parlava di sé come di un intellettuale appartenente a quella schiera di
«“sperimentatori” puri, predestinati, prossimi quindi, nella loro passione linguistica
precostituita nella psicologia», ad una operazione «sovvertitrice e anarchica»20. Tornava qui
(come nella Prefazione ai due romanzi giovanili e come tante volte ancora in futuro) il termine
«passione», ad indicare, questa volta con maggiore cognizione di causa, una istanza
dell’intelletto, fatale ed individuante, drammatica e purificatrice, astratta e al tempo stesso
radicata nel substrato biologico dell’esperienza. In questo saggio, Pasolini sfiorava i limiti
dell’utopia, delineando un’idea di «stile» come precipitato di passione politica, come veicolo di
una militanza talmente consapevole dei propri mezzi da riuscire a far della poesia – e del
linguaggio – il veicolo trasparente e fruibile di una scelta di verità umana ed ideologica, capace
di rendere conto anche della soggettività dell’autore e del suo sofferto incontro/scontro con la
realtà esterna. Al di là della inevitabile vaghezza programmatica delle conclusioni, al di là
dell’immediata ricaduta della riflessione sul rapporto con le istituzioni letterarie, al di là anche
delle polemiche che ne nacquero, l’intervento aveva tra gli indiscutibili meriti quello di
delineare l’orizzonte ideale di una volontà di impegno insofferente ad ogni schematismo
politico; di indicare alcuni possibili presupposti per una interpretazione della cultura e degli
6
scrittori attraverso il vaglio dei linguaggi e delle tecniche; di aver aperto, al di fuori delle
premesse “terroristiche” delle avanguardie e del neo avanguardismo, una via di giustificazione
teorica al superamento degli stretti confini letterari della letteratura e alla ricerca di nuovi
mezzi di espressività totale: una via valida, se non per tutti, almeno, senz’altro, pro domo sua.
Così, alle soglie degli anni Sessanta, mentre sta franando, in una omogeneizzazione generale,
l'impalcatura delle varie convenzioni linguistiche, sullo sfondo di orizzonte culturale che si
apre al dibattito sulla semiosi dei linguaggi, mentre comincia ad avvertire non soltanto la
convenzionalità della poesia ma anche della stessa lingua che viene adibita all'uso poetico,
Pasolini si accosta al cinema (è del ’57 la sceneggiatura de Le notti di Cabiria). Il passaggio,
che lo porta a trasporre sul piano dell’immagine situazioni e procedimenti che sono propri della
poesia, non meraviglia. Il laboratorio poetico e la ricerca linguistica, in Pasolini, erano stati da
sempre strettamente legati al trattamento preverbale dell’immagine: dalla prima stagione
poetica friulana alle Ceneri di Gramsci, fino ai contemporanei romanzi in dialetto romanesco,
versi e pagine di prosa orbitano attorno all’evocazione di luoghi e personaggi di un teatro
mentale che sostanzia l’ispirazione, e dal quale trapela, come una sorta di sottesa energia,
l’esigenza di dare corpo alle parole, di conferire evidenza figurale alla poesia stessa e di
compiere un balzo fuori del cursus dei linguaggi endoletterari.
L’apprendistato intellettuale stesso di Pasolini si era svolto, del resto, all’insegna di un duplice
insegnamento: gli esercizi di stile di Contini e lo studio del verso pascoliano erano andati quasi
di pari passo con le lezioni di Roberto Longhi, con un magistero volto a privilegiare, della
storia dell'arte, quei momenti in cui le figure, e in particolare la figurazione dei corpi,
conobbero il loro momento di gloria. Anche l’intensa stagione di scrittura drammaturgica e la
riflessione sul teatro si configurano dunque, a questa altezza, per effetto delle tensioni storiche
e psicologiche che abbiamo descritto, come conseguenza di una necessaria gravitazione verso
l'unico segno che non può mentire: il corpo. Sin da Accattone e Mamma Roma (’61), Pasolini
si era ritrovato a contemplare i corpi con uno sguardo sostanzialmente solidale con la visione,
tra ideale e laicamente religiosa, della pittura del Rinascimento. Già in quelle pellicole, si
aveva l’impressione che, nei riccioluti «pischelli» che popolavano l’universo anomico delle
borgate romane visitate da Pasolini, rivivessero i modelli di Masaccio e di Piero della
Francesca (basti ricordare la prospettiva alla Mantegna che presiede all’agonia del giovane
uomo sul letto di contenzione della prigione). Pasolini ama quei pittori e il loro ideale
filosofico, che concede al corpo e alla sua sensualità un assoluto protagonismo, ravvisandovi la
forma vivente di un principio intellettuale. L’apparizione dei corpi, con tutta la loro
conturbante bellezza, corrisponde, nell’ottica umanistica, all’epifania di qualche cosa di sacro,
che rimanda alla centralità dell’uomo, «all’amore fisico e spirituale» per il suo universo di
pensieri e di affetti, alla fisicità come all’inverarsi storico di un'idea. La pittura di Piero e di
Masaccio sembra voler rendere evidente l’incarnarsi dell’intelletto, che nel corpo si sostanzia
di materia e, ammantato di splendore e miseria, esce dal mondo iperuranio ed entra da
protagonista nella storia.
L’approdo alle arti della visione si prospetta dunque, in Pasolini, oltre che come occasione per
sperimentare nuovi mezzi espressivi, come portato di un nucleo critico di riflessione e
precipitato conseguente di una serie di contraddizioni che attraversano la sua esistenza e la sua
opera. Nel cinema e nel teatro, Pasolini riuscirà a dar letteralmente corpo alla propria tensione
creativa, rispondendo all’esigenza di articolare un’afasia, di cogliere, in re, nel suo più
drammatico nodo creaturale, la divisione della psiche e del linguaggio. Non a caso i sei drammi
e il Manifesto per un nuovo teatro (il quale, benché sia stato pubblicato dopo, assai
probabilmente è stato pensato prima o durante la stesura delle tragedie, in una contemporaneità
di scelte ideologiche, poetiche e stilistiche che è caratteristica di Pasolini) vengono concepiti
quasi simultaneamente, in un punto preciso del percorso pasoliniano: nel 196621, durante un
7
periodo di malattia, di impotenza incisa nel corpo. Pasolini racconterà poi di essere arrivato al
teatro nel ‘65, durante la convalescenza da una forma grave di ulcera, dopo aver letto Platone
22
. Proprio questa lettura lo avrebbe spinto a desiderare di scrivere – e di scriversi – attraverso
interposte persone, attraverso cioè personaggi che gli permetteranno nuovamente di comporre
versi, tragedie in versi, nel momento in cui, per sua stessa ammissione, da tempo aveva
esaurito «la sua prima fase poetica»23.
E proprio nel Manifesto per un nuovo teatro 24, Pasolini cercherà di sciogliere le sue
preoccupazioni riguardanti l’artificiosità della lingua italiana e dei linguaggi teatrali
prospettando una loro rivitalizzazione poetica. Secondo lui, il teatro di parola deve opporsi sia
al teatro della chiacchiera sia a quello puramente gestuale delle avanguardie – che ha
soprattutto il torto di mancare di stile e di ricadere in una forma di accademica provocazione –,
portando sulle scene il linguaggio della poesia: sarà dunque un teatro in versi, «teatro di
parola», misto di «poesia letta ad alta voce» e di «convenzione teatrale» ridotta al minimo25. Il
verso si rinsanguerà di nuova vita nell’oralità, che fu all’origine della sua nascita; la poesia
ritroverà il suo primitivo senso di liturgia collettiva nell’ambito rituale e socializzante del
teatro26; l’artificiosità della lingua e la convenzionalità della parola saranno riscattate dalla
presenza fisica degli attori, dalla testimonianza viva dei loro corpi.
In nome della socialità, Pasolini sceglierà anche di non scrivere più in terzine, come egli stesso
prospetta in quella bellissima poesia che s’intitola Una disperata vitalità, eminentemente
teatrale a cominciare dal suo spunto dialogico (intervistatrice-intervistato) e concepita come
una sceneggiatura («Come in un film di Godard»); poesia di poco precedente il 1966, anno in
cui l’autore ideò e cominciò a lavorare alle tragedie. La sicurezza che deriva dalla via appena
imboccata, consentirà anche un ritorno esplicito e provocatorio all’autobiografia, «al magma
tout-court» (cui si allude proprio in Una disperata vitalità27), in un’ansia di autoesposizione
che toccherà il suo vertice nell’ultima delle sei tragedie, la più incerta e sofferta28: Bestia da
stile, che sintetizza un pensiero dominante. Qui, poco dopo aver confermato la volontà di
essere poeta - e l’autenticità di questa vocazione, che coincide con la verità di essere al mondo
(«Voglio essere poeta e non distinguo / questa decisione dagli odori bui della cucina... / non lo
distinguo dal silenzio di granaio / delle camere sospese nelle notti in cui figli / restano soli con
tutto il cielo davanti…. Non lo distinguo dai tetti e dalle rondini» ecc.) – 29, Pasolini, con
movenza lacaniana, e quasi simulando un lapsus, ribadisce: «io non potrò dormire, / perché ho
il cuore ferito da un’idea // Un’idea di stile: uno stilo! / Piantata nel cuore / fin dove vibrano le
corde più segrete/della mia arpa ceca»30.
È la passione stilistica, dunque, che fa vibrare il poeta, ed essa è tale perché si radica «nel buio
delle viscere», dove risuonano le corde più profonde. Ma come farà il poeta, che trafitto
«sanguina dal cazzo e dal cuore», a ridire i propri segreti, con parole fatalmente contaminate,
senza tradire né se stesso né la verità né lo stile?
È l’Ombra di Sofocle che, in Affabulazione, ci spiega, parlando del suo «grande amore» che:
Nel teatro la parola vive di una doppia gloria
[ …]
Perché essa è, insieme, scritta e pronunciata.
È scritta come la parola di Omero,
ma insieme è pronunciata come le parole
che si scambiano tra loro due uomini al lavoro,
o una masnada di ragazzi
[…] come le parole insomma
che si dicono ogni giorno e che volano via con la vita:
le parole non scritte di cui non c’è niente di più bello.
8
In teatro, le parole e «i versi avranno una loro grazia / dovuta […] a una certa oggettività»:
infatti, sul palcoscenico «l’evocazione della parola» si completa «con la presenza […] in carne
ed ossa» dell’autore o di
qualcuno di analogo a lui, e, comunque, anch’esso
in carne e ossa – con le sue membra scoperte.
Devi vederlo, non solo sentirlo;
non solo leggere il testo che lo evoca,
ma avere lui stesso davanti agli occhi. Il teatro
non evoca la realtà dei corpi con le sole parole
ma anche con quei corpi stessi…
L’uomo si è accorto della realtà
solo quando l’ha rappresentata.
In teatro, come nella rappresentazione vivente per immagini stilizzate che il cinema consente –
si scioglie l’antinomia tra verità e linguaggio: i segni non sono codificati o simbolici – sono
icone viventi, come i segni stessi della realtà. L’utopia assoluta della coincidenza tra verità e
stile sembra più prossima al raggiungimento, perché il linguaggio coinvolge il corpo, lo chiama
a testimone e lo rende protagonista, esibendolo come ostaggio della verità.
Ancora più quando, in teatro o nel cinema, l’esemplarità del mito si offre a specchio dell’
autobiografia riscattandola, come avviene in Pilade31. Il mito offre la possibilità di retrocedere
fino a un orizzonte che sembra anteriore alle contaminazioni della cultura e della storia, proprio
perché ne è all’origine. E l’autore può permettersi di subirne l’attrazione, di abbandonarsi alle
sue ambigue e potenti suggestioni, proiettando in quel calco vuoto e risuonante i propri
conflitti, che pure sono resi operanti, attuali, “veri” dalla loro stessa rappresentazione: incarnati
e inverati dalla presenza degli attori. L’immagine cinematografica permetterà a Pasolini anche
di ritrovare nello splendore barbaro di regioni lontane nel tempo e nello spazio la bellezza
pietrosa e incontaminata dei paesaggi della sua infanzia e di trasfondere, nei gesti assoluti e
sacrificatori dei protagonisti di Edipo re, Teorema, Medea, la propria volontà di essere poeta, e,
come tale, di spendersi senza riserve. La discesa nel mito non promette alcuna catarsi, ma
sostiene e conforta nell’accettazione del proprio destino.
Nell’ultimo periodo, un senso di disgregazione sembra pervadere tutta l’opera di Pasolini, un
senso come di inutilità, un cupo senso di morte. Il primo dei film che avrebbero dovuto
comporre la trilogia della morte insiste particolarmente sui corpi e sembra voler risolvere
dantescamente in figura il conflitto tra verità e stile. Pasolini ora affida integralmente alle
immagini la soluzione del suo problema stilistico: la liturgia dell'orrore è portata ai massimi
livelli attraverso la massima economia delle parole e dei suoni. A dire il terrore è la
reificazione delle vittime; sono le bocche spalancate senza grido, il silenzio pietrificato delle
membra offese. Salò, è stato detto, è un film «nicciano»32: annichilisce le falsità e le
convenzioni della civiltà mostrando la loro consistenza di pura facciata; smaschera le finzioni
del potere additando la sua disumana sete di sangue e di abominio. E lo mostra attraverso lo
strazio dei corpi, con il lamento senza parole della creaturalità offesa, che può più
eloquentemente parlare e farsi latore, più delle parole, in maniera più sobria, più vera,
stilisticamente risolta in evidenza, di un messaggio che non può non coincidere con la verità.
Verità che non occorre dire quando si può mostrare: affidando alla intensità delle immagini
anche la rappresentazione del non detto che più intimamente e segretamente ci riguarda e ci fa
in certo qual modo tutti, nostro malgrado, corresponsabili dell’orrore.
9
1
C.Pavese, Il mestiere di vivere, Torino, Einaudi, 1952, p.205 (appunto del 2 maggio 1941).
La libertà stilistica, «Officina», 9-10, giugno 1957
3
Le ceneri di Gramsci ,IV, in Le ceneri di Gramsci; ora in Tutte le poesie, a c. di Walter Siti, Milano,
Mondadori, 2003, 2 voll.; I, p. 820.
4
Su questa caratteristica della psicologia pasoliniana, si soffermava, già nel lontano 1978, Gianni Scalia
in La mania della verità:dialogo con Pier Paolo Pasolini (Bologna, Cappelli).
5
Il volume di Herbert Marcuse, L’uomo ad una dimensione, pubblicato nel ’64, uscì in traduzione italiana
nel ’67.
6
Per un approfondimento di questo aspetto del pensiero pasoliniano, e per il carattere di incompiutezza
della sua opera, cfr. Antonio Tricomi, Sull’opera mancata di Pasolini. Un autore irrisolto e il suo
laboratorio, Roma, Carocci, 2005.
7
Sul valore al tempo stesso testimoniale e testamentario di tanta parte dell’opera pasoliniana, iscritta sotto
un cupo senso di morte che ne pervade le intime fibre, vedasi S.Agosti, La parola fuori di sé: Scritti su
Pasolini, MAnni, Lecce, 2004. Ma, ad esemplificazione dello stato d’animo che la nutre, valga per tutte,
tra le numerosissime, possibile, verifiche testuali, una poesia scritta nel ’48-’49, La crocifissione, in
L’usignolo della Chiesa cattolica, ora in Tutte le poesie, cit., I, p.467-68, in part. dal verso 20: «Bisogna
esporsi […] / la chiarezza del cuore è degna / di ogni scherno, di ogni peccato / di ogni più nuda passione
// […] Noi staremo offerti sulla croce / alla gogna […] / miti, ridicoli, tremando / d’intelletto e passione
nel gioco / del cuore arso dal suo fuoco / per testimoniare lo scandalo».
8
Su questa rimozione della critica, ha attirato recentemente l’attenzione Andrea Cortellessa, Grandezza e
miseria di un luterano corsaro, in «Micromega», 6, 2005, pp.140-62.
9
Cfr.Enzo Golino, Pasolini, il sogno di una cosa. Pedagogia, eros e letteratura, Milano, Bompiani, 1992;
2005 2.
10
Dante Della Terza, Il realismo mimetico di Pier Paolo Pasolini, in «Italica», vol.38, n.4 (dicembre
1961), p. 308.
11
Corsivo nostro.
12
Mimesis fu tradotto in Italia nel ’56, ma Pasolini lo lesse un po’ in ritardo, all’altezza della sua scoperta
delle potenzialità stilistiche del linguaggio teatrale e cinematografico.
13
La meglio gioventù, del resto, è proprio quella che muore. Ad un addio definitivo, di fatto, rinvia la
vecchia canzone militare della prima guerra mondiale (che fu poi ripresa nella seconda) da cui deriva
questo verso.
14
Dalla canzone Lanquan li jorn son lonc en mai.
15
Cfr. Nota e notizia sui testi, in Pasolini, Tutte le poesie, cit. pp.1459-60; C.D’Angeli, Nota ad Amado
mio, Milano, Garzanti, 1982, p. 195 sgg.
16
Scrive l’autore nella già citata Prefazione: ««Ho rischiato molto nello scrivere Atti impuri e Amado
mio. Non so se gli argomenti così scabrosi di questi due racconti siano sufficientemente necessari e
oggettivati. […] le stesse fonti del libro, da De Laclos a Peyrefitte, da Gide a Mann, dicono come nel
taglio del racconto, tra leggendario e letterario, abbia scelto un’intonazione proprio cattiva». (Op. cit.,
pp.195-97).
17
Op. cit., p. 197.
18
Op.cit., p. 195.
19
Giulio Ferroni, Storia della letteratura italiana. Il Novecento, Milano, Einaudi-Elemond, 1991, p.518.
20
Corsivo nostro.
21
Anche se poi le stesure subiranno lente elaborazioni, con aggiunte ed espunzioni anche importanti, i
diversi abbozzi delle “tragedie” vedono la luce in pochi mesi.
22
Walter Siti e Silvia De Laude, Note e notizie sui testi, in P.P.Pasolini, Teatro, Teatro, a c. di W.Siti e
S.De Laude, Milano, Mondadori, 2001, pp.1147 sgg. La retrodatazione è di Pasolini.
23
Lo ricorda Aurelio Roncaglia, nella Nota a Porcile, Orgia, Bestia da stile¸ Milano, Garzanti, 1979,
citando anche l’intervista concessa a Jean-Michel Gardair e pubblicata il 13 novembre 1971 sul «Corriere
del Ticino»; ora la stessa si legge in P.P.Pasolini, Teatro, a c. di G.Davico Bonino, Milano, Garzanti,
1988, p.7.
24
Pubblicato su “Nuovi Argomenti”, 9, gennaio-marzo 1968,
25
Intervista al quotidiano milanese « Il giorno», 1° dicembre 1968..
26
Ricordiamo che Pasolini stesso, già nel 68, assieme a pochi altri, ebbe modo di leggere personalmente
le sue poesie in pubblico, anche a teatro.
27
Una disperata vitalità, II, in Poesia in forma di rosa (1964); ora in P.P.Pasolini, Tutte le poesie, a c.di
W.Siti, Milano, Mondadori, 2003, 2 voll.; I, p.1185.
2
10
28
Una tragedia scritta (come egli stesso dice nella nota introduttiva) dal 1965 [al?] 1974, attraverso
continui aggiornamenti. Cfr. la Nota a Bestia da stile in Teatro, cit., pp. 1195 sgg.
29
Così recita il doppio di Pasolini, Jan. Cfr. Bestia da stile, II episodio, ora in: P.P.Pasolini, Teatro, cit.,
p.769-70.
30
Bestia da stile, V episodio; ora in: P.P.Pasolini, Teatro, cit., p. 789-91. Si noti anche il sotteso rimando
dell’assonanza in absentia: ceca→ cieca.
31
E anche, con i dovuti distinguo, in Medea, o nel Vangelo secondo Matteo, che rimanda all’esemplarità
della storia sacra delle origini.
32
Lo ricordava Federico De Melis nell’articolo La smascherata, a proposito della mostra dei materiali
fotografici scattati sul set di Salò: in «Alias-Il Manifesto», anno 8, n.42, sabato 29 ottobre 2005, p.2.
11