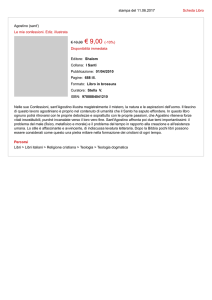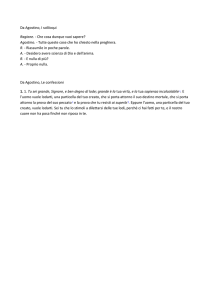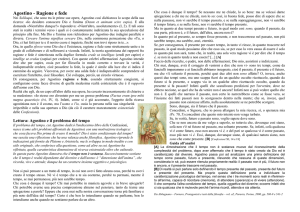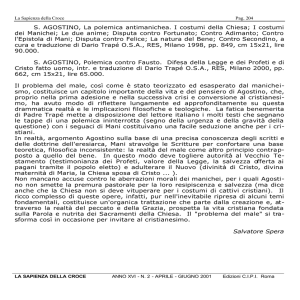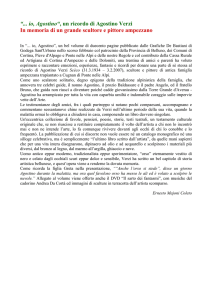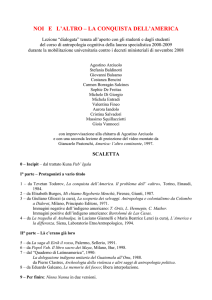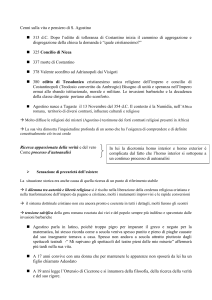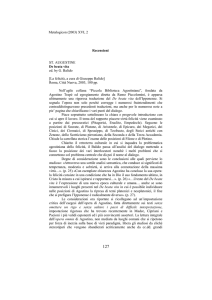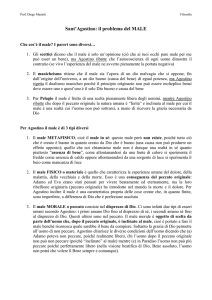Da Roma a Milano
Amareggiato e indispettito dal comportamento degli studenti romani, abituati ad abbandonare in
massa il maestro all’approssimarsi delle scadenze di pagamento, Agostino vide allontanarsi poco
alla volta l’entusiasmo per l’insegnamento e dissolversi così l’unico motivo che lo aveva fatto
trasferire da Cartagine a Roma. La situazione si faceva per lui sempre più insopportabile e “odiosa”
e diventava urgente trovare una soluzione più adeguata alle sue aspirazioni.
A Roma egli era ancora legato al manicheismo, sebbene l’ardore di un tempo si fosse ormai
assopito e al suo posto fosse subentrata la sfiducia di trovare delle novità autentiche in quella
dottrina. Se dunque continuava a frequentare i circoli manichei romani, stringendo amicizie anche
con quegli “eletti”, alla cui schiera egli, semplice “uditore”, non apparteneva, cio’ dipendeva in
gran parte dall’abitudine e da una lunga familiarità con quell’ambiente, che lo rendeva pigro nel
cercare qualche alternativa. Anche lo scetticismo che aveva incontrato nell’Accademia - e che
pensava fosse l’insegnamento di questa scuola, prima di scoprire che il dubbio su tutto veniva
proposto al solo scopo di tenere nascosta alle moltitudini la vera dottrina per renderla accessibile
solo ai pochi sapienti – non era riuscito a fargli cambiare strada, quantunque, per un certo periodo,
avesse esercitato su di lui una forte attrattiva. Perciò la scelta di abbandonare la setta, che nel suo
cuore stava lentamente maturando, non trovava ancora motivi validi per essere presa ed era
continuamente rimandata. Finché i manichei stessi vennero in suo aiuto e, senza volerlo, crearono le
condizioni di quella che sarà la svolta fondamentale nella vita di Agostino. A Milano era stato
messo a concorso dalle autorità governative un insegnamento di retorica, resosi vacante. Essi
intercedettero presso il prefetto pagano Simmaco, affinché quel posto fosse assegnato ad Agostino,
come riconoscimento dei suoi meriti e del suo giusto valore. Simmaco si prodigo’ per soddisfare la
richiesta, anche perche’ in quei giorni stava intrattenendo una durissima polemica con il Vescovo di
Milano e l’invio, nella sua citta’, di un eretico, per di piu’ legato irregolarmente a una donna, gli
parve un atto di forza che avrebbe certamente indispettito l’avversario. L’operazione ottenne,
dunque, l’esito desiderato ed Agostino fu ben lieto di trasferirsi in una citta’ che egli sperava di
trovare piu’ adatta ai suoi scopi e al suo temperamento.
A Milano egli non trovo’ una nuova dottrina, ma la benevolenza di un uomo, Ambrogio.
Essa e la soavita’ del suo parlare attrassero l’ancor giovane retore e accesero in lui l’amore e
l’interesse per quella bellezza della forma che, messi da parte i contenuti e le questioni sulla verita’,
gli appariva allora come l’unica cosa degna di considerazione.
Ma con le parole passarono le idee e Agostino, ascoltatore assiduo delle prediche di Ambrogio,
comincio’, anche grazie all’aiuto di Monica, a vedere nel cristianesimo non piu’ una religione
“vinta” dalle obiezioni manichee, ma una “fede” che non era temerario sostenere. All’incontro con
Ambrogio s’aggiunsero poi gli incontri con la “ Ecclesia plena” di Milano e con il “circolo
neoplatonico milanese”. Grazie al primo, Agostino capì che la verita’ non e’ solo un puro oggetto
dell’intelligenza, ma e’ concretamente presente in un “luogo”, ove merita di essere cercata:
l’attrattiva esercitata sul suo animo dall’unita’ e dall’armonia del popolo cristiano, del quale
conservo’ per tutta la vita l’immagine, arricchendola con le successive esperienze, altro non fu che
l’iniziale legame con quella realta’ storica che egli considero’, col passare degli anni, come la via
piu’ propizia per raggiungere la verita’. Grazie al secondo, Agostino potette conoscere le idee e i
“libri” che quel gruppo di persone, ben diverso da una scuola o da un accademia, aveva in comune,
insieme alla reciproca amicizia.
Si indebolirono cosi’, fin quasi a crollare, i capisaldi della critica manichea e Agostino risolse in
breve tempo di abbandonare definitivamente la setta, senza tuttavia aderire pienamente al
cristianesimo.
Il dubbio e il timore di cadere in un nuovo errore lo allontanavano da ogni dottrina; la nuova
situazione gli suggeriva, pero’, prudenza ed egli ritenne opportuno restare nell’ambito della chiesa,
anche solo come semplice catecumeno.
Cosi’, nell’attesa di qualcosa di certo, iniziava un periodo ricco di scoperte e di radicali
cambiamenti, per Agostino e per coloro che, dalla sua vicenda, hanno saputo trarre utili
insegnamenti.
La certezza matematica
Molto e’ stato scritto sulla conversione di Agostino, in modo pregevole ed utile a conoscere sia
quanto si agitò nell’animo che quanto mutò nella sua concezione filosofica prima, durante e subito
dopo quel momento che va dall’autunno del 368 alla tarda primavera del 387. Non e’ dunque il caso
di ritornare sull’argomento; ne’ rientra nelle finalità di questa introduzione l’analisi delle influenze
culturali e dei complessi rapporti fra neoplatonismo e cristianesimo nell’evoluzione intellettuale di
Agostino.
Qui, invece, si vogliono mettere in luce i presupposti teorici della concezione agostiniana e il
diverso modo di intendere la conoscenza e la fede prima e dopo la conversione.
Divenuto “certo dell’incertezza” delle dottrine manichee Agostino vide svanire la promessa fatta da
quegli uomini, fra i quali egli era capitato solo perche’ dicevano che “ con la paura e semplice
ragione avrebbero condotto a Dio e liberato da ogni errore chi voleva ascoltarli”. In lui, confuso e
restio a prendere nuove e definitive posizioni, si scontravano due tendenze opposte: da una parte la
tentazione di abbandonare, per la difficolta’ a trovarlo, la ricerca del vero, che sempre aveva amato,
dall’altra il forte desiderio di superare lo smarrimento e di raggiungere qualcosa di certo.
Tale desiderio era sicuramente predominante nell’inquieto animo di Agostino, e trovava d’altronde
conferma e sostegno in due fatti, che egli aveva sempre ben presenti. Innanzi tutto la natura della
mente umana, con le sue indomabili esigenze e con la sua capacità di indagare e di penetrare nelle
questioni piu’ oscure ed intricate; tutto cio’, pensava Agostino, sarebbe inutile, e persino senza
senso, se all’uomo fosse preclusa la conoscenza della verita’, ossia se quelle esigenze e capacita’
non raggiungessero il loro scopo. In secondo luogo, e soprattutto, il possesso indiscutibile di una
conoscenza, quella matematica, che egli aveva sempre considerato assolutamente evidente, certa e
indefettibile. Essa resisteva a qualsiasi dubbio e appariva percio’ ad Agostino come il modello e il
criterio di verita’ di ogni altra forma di sapere.
“Volevo diventare certo di quelle cose che non vedevo come sono certo che sette piu’ tre fa dieci”
scrive Agostino nelle Confessioni, commentando le sue aspirazioni intellettuali nei primi mesi di
permanenza a Milano, quando, dopo aver scoperto il “senso spirituale” delle Scritture, si stava
avvicinando alle verita’ della religione cristiana, senza pero’ riuscire ancora ad accettarle, perche’
gli apparivano prive di ragioni e di evidenza. Dopo la conversione tale aspirazione fu giudicata una
vana pretesa, come si afferma nello stesso brano; tuttavia non fu la matematica, con le sue regole,
ad essere posta sotto accusa, ma solo la sua applicazione ad una serie di realta’ che non possono
rientrare nel suo ambito di conoscenza.
Ai numeri Agostino attribui’ sempre una grande importanza dal punto di vista gnoseologico – e
talvolta anche da quello ontologico e morale – e si puo’ dire che non ci fu discussione sulla
conoscenza senza un riferimento piu’ o meno esplicito al sapere matematico. E’ dunque a questo
sapere che occorre porre attenzione per comprendere in modo adeguato la posizione di Agostino
sulla conoscenza, e anche per rendersi conto dell’importanza che esso ebbe nel determinare la
problematica inerente ai rapporti fra sapere razionale e fede.
Alla matematica Agostino ha dedicato specifiche trattazioni, soprattutto nelle sue prime opere. Nel
De ordine, nel De musica, nei Soliloqui, e, poi, nel De libero arbitrio, si trovano le sue piu’
approfondite analisi sulla natura dei numeri, sulle loro leggi e sulle corrispondenze che essi hanno
nell’ordine naturale e nelle “opere” create dall’uomo.
Al sapere matematico Agostino si era dedicato fin dall’eta’ giovanile, quando, da solo e senza
grandi difficolta’, aveva appreso i fondamenti dell’aritmetica e della geometria, insieme a quelli
dell’eloquenza, della dialettica e della musica. Ebbe una buona conoscenza delle teorie matematiche
del suo tempo, e fu particolarmente vicino alla tradizione degli Stoici, dei Pitagorici e dei Platonici.
In genere egli cerco’ di collegare le sue discussioni sulla matematica ad altri problemi, senza mai
farne delle trattazioni specifiche e fine a se stesse e , in particolare, si servi’ delle nozioni
matematiche per elaborare la sua dottrina della conoscenza e per delineare la sua concezione della
verita’.
Nella loro essenza i numeri sono, per Agostino, realta’ “divine ed eterne”, “immutabili”, oggetti
non sensibili, che solo l’intelletto puo’ conoscere, e indipendenti dall’esperienza sia esteriore che
interiore.
Per la loro natura, le verita’ matematiche soddisfano pienamente le esigenze della ragione e sono
pertanto le verita’ conoscibili per eccellenza. Esse sono, infatti, immediatamente evidenti e si
mantengono sempre identiche. Nessuno, afferma Agostino, ha mai potuto cambiare le leggi dei
numeri e nessuno potrà mai farlo in futuro. Anche se tutto finisse e il mondo fosse distrutto, la ratio
dei numeri continuerebbe ad esistere e la somma di due numeri non sarebbe diversa da come e’
adesso. Le verita’ matematiche, come e’ evidente e ammesso da tutti, non dipendono neppure dalla
mente umana, che e’ mutevole e non puo’ dunque essere la causa di cio’ che e’ piu’ perfetto di lei.
Percio’ quando la mente pensa e conosce i numeri, non crea ne’ determina in alcun modo il proprio
oggetto, ma si rivolge a entità di per sé esistenti, cui deve cercare di adeguarsi. Di conseguenza la
conoscenza matematica e’ indipendente dal soggetto conoscente e dal momento o luogo nel quale si
realizza; essa e’ sempre la stessa ed e’ pertanto la fonte della piu’ grande certezza.
Il carattere oggettivo della conoscenza matematica e’ ulteriormente sottolineato da Agostino
nell’analisi delle regole che governano i rapporti fra i numeri ( disciplina numeri);in esse egli vide
realizzarsi una verita’ di relazioni ( veritas connexionum) che non trova riscontro nell’attivita’
mutevole e spesso arbitraria dell’uomo e puo’ solo essere spiegata come frutto di un azione
superiore e divina (divinitus instituta). La verita’ matematica, insomma, non “deve essere” ma “e’”,
e , pertanto non consegue al ragionamento, ma lo precede e lo guida.
Per queste sue caratteristiche, la matematica viene a configurarsi come un sapere oggettivo e
universale, che supera ogni altro sapere e ne e’, allo stesso tempo, il modello. Si spiega cosi’ la
tendenza di Agostino a individuare nei vari tipi di sapere il loro risvolto matematico e, in
particolare, perche’ egli fondi l’estetica e la razionalita’ sui numeri.
Per quanto riguarda la prima, Agostino ritiene che i numeri stiano alla base del giudizio estetico,
perche’ in essi si realizza e si scorge quell’ordine e quell’unita’ che ogni percezione sensibile cerca
di trovare. Non vi e’, infatti, realta’ sensibile che non piaccia per la proporzione e l’uguaglianza;
tuttavia l’armonia, che e’ l’oggetto della percezione estetica, non e’ dei corpi, che mutano e non la
realizzano pienamente, ma e’ in essi come riflesso di un ordine che li trascende. E’ quest’ordine che
l’animo umano ama in senso proprio ed e’ ad esso che le realta’ sensibili , con i loro ritmi e le loro
forme, continuamente rimandano. Ma siccome ogni ordine si fonda su rapporti numerici, che sono
la causa ultima del piacere estetico, tutte le volte che si realizza una proporzione o un’uguaglianza,
lì si realizza l’eterna legge dei numeri. Di conseguenza essa e’ anche la causa e il fondamento di
ogni arte. E poiche’ ai numeri si riconducono tutte le simmetrie, le ugualianze, le proporzioni che
rendono un oggetto bello e piacevole, Agostino sente il diritto di chiamare “belli” i numeri e di
attribuire gioia e piacere alla loro scoperta.
Per quanto riguarda il secondo caso, i numeri hanno a che fare con la ragione perche’ sono portatori
di un ordine universale e immutabile e la logica che esprimono puo’ essere assunta a paradigma
della conoscenza razionale: “ nella ragione nulla e’ migliore e piu’ potente dei numeri, o meglio, la
ragione non e’ nient’altro che numero”. La ratio, infatti, e’ la forza interiore capace di unificare
l’esperienza molteplice secondo regole ben precise, in modo da renderla intelligibile; e i numeri non
sono altro che gli elementi portanti di quest’ordinamento, che servono a stabilire gerarchie,
connessioni e paragoni fra vari oggetti. In questa prospettiva si spiega anche perche’ Agostino arrivi
a mettere sullo stesso piano i numeri e la sapienza e a considerarli l’oggetto ultimo della vera
ricerca umana, conformemente all’insegnamento biblico, che invita a “conoscere, indagare e
cercare la sapienza e il numero”. Sia la sapienza che il numero appartengono alla medesima verita’
e in essa vengono conosciuti; di entrambi la conoscenza e’ immutabile e certa, perche’ chi possiede
la sapienza apprende le verita’ ultime ed eterne, e chi conosce i numeri scopre le ragioni ultime e
immutabili delle cose. Pertanto chi conosce i numeri ha gia’ una buona preparazione filosofica e
puo’ aspirare a risolvere i due fondamentali problemi della filosofia: l’anima e Dio.
Anche se Agostino, nelle Rittrattazioni, considera il sapiente, che indaga le “invisibilia Dei” in
forza della conoscenza dei numeri, condannato alla perdizione se manca della fede, mentre il
semplice fedele “ignorante” e’ destinato alla certezza ed alla felicita’ della visione beatifica, sono
pero’ fuori discussione la stima e la considerazione ch’egli ebbe verso la matematica, come gradino
indispensabile per raggiungere la conoscenza piena della verita’.
In quest’ottica non sarebbe affatto fuori luogo vedere dei punti di contatto fra la conoscenza dei
numeri e quella disciplina, la dialettica, che Agostino non solo non considera pura tecnica del
discutere – quantunque la definisce disciplina disputandi, disciplina disputationis, disputatoria ars,
ratio disputandi, disputandi scientia – ma addirittura non esita a equiparare alla verita’ stessa. Le
ragioni di questo paragone sono almeno due.
Innanzi tutto vi e’ una forte analogia fra i numeri e i principi sui quali si fonda la dialettica. Essa,
infatti, e’ l’arte che la ragione scopre quando prende coscienza del suo funzionamento metodico,
ossia quando si accorge che il proprio modo di ordinare gli oggetti, i termini e le proposizioni,
mediante definizioni, analisi e sintesi, segue regole precise e immutabili, che non sono sottoposte
all’arbitrio dell’uomo.
In secondo luogo la dialettica, come la matematica per le altre forme di conoscenza, e’ in grado di
informare e di essere criterio di altre discipline.Essa e’ infatti la scienza che rende vere tutte le
scienze ed e’ la madre di ogni arte (“disciplina disciplinarum”); percio’ e’ la scienza che e’ di per se
stessa vera. In tal senso la dialettica funge da regola formale, perche’ si occupa delle condizioni di
verita’ e non dei contenuti di ogni altra scienza.
Tornando ai numeri, si puo’ dire che essi, analogamente, rappresentano la struttura a priori della
percezione estetica e del ragionamento.
Le leggi della matematica, sostiene Agostino, sono le stesse leggi che formano il giudizio estetico e
rappresentano quella “sorta” di “apriori” del sentimento” in base al quale si giudica positivamente o
negativamente cio’ che si vede e si sente. Il criterio estetico non e’ tratto dall’esperienza, ma e’
nell’uomo prima di ogni apprensione sensibile, e si configura come esigenza di proporzione e di
simmetria, che ricerca una corrispondenza nella realta’. Percio’ le cose piacciono perche’ sono
belle; ed esse sono belle perche’ rispettano, nel loro essere e nel loro modo di esistere, la legge
dell’armonia, cioe’ esprimono un’insieme unitario di parti, uguali o proporzionate, che realizza dal
punto di vista reale quelle relazioni che esistono tra i numeri, In questo senso le leggi matematiche
stanno alla base di ogni progetto e di ogni costruzione, materiale o intellettuale, che l’uomo vuole
compiere “in modo razionale”. Esse, che Agostino chiama anche “ numeri judicales”, unificano
l’esperienza, che dalla molteplicità passa all’unita’ e fungono da criteri normativi dell’espressione
artistica, linguistica, poetica e musicale. La statua non potrebbe essere scolpita, se l’artista non
seguisse quell’armonia che deriva da certi rapporti numerici; parimenti la frase o il testo intero, il
verso o la strofa, non avrebbero senso ne’ valore se le diverse parti non componessero, secondo
rapporti ben precisi di proporzione e simmetria, un tutto organico e unitario.
La razionalita’ del discorso, cosi’ come la razionalita’ di un dipinto o di un’altra opera artistica,
coincide percio’ con la perfezione dei rapporti e con la congruenza delle parti fra loro e con l’intero.
In questo modo Agostino mette chiaramente in luce che la struttura del senso estetico coincide con
quella della razionalita’ e che il motivo di tale coincidenza e’ dato dal fatto che sia l’uno che l’altra
si fondano sulle precise regole dei numeri.
Dunque ogni opera dell’uomo e’ ragionevole in quanto bella, ed e’ bella in quanto rispetta la giusta
misura, la proporzione, l’armonia delle parti. Percio’ gli architetti chiamano “ragione” la
proporzione e la simmetria e considerano “senza ragione” una costruzione che non abbia tutti gli
elementi concordemente collegati.
Ora, i numeri non costituiscono solo la struttura a priori del modo di vedere le cose, ma sono anche
gli elementi fondamentali e normativi delle cose stesse, in quanto tutto cio’ che esiste, esiste
secondo un ordine e una proporzione.
Ogni ente di natura si fonda, infatti, su un rapporto numericamente definito delle sue parti.
In ogni corpo animato i rapporti e l’ordine delle parti appartengono ad un’unita’ armonica: per
questo motivo esso ha vita e una propria identita’, ed e’ bello nel suo genere. Nelle sue opere
Agostino si sofferma spesso sulla descrizione della natura. Parla dei monti, delle valli, del mare, dei
paesaggi, del cielo, delle piante, dei fiori: tutte realta’ che, per come esistono, esprimono un ordine,
che e’ loro e anche di tutta la natura, e che si presentano belli all’occhio dell’osservatore perche’ in
essi si realizzano l’accordo delle parti con l’intero e una conveniente proporzione o simmetria. Ma
questo accordo non esisterebbe nelle cose se non esistesse, fuori dalle cose stesse, quell’unita’ che
consente di ordinarle; parimenti, non sarebbero affatto belle se non vi fosse una bellezza da imitare.
Una cosa, infatti, e’ bella non per se stessa, ma per la bellezza.
Essa e’ forma superiore e consiste nell’unita’ di tutte le parti armonicamente ordinate. Adeguandosi
e assomigliando a questa bellezza “ ideale”, le cose appaiono belle, allontanandosi da essa,
divengono brutte. Come l’uomo e’ malvagio quando entra in conflitto con l’intera societa’ e la
turba, cosi’ una cosa o una parte e’ brutta quando non si accorda con il tutto. E il tutto o l’intero,
che e’ unita’ e bellezza, riposa su regole matematiche. Questa concezione della bellezza del reale
fondata sui numeri, che risente di un influsso neoplatonico, come Agostino ammette nel De civitate
Dei, e anche pitagorico, e che sara’ condivisa da molti autori medievali, si ritrova in tutta la sua
opera senza sostanziali modificazioni.
Fra tutti i numeri merita una particolare attenzione il numero “uno”. Esso e’ principio e origine di
tutti i numeri, ma e’ anche principio estetico e ontologico. L’appetere unitatem non segna solo il
confine fra cio’ che e’ bello e piacevole e cio’ che e’ brutto e ripugnante, ma contraddistingue tutto
cio’ che esiste in quanto esiste. “Non c’e’ cosa che, per essere quel che e’, non tenda all’unita’”,
afferma Agostino nel De musica, ribadendo un concetto gia’ espresso, forse con maggior forza, nel
De ordine e spesso ripreso in altri scritti, soprattutto in quelli antimanichei.
L’essere e’ unita’, e cio’ che esiste e’ uno. La pietra, per essere tale, deve avere tutte le sue parti e
tutta la sua “natura” tenuta fermamente insieme nell’unita’; non esisterebbe infatti, cosi’ come non
esisterebbe la pianta o qualsiasi altra cosa se non fosse una.
Parimenti, non esisterebbero rapporti sociali, amicizie, amore, se mancasse l’unita’ e la tensione
all’unita’.
Le realta’ semplici, specifica Agostino, esistono perche’ sono un’unita’; quelle complesse perche’
ricercano e imitano l’unita’ mediante l’accordo delle loro parti.
Ma esistere in quanto si e’ o si tende ad essere una cosa significa concepire l’esistenza in continua
relazione alla sua forma o al suo principio, e percio’ come possibilita’ di conoscere cio’ che
dell’esistenza e’ causa e ragione.
La bellezza, la ragionevolezza, l’esistenza stessa delle cose rimandano, dunque, all’eterna legge dei
numeri, e, tramite questa, al cuore stesso della verita’.
La conoscenza dei numeri e’, per Agostino, una delle strade per salire ad incorporea, proprio
perche’ essa e’ ambito nel quale la sapienza gia’ opera e si mostra “in modo piacevole”.
Partendo dalla conoscenza matematica Agostino, in diverse occasioni, cerchera’ di arrivare
all’esistenza di Dio e di dimostrare l’immortalita’ dell’anima. Giacche’ la conoscenza dei numeri,
della misura e dell’ordine delle cose, molto facilmente permette di risalire la’ dov’e’ “la somma
misura, il sommo numero e il sommo peso”, ossia quel Dio che ha disposto ogni cosa “secondo la
misura, il numero e il peso”; parimenti, la stessa conoscenza, che e’ mutevole, prova l’immutabilita’
della ratio e postula l’immortalita’ dell’anima, che ad essa e’ inseparabilmente legata.
Ma la matematica non e’ solo una via per conoscere Dio e l’anima: essa e’ anche criterio e termine
di paragone della conoscenza che si vuole ottenere.
Cio’ risulta chiaro nei Soliloqui, allorché si tratta di definire il grado di certezza della conoscenza di
Dio. La Ragione, prima di inoltrarsi nel cammino della scientia di Dio, chiede ad Agostino di
fissare il tipo d’evidenza che tale conoscenza dovrebbe avere e se non sia soddisfacente quello delle
verita’ geometriche, sottintendendo che esso e’ superiore a qualunque altro. “Rispondi – dice infatti
la Ragione – se ti e’ sufficiente conoscere Dio cosi’ come conosci la sfera geometrica, ossia se ti
basta non dubitare di Lui come non dubiti di quella.”
La risposta di Agostino e’ dapprima negativa, a causa delle diversita’ degli oggetti e anche dei tipi
di conoscenza, giacche’ quella di Dio arreca una gioia grandissima e supera di gran lunga tutte le
altre, fino quasi ad oscurarle.
Tuttavia, dopo un’acuta osservazione della Ragione, Agostino e’ costretto ad ammettere che la sola
differenza valida e’ quella che concerne gli oggetti e che, per quanto riguarda la certezza, la
conoscenza matematica e quella di Dio si equivalgono.
Anche di sé o dell’anima egli desidera avere questo tipo di scientia, che si ottiene, almeno per
quanto riguarda la coscienza di sé, nell’evidenza del cogito.
La matematica e’, dunque, il paradigma della conoscenza vera e certa e ad essa dovrebbero rifarsi
tutte le conoscenze, per avere valore e non essere mere opinioni o congetture.
La conoscenza per fede
Cosi’ pensava Agostino, fino al giorno in cui capì che non tutta la realtà può essere conosciuta in
modo uguale, e che esiste un campo di oggetti “ ragionevolmente” conosciuti, quantunque non
abbiano l’evidenza delle verita’ matematiche.
La consapevolezza della necessità di una pluralità di metodi coincise col momento della
conversione, quando Agostino accetto’ la fede e il suo valore e , divenuto “credente”, smise di
essere solamente un conoscitore o cultore di dottrine “religiose”, fra le quali anche quelle cristiane.
Questo passaggio fu caratterizzato dalla scoperta della razionalita’ della fede, non solo come “fede
religiosa”, ma anche, e soprattutto, come metodo di conoscenza. Nelle Confessioni Agostino cosi’
descrive questa scoperta.
“Poco alla volta tu, o Signore, con la piu’ benevola e misericordiosa mano hai fatto e formato il mio
cuore, per farmi considerare a quante cose io credessi, senza vederle e senza prendervi parte nel
loro svolgersi, come il gran numero di fatti nella storia dei popoli, la mole di notizie su luoghi e
citta’ che non avevo visto, e quanto credito dessi agli amici, ai medici, a persone di ogni genere,
senza del quale non faremmo proprio niente in questa vita; e infine quanto fossi fermamente
convinto , per mezzo della fede, di chi fossero i genitori da cui sono nato, cosa che non avrei potuto
sapere se, udendola, non l’avessi creduta.”
In questa nuova prospettiva Agostino muta profondamente il suo atteggiamento nei confronti delle
Scritture, le accetta, trovandole finalmente chiare e degne della piu’ grande considerazione e, per
mezzo loro, inizia a percorrere la lunga strada della ricerca e della conoscenza di Dio. Ma
soprattutto riconosce nella fede quell’importanza che fino ad allora le aveva negato, attribuendole
una funzione ed un valore sul pino conoscitivo. Valore che soddisfa pienamente l’esigenza
razionale di Agostino, che nel manicheismo aveva un tempo visto la possibilita’ di abbandonare le
“favole” e di raggiungere una conoscenza certa ed adeguata della verita’, e che ora considera quella
promessa una illusione, alla quale piu’ opportunamente e realisticamente bisogna preferire la
dottrina cattolica, che piu’ modestamente, ma anche con minor fallacia, distingue tra le cose che si
possono sapere e quelle che si debbono credere.
Con cio’ Agostino non rinuncia a conoscere la verita’: egli e’ ben convinto che la mente umana, per
la “vivacita’, sagacita’ e perspicacia” che la caratterizzano, cerca in ogni istante e in ogni occasione
di rendersi conto e di spiegare la realta’, tanto e’ vero che se cio’ le fosse impedito essa si
sentirebbe violata in quella che e’ la sua piu’ connaturata esigenza. Ma, dalla conversione in poi,
egli e’ anche ben consapevole che la verita’ esige metodi diversi di indagine, corrispondenti alla
natura degli oggetti che si vogliono indagare e conoscere.
Fermo restando il fatto che la verita’ non si inventa mai, ma si riconosce sempre e che l’oggetto
conosciuto non dipende dall’atto conoscitivo, ma possiede un ultimo fondamento oggettivo – “le
cose da conoscere” si legge nel De trinitate “producono la conoscenza, ma non sono prodotte dalla
conoscenza” - , Agostino ha ben chiaro che il metodo per conoscere verita’ astratte, matematiche e
logiche, e’ diverso da quello che si applica ai fatti dell’esistenza, ossia a quelle realta’ che si trovano
in un tempo e in uno spazio, e che assurdo sarebbe sia applicare un metodo ad un oggetto che non
gli compete, sia considerare irrazionale quella o quelle conoscenze che non possono essere
ricondotte alla conoscenza matematica. Questa resta sempre presente ad Agostino, come
fondamentale esigenza di perfezione, di ordine e di unificazione; ma, nello stesso tempo, egli si
rende conto che, di fatto, gli uomini fanno uso anche di un altro tipo di conoscenza, e che ad essa
affidano gran parte, se non la quasi totalita’, delle scelte e dei comportamenti che assumono nella
vita.
L’ambito dei fatti storici e delle situazioni legate in qualche modo all’esistenza smette così d’esser
considerato esclusivamente come oggetto di opinione – costituendo percio’ il terreno piu’ fertile per
ogni forma di scetticismo – e diviene oggetto di fede, ossia di un tipo di conoscenza che si fonda
sulla testimonianza e che consente di raggiungere una verita’ altrimenti destinata a restare
sconosciuta.
La fede non e’ l’accettazione avventata di una opinione, come potrebbe essere una qualsiasi forma
di credenza o un atto di credulità, ma e’ un possesso certo e indefettibile della verita’, quantunque
questa non sia appresa in modo evidente e mediante una constatazione diretta. La certezza della
fede e’ data dal profondo legame che essa intrattiene con la verita’. La fede e’ tale, ovvero e’ fede
vera e non credulità, perche’ consente di raggiungere e affermare qualcosa di vero.
Etimologicamente, osserva Agostino, la fides deriva da fieri, e indica appunto l’accadere, ossia il
realizzarsi di cio’ che si dice.
Dunque, credere non significa ammettere qualcosa di irrazionale, bensi’ accettare una verita’ che, in
quanto tale, non e’ contro la ragione, benche’ la mente umana non possa totalmente ed
esaurientemente dominarla.
Cio’ che si sa, lo si sa per mezzo della ragione, giacche’ la scientia e’ quella comprensione che si
ottiene con la firma ratione della mente.
Ma non tutto cio’ che si conosce si sa, e non ogni verita’ e’ saputa.
La nozione di fede come atto conoscitivo – tale per cui Agostino puo’ definirla come “gradua
intelligendi” – consente di comprendere la circolarita’ fra credere e scire, tipica del pensiero
agostiniano; essa si configura come abbraccio, da parte della fede, di tutto cio’ che la mente sa e
come rimando alla fede, da parte dell’intelletto, per tutto cio’ che non si puo’ sapere. Tale relazione
e’ ben evidenziata in alcuni passi.
Nei Soliloqui Agostino, pur con qualche incertezza, dice che “tutto cio’ che sappiamo lo crediamo
anche; mentre non sappiamo tutto cio’ che crediamo”
Nel De Magistro tale formulazione viene ampliata ed arricchita: “Cio’ che conosco, lo credo pure;
ma non conosco tutto cio’ che credo; so, invece, tutto cio’ che conosco, mentre non so tutto cio’ che
credo”. Il contesto in cui la frase e’ posta chiarisce abbastanza bene il ruolo indispensabile che
Agostino attribuisce alla fede per la conoscenza umana.
Tale funzione viene riproposta nel De utilitate credendi, attraverso la distinzione delle tre modalita’
di giudizio dell’animo umano che sono rappresentate dal sapere, dal credere e dall’avere opinioni.
Dopo aver detto che il primo (qui detto intelligere, ma nelle Rittrattazioni Agostino ritorna al
termine scire) e’ dovuto alla ragione, il secondo all’autorita’ e il terzo all’errore, Agostino,
riprendendo la formulazione dei Soliloqui e del De Magistro ed estendendola all’opinione, afferma
che “chiunque sa , crede, e anche chi ha opinioni crede; ma non chiunque crede sa e nessuno che ha
opinioni sa”.
Esistono dunque due tipi di fede: l’una, che e’ detta fede solo impropriamente, corrisponde
all’opinione, ed e’ costituita da un assenso dato senza validi motivi, un assenso che percio’ e’
destinato a cadere; l’altra, che e’ fede in senso vero, e’ un assenso certo e indefettibile ad un
complessi di verita’.
Di queste verita’, alcune possono essere conosciute mediante la ragione (sciate): percio’ e’ legittimo
il desiderio di spere cio’ che si crede. Altre, invece, non possono essere conosciute e si presentano
sempre come oggetto di fede.
Nel primo caso la fede ha il compito di anticipare il contenuto che poi sara’ conosciuto e di
sorreggere l’intelligenza affinche’ essa non sia impedita dalla distrazione.
Come il vedere consegue al guardare e si compie per mezzo di occhi buoni, cosi’ ogni atto di
conoscenza presuppone un’attenzione dell’animo e viene realizzato da una mente purificata e libera
da qualsiasi distrazione. Ora, la fede, sostiene Agostino nei Soliloqui, offre il proprio contributo alla
conoscenza perche’ dispone l’animo, purificandolo, e indirizza, sostenendolo con fermezza, lo
sguardo verso cio’ che si deve vedere.
L’importanza di questo aiuto viene ribadito e, per alcuni versi, ulteriormente specificato nel De
utilitate credendi. Qui Agostino, dopo aver sottolineato il nesso positivo fra la fede e la
comprensione della verita’, in quanto la prima prepara e predispone l’animo cosi’ che esso diviene
capace della seconda, osserva che, a causa della stoltezza, la maggior parte degli uomini non e’ in
grado d’intuire la verita’. Ora, e’ solo la fede che puo’ operare questa purificazione: essa, suscitata
dall’autorita’, anticipa il contenuto del conoscere e muove verso di esso l’animo, innalzandolo e
rendendolo cosi’ capace di una conoscenza altrimenti impossibile.
“Penso che il credere prima della ragione,” dice Agostino “ quando non sei capace di percepire la
ragione, e l’educare con la fede stessa l’animo ad accogliere i semi della verita’, non solo sia la cosa
piu’ salutare, ma sia anche assolutamente indispensabile per riportare la salute agli animi
ammalati.”
In questa funzione complementare la fede non si oppone alla ragione, anzi la esige, e, d’altra parte,
non viene negata o ripudiata quando cio’ che prima era solamente creduto, comincia ad essere
anche conosciuto.
In questo reciproco rapporto fra credere e conoscere si trova, com’e’ noto , una delle piu’ alte
espressioni della riflessione agostiniana” “si non potes intelligere, crede ut intelligas; praecedit fides
sequitur intellectus”
Ma la fede non e’ solo una propedeutica alla conoscenza. Come si e’ detto Agostino la considera
una forma di conoscenza in senso pieno. Per due motivi: innanzi tutto egli afferma che e’
ragionevole credere cio’ che non si puo’ sapere o che non si sa ancora. Diversamente dall’opinione,
che presenta come saputo cio’ che invece non si sa affatto, la fede riguarda cio’ che si sa di non
sapere. Questa consapevole ignoranza e’ all’origine della fede e la rende, come conoscenza,
rigorosa e legittima. “Se qualcuno crede in qualcosa, sapendo di non saperlo, non vi e’ colpa
alcuna” dice Agostino nel De utilitate, poiche’ se “so con certezza che non posso saperlo in nessun
modo”, allora l’unica via per apprendere una tale verita’ e’ quella di crederla. L’opinione e la
credulita’, per la presunzione del sapere, che e’ nociva alla vera conoscenza (“chi si e’ convinto di
spere gia’, non puo’ imparare”), e per l’avventatezza, che e’ fonte di facili errori, alterano il
rapporto con la verita’ e generano false visioni della realta’. Cosi’ l’uomo “quando pensa qualcosa,
crede di conoscere”, mentre e’ solo ingannato dalle apparenze.
La fede, invece, ha un riferimento preciso alla verita’. Quando si tratta di stabilire quali uomini sono
degni di lode, Agostino dice che sono quelli che credono alla verita’ e quelli che, ricercandola o
amandola, credono all’autorita’. Per questo motivo egli vede degli avversari della verita’ in coloro
che combattono la scienza o che condannano tanto la scienza quanto la fede.
Come la scienza, infatti, anche la fede e’ una conoscenza vera e certa, quantunque non evidente, a
causa dell’oggetto che indaga, che e’ assente o non puo’ essere visto.
Le verita’ che possono essere solo oggetto di fede sono le verita’ storiche, quelle inerenti ai giudizi
e ai comportamenti morali e a tutte quelle realta’ “che non si vedono” o che non sono evidenti come
le verita’ logico-matematiche.
L’assenso dato a tali verita’ non puo’ avere la conferma della verifica empirica, ne’ puo’ essere la
conseguenza di un ragionamento deduttivo. Esso infatti si rivolge a qualcosa che di per se’ e’ solo
“probabile”. Percio’ la fede deve supplire alla mancanza d’evidenza, mettendo, per cosi’ dire,
qualcosa di suo, che tolga l’incertezza della “probabilita’” e , nello stesso tempo, la rispetti,
assumendola come indizio, suggerimento e indicazione di cio’ che non si vede.
“La fede e’ tanto grande” osserava Agostino nel De fide rerum “ che non siamo fuori luogo a
pensare di vedere, per cosi’ dire, con i suoi occhi cio’ che crediamo, quando siamo costretti a
credere perche’ non possiamo vedere”. E quasi con le stesse parole, Agostino risponde all’amico
Consenzio che “la fede ha i suoi occhi con i quali, in un certo modo, vede che e’ vero cio’ che
ancora non vede e con i quali vede con assoluta certezza che non vede ancora cio’ che crede”.
In secondo luogo, la conoscenza per fede e’ utile e indispensabile per la vita pratica.
“Non so proprio come l’uomo possa non credere a niente”, osserva Agostino riferendosi a tutte
quelle cose che nella vita quotidiana vengono accettate per fede. Egli prende in considerazione
innanzi tutto i legami con le altre persone, siano essi di amicizia o di parentela. Non esisterebbe
alcuna amicizia, infatti, “se non si credesse qualcosa che non si puo’ dimostrare con ragione
sicura”. All’amico si crede sempre, poiche’ le sue intenzioni nei nostri confronti non possono essere
viste o dimostrate, ne’ potrebbero essere ricambiate se non fossero credute. E se cio’ non accadesse,
molto dell’esperienza umana e anche sociale andrebbe perduto. Ogni vincolo di parentela
cesserebbe d’esistere, perche’ senza credere all’amore di un altro nei propri confronti, sarebbe
impossibile legarsi ad esso e cosi’ finirebbero le unioni coniugali, e nessuno oserebbe piu’ mettere
al mondo dei figli, dubitando del loro reciproco amore.
In particolare, se la fede fosse ripudiata, crollerebbe ogni rapporto di figliolanza. Nessuno, infatti,
puo’ sapere di chi e’ figlio, giacche’ non puo’ ricordare il momento della nascita, ma lo apprende
attraverso parenti, amici e persone che lo hanno visto nascere. Se un uomo non credesse a tali
testimonianze, dovrebbe per coerenza, mettere in dubbio di essere figlio di coloro che tutti
considerano i suoi genitori e di conseguenza, per la possibilita’che essi non siano quelli veri,
dovrebbe abbandonarli.
Senza entrare nel merito della valutazione di Agostino, che giudica scellerato un figlio che si
comporta in questo modo, e invece saggio quello che ritiene essere suoi genitori coloro che non lo
sono, si puo’ tuttavia notare che tutta la discussione ruota intorno al fatto che una “conoscenza”, fra
le piu’ certe e comuni, come quella che riguarda il proprio padre e la propria madre, non e’ di per
se’ evidente, ne’ puo’ essere dimostrata , ma viene acquisita solo mediante la fede. Difatti, la
differenza fra il figlio che riconosce i suoi genitori e quello che non li riconosce e’ data solo dal
fatto che il primo crede a cio’ che gli viene detto, accettando cosi’ i suoi genitori, mentre il secondo,
pur trovandosi nella medesima situazione e con gli stessi elementi di valutazione e le stesse
informazioni, non presta fede a coloro che gli testimoniano e i suoi legami di parentela.
Parimenti, la fede e’ indispensabile per apprendere tutta una serie di fatti che costituiscono un
bagaglio di nozioni e di cultura di ogni uomo e di interi popoli.. Eventi storici, ai quali non si e’
preso parto, luoghi o persone che non si sono visti, vengono conosciuti solo attraverso i documenti
o la testimonianza diretta di chi vi ha partecipato li ha visitati o incontrati. E siccome l’esperienza
diretta e’ alquanto limitata, se non si credesse alle parole altrui si rimarrebbe confinati in una
conoscenza angusta e insufficiente non tanto all’operare quanto allo stesso vivere. Se dunque non
fosse lecito credere a cio’ che non si puo’ comprendere con evidenza, non solo la societa’ umana
crollerebbe per la mancanza di concordia, ma anche nulla di essa rimarrebbe impregiudicato e quasi
tutto sarebbe messo in discussione. Con questa apologetica della fede Agostino dimostra
l’infondatezza della pretesa manichea di accettare solo cio’ che si puo’ vedere; ma anche, e
soprattutto, egli mette in luce il particolare ed essenziale ruolo della fede, sia come facolta’ che
coaudiva la conoscenza, sia come specifica forma di conoscenza.
Autorità e ragione
La fede si basa su indizi. Gran parte del De fide rerum, dal paragrafo quinto in poi, insiste sul fatto
che credere significa considerare realta’ e fatti presenti che non esauriscono in se stessi il loro
significato, ma rimandano ad altro, a cio’ appunto di chi sono indizio o segno. Per questo preciso
motivo Agostino non considera la fede precipuamente come atto della volonta’, ma come atto
dell’intelligenza, che, applicandosi ad una realta’ presente, sa comprendere cio’ che essa indica.
Questa “apologetica del segno” permette di definire la fede come un comprendere che si attua
attraverso un’interpretazione.
E’ infatti partendo dalle cose che si vedono che si raggiungono quelle che non si vedono. Questo
passaggio non e’ continuo, ma presenta un “salto”, giacche non e’ sorretto da alcuna necessità.
Tuttavia esso non e’ arbitrario, ne’ causale, ma segue un criterio ben preciso, che e’ quello della
corrispondenza reciproca fra gli indizi o i segni e la loro spiegazione. Cio’ che non si vede, in altri
termini, viene creduto solo perche’ si presenta come la ragione di cio’ che si vede, e dimostra di
esserlo veramente. Vi e’ percio’ un movimento che va dagli inizi al loro movente, ammesso per
fede agli indizi, che vengono in questo modo illuminati e possono essere interpretati secondo il loro
giusto significato.
Tutta la seconda parte del De fide rerum e’, da questo punto di vista, un grande elogio della fede
come metodo di conoscenza storica (in questo caso si tratta della storia del popolo ebraico e del
cristianesimo, che hanno il loro centro e la loro origine nel mistero dell’incarnazione di Cristo). Ma
la fede e’ anche il metodo per comprendere i comportamenti umani, gli atteggiamenti e le intenzioni
che gli altri hanno nei nostri confronti, per esempio la benevolenza e l’amicizia che ci portano, che
non possono essere viste e debbono essere accettate e ricambiate. Ed e’ anche, la fede, il modo piu’
appropriato per apprendere il senso di un testo, che non si riduce alla “lettera” che si vede, ma
corrisponde a cio’ che l’insieme delle parole e delle proposizioni indica, anche al di la’
dell’intenzione dell’autore, come nel caso della sacra Scrittura.
Ora, secondo una tale concezione, la fede non puo’ prescindere da quello che, da un punto di vista
oggettivo, e’ il criterio della sua verita’ e che, metodologicamente e pedagogicamente, e’ lo
strumento del suo realizzarsi come forma di conoscenza. Cio’ e’, appunto, auctoritas. E si
comprende perche’ Agostino attribuisca ad essa un’importanza capitale, non solo sotto l’aspetto
morale, ma anche sotto quello conoscitivo in senso stretto.
Come confessa a Onorato nel De utilitate, egli, riflettendo sulle capacita’ della mente umana si era,
infatti, convinto che “la verita’ rimane nascosta solo perche’ non si conosce il modo di cercarla”, e
che” questo stesso modo deve essere preso da qualche autorita’ divina”. E’ infatti l’auctoritas il
fattore visibile e incontrabile che sta all’origine e l’accompagna, sostenendolo, il cambiamento e il
miglioramento dell’uomo, dal punto di vista sia conoscitivo (dall’ignoranza alla sapienza) che
morale (dall’uomo decaduto all’uomo nuovo).
Elemento fondamentale delle polemiche antimanichee, il valore dell’autorita’ viene messo in luce in
diverse opere agostiniane, dagli scritti di Cassiciaco a quelli della maturita’.
In linea generale l’autorita’ e’ presentata come cio’ che suscita la fede, che prepara alla ragione e
che, la precede. “All’apprendimento siamo necessariamente condotti in duplice modo: con
l’autorita’ e con la ragione. In ordine di tempo viene prima l’autorita’, nella sostanza la ragione.”
E’, infatti, il saggio che consente allo stolto di acquisire la sapienza, ed e’ seguendo la sua autorita’
che la massa degli uomini cambia la vita disponendosi ad accogliere la ragione.
Nel Severa religione il ruolo dell’autorita’ viene di nuovo illustrato, in termini ancora piu’ espliciti
e perentori per quanto concerne la sua complementarietà alla ragione. La ragione conduce
all’intelligenza e alla conoscenza. Anche se la ragione non abbandona del tutto l’autorità’, quando
si considera a chi si deve credere; e certo suprema e’ l’autorità’ della verita’ stessa gia conosciuta ed
evidente”.
Per credere, occorre sapere quale sia l’autorita’ giusta da seguire; un errore a questo riguardo
potrebbe impedire il raggiungimento della vera conoscenza. Non era forse passato lo stesso
Agostino attraverso la falsa fede nei manichei e nelle loro dottrine? Ma, una volta trovati” gli
uomini e i libri” cui e’ opportuno credere, allora la strada per uscire dall’ignoranza e dalla
perversione si apre davanti all’uomo, ed egli puo’ percorrerla agevolmente, cio’ che invece non
potrebbe fare se fosse solo.
Evidentemente questa autorita’ non e’ la terribilis auctoritas che un tempo il giovane Agostino
aveva sfuggito, ne’ e’ quella che egli stesso rifiuta di assumere, quando invita Evodio a fare suo il
motto di Orazio (sapere aude) e ad essere sottomesso alla ragione piuttosto che alla paura.
Quantunque molteplici siano le descrizioni di tale termine e talvolta esso sia associato alla figura
del “sapiente”, e’ pero’ fuor di dubbio che Agostino non circoscrive l’auctoritas a una singola
persona, ma la considera come quel complesso di fatti ed elementi fra loro connessi in modo tale da
indicare una via da seguire e da fare apprendere come vere quelle cose che non sono ancora sapute.
In tal senso, se l’autorita’ e’, in ogni caso, lo strumento per acquisire nozioni, informazioni e
conoscenze, in senso pieno essa e’ la grande occasione che e’ data al genere umano per adeguare la
propria vita alla verita’.
Si puo’ cosi’ capire nel De vera religione Agostino parli dell’autorita’ come di uno dei modi scelti
dalla divina provvidenza per salvare l’uomo, e anche perche’ egli sostenga che essa si comunica in
una storia e attraverso la profezia che essa contiene. Questa e’ la storia, prima, del popolo ebraico,
poi del popolo cristiano, che di quello e’ il compimento. Storia di profezie e di eventi che le hanno
realizzate, storia di miracoli, di fatti e di uomini che, attraverso la loro vita, hanno mostrato e
mostrano a tutta l’umanita’ quale sia la verita’ da ricercare e quale sia il Dio da adorare.
In ultima analisi la sola autorita’ che Agostino si propone di seguire e’ quella di Cristo. Ma essa non
e’ separata dalla storia contenuta nel Vecchio Testamento – contro le maledicente dei manichei, che
quegli scritti disdegnavano e volevano distruggere -, ne’ dalla storia del Nuovo Testamento, che si
realizza in tutto il mondo per mezzo di “uomini nuovi”, portatori di un nuovo modo di vivere.
Anzi sostiene Agostino, questa storia del nuovo popolo di Dio, oggi presente e operante, qualora
tutte le precedenti profezie e testimonianze fossero eliminate, sarebbe di per se’ un motivo
sufficiente per credere e per cambiare vita.
Essere nell’alveo di questa storia significa dunque accogliere l’opera e l’aiuto divino per
raggiungere la sapienza, ed e’ anche la condizione per interpretare in modo vero quella stessa storia,
cosicché essa appaia in tutta la sua autorevolezza e capacità di suscitare e alimentare la fede.
Il ritorno di Agostino alle Scritture, dopo il disprezzo del periodo manicheo, e la sua strenua difesa
della complementarietà dei due Testamenti non possono essere visti che nell’ottica di questa fiducia
e adesione alla cura che la divina provvidenza ha avuto del genere umano attraverso la storia di
alcuni uomini. L’esito di questa cura e’, comunque, la restaurazione dell’uomo nell’unita’ e
integrità originarie, che gia’ cominciano ad essere sperimentate dall’uomo che nasce dalla fede,
come bene e’ descritto nel De vera religione e nel De utilitate.
Ma a questa unita’ puo’ condurre anche la ragione, che e’ la facolta’ specifica data all’uomo perche’
si elevi sopra le altre cose e passi dalle realta’ mutevoli a quelle immutabili. Cio’ la ragione compie
attraverso un’indagine su di se’, che la porta a scoprire il profondo ed essenziale legame che essa ha
con la verita’, e anche quale sia la natura e l’essenza della stessa verita’.
Una mirabile descrizione di questo cammino si trova nei capitoli XXIX-XXXI del De vera
religione, e puo’ essere cosi’ sinteticamente riassunto. Cio’ che contraddistingue l’uomo e’ la
ragione, e la ragione si esprime sostanzialmente nel giudizio; il sentire sensibile e’ invece comune a
uomini e ad esseri privi di ragione. Ora, il giudizio deve avere un criterio o una regola immutabile
cui riferirsi, altrimenti sarebbe mutevole come le sensazioni, che dipendono dall’esperienza. Ma la
mente umana, che e’ mutevole, no puo’ fornire questo criterio; essa anzi deve essere educata per
essere in grado di giudicare.
Il criterio e’ invece dato da una legge superiore alla mente, ed e’ cio’ che si chiama verita’. La quale
non puo’ essere vista con gli occhi, ma e’ riconosciuta dall’intelligenza come l’elemento
immutabile presente in ogni pensiero e in ogni ragionamento. Essa si trova in interiore nomine, ove
non gli oggetti sensibili, ma solo quelli intelligibili vengono indagati; tuttavia non coincide con
l’interiorita’, ne’ con la mente, perche’ anch’esse mutano, ma le trascende.
La verita’ e’ il fondamento del giudizio, in quanto esso stabilisce una relazione fra i dati percepiti e
la loro forma ideale. Percio’ quando si giudica un’opera, un fatto, una circostanza, non ci si limita a
sapere che le cose stanno in questo o in quel modo, ma le si paragona a quella legge che e’ in noi e
che consente di apprezzarle o disapprovarle.
Ora, Agostino non concepisce la verita’ solo dal punto di vista logico, come corrispondenza fra cio’
che si dice e le cose cosi’ come stanno, ma fondamentalmente come legge o forma superiore, in
potenza, ad ogni cosa, che precede il ragionamento e ne e’ implicata. Chiunque esprima un giudizio,
anche il piu’ irrilevante, e’, comunque, costretto a fare in conti con essa. Persino chi si abbandona ai
piaceri umani deve riconoscere di apprezzare cio’ che realizza una qualche corrispondenza e
proporzione e , dunque, una legge di armonia e simmetria, che e’ superiore alle cose stesse.
Nessuno puo’ percio’ allontanarsi cosi’ tanto dalla verita’ da “ non essere afferrato da qualche
segno di essa”.
La ragione, dunque, proprio in quanto opera, pone la verita’, non in quanto la crea, ma in quanto la
implica e la riconosce. Infatti “la verita’ non giunge a se stessa col ragionamento, ma e’ cio’ cui
tendono coloro che ragionano”.
Ma che cos’e’ la verità?
Dalle tre definizioni date nei Soliloqui – “vero è ciò che è così come appare a chi lo conosce”, “vero
e’ cio’ che e’”, vero e’ cio’ che realizza la “somiglianza” - Agostino riprende, nel De vera
religione, soprattutto la terza. Come la falsita’ consiste nella dissomiglianza da cio’ che si imita o si
vorrebbe essere, dunque nel ritenere che qualcosa sia cio’ che invece non e’, cosi’ la verita’
corrisponde all’essere e mostra cio’ che e’. Parimenti, la causa dell’inganno non e’ una “cosa”, ma
qualcosa di non esistente creduto o fatto credere come esistente.
Ora, tutti gli enti di natura hanno una loro unita’, in quanto esistono, e per questa unita’ sono
considerati veri. Tuttavia non realizzano pienamente l’unita’ – sono “false unita’” dice Agostino – e
se venissero presi come l’unica e assoluta realta’, essi ingannerebbero e getterebbero nella
menzogna chi cosi’ li giudica.
In tal senso il concetto di “somiglianza” viene arricchito di una ulteriore e fondamentale
specificazione. Se tutto cio’ che esiste e’ vero in quanto esprime unita’, ed e’ falso in quanto non la
realizza completamente, si puo’ dunque dire che il criterio di verita’ coincide con l’unita’. Questo e’
indubbiamente il guadagno principale del De vera religione. Si comprende percio’ perche’ Agostino
affermi che la ricerca della verita’ e’ inseparabile dalla ricerca dell’Uno; infatti cio’ che e’ vero gli
assomiglia, cio’ che e’ falso non gli assomiglia. Percio’, per conoscere la verita’ bisogna ritornare
all’Uno, che e’ assolutamente semplice ed e’ il Principio dal quale trae la sua unita’, cioe’ la sua
verita’, ogni realta’ esistente.
E’ facile trovare in queste affermazioni un’analogia con la matematica e con l’idea che la natura sia
ordinata secondo regole matematiche. Agostino stesso, d’altrone, lo ammette espressamente,
descrivendo la realta’ e i movimenti naturali, i quali tendono quasi spontaneamente all’unita’ e sono
formati e regolati dall”eterna legge dei numeri”.
Tuttavia l’Uno, di cui si parla nel De vera religione, e’ ontologicamente diverso dall’entita’ astratta
che sta all’origine e a fondamento della serie dei numeri. L’Uno, cui tutto si riconduce, e’, infatti,
per Agostino il Verbo, il Figli, L’Unigenito “che era in principio, Dio presso Dio”: Egli e’ la verita’,
perche’ e’ senza dissomiglianza e realizza completamente l’unita’. Ma questo Uno e’ entrato nella
storia, divenendo un uomo, e viene conosciuto mediante la fede. Sicche’ quell’Uno, quella Verita’,
quel Principio che era l’oggetto principale della conoscenza razionale viene ad essere l’oggetto
proprio della conoscenza che si ha mediante la testimonianza e attraverso l’autorita’. Proprio
nell’identificazione della Verita’ con L’Uno e dell’Uno con Cristo le due prospettive vengono cosi’
ad incontrarsi e la strada per l’unita’ della vera filosofia con la vera religione puo’ dirsi finalmente
aperta.
La vera filosofia e la vera religione.
Erano stati due i motivi che avevano portato Agostino ad aderire, seppure in forma non completa e
definitiva, al manicheismo.
Innanzi tutto la passione per la verita’ e la speranza di trovare, in quella dottrina che si annunciava
come la piu’ scientifica del tempo, le risposte agli interrogativi sulle grandi questioni dell’esistenza,
quali l’origine del mondo, le cause e le leggi dell’universo, la natura dell’uomo e quella di Dio. In
secondo luogo, l’attrattiva che sul suo animo giovanile esercito’ il rigoroso metodo chi i manichei
dichiaravano di adottare: esso consisteva nell’escludere tutto cio’ che non era o non poteva essere
provato con la ragione, nel combattere ogni imposizione di idee e di giudizi e nell’escludere ogni
atto di fede nel corso della ricerca.
Entrambe le attese furono deluse: Agostino non trovo’ le spiegazioni che cercava, ma soprattutto si
accorse che nell’insegnamento dei manichei molte affermazioni erano poste come dimostrate,
quando invece erano solo supposte o credute. In questo modo il manicheismo falliva il suo scopo, e
l’incoerenza fra l’enunciazione teorica e la realizzazione pratica mostrava ad Agostino la fragilita’ e
la falsita’ dell’intera dottrina, che, bollata come forma di “superstizione”, venne criticata nei suoi
presupposti ontologici, nelle sue conseguenze antropologiche e morali, ma anche per la vana
promessa che conteneva. La nuova religione, che avrebbe dovuto liberarlo dall’antica
“superstizione”, si rivelava cosi’ una falsa credenza e una nuova forma di superstizione.
Sul versante filosofico, l’”appetit rationaliste” aveva sempre animato e sostenuto la ricerca di
Agostino, dalla lettura dell’Hortensius fino alla scoperta, nell’incontro con il neoplatonismo, della
natura spirituale di Dio e della non sostanzialita’ del male, e lo aveva portato a riconoscere
nell’amor et studium sapientiae l’attivita’ piu’ propria dell’uomo e, per cosi’ dire, il luogo ov’egli
ritrova se stesso e il giusto valore di tutte le cose (“est vera et inconcussa nostra habitatio”).
Divenuto cristiano, Agostino non abbandona la filosofia ma, secondo una tendenza generalmente
condivisa dai cristiani d’Occidente nei primi secoli, eccetto che dagli asceti, cerca di conciliare la
nuova religione con la filosofia del tempo. In questo senso egli vede nel platonismo una filosofia
molto vicina al cristianesimo, tale che, secondo le note parole, paucis mutatis verbis atque sententiis
avrebbe potuto ben funzionare come struttura di pensiero adatta ad esprimerne il contenuto.
Pertanto la filosofia platonica e’ accettata come una filosofia vera, per le molte verita’ che contiene;
Tuttavia essa non e’ ancora la vera filosofia.
In genere Agostino individua la non verita’ della filosofia in due motivi fondamentali, neppur tanto
connessi al contenuto delle dottrine professate. Il primo e’ dato dall’accettazione e dalla pratica di
una credenza religiosa diversa dalla convinzione filosofica.Nel mondo greco la religione era unica
per tutti, eppure esistevano differenti scuole filosofiche; pertanto, se in privato si esprimevano
convinzioni in contrasto fra di loro e in pubblico un’unica e comune credenza, allora tutte le
dottrine filosofiche, eccetto caso mai una, erano in conflitto con la religione e, dunque, chi le
professava era costretto ad accettare, praticamente e anche concettualmente, due strade e due
concezioni diverse. Ora, proprio questo dualismo e’ la prova della non verita’ di quelle filosofie.
Non solo per l’evidente motivo della critica, perche’ l’ammissione di “diverse vie” rende
problematica la conoscenza della verita’ e mette in dubbio la verita’ stessa della filosofia.
La questione non era nuova ed era gia’ stata affrontata nella polemica fra Ambrogio e Simmaco.
Questi, sostenendo l’impossibilita’ di un unicum iter per raggiungere la verita’, era arrivato quasi a
negare l’utilita’ di cercarla, e si era sentito rispondere dal Vescovo di Milano che la rivelazione
cristiana e’ la via della certezza e della conoscenza. Agostino, consapevole della derivazione
porfiriana del problema, lo tratta nell’ambito della discussione sulla via universalis, collegandolo
strettamente al tema della verissima philosophia.
Porfirio, nel De regresso animae, come Agostino riferisce nel De civitate Dei, aveva sostenuto che
c'e’ nella piu’ vera filosofia , ne’ nelle usanze e negli insegnamenti religiosi degli Indiani o dei
Caldei poteva trovarsi la via universale, ossia valida per tutti, per la liberazione dell’anima. Cio’
dicendo, commenta Agostino, egli ammetteva l’esistenza di questa via, ma non sapeva ancora dove
fosse. Inoltre affermando che essa non si trovava nella verissima philosophia, commetteva un
grande errore; come poteva, infatti, essere considerata verissima una filosofia che non conteneva la
via . Di conseguenza, una filosofia puo’ essere considerata e definita vera solo in quanto
rappresenta o contiene la via universale, dunque unica, per la salvezza dell’uomo. In tal modo
Agostino congiunge l’origine della filosofia, che, come aveva appreso dall’Hortensius, sorge per
cercare la felicita’, con l’effettiva possibilita’ di realizzarla.
Ma non era proprio su questo punto che tutta la filosofia aveva fino ad allora falliti? E come poteva
un sapere dell’uomo, come la filosofia, pretendere di diventare una via certa e sicura per tutto
genere umano? Fino al momento della conversione, quest’ultimo interrogativo aveva continuamente
messo alla prova l’intelligenza di Agostino; dopo, esso trova una soluzione nella progressiva
enificazione dell’elemento filosofico con quello religioso, che gia’ si trova, pur in modo parziale e
con qualche incertezza, negli scritti di Cassiciaco, e che per raggiungere il suo vertice nel De vera
religione, ove l’identita’ fra vera philosophia e vera religio trova la sua formulazione piu’ completa
e matura.
L’espressione “vera filosofia”, che Agostino prende quasi sicuramente da Porfirio, si trova due
volte nel Contra Academicos; con essa non si intende la filosofia di una singola scuola, ma quella
che si e’ formata, nel corso dei secoli e attraverso molte dispute, dall’insieme di dottrine diverse, e
che ha per oggetto il mondo intelligibile e la cura dell’anima. Tale filosofia, pero’, ha da sola poca
efficacia e raggiungerebbe pochissimi uomini, se non fosse unita a quell’”autorità dell’intelletto
divino nel corpo umano” che ha la forza di richiamare alla verita’ tutto il genere umano. L’apertura
alla religione e l’utilita’ che da questa puo’ provenire alla filosofia sono sottolineate anche nel De
ordine, dove Agostino specifica che se il compito della vera filosofia e’ fare conoscere il principio
di tutte le cose, la fede cristiana permette a tutti i popoli di riconoscerlo e accettarlo come Dio
onnipotente e trino.
Un’affermazione di tenore diverso si ha, invece, nei Soliloqui, quando, a proposito della sapienza,
Agostino dice che non esiste un’unica via per raggiungerla. Questa frase e’ stata a volte interpretata
come una smentita della posizione che Agostino aveva in precedenza esposto; tuttavia il contesto
nel quale e’ posta suggerirebbe di non interpretarla come una negazione della via universalis, ma
solo come l’ammissione di differenti cammini personali, adeguati alle esigenze di qualcuno, per
raggiungere la salvezza. E’ questo d’altronde, il senso che Agostino, nelle Retractiones sostiene di
avere dato alla frase; egli dunque la ritratta solo perche’ suon a ambigua e potrebbe dare adito a
fraintendimenti, non certo per il contenuto, che egli condivide ancora, intendendo per vie quelle di
cui parla il Salmo 24. Nei primi scritti, dunque, la problematica filosofica e’ vista in stretta
relazione con quella religiosa; tuttavia la mancanza di una trattazione esplicita sembra non conferire
solide basi a questo rapporto, e le due prospettive, per quanto convergenti, sembrano ancora
conservare una loro autonomia.
E’ solo nel De vera religione che l’unificazione fra vera filosofia e vera religione si compie.
La locuzione vera religio, che era gia’ conosciuta dai Padri latini, come ad esempio Tertulliano e
Lattanzio, e’ usata per la prima volta da Agostino nel De quantitate animae. Con essa egli intende la
religione che riconcilia l’uomo con Dio e che, unica nel suo genere e diversamente da qualsiasi
filosofia, puo’ rendere ogni uomo capace di questo rinnovato rapporto. Nel De moribus ecclesiae la
vera religione e’ associata al rinnovamento dell’anima e opposta alla superstizione. Tuttavia questi
sono solo accenni, che tra l’altro non riguardano affatto fra filosofia e religione.La trattazione
dell’intera questione si ha dunque, in senso vero e proprio, solo nel De vera religione, ove Agostino
vuole finalmente far conoscere all’amico Romanzano il suo pensiero sulla religione.
Innanzi tutto egli intende per “vera religione” la conoscenza e l’adorazione del vero Dio, la strada
verso la verita’ e la felicita’ (“ad veritatem ac beatitudinem via”) e il mezzo per il rinnovamento e la
restaurazione dell’integrita’ originaria dell’uomo. Questo “legame” con cio’ che puo’ dare dignita’
e valore alla vita e’, per Agostino, un’esigenza connaturata all’uomo: infatti “fra coloro i quali
pensano che non vi e’ nulla da adorare, non vi e’ nessuno che non si sottomesso ai piaceri della
carne o non coltivi un vano potere oppure non perda la testa allettato da qualche spettacolo”.
Ciascun uomo, dunque, dipende da qualcosa; ma non ogni dipendenza rende l’uomo libero, anzi
spesso gli uomini, sbagliano il rapporto di dipendenza, cadono nella superstizione e nell’idolatria.
Agostino e’ consapevole che anche nella religione si puo’ commettere un errore di questo genere,
come quando si e’ indotti a venerare “un’anima o un corpo o le sue immaginazioni”.
Percio’ il problema della vera religione e’ strettamente connesso alla scelta del dio da adorare,
giacche’ solo “tendendo….all’unico Dio e legando a lui solo le nostre anime…ci teniamo lontani da
ogni superstizione”. Ora, questo Dio, che rende l’uomo libero, altro non e’, sostiene Agostino, che
Colui che ha fatto tutte le cose e che, percio’, e’ la verita’ di tutto. Quella stessa verita’ che sta alla
base di ogni essere e che e’ l’oggetto di ogni conoscenza.
Questo e’ il punto di unione della religione con la filosofia:tutte e due si rivolgono alla stessa realta’
e la fanno conoscere, cosi’ che l’uomo possa conformarsi ad essa e essere rinnovato. Qui sta
l’inizio, dice Agostino, della salvezza umana, nel credere e nell’affermare che la filosofia e la
religione non sono due cose diverse.
Questa convinzione non venne mai abbandonata da Agostino, anzi, nelle successive opere, fu
spesso ribadita e ulteriormente specificata. Cosi’, ad esempio, nel De utilitate credenti, la vera
religione viene fatta coincidere con l’acquisizione della sapienza da parte dell’anima. Nell’Epistola
102 viene comparata “vera sapienza” e messa in alternativa alla superstizione. Nel Contra
Gaudentium viene difesa contro la presunta verita’ degli eretici. Nel De civitate Dei e’ considerata
il vero culto di Dio, lontanissima da qualsiasi adorazione del mondo, opposta alla superstizione e,
nello stesso tempo, atta a rivelare ogni forma di idolatria. Essa non e’ una religione creata dallo
stato e istituita dalla citta’ terrena, ma e’ cio’ su cui si istituisce la citta’ celeste. Il suo fine e’
liberare l’anima, ossia consentire all’uomo di ricongiungersi alla vera origine e realizzarsi
pienamente; ed essa stessa e’ la strada che tutti possono percorrere per raggiungerlo. Come,
appunto, dovrebbe essere anche la vera filosofia.
Ma qual’e’ la religione che risponde a tutte queste caratteristiche, si da essere a buon diritto
considerata vera? Agostino non ha evidentemente dubbi: l’unica vera religione e’ quella cristiana.
Nel De vera religione cio’ e’ detto chiaramente quando, dopo avere a lungo trattato della religione
vera e perfetta, Agostino conclude che “essa e, nei nostri tempi, la religione cristiana”, e che
“conoscerla e seguirla e’ la salvezza piu’ sicura e certa”. La stessa convinzione viene espressa nel
De civitate Dei, ove si dice che la religione cristiana “e’ una religione salutare e vera”, e nelle
Retractationes, ove si parla della “religione cristiana, che e’ la vera religione”.
Cio’ che spiega queste affermazioni e’, per Agostino, la diversita’ stessa che il cristianesimo
rappresenta rispetto a tutte le altre forme religiose; esso infatti non sorge per iniziativa umana, ma
scaturisce dall’azione di Dio, che si e’ preso cura dell’uomo fino a divenire Lui stesso uomo. Il
centro del cristianesimo e Cristo; non un uomo o di eccezionali virtu’ e intelligenza, come anche
Agostino aveva un tempo creduto, ma il sorprendente evento della divinita’ che, abbassandosi fino
alla “carne”, muta ontologicamente la natura umana, riportandola all’integrita’ originaria. In Cristo
si compie una traiettoria della storia umana, quella iniziata da Adamo, e da lui inizia una nuova
storia, quella dell’uomo nuovo, che vive, pensa e agisce non piu’ a partire da se stesso, ossia dalla
sua natura decaduta, ma dalla grazia o “cura”che ha ricevuto. Questa cura e’, tra l’altro, l’unico
motivo per interessarsi alla religione; infatti, “se la provvidenza divina non governa le vicende
umane, non vale la pena di agitarsi per la religione”. Ma se invece, le regge, allora non si puo’ non
tenerne conto e bisogna riconoscere nel Dio che si e’ fatto uomo la suprema autorita’ e la via unica
da seguire.
Nel bellissimo capitolo terzo del De vera religione, Agostino immagina un dialogo tra Platone e un
suo discepolo; alla fine della lezione, questi chiede al maestro se esista un uomo capace di far
conoscere a tutti gli uomini le verita’ che ha appreso, e Platone risponde che quest’uomo non esiste,
perche’ dovrebbe essere investito e formato dalla sapienza e potenza stessa di Dio…si e’ degnata di
assumere totalmente l’uomo”. Egli e’ la verita’, la ragione di tutte le cose, il Principio che da’ unita’
a tutto.Si puo’ forse dubitare, dice Agostino a Dioscoro nell’Epistola CXVIII, che il modo migliore
per mettere in rapporto gli uomini con la verita’ sia quello di dare a loro un uomo che in modo
mirabile e ineffabile, e’ stato assunto dalla verita’ stessa? Percio’ Cristo, che e’ l’unico centro della
vera religione ed e’ il senso vero di tutte le Scritture, e’ anche il centro della filosofia, che a Lui
deve rivolgersi, come studium sapientiae, e da Lui deve trarre la forza per diffondersi nel mondo.
Si spiega cosi’ perche’ Agostino giunga persino a parlare di una philosophia Christiana, che e’ vera
e non meno valida di quella dei “pagani”. Ma soprattutto si capisce perche’ egli veda compiersi
proprio nel cristianesimo quell’unita’ di filosofia e religione, che egli aveva individuato come il
principale elemento della sanita’ intellettuale e morale dell’uomo. Se un tempo Agostino aveva
visto nella filosofia l’oggetto principale dei suoi interessi e della sua stessa affermazione, perché
essa “e’ più bella di Tisbe e di Priamo, di Venere e Cupido e di simili amori”, ora egli vede
compiersi questo desiderio proprio nella verità cristiana, “che e’ incomparabilmente più bella
dell’Elena dei Greci e per la quale i nostri martiri hanno lottato contro il male con molto più vigore
di quanto quegli eroi abbiano fatto contro Troia per quella donna”.