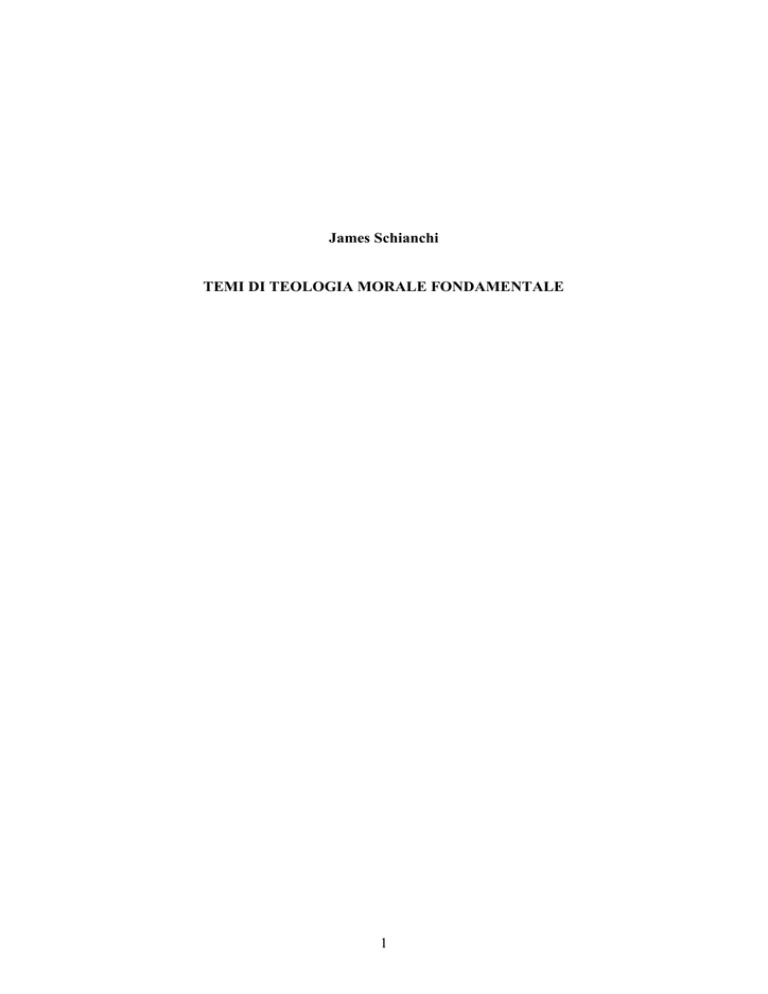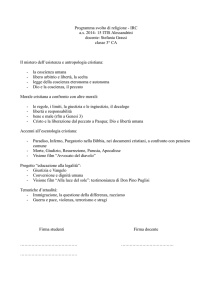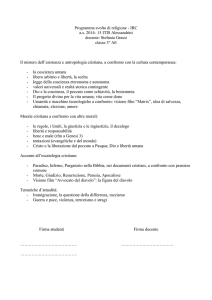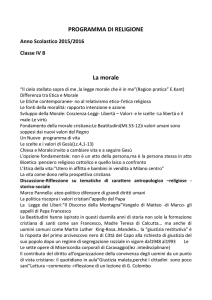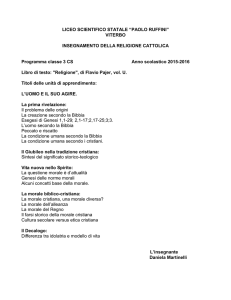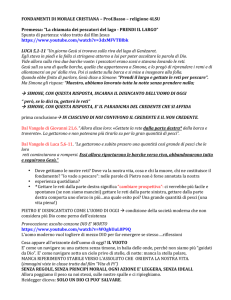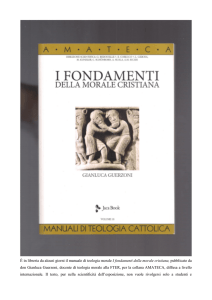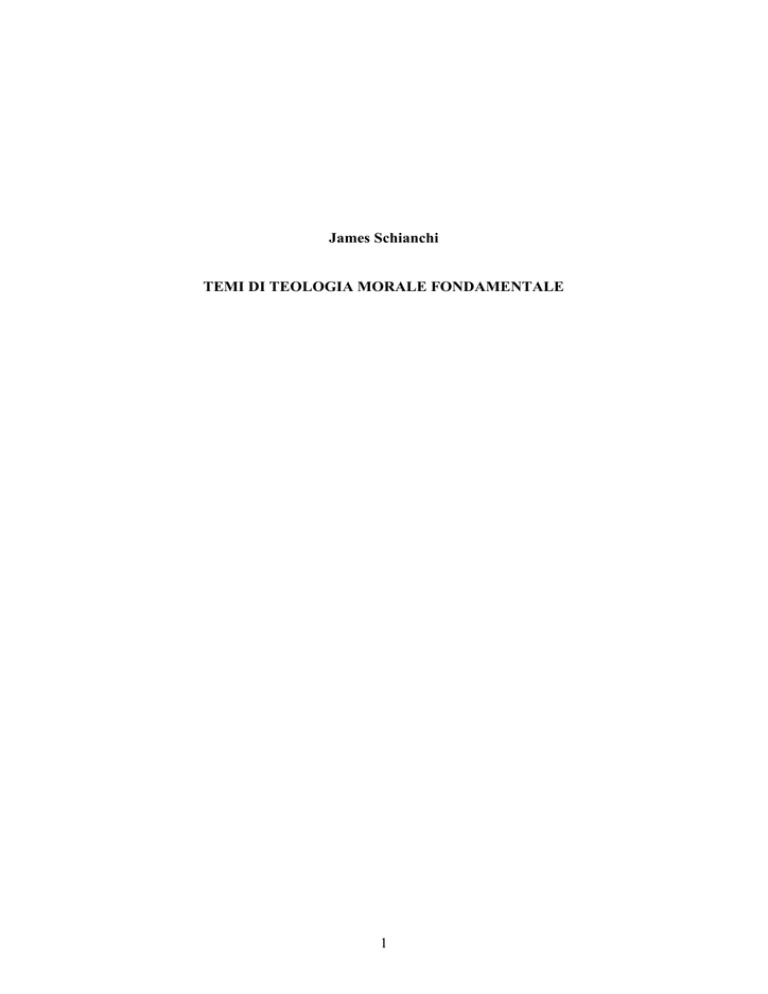
James Schianchi
TEMI DI TEOLOGIA MORALE FONDAMENTALE
1
Capitolo I
L'EVENTO PASQUALE GARANZIA E NORMA DELL'AGIRE CRISTIANO
Il cristiano, dal punto di vista morale, è colui che orienta le sue scelte di vita in conseguenza della
fede in Gesù, il Cristo. Tale fede ha come contenuto irrinunciabile, prima della dottrina del maestro
Gesù, il fatto che egli, condannato e crocifisso sotto Ponzio Pilato, è stato resuscitato da Dio e posto
nella condizione gloriosa di Salvatore del mondo.
Ci confermano in questa posizione le sintesi della fede riportate nel Nuovo Testamento, che hanno
carattere di vicinanza alle origini e tramandano spesso la catechesi primitiva, cioè la testimonianza
dei protagonisti diretti della Pasqua di Gesù. Spesso esprimono la predicazione orale che ha
preceduto la sistemazione scritta dei Libri neotestamentari.
Alcune a modo d'esempio:
- Rom. 10, 9: "Se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore e crederai con il tuo cuore
che Dio lo ha resuscitato dai morti, sarai salvo" (cfr. anche 1 Cor. 15, 3-5).
-
Atti 2, 36: "Sappia dunque con certezza tutta la casa d'Israele che Dio ha costituito Signore e
Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso…".
Esiste poi un testo primario per la fondazione della teologia morale secondo l'ispirazione paolina; è
Fil. 2, 5-11. Ci sono tre passaggi chiave:
-
"Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù: "Gesù è modello di vita morale;
"...facendosi obbediente fino alla morte...": la sua "opzione fondamentale" in quanto persona
umana è l'abbandono filiale in Dio Padre;
- "Per questo Dio lo ha esaltato...": la croce non ha solo preceduto temporalmente la resurrezione
e la glorificazione di Gesù, ma ne è stata la causa. Cioè "Gesù Cristo è il Signore", perché è
stato crocifisso per libera obbedienza al progetto del Padre.
Sulla scorta di questo testo magistrale approfondiamo la struttura di un’esistenza morale ispirata
alla Pasqua.
Tre tesi teologiche reggono il discorso:
1. la Pasqua è fondamento del vivere morale cristiano;
2. la Pasqua è modello di prassi cristiana;
3. la Pasqua è comunicata al battezzato nello Spirito Santo.
1. La Pasqua di Gesù garantisce la validità della proposta morale cristiana
Credere nella Pasqua di Cristo significa avere fede che in quella esperienza di Gesù di Nazareth si è
prodotto un evento unico per la storia umana: un uomo, Gesù figlio di Maria, ha realizzato tutte le
sue aspirazioni esistenziali; ha raggiunto la pienezza della vita perché si è unito a Dio, fonte della
vita, in modo perfetto ed irreversibile. Noi apparteniamo a Dio in quanto creature; infatti separate
da Lui non esisteremmo. Ma Gesù si trova, con la sua umanità nella gloria di Dio; in quella
condizione cioè che ha superato positivamente la morte, senza che questa annientasse la sua identità
personale. I racconti delle apparizioni del Risorto ai suoi si caratterizzano infatti per questi due dati:
2
-
Gesù è in una condizione straordinaria, trasfigurata. Non è legato alle leggi spazio-temporali,
ma non è un fantasma: ha una sua corporeità, al punto che può mangiare con i discepoli e dire
loro "Toccatemi!" (Lc. 24, 36-43).
- ha conservato la sua identità personale, è il medesimo che è stato crocifisso, come ci comprova
l'apparizione a Tommaso (cfr. Gv. 20, 26-29).
In Lui è cambiata la condizione dell'uomo nel mondo. L'evento della sua resurrezione ha segnato
l'inizio di uno status nuovo per l'umanità: lo stato di uomo-risorto. Non c'è alcuna somiglianza con
la condizione di chi è tornato in vita , alla maniera di Lazzaro o altri personaggi resuscitati da Gesù
o da Pietro. Per Gesù si tratta di una condizione nuova, non riconducibile ad altre esperienze umane:
è il passaggio alla comunione piena con Dio nello Spirito Santo, come aveva anticipato agli apostoli
la sua trasfigurazione. Con il Risorto, in altre parole, si è realizzato nel mondo un fenomeno
totalmente nuovo, che coinvolge le relazioni tra Dio e l'umanità. E' un salto qualitativo della
condizione degli uomini nel mistero della creazione.
Si tratta di un evento paragonabile all'apparire sulla terra della vita e poi della intelligenza nell'homo
sapiens (cfr. i concetti di biosfera, noosfera e cristosfera di Teillhard de Chardin).
La Pasqua pertanto ci garantisce con la forza che hanno i fatti accaduti che l'impegno di aderire ai
valori evangelici non è esposto al fallimento della morte, ma ha la possibilità di farci pervenire alla
condizione indicibile, ma certa, di Gesù risorto e glorificato.
Solo la resurrezione di Gesù è risposta adeguata all'obiezione (degli epicurei, pragmatisti, ecc.) che
la dottrina morale è sì necessaria per regolare i comportamenti individuali e collettivi, al fine di non
aggravare l'esistenza, ma non può mutare sostanzialmente la condizione umana sulla terra: sarebbe
un'aspirazione illusoria. La morale cristiana invece raccoglie proprio questa sfida prometeica. Fatta
propria anche da altre dottrine morali (di origine religiosa o ideologica, come i progetti delle
rivoluzioni sociali), rimane in quei sistemi un'utopia, cioè un ideale, un progetto futuro, la cui unica
garanzia è data dalla capacità e dalla volontà dei suoi aderenti. Nel cristianesimo invece la proposta
di vita morale che deriva dalla fede pasquale ha la credibilità che proviene da un evento accaduto,
sia pure recepito per quel tipo di conoscenza chiaroscurale, cioè meta-razionale ma non irrazionale,
che è la fede.
2. La Pasqua è modello obbligato di Morale cristiana
Gesù non è una fra le possibili vie della salvezza, ma l'unica voluta da Dio. La sua esperienza
pasquale, che lo ha condotto alla resurrezione mediante l’obbedienza della croce, è l'unica che
permetta all'uomo di realizzarsi, cioè di salvarsi dalla sconfitta della morte.
E' questo un dato che appartiene strettamente alla fede, come provano i testi della S. Scrittura, di cui
cito alcuni a modo di esempio:
- "Uno solo è Dio e uno solo il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Gesù Cristo...” (I Tim.
2,5);
- "Per un uomo solo venne la morte, per uno solo la vita" (Rom. 5, 12);
- "Io sono la via, la verità, la vita ... Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me" (Giov. 14,
6).
E' sintomatico che Gesù sia l'unico fondatore religioso ad esigere di credere nella sua persona. Si
presenta come mandato dal Padre, ma anche come uguale a Dio.
Se riconosciamo che Gesù di Nazareth, glorificato per la Pasqua, è l'uomo nuovo che la morale
cerca di costruire nei battezzati, ne consegue che gli atteggiamenti che gli hanno permesso di
raggiungere quel traguardo esistenziale diventano obbliganti, moralmente normativi. La sua vita
3
morale diventa la ricerca etica del cristiano che si fa discepolo mediante la relazione di fede con
Lui.
Ora negli avvenimenti della sua Pasqua Gesù rivela in modo pieno la sua personalità umana
profonda, manifesta l'orientamento ultimo della sua esistenza come uomo. Ebbene risulta che Gesù
ha impostato il suo vivere umano come un rapporto di figlio verso Dio, conosciuto come Padre, in
una obbedienza senza riserva, disponibile al dono di sé, compresa la vita, mediante l'ignominia della
croce. Ci sostiene in questa tesi soprattutto il testo di Ebrei 5, 7-10.
L'obbedienza della croce è il punto culminante di un'esistenza tutta impostata nella scelta (opzione
fondamentale) di vivere da Figlio.
Non ignoriamo che l'orientamento etico di Gesù, visto come persona storica, si inserisce
nell'orizzonte dogmatico del mistero dell'Incarnazione nel quale si realizza l'annientamento del
Figlio per compiere il progetto del Padre di salvare l'uomo mediante la misericordia. E' il mistero
dell'annientamento (kénosis) di Dio nel suo Verbo, che adombra Filippesi 2, 7-8: "Cristo, pur
essendo di natura divina, ... divenendo simile agli uomini; apparso in forma umana ... umiliò se
stesso..." (cfr. anche Gv. 1, 1; 2 Cor. 8, 9; Rom. 8, 3).
Ma agli effetti di motivare il discorso morale cristiano ci basta guardare a Lui come il Salvatore, che
è pervenuto alla condizione di risorto in forza dell'obbedienza della croce. Con questo non si ignora
che Gesù è personalità teandrica, cioè uomo-Dio, e che le due nature, umana e divina, sono unite
nell'unico Io personale di Lui Cristo Signore.
Confermiamo con il richiamo ad alcuni testi scritturistici la tesi che Gesù ha impostato la sua
personalità etica nell'atteggiamento fondamentale di figlio in relazione a Dio:
- Lc. 2, 41 segg. "Non sapevate che io devo attendere alle cose del Padre mio?" E' una frase molto
rivelativa, perché espressa nella fase adolescenziale di Gesù, quando nell’evoluzione dell'uomo
si pongono le basi della personalità matura.
-
Lc. 4, 1 segg. Il racconto della tentazione del deserto, posto dai Sinottici all'inizio della
manifestazione messianica di Gesù, dice quale tipo di Messia Gesù intendeva essere. Tra i
diversi tipi presenti nell'attesa del popolo d'Israele al suo tempo (zeloti, esseni, ecc.) Gesù
sceglie la figura di Messia sofferente, che si fa carico del peccato del popolo e rimette a Dio la
sua causa. E' il tipo di Messia prefigurato da Isaia nei suoi quattro carmi del "Servo di Jahvè",
che hanno il loro vertice nel cap. 53. Notiamo che l'esperienza della tentazione nel deserto segue
l'infusione dello Spirito al Giordano, quando Gesù riceve l'investitura messianica ed è
proclamato dal cielo "Figlio diletto". Sembra quindi la risposta umana di Gesù alla chiamata
rivoltagli dal Padre.
-
Lc. 18, 31. La decisione di 'salire' a Gerusalemme, pur consapevole dei rischi che comportava
(cfr. Gv. 11, 7), era motivata dalla intenzione di fare la volontà del Padre; decisione rinnovata in
modo drammatico al Getzemani.
-
Gv. 4, 34. Tutta l'opera pubblica , la predicazione e i segni miracolosi, è vissuta con la coscienza
di “fare l'opera del Padre”, cioè iniziare il suo regno (cfr. anche Gv. 10, 25. 32. 37. 39).
-
Lc. 22, 42. Rivolgendosi a Dio Gesù usa un appellativo preso dal linguaggio familiare, che è
riconosciuto come tipico del Gesù storico, appartenente alle sue "ipsissima verba", e che se non
era proprio scandaloso per un pio giudeo, certo era inusuale: il termine "Abba".
4
Questa concezione dell'esistenza umana, propria di Gesù, ha un valore rivoluzionario sul piano
etico: è l'atteggiamento del cuore che la Rivelazione riconosce opposto a quello del peccatore. Alla
radice del peccato umano sta la diffidenza, il rifiuto della paternità di Dio. Il primo uomo, che
permane in noi con la sua mentalità, vede Dio come concorrente alla propria libertà ed è spinto
all'autosufficienza nell'organizzazione della propria vita. Il peccato di Adamo (l'uomo) più che
disubbidienza è sfiducia secondo Gen. 3, 4-5; è cedere alla tentazione del serpente: "Dio sa che se
ne mangerete diverrete simili a Lui".
Gesù invece, nell'impostare la sua vita, si pone nella linea dell'alleanza di Abramo, colui che vive
con Dio l'unico rapporto adeguato all'uomo, la fede. In tal senso Gesù è l'anti-adamo, l'uomo nuovo
(Rom. 5, 12-19).
Le applicazioni morali di questo fondamento di fede sono rilevanti. Di fronte ai problemi etici che
deve affrontare, come risposta ai molti interrogativi circa gli obblighi derivanti dalla fede scelta, il
cristiano segue questo unico criterio di verità, questa chiave interpretativa dei suoi doveri: la
volontà di Dio, accolta come quella di un Padre, così come è possibile conoscerla. Obbedire a Dio,
come ha fatto Gesù, fino alla rinuncia della vita, è l'intenzione ultima, che guida il cristiano nelle
scelte morali non sempre chiare né facili.
3. La Pasqua è esperienza partecipata al battezzato nello Spirito Santo.
La fondazione della morale in chiave cristiana esige che si chiarisca il rapporto che secondo il
Nuovo Testamento intercorre tra Gesù e i discepoli, tra Lui glorificato e la comunità che nel tempo
lo riconosce e confessa Cristo di Dio, salvatore dell'uomo.
Affermare infatti che Gesù risorto è modello di vita realizzata in pienezza e che dobbiamo imitarlo
nel fare dell'amore obbediente a Dio Padre il criterio morale di tutta l'esistenza, può risultare
un'affermazione eretica, cioè parziale rispetto al patrimonio autentico della fede. Non significa
soltanto che Gesù ci ha dato l'esempio, e noi dobbiamo seguirlo. Se così fosse egli sarebbe un
maestro, non il salvatore dell'umanità. Tra Lui, "salito nella gloria del Padre" e la comunità dei suoi
discepoli ci sarebbe una continuità dottrinale, un vincolo cioè garantito solo dal suo insegnamento.
Invece la relazione tra il Cristo e la sua Chiesa è realizzata dallo Spirito Santo, che è Spirito del
Padre, ma mandato dal Figlio, del quale prolunga l'opera nel tempo, che dalla Pasqua diventa storia
di salvezza.
Le due tradizioni neotestamentarie, quella giovannea e quella paolina, sono concordi
nell'annunciare questo punto cardine della fede cristiana, che ne costituisce anche un carattere
originario rispetto ad altri messaggi religiosi, soprattutto per l'aspetto etico.
Riporto alcuni testi esemplari:
1. Dal Vangelo di Giovanni 16, 7-15; 14, 16-20. 23. 26. Il paragone poi istituito da Gesù della vite
e dei tralci, per significare la natura del rapporto che intercorrerà tra Lui e i suoi nella
condizione nuova a cui lo condurrà la Pasqua (Gv. 15, 4-8), diventa pienamente comprensibile
solo in riferimento allo Spirito che è la vita in senso proprio di Lui, Verbo fatto carne.
2. Dell'epistolario paolino è emblematica l'affermazione di 1 Cor. 12, 3: "... Nessuno può dire
‘Gesù è il Signore’ se non sotto l'azione dello Spirito". La comunione a Cristo avviene mediante
l'atto di fede che lo riconosce “kurios” = Signore e Salvatore. Professare tale fede che salva è
possibile solo nello Spirito Santo, come sostiene Paolo. Quindi è l'azione dello Spirito Santo che
permette l'incontro tra il Risorto e i credenti in Lui: e tale azione conduce il battezzato a
configurarsi con l'umanità del Risorto (Ef. 4, 13). La volontà di Dio Padre infatti è che i credenti
5
in Cristo condividano la sua esperienza pasquale (Rom. 8, 29-30), affinché dove è Cristo, nella
gloria del Padre, là siano i suoi (Giov. 17, 24).
L'apostolo Paolo esprime il medesimo concetto con due immagini eloquenti:
- il battezzato è detto "tempio dello Spirito Santo" (1 Cor. 6, 19) e ciò va inteso nella sua
corporeità, non solo nella sua anima (Fil. 3, 21);
- egli è membro del corpo di cui Cristo è il capo (1 Cor. 12, 27; cfr. anche Ef. 5, 30 e Col. 1, 24;
2, 19).
In Rom. 6, 2b-11 si attesta in modo esplicito ed organico che il battesimo comporta per il discepolo
di rivivere la medesima esperienza di morte che conduce alla vita nello Spirito, che Gesù fece nella
sua Morte-Resurrezione (cfr. Ef. 2, 4-7).
Tommaso d'Aquino esprime con profondità questa verità di fede, quando scrive nella Summa
Teologica: "Ciò che è specifico nella legge del Nuovo Testamento (potremmo tradurre "nella
morale cristiana") e in cui consiste tutta la sua forza, è la grazia dello Spirito Santo che è data per la
fede in Cristo; perciò la legge nuova è la stessa grazia dello Spirito Santo, che si dà ai cristiani"
(I, II q. 106, a. I). La legge che guida il comportamento del cristiano è per il grande teologo
'indita', cioè iscritta nel cuore, così che lo Spirito è la vera guida, il maestro interiore che plasma la
personalità a immagine dell'uomo nuovo, Gesù il Signore.
L'azione dello Spirito si manifesta sostanzialmente nei tre atteggiamenti morali, che la tradizione
cristiana chiama "virtù teologali": fede - speranza –carità (Gal. 5, 5-6).
La fede costruisce una relazione di fiducia tra Dio e il battezzato, di cui Cristo è mediatore, nel
senso che mediante l'umanità risorta di Gesù noi conosciamo Dio e il suo amore per l'uomo. Tale
fiducia ha il suo modello nel rapporto filiale con Dio Padre proprio di Gesù, che porta a perfezione
la fede di Abramo, l'unica modalità di un rapporto adeguato che l'uomo può avere con la Divinità.
Paolo e Giovanni ricorrono al concetto di "adozione" per esprimere la condizione in cui viene a
trovarsi il battezzato. Ovviamente il riferimento è a Gesù Cristo, Figlio generato dall’eternità
(cfr. Gv. 1, 12-13; 1 Gv. 3, 1-2; Rom. 8, 12-17; Gal. 4, 5).
La fede fiduciale (che nasce cioè dall'amore e non dal timore) ci fa accogliere le promesse di Dio;
ci fa riconoscere che egli è fedele e porta a compimento l'opera di riunire in Cristo ogni cosa
(Ef. 1, 10). Perciò la fede si prolunga nella speranza, nell'attesa della salvezza piena che già
possediamo in modo incipiente (cfr. I Gv. 3, 2).
La fede-speranza suscita un atteggiamento d'amore, perché ci sappiamo amati da Dio, che ci chiama
alla comunione con Lui, e quindi siamo portati ad amarlo come vertice delle nostre aspirazioni.
Se la fede-speranza conducono alla carità, esse sono da questa rafforzate, perché è più profonda la
fiducia in colui che si ama ed è più forte la speranza nell'amato; perciò nel Nuovo Testamento
troviamo che frutto della salvezza è la carità (1 Cor. 13; 1 Gv. 4).
La carità non solo rafforza la fede-speranza, ma le verifica nella loro autenticità, perché siano non
dei puri sentimenti, ma dei veri orientamenti morali. Lo Spirito infatti rinnova l'uomo nella sua
totalità di soggetto capace di pensiero e di azione. E' quindi la carità vissuta che vaglia la fedesperanza; il giudizio globale sulla nostra vita sarà fatto circa la carità (cfr. Giac. 2, 14; Matt. 25, 31
segg).
Mediante la vita morale, quindi, possiamo verificare la nostra docilità all'azione dello Spirito Santo
in noi, così come Gesù dimostrò di essere "mosso dallo Spirito" perché fu obbediente a Dio Padre
fino alla morte.
6
Capitolo II
LA COSCIENZA
Il termine coscienza raccoglie diversi significati; due sono dominanti nelle lingue di origine latina:
- essere coscienti, rendersi conto: è l'esperienza che viene attribuita alla coscienza psicologica;
- essere responsabili: tale aspetto viene detto coscienza morale. Questa aggiunge alla
consapevolezza che il soggetto percepisce l'aspetto dell'impegno e della valutazione. In forza
della sua coscienza morale la persona dà un giudizio di valore alle sue azioni, ovviamente in
dipendenza a quell'ordine di valori, a quella opzione fondamentale che essa ha scelto nel
costituirsi della sua personalità etica e che racchiude il progetto della sua esistenza.
Qui studieremo la coscienza in quanto guida della vita morale orientata dalla fede cristiana. Perciò
attingeremo alla Sacra Scrittura, al Magistero e alla tradizione teologica.
1. Dalla Sacra Scrittura
La Rivelazione cristiana ci dice che lo Spirito Santo trasforma nel battezzato questa capacità di
discernimento morale, sostenendola perché lo possa guidare a vivere la volontà che Dio Padre ha su
di lui personalmente. Il testo di Fil. 1, 9-11 è fonte autorevole per questa verità: "Prego che la vostra
carità si arricchisca sempre più in conoscenza e in ogni genere di discernimento, perché possiate
distinguere sempre il meglio ed essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di quei
frutti di giustizia che si ottengono per mezzo di Gesù Cristo, a lode e gloria di Dio" (cfr. Col. 2, 2
ed Ef. 1, 17-19).
La teologia paolina raccoglie su questo punto il pensiero dei profeti dell'Antico Testamento, che
richiamavano come Dio attende dall'uomo una fedeltà che emerga dal profondo del cuore e che è
l'intenzione del cuore a definire il valore degli atti umani (cfr. Isaia 29, 12-16; Ezech. 36, 25-27).
In due passi del suo epistolario Paolo afferma che la fede fa sorgere in noi un criterio pratico di
giudizio per quanto riguarda la salvezza. Si tratta di 1 Cor. 8 e 10, 23-32 e di Rom. 14, 23.
Ambedue i testi si riferiscono al problema pratico, se è lecito ai cristiani mangiare carni immolate
agli idoli. Dal momento che gli dèi sono nulla e che Cristo ci ha liberato da ogni imposizione
donandoci lo Spirito di figli di Dio, sembrava legittimo cibarsi di carni sacrificate. Ma poiché esse
provenivano da un rito idolatra, mangiarne esponeva al peccato di idolatria.
Il problema, dibattuto evidentemente nelle comunità, dà occasione all'apostolo per affermare alcuni
principi sull'autorevolezza della coscienza sul nostro agire pratico:
1. Le nostre azioni non sono valutate solo per il loro contenuto, ma anche per l'intenzione con cui
si compiono: cfr. Rom. 14, 5b. 12. 14b. 22b-23; 1 Cor. 8, 4-6 e 10, 23-24.
2. Dobbiamo seguire la voce della coscienza. Ma bisogna essere attenti alle conseguenze che le
nostre azioni hanno presso il prossimo, perché al di sopra della nostra libertà sta la carità
fraterna: Rom. 14, 1-4. 10.15.20-21; 1 Cor.8, 7-13 e 10-23-24.
3. Il giudizio di Dio è più alto della nostra coscienza, per cui dobbiamo cercare la verità oggettiva
dei nostri comportamenti, cioè quale è la volontà di Dio sulle situazioni della nostra vita. Solo
tale scienza conduce a libertà e opera la nostra salvezza (1 Cor. 4, 4; Rom. 14, 5-9).
7
2. Dal Magistero ecclesiale
Del magistero dei pastori rimane ancora insuperato circa la problematica della coscienza un passo
della costituzione Gaudium et Spes del Vaticano II. Mi limito pertanto a riportare questo testo, che
oltre ad essere autorevole perché espressione di un'assise conciliare, sintetizza quanto di meglio la
riflessione teologica ha maturato sul tema delicato della coscienza morale.
"Nell'intimo della coscienza l'uomo scopre una legge che non è lui a darsi, ma alla quale invece
deve obbedire e la cui voce, che lo chiama sempre ad amare e a fare il bene e a fuggire il male,
quando occorre, chiaramente dice alle orecchie del cuore: fa questo, fuggi quest'altro. L'uomo ha in
realtà una legge scritta da Dio dentro al suo cuore: obbedire ad essa è la dignità stessa dell'uomo, e
secondo questa egli sarà giudicato.
La coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo, dove egli si trova solo con Dio, la cui
voce risuona nell'intimità propria. Tramite la coscienza si fa conoscere in modo mirabile quella
legge, che trova il suo compimento nell'amore di Dio e del prossimo. Nella fedeltà alla coscienza i
cristiani si uniscono agli altri uomini per cercare la verità e per risolvere secondo verità tanti
problemi morali, che sorgono tanto nella vita dei singoli quanto in quella sociale. Quanto più
dunque, prevale la coscienza retta, tanto più le persone e i gruppi sociali si allontanano dal cieco
arbitrio e si sforzano di conformarsi alle norme oggettive della moralità. Tuttavia succede non di
rado che la coscienza sia erronea per ignoranza invincibile, senza che per questo essa perda la sua
dignità. Ma ciò non si può dire quando l'uomo poco si cura di cercare la verità e il bene, e quando
la coscienza diventa quasi cieca in seguito all'abitudine al peccato." (G. S. n. 16).
3. Indicazioni della teologia morale
La teologia morale, in quanto aspetto della ricerca teologica, deve riprendere dal suo punto di vista,
che è quello dell'etica, i dati della Rivelazione divina autorevolmente interpretati dal magistero
ecclesiale. Studiamo alcune questioni che nella tradizione teologica e nel nostro tempo hanno
assunto particolare rilevanza:
A. NATURA E AUTOREVOLEZZA DELLA COSCIENZA PERSONALE
La coscienza è presente nella persona umana come una facoltà, cioè una capacità di discernere il
bene dal male e di agire responsabilmente. Non è legata ad una specifica struttura della personalità,
ma coinvolge contestualmente intelletto e volontà, al punto che qualcuno ha affermato: "L'uomo
non ha la coscienza, ma è coscienza". Dice il Vaticano II sopraccitato: "E' il nucleo segreto e il
sacrario dell'uomo, dove egli si trova solo con Dio, la cui voce risuona nella intimità propria" (G.S.
n. 16). Possiamo definire quindi la coscienza come il luogo della chiamata di Dio e della risposta
dell'uomo, dove si gioca in ultima istanza il valore dell'esistenza.
Tale facoltà si applica agli atti che impegnano la persona, richiedendole un giudizio etico sull'azione
che sta per compiere.
S.Tommaso distingue tra coscienza abituale e coscienza attuale, intendendo la prima come
orientamento fondamentale che il cristiano ha acquistato dalla fede circa la vita morale; per
coscienza attuale intende la capacità di decidere nelle scelte particolari in conformità a quell’
orientamento globale del cuore. Si tratta in realtà di due aspetti strettamente collegati: quanto più la
personalità è decisa per il bene, tanto più sarà capace di sceglierlo nei casi concreti in cui è chiamata
a decidere.
8
Però tale coerenza non è garantita, perché qualche fattore può condurla a decisioni che smentiscono
l'orientamento abituale del soggetto. Per cui per valutare gli atti morali di una persona occorre
considerare tutti e due gli aspetti della coscienza. Un atto negativo sarà meno colpevole in una
persona abitualmente virtuosa; ma l'orientamento generalmente positivo della sua vita non esclude
che in quel singolo atto la coscienza lo abbia smentito deliberatamente e che perciò la decisione sia
colpevole. E' una considerazione che serve a stabilire la gravità dei peccati.
Poiché la coscienza esprime la dignità della persona, come il Creatore l'ha voluta, cioè capace di
intendere e di volere, occorre nell'agire seguire la propria coscienza, altrimenti l'agire dell'uomo non
sarebbe morale.
I medioevali lo definivano “actus hominis non actus humanus”, cioè tale che non coinvolge tutta la
sua personalità e quindi la responsabilità. Dio non vuole che l'uomo agisca come un automa, anche
quando fa il bene. Il valore delle sue azioni pertanto, in bene e in male, è legato alla condivisione
della sua coscienza e al giudizio che essa ne dà.
Agire contro l'indicazione della coscienza significa rifiutare quella conoscenza del bene morale che
possediamo in quel momento; di fatto si è disponibili al peccato, cioè a compiere atti non conformi
alla volontà di Dio conosciuta per il suggerimento della coscienza.
Si può dire che il giudizio della coscienza è la norma morale personalizzata, cioè riferita al singolo
con i suoi doni, le sue responsabilità, la sua situazione concreta. La coscienza compie l'ultimo atto
del processo decisionale in cui maturano le scelte morali. Nessuna azione può essere valutata
moralmente se non "in coscienza", perché:
1. E’ attraverso la coscienza che il singolo conosce il valore personale della legge morale, cioè il
contenuto della volontà di Dio, che è rivolto a tutti, ma chiede che ciascuno vi obbedisca
secondo le sue caratteristiche individuali. "Tramite la coscienza si fa conoscere in modo
mirabile quella legge, che trova il suo compimento nell'amore di Dio e del prossimo" (G. S. n.
16).
2. E' dalla voce della coscienza che deriva l'obbligatorietà di un comando morale. Se non è
maturata in coscienza, una decisione è presa per motivazioni che in ultima analisi sono
immorali: paura, tornaconto, conformismo ecc. "L'uomo ha in realtà una legge scritta da Dio
dentro il suo cuore: obbedire ad essa è la dignità stessa dell'uomo, e secondo questa egli sarà
giudicato" (G. S. n. 16).
Tali riflessioni portano a concludere che nessuno può giudicare la moralità di un altro, perché non
può cogliere l'indicazione della sua coscienza. Il Vangelo è esplicito nel richiamare questo
atteggiamento verso il prossimo (cfr. Matt. 7, 1).
Inoltre occorre tendere ad attribuire ai nostri comportamenti lo spessore di decisioni consapevoli,
che provengano dalla profondità della coscienza e non siano superficiali ed abitudinari.
B. CONDIZIONI PER L'AGIRE DELLA COSCIENZA
Sia nel formarsi come facoltà, sia nell'agire volta per volta la coscienza non è autonoma, ma in
relazione. Prima di tutto è in relazione con Dio, perché l'uomo non è assoluto, ma originato, e
pertanto dipendente nell'esistere e nell'agire. "Nell'intimo della coscienza l'uomo scopre una legge
che non è lui a darsi, ma alla quale invece deve obbedire" (G. S. n. 16). Per cui quando la coscienza
si considera fonte assoluta di moralità, legge a sé stessa, è inquinata, non veritiera.
9
Il rapporto con Dio, per scoprire le sua volontà in cui consiste il contenuto della moralità dell'uomo,
si sviluppa nell'accogliere tutte le rivelazioni che Dio ha fatto di se stesso all'umanità e che
costituiscono altrettante mediazioni del suo volere circa l'uomo: dal creato (Rom. 1, 19-20), alla
Scrittura (Matt. 5, 17-19), alla Chiesa in quanto comunità che interpreta, custodita dallo Spirito
Santo, il comandamento di Dio che è la persona di Cristo Gesù (Matt. 10, 40; 18, 17-18).
Specificando ulteriormente, affinché la coscienza meriti la dignità e l'autorevolezza di guidare la
vita morale del cristiano essa deve avere le tre qualifiche:
-
retta = che sia cioè sincera con se stessa, protesa alla ricerca della risposta che deve a Dio e non
disponibile a compromessi di comodo. "Quanto più prevale la coscienza retta, tanto più le
persone e i gruppi sociali si allontanano dal cieco arbitrio e si sforzano di conformarsi alle
norme oggettive della moralità" (G. S. n. 16);
-
vera = nel senso che è d'accordo con la verità oggettiva circa il bene o in ricerca di porvisi. E'
l'opposto della coscienza erronea. Non è facile per la coscienza, anche guidata da retta
intenzione, raggiungere la verità morale. Succede con frequenza che essa è erronea, non per
propria colpa: in tal caso non perde la propria funzione di guida nelle scelte morali e il suo
giudizio errato non è imputabile. Ma, come insegna S.Tommaso, l'errore involontario di
coscienza, rende sì l'azione non colpevole, ma non fa crescere nella carità. Perciò occorre
ricercare continuamente la verità oggettiva circa il bene e non accontentarsi del grado soggettivo
di conoscenza che abbiamo raggiunto circa i problemi morali che ci competono. "Succede non
di rado che la coscienza sia erronea per ignoranza invincibile senza che per questo essa perda la
sua dignità. Ma ciò non si può dire quando l'uomo poco si cura di cercare la verità e il bene, e
quando la coscienza diventa quasi cieca in seguito alla abitudine del peccato" (G. S. n. 16);
-
certa = le decisioni di carattere morale sono di tale importanza che occorre sicurezza circa la
loro conformità al bene. Chi è nel dubbio se un atto è buono o immorale e sceglie senza aver
cercato di risolvere il dubbio, si dimostra indifferente ai valori etici, quindi disponibile a fare il
male.
La certezza circa la verità delle scelte che la coscienza deve fare non può essere sempre assoluta
e perfetta. Deve essere però almeno provvisoria, riferita cioè alla questione impellente circa la
quale occorre prendere la decisione, con la disponibilità a cercare ulteriormente la verità più
sicura.
C. CONFLITTI E PATOLOGIA DELLA COSCIENZA
La condizione di perplessità nel prendere le proprie decisioni etiche è normale; in molte persone è
più frequente di quella sicura e certa, perché con difficoltà l'uomo conosce la verità circa i propri
doveri morali.
I dubbi sono di diversa natura:
- ignoranza sul dovere che obbliga moralmente (dubbio speculativo: ad es. quanto tempo di
digiuno deve trascorrere per accostarsi alla S. Eucaristia?)
- ignoranza circa la situazione che può modificare l'obbligatorietà del dovere (dubbio pratico: ad
es. quanto tempo è trascorso da quando ho preso il caffè e l'inizio della S. Messa?)
- conflitti di doveri, per cui l'assolvimento di uno comporta ineluttabilmente la trasgressione di
un altro; nessuna scelta pertanto sembra immune da colpa. (ad es. debbo andare alla S. Messa
festiva o restare a custodire il figlio ammalato che non è prudente lasciare solo?).
10
Per raggiungere quella condizione di certezza circa la volontà di Dio a riguardo della persona che
deve agire nella situazione concreta (hic et nunc), certezza necessaria perché la coscienza dimostri
l'intenzione di volere il bene morale, possono servire due criteri:
1. Confrontarsi con le fonti di verità che il Signore ha messo a disposizione del popolo di Dio: la
Parola rivelata, il magistero dei pastori, la competenza degli esperti (es. teologi), le ispirazioni
interiori ascoltate con purezza di cuore. Ovviamente quando è possibile e la decisione rinviabile.
2. Scegliere, tra due doveri in contrasto, il "male minore", il che significa aderire al valore
prioritario, cioè al bene possibile in quella specifica condizione del soggetto. Tale atteggiamento
esprime la rettitudine della coscienza, la sua volontà di evitare la colpa che non è mai solo un
atto sbagliato, ma un atteggiamento del cuore che conduce a una determinata azione.
La ricerca del giudizio di coscienza può essere ostacolato da tendenze patologiche. Naturalmente
qui si considerano i casi di carattere teologico-spirituale, non le forme che hanno origine psichica,
anche se la distinzione non è mai netta nel vissuto delle persone.
Possiamo riunire questi casi in due tendenze opposte:
1. Orientamento al perfezionismo
E' ovvio che la vita morale del cristiano deve tendere alla perfezione (cfr. Matt. 5, 48). Ma c'è
sempre uno scarto tra la chiamata divina e la risposta umana. Tale condizione può essere vissuta
con una ricerca eccessiva di sicurezza morale, che può ingenerare egocentrismo spirituale, fiducia
eccessiva nelle proprie forze, scarsa confidenza in Dio e di riflesso scoraggiamento.
Manifestazione particolare di tale tendenza è la coscienza scrupolosa. Molti fattori concorrono a
fare di una persona un soggetto scrupoloso: componenti psichiche della personalità profonda,
educazione religiosa legalista e rigida, ecc. Dal punto di vista etico può avere, in determinata
misura, una funzione positiva, quando scuote la coscienza da una vita spirituale superficiale e
sviluppa il senso di responsabilità. Ma quando la ricerca della perfezione morale è vissuta in modo
esagerato, mortifica la crescita della carità per l'eccessiva preoccupazione di una sicurezza che è
motivata da paura nei confronti di Dio o circa la propria salvezza personale. Si tratta di una
impostazione che, al di là di una apparente serietà morale, non è evangelica, perché trascura di Dio
uno dei capisaldi della rivelazione cristiana, la sua misericordia.
L'aiuto allo scrupoloso può consistere nel ricorso a sussidi psicoterapeutici quando si tratta di stati
gravemente patologici (scrupolosità nevrotica o compulsiva). Normalmente occorre educare al
senso di fiducia in Dio e a una concezione in positivo dell'etica, che è una ricerca del bene
umanamente possibile e non solo assenza ossessiva del male. Si deve anche rettificare il senso
religioso, educando alla consapevolezza della paternità di Dio e purificando lo scrupoloso dal
bisogno di compensazione, latente nella sua ricerca di purità dalla colpa, che è una forma di
narcisismo.
2. Orientamento al lassismo
E' l'atteggiamento di chi non dà importanza alla coerenza tra convinzioni ideali e comportamento di
fatto. Si riscontra nelle persone che hanno scarso senso morale o una fede fragile, inadeguata a
sorreggere gli impegni esistenziali che ne conseguono. La coscienza lassa si manifesta abitualmente
nel giudizio attribuito alla colpa morale, che viene giustificata con facilità, e nello scarso impegno a
vivere i valori e gli ideali morali.
Per guarire la coscienza dal lassismo occorre rimotivare la scelta della fede, come concezione che
investe tutta la personalità e non va ridotta al suo aspetto sociale o rituale. Bisogna provocare quella
conversione del cuore che è il primo passo della esperienza cristiana e favorire la condivisione di
quei valori del Regno di Dio, cui lo Spirito conduce il cuore di chi ha accolto responsabilmente
l'Evangelo.
11
D. COSCIENZA INDIVIDUALE E MAGISTERO ECCLESIALE
La coscienza del cristiano nelle sue decisioni si riferisce sempre a Cristo, vero maestro e guida
dell'umanità. Ora Cristo si incontra in modo privilegiato nella Chiesa, suo mistico corpo, che,
guidata dallo Spirito Santo, annuncia e testimonia la vita morale pienamente umana.
Tra i diversi ruoli e servizi propri delle persone che compongono il popolo di Dio, un'autorità
speciale va riconosciuta a coloro che Gesù ha inviato come apostoli, cioè maestri autentici del
Vangelo e quindi della vita morale. La loro missione non è di trasmettere meccanicamente la
predicazione del Signore, ma di "fare suoi discepoli tutti gli uomini" (Mt. 28, 19). Compito del
Magistero episcopale è di formare i battezzati perché maturino una coscienza retta. Questi allora,
per non seguire una coscienza individualista, non possono ignorare la volontà di Cristo che ha dato
tale autorevole incarico ai Pastori della Chiesa (cfr. Gv. 21, 15 s; Mt. 16, 18). Un retto rapporto con
il Magistero non è l'esecuzione passiva delle direttive della Gerarchia: tale atteggiamento trascura il
dono dello Spirito che, attraverso la coscienza illuminata, ci fa conoscere il bene morale. Però la
contestazione del Magistero, quando è eretta a sistema, rivela una visione della Chiesa non
conforme alla fede: essa infatti non è una società umana, ove l'autorità riceve il proprio mandato
dall'incarico dei suoi membri. Il mandato di "insegnare o guidare", proprio del Magistero
episcopale, si fonda sulla volontà di Cristo ed è garantito dalla Sua promessa di essere con i suoi
discepoli fino alla fine dei tempi.
Certamente il grado di infallibilità del Magistero non è uguale per ogni pronunciamento. Quando
proclama la verità da credere e da praticare in forza dell'autorità data da Cristo, non può errare:
sarebbe vana la parola del Signore che ha promesso assistenza alla Chiesa (Mt. 28, 20). La
coscienza del battezzato non può che accettare per fede. Ma quando si tratta dell'applicazione delle
esigenze evangeliche a situazioni concrete, può nascere contrasto tra il giudizio del Magistero e il
giudizio morale che matura nella coscienza individuale. Naturalmente questa deve meritare tale
nome, non essere solo l'orgogliosa e arbitraria opinione personale.
Tale conflitto in tutti i modi non è normale. Anzi sul piano oggettivo non è possibile, perché sia la
coscienza retta che il Magistero sono guidati dallo Spirito Santo. Quando esso si verifica, come
avviene spesso, o la coscienza non è docile allo Spirito, o l'insegnamento proposto non appartiene
strettamente alla rivelazione, quindi non possiede certezza infallibile. Si aggiunga che la situazione
concreta a cui si deve applicare il comandamento di Dio può essere conosciuta e valutata in modo
opposto dai Vescovi, incaricati dal Magistero, e dalle singole coscienze, in dipendenza delle
capacità, della cultura e delle informazioni rispettivamente possedute.
La coscienza individuale, anche quando è certa del proprio giudizio morale, non può dimenticare
l'incarico che per volontà di Cristo spetta al Magistero della Chiesa. Quindi la persona che per
motivi molto fondati crede di doversi staccare nel caso concreto dalla indicazione della Gerarchia
non può ritenere definitivo il proprio giudizio, ma mantenersi in confronto continuo per verificare
l'autenticità delle proprie motivazioni. Inoltre non può pretendere che il proprio giudizio di
coscienza sostituisca per la comunità l'insegnamento episcopale, perché la coscienza è norma solo
per sé stessa in forza della grazia personale ricevuta; mentre la Gerarchia è deputata da Cristo
all'ufficio di illuminare la Chiesa. I motivi cioè che fondano l'autorità della coscienza sono ben
diversi da quelli che garantiscono l'autorità del Magistero; la coscienza si basa sul grado di verità
che per grazia di Dio e le proprie capacità ha raggiunto: il Magistero insegna e guida in forza della
volontà e dell'assistenza che Cristo ha promesso. Il giudizio di coscienza vale per l'individuo;
l'insegnamento del Magistero è destinato al bene della Chiesa.
12
In altre parole: la coscienza risponde alla domanda: "che cosa mi chiede il Signore in questa
determinata situazione, considerando le mie capacità personali?".
Le indicazioni della Gerarchia rispondono ad un'altra esigenza: "che cosa è più conforme, nel caso
concreto in cui si trova la comunità, alla missione che Cristo ha affidato alla Sua Chiesa?".
I due giudizi morali che ne seguono non debbono contrapporsi, ma integrarsi, perché la coscienza
cristiana che agisce moralmente è personalmente responsabile davanti a Dio, ma inserita nel Popolo
della Nuova Alleanza.
13
Capitolo III
LE LEGGI MORALI
1. Necessità e funzione della legge morale
Il discorso circa la coscienza può ingenerare l'impressione di relativismo morale, quasi che ciascun
uomo, in forza della propria coscienza, possa farsi regola morale a sé stesso. Perciò tale riflessione
va completata con il capitolo sulla norma morale. Del resto parlando della coscienza, della sua
funzione, autorità ed esercizio, non abbiamo trattato dei suoi contenuti, che sono appunto le norme
etiche.
Per il cristiano la vera ed unica norma etica è la persona di Cristo Risorto: egli è il comandamento
di Dio riguardo all'uomo. La coscienza, guidata dallo Spirito Santo, deve pervenire a condividere la
condizione gloriosa di Gesù Signore mediante la trasformazione in Lui della propria umanità.
Questa rimane la meta del vivere morale.
Questo progetto etico globale ha delle specificazioni di varia natura. Riflettiamo in queste righe sul
loro valore e sulla loro funzione: esse costituiscono di fatto i contenuti delle decisioni che la
coscienza è chiamata a prendere nel suo agire. Questa infatti non può discernere il bene senza
riferimenti che siano fuori di sé stessa e della situazione, altrimenti cadrebbe nel puro soggettivismo
che impoverirebbe l'umanità della persona.
Il Nuovo Testamento è molto esplicito nell'affermare che la scelta di Cristo mediante l'esperienza di
fede, comporta una serie di doveri: determinati comportamenti sviluppano l'opera dello Spirito
Santo nel battezzato, altri la annullano. La necessità della norma morale anche per il battezzato è
indiscussa nella rivelazione cristiana. Come testi probanti possiamo citare il Discorso della
Montagna e la parenesi (esortazione) delle lettere apostoliche. In particolare S. Paolo imposta le sue
lettere secondo una struttura molto significativa: all'esposizione della verità di fede, cioè
dell'annuncio (kérigma) che illustra il mistero di Cristo, segue una parte, in genere ampia per
l'economia della lettera, in cui elenca le esigenze che comporta l'accoglienza di tale messaggio. Il
contraddire le norme comportamentali richieste dall'essere discepoli di Cristo espone alla condanna
divina e all'esclusione dalla salvezza.
L'Antico Testamento esprimeva in termini dettagliati le osservanze richieste dal patto tra Jahvè e
Israele; cfr. i "Codici" del Pentateuco: Decalogo in Esodo 20, 1-17 e Deut. 5, 6-21; Jahvista in Es.
34, 10-28; dell'Alleanza in Es. 20, 22-23; Legge di santità in Lev. 17-26; Sacerdotale in Es. 25-31 e
35-40, in Lev. 1-16, in Num. 1-10.26-30.33-36; Deuteronomio 5, 11 e 12-26; Legge di purezza in
Lev. 1-26 ecc.
Analogamente possiamo trovare formulazioni simili nel Nuovo Testamento per esprimere la Nuova
Alleanza nello Spirito: Matt. 5, 17-7, 23; Gal 5, 18-21; Ef. 4, 20-6, 18; Col. 3, 5-4, 6.
Non contraddice questa lettura del Nuovo Testamento la contrapposizione, così ripetuta soprattutto
in S. Paolo, tra Legge e Spirito, tra Legge e fede in Cristo.
E' infatti contro una determinata interpretazione della legge mosaica che scrive l'apostolo: quando
cioè essa è assolutizzata e perde il riferimento all'Alleanza di cui deve essere espressione e quando è
ritenuta oppositiva con la fede in Gesù, vera rivelazione e alleanza di Dio con l'uomo. Ma è fuori
del messaggio evangelico l'idea che la novità cristiana non comporti una concretizzazione della vita
morale in precetti obbliganti. Nel modo di riferirsi alla legge divina si svela la differenza tra la
14
figura morale del fariseo e quella del discepolo di Cristo. Il fariseo dei tempi di Gesù osservava la
legge come titolo di merito davanti a Dio e di superiorità verso i non osservanti (Gv. 7, 49; Lc. 18,
9-14). Tale atteggiamento stravolgeva la funzione della legge mosaica: anziché esprimere che Dio
era alleato di Israele, lo rendeva l'avversario verso il quale bisognava cautelarsi con l'osservanza
della legge. Il discepolo di Gesù, che "non è venuto ad abolire la legge, ma a perfezionarla" (Matt.
5, 17) osserva la legge come espressione completa della carità ricevuta mediante la fede in Cristo e
che lo pone in atteggiamento filiale nei confronti di Dio.
Anche una serena indagine razionale porta a recepire la necessità della norma prescrittiva nella vita
morale del cristiano. Infatti l'uomo normalmente non conosce il bene per via intuitiva, ma
discorsiva: cioè arriva ad apprezzare il valore morale dopo una ricerca che lo espone a deviazioni di
diversa natura. In tale ricerca si giustifica la funzione delle norme morali che aiutano a capire i
valori che racchiudono in se stesse e per questa ragione sono obbliganti.
Però mentre educano la coscienza ai valori, le regole morali fanno da velo alla profondità del
comandamento di Dio, che vuole condurre i cristiani "allo stato di uomo perfetto, nella misura che
conviene alla piena maturità di Cristo" (Ef. 4, 13). I precetti morali infatti non potranno mai
esprimere esaurientemente il dinamismo dello Spirito Santo, vera guida nella prassi cristiana. Perciò
la coscienza, dell'uomo e del credente, non deve farsi guidare solo dalla misura di bene racchiusa
nella formulazione della legge, ma aspirare al valore che la trascende e che essa indica senza
esaurire. E' tale concezione legalista della morale (presente per certi aspetti nell'etica kantiana del
dovere per il puro dovere o in modo più divulgativo nell'intendere la morale come scienza del lecito
e del proibito) che Gesù rimprovera nella figura del fariseo.
Giova riprendere a questo punto la citazione di S. Tommaso riportata a pag. … e completarla: "ciò
che più importa nella legge del Nuovo Testamento, ciò da cui deriva tutta la sua efficacia, è la
grazia dello Spirito Santo, data mediante la fede in Cristo. Così la legge nuova è innanzitutto la
stessa grazia dello Spirito Santo concessa ai credenti...E tuttavia la legge nuova ha pure dei
comandamenti che dispongono alla grazia dello Spirito Santo e riguardano l'esercizio di tale grazia.
Essi sono come elementi secondari della legge nuova, a proposito dei quali fu necessario istruire i
fedeli di Cristo con parole e con scritti, sia riguardo alle cose da credere, sia riguardo alle cose da
fare.
Possiamo dunque dire che la legge nuova è primariamente legge iscritta nell'animo,
secondariamente però è anche legge scritta (S. T. I. II q. CVI a. I).
Quindi le leggi morali sono necessarie in quanto danno concretezza all'unico comandamento divino
della carità, ma vanno osservate con il cuore proteso alla pienezza dell'amore, perché a questo ci
conduce il dono dello Spirito.
In questa ottica non sorprende che esse mutino nel tempo. Per servire il comandamento eterno e
immutabile di Dio a riguardo dell'uomo, le leggi morali devono essere formulate in modo adeguato
al trasformarsi delle condizioni umane senza essere un adattamento di compromesso con la
situazione (cfr. "morale della situazione"), ma per esprimere tutta l'esigenza dell'eterna volontà di
Dio nella realtà che si è fatta diversa.
2. Tipologia delle leggi morali
Le norme etiche hanno diversi livelli in quanto a natura e ad autorevolezza. Possiamo richiamare la
triplice distinzione classica della legge morale:
15
A. LEGGE DIVINA RIVELATA
Sono tutte le prescrizioni che troviamo nella S. Scrittura. Si distinguono in norme proibitive, che
indicano quanto si oppone direttamente all'amore, e norme propositive, che esprimono ideali da
perseguire. Non sono però opzionali, ma orientano la volontà e richiedono una mediazione per
essere vissute nel concreto (es. le beatitudini). La loro autorevolezza è di assoluto rilievo perché
divinamente ispirate. Occorre però provarne l'obbligatorietà permanente, cioè dimostrare che
esplicitano la volontà di Dio a riguardo dell'umanità per ogni tempo. Diverse prescrizioni della
parenesi apostolica infatti sono legate alla situazione delle comunità che hanno espresso gli scritti
del Nuovo Testamento e come tali transitorie: ad esempio il divieto di cibarsi di animali soffocati di
Atti 15, 29 o l'imposizione alle donne di velarsi il capo nell'assemblea ecclesiale di 1 Cor. 11, 5.
Una lettura fondamentalistica della S. Scrittura, tipica dei Testimoni di Geova, osserva sì la lettera
della parola di Dio, ma ne stravolge il significato, impedendo di viverne il valore morale. Anziché
promuovere l'umanità della persona, ne paralizza la crescita morale mediante un’osservanza formale
del comandamento di Dio.
B. LEGGE UMANA POSITIVA: ECCLESIALE E CIVILE
Esprime uno dei valori racchiusi nella duplice appartenenza del cristiano che è
contemporaneamente membro della Chiesa e della società civile. Come tali sono obbliganti in
coscienza e la loro trasgressione è colpevole in quanto trascura il valore che contengono. Ciò vale
non solo per le leggi ecclesiali, che esplicitano i doveri inerenti alla salvezza, ma anche per quelle
civili. Queste infatti riguardano sì valori naturali, ma l'ordine del creato appartiene alla volontà
salvifica di Dio e per molti uomini è l'unica via di redenzione conosciuta. Non è più sostenibile
pertanto la posizione di qualche teologo del recente passato, che riteneva le leggi civili non
obbliganti in coscienza (mere poenales), purché il cittadino fosse disposto ad assolvere l'ammenda
che è legata alla loro trasgressione. La legge civile, se legittima, cioè se è richiesta dal bene
comune, esprime quella solidarietà verso il proprio gruppo sociale, che è un aspetto del
comandamento della carità. Tale concezione della obbligatorietà della legge civile non smentisce la
legittimità del confronto democratico, quindi del dissenso e anche della resistenza perché una legge
sia migliorata o abrogata.
Però in questa azione il cristiano deve essere guidato dalla volontà di concorrere al bene sociale,
non da interessi personali o di gruppo. E una legge, se non è chiaramente illegittima o
intrinsecamente immorale, obbliga in coscienza finché appartiene alla legislazione dello stato, in
quanto realizza tra i cittadini il valore del bene comune.
C. LEGGE NATURALE
Il dibattito sul concetto di legge naturale è ancora ampio e complesso tra i teologi moralisti. Ai fini
del presente lavoro, che deve attenersi al carattere di essenzialità e semplicità, basterà esporre i
punti sostanziali e non problematici della questione.
Intendiamo per Legge Naturale quell'insieme di norme etiche che derivano dalla natura umana. La
conoscenza della propria natura è infatti una delle vie che l'uomo ha per scoprire i propri doveri in
quanto soggetto libero e che si va realizzando mediante le libere scelte compiute lungo l'esistenza.
S. Tommaso, sulla scorta della concezione dell'uomo "creato a immagine di Dio", la definisce
"partecipazione della legge eterna nella creatura razionale" (S.Th. I-II q. 91, a. 2). Vale a dire che la
nostra condizione di creature intelligenti e libere è segno di un progetto di Dio a nostro riguardo che
ci impegna moralmente. Nella ricerca della norma che deve guidare la vita morale, la coscienza non
può ignorare le indicazioni che provengono dalla propria natura. Per il credente la chiamata alla vita
è il primo imperativo di Dio e la creazione è la sua prima rivelazione. La natura inoltre ha il
16
carattere dell'universalità, nel senso che è fonte di moralità per ogni uomo, prima ancora delle sue
opzioni religiose. Perciò anche il cristiano nel formulare il suo orientamento morale attinge alla
legge di natura, senza separarla dalla Rivelazione positiva, quasi esistessero per lui due fonti di
moralità. Sia il Creato che la S. Scrittura sono manifestazioni del Verbo di Dio, perciò i singoli dati,
della natura e della Bibbia, si illuminano reciprocamente. Confermano questa tesi due passi
scritturistici: Ebr. 1, 1-4 che afferma come Dio si è rivelato pienamente in Cristo, ma già prima
aveva parlato all'umanità in altri modi; Rom. 2, 11-15 che prova l'imparzialità di Dio dal fatto che i
pagani, pur non conoscendo la legge divina, hanno una guida per la loro condotta "come risulta
dalla testimonianza della loro coscienza e dai loro stessi ragionamenti, che ora li accusano ora li
difendono", cfr. anche 1 Tess. 5, 21 e Fil. 4, 8. Tuttavia nel dialogo con i non credenti può essere
utile partire dal piano condiviso che è la conoscenza della natura umana raggiungibile con lo
strumento comune della ragione.
Il problema più serio inizia però quando si procede a definire la natura umana e a stabilire come i
suoi dati diventano obbliganti moralmente. La complessità dell'uomo è tale che non si ha una
conoscenza esaustiva ed universalmente condivisa della sua natura. Ciò comporta che si rispettino
alcuni criteri nella ricerca della legge di natura moralmente obbligante:
1. Occorre evitare ogni riduzionismo. L'uomo non può essere pienamente conosciuto dallo studio
di alcuni aspetti soltanto della sua realtà: biologico, sociologico ecc. E' la globalità delle sue
dimensioni che ci conduce alla verità su di lui. Quindi la natura umana non va intesa nel modo
delle scienze sperimentali, come realtà fissa. Nel definirla concorrono elementi della cultura che
l'uomo elabora e che lo svelano a sé stesso.
2. La conoscenza della legge naturale è dinamica. Ogni epoca può progredire o regredire in questo
processo. Alcuni punti fermi sembrano però indiscussi, e per la loro condivisione da parte di
tutte le civiltà e per la prossimità con la difesa della dignità dell'uomo: ad esempio "la persona
umana è fine, mai mezzo", il che significa che nessuno può disporre del proprio simile a suo
arbitrio; oppure "Non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te", ecc.
3. Legge naturale e magistero ecclesiale
Il cristiano ha una verifica ulteriore alla legge naturale che è la rivelazione diretta e il magistero
della Chiesa. Ma come la rivelazione dà sicurezza ed approfondimento alle verità che la ragione
umana scopre, così nella storia è successo che una conoscenza più approfondita dell'uomo abbia
fatto progredire la comprensione della Parola di Dio. La chiesa "è persuasa che molto e in svariati
modi può essere aiutata nella preparazione del Vangelo dal mondo, sia dai singoli uomini, sia dalla
società umana, con le loro doti e la loro operosità". Sono parole del Vaticano II (Gaudium et Spes n.
40).
Un aspetto molto dibattuto della legge naturale è il ruolo del magistero ecclesiale nella sua
interpretazione. Un caso notorio è stato il giudizio di immoralità attribuito da Paolo VI alla pratica
della contraccezione: le argomentazioni del pontefice sono attinte dalle leggi di natura circa l'amore
coniugale, non direttamente dalla Parola di Dio. (cfr. Humanae Vitae n. 11). Ma appartiene alla
tradizione del magistero dei romani pontefici rivendicare la loro competenza circa l'interpretazione
della legge naturale, anche se non sono mai pervenuti ad una definizione de fide su questioni di
carattere morale e tanto meno a proposito della legge naturale. Il Vaticano II, riprendendo
l'insegnamento del Vaticano I, dice espressamente: "Questa infallibilità, della quale il divino
Redentore volle provveduta la sua Chiesa nel definire la dottrina della fede e della morale, si
estende tanto, quanto il deposito della divina Rivelazione. Di questa infallibilità il Romano
Pontefice, capo del collegio dei Vescovi, fruisce in virtù del suo ufficio, quando ... sancisce con atto
definitivo una dottrina riguardante la fede e la morale" (L. G. 25).
17
Può giovare a chiarire l'importanza del contributo del Magistero nella retta interpretazione della
legge naturale, la citazione di un teologo qualificato del nostro tempo:
"Tutti ci rendiamo conto che occorre una acuta ermeneutica per interpretare e applicare rettamente i
testi scritturali ai problemi morali del mondo di oggi. La consapevolezza di queste difficoltà può
condurre alcuni a basare il loro pensiero quasi esclusivamente sulla legge naturale. Ma il pensiero di
legge naturale necessita di un'ermeneutica altrettanto profonda. In ogni epoca dobbiamo cogliere le
migliori intuizioni su ciò che significa natura umana e storia umana in quel dato contesto vitale e
nella luce di Gesù Cristo.
Ciò di cui oggi vi è più bisogno e che dovrebbe essere particolarmente promosso da quanti hanno
autorità nella chiesa, è la visione specificamente cristiana della legge naturale: abbiamo cioè
bisogno che la legge naturale sia vista nell'ambito della legge di Cristo. Di tale visione cristiana vi è
bisogno anche in ordine al dialogo della chiesa con il mondo moderno, dialogo in cui è
estremamente importante che noi ci presentiamo con la nostra identità cristiana". (B. Häring, Liberi
e fedeli in Cristo, Roma 1979, pag. 393).
18
Capitolo IV
L'ESPERIENZA DELLA COLPA ALLA LUCE DEL MISTERO PASQUALE
Il discorso etico si incontra con un dato universale di esperienza: l'uomo prova nella tensione verso i
valori morali il fenomeno della colpa. Esperimenta cioè uno scarto tra il desiderio del cuore e
l'azione che compie. La volontà è attratta dal bene che la coscienza le presenta, ma in maniera non
sempre decisiva, per cui aderisce a comportamenti negativi che la coscienza stessa poi si
rimprovera, li ritiene imputabili alla volontà, perciò riconosce che poteva agire diversamente.
Questa dimensione che chiamiamo etica della colpa si è sempre accompagnata al dato religioso:
cioè il male commesso era percepito dalla coscienza in riferimento a Dio, in qualunque modo fosse
conosciuto.
Nella cultura occidentale contemporanea si è verificato questo fatto nuovo: la separazione dei due
aspetti, etico e religioso, dell'esperienza della colpa.
I fattori che l'hanno determinato sono molteplici, ma si possono riunire nel fenomeno della
secolarizzazione. Venendo meno il senso di Dio e la visione religiosa della vita, dal momento che
l'uomo è al centro dell'universo, il peccato diventa un fatto puramente umano e le sue cause vanno
ricercate nella struttura della persona. Saranno perciò le scienze umane a dare spiegazione del
fenomeno della colpa, che l'esperienza del rimorso rende ineludibile: per la psicologia il peccato è
l'effetto di meccanismi interiori inconsci; per la biologia sono gli istinti, le pulsioni, l'ereditarietà a
provocare certi comportamenti fuori norma; la sociologia individuerà nelle strutture sociali le cause
del peccato; la politica infine ha sospinto la coscienza a recepire in modo primario determinate
forme di colpevolezza, quelle compiute verso la società, a scapito di altri aspetti del vivere negativo.
Anche nel vissuto della comunità ecclesiale il senso del peccato ha subito modificazioni. Due
sembrano rilevanti, sia per il loro grado di diffusione che per la grave opposizione alla fedeltà
evangelica:
a) Si è recepita in campo cattolico una visione luterana della colpa, che potremmo chiamare
paradossalmente "mistica del peccato". Esaltando la figura del pubblicano, si propone
la vita cristiana incentrata nella confessione che siamo peccatori. Cristo ci salva quanto più
siamo falliti nella colpa, perché allora si manifesta la grandezza di Dio che redime. Il peccato
è una condizione strutturale dell'uomo che svela così la grazia di Dio, per cui lo sforzo di
opporsi al peccato risulta una sottile presunzione di autosalvezza, che esclude dalla fede e dalla
grazia.
b) Quasi come una conseguenza ne è derivato una diminuzione del senso di colpevolezza e un
disimpegno morale, un calo di tensione etica nel vivere la fede. Ne è prova la prassi di tanti
battezzati, che sono anche fedeli alle pratiche sacramentali, ma trascurano senza rimorso la
coerenza sul piano morale. Se la frattura tra fede e cultura, che Paolo VI giudicava uno dei
grandi mali del nostro tempo (cfr. Evangelii Nuntiandi, n. 20), riguarda la presenza della
Chiesa nella società, la separazione pacificamente vissuta tra appartenenza alla Chiesa e prassi
etica è un dato sperimentato all'interno della comunità cristiana. Già un grande teologo e
testimone della confessione evangelica, Dietrich Bonhoeffer, denunciava questo orientamento
pastorale delle Chiese nell'epoca moderna, quando parlava della distribuzione della grazia
"a poco prezzo", che diventa una giustificazione non del peccatore, ma del peccato (cfr.
Sequela, Brescia 1971, pag. 21 segg.). Del resto vediamo che la Chiesa è contestata, sia dai
suoi membri che nella società, non per i suoi dogmi, né per i suoi riti, ma per le proposte
morali che la catechesi ritiene consequenziali alla fede in Cristo Gesù.
19
Occorre dunque riaffermare che il peccato non ha alcun valore positivo, nemmeno paradossalmente
quello di rivelare la grazia. La fede in Cristo unico redentore non ci esime dal combattere il peccato
in noi. Anzi la coerenza tra fede e vita, tra legge morale cristianamente ispirata e comportamenti
vissuti, è una esigenza della salvezza.
Tale fermezza nell'essere fedeli alle esigenze dell'evangelo non giustifica però la pigrizia pastorale
nel ricercare il linguaggio dell'annuncio adatto all'uomo d'oggi e nel discernere quei valori recepiti
dalla cultura che possono costituire valido fondamento all'edificazione di personalità cristiane.
Facciamo pertanto un primo approccio all'incontro tra la salvezza cristiana e la realtà del peccato
umano, per riprendere poi nel paragrafo successivo il medesimo problema in modo più sistematico,
nel confronto con le fonti della teologia.
1. L'annuncio della salvezza cristiana e l'esperienza umana della colpa
La realtà del peccato umano è al centro della rivelazione cristiana, sia pure in negativo, nel senso
cioè che tutta l'opera di Dio, comunicata dalla sua rivelazione, presenta come finalità la liberazione
dell'uomo dal suo peccato. Questa tesi, che proveremo più ampiamente nel paragrafo successivo, ci
porta a concludere che il significato cristiano della colpa morale esige per essere compreso in tutta
la sua estensione la visione religiosa della vita.
Vale a dire che il peccato svela la sua natura solo se considerato in riferimento a Dio. Nella
concezione cristiana il peccato rompe la sua alleanza con Lui, creatore e amico; lo offende perché
respinge la sua proposta di comunione. Tutta la storia della salvezza nella rivelazione biblica è la
risposta di Dio all'uomo che lo rifiuta. L'agire divino infatti si incontra con la pretesa dell'uomo di
essere autonomo dal Creatore. Alla radice del volere peccaminoso sta la presunzione di
autosufficienza dell'uomo nei confronti di Dio. La pagina della Genesi (3, 1-7) svela la struttura di
ogni peccato: la volontà di essere come Dio. Il primo peccato si ripete nel peccare degli uomini,
perché le colpe personali si iscrivono nelle condizioni dell'umanità, che è peccatrice fin dalle
origini.
Ciò significa che l'esperienza del peccato suppone la dottrina del peccato originale per avere una
certa quale comprensione. Secondo questo dogma cristiano l'attuale è un mondo decaduto;
all'origine non era così. E anche ora è possibile il riscatto, perché Dio non ha rinnegato la sua
creazione, anzi in Cristo l'ha restaurata.
L'opera di Gesù, il mistero pasquale, ha come obiettivo la vittoria sul peccato, inteso come un
potere tenebroso che si inserisce negativamente nelle relazioni tra l'uomo e Dio. Cristo è l' "agnello
che toglie il peccato del mondo" (Gv. 1, 29) in quanto restituisce all'umanità la sua condizione,
originaria almeno nella volontà divina, di poter vivere in comunione d'amore con Dio.
La mentalità dell'uomo contemporaneo rifiuta di ricorrere ad elementi religiosi per spiegare il
fenomeno della colpa, perché questi sfuggono alla verifica cui è abituato da tutta la sua cultura.
E anche il cristiano è indotto a vivere la propria colpa come un fatto puramente morale: tale cioè
che riguarda solo la sua coscienza e quella norma di vita che si è impegnato ad osservare.
Anche il sacramento della Riconciliazione può essere vissuto quasi esclusivamente nei suoi aspetti
etici: giudizio negativo sulle azioni confessate, riconoscimento della propria responsabilità,
impegno a comportarsi diversamente. Occorre invece vivere l'esperienza della propria colpa in
riferimento a Dio, collocandola in relazione a due eventi: la colpa originaria dell'uomo e la
redenzione mediante la Passione-Morte-Resurrezione di Gesù Cristo.
Infatti la riduzione della colpa a solo elemento personale espone a interrogativi che non trovano
risposta. B. Pascal evidenzia la superiore razionalità di chi accetta il dogma cristiano del peccato
originale come spiegazione del male del mondo. Rifiutare tale spiegazione significa rinunciare a
20
capire il fenomeno, cioè contraddire i principi stessi della ragione: "Certo, nulla ci urta più
fortemente di questa dottrina; eppure, senza questo mistero, il più incomprensibile di tutti, noi
siamo incomprensibili a noi stessi. Il nodo della nostra condizione si avvolge e si attorce in questo
abisso: sicché l'uomo è più inconcepibile senza questo mistero di quanto questo mistero non sia
inconcepibile per l'uomo" (Pensieri, n. 456).
Il pensiero ateo rivolge diverse obiezioni alla concezione cristiana della colpa morale, per il fatto
che si colloca in una dimensione teologica, cioè in riferimento a Dio. Le più diffuse sono quelle
prodotte dal marxismo e dalla psicanalisi.
L'antropologia marxista rimprovera al pensiero religioso di sminuire la responsabilità personale
sopratutto verso i peccati cosiddetti sociali e in particolare circa le strutture di classe che sono fonte
di ingiustizia.
Un'autentica religiosità al contrario accentua invece il senso di responsabilità, perché ritiene che il
peccato è commesso alla presenza di Dio, il quale non tollera ombra di male. E' un atto che non si
esaurisce nell'ambito del soggetto, ma coinvolge la Divinità, perché viene a mutare i rapporti di
questa con l'uomo peccatore. Ne viene quindi accentuata la gravità rispetto a qualunque altro
riferimento: ad esempio la violazione della giustizia sociale e altri.
Anche l'aspetto comunitario della colpa non viene trascurato nella visione cristiana; non le
appartiene una concezione individualista della responsabilità morale. Per la Rivelazione la colpa
rimane rottura con gli altri e con il cosmo. In Genesi (3, 1 segg.) viene insegnato ampiamente che il
peccato contro Dio provoca la rottura dell'unione uomo-donna e la ribellione del creato ("la terra
produrrà spine").
Tale verità viene confermata nel Nuovo Testamento con la realtà del corpo mistico: "Siamo membri
gli uni degli altri" (Rm. 12, 5).
Il carattere personale della colpa è pertanto inseparabile dagli effetti sociali ed ecclesiali, così come
l'intenzione del cuore è elemento inseparabile dagli effetti storici del peccato: l'aspetto soggettivo ed
oggettivo di questo vanno collegati. Vale a dire che nel qualificare il peccato è importante
l'intenzione di chi lo commette, ma anche il contenuto dell'azione, quel dato che la teologia
tradizionale chiamava "materia" dell'atto colpevole e che entra con la volontarietà tra gli elementi
che ne misurano la natura e la gravità.
La psicanalisi a sua volta, o meglio una corrente di questa dottrina, rimprovera alla fede religiosa di
essere all'origine dei sensi di colpa che si manifestano in determinate patologie psichiche.
Pur riconoscendo che alcuni modi di educazione religiosa possono aver indotto alcuni soggetti a
formarsi una coscienza nevrotica, va ricordato che un'autentica concezione cristiana della colpa si
accompagna indissolubilmente con la certezza del perdono di Dio, il quale in molteplici modi ha
rivelato la sua misericordia nei confronti dell'uomo peccatore. Riconoscere la volontà redentrice di
Dio non è un elemento giustapposto alla consapevolezza di essere peccatori verso di Lui, ma
appartiene al medesimo ed unico atto di fede; al punto che la coscienza cristiana affina ed
approfondisce il senso di colpevolezza quanto più si apre alla certezza della bontà divina, perché ha
la dimensione dell'amore tradito dal proprio peccato.
Forse è stato solo delibato non approfondito a livello di antropologia culturale il valore liberante
della categoria biblica del perdono divino. Di fronte al vissuto della colpa la coscienza
cristianamente formata non riduce la portata della propria responsabilità, banalizzando la negatività
del proprio comportamento, né cade nella disperazione. Ma mediante il richiamo evangelico della
conversione del cuore fa del peccato un fattore positivo di ripresa morale.
Ancora una volta la dimensione religiosa della colpa si dimostra un elemento di umanizzazione di
un fenomeno che colpisce nel profondo credenti e atei.
21
Possiamo concludere che il tentativo della cultura occidentale di ridurre la colpa a fenomeno
spiegabile con i meccanismi della personalità, e quindi da rimuovere con terapie ispirate alle
scienze umane, non ha risolto il problema esistenziale di questa esperienza negativa. Non ha
eliminato l'angoscia personale che ne deriva e non dà adeguata giustificazione dei mali sociali
provocati dalla lucida volontà degli uomini. L'evangelo sollecita a collocare il dato umano della
colpa nell'opera di salvezza che Dio ha compiuto in Cristo per l'uomo.
Inserito nel mistero della redenzione il problema del male, e in particolare del male provocato dal
volere degli uomini, acquista una parziale comprensione e, cosa ancor più importante, la possibilità
di essere liberati.
Accostiamo perciò, sia pure sommariamente, l'intelligenza del peccato a cui è pervenuta la
riflessione teologica.
2. Significato del peccato nella riflessione ecclesiale della fede
La Rivelazione cristiana parla del peccato nel contesto della sua remissione, cioè ne svela il senso
mediante la sua redenzione da parte di Dio nel Figlio.
E' un'ottica diversa dalla cultura contemporanea che pensa all'uomo, al suo valore e al suo destino
solo in base alla sua esperienza. La teologia non si oppone a questo sapere, ma lo arricchisce
verificandone la verità con quanto Dio ha rivelato all'uomo.
A. IL SIGNIFICATO DEL PECCATO NELLA PAROLA DI DIO
Il dato peculiare della S. Scrittura circa la comprensione del peccato è l'orizzonte in cui lo colloca,
che è quello dei rapporti tra l'uomo e Dio, il quale intesse una storia di salvezza a suo favore.
Nell'Antico Testamento la dimensione del peccato è data dal carattere dominante l'antropologia
veterotestamentaria, che è l'esistenza "davanti a Dio", per cui peccato è l'orgogliosa ribellione al
Creatore, l'autoaffermazione umana (cfr. Osea 7, 15).
La riflessione più matura viene raggiunta nel contesto della categoria di "alleanza": il peccato
consiste nella rottura del Patto tra Jahvè e il popolo (cfr. Osea 1, 3; Ger. 3, 1-5 e 4, 1-4;
Ezech. 16; Isaia 24, 5 e 62, 4-5).
L'insegnamento veterotestamentario evidenzia particolarmente due aspetti del peccato:
-
La dimensione intrastorica, per cui l'azione peccaminosa manifesta la sua valenza negativa non
solo nei confronti di Dio, ma all'interno delle relazioni umane, soprattutto come offesa all'uomo
e violenza al debole (cfr. i richiami alla giustizia che va resa all'orfano, alla vedova e allo
straniero, all'equità nei tribunali, ecc.). L'estensione della colpa va ben oltre la trasgressione
culturale.
-
La dimensione comunitaria: dato che l'Alleanza è una realtà comunitaria, perché il Patto non è
con i singoli individui ma con il popolo, è all'interno di questo che il peccatore scopre
l'estensione della sua colpa. Chi abbandona la solidarietà dell'alleanza, cade nella solidarietà del
peccato e la gravità di questo è in riferimento al danno comunitario provocato: cfr. il rimprovero
ai peccati dei re, dei sacerdoti, alla idolatria collettiva, ecc.
22
Le forme espressive usate negli scritti dell'AT per parlare del peccato sono diverse ed hanno un'alta
validità letteraria: codici (rituali, morali, legali), cronache (storie di peccato come quelli di Saul e di
Davide, ad esempio), oracoli profetici, riflessioni sapienziali.
Con il periodo che segue l'esilio babilonese la concezione del peccato si arricchisce del concetto di
responsabilità individuale soprattutto mediante la letteratura profetica (cfr. Ez. 18, 1 ss.).
Il Nuovo Testamento riporta una distinzione importante, quella tra male assoluto e male morale.
C'è una potenza di male operante nel mondo, un “mistero di iniquità” che si contrappone al regno di
Dio (cfr. l'ora, la potenza delle tenebre di Lc. 22, 53 e la lotta escatologica tra il regno di Cristo e il
mondo sconfitto dalla forza della croce di Apoc. 6 e 19-20). La comprensione piena di questa realtà
rimane problematica. E' certo però che il NT esclude ogni contrapposizione alla pari con Dio.
Come già nell'AT (Giobbe, Genesi) la Rivelazione cristiana non dà adito a nessuna forma di
manicheismo, cioè all'idea di due forze, il Bene e il Male, che si contendono il mondo. Però con
uguale chiarezza gli scritti neotestamentari affermano che il peccato dell'uomo è possibile perché
esiste il male nel mondo. Non sono gli atti colpevoli che creano nella persona la tendenza
peccaminosa, ma viceversa è nella situazione di peccato propria della natura umana che gli atti
peccaminosi hanno la loro origine (Gc. 1, 13-15).
Dunque nel Nuovo Testamento il termine peccato (amartìa) indica sia la incapacità dell'uomo a
riconoscere Dio (incontrato almeno nei suoi attributi: vita, giustizia, santità, amore, ecc.) cioè la sua
tendenza a contrapporsi al Creatore facendosi un proprio ordine di vita (è il peccato del mondo, il
peccato originale), sia, soprattutto quando è usato al plurale, gli atti peccaminosi che esprimono ed
aggravano la condizione umana (i peccati personali).
Alcune insistenze caratterizzano gli scritti del NT circa l'aspetto morale del peccato:
-
il peccato ha la sua origine nel cuore dell'uomo (Sinottici). In particolare gli scritti giovannei
pongono la radice del peccato nel rifiuto di Gesù Salvatore, quindi nella mancata fede verso il
Cristo.
-
la misura del peccato, in riferimento al suo contenuto, si ha nell'offesa che reca al prossimo
perché il comandamento fondamentale è unico, quello dell'amore a Dio e al prossimo (Sinottici
e 1 Gv.).
-
vengono esemplificati ampiamente elenchi di comportamenti peccaminosi (corpus delle lettere
paoline).
Ma è soprattutto in un altro dato che consiste la novità del NT circa il peccato umano, in quello che
possiamo definire il cuore dell'evangelo cristiano: il fatto cioè che il peccato è la causa della morte
di Gesù, Verbo incarnato. Essa è il sacrificio di liberazione per i peccati dell'umanità. Per quanto
inadeguati questi termini introducono al mistero di Dio che si fa povero per assorbire nella
profondità dell'amore la negatività del peccato del mondo. E' il fascio di luce su questa realtà umana
che sconcerta l'intelligenza creata, ma dilata la verità sul mistero del nostro peccare.
B. IL CONTRIBUTO DEL MAGISTERO GERARCHICO
Il Magistero ecclesiale gerarchico non ha dato molto spazio alla dottrina del peccato, poiché essa
non ha subito controversie di rilievo fino alla Riforma Luterana. E' perciò nel Concilio di Trento
che abbiamo interventi autorevoli a riguardo dei seguenti punti di dottrina:
- condanna di alcune proposizioni luterane sulla condizione dell'uomo peccatore;
23
-
dottrina cattolica sul peccato originale;
dottrina cattolica circa la giustificazione del peccatore;
dottrina cattolica sulla penitenza e sul sacramento della confessione.
Il Concilio Vaticano II esprime in linguaggio appropriato la dottrina tradizionale sul peccato,
ponendolo in riferimento al mistero del male, contro il quale per la comunione a Cristo risorto deve
lottare il battezzato, e alla natura sacramentale della Chiesa, che è insieme santa per i doni di grazia
ricevuti, e peccatrice, perché nei suoi membri perdura la presenza della colpa, in attesa della piena
liberazione (cfr. Lumen Gentium 8 e Gaudium et Spes 13, 22; 37, 38).
Il tema del peccato è stato poi oggetto di approfondimento da parte del VI Sinodo dei Vescovi,
i cui risultati furono resi pubblici nell'esortazione apostolica Reconciliatio et Poenitentia da
Giovanni Paolo II (1984). La riflessione teologica e pastorale sul peccato viene inserita nel mistero
della riconciliazione di cui la Chiesa è sacramento: "il mistero d'iniquità" che travaglia il cuore
dell'uomo e la sua storia è illuminato dal "mistero di pietà" di Dio verso di noi (cfr. ivi, n. 14-15 e
19-21).
C. TENTATIVI DI DEFINIRE IL PECCATO
Nello sviluppo della teologia cristiana sono stati compiuti molteplici tentativi per approfondire il
senso del peccato umano nelle sue dimensioni antropologiche in riferimento alla vita di grazia, che
è il frutto della salvezza partecipata nello Spirito Santo per la fede in Cristo Gesù.
La teologia della Chiesa latina è segnata dall'influsso di Agostino, a cui si sono riferiti, a modo di
sviluppo o di opposizione, i pensatori e le correnti che più si sono interessate al problema. Basti
ricordare la disciplina canonica della penitenza dal sec. VIII al IX, S.Tommaso, Lutero, il
movimento giansenista francese del 1600.
Rimandando alle fonti proprie per la storia del dogma, vengono esposte qui a modo di definizione le
concezioni del peccato che hanno predominato nella riflessione teologica, con l'aggiunta di qualche
nota critica per una comprensione più vera di questa realtà complessa, che interessa la relazione tra
l'uomo e Dio e perciò rimane incomprensibile nella misura in cui Dio resta mistero per la nostra
mente.
Il peccato è violazione della legge di Dio
E' una definizione di origine agostiniana (dal Contra Faustum), adottata dagli scolastici e anche da
S. Tommaso (Summa Teol. I-II q. 71 a. 6): peccato "è una cosa compiuta, detta o desiderata contro
la legge eterna". La legge eterna è quella volontà di Dio circa l'umanità espressa dalla rivelazione e
dalle leggi positive. Ma è soprattutto lo Spirito Santo, il quale guida la storia umana.
L'espressione raccoglie i due aspetti del peccato: il contenuto umano (parola-azione-pensiero) e
l'intenzionalità negativa (violazione della legge divina) che caratterizza l'azione moralmente
colpevole.
Però corre il rischio di dare al termine legge un significato riduttivo, come è avvenuto nella tarda
scolastica e nella conseguente morale casistica.
24
Il peccato è offesa a Dio
Il Catechismo Romano pubblicato da Pio V come divulgazione del Concilio Tridentino, considera il
peccatore come un debitore insolvente verso Dio: solo i meriti di Cristo ci liberano da questo
debito. Espone questo pensiero nel commento della quinta invocazione del Padre nostro: "Rimetti a
noi i nostri debiti" (Matt. 6, 12).
Chiaramente il concetto di offesa non può essere che analogico nei confronti di Dio, che non è mai
toccato dall'azione umana. Tuttavia esprime l'intenzionalità del soggetto, disposto a trascurare il
giusto rapporto con Lui, tale cioè che ne riconosca la signoria e la santità. Però l'equazione peccatodebito ricorre ad un antropomorfismo, che mortifica la trascendenza; e i termini giuridicoamministrativi di “debito-riparazione” ecc. sono molto inadeguati alla realtà soprannaturale che
debbono specificare.
Il peccato è allontanamento da Dio e adesione alle creature
E' un'altra formula agostiniana molto fortunata, che bene esprime il processo psicologico della
decisione peccaminosa, nel duplice movimento di avversione a Dio - conversione alla creatura.
Questa definizione suppone la concezione dell'uomo propria dell'esistenzialismo agostiniano, cioè
di quel tentativo geniale di penetrare le dinamiche interiori della persona e in particolare dell'uomo
di fronte alla verità, travolto dal male, provato dalla tentazione.
S. Tommaso vede definita in questa formula la malizia del peccato mortale, la cui gravità sta
proprio nella scelta del bene finito, raggiunto dall'azione colpevole, rispetto a Dio, bene infinito
(Summa T. I-II q. 87 a. 4 e III, q. 86, a. 4).
Alla profondità delle definizione si può solo rilevare il limite di una accentuazione individualistica
della colpa, di cui sono taciuti i riflessi comunitari, e dell'insistenza sull'aspetto interiore dell'atto a
scapito del contenuto del peccato.
Il peccato è azione disordinata (la definizione forse più diffusa nella coscienza popolare)
La paternità ultima della formula va attribuita a S. Tommaso e va inquadrata nella concezione
dell'atto umano propria del suo pensiero. L'atto è umano quando è volontario ed è cattivo quando
non rispetta la regola che deve guidare la volontà: tale regola è dettata dalla ragione e in ultima
istanza dalla "legge eterna, che è come la ragione dello stesso Dio" (Summa T. I-II q. 71 a. 6).
Gli elementi positivi di tale concezione giustificano l'autorità che ha avuto in teologia morale.
Infatti riporta la colpevolezza negli atti singoli del soggetto, richiamando come di fatto è mediante
le azioni concrete che si svela l'intenzione del cuore. Inoltre il giudizio è formulato in base ad una
norma etica universale che la ragione in prima istanza e poi la fede più profondamente possono
individuare: la bontà di un'azione sta nel rispetto del suo fine voluto da Dio (la norma eterna). Posto
fuori da questo ordine l'atto è peccaminoso e, nella misura in cui è voluto liberamente, è colpevole.
Però è a una lettura distorta di questa concezione del peccato che si debbono far risalire i limiti della
morale casistica, che ha dominato la teologia e la pastorale fino agli anni '60; vale a dire
l'impostazione frammentaria del vivere etico, per cui l'importanza attribuita ai singoli atti ha
trascurato l'unitarietà della persona e non dà il dovuto rilievo, nel valutare le singole azioni, a
quell'orientamento del cuore che abbiamo chiamato opzione fondamentale e che qualifica la persona
dal punto di vista etico.
25
Sempre a una distorta interpretazione di questa visione tomista del peccato va attribuito il carattere
formalista della morale post scolastica. Intendo quella accentuazione attribuita alla conformità o
meno dell'azione verso la norma. Concentrando la malizia del peccato sul mancato rispetto della
legge, si sminuiva l'importanza del contenuto dell'azione colpevole e dei suoi effetti nella situazione
storica. "Con la definizione tomista è difficile mettere in movimento una lotta sociale contro
situazioni di peccato", dice M. Vidal (cfr. L'atteggiamento morale, Vol. I, Assisi 1976, pag.
439. Da questa opera ho attinto ampiamente per stendere il presente paragrafo).
I brevissimi rilievi espressi suggeriscono che non in una singola definizione contrapposta ad altre
sta la migliore comprensione teologica del peccato, ma nell'insieme degli sforzi che la Chiesa nella
sua teologia e nella pastorale va facendo, docile allo Spirito Santo.
3. Distinzione tra i peccati: veniale/mortale - personale/sociale
A. PECCATO MORTALE E PECCATO VENIALE
Contro il rigorismo luterano accentuato da Calvino per il quale ogni peccato essendo offesa di Dio è
sempre grave, appartiene alla fede cattolica la verità che non tutti i peccati sono uguali e non tutti
hanno la medesima forza negativa di separarci dalla salvezza. La tradizione teologica ha codificato
la distinzione tra peccato mortale e veniale. Però già nella prima lettera di Giovanni si distingue tra
peccato che "conduce alla morte" e non.
"Ogni iniquità è peccato, ma c'è il peccato che non conduce alla morte" (ivi, 5, 17)
La prassi penitenziale della Chiesa antica rapportava la riparazione imposta al penitente alla gravità
dei peccati, fino al formarsi, con la tradizione irlandese trasferita in tutta Europa nei sec. VIII-IX, di
cataloghi cui corrispondeva la relativa penitenza.
Possiamo dire che in modo esplicito è ancora Agostino ad introdurre un criterio di distinzione nella
valutazione della gravità del peccato. Egli utilizza i due concetti espressi nella formula latina 'utifrui'. Cioè l'uomo deve usare (uti) delle cose, ma godere, saziarsi (frui) solo di Dio, bene sommo.
Quando invece mette una creatura al vertice delle sue aspirazioni pecca "mortalmente". Minore
invece è la gravità della colpa quando non distingue con sufficiente determinazione tra il fine del
suo agire che è Dio, e i mezzi, che sono le creature. Evidentemente sottostà a questa distinzione
agostiniana la sua concezione, già richiamata, del peccato come "aversio a Deo et conversio ad
creaturas".
S. Tommaso ricorre alla concezione di legge per qualificare la gravità del peccato. La legge eterna,
l'ordine divino vuole che le cose siano considerate in ordine al loro fine, cioè secondo quella
gerarchia di valori che il Creatore ha posto nel mondo. C'è un peccato che si pone direttamente
contro il fine delle cose, quindi contro la legge eterna iscritta da Dio nel creato: è mortale, perché
esclude dalla volontà di Dio, al di fuori della quale non c'è salvezza. Esempio l'avaro che non
possiede le ricchezze per servirsene, ma ne fa l'unico oggetto delle sue aspirazioni e della sua
attività al punto da trascurare la ricerca di Dio. Ci sono azioni peccaminose commesse al di fuori
della legge che ordina tutto a Dio (praeter legem): ad esempio trattenere per sé una cosa non
strettamente necessaria, ma per la soddisfazione di possederla.
Nel secondo caso non viene meno l'orientamento generale della coscienza a Dio come fine di tutta
l'esistenza, perciò la colpa non separa pienamente da Lui, non è quindi mortale (Summa T. I-II,
q. 88 a. 5; q. 89 a. 1). E siccome la polarizzazione a Dio è data dalla carità, ne consegue che il
peccato mortale è contro la carità, mentre il peccato veniale è una scelta compiuta fuori dell'amore.
26
Il Concilio Tridentino contro il rifiuto luterano della distinzione dei peccati a motivo della
fondamentale peccaminosità dell'uomo, ha distinto tra peccati che tolgono la grazia (Denzinger
1573, 1977) e mancanze quotidiane, che sono pressoché inevitabili finche non abbiamo ricevuto il
dono della perfezione (idem, 1536, 1979). La teologia morale post tridentina ha però applicato in
modo oggettivato la distinzione conciliare, che è venuta a perdere il suo carattere personalistico;
cioè si valutava la gravità del peccato dal grado di trasgressione della legge morale, trascurando di
considerare il soggetto che lo commetteva, vale a dire il livello di responsabilità, la sua capacità
etica, ecc.
La prassi catechistica, soprattutto in ordine alla confessione sacramentale aveva individuato tre
condizioni per definire un peccato come mortale: quando vi era materia grave, piena avvertenza,
deliberato consenso (cfr. Piccolo Catechismo di Pio X). Tale definizione ha una sua chiarezza e
praticità. Però le tre condizioni devono coesistere contestualmente e soprattutto non è facile valutare
la consapevolezza (“piena avvertenza”) e la volontarietà (“deliberato consenso”) di un'azione
colpevole. Cosicché privilegiando l'elemento quantitativo del peccato mortale (“materia grave”),
molti battezzati si sentivano condannati all'inferno, anche quando l'età o la situazione non avrebbero
permesso nemmeno a un tribunale umano di formulare una condanna capitale.
Il problema sta nell'operare la sintesi tra l'aspetto oggettivo e quello soggettivo dell'azione che va
giudicata. Cioè a qualificare come mortale un atto colpevole serve il contenuto dell'azione e
inseparabilmente l'intenzione del cuore, che viene valutata in riferimento a quella gerarchia di valori
che abbiamo chiamato opzione fondamentale. Se l'atto cattivo è tale da orientare contro Dio la
coscienza, allora viene operata una separazione da Lui che deve definirsi mortale in ordine alla vita
eterna. Altrimenti per quanto grave l'atto non pregiudica l'orientamento dell'esistenza verso la
salvezza, anche se può essere premessa prossima del suo fallimento etico.
La parzialità di certe recenti posizioni teologiche, e soprattutto pastorali, sta nel dare importanza
o all'atto, considerato separato dalla persona che lo compie, o alla pura intenzione del soggetto. Ne
deriva quell'opposto estremismo di chi qualifica peccato mortale ogni colpa grave o di chi lo ritiene
quasi impossibile perché solo eccezionalmente una persona rifiuta Dio in modo esplicito. In questo
lassismo, che è la posizione oggi predominante ma per nulla liberatoria alla pari del rigorismo suo
contrario, si dimentica che la scelta moralmente colpevole di un atto gravemente contrario alla
volontà di Dio mortifica l'amore, separa da Lui, anche se il rifiuto di Dio è implicito e non diretto.
Ci sono azioni infatti, che per la loro gravità un uomo non arriva a compiere se non perché si è
affievolito l'orientamento del cuore verso il bene; quindi sono da qualificarsi mortali (crf.
Reconciliatio et Poenitentia, n. 17).
Cosicché, riassumendo, si può considerare peccato mortale un atto morale (quindi consapevole e
libero) compiuto contro Dio: l'opposizione a Lui, Bene supremo, può essere nella pura intenzione,
la quale può anche non pervenire a compiere l'azione progettata perché ostacolata dall'esterno, o in
un atto che per la sua gravità implica che la volontà sia contraria a Dio.
E' veniale invece quel peccato che essendo un'azione leggera non coinvolge profondamente la
coscienza nella opposizione a Dio; oppure, pur essendo una trasgressione grave, non è stato da
questa condiviso pienamente.
Chi nel qualificare la gravità del peccato considera solo l'intenzione, dimentica che l'uomo è
unitario e nell'agire fa sintesi tra l'intenzione e il dato di fatto. Chi al contrario considera quasi
esclusivamente la cosa compiuta, dimentica che il peccato sta nel cuore dell'uomo, perché da esso si
qualificano le azioni umane (Matt. 15, 19).
27
Una illuminata comprensione della colpa grave rende anche ragione di un problema classico per la
morale tradizionale: l'esistenza di atti che siano peccato mortale "ex toto genere suo", cioè tali che
non ammettono venialità. Ad esempio circa la sessualità si riteneva che ogni trasgressione anche
minima fosse un'opposizione tale all'ordine divino da costituire sempre peccato mortale. A parte
l'ignoranza della psicologia umana che stava alla base di questa posizione, occorre dire che dal
punto di vista teologico era determinata da una concezione dell'atto umano limitata al fenomeno in
sé, trascurando l'intenzionalità che è essenziale per qualificarlo moralmente. Ora nel caso specifico
dell'esercizio della sessualità si danno molte circostanze per le quali si deve convenire che l'azione
cattiva, e spesso colpevole, non inquina talmente la coscienza da separarla dalla carità divina, per
cui non ogni peccato sessuale è sempre mortale1.
Concludendo la riflessione sul giudizio circa la gravità del peccato, problema semplice sul piano
teoretico, ma così rilevante per la serena crescita delle coscienze, si può ricordare ancora un
assioma di S. Agostino: "Per valutare che cosa è grave e che cosa è leggero occorre seguire non il
giudizio degli uomini ma quello di Dio". Tale riferimento soprannaturale comporta di non essere
soffocati dal rigorismo, perché Dio è misericordioso, ma anche di non rimanere indolenti nella
mediocrità morale, perché la santità divina mette a nudo le più recondite opposizioni all'amore.
B. PECCATO PERSONALE E PECCATO SOCIALE
La cresciuta sensibilità della coscienza collettiva verso i valori etico-politici della giustizia e
dell'uguaglianza hanno accresciuto l'interesse della teologia morale verso quelle forme di male che
viene espresso dalle situazioni sociali e in particolare è prodotto dalle istituzioni che regolano la
politica e l'economia. E' entrata così nel linguaggio teologico la categoria di peccato sociale, per
indicare una colpa che non appartiene alla persona singola, ma a gruppi o a nazioni intere.
Il termine è molto efficace per segnalare responsabilità collettive e per richiamare che il male,
soprattutto quello verso il prossimo, non ha dimensioni individuali, ma si inserisce nei rapporti
collettivi, provocando ingiustizie esponenziali di gruppi, o addirittura nazioni, verso altri. La
divisione dell'umanità in “primo”, “terzo”, “quarto” mondo non è solo un'espressione giornalistica;
ma denuncia rapporti d'ingiustizia che tra l'altro non riguardano solo le aree geografiche, ma
intersecano ogni società del pianeta.
Tuttavia, pur riconoscendo la validità dell'espressione nel denunciare l'esistenza di colpe non
private, ma ugualmente gravi anche se collettive, occorre affermare che la responsabilità etica in
senso proprio rimane personale e solo indirettamente il singolo è colpevole di situazioni violente e
ingiuste, anche se di fronte ai mali sociali è molto facile che si configuri il peccato di omissione. Va
però ricordato che per tutta la Rivelazione il peccato sta nel cuore dell'uomo, nel luogo cioè da cui
1
Però mentre è da respingere come contrario alla rivelazione biblica il rifiuto di distinguere le colpe nella loro gravità, sarebbe
ugualmente errato pensare che il peccato veniale sia di poca importanza. Quale offesa a Dio, Bene sommo dell'uomo, e per la sua
forza di rallentare, fino a comprometterlo, il cammino morale verso la pienezza della vita cristiana, occorre combatterlo come un vero
ostacolo per la salvezza del battezzato.
Un tentativo di superare le difficoltà che comporta la valutazione della gravità del peccato viene compiuto con l'ipotesi, formulata da
alcuni teologi contemporanei, di una triplice classificazione; in ordine: peccato mortale, grave, veniale. La distinzione nuova viene
introdotta tra il peccato
mortale, che spegne ogni rapporto di carità con Dio perché l'opzione fondamentale si è spostata ad altri beni inferiori, e il peccato
grave, che pur compromettendo pesantemente la fedeltà alla scelta etica di Dio, non opera una rottura irreversibile verso di Lui.
Anche nel VI Sinodo dei Vescovi alcuni Padri hanno proposto il ricorso a tale distinzione tripartita per i vantaggi di chiarificazione
delle coscienze che secondo i sostenitori potrebbe produrre.
Una valutazione autorevole di tale ipotesi teologica è data dalla esortazione apostolica che raccoglie i risultati del Sinodo stesso: "La
tripartizione potrebbe mettere in luce il fatto che fra i peccati gravi esiste una gradazione. Ma resta sempre vero che la distinzione
essenziale e decisiva è fra peccato che distrugge la carità e peccato che non uccide la vita soprannaturale: fra la vita e la morte non si
dà via di mezzo." (Reconciliatio et Poenitentia, n. 17).
28
partono le decisioni che qualificano la personalità e danno valore positivo o negativo all'esistenza di
un individuo. Quindi solo in modo analogico si può parlare di un peccato sociale. In senso proprio il
peccato è sempre personale, con effetti, però, almeno come omissione, sul piano comunitario. E tali
conseguenze, va ricordato, concorrono a stabilire la gravità del peccato personale (cfr. Reconciliatio
et Poenitentia n. 16, dove i due concetti sono presentati e valutati con profonda lucidità, soprattutto
in riferimento ad alcune posizioni della cosiddetta “teologia della liberazione”).
4. La conversione: stato permanente di vita cristiana
La riflessione cristiana sul peccato umano promuove nella coscienza del battezzato l'atteggiamento
etico insistentemente richiamato dalla S. Scrittura: la conversione del cuore. E' il primo atto
dell'esistenza impostata secondo Cristo, che iniziò la sua predicazione con il programma
"Convertitevi e credete al Vangelo" (Mc. 1, 15). Ma tale impegno qualifica l'intera vita dei suoi
discepoli.
Infatti la condizione nuova in cui la Pasqua di Cristo ha posto l'umanità costituisce la premessa che
rende possibile la liberazione dal peccato, quale realtà che oppone a Dio. E poiché l'opera di Cristo
era finalizzata in ultima istanza a redimere l'uomo dallo stato di peccato per riconciliarlo con il
Padre, il discepolo di Cristo, deve concentrare la sua vita morale nel trasformare la propria
personalità dalla concupiscenza, ereditata per la solidarietà ad Adamo, alla carità, che è lo stato dei
rigenerati in Cristo. A questa meta infatti conduce l'azione dello Spirito Santo che ci è partecipato
per la fede in Gesù Salvatore. Esso è dato "per la remissione dei peccati" (Gv. 20, 23) e solo chi è
stato liberato dal peccato è accetto a Dio (Rom. 14, 17) e può entrare nel suo regno (Ef. 5, 5). Per
cui la conversione è al centro dell'esistenza etica cristiana come un dato permanente.
Può insorgere un'obiezione a questa tesi: "Perché il cristiano, che nel battesimo diventa creatura
nuova, è ancora esposto alla possibilità di peccare?". La Chiesa dei primi secoli ha sentito
fortemente questo problema: ne fa fede, oltre a diversi scritti patristici, la disciplina ecclesiale della
riconciliazione dei 'lapsi' (cristiani che durante la persecuzione avevano rinnegato la fede, e poi,
passato il pericolo, chiedevano la riammissione nella Chiesa) e dei peccatori pubblici. Le
condizioni per essere riconciliati erano molto severe e richiedevano anni di dura penitenza.
Ma già la prima lettera di Giovanni (cfr. 1, 6-2, 2 e 3, 4-10) rispecchia questo interrogativo
scandaloso, che sembrava falsificare la salvezza di Cristo: "Come è possibile che il cristiano pecchi,
se Cristo lo ha redento dal peccato?". E' l'obiezione che il pensiero anticristiano ha spesso posto alla
Chiesa: "Quale salvezza è il Cristianesimo se i cristiani non si discostano dalle miserie morali degli
altri uomini?".
La forza concettuale di questa obiezione ci conduce ad approfondire la condizione del battezzato:
avendo ricevuto lo Spirito di Cristo, ha in sé un'energia che lo rende capace di superare la schiavitù
del peccato. Quindi la lotta al male diventa un obbligo morale, conseguente al dono di grazia
ricevuto.
Ma la novità dello Spirito obbedisce alla legge della Pasqua. E come Gesù per risorgere nella gloria
del Padre dovette passare attraverso l'obbedienza della croce, così il discepolo deve
progressivamente spogliarsi delle passioni carnali per rivestire la carità perfetta. Quindi la sua vita
morale è un lungo cammino di purificazione, sostenuto e guidato dallo Spirito di Cristo. Il
permanere della colpa nei battezzati non vanifica la forza redentrice del mistero pasquale, ma ci
rivela che Dio, nella sua misericordiosa economia, salva gli uomini non rendendoli automi, ma
rispettandone la libertà, anche se inferma. Il convertito riconosce infatti, riflettendo sulla propria
esperienza, di essere pervenuto al nuovo stato interiore sospinto sì dalla grazia divina, ma anche con
l'adesione libera della sua volontà.
29
La conversione cristiana rimane pertanto un'esperienza soggettiva indicibile, ma verificabile dai
comportamenti, che si raccolgono in un rapporto di comunione con Dio, di pace con sé stessi, di
fraternità verso gli altri. Si vivono, con intensità diverse, i frutti dello Spirito elencati da Paolo in
Gal. 5, 22.
E' un cammino che, pur ostacolato da ripensamenti e involuzioni, orienta la personalità religiosa
alla Parusia, cioè a quello stato perfetto conosciuto nel Risorto e che costituisce la meta
dell'impegno morale.
Esso rivela la condizione del battezzato che vive tra il "già e il non-ancora": già redento per il
battesimo, non è pervenuto ancora a condividere perfettamente i dinamismi dell'umanità trasformata
in pienezza dallo Spirito Santo.
Gli autori spirituali schematizzano in tre tappe il cammino della conversione cristiana:
- l'adesione a Cristo quando si fa la scelta di vivere nella fede, rompendo con l'egoismo che pone
se stessi al centro del vivere;
- la ricerca seria di seguire le virtù ispirate alla carità che opera la scomparsa del peccato, anche
leggero, deliberato;
- quando lo spirito non incontra più resistenza e il battezzato può dire come Paolo: "E' Cristo che
vive in me" (Gal. 2, 20).
Ovviamente questi gradi spirituali non sono vissuti secondo la rigidità dello schematismo riportato:
si tratta nella realtà di un unico processo che conduce a spogliarsi del proprio io perché Cristo guidi
l'esistenza, come in Lui, in forza dell'amore unitivo perfetto, agiva Dio Padre.
Tale cammino, inoltre, nella norma dei cristiani non gratificati da doni speciali dello Spirito, deve
essere riconfermato a tutti i livelli, anche perché chi è pervenuto allo stato definito “terza
conversione”, può essere tentato contro la fede.
La Chiesa ha ricevuto dal suo Fondatore un sacramento deputato a rinnovare periodicamente la
riconciliazione, per cui la rottura con il peccato, operata nel battesimo, viene riconfermata dal
penitente. Egli poi trova nell'Eucaristia il sacramento che lo sostiene in modo perfetto nella
purificazione dai peccati.
Ma nella vita ecclesiale sono molteplici i modi e i tempi che invitano alla conversione del cuore: la
preghiera penitenziale, il digiuno, l’”elemosina", il tempo della Quaresima che è quasi un
sacramento per il popolo di Dio.
La conversione deve avere i caratteri che il Vangelo esige: deve essere cioè ferma, non superficiale,
e totalizzante, tale quindi da coinvolgere la persona nella sua profondità.
Infine a sorreggerla non siano motivazioni puramente etiche e psicologiche, ma promosse dallo
Spirito Santo, perciò teologali. Il che significa che il "dolore dei peccati" non deve consistere solo
nel rammarico per i propri errori morali o nell'umiliazione di aver mancato a un impegno assunto di
fronte a sé stessi. Ma deve essere ispirato dalla fede nell'opera di salvezza compiuta da Cristo,
motivato dalla speranza nella sua misericordia che suscita quell'amore che è pronto a dare tutto pur
di non separarci dalla carità di Cristo e che la Bibbia chiama "timor di Dio".
La conversione cristiana non ha pertanto solo una valenza negativa di rifiuto del peccato, ma
esprime la tensione morale del battezzato che aspira a pervenire a quella condizione di “amico di
Dio” che è per l'uomo lo stato di vera giustizia.
30
Capitolo V
LA FIGURA ETICA DEL CRISTIANO
La vita cristiana genera una personalità che riproduce, almeno tendenzialmente, l'esistenza di Cristo
Gesù. Abbiamo delineato nel capitolo IV come il cristiano vive l'esperienza negativa dell'eticità, il
peccato. Ora ci accingiamo a descrivere i caratteri positivi della moralità cristiana. Tale ricerca ci
porterà a definire gli atteggiamenti fondamentali, e i dinamismi che esprimono nei vari livelli della
esistenza le aspirazioni, i convincimenti, i criteri valutativi, insomma la figura morale del
battezzato.
1. Caratteristiche della moralità cristiana
Richiamiamo alcuni caratteri generali della morale ispirata cristianamente, come premessa a
descrivere la figura morale del battezzato.
1. La moralità cristiana è un'etica che coinvolge la personalità intera, partendo dalla sua interiorità
fino alle diverse espressioni dell'io. Non è cristiana l'osservanza di doveri senza l'adesione
convinta del cuore. Perciò la morale cristiana non è né formale, né rituale, ma personalista. Per
questo aspetto essa risponde alle esigenze della moralità umana in generale.
2. Il suo fondamento è ancorato all'Assoluto, per cui moralità e religiosità si integrano a vicenda.
La fede religiosa propone l'orizzonte dei fini morali, la loro autorevolezza e i mezzi per
realizzarli in comportamenti vissuti, il giudizio circa le mancanze verso gli impegni assunti;
l'etica verifica la serietà dell'opzione religiosa e ne inserisce le dinamiche nel concreto
dell'esistenza. Poiché la sostanza della religione cristiana consiste nel fatto che "Dio è amore" (1
Gv. 4, 8), è questo il valore morale ultimo perseguito dal cristiano. Tutti i doveri morali sono
espressione di questo unico comandamento.
3. Dal momento che la fede cristiana è intesa come risposta alla chiamata redentrice di Dio rivolta
all'uomo mediante Gesù Cristo, la moralità è vissuta come sequela, per cui non si esaurisce nella
osservanza di doveri, ma aspira a quella comunione interpersonale con Cristo, che è
condivisione di vita. Come afferma B. Häring (cfr. Liberi e fedeli in Cristo, Roma, 1979, pag.
12-13), è un vivere etico che coniuga due categorie morali apparentemente contrastanti: libertà e
fedeltà. La fedeltà del battezzato ai valori del Cristianesimo è totale, perché motivata dall'amore.
Ma non è legalista; muove dalla libera scelta che è alla base dell'atto di fede. La libertà a sua
volta non è individualistica; emerge da una relazione interpersonale che riconosce in Cristo
Risorto la meta delle potenzialità proprie dell'uomo. Coniugando la valenza della libertà e della
fedeltà, si può affermare che dal punto di vista antropologico la moralità cristiana è un'etica
della responsabilità.
2. Le virtù morali
Il cristiano è colui che si va costruendo, coerentemente con la fede professata, una vita morale che
abbia i connotati soprariportati.
La tradizione teologica per descrivere la figura etica del cristiano ha seguito tre schemi
fondamentali: i dieci comandamenti, i doveri del proprio stato, le virtù.
31
I limiti del ricorso a tali strumenti concettuali sono evidenziati dai risultati. Succintamente, poiché
alcuni rilievi sono già stati espressi nelle pagine precedenti, si possono elencare così le conseguenze
negative circa la concezione della moralità presso molti cristiani in dipendenza da quelle strutture
mentali:
- la frammentazione del vivere morale in tanti segmenti separati (es. la pratica religiosa che non
influisce sulla professione, ecc.) a scapito del formarsi di una personalità etica capace di scelte
coerenti nelle diverse situazioni esistenziali;
- tendenza legalista che puntava al minimo di moralità, anziché impegnarsi nel condividere la
sapienza paradossale del Vangelo. Il criterio che guidava la coscienza era prevalentemente il
binomio “lecito-proibito”, non la “beatitudine” del Discorso della Montagna;
- la riduzione dell'impegno morale agli aspetti soggettivi, lasciando in ombra la responsabilità
sociale del battezzato come cittadino e come membro della comunità cristiana;
- la difficoltà ad armonizzare, soprattutto per quanto riguarda lo schema delle virtù che suppone
una determinata antropologia, i contributi delle scienze umane e della teologia biblica con i
moduli tradizionali del discorso teologico morale.
Perciò nel movimento teso a rinnovare la teologia morale si è prodotto il tentativo di abbandonare il
concetto aristotelico-tomista di virtù, come inadeguato a delineare la personalità morale del
cristiano. Si è preferito come sostitutivo il concetto di "atteggiamento". Si intende per
"atteggiamento morale" il concretarsi dell'opzione fondamentale secondo la struttura della persona e
in riferimento alla situazione storica vissuta. Nel concetto di “atteggiamento” confluiscono infatti le
diverse dimensioni del soggetto: le passioni, le idee, la volontà, l'agire. E nell'atteggiamento 'morale'
si incontrano le motivazioni, che portano a scegliere determinati comportamenti fra altri, le richieste
che provengono da situazioni specifiche, le quali concretizzano nello spazio e nel tempo gli ideali
del soggetto; infine la proiezione verso il futuro della persona, che non può esaurire al presente
l'impegno morale, ma è attirata verso aspirazioni ulteriori.
In realtà la ricerca è pervenuta a risultati poco più che terminologici, perché anche muovendo dal
concetto di virtù, recuperato nella sua autentica accezione tomista, si imposta un discorso della
moralità capace di recepire quanto di innovativo la teologia morale fondamentale ha prodotto. Per
questo motivo il concetto di virtù è tornato a comparire nei trattati di morale sistematica.
La sua trattazione muove dal fine supremo dell'agire morale che è la dignità umana. Questa a sua
volta è da intendere come lo stato in cui l'uomo si sente pienamente realizzato. Nel cristiano la
realizzazione perfetta delle proprie aspirazioni passa dall'identificazione di se stessi nel Cristo e
quindi la scelta soggettiva si arricchisce di contenuti precisi, che sono le esigenze della fede nel
Signore Gesù. Sono i valori che la vita morale cerca di conquistare. E abbiamo visto che questo è lo
scopo di ogni attività morale, qualunque sia la sua ispirazione.
In questo cammino la coscienza è favorita dal formularsi di norme.
Ora, tra il valore e la norma che lo concretizza si inserisce, sul piano della realizzazione, il concetto
di virtù nel senso classico di habitus che significa "abitudine a volere e a condividere di fatto un
bene morale determinato". Ovviamente il termine ha il senso positivo di atti ripetuti non per inerzia,
ma consapevolmente; per cui in questo contesto “abitudine” diventa sinonimo di fedeltà o di
atteggiamento acquisito e non rimesso in discussione perché ancora condiviso. La virtù comporta
pertanto una predisposizione al valore morale rispettivo, ingenerato dalla ripetizione di atti che
muovevano da una scelta chiara di quel valore, e che facilita la decisione verso di esso quando la
coscienza è interpellata. In tal modo le virtù diventano elementi della fisionomia etica di una
persona, perché sono caratteri permanenti del soggetto.
Secondo S. Tommaso i valori morali fondamentali sono realizzati mediante l'acquisizione di quattro
virtù (prudenza, giustizia, fortezza, temperanza) chiamate cardinali perché cardine della moralità.
Esse ordinano le tre inclinazioni naturali che sono: l'istinto a conservarsi nella vita, la tendenza a
socializzarsi mediante rapporti parentali (famiglia) e mediante rapporti di comunità (vita sociale).
32
Le virtù debbono essere compresenti; infatti il raggiungimento del fine della moralità, la dignità
umana, non è possibile se ne manca anche parzialmente una sola.
Si può dire che la virtù è la progressiva umanizzazione della persona, la quale tra le diverse
categorie di bene (il piacevole, l'utile, l'onesto) acquisisce quello morale (il bene onesto) e diventa
così ciò che può e quindi deve diventare.
S. Agostino definisce la virtù "una buona qualità dello spirito, per mezzo della quale si vive
rettamente, della quale non si può fare cattivo uso (e che Dio opera in noi senza di noi)". La
determinazione racchiusa in parentesi si riferisce alle virtù infuse per grazia divina; ma il resto della
definizione è applicabile alle virtù acquisite mediante il vivere morale e che sono il risultato, mai
concluso, delle scelte che ognuno ha fatto utilizzando le doti naturali, gli stimoli ambientali e tutti
gli elementi che concorrono a formare il mondo morale. Essa inerisce, come una qualità buona e
quindi opposta direttamente al vizio, allo spirito e cioè alle sue quattro funzioni: intelligenza,
volontà, impulsi possessivi e di difesa.
Le virtù sono guidate dalla ragione, che mira a conseguire la perfezione della persona. Ora la
ragione che guida l'attività morale (ragion pratica) non si esaurisce nel puro conoscere, ma
coinvolge la volontà, perché il bene non basta discernerlo, occorre farlo; la perfezione infatti va
realizzata, non desiderata solamente. Tra intelligenza e volontà c'è integrazione reciproca in tutti i
passaggi del processo che conduce all'atto virtuoso: per volere una cosa bisogna conoscerla; ma se
si vuole, si cerca di conoscerla con più assiduità.
Quindi la virtù è una qualità permanente della persona intesa nella sua totalità. Essa risulterà dalla
valutazione di tutti gli aspetti dell'atto che si deve compiere.
Il pensiero classico esprimeva questo carattere della virtù con il concetto di medietas, che non
significa mediocrità o compromesso, ma la scelta di ciò che è più virtuoso nel caso concreto
sottoposto alla ragione. Ad esempio, la virtù della solidarietà porta a soddisfare i bisogni del
prossimo. Ma se un alcolista chiede alcool, normalmente sarò veramente solidale se glielo rifiuto.
Esistono molti elenchi delle virtù morali. Già Aristotele aveva elaborato elenchi di virtù, descritte
secondo la loro medietas, che le presenta tra i due vizi corrispondenti, estremi ed opposti, per
eccesso o per difetto.
S. Tommaso ne ha fatto una traduzione conforme alla fede cristiana (Summa T. I-II, qq. 55-70).
Poiché le virtù sono le capacità del soggetto che conducono razionalmente al fine morale, la loro
individuazione dipende dallo scopo ultimo nel quale il soggetto vede realizzata la sua perfezione.
Per il cristiano, come si è affermato più volte, la perfezione dell'uomo consiste nella comunione a
Dio mediante e nella misura di Cristo Gesù. In questa meta egli vede realizzate tutte le aspirazioni
umane che le virtù morali cercano di soddisfare. Ma questa meta suppone quella relazione a Dio che
è di fiducia, di attesa certa, quindi di comunione amorosa. Perciò le virtù teologali, fede-speranzacarità, sono per un certo verso il fondamento della figura etica del cristiano: sono cioè queste
aperture a Dio (perciò dette teologali) che caratterizzano come cristiana la moralità del battezzato.
Esse illuminano le capacità morali che egli possiede in quanto uomo e che secondo la tradizione
teologica vengono raggruppate intorno alle quattro cardinali.
Dice S.Tommaso: "Tutta la materia morale si riduce alla considerazione delle virtù...e tutte le virtù
sono riducibili a sette: delle quali tre teologali, che vanno considerate per prime; mentre le altre
quattro sono cardinali...Le altre virtù morali si riducono in qualche modo tutte alle virtù cardinali...
E così nulla sarà trascurato della materia morale" (Summa T., II-II, prologo).
Quindi le virtù naturali nel vissuto del cristiano sono il risultato della fede, perché la fede in Gesù
Cristo conduce il discepolo a vivere al meglio la sua umanità. Ma a loro volta le virtù naturali
33
verificano l'autenticità di quelle teologali, perché il cristiano vive da uomo la relazione a Cristo.
Una fede senza giustizia, ad esempio, non è conforme al vangelo e non risponde alla figura morale
del vero discepolo di Gesù. Le virtù teologali danno a quelle naturali, le quali ci accomunano a tutti
gli uomini in ricerca del bene morale, motivazioni e contenuti superiori al livello della semplice
ragione. La relazione a Dio infatti eleva le ragioni dell'impegno e ne amplifica la tensione.
Soprattutto poi danno i mezzi per acquisirle. Non c'è forza umana infatti che possa eguagliare
la fiducia e l'amore a Dio con l'attesa di Lui quale ricompensa, nel sostenere la fatica di diventare
giusti, forti, temperanti e di cercare secondo ragione (cioè prudentemente) tutte le possibilità di fare
il bene.
34
CONCLUSIONE
La moralità cristiana risulta dall'incontro tra ascesi del soggetto e dono di Dio, il quale nello Spirito
di Gesù redentore ha rigenerato la condizione dell'umanità e quindi il suo agire morale, vale a dire
quella prassi che conduce le persone a realizzare in pienezza la propria esistenza. Perciò la teologia
morale ispirata al cristianesimo assume, mediante un processo di discernimento, molti elementi
della ricerca etica razionale. Ma tali contenuti vengono trasfigurati dal fatto che la moralità cristiana
è sviluppo della vita soprannaturale donata germinalmente da Dio e affidata alla responsabilità del
battezzato, perché la faccia crescere in comportamenti conseguenti.
Il dovere e l’impegno quindi conseguono a un dono divino soprannaturale, il quale determina perciò
nel credente le mete e i modi di realizzarsi eticamente. La personalità etica del cristiano si configura
in una libertà che, sanata da Dio, responsabilmente ha accolto la sua chiamata e vi risponde
coerentemente. Essa sembra ben espressa da questo convincimento di S. Paolo raccolto nella prima
lettera ai Corinti (2, 12 segg.): "Di queste cose (“tutto ciò che Dio ci ha donato”) noi parliamo, non
con un linguaggio suggerito dalla sapienza umana, ma insegnato dallo Spirito, adattando dottrine
spirituali a uomini spirituali".
Possiamo tradurre parafrasando che l'agire morale, cioè il linguaggio della vita è docilità a Dio
("linguaggio...insegnato dallo Spirito") e che il sapere etico ha il suo scopo, umile ma tremendo,
nel fare incontrare ("adattando") il comandamento eterno di Dio con l'uomo vivo e concreto.
35
FONTI BIBLIOGRAFICHE
Riporto solo i titoli in lingua italiana facilmente accessibili e consentanei alle finalità didattiche del
presente lavoro.
A. PER LA FONDAZIONE BIBLICA DELLA MORALE
E. Testa, La morale dell'Antico Testamento, Morcelliana, Brescia, 1981
R. Schnackenburg, Messaggio morale del Nuovo Testamento, Paoline, Alba, 1971
AAVV, Fondamenti biblici della teologia morale, Paideia, Brescia, 1973
B. PER L'IMPOSTAZIONE SISTEMATICA DELLA TEOLOGIA MORALE GENERALE
M. Vidal, L'atteggiamento morale, Cittadella, Assisi, 1976
E. Chiavacci, Teologia morale 1, Cittadella, Assisi, 1977
F. Böckle, Morale fondamentale, Queriniana, Brescia, 1979
B. Häring, Liberi e fedeli in Cristo 1, Paoline, Roma, 1979
AAVV, Il fenomeno morale 1, Dehoniane, Bologna, 1981
C. Caffarra, Viventi in Cristo, Jaca Book, Milano, 1981
AAVV, Vita nuova in Cristo 1, Queriniana, Brescia, 1983
C. CIRCA TEMI SPECIALI DI TEOLOGIA MORALE FONDAMENTALE
F. Böckle, I concetti fondamentali della morale, Queriniana, Brescia, 1968
B. Schüller, La fondazione dei giudizi morali, Cittadella, Assisi, 1975
J. Fuchs, Esiste una morale cristiana, Morcelliana, Brescia, 1970
F. Compagnoni, La specificità della morale cristiana, Dehoniane, Bologna, 1972
C. Caffarra, La prassi cristiana nella teologia del 20° Secolo, Cittadella, Assisi, 1971
AAVV, Questione etica e impegno ecumenico delle Chiese, Dehoniane, Napoli, 1986
AAVV, La coscienza cristiana, Dehoniane, Bologna, 1971
A. Hortelano, Morale responsabile, Cittadella, Assisi, 1970
AAVV, Magistero e morale, Dehoniane, Bologna, 1971
AAVV, La legge naturale, Dehoniane, Bologna, 1970
J. Fuchs, Responsabilità personale e norma morale, Dehoniane, Bologna, 1978
AAVV, La fondazione della norma morale (nella riflessione teologica e marxista contemporanea),
Dehoniane, Bologna, 1979
AAVV, Ordine morale e ordine giuridico, Dehoniane, Bologna, 1985
B. Häring, Shalom: pace (nuove prospettive del sacramento della riconciliazione), Paoline, Roma,
1972
B. Häring, Il peccato (in un'epoca di secolarizzazione), Paoline, Bari, 1975
C. Vogel, Il peccatore e la penitenza nella Chiesa antica, LDC, Torino, 1967
Sono pure consigliabili alcune voci dei dizionari teologici
36
SOMMARIO
INTRODUZIONE
CAPITOLO I - L'EVENTO PASQUALE GARANZIA E NORMA DELL'AGIRE CRISTIANO
1. La Pasqua di Gesù garantisce la validità della proposta morale cristiana
2. La Pasqua è modello obbligato di Morale cristiana
3. La Pasqua è esperienza partecipata al battezzato nello Spirito Santo
CAPITOLO II - LA COSCIENZA
1. Dalla S. Scrittura
2. Dal Magistero ecclesiale
3. Indicazioni della Teologia morale
A. Natura ed autorevolezza della coscienza morale
B. Condizioni per l'agire della coscienza
C. Conflitti e patologia della coscienza
D. Coscienza individuale e Magistero ecclesiale
CAPITOLO III - LE LEGGI MORALI
1. Necessità e funzione della legge morale
2. Tipologia delle leggi morali
A. Legge divina rivelata
B. Legge umana positiva: ecclesiale e civile
C. Legge naturale
3. Legge naturale e magistero ecclesiale
CAPITOLO IV - L'ESPERIENZA DELLA COLPA ALLA LUCE DEL MISTERO PASQUALE
1. L'annuncio della salvezza cristiana e la esperienza umana della colpa
2. Significato del peccato nella riflessione ecclesiale della fede
A. Il significato del peccato nella Parola di Dio
B. Il contributo del Magistero gerarchico
C. Tentativi di definire il peccato
3. Distinzione tra i peccati: veniale/mortale - personale/sociale
4. La conversione: stato permanente di vita cristiana
CAPITOLO V - LA FIGURA ETICA DEL CRISTIANO
1. Caratteristiche della moralità cristiana
2. Le virtù morali
CONCLUSIONE
FONTI BIBLIOGRAFICHE
37