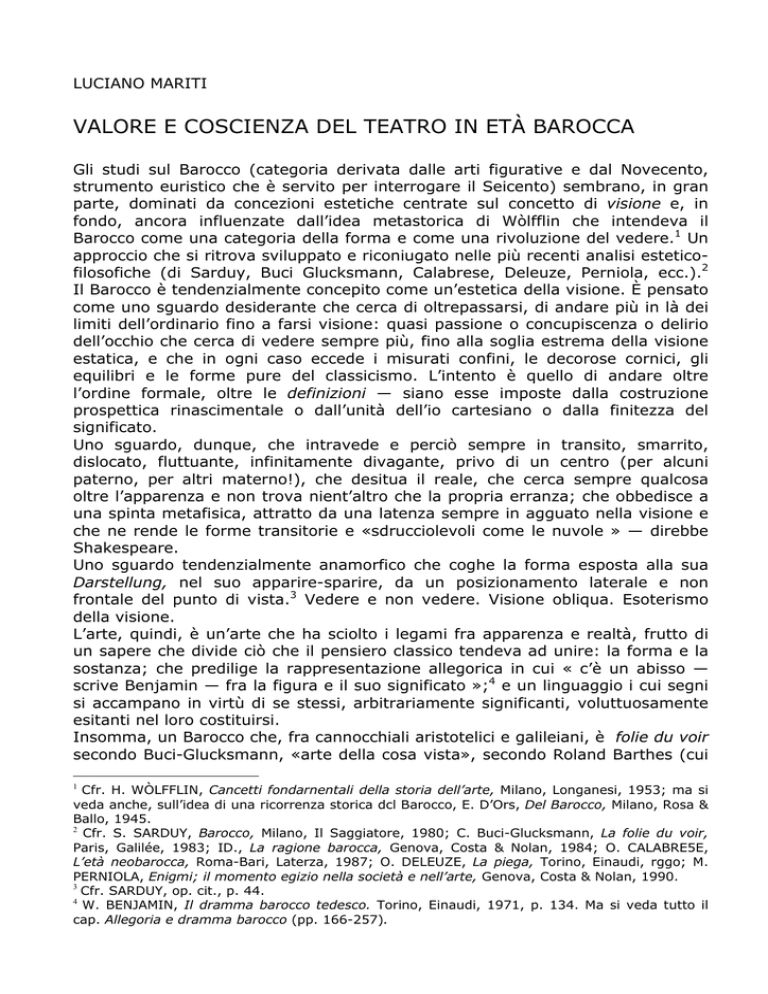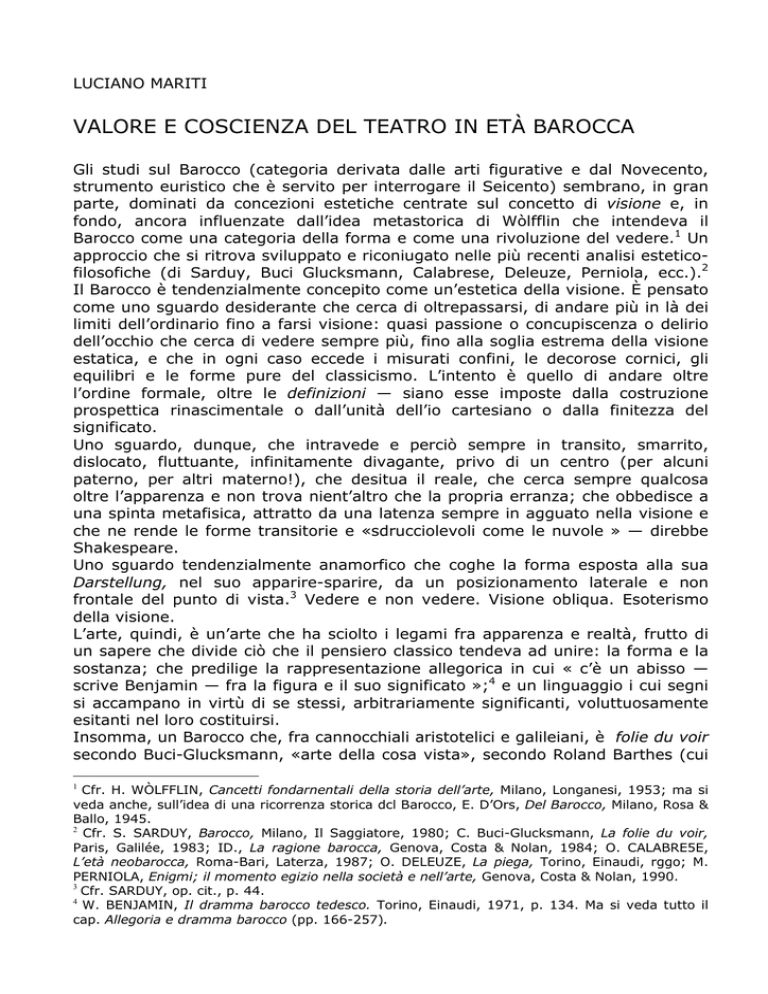
LUCIANO MARITI
VALORE E COSCIENZA DEL TEATRO IN ETÀ BAROCCA
Gli studi sul Barocco (categoria derivata dalle arti figurative e dal Novecento,
strumento euristico che è servito per interrogare il Seicento) sembrano, in gran
parte, dominati da concezioni estetiche centrate sul concetto di visione e, in
fondo, ancora influenzate dall’idea metastorica di Wòlfflin che intendeva il
Barocco come una categoria della forma e come una rivoluzione del vedere.1 Un
approccio che si ritrova sviluppato e riconiugato nelle più recenti analisi esteticofilosofiche (di Sarduy, Buci Glucksmann, Calabrese, Deleuze, Perniola, ecc.).2
Il Barocco è tendenzialmente concepito come un’estetica della visione. È pensato
come uno sguardo desiderante che cerca di oltrepassarsi, di andare più in là dei
limiti dell’ordinario fino a farsi visione: quasi passione o concupiscenza o delirio
dell’occhio che cerca di vedere sempre più, fino alla soglia estrema della visione
estatica, e che in ogni caso eccede i misurati confini, le decorose cornici, gli
equilibri e le forme pure del classicismo. L’intento è quello di andare oltre
l’ordine formale, oltre le definizioni — siano esse imposte dalla costruzione
prospettica rinascimentale o dall’unità dell’io cartesiano o dalla finitezza del
significato.
Uno sguardo, dunque, che intravede e perciò sempre in transito, smarrito,
dislocato, fluttuante, infinitamente divagante, privo di un centro (per alcuni
paterno, per altri materno!), che desitua il reale, che cerca sempre qualcosa
oltre l’apparenza e non trova nient’altro che la propria erranza; che obbedisce a
una spinta metafisica, attratto da una latenza sempre in agguato nella visione e
che ne rende le forme transitorie e «sdrucciolevoli come le nuvole » — direbbe
Shakespeare.
Uno sguardo tendenzialmente anamorfico che coghe la forma esposta alla sua
Darstellung, nel suo apparire-sparire, da un posizionamento laterale e non
frontale del punto di vista.3 Vedere e non vedere. Visione obliqua. Esoterismo
della visione.
L’arte, quindi, è un’arte che ha sciolto i legami fra apparenza e realtà, frutto di
un sapere che divide ciò che il pensiero classico tendeva ad unire: la forma e la
sostanza; che predilige la rappresentazione allegorica in cui « c’è un abisso —
scrive Benjamin — fra la figura e il suo significato »;4 e un linguaggio i cui segni
si accampano in virtù di se stessi, arbitrariamente significanti, voluttuosamente
esitanti nel loro costituirsi.
Insomma, un Barocco che, fra cannocchiali aristotelici e galileiani, è folie du voir
secondo Buci-Glucksmann, «arte della cosa vista», secondo Roland Barthes (cui
1
Cfr. H. WÒLFFLIN, Cancetti fondarnentali della storia dell’arte, Milano, Longanesi, 1953; ma si
veda anche, sull’idea di una ricorrenza storica dcl Barocco, E. D’Ors, Del Barocco, Milano, Rosa &
Ballo, 1945.
2
Cfr. S. SARDUY, Barocco, Milano, Il Saggiatore, 1980; C. Buci-Glucksmann, La folie du voir,
Paris, Galilée, 1983; ID., La ragione barocca, Genova, Costa & Nolan, 1984; O. CALABRE5E,
L’età neobarocca, Roma-Bari, Laterza, 1987; O. DELEUZE, La piega, Torino, Einaudi, rggo; M.
PERNIOLA, Enigmi; il momento egizio nella società e nell’arte, Genova, Costa & Nolan, 1990.
3
Cfr. SARDUY, op. cit., p. 44.
4
W. BENJAMIN, Il dramma barocco tedesco. Torino, Einaudi, 1971, p. 134. Ma si veda tutto il
cap. Allegoria e dramma barocco (pp. 166-257).
si deve anche la denuncia di un «imperialismo barocco della visione»5) che è
apoteosi e concupiscenza del vedere, ma anche ambiguità e disillusione del
vedere.
Naturalmente, una volta affermato il primato della vista nell’estetica e nella
sensibilità del Barocco, ne consegue che il Barocco non possa non realizzarsi nel
teatro, essendo il teatro — si ripete spesso — il luogo della visione effimera per
eccellenza.
Ma cosi non è, perché il teatro è anche poesia della visione, ma non sopporta di
essere ridotto ad un’estetica della visione tout court. Non solo perché percepibile
in modo polisensoriale e cinestetico; ma soprattutto perché è un’arte dell’uomo
che usa se stesso, come strumento e oggetto, per rappresentarsi ad altri uomini.
Contiene cioè un aspetto antropologico in cui si concentrano i complessi valori di
una cultura, con un’intensità tale che non può essere emulata da operazioni
meno immediate. Un aspetto che non si può eludere, a meno che non si voglia
parlar d’altro.
La Visionarietà “figurativa” del Barocco rischia di rispecchiarsi nell’occhio
sapiente della critica con pericolosi eccessi perché — lo ricordano proprio le
figure mitiche predilette dal Barocco: da Orfeo a Narciso a Psiche a Medusa a
Proteo — «a forza di voler estendere la portata dello sguardo, l’anima si offre
all’accecamento e alla notte»6.
Ironia a parte, cercherò di fare qualche riflessione sul valore e sulla coscienza
che il teatro ha di se stesso con un orientamento metodologico rivolto non
all’abusato coté visivo-estetico del presunto spettacolo, ma all’aspetto
antropologico del teatro, vale a dire all’uomo-attore, all’uomo di teatro, la cui
forte presenza è il cuore e il respiro vitale della più atta drammaturgia barocca7.
Ricordando, preliminarmente, che sotto tanto effimero barocco c’è la massima
concretezza: la diffusione, cioè, del professionismo delle compagnie teatrali che,
sostituendosi alla tradizione dilettantesca iniziata nel Medioevo, determina il
profilo moderno del teatro occidentale, con il costituirsi dell’impresa teatrale,
l’apertura dei primi teatri pubblici, l’affermarsi di una nuova collocazione sociale
e culturale dell’attore. In una parola, si muovono i primi fondamentali passi
verso l’istituzione del teatro: ed è questo il dato concreto e davvero unificante
nel panorama teatrale barocco.
E bene inoltre, sempre preliminarmente, ricordare che Proteo, protettore del
teatro, se agita la sua incessante girandola di metamorfosi lo fa anche per
difendersi. Le variae species e gli ora ferarum che Proteo assume allo scopo di
eludere la presa di Menelao nel poema omerico e quella di Aristeo nelle
Georgiche, sono finalizzati alla conquista di un’invisibilità che rende invulnerabili.
La difesa di Proteo, l’indovino che conosce il passato e il futuro, non è la fuga,
ma l’esporsi alla vista e insieme il rendersi invisibile per eludere la presa di chi lo
minaccia o di chi minaccia il suo potere. Un aspetto di cui bisognerà tener conto
5
Cfr. BUCI-GLUCKSMANN, La folie, ct.; R. BARTHES, Sade, Fourier, Loyola, Torino, Einaudi,
1977, p. 54: «l’occhio diviene l’organo fondamentale della percezione come attesterà il Barocco,
che è arte della cosa vista».
6
Cito da J. STAROBINSKI, L’occhio vivente, Torino, Einaudi, 1975, p. 9.
7
Sulla drammaturgia secentesca, indagata anche nel suo sviluppo dalla tradizione
cinquecentesca, cfr. C. FALLETTI CRUCIANI, Il teatro in Italia, Il Cinquecento e Seicento, Roma,
Studium, 1999.
quando parleremo di un teatro “di mestiere”, che in quest’età tenta a fatica di
difendere il suo stesso diritto all’esistenza, rendendosi appunto visibile-invisibile.
1. L’età barocca è l’età d’oro del teatro8. Corneille, ne L’Illusion comique,
dichiara che « à présent le Théàtre / est en un point si haut que chacun l’idolàtre
». E l’amore di tutti «i grandi spiriti», del popolo, dei nobili e «perfino del nostro
grande re»9. Il teatro è praticato in ogni dove: nella piazza carnevalesca, in
Corte, in Accademia, nei collegi, nelle stanze private, e da tutte le classi sociali.
A Roma, nei primi anni del secolo, una generazione di più di cento attori
dilettanti (accademici, studenti, bottegai, artigiani, pittori, avvocati, scrittori di
cui conosciamo nome e cognome, attività e parti interpretate) improvvisano
commedie «ridicolose» con maschere10. La stampa teatrale aumenta
enormemente»11, e per la prima volta ha larga diffusione un teatro in forma di
libro che avrà forti conseguenze nel sistema teatrale moderno.
La scrittura teatrale è considerata dai giovani letterati il linguaggio più adatto a
tradurre la loro visione del mondo, come accade in Inghilterra o nella Francia
degli anni Venti con Mairet, Pichou, Rotrou, Mareschal, Scudery e Corneille12. Ma
c’è anche un teatro che fa a meno del testo scritto, come la commedia dell’arte.
La presenza del teatro nella società è straordinaria. Tuttavia, se le corti d’Europa
e le accademie fanno gare di messinscena, se Richelieu fa costruire la più bella
sala di teatro nel suo palazzo, se insomma c’è tanto interesse per le scene, è
perché il teatro non è concepito e percepito soltanto come un linguaggio artistico
o una forma estetica dell’illusione: è anche un sapere in azione che sembra
addirittura soddisfare la maniera in cui l’uomo barocco conosce il mondo.
Mi riferisco, ovviamente, all’idea ossessiva, riproposta in mille modi, del mondo
come teatro, del teatro metafora di un universo rappresentabile nel quale gli
8
Per un’analisi organica dello spettacolo secentesco italiano, cfr. S. CARANDINI, Teatro e
spettacolo nel Seicento, Roma-Bari, Laterza, 1990; ma si veda anche F. ANGELINI, Barocco
italiano, in Storia del teatro moderno e contemporaneo, dir. R ALONGE e G. DAVICO BONINO, I.
La nascita del teatro moderno. Cinquecento-Seicento, Torino, Einaudi, 2000, pp. 194-274.
9
P, CORNEILLE, L’illusion comique, comèdie, Paris, Targa, 1639, v 5 1781-82.
10
Al riguardo è testimonianza preziosa e rara un Indice manoscritto compilato da Giovanni Briccio
(1579-1645), che elenca ben cento attori dilettanti che hanno recitato con lui « più di una volta»,
delineandone sinteticamente il ruolo e i modi recitativi. L’Indice, rinvenuto e copiato da Carlo
Cartan nel 168o in casa di Basilio, figlio di Briccio, è conservato all’Archivio di Stato di Roma,
CartariFebei, cc, 232v-236v.
11
Si vedano, come significative del forte impulso impresso nel Seicento all’editoria teatrale, la
situazione romana e napoletana di cui conosciamo alcuni dati concreti. Sulla prima cfr. S.
FRANCHI, Drammaturgia romana. Repertorio bibliografico cronologico dei testi drammatici
pubblicati a Roma e nel Lazio. Secolo XVII, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1988; ma vd.
anche L. MARITI, Commedia ridicolosa. Comici dilettanti, professionisti ed editoria teatrale a
Roma nel Seicento, Roma, Bulzoni, 1978, pp. XL-LXX. Sull’editoria napoletana vd. M. BRINDICCI,
Il libro di teatro a Napoli nel XVII secolo, 1994 (tesi di dottorato di ricerca in Italianistica, Facoltà
di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Napoli). Per la situazione francese è ancora
molto utile H.J. MARTIN, Livre, pouvoirs et société à Paris au XVII’ siècle (1598-1 701), Genève,
Droz, 1969. Il fenomeno del resto riguarda anche la letteratura: «i poeti barocchi, in
particolarissimo modo il Marino, sono i primi ad usare su larga scala e con spirito da mass-media
gli strumenti di moderna diffusione della cultura che sono la stampa e l’editoria » (A. ASOR
ROSA, Sintesi di storia della letteratura italiana, Firenze, La Nuova Italia, 1972, p. 208).
12
J. Schérer fa notare che « entre 1625 et 1630, Mairet, Auvray, Baro, Du Ryer, Pichou, Rotrou,
Scudéry, Maresehal, Rampale, Rayssiguier et Corneille font jouer leur première pièce » (J.
SCHÉRER, Théatre du XVII’ siècle, Paris, Gallimard, 1975, Vol. I p. XVII).
uomini recitano come attori: attori — aggiungerà uno Shakespeare blasfemo —
di una favola « raccontata da un idiota, piena di rumore e di furia / che non
significa nulla» (Macbeth, v 27-28).
Il Theatrum Mundi non è un’invenzione del Barocco, sebbene quest’età abbia
avvertito acutamente il senso di un mondo scardinato, in cui la sola impressione
di consistenza è fornita da Dio. Questo vecchio topos — appartenuto ai
presocratici, trasmesso dal platonismo e dai padri della Chiesa al Medioevo per
essere integrato in una visione provvidenzialistica, accolto poi dal Rinascimento
in versione scettica nel momento in cui il teatro, da evento rituale, si trasforma
in distaccata rappresentazione con il conseguente senso d’oggettivazione del
mondo e d’allontanamento da Dio — è cosi ben integrato e funzionale
all’ideologia barocca da apparire ben presto un luogo comune13. Quando Don
Chisciotte pronuncia l’elogio della commedia, mettendola in relazione con la
commedia del mondo, Cervantes affida a Sancio una sottolineatura ironica: «
bellissimo paragone — disse Sancio — tuttavia non tanto nuovo, perché l’ho
udito molte e diverse volte» (II 12)14. Dunque già nel 1615 è un modo di dire
abusato, oltre che astratto e libresco. È una formula che spiega tutto senza
niente spiegare; e, tuttavia, rimane un segno fortemente indiziario del valore
culturale assunto dal teatro, che ora sembra essere il luogo concreto in cui può
manifestarsi una diversa appercezione della realtà.
In altri termini, il teatro avrebbe avuto il grande pregio di poter testimoniare, in
virtù della sua specifica natura, la ricaduta epistemologica del passaggio —
direbbe Thomas Kuhn -15 da un paradigma scientifico ad un altro, da un Sistema
di conoscenza ad un altro. Per Foucault, la passione per il teatro sarebbe l’effetto
dell’abbandono di un sapere basato sulle “somiglianze”. Un sapere che comincia
ad essere oggetto di critica da parte di Bacone e poi di Cartesio poiché,
annullando ‘e differenze e le identità, tendeva ad attribuire ad una cosa la
caratteristica dell’altra producendo equivoci e confuse verità. Quando, agli inizi
del XVII secolo, l’età delle corrispondenze — scrive il filosofo — sta per chiudersi
in se stessa,
dietro di sé non lascia che giochi. Giochi i cui poteri magici traggono alimento dalla nuova parentela tra
somiglianza e illusione; le chimere della similitudine prendono ovunque forma, ma si sa che sono chimere:
è il tempo privilegiato del trompe-l’oeil, dell’illusione scenica, del teatro che si sdoppia e rappresenta un
teatro, del qui pro quo, dei sogni e delle visioni; è il tempo dei sensi fallaci; è il tempo in cui metafore,
paragoni, allegorie definiscono lo spazio poetico del linguaggio16.
13
La metafora Theatrum mundi, adottata anche da Erasmo nell’Elogio della pazzia, pubblicato
nel 1515 (ERASMO DA ROTTERDAM, Elogio della pazzia, a cura di T, FIORE, Torino, Einaudi,
1961, p. 25), acquisisce massima estensione nel Seicento anche in virtù della sua
rappresentabilità allegorica, a cominciare dall’auto sacramntal, del 1635,di Pedro Calderòn de la
Barca, Elgran teatro del mundo. Sull’argomento si vedano, almeno, J. JACQU0T, Le théatre du
monde de Shakespeare à Calderòn, in « Revue de Littérature comparée 5, XXI 1957, pp. 341-72
M. COSTANZO, I segni del silenzio, Bulzoni, Roma, 1983; L.G. CHRISTIAN, Theatrum mundi.
The History of an Idea, New York-London, de Gruyter, 1987.
14
MIGUEL DE CERVANTES, Don Chisciotte della Mancia, a cura di C. SEGRE e D. MORO PINI,
trad. di F. CARLESI, Milano, Mondadori, 1974, p. 682. Il secondo libro, cui appartiene la
citazione, è scritto nel 1615.
15
T, KUHN, La struttura delle rivoluzioni scientifiche. Come mutano le idee della scienza, Torino,
Einaudi, 1978. Sugli effetti della rivoluzione scientifica nel pensiero barocco vd. SARDUY, op. cit.
16
M. FOUCAULT, Les mots et les choses, Paris, Gallimard, 1966, p.65 (ed. it.: Le parole e le
cose, trad. di E. PANAITESCU, Milano, Rizzoli, 1978, p. 66).
Non è, però, solo i tempo dei giochi, delle fantasticherie e dei fascini d’un
vecchio sapere non resosi ancora “responsabile”. E anche e soprattutto il tempo
in cui, nei capolavori drammatici del Seicento (penso a Molière e a
Shakespeare), si può vedere la crudele ragione delle identità e delle differenze
(Otello, Shylock, ecc.) deridere all’infinito corrispondenze e similitudini, proprio
perché è soprattutto a teatro che è possibile spezzare più facilmente la vecchia
parentela del linguaggio con le cose.
Il teatro, nel passaggio epistemico all’età moderna, è nel punto di
contraddizione. Non è alienato nel sapere per corrispondenze né in quello per
differenze. È più semplicemente abilitato a testimoniare la tensione del rapporto
fra realtà e apparenze. Rapporto che, per Orlando, è il comune denominatore
delle tematiche letterarie barocche, di quelle costanti di cui ha parlato Rousset:
la metamorfosi, e la sua variante affetti va che è l’incostanza, il travestimento, il
doppiamento e lo sdoppiamento, i temi dell’inganno, dell’illusione,
dell’ostentazione, e di tutta l’imagerie dell’effimero: nuvole, acqua, specchio17.
Illusorie permanenze e apparenze, liquidità e “specchiosità” quasi spirituali e
molto astratte che tanto affascinano e deliziano chi studia il Barocco.
La finzione del teatro è disattivare e rivitalizzare il rapporto fra apparenza del
reale e mondo dell’autenticità. Perché il teatro conosce i “sembra” e, come
accade nel sogno o nella follia, trattiene sempre qualcosa della cosa originaria ed
autentica o ne rivela l’assenza costruendola come apparenza. Il teatro non dice
né la verità né il falso, sta solo in mezzo per provocare la tensione e lo scarto
folgorante con la realtà, quello straniamento chiamato «maraviglia», che rivaluta
il mondo alla luce di una nuova appercezione o, al contrario, lo svaluta in quanto
apparenza ingannevole: sembianza che scintilla davanti agli occhi e svanisce allo
sguardo di chi gli si porta vicino, per ricomporsi un po’ più in lì Apparenza che
non si lascia cogliere se non nel mutamento, nello sparire dalla vista, perché la
sostanza che la abita si pone sempre al di là, aspira a trascendersi, a tradursi in
sostanza metafisica. Con un innegabile effetto di turbamento che il relativismo
infinito di questo processo di Denaturierung produce.
La propensione all’eccesso del Barocco18 contribuì, indubbiamente, ad
accentuare ulteriormente quella naturale disposizione all’extraquotidiano che è
propria del teatro in quanto imitazione dell’azione possibile19. E lo spinse a
17
Cfr. F. ORLANDO, Illuminismo, Barocco e retorica freudiana, Torino, Einaudi, 1972 (nuova ed.
ampliata), pp. 72-73.11 riferimento è a J. ROUSSET, La Littérature de l’age baroque en France.
Circe et le paon, Paris, Corti, 1954 (trad. it.: Bologna, Il Mulino, 1985).
18
Vd. J.A. MARAVALL, Culture of the Baroque, Minneapolis, Univ. Of Minnesota Press, 1986, che
considera l’eccesso il tratto caratterizzante della cultura barocca.
19
Secondo Aristotele « compito del poeta non è dire le cose avvenute, ma quali possono
avvenire, cioè quelle possibili [dynata] secondo verosimiglianza [katà to eikos] o necessità [ katà
te anankaion] » (ARISTOTELE, Poetica, 5Ia 36-37, trad. a cura di D. LANZA, Milano, Rizzoli,
1987, p. 147). Il poeta, a differenza dello storico, deve rivolgersi a quella specifica sfera di realtà
che è la possibilità. Funzione del dramma non è riprodurre una determinata « composizione dei
casi», ma di rappresentare pragmata fra loro connessi secondo relazioni di verosimiglianza o
necessità. Il verosimile non coincide con ciò che possa essere accertato in quanto effettivamente
accaduto, ma con ciò che, potendo accadere, esprime un ordine di possibilità del reale.
Significativa è l’esemplificazione addotta da Aristotele a chiarimento del concetto di
verosimiglianza: l’episodio della statua di Miti che uccise il colpevole della morte del personaggio
raffigurato rovinandogli addosso. Episodio sempre richiamato e accostato alla statua mobile del
Don Giovanni: per Goldoni una “buffoneria” talmente inverosimile, da essere eliminata nel suo
rifacimento del dramma.
creare incessantemente mondi possibili e visibili, generando in noi l’impressione
che questo teatro sia sempre in fuga dall’ordinario e dal quotidiano, di cui non
sembra esserci traccia sulle scene.
A volte nella commedia si avverte un’ondata di calda simpatia per la realtà o
un’allegrezza con cui la natura sembra rivendicare il suo lieto trionfo sopra il
destino, ma più spesso la commedia annuncia un riso fragoroso. Il teatro
corteggia la realtà, ma la sberleffa, ghigna alle sue spalle come un bambino
irrispettoso davanti ad una vecchia signora. E finge persino di essere un teatro
stupido e volgare, ma perché stupida e volgare è la realtà. Disarmato di fronte al
reale, il Barocco elegge il teatro, come la biblioteca, a non luogo in cui poter
leggere la vita perché qui trova ciò che è riparato e coperto. Cerca qui una
rassicurazione perché, non fermandosi al cuore inalterabile delle cose (come la
ragione classica), rischia la vertigine della relatività assoluta.
Quest’effetto di derealizzazione provocò anche quell’evidente essere e non
essere, quell’incertezza del personaggio su se stesso, smarrito fra sdoppiamenti
e travestimenti, preso nelle maglie labirintiche dell’accadere, messo in maschera
e persino ridotto a misteriosi ossimori come quei fantasmi di padri e d’eroi che
insistentemente ritornano, ombre d’acciaio e di marmo che parlano e
camminano, come il padre d’Amleto e l’altro padre e commendatore del Don
Giovanni.
Deputato ad essere termine di confronto con il mondo, il teatro mantenne
comunque la sua ambiguità ermeneutica: sostanzialmente preparò all’incertezza,
alla visione non univoca. Inquietò confortando. Segnalò il vero tradendolo.
Incarnazione di mille ossimori, dimostrò che solo l’intelligenza degli angeli è
univoca: quella degli nomini giunge alla verità attraverso la contraddizione. E si
offrì anche come sintesi conciliatrice di livelli culturali e di contrasti passionali e
come potenziale disvelatore dei tarli di quel sistema rigidamente ideologico.
Eppure il teatro barocco — e perfino quello professionale, a lungo rifiutato dalla
Chiesa — sembrò acquisire Valore e piena legittimità solo quando riuscì,
direttamente o indirettamente, ad assicurare una ricaduta metafisica al “discorso
culturale”, che può esprimersi così: se il mondo è apparenza, cioè sogno, pazzia,
teatro, allora la realtà autentica è in quell’altro mondo che Platone prima e il
cristianesimo poi hanno posto.
Paradossale riscatto metafisico per un’arte cosi ruvida e materiale qual è il
teatro!
2. Il Valore assunto dal teatro, che si fa finestra epistemologica e metafisica
delle apparenze, è dovuto a un presupposto teologico, ben presto divenuto un
atteggiamento mentale proprio del cristianesimo, che a mio parere spiega alcuni
aspetti fondamentali del Barocco. Mi riferisco al fatto che il cristianesimo ha
sostituito la verità con la fede che un qualcosa sia vero. Il cristianesimo, ha
scritto acutamente Nietzsche, «sa che è in sé completamente indifferente il fatto
che una cosa sia vera o no, ma è estremamente importante, invece, fino a che
punto sia creduta [..J. Se per esempio, è insita una felicità nei credenti redenti
dal peccato, come premessa di ciò, non è necessario che l’uomo sia peccatore,
ma che si senta peccatore »20.
20
F. NIETZSCHE L’Anticristo. Maledizione del cristianesimo, a cura di G. COLLI e M. MONTINARI,
versione di F. MASINI, Milano, Adelphi, 1984, p. 27. La stessa lotta contro il peccato — scrive il
Se importante è credere, se importante è ciò che fa fede, allora è evidente
perché il massimo rilievo fu dato alla retorica, che è l’arte di persuadere l’altro
affinché la cosa sia creduta vera. Ma il presupposto teologico spiega anche il
carattere dell’episteme barocca fondata sulla metafisica delle apparenze (credere
vero solo il mondo che sta dietro il mondo) ed espressa nella formula del Mondo
come Teatro che non vuoi dire, appunto, che il mondo è semplicemente un
teatro, ma che è indifferente che il mondo sia vero o falso: importante è fino a
che punto sia credibile.
Il teatro in fondo interpretava un esercizio importante per l’anima, inducendo lo
spettatore a ritenere il mondo né vero né falso, ma comunque non credibile, non
completamente degno di fede. Il teatro, specie quello profano, esprimeva così,
paradossalmente, la vera retorica richiesta dal cristianesimo (o dalla casta
sacerdotale per la quale è sempre essenziale che si pecchi): persuadendo alle
visioni, persuadeva al nulla e induceva lo spettatore a sentirsi peccatore.
Il teatro profano, sebbene fosse apparentemente osteggiato, ebbe enorme
sviluppo in un’età di religioni guerreggiate, perché fu, per così dire, una manna
per la Chiesa. E se nel concetto che non è importante la verità, ma solo il grado
di credibilità, c’è la radice dell’ipocrisia, allora sorge spontanea questa domanda:
che il teatro, o almeno certo teatro, sia stato un progetto di Dio contro l’ipocrisia
della Chiesa?
Se l’ipotesi è giusta, allora dovrebbero considerare Molière come una spia
mandata dagli dèi e il suo teatro come un antiteatro fra i teatri barocchi. Non
solo per questioni stilistiche (unifica e semplifica il complesso), ma perché osò
mettere gli spettatori nella condizione di interrogarsi su «cosa fa fede »21.
Accadde nel 1669 col Tartuffe (e poi col Dom Juan), con la storia di un vampiro
che, con le grimaces di Dio, tenta di succhiare donne e patrimonio alla famiglia
del succube Orgon. Com’è noto, lo spettacolo fu uno scandalo assoluto —
Bossuet lo riteneva ancora un affronto più di vent’anni dopo — che svelò come
l’ipocrisia sia la madre di tutte le retoriche e di tutti i finti teatri. Fu uno
spettacolo contro quella retorica dell’apparenza e quella metafisica del Mondo
come Teatro che faceva recitare agli attori il ruolo di capro espiatorio (ombre
d’uomini fra le ombre della scena). Fu un’onda di realtà vera e di riso comico che
spazzò via quei teatri delle apparenze — retorica del Cielo — che pretendevano
di parlare in nome di Dio. E quindi fu la più decisa « rivelazione di esistere » (per
usare una bella espressione di Cesare Garboli) offerta all’uomo barocco, e la più
coraggiosa.
Molière giunge al termine di un lungo percorso costellato di polemiche fra teatro
professionale e Chiesa, in cui nessun attore, pur conoscendo l’efficacia del
teatro, osò sostenere la supremazia fascinatoria dell’actio teatrale su quella
sacra, ponendo il teatro come rivale della Chiesa.
filosofo — si basa su un processo per cui alla verità di natura che si esprime in piacere-dolore
subentra la verità creduta di premio-castigo, che fa riferimento alla nozione di peccato « a
quell’unica condizione — dice Nietzsche — che si oppone alla vita » e da cui ci si redime
sentendosi appunto peccatori (p. 197).
21
Cfr. M. FUMAROLI, Eroi e oratori. Retorica e drammaturgia secentesche, Bologna, Il Mulino,
1990, p. 334.
Polemiche e processi22 furono all’ordine del giorno, ma a rendere del tutto vani
fu un colpo di realtà: la conquista da parte delle compagnie teatrali di una
sempre più ampia autonomia economica. La metafora del Mondo come Teatro
per i professionisti del teatro non era mai stata il principio di una visione
religiosa del mondo, bensì la definizione di una fetta di spazio pubblico,
autonomo e laico, che è quello spazio su cui sarà fondata l’istituzione del teatro
nella città borghese.
3. Il fatto che il valore del teatro fosse stato cori transvalutato in metafisica, era
determinato anche dall’essere, il teatro, l’esatto contrario: azioni di corpi fisici in
forma di personaggi che attraggono l’attenzione d’altri corpi. Il teatro era
naturalmente et in substantia eros; e proponeva, in un mondo di religiosi
scannamenti, questo valore, riattizzando continuamente sulle scene una delle
più forti contraddizioni che attraversa la cultura barocca: quella fra Eros ed
Ethos.
Già di per sé il teatro è festa dei sensi, gioiosa o luttuosa che sia. Ma tutta la
drammaturgia barocca è abitata apertamente o segretamente da Amore che
cerca di trionfare sulle leggi e le logiche della morale e della politica.
Gli esempi potrebbero essere molti. Basti ricordare l’istituzione in Francia, pur
con esiti diversi, tra barocco corneilliano e razionalismo raciniano, di una scena
che fu scuola di sentimenti e di passioni;23 o, più in generale, tener presenti i
personaggi della tragedia, mai pacatamente illuminati — come le figure della
pittura manieristica — ma sempre tagliati a luci crude, mentre ostentano il
potere e nel contempo soggiacciono all’arbitrio di bufere passionali, come lacere
bandiere sventolanti.
Bufere passionali che agitano ancor di più le eroine della tragedia, vittime della
ragion di Stato o dei propri padri (Merope), ma capaci di suscitare anche fantasie
sensuali (Iudit), cosi come le innumerevoli Cleopatre e Lucrezie, o le Maddalene
della spiritual tragedia, o, ancora, le protagoniste delle pastorali fra le quali
ricordo Corisca del Pastor fido di Guarini, ninfa perversa e «teorica
dongiovannesca del desiderio mobile, indifferenziato e molteplice»24 e la
scandalosa Filli di Sciro (dell’omonima pastorale del Bonarelli) che ama
contemporaneamente due pastori.
È soprattutto la pastorale — proprio il genere che appartiene tutto al Barocco e
che muore col Barocco — proporre accensioni erotiche più alte e sottili, rispetto
22
Sull’argomento: F. TAVIANI, La commedia dell’arte e la società barocca. La fascinazione del
teatro, Roma, Bulzoni, 1969; ID., Introduzione a N. BARBIERI, La supplica, discorso famigliare a
quelli che trattano de’ comici, Milano, Il Polifilo, 1971, pp. XI-LXXXV; M. FUMAROLI, La querelle
de la moralité du théatre avant Nicole et Bossuet in « Revue d’histoire littéraite de la France »,
LXX 1970, pp. 1007-30; ID., Eroi, cit., capp. VIII e IX; M. LOMBARDI, Processo al teatro. La
tragicommedia barocca e i suoi mostri, Pisa, Pacini, 1995
23
Cfr. MACCHIA, La scuola dei sentimenti, Caltanissetta-Roma, Sciascia, 1963.
24
ANGELINI, op. cit., p. 164 (ma cfr. tutto il sintetico e stimolante par. Ameni loci: il terzo
genere, pp. 254-66). Sulla pastorale vd. Sviluppi della Drammaturgia Pastorale nell’Europa del
Cinque-Seicento. Atti del xv Convegno Internazionale promosso dal Centro Studi sui Teatro
Medioevale Rinascimentale (Roma. 23-26 maggio 1991), a cura di M. CHIABO’ e F. DOGLIO,
Viterbo, Union Printing, 1992; e, fra i contributi più recenti e più validi: LOMBARDI, op. cit.; e il
cap. III (La ninfa e il bosco, Ambienti pastorali nel teatro barocco) di Teatri barocchi, Tragedie,
commedie, pastorali nella drammaturgia europea fra ‘5oo e ‘6oo, a cura di S. CARANDINI, Roma,
Bulzoni, 2000, pp. 375-602.
alla tragedia e all’osceno risibile della commedia, che saranno poi ancor più
accentuate dal melodramma.
La pastorale è, infatti, un vero e proprio viaggio iniziatico alla scoperta e alla
comprensione dell’amore. Un percorso con le sue tappe ascensionali, che vanno
dalla rivelazione alla coscienza del corpo (anche nelle sue forme bestiali), fino
alla sua costante rimozione. Un percorso, potenzialmente metafisico, verso
l’armonia platonica o verso il sublime, ma che attraversa il mistero del rapporto
consustanziale che l’amore intrattiene con la violenza, e a cui si debbono vittime
sacrificali, guerre d’amore, malattie, lamenti e malinconie.
È un eros che vive nella latenza di un corpo sempre desiderato, sempre
censurato, sempre rimosso, ma poco esposto e che perciò si rivela in danze di
visioni mentali suscitate dalla parola e dalle sue figure, fra le quali la metafora è
sempre la più lussuriosa. Un eros che, sintomaticamente, è sempre protetto e
coperto dai luoghi topici e oscuri del bosco e della grotta; e che forse si vorrebbe
leggero, limpido, ingenuo, capace di riflettere ancora, nel paradiso edenico
d’Arcadia, la grazia dello stato della creazione; ma che invece assume i riflessi di
un oscuro rispecchiamento nella pozza della colpa adamitica.
Ciò che, tuttavia, veramente provocò, sulle scene barocche, una tensione
assoluta fra Eros ed Ethos, fu la forte presenza delle prime attrici professioniste
e l’audacia sconcertante delle loro interpretazioni. Un fenomeno molto concreto e
poco effimero che spesso si dimentica.
Questa nuova tradizione recitativa modificò sensibilmente il vecchio teatro,
aumentandone il grado di fascinazione e il potere contrattuale, cosi come
profondamente modificò il teatro inglese della Restaurazione quando venne
introdotta, nel periodo carolino, insieme alla scene mobili25.
La tradizione, come è noto, era iniziata con le peformances di Isabella Andreini,
poetessa e prima diva del teatro moderno, morta nel 1604 e celebrata in
Europa26, che nelle scene di pazzia, ma anche nella sua MirtilLi, si era proposta
audacemente in situazioni esplicitamente o ambiguamente erotiche27. Una
tradizione recitativa portata avanti dalle altre grandi attrici della prima
generazione della commedia dell’arte (Silvia Roncagli, Vincenza Armani, Vittoria
25
P.BERTINETTI, Il teatro e la corte nell’età della Restaurazione, in AA.VV., Storia, cit., pp. 472513, alle pp. 480-83.
26
Su Isabella Andreini cfr. F. MAROTTE-G. ROMEI, La commedia dell’arte e la società barocca. La
professione del teatro, Roma, Bulzoni, 1991, pp. 163-208; F. TAVIANI, Bella d’Asia. Torquato
Tasso, gli attori, l’immortalità, in « Paragone-Letteratura», xxxv 1984, nn. 408-10 pp. 3-76; R.
TESSARI, O Diva, o “Estable à tous chevaux”. L’ultimo viaggio di Isabella Andreini, in Viaggi
teatrali dall’Italia a Parigi fra Cinque e Seicento. Atti del Convegno internazionale di Torino, 6-8
aprile 1987, Genova, Costa&Nolan, 1989, pp. 128-42; F.R. DE’ ANGEI.ÌS, La divina isabella. Vita
straordinaria di una donna del Cinquecento, Firenze, Sansoni, 1991.
27
. Mi riferisco soprattutto alla scena della Mirtilla (III 5 ) in cui il satiro cerca di violentare Filli, la
quale riesce a liberarsene con la promessa di un bacio: della scena che nell’Aminta è solo narrata
da Tirsi. Maria Luisa Doglio, nell’introduzione ad un’edizione moderna della Mirtillo (pubblicata
nel 1588 a Verona da S. dalle Donne e C. Franceschini), sottolinea l’emergere di un forte accento
di narcisimo femminile: «una nota voluttuosa, sottilmente ambigua, di un’audacia sconcertante »
(I. ANDREINI, La Mirtilla, a cnra di M.L. DOGLIO, LUCCA, FAZZI, 1995, p. 14). Sulla Mirtilla vd.
anche F. VAZZOLER, Le pastorali dei Comici dell’Arte: la Mlirtillo di Isabella Andreini, in AA.VV.,
Sviluppi, cit., pp. 281-99.
Piissimi, «bella maga d’amore »)28 e proseguita, nel Seicento, da Orsola
Cecchini, da Virginia Ramponi (famosa interprete anche dell’Arianna di
Monteverdi nel 1608, particolarmente ammirata dal Marino)29 e poi da quelle
attrici che, nella seconda metà del secolo, recitarono sulle scene francesi, come
Orsola Cortesi30 moglie del celebre Arlecchino Domenico Biancolelli.
Le attrici-donne trionfarono soprattutto nelle scene di pazzia e nei frequenti
travestimenti da uomo (con ostensioni, rare a vedersi, di gambe fasciate da
calze maschili e petti compressi e liberati in improvvise agnizioni31) in tutte
quelle situazioni, cioè, che si offrivano al gioco recitativo dei forti contrasti
(volgare/sublime, femminile/maschile)32 ; o anche in più raffinate ed estreme
peformances psicologiche in cui la donna, a metà tra carnefice e vittima, vive
28
Sulle prime attrici della commedia dell’arte e sulla “nuova cultura” da loro prodotta, è
fondamentale F. TAVIANI-M, SCHENO, Il segreto della commedia dell’arte, La memoria delle
compagnie italiane del XVI, XVII e XVIII secolo, Firenze, La Casa Usher, 1982, pp. 331-53 (la
citaz., da T. Garzoni, è riportata a p. 332). Sulle tecniche recitative delle attrici vd. F. TAVIANI,
Un vivo contrasto. Seminario su attrici e attori della commedia dell’arte, in » Teatro e Storia», I
1986, n. I pp. 25-75.
29
Su queste attrici e in particolare su Virginia Ramponi, in arte Florinda, moglie di Giovan Battista
Andreini, si veda la documentazione prodotta in Comici dell’Arte. Corrispondenze (GB. Andreini,
N. Barbieri, PM, Cecchini, S. Fiorillo, T. Martinelli, E. Scala), dir. S. FERRONE, a cura di C.
BURATTELLI, D. LANDOLFI e A. ZINANNI, Firenze, Le Lettere, 1993; e il cap. VI (Lelio bandito e
santo) dell’importante studio sulla commedia dell’arte: S. FERRONE, Attori mercanti corsari. La
commedia dell’arte in Europa tra Cinque e Seicento, Torino, Einaudi, 1993, pp. 223-73, in partic.
alle pp. 236-38, 240-46, 253-58. Sulle feste mantovane del 1608 per le nozze del principe
Francesco Gonzaga con Margherita di Savoia, nelle quali Virginia Ramponi (Florinda) cantò
nell’Arianna e prese parte al Ballo delle ingrate, ambedue di Rinuccini e Monteverdi, cfr, P.
FABBRI, Monteverdi, Torino, EDT, 1985, pp. 124-48; e C. BURATTELLI, Spettacoli di corte a
Mantova tra Cinque e Seicento, Firenze, Le Lettere, 1999, pp. 35-80. Quell’interpretazione è, fra
tanti altri, celebrata anche dal Marino nell’Adone («E in tal guisa Florinda udisti, O Manto / là ne’
teatri de’ tuoi regi tetti / d’Arianna spiegar gli aspri martiri / e trar da mille cor mille sospiri», VII
88). Nell’idillio de La Sampogna (1620), il passaggio del Marino ad una ispirazione meno elegiaca
e più sensuale, nonché l’insistenza su alcuni dettagli del corpo (come i capelli sciolti: tratto
sempre presente nell’iconografia recitativa di fanno pensare ad un’influenza di quella visione
scenica. In una lettera, più volte citata, di Virginia Ramponi a Ferdinando Gonzaga, scritta da
Tonno il 4 agosto 1609 (Archivio Storico di Mantova, Autografi, b.10, c.57rv) l’attrice riferisce di
« cento ottave e quaranta sonetti» scritti dal Marino in suo onore. A tali composizioni fa
riferimento anche G.B. Andreini in una lettera a Vincenzo I Gonzaga scritta pochi giorni dopo
quella della moglie (il 14 ago. 1609) e sempre da Torino (Comici, cit., vol. I pp. 90-92, lett. II).
30
Su Orsola Cortesi: L. RASI, I comici italiani. Biografia, bibliografia, iconografia, Firenze, Bocca,
1897-1905, vol. I pp. 696-702; V. SCOTT, The commedia dell’arte in Paris. 1644-1697,
Charlottesville, Univ. Press of Virginia, 1990, pp. ro8-ii, e soprattutto D. GAMBELLI, Arlecchino a
Parigi. Dall’inferno alla corte del Re Sole, Roma, Bulzoni, 1993, pp. 277-81. A questi due ultimi
studi si rimanda anche per notizie sulle altre attrici italiane che recitarono in Francia.
31
Esibizioni simili, inaugurate in Italia da Vincenza Armani, saranno tipiche, nell’Inghilterra di
Carlo II, delle cosiddette breeches parts che prevedevano, appunto, il travestimento in abiti
maschili.
32
Cfr. TAVIANI, Un vivo, cit., pp. 68-70. Per Taviani il segreto del fascino e del successo delle
grandi attrici della fine del Cinquecento e della prima metà del Seicento (da Isabella Andreini,
che nelle scene di follia riproponeva elementi dell’espressività buffonesca, a Orsola Cecchini, che
compariva in scena sparando con l’archibugio, ad Angela d’Orso che guidava i soldati in battaglia
come capitano) è in gran parte dovuto al gioco dei contrasti estremi (femminile./ maschile,
ridicolo/tragico, volgare/sublime). Eugenio Barba ha individuato nel ricorso, anche simultaneo, a
due tipi opposti di energia «uno vigoroso, forte (Animus), e l’altro morbido, delicato (Anima) «,
da non confondere con la polarità dei sessi, una regola ricorrente del comportamento
transculturale dell’attore. Cfr. E. BARBA, La canoa di carta. Trattato di Antropologia Teatrale,
Bologna, il Mulino, 1993, pp. 96-106
quella violenza che Amore non sembra poter abbandonare e che si esprime nel
delirio amoroso o nel lamento patetico, poi sfruttato dal melodramma.
Nella loro recitazione, l’eros (carne e passione), rimosso in tanta drammaturgia e
in tanto spettacolo senza donne, si fece fisicamente sensibile, veicolato anche
dal volto senza maschera, nuda finestra dell’anima. Volto di fronte al quale —
ricorda Benjamin — la letteratura barocca che pure, nella narrativa, coglie il più
piccolo gesto, sembra disarmata33.
E furono anche eccitazioni e carezze canore, di cui i testi scritti non serbano che
una pallida, prosodica, eco. Ma non si trattò solo di fiammeggiamenti sessuali o
di carnale poesia. Credo che il riconoscimento stesso del valore della recitazione
come esperienza non superficiale, ma organica e totale di mente e di corpo,
derivi soprattutto dalla straordinaria potenza performativa delle attrici.
Le attrici, dive e prostitute, avevano infuso nella recitazione, « esercizio tanto
pericoloso per donna »34, un senso di rischio e di vibrazione, esaltando il corpo
fino alla barbarie più lussuosa e le passioni fino alla più sottile raffinatezza
sentimentale.
Quel flusso di impulsi emozionali, governato e modellato, quell’energia
espressiva in cui sembrava di percepire il fremito della mano interiore della
natura, furono per gli spettatori la prova tangibile che la recitazione avrebbe
potuto sommuovere il fondo oscuro dell’anima. Quei momenti di pienezza
emotiva, creaturale, generarono l’impressione di un’irruzione di realtà vitale,
capace di squarciare il velo e l’ipocrisia della finzione. Un’impressione ben
diversa da quella provocata dall’artefatto del corpo buffonesco che muoveva i
suoi meccanismi corporei per comica necessità35.
La presenza delle attrici fu la dimostrazione più certificabile di una potenza
recitativa, nuova e insostituibile: «la donna è del teatro il tutto, poiché qual più
languida cosa puossi vedere che tutta d’uomini recitar una commedia? Non vedi
che ci levi il verisimile, anima e cuore di questo poema, ed ogni grazia, ed ogni
affetto?»36.
Gli spettatori testimoniarono, per via poetica, una indicibile incantazione, il loro
incontrollabile trasporto emotivo (« mi disperaste in un volubil giro»)37 l’efficacia
quasi psicagogica della recitazione, l’impotenza di ogni difesa razionale. La voce
33
Cfr. BENJAMIN, op. cit,, p. 59 Benjamin assume il concetto da H. CYSARZ, Deutsche
Barockdichtung. Renaissance, Barocle, Rokako, Leipzig 1924
34
Cori scrive, da Vienna il s6 novembre 1628 a Maria Gonzaga, l’attrice Virginia Rotari (Lidia),
«madre vedova e carica di sette figliuoli », mostrandosi preoccupata del futuro della figlia
Leonora e temendo di doverla avviare «per gran necessità» al mestiere comico (Comici, cit., vol.
I pp. 145-46, lett. 54).
35
Il Corago (trattato anonimo scritto tra il 1628 e il 1637), sottolineando il limite imposto dalla
maschera agli attori nell’esprimere i sentimenti, scrive: «io non so come potessi rappresentare
cosi bene gli afferri come si fa oggi da nostri comici i quali, mutandosi di volto, ora danno segno
di allegrezza, ora di malinconia, ora di sdegno e simili. Se una donna si vedesse da noi comparire
in scena con la maschera darebbe piti presto noia e fastidio » (Il Corago, o vero alcune
osservazioni per metter bene in scena le composizioni drammatiche, a cura di P. FABBRI e A.
POMPILIO, Firenze, Olschki, 1983, p. 105).
36
GB. ANDREINI, La Ferza. Ragionamento secondo contra l’accuse date alla Commedia, Parigi,
Callemont, (1625), p. 44 (in MAROTTI-ROMEI, op. cit., p.510)
37
F. ELLIO, La Sirena del Mar Tirreno. Stanze in lode della Signora Virginia Ramponi, comica
Fedele detta Florinda, in ID., Idilli di diversi ceneri, Milano, Bidelli, 1618 (parzialmente riportato
da RASI, I comici, cit., vol. I pp. 149-51, da cui traggo la citaz. a p. 150).
angelica di Florinda (Virginia Ramponi) - «questa dolce omicida ed innocente»38
— fu definita «di ragione incognito terrore».39
Di fronte alle attrici, come del resto di fronte al teatro tout court, era messa alla
prova una ragione sensibile — ben diversa da quella cartesiana — che
pretendeva affinità di sensi e di intelletto, di corpo e mente, e quindi disposta al
piacere di percepire simultaneamente il corporeo e lo spirituale. Non a caso,
l’accusa rivolta agli attori fu anche quella di constuprare Minervam., prostituere
et foedari Parnassum — sintesi che sta pure ad indicare contro chi gli attori
dovettero fortificarsi: contro i saggi, i letterati e i moralisti40.
Le attrici si difesero come si difende Proteo, facendosi accreditare come corpi
doppi: come Veneri terrene e insieme come Veneri celesti, timoniere di un
platonico viaggio ad astra: perciò «divine», celesti sirene», «terrene angiolette
», «attrici di Dio», 41 collocandosi così in quel punto della contraddizione tra
sacro e profano da cui era possibile percepire come Eros ed Ethos esistano non
separabili, ma necessariamente dipendenti e posti uno dall’altro.
Le attrici incarnavano grandiosamente il Mondo, e furono quindi il nemico per
eccellenza della Chiesa42. Ma queste donne — virtuose anche nel canto, nella
danza, nella pratica poetica e accademica dell’improvvisazione, e spesso
38
Sonetto di A. SANTA MARIA, Alla Signora Florinda comica fedele, in ID., Concerto poetico,
Napoli, s.i.t., 1620, p. 96
39
Sonetto dell’accademico filarmonico Il Preparato Ne gli afeitti di Florinda (Bibl. Naz. Braidense
di Milano, Raccolta Morbio, codice n. I: Poesie di diversi in lode dei comici Gio. Battista Andreini,
detto Lelio, e la moglie Virginia, nata Ramponi, detta Florinda, c.15 r.). La raccolta contiene 59
componimenti dedicati a Florinda, in gran parte di spettatori vicentini e appartenenti
all’Accademia Filarmonica di Verona, probabilmente raccolti da Giovan Battista Andreini (a cui è
dedicato solo il primo sonetto), dato che si rilevano sue annotazioni a margine, e anche ironiche,
nei confronti dì autori troppo sdolcinati. In un sonetto di risposta agli autori-spettatori intitolato
La celeste sirena a’ suoi Filarmonici, è Florinda stessa a mostrarsi meravigliata per come -«falsa
sirena», «con il suo parlar dolce» e «un finto adorno viso» - abbia «spenti i pensier casti e santi»
(c. 25r).
40
E l’accusa rivolta agli attori da Modestinus nelle Orationes di padre Louis Cellot (Ludovici
Cellotii parisiensis S.J. Panegyrici et Orationes, Parisiis, apud Sébastien Cramoìsy, 1631). La
citaz. è a p. 330 dell’ed. di Colonia del 1770. Su quest’opera di Cellot, vd. FUMAROLI, Eroi, cit.,
pp. 307-33
41
Queste definizioni, sempre ricorrenti, fino a diventare topoi nella poesia encomiastica e,
probabilmente, nel linguaggio comune, hanno inizio con la strategia di mitizzazione delle attrici
già nell’orazione funebre — primo grande manifesto apologetico della dignità e nobiltà del
mestiere comico — che Adriano Valerini dedica all’amante e compagna di scena: A. Valerini,
Oratione in morte della Divina Sinora Vincenza Armani, Comica Eccellentissima, Verona [1570].
Nel 1606, per il compianto della madre, Giovanni Battista Andreini torna a riproporre l’immagine
platonica di Isabella splendente fra le sfere celesti, mentre la musica armoniosa riecheggia il suo
canto (Il Pianto d’Apollo. Rime funebri in morte d’Isabella Andreini Comica Gelosa, ed
Accademica Intenta, detta l’Accesa, di Gio. Batista Andreini suo figliuolo, con alcune Rime
piacevoli sopra uno sfortunato poeta, dello stesso Autore, Milano, Bordoni e Locarni, 1606, p.
25).
42
Fra le tante proibizioni, occorre ricordare che anche in ambito educativo la sessualità di cui la
donna è portatrice è considerata una minaccia, tanto che nella rappresentazione gesuitica la
donna può solo essere « evocata mediante parole; può mostrarsi irriconoscibile sotto un
travestimento maschile; può compatire in figura allegorica, cioè solo simbolicamente femminile,
ma di fatto asessuata, non donna» (B. MAJORANA, La scena dell’eloquenza, in AA.VV., Storia,
cit., pp. 1043-66, a p. 1059). Per l’organica trattazione del complesso problema pedagogico e
comportamentale, anche ID., Finzioni, imitazioni, azioni: donne e teatro, in Donna, disciplina,
creanza cristiana dal XV al VII secolo. Studi e testi a stampa, a cura di G. ZARRI, Roma, Edizioni
di Storia e Letteratura, 1996, pp. 121-39.
circondate da fama letteraria — costituirono il fenomeno più importante e più
nobile del teatro italiano e, credo, un nodo di forte e vitale contraddizione nel
sistema culturale barocco, se non altro perché la presenza reale del corpo in
scena, nella sua immediatezza, sorpassò ogni estetica basata sul pensiero
allegorico e ogni metafisica delle apparenze.
La loro poesia performativa rese, inoltre, evidente l’inutilità scenica del vuoto
formalismo letterario degli scrittori accademici, e, naturalmente, alimentò la
drammaturgia degli attori; di quegli attori o uomini di teatro che si fecero
letterati e che realizzarono ciò che per noi, oggi, è quasi un’eccezione: essere un
letterato e, nello stesso tempo, un uomo chiuso nei limiti più stretti del mes6ere
teatrale. Questi poeti di teatro — come dimostrano i casi eclatanti di Molière,
Shakespeare o di Giovan Battista Andreini — che seppero rendere e restituire
anche nella scrittura la qualità della parola viva, modificarono profondamente la
rigida gerarchia fra poeti e attori, fra letteratura e teatro.
Fu questo, l’altro grande fenomeno del teatro europeo — esito di un lavoro
attoriale non meramente esecutivo ma creativo, il cui ingenium implicò anche
quell’inventio che i comici dell’arte avevano per primi messo in atto con la loro
drammaturgia d’attore, riunendo in una sola persona l’invenzione del poeta e
l’azione dell’attore. È quello che, sull’esempio degli italiani, sarà e farà
esattamente Molière e, in maniera non sostanzialmente dissimile, Shakespeare.
Due pilastri del teatro europeo, la cui drammaturgia va ben al di là della vuota
sofistica oratoria e letterata, per divenire — quasi paradossalmente —
fondamento delle rispettive letterature nazionali.
Presa nell’abbraccio del teatro materiale, la stessa letteratura si valorizza, prima
prostituendosi e stravolgendo i propri modelli e poi arricchendo come mai la
propria gamma espressiva, in virtù della polifonia teatrale e a contatto con la
viva parola: come accadde clamorosamente alla lingua inglese con
Shakespeare43.
Anche la letteratura cerca cosi il teatro, e al teatro, forse, chiede soprattutto la
sua diabolica incertezza, perché anche la parola, soggetta alle predeterminazioni
poetiche ed ideologiche, possa rendersi sempre più indefinita, polivalente, e
trovare un più ampio spazio di libertà.
4. Frutto della forte presenza sociale e culturale del teatro, mai pienamente
legittimata, è anche il metateatro — questa pratica che, forse, fu introdotta dal
Barocco per far sentire “finti” gli spettatori. Mai come in questa epoca, il teatro si
guarda, si mette in discussione, si discolpa, si difende, cerca il suo valore.
Significativamente, tra Italia e Francia è pubblicato, per tutto il secolo, almeno
un centinaio di metadrammi44.
43
Vd. F. MARENCO, Shakespeare e dintorni:gli inizi del teatro moderno, in AA.VV, Storia, cit., pp.
277-72, a p. 360
44
Il metadramma, strutturalmente derivato, con molta probabilità, dalla tradizione del coro e del
prologo, o del doppio prologo (quello, ad es., del Candelaioi, di Giordano Bruno) fa la sua
apparizione in Inghilterra con la Spanish Tragedy di Thomas Kid del 1589, ma si sviluppa
soprattutto in Italia e in Francia. Lo studio più completo sul metateatro secentesco francese
elenca quaranta metadrammi di un certo valore: G. FORESTIER, Le théatre dans le théatre sur la
scene francaise du XVII siecle, Genève, Librairie Droz, 1981, App. II pp. 351-54. Ma si veda
anche L. D’ALLENBACH, Le Récit spéculaire. Essai sur la mise en abyme, Paris, Seuil, 1977; e
L’Introduzione di L. MARANINI a La commedia in commedia. Testi del Seicento francese. Tre
«pièces»: Baro, Gougenot, Scudéry (1629-1635), a cura della stessa, Roma, Bulzoni, 1974, pp.
11-15. Manca uno studio valido sul “teatro nel teatro” in Italia, dove il fenomeno si manifesta
È una presa di coscienza del teatro che è segno, almeno sembrerebbe, della sua
raggiunta maturità. Ma lo è anche della sua aspirazione a trascendersi nell’unico
modo in cui gli era concesso trascendersi, e cioè attraverso un’inevitabile
metafisica. Il metateatro, presentando uomini che sono attori e che poi, senza
cessare d’essere attori, si fanno spettatori d’altri attori, sotto lo sguardo di un
pubblico vero, proietta lo stesso smascheramento, interno alla doppia pièce, sul
rapporto fra Uomini e Attori. Insomma, un’elevazione al quadrato del rapporto
fra teatro e Teatro del Mondo.
Se si escludono le prove più banali, che appartengono soprattutto al secondo
Seicento, si nota che qui il teatro tende a proporsi come psicagogia della
coscienza che passa dalla oscurità alla chiarezza, dalla dipendenza alla libertà, e
che fa spettacolo di se stessa. E quello che accade nell’elogio più bello del teatro
che è l’Illusion comique di Corneille, in cui il teatro è inteso come viaggio
iniziatico per l’attore Clindor e per suo padre, che non solo guarisce dagli errori,
ma conduce ad una saggezza superiore di cui detiene le chiavi il mago e
demiurgo Alcandre, dietro cui si cela l’autore drammatico e il metteur en scène.
Saggezza che coincide con la coscienza del Valore positivo dell’illusione (di cui
sono vittime Pridamant, il figlio attore e lo spettatore), che viene conquistata
gradualmente e guarisce dai pregiudizi sul teatro.
Se qui l’apologia è più del drammaturgo, che sta guadagnando il primo posto
nella classifica degli scrittori letterati, l’interesse dei metadrammi più prestigiosi
cade sull’attore, sul problema sociologico e antropologico che l’uomo-attore
rappresenta nella società barocca. E, non a caso, una serie di metadrammi — la
più interessante — propone la vecchia storia di san Genesio, dell’attore pagano
Genesio che, mentre finge per derisione il battesimo di fronte a Diocleziano,
improvvisamente si converte alla nuova religione e finisce martirizzato.
La vicenda, già sceneggiata nel Medioevo, è drammatizzata prima da Lope de
Vega (Lo fingido verdadero, scritto fra il 1609 e il 1618), poi da Nicolas
Desfontaines (L’Illustre comédien ou Le Martyre de Saint-Genest, Paris,
Besongne, 1645, rappr. nel 1644) e da Jean Rotrou nel 1644 (Le Véritable saint
Genest, Paris, Toussaint Quinet, 1647, rappr. nel 1645 o nel 1646); in Italia,
fiaccamente, da Michele Stanchi (Il San Ginnesio, pubblicato postumo a Roma da
Tizzoni nel 1687).
Il dramma dell’attore santo e martire, la cui esperienza è esaltata come uno dei
modi della “imitazione di Cristo”, che aveva spesso circolato nei collegi dei
gesuiti, diventa paradossalmente un modo per difendere la professione di attore
e la problematica condizione del teatro profano. Per Rotrou, Genesio è
innanzitutto un grande attore. La recita è scelta, infatti, dalla figlia di Diocleziano
non in funzione del soggetto, ma della potenza recitativa con cui Genesio è solito
interpretare un cristiano condotto al martirio: «Mai on vante sourtout l’inimitable
adresse / Dont tu feis d’un chretien le zele et l’allegresse, / Quand, le voyant
marcher du bapteme au trepas, / Il semole que les feux soient des fleurs sous
prima e con più forza (negli scenari della commedia dell’arte e nella commedia di G.B.
ANDREINI, Le due comedie in comedia, Venezia, Imberti, 1623) e comprende un corpus di opere
equivalente a quello francese, come mi risulta dall’analisi dei principali repertori bibliografici. Fra
gli autori più interessanti, ricordo, oltre al più noto Bernini de L’impresario e de Li due Covielli
(1637): Scipione Errico, Onofrio Onofri, Giacinto Andrea Cicognìnì, Giulio Rospigbosi, Giovanni
Andrea Lorenzani, Domenico Mancini e l’attore Gennaro Sacchi (Coviello).
tes pas»(I 5 293-96) 45. E, rispondendo, Genesio stesso si vanta di interpretare
la morte di Adriano «avec un art extrème / et si peu différent de la vérité
méme».
Sia in Rotrou, sia in Desfontaines, quando l’attore, ormai illuminato dalla Grazia,
comincia a parlare a suo proprio nome, nessuno, né Diocleziano, né gli
spettatori, sarà più in grado di distinguere se Genesio recita o meno. I compagni
saranno convinti che reciti « sur le champ», che improvvisi, crederanno alla sua
« art extreme ». A Diocleziano che esalta il talento di Genesio, Valerie
risponderà: « Pour tromper l’auditeur, abuser l’acteur méme, / de son métier,
sans doute, est l’adresse suprème »46.
Soltanto quando Genesio, ormai convertito, confessa a Diocleziano, ancora
convinto che l’attore stia improvvisando: « Dieu m’apprend sur le champ ce que
je vous recite», allora cessa di essere attore. È ormai divenuto attore di Dio:
Il est temps de passer du théàtre aux autels;
Si je l’ai merité, qu’ou me mène au martyre;
Mon ròle est achévé, je n’ai plus rien à dire47.
La portata metafisica è che in un mondo che è teatro sotto lo sguardo di Dio, la
vita mondana non è che un ruolo da non confondere con la vita autentica, la
quale non esiste che in Dio. Detto in altri termini, Dio non recita, non vuole
avere a che fare con il teatro; nè si può essere insieme attori e santi, attori e
uomini autentici.
Insomma, quando il teatro tenta di trascendersi, di superare se stesso,
automaticamente acquisisce un significato metafisico e cessa di essere teatro,
come l’attore cessa di essere attore per divenire attore di Dio. L’estremo confine
del teatro è questo e deve essere rimarcato48.
Si ha però l’impressione che il metadiscorso in difesa dall’attore trattenga anche
un sottotesto. Liberata dalla prospettiva metafisica, la recita santificatrice ci dice
che è proprio in virtù della recitazione che in Genesio si è compiuto un salto di
coscienza, che una coscienza imprevista si è fatta avanti e ha preso il posto di
quella prevista. L’atto santificato di Genesio è l’atto estremo in cui l’attore,
attraverso la finzione, ha bruciato l’ipocrisia della finzione, ha vissuto un’azione
più reale del reale e un’esperienza di coscienza che avrà riflessi sulla sua vita
spirituale.
45
Cito, qui e successivamente, da Théatre du XVII siède, textes choisis, établis, présentés et
annotés par J. SCHERER, Paris, Gallimard, 1975, p. 953
46
IV 5 1263-64 (p. 987).
47
IV 7 1316, 1369-72 (pp. 989, 991). I versi di Rotrou fanno eco a quelli della dichiarazione di
Genesio a Diocleziano ne L’illustre comédien (III 2) di Desfontaines
48
Si veda anche l’efficace analisi di F. TAVIANI, Né profano né sacro: prospettive teatrali, in
Luoghi sacri e spazi della santità, a cura di S. BOESCH GAJANO e L. SCARAFFIA, Torino,
Rosenberg & Sellier, 1990, pp. 219-39. Per Taviani il mito di san Genesio, tramite l’esempio di
un attore che scopre il profondo valore del teatro, ma proprio per questo abbandona il teatro,
rivela indirettamente la condizione di extraterritorialità, di « atopia » del teatro: il suo essere da
« profano » nel territorio del sacro e da « sacro » nel territorio del profano fino ad affermare
l’ultima libertà di essere « né profano né sacro». Per Majorana il mito non esprime
l’inconciliabilità ma, al contrario, la convergenza di valori tanto professionali quanto spirituali: B.
MAJORANA, Lo pseudo-Segneri e il Teatro celeste: due trarre secentesche, in «Teatro e Storia»,
IX 1994, n. 16 pp. 357-88, alle pp. 379-88.
La recitazione è dunque un processo di trasformazione interiore, ha il valore
d’una pratica intellettuale e spirituale. Un valore riconosciuto dalla cultura
cattolica, ma forse ritenuto pericolosamente alternativo a più nobili modi di
governo del corpo e della mente e quindi scavalcato con un salto metafisico.
Come se solo l’ascensione al Cielo potesse liberare l’attore da quella falsa
coscienza che la recitazione non può non indurre.
L’elogio dell’attore esige un inevitabile appello alla metafisica che spinge a
guardare più in là, sempre più in là dell’attore concreto. Fatto santo, l’attore si
proietta troppo oltre per poter esser riconosciuto come attore. Ed è tolto alla sua
consistenza e alla sua realtà.
5. Il metateatro, tuttavia, per la sua natura di congegno scenico, rese fin troppo
congegnata, scoperta e frontale, l’apologia dell’attore e del teatro.
I valori del teatro trovarono, allora, un altro modo molto più sottile per
esprimersi. Si consustanziarono ai drammi.
Laddove la scrittura è alta, e non nei fallimenti, se facciamo attenzione a quella
zona oscura che si proietta fino a noi, in cui si preserva ciò che di più inquieto
costituisce l’opera stessa, allora ci è dato spesso di ritrovare la presenza del
teatro o dell’attore; di quell’attore che rimane la figura antropologica più
problematica del secolo, come sapeva Shakespeare che la elesse a immagine di
quell’ombra indecifrabile che è l’uomo: « La vita non è che un’ombra che
cammina, un povero attore / che si esibisce e si agita per il tempo che gli è dato
/ e poi scompare, a tutti ignoto […]» (Macbeth, V 5 24-26).
Ho l’impressione che tutto il grande teatro del Seicento mostri i segni di un più
sottile teatro nel teatro, o, per meglio dire, teatro del teatro: formule —
inadeguate — con cui intendo non tanto e non solo la riflessività del teatro su se
stesso o un procedimento di mise en abyme, quanto piuttosto il modo in cui il
teatro difende i propri valori sottendendo o mostrando nell’opera la propria
operatività. Proprio questa forma scenica che esalta se stessa è spesso la cifra
che distingue le opere piatte dai capolavori ed esige di essere rilevata dall’analisi
testuale, molto più della funzione mimetico-interpretativa.
Si potrebbe osservare facilmente, come è stato fatto, quale manifesto allegorico
del teatro vi sia in certe opere di Corneille (Médée, Britannicus) o con quale
delicata maniera Racine allegorizzi la Tragedia nel personaggio di Phèdre. O,
ancora, si potrebbe citare il Tartuffe quale dramma dell’hypocrités; e,
ovviamente, l’Amleto, una vecchia, tradizionale tragedia di vendetta sconvolta
dall’immissione di teatro e di pazzia “finta” (cioè equivalente al teatro), con un
protagonista che difende gli attori, i soli che gli procurino gioia, e che trova la
sua verità nel definirsi attraverso un corpo d’attore, doppio e burlesco.
Gli esempi potrebbero continuare. Specie se ci si abitua allo sguardo anamorfico
e allegorico della mentalità barocca, è possibile evocare non pochi di questi
fantasmi teatrali. Ma, a prova significativa, vorrei portare il Don Giovanni, mitica
invenzione scenica del secolo, nonché sintesi antropologica dei temi più sacri e
scottanti del Barocco.
Don Giovanni, quest’eroe che sta di casa solo nei teatri, credo che possa
sopportare fra le tante interpretazioni anche quella di essere considerato una
delle espressioni più emblematiche dell’attore. Basterà qualche cenno.
Non solo Don Giovanni è il caso, unico, di un personaggio che mostra
apertamente la sua abilità performativa, pur finalizzandola alla seduzione,
sensuale o intellettuale. Ma il dramma stesso sembra essere congegnato per
attivare la recita delle simulazioni, per misurare la disponibilità della realtà a
lasciarsi contaminare dalla finzione. Tutti sembrano costretti a recitare una
parte, ad esporre il loro modo di rappresentarsi. In un’opera che è il teatro dei
teatri, tutti recitano le retoriche del teatro: le donne il loro melodramma, i servi
la loro commedia, il Cielo la sua tragedia. Tutti recitano, compresi gli dèi tramite
il loro intermediario marmorizzato, servendo il ruolo che è stato loro assegnato.
Ma tutti recitano in vista di un risultato: un matrimonio, un salario, la redenzione
dal peccato. Come attori si muovono entro un percorso previsto e prevedibile e
danno l’impressione di figure seriali e un po’ false, perché la recitazione, che
conosce il risultato, soffoca la libertà dell’attore.
Di fronte a tanti cattivi attori, Don Giovanni appare un vero attore, un attore
efficace, quasi un’idealità d’attore. Intanto mostra di recitare. Ostenta tutti i
trucchi della recitazione convenzionale (travestimento, virtuosismo verbale,
doppiezza di comportamento, ecc.), tentando di far dimenticare che sta
recitando, come se tutti conoscessero il suo essere falso e ingannatore. Sa
utilizzare ricette sperimentate per entrare con arte nell’animo degli altri e uscirne
in immagine. Sa variare stili e modi recitativi in relazione alle aspettative,
generando sospetti o credulità e incontrando fallimenti, come accade con la
statua e, in Molière, con il Povero. Il gioco è cosi raffinato e pericoloso che lo
stesso servo esita, quando Don Giovanni gh propone lo scambio dei vestiti, a
entrare nel cerchio della recitazione in cni si dibatte il padrone: «O Ciel — dirà
Sganarello —, [.. .j fais-moi la gràce de n’ètre point pris pour un autre» (II 5 )49.
Don Giovanni — ha scritto Macchia — è una delle espressioni più autentiche dell’
attore « et comme tous le plus grands acteurs, il pervient à semer la
confusion»50. Per Francisco Rico «diabolica, in ogni caso, è la sapienza teatrale
del Beffatore »51. E solo recitando, riducendo tutto a teatro, che Don Giovanni
può agire sulle connessioni fra vita e teatro, tra verità e menzogna, sfruttarne le
ambiguità, permettersi il gioco di rendere vera la finzione e falsa la realtà.
Fingendo, assumendo come propri i valori (dei devoti e degli innamorati, dei
poveri e dei nobili) può misurarne il grado di falsità; può modificare il rapporto
coatto tra dire e fare, fra la promessa e il mantenimento. Non è difficile
constatare come, in ogni azione, riesca ad attirare l’attenzione sulla recitazione.
Costringe a vedere tutto sub specie theatri, ma sempre mostrando di non
appartenere troppo alla finzione, perché se tutto è artificio tutto è falso52.
Ma se Don Giovanni è grande attore, lo è soprattutto in virtù
dell’improvvisazione che, forse, è l’ideale recitativo del secolo ed è l’aspetto che
in fondo più seduce i suoi interlocutori e più ha sedotto gli spettatori, Kirkegaard
compreso. È improvvisatore non perché si muove a caso; ma perché è fedele,
49
MOLIÉRE, Don Giovanni, a cura di D. GABELLI, trad. della stessa e di D. Fo, con testo a fronte,
Venezia, Marsilio, 1997, p. 114
50
G. MACCHIA, Dan Juan. Metamorphose et immobilitè in « Théatre en Europe», 16 1988, p. 5.
51
F. Rico, Biblioteca spagnola. Dal Cantare del Cid al Beffatore di Siviglia, Torino, Einaudi, 1994,
p. 252
52
Come ha scritto, in pagine stimolanti, Cesare Garboli, riferendosi al personaggio di Molière, la
recitazione di Dom Juan è «quantistica»: recita a tratti, per intermittenze, entra ed esce dalla
finzione, mentre gli altri recitano servi1- mente e meccanicamente la parte loro assegnata dalle
istituzioni (C. GARBOLI, Come recita Don Giovanni, in AA.VV., Scritti, cit., vol. II pp. 284-308).
come ogni grande attore, a una partitura (quella che gli consente l’azione di
seduzione, a cui sempre ritorna), ma vivo dentro la partitura e sensibile al
mutamento. Seguendo la partitura può essere preciso, improvvisando non
rischia di cadere nella ripetizione meccanica, che è ciò che Don Giovanni si
rifiuterà sempre di fare, dato che
«[...] tout le plaisir de l’amour est dans le changement»53. Precisione e capacità
di reagire al mutamento sono le sue caratteristiche. Come quell’attore ideale che
è santo Genesio, Don Giovanni non gode di una coscienza preventiva e perciò sa
unire volontà, pensiero e azione. Quando è attore convenzionale, la sua
recitazione è scoperta e odora di inganno o di burla, ma quando si fa veicolo di
un impulso, le azioni fisiche e i movimenti del suo organismo affettivo e mentale
si corrispondono con simultanea immediatezza.
Espone così, come l’attore santo, una coscienza vissuta nel farsi stesso
dell’azione, non infagottata in una falsa coscienza. Che poi, in fondo, è
l’esaltazione di una libertà che permette all’attore di denunciare negli altri la
contraddizione fra essere e dover essere.
Se Don Giovanni esprime le forze dell’animo in quanto forze, gli altri le
esprimono in quanto figure: sono costretti ad avere un’espressione. Se la
recitazione convenzionale degli altri è una naturalità fissata e cristallizzata nella
coerenza di un modello di comportamento, la recitazione di Don Giovanni, il suo
modo di essere, è assimilabile alla connotazione apparentemente spontanea e
inesauribile della libertà. È il paradigma irraggiungibile, ma perciò trainante, di
un’idea regolativa della libertà dietro cui ammicca misteriosamente l’attore.
Perciò le donne si innamorano e chi dovrebbe odiarlo ne è affascinato.
Basta così la presenza di Don Giovanni perché gli altri personaggi risultino moli
posticci e il loro teatro finzione intollerabile.
Se il teatro di Don Giovanni è il regno del possibile, quello degli altri è il regno
del già pensato. E l’attore può sfidare gli altri a vivere una vita piena, non
determinata da una falsa parodia di coscienza o dalla presenza di una Coscienza
soddisfatta e solidificata di una statua interiore.
In Don Giovanni c’è una mente teatrale che è la sua arte del pensiero
contraddittorio, la sua doppia coscienza, il suo doppio sguardo che gli consente
dì gestire l’interfaccia fra realtà e immaginario, fra vero e falso, fra sacro e
profano.
Il Don Giovanni fu un esempio dell’estrema avventura del teatro. Un modello
riuscito della forza maieutica del teatro. Fu una sorta di prova di come il teatro
avrebbe potuto esercitare il suo potere. Per questo fu tanto amato dagli uomini
di teatro che, a cominciare dai comici dell’arte fino a Molière, lo rielaborarono, ne
fecero un cavallo di battaglia, ne temperarono la lama a doppio taglio e, infine,
ne accreditarono il mito.
Questo eroe antieroe fu particolarmente amato anche dal più grande
drammaturgo italiano, dal comico dell’arte Giovan Battista Andreini, figlio di
Isabella e Francesco, capocomico dei Fedeli, attore e scrittore54. Il quale
53
MOLIERE, op. cit., I 2, p. 68.
Per una analisi della vicenda artistica e della variegata drammaturgia di Andreini rimando agli
studi di Siro Ferrone: Commedie dell’arte, a cura di S. FERRONE, Milano, Mursia, 1985-1986, vol.
I pp. 36-40 e vol. II pp. 11-16, e soprattutto ID., Attori, cit., cap. v (Arlecchino rapito, pp. 191222), cap. VI (Lelio bandito e santo, pp. 223-73) e passim. Vd. inoltre, per l’accurata analisi dei
54
compose nel 1651, quattordici anni prima di Molière, un Convitato di Pietra
sterminato e iperbarocco, di 7665 versi in 5 atti e 52 scene, di cui esistono due
versioni manoscritte55.
È significativamente l’ultima opera composta dall’attore-drammaturgo e quindi il
testamento di chi, come nessun altro, aveva speso la vita scrivendo e operando
in difesa del valore del teatro e del mestiere d’attore.
È un Convitato che dilata a dismisura il modello tradizionale e presenta molte
novità, a cominciare dai personaggi fra i quali troviamo, assente nella tradizione,
la madre di Don Giovanni, Lisidora, e figure allegoriche e mitologiche. È
strutturato come una pièce a grand spectacle — di quelle che stavano
conquistando, grazie anche all’apporto di Torelli, la Parigi di Mazzarino
frequentata da Andreini — con musica e canto, effetti macchinistici e ben dodici
cambiamenti di scena, fra cui regge, marine, due straordinari inferni e i Campi
Elisi. E con un Don Giovanni ateo fin dal primo vagito, “falsatore”, stupratore e
assassino di donne, di cui Andreini accentua la dimensione mitica, mostrandolo
nel lungo prologo arruolato dai Titani, novello Icaro o Fetonte, per una nuova
scalata al Cielo. Scalata che si concluderà, fra le fiamme infernali, in una
memorabile ultima scena in cui la madre e il figlio scapestrato si rinfacceranno le
reciproche colpe.
Come tutti i Don Giovanni, il dramma vive di contrasti e contrappunti, alternando
scene di comicità e di tragedia, di mezzogiorno e di mezzanotte, di verginità e
peccato, di carne giovane e cadaverica, di bado e di pugnale, di delitto e di
preghiera.
La stoffa di cui è fatto è la contraddizione; ma è da notare — fra le altre novità
su cui non possiamo soffermarci — che qui la dialettica dei contrari investe
decisamente la concezione dell’amore. Diversamente da altre versioni
precedenti, qui eros è continuazione, sotto altre forme, della violenza.
Dell’amore si evidenzia la radice bellica, la compresenza inscindibile di amore e
odio, la costitutiva e insopprimibile ambivalenza con cui esso gioca nella vita
dell’uomo: veicolo di redenzione ed elevazione, ma anche di degradazione e
infine di perdizione.
Questo Don Giovanni non è solo l’amante-ape, ossessiva metafora degli amori
pastorali, ma anche un’ape-vampiro: «ape sitibonda io sono che godo a bever
sangue de i fiori» (IV 9). L’amplesso è lotta: la donna, narra Don Giovanni ad
testi, M. REBAUDENGO, Giovan Battista Andreini tra poetica e drammaturgia, Torino, Rosenberg
& Sellier, 1994; ID., Letture alfileriane per un «mostruoso spettacolo» Tasso, GB. Andreini,
Milton e l’Abele’, in «Giornale Storico della Letteratura Italiana», CXIII 1996, vol. CLXXIII fasc.
561 (1° trimestre), pp. 78-110, alle pp. 85-96. Determinante per l’acquisizione di nuove fonti è
stata la pubblicazione dell’epistolario andreiniano curata da A. ZINANNI e C. BURATTELLI in
Comici, cit., vol. I pp. 63-172 e vol. II pp. 13-31. Indicazioni e notizie sono anche in S.
MAZZONI, Genealogia e vicende della famiglia Andreini, in Origini della Commedia Improvvisa e
dell’arte. Atti del XIX Convegno internazionale promosso dal Centro Studi sul Teatro Medioevale
e Rinascimentale (Roma, 12-14 ott. 1995-Anagni, 15 ott. 1995), a cura di M. CHIABO’ e F.
DOGLIO, Roma, Torre d’Orfeo, 1996, pp. 107-52, alle pp. 126-36 e passim.
55
Si tratta di due mss. autografi e firmati, pronti per l’edizione. Il primo, conservato a Roma,
nell’archivio privato Cardelli (segn. XXXXVII, T. VII) si intitolai Il Concitato di pietra ed è dedicato
a « Monsignor Pio di Savoia, Chierico di Camera» (Carlo Pio di Savoia) con la data 20 sett. 1651.
Il secondo, alla Bibl. Naz. di Firenze (coll. Magliab. VII 16) si intitola Il nuovo risarcito Convitato
di Pietra ed è dedicato, in data 17 dic. 1651, al Granduca di Toscana Leopoldo. Un’edizione
critica, curata da me e da Silvia Carandini, è in corso di stampa presso l’editore romano Bulzoni.
Le citazioni che seguono sono tratte dal ms. fiorentino
Ottavio, «ti si avvinchia d’intorno come l’angue / A la cicogna collo, e cosce
cinge, / [...] / Qui nel sen serpe vaga, e candidetta, / Strisciandoti stizzosa. /
Sudandoti gelata, / Vibra lingua di foco, / E ‘n morsi aventa baci »56. Non si
celebrano armonie. Rifiutandosi di introiettare l’immagine della donna, che sente
persecutoria, Don Giovanni porta violenza nell’amore e l’amore offeso delle
donne diventa amore della violenza o lotta interiore nella donna tra la sua parte
femminile e la sua parte virile. Dirà Anna: « Oh sesso femminile, oh sesso
involto / Tra’ ceppi, e tra’ ritorte / Di mulièbri invogli; Ah, potess’io / Quelli
squarciar, com’io mi squarcio il petto» (III 2). E un’altra guerra tra sessi e del
sesso femminile con se stesso, con esiti scandalosamente omosessuali, Andreini
l’aveva rappresentata in Arnor nello specchio, pubblicato a Parigi nel 1622,
quando era entrato in contatto con i libertini57.
57.
Don Giovanni è, insomma, chiamato a rivelare la segreta convergenza dei
contrari, di Eros ed Ethos, di Bene e Male che rende l’uomo ancipite. Il male è
l’uomo a farlo, eppure è il male che lo seduce, lo domina, se ne fa beffe,
schernisce la sua presunta
innocenza, lo schianta. Il male essenzialmente non ci appartiene ed
essenzialmente ci appartiene. Allora, non meraviglia che il dramma abbia una
morale e una contromorale espressa da Lisidora (IV 2) che suona così: il troppo
amore, come quello di una madre per un figlio, può generare un mostro, il
troppo bene l’estremo male.
Anche da questi pochi cenni, si può notare come il dramma trovasse la propria
forza in un giuoco d’irrisolte sospensioni, nell’alimentare la vita dei contrari. Ma
questa forza — ed è ciò che, qui, più ci interessa sottolineare — è una forza
tenuta viva dal teatro, da una mente teatrale che si riflette nel pensiero e nel
comportamento del protagonista: nel suo doppio sguardo d’attore, nella sua
vocazione a tenersi a distanza da ogni soluzione unilaterale. Se lo statuto del
personaggio è la contraddizione non è per suggestioni neoplatoniche, ma perché
esso risponde a una poetica alimentata dalla condizione sociale e culturale dei
comici professionisti, collocati in una zona franca della cultura da cui era
possibile esercitare la molteplicità dei punti di vista e la libertà della
56
Questa descrizione dell’amplesso, in III 5, collocata nel momento in cui Don Giovanni incontra
di nuovo Ottavio per restituirgli il mantello e il cappello con cui si è travestito per sedurre Anna, è
del tutto originale rispetto alla precedente tradizione.
57
La frequentazione dell’ambiente libertino da parte di Andreini è testimoniata dai versi
dedicatigli nella Centaura. Suggetto diviso in commedia, pastorale e tragedia (Parigi, Della Vigna,
1622) da Théophile de Viau e da Saint-Amant, i maggiori esponenti del libertinisnio erudito, e da
Scipion de Grammont. Componimenti che, insieme a quelli di Jacques de Fonteny e di E Du Prè,
prudentemente scompariranno nell’edizione veneziana del 1633. Théophile è accusato, proprio
nel 1622, di essere l’autore del Parnasse satyrique e nel 1623 condannato in contumacia e
bruciato in effigie. Un’analisi di Amor nello specchio (Parigi, Della Vigna, 1622) è nel saggio di S.
MAIRA, introduttivo all’ed. moderna dell’opera, curata dallo studioso e da A.M. BORRACCI (G.B.
ANDREIN1, Amor nello specchio, Roma, Bulzoni, pp. 9-34 Ma vd. anche M. REBAUDENGO, «
Grandissima forza ha ‘1 piccolo fanciullo Amore»: l’eterodossia erotica in ‘Amor nello specchio’ di
Giovan Battista Andreini, in « Sodoma », VI 1993, pp. 57-74; e il più recente N. BUOMMINO, Lo
specchio nel teatro di Giovan Battista Andreini, in « Atti dell’Accademia Nazionale dei Lincei»,
CCCXCVI 1999, «Memorie», s. IX, vol. XII, in partic. pp. 7-34. -
contraddizione58.
Il teatro, quello professionale, nomade e sempre fuori luogo, proprio per la sua
anomala collocazione nella cultura, per la sua sofferta e lussuosa libertà di
appartenere e al contempo disappartenere al consorzio civile, per essere
aristocrazia dello spirito e povertà materiale e morale, per essere finzione nella
realtà e realtà nel sistema di finzione della società, per essere capace di offrire la
presunta oggettività come soggettiva e la presunta illusione come oggettiva —
almeno per tutto questo, era nella privilegiata condizione di potersi piantare nel
luogo della contraddizione da cui governare le oscillazioni della verità senza
accettare passivamente soluzioni predefinite.
E per questo che il Don Giovanni — facilmente usabile per l’illustrazione di
problemi morali, come lo è un manichino per lo studio dell’anatomia — venne
tenuto in vita dagli attori. Non è proprio grazie ai comici dell’arte, ad Andreini e
all’attore Molière — attore che più di tutti avverti l’anomala della propria
condizione — che la storia di un burlador, rigenerata da una mente attorica,
diventa un capolavoro in grado di rappresentare compiutamente l’età barocca
non come fattore di sintesi, ma come persistente segno di contraddizione?
E interessante notare che Andreini fu ossessionato da un altro personaggio, da
Santa Maria Maddalena, tanto da dedicarle una particolare devozione, nonché
alcuni componimenti poetici e una sacra rappresentazione nel 1617, poi
rielaborata col titolo Maddalena lasciva e penitente nel 1652, proprio a ridosso
della composizione del Convitato59.
Il dramma, denso di una particolare sensualità che manca alle altre
numerosissime sante Maddalene barocche, delinea il personaggio come un alter
58
Cfr. al riguardo la dichiarazione di poetica, basata sulla dinamica degli opposti, di Andreini
nell’avvertenza ai lettori de Lo Centaura.
59
‘La Maddalena lasciva e penitente’, azzione drammatica, e divota in Milano rappresentato,
Milano, Malatesta, [1652]. L’attenzione a questo soggetto è ricorrente in Andreini: dal poema in
tre canti e in ottave del 1610 (La Maddalena, Venezia, Somasco) a ‘La Maddalena’, sacra
rappresentazione (Mantova, Osanna, 1617) a Le Lagrime « divoto componimento » (Paris,
Charles, 1643). Sulle due stesure teatrali comparate al poema, vd. S. FABRIZIO-COSTA, Les
pleures et la gràce: ‘La Maddalena’ de Giovan Battista Andreini, in Théatre en Toscane. La
comédie (XVI’; XVII’ et XVIII’ siècle), Saint-Denis, Presses Univ. de Vincennes, 1991, pp. 11356; ID., Notes sur une mise en spectacle de la sainteté par un « Comico dell’Arte»: GB. Andreini
e ‘La Maddalena lasciva e penitente’ (1652), in « Chroniques Italiennes », IV 1988, nn. 1-2 (1314) pp. 71-86. Sul processo di rielaborazione delle tre versioni vd. REBAUDENGO, Giovan, cit.,
pp. 88-93. Sulla Maddalena del 1652, nel contesto della drammaturgia sacra, cfr. A. CASCETTA,
L’«Azione [.. ] divota » e l’anfibologia dell’Arte, La «spiritual tragedia » e l’«azione devota». Gli
ambienti e le forme, in La scena della gloria. Drammaturgia e spettacolo a Milano in età
spagnola, a cura di A. CASCETTA e R CARPANI, Milano, Vita e Pensiero, 1995, pp. 184-98. Una
puntuale analisi dei “retorèmi” dell’opera condotta da M. SARNELLI, « Col discreto pennel d’alta
eloquenza». «Meraviglioso » e Classico nella tragedia (e tragicommedia) italiana del CinqueSeicento, Roma, Aracne, 1999, pp. 45-60. Si veda, inoltre, la raffinata indagine iconografica di
FERRONE, Attori, cit., pp. 245-47, che mette in luce le somiglianze delle immagini, che
accompagnano le edizioni del poema e della sacra rappresentazione, con la celebre Malinconia
(quadro del 1618 circa) di Domenico Petti, amico di Andreini. Alla scena terza del quarto atto
(testo del 1652) sembrerebbe ispirarsi, secondo O. Milantoni, il quadro di Guido Cagnacci La
conversione di Maria Maddalena. Cfr. Guido Cagnacci, a cura di D. BENATI e M. B0NA
CASTELLOTTI, Milano, Electa, 1993 (Catalogo della mostra, Roma, dic. 1993-gen. 1994), pp.
166-68.
ego di Don Giovanni. Numerosi sono i parallelismi fra i due drammi e continuo,
quasi strutturale, il contrappunto fra la penitente e l’impenitente libertino, il
quale fallisce perché, al contrario di Maddalena, rifiuta di conoscere il punto in
cui Male e Bene, Eros ed Ethos, di per sé contrarissimi, convergono e si nutrono
uno dell’altro.
L’itinerario dei due drammi è opposto, ma ambedue traggono vita scenica dalla
volontà dì esaltare la virtuosa amoralità del teatro. Caratterizzati dall’essere
drammi del corpo, dimostravano quello che solo a teatro, arte delle azioni e dei
corpi, era dimostra- bile: che Ethos può essere posto come cosa viva solo se
scende in quel luogo, che davvero appartiene all’uomo e a cui l’uomo appartiene,
che è il suo corpo. Dunque peformances del corpo per eccellenza, teatri d’attore.
E, inoltre, evidente quanto la storia della santa potesse rendersi equivalente,
nell’ambigua coniunctio di sacro e profano, alla vicenda artistica dell’attrice e
farsi esempio emblematico di una trasformazione interiore che anche il teatro,
nonostante tutto, avrebbe potuto assicurare. Maddalena mostrava in
trasparenza, sotto l’immagine della donna lasciva e «pentita di vagabonda vita»
(v 2), il volto santificabile della donna attrice. A cui peraltro si allude
chiaramente quando la si definisce — e Andreini non è il solo — « recitante » di
cui è « spettator l’Angelo e Dio » (v 9) 60. E s’intravede anche l’immagine che
Giovan Battista aveva pazientemente composto della madre Isabella, che sarà
accolta, insieme con altri santi attori, nel Teatro celeste: una raccolta di 21
sonetti che Andreini dedica ad attori penitenti o votati alla santità, la cui figura
centrale è ancora san Genesio61.
6. Al termine di questo breve percorso, nel quale abbiamo indicato solo alcuni
punti di analisi che certo non esauriscono la complessità del problema,
emergono un paradosso e un ulteriore interrogativo.
Il paradosso è che mentre il Barocco si pensa e si osserva sub specie theatri, il
teatro in quanto professione e microsocietà (con ampi margini di antonomia
economica che garantiscono autonomia e differenza sociale) stenta ad essere
riconosciuto nel sistema culturale e sociale, almeno fino a quando non
guadagnerà uno spazio di libertà pubblico, laico, legittimato e garantito (in
Francia lo è dal re, nel 1641), istituzionale.
L’interrogativo è perché i capolavori della drammaturgia barocca sono
autoreferenziali, perché direttamente o indirettamente, velatamente o
60
Le due citaz. sono tratte da La Maddalena, cit., pp. 181, 219. L’intensa e particolare
fascinazione procurata dall’interpretazione della Maddalena da parte di un’attrice professionista si
avverte nel sonetto, di Pietro Michiele, A un’attrice che rappresenta la peccatrice convertita, in B.
CROCE, Lirici marinisti, Bari, Laterza, 1910, p. 309.
61
G.B. ANDREINI, Teatro celeste. Nel quale si rappresenta come la divina bontà habbia chiamato
al grado di Beatitudine, e di Santità Comici Penitenti, e Martiri [...], Paris, Callemont, [1625]. Il
testo, non datato, fu divulgato in appendice a Lo Specchio pubblicato nel 1625. Alla Bibl. Naz. di
Parigi ne esistono due esemplari, uno autonomo con frontespizio identico a quello dell’ed. sopra
citata e uno, inserito nel volume Lo Specchio, del 1625, col titolo Comici Martiri, e Penitenti che
però — come si deduce dal frontespizio (accompagnato anche da un altro frontespizio simile col
titolo Teatro celeste) — risulta edito da Callemont nel 1624. L’ed, originaria del 1624 è simile nel
contenuto e nella veste tipografica a quella del 1625, la quale presenta un frontespizio riadattato
per inserirvi la dedica a Richelieu (mentre nella precedente ed. al cardinale è dedicato un
sonetto).
apertamente, “esprimono teatro”; perché, attraverso una forma scenica che
esalta se stessa, l’opera esprime la propria operatività. Si potrebbe sostenere
che non ci sia mai vero teatro senza teatralità o coscienza della teatralità. Ma
l’affermazione rischia fortemente la tautologia.
Più semplicemente, è che il teatro di professione cerca di affermarsi e difendersi
e comunica questa tensione attraverso il dramma. La grande drammaturgia
barocca (in cui è compresa, ovviamente, la commedia dell’arte) è, infatti, una
drammaturgia fatta da attori o da uomini di teatro. I quali non solo hanno lottato
per accreditare la loro professione, ma hanno interpretato e scritto drammi
anche per sperimentare il potere e il valore stesso del teatro.
Questa drammaturgia fu, per così dire, una sorta di prova ontologica del teatro:
fu un modo di saggiare la resistenza della realtà alla finzione; ma soprattutto un
modo di saggiare la resistenza della società e della cultura al teatro. E fu la
risposta astutissima (la risposta di Proteo che si rende invulnerabile non
fuggendo ma rendendosi visibile-invisibile) e concreta a chi non riconosceva
alcun diritto al teatro; oppure a chi, pur riconoscendo il valore del teatro,
tendeva a transvalutarlo in metafisica, facendone il tempo e il luogo di
un’esperienza eccezionale, del tutto casuale (la recitazione eccezionale di
Genesio assicurata dalla Grazia divina), e non quell’esperienza costante che
soltanto adeguate condizioni economiche e politiche avrebbero potuto
assicurare.
In tempi in cui il diritto stesso all’esistenza del teatro non era riconosciuto, la
grande drammaturgia degli uomini di teatro dominò proprio quello scarto che nel
Barocco si era prodotto tra la concezione metafisica del teatro e la concretezza di
un mestiere anomalo come quello d’attore. Uno scarto che ha segnato la storia
occidentale del teatro ed ha generato molti dei suoi paradossi.