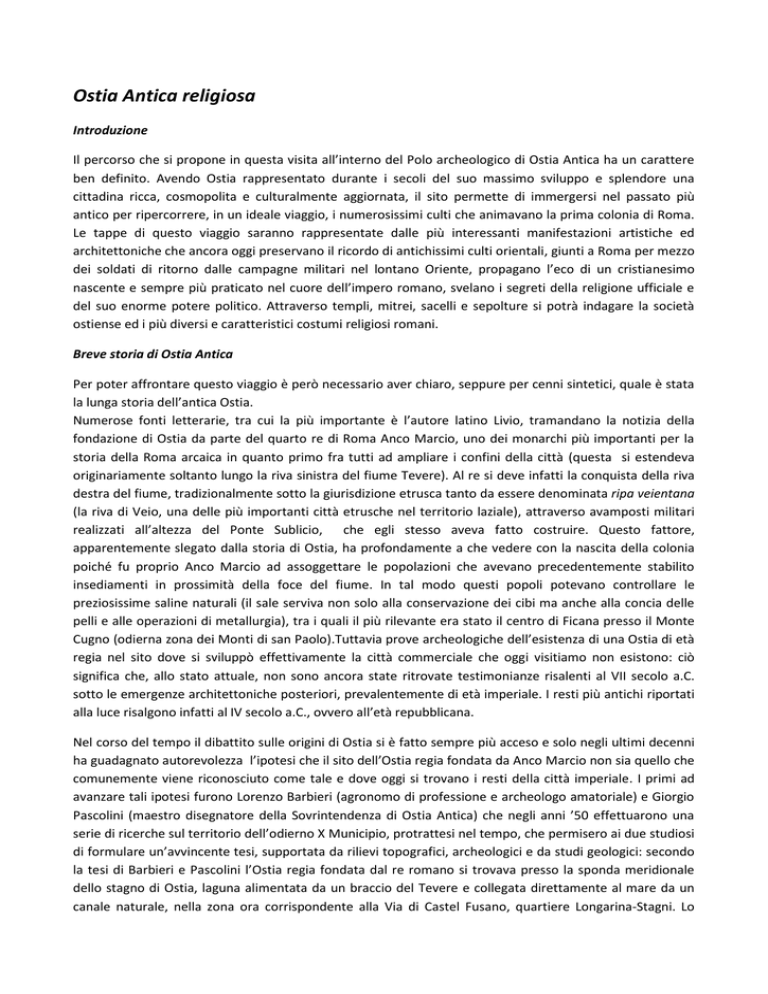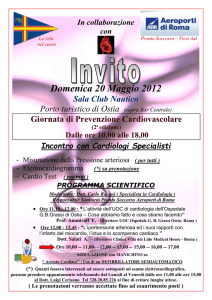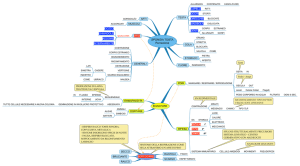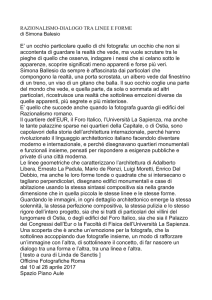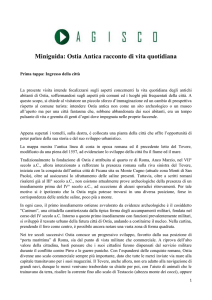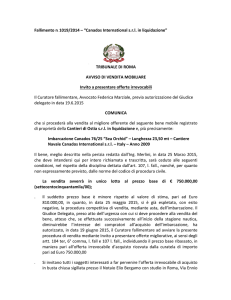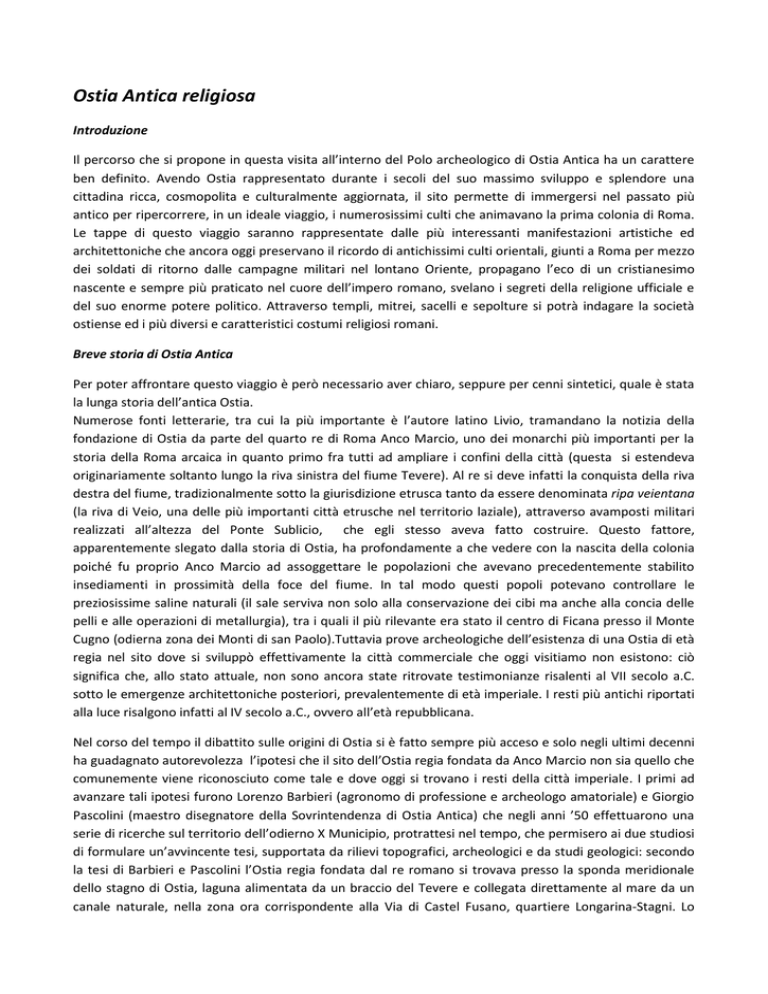
Ostia Antica religiosa
Introduzione
Il percorso che si propone in questa visita all’interno del Polo archeologico di Ostia Antica ha un carattere
ben definito. Avendo Ostia rappresentato durante i secoli del suo massimo sviluppo e splendore una
cittadina ricca, cosmopolita e culturalmente aggiornata, il sito permette di immergersi nel passato più
antico per ripercorrere, in un ideale viaggio, i numerosissimi culti che animavano la prima colonia di Roma.
Le tappe di questo viaggio saranno rappresentate dalle più interessanti manifestazioni artistiche ed
architettoniche che ancora oggi preservano il ricordo di antichissimi culti orientali, giunti a Roma per mezzo
dei soldati di ritorno dalle campagne militari nel lontano Oriente, propagano l’eco di un cristianesimo
nascente e sempre più praticato nel cuore dell’impero romano, svelano i segreti della religione ufficiale e
del suo enorme potere politico. Attraverso templi, mitrei, sacelli e sepolture si potrà indagare la società
ostiense ed i più diversi e caratteristici costumi religiosi romani.
Breve storia di Ostia Antica
Per poter affrontare questo viaggio è però necessario aver chiaro, seppure per cenni sintetici, quale è stata
la lunga storia dell’antica Ostia.
Numerose fonti letterarie, tra cui la più importante è l’autore latino Livio, tramandano la notizia della
fondazione di Ostia da parte del quarto re di Roma Anco Marcio, uno dei monarchi più importanti per la
storia della Roma arcaica in quanto primo fra tutti ad ampliare i confini della città (questa si estendeva
originariamente soltanto lungo la riva sinistra del fiume Tevere). Al re si deve infatti la conquista della riva
destra del fiume, tradizionalmente sotto la giurisdizione etrusca tanto da essere denominata ripa veientana
(la riva di Veio, una delle più importanti città etrusche nel territorio laziale), attraverso avamposti militari
realizzati all’altezza del Ponte Sublicio, che egli stesso aveva fatto costruire. Questo fattore,
apparentemente slegato dalla storia di Ostia, ha profondamente a che vedere con la nascita della colonia
poiché fu proprio Anco Marcio ad assoggettare le popolazioni che avevano precedentemente stabilito
insediamenti in prossimità della foce del fiume. In tal modo questi popoli potevano controllare le
preziosissime saline naturali (il sale serviva non solo alla conservazione dei cibi ma anche alla concia delle
pelli e alle operazioni di metallurgia), tra i quali il più rilevante era stato il centro di Ficana presso il Monte
Cugno (odierna zona dei Monti di san Paolo).Tuttavia prove archeologiche dell’esistenza di una Ostia di età
regia nel sito dove si sviluppò effettivamente la città commerciale che oggi visitiamo non esistono: ciò
significa che, allo stato attuale, non sono ancora state ritrovate testimonianze risalenti al VII secolo a.C.
sotto le emergenze architettoniche posteriori, prevalentemente di età imperiale. I resti più antichi riportati
alla luce risalgono infatti al IV secolo a.C., ovvero all’età repubblicana.
Nel corso del tempo il dibattito sulle origini di Ostia si è fatto sempre più acceso e solo negli ultimi decenni
ha guadagnato autorevolezza l’ipotesi che il sito dell’Ostia regia fondata da Anco Marcio non sia quello che
comunemente viene riconosciuto come tale e dove oggi si trovano i resti della città imperiale. I primi ad
avanzare tali ipotesi furono Lorenzo Barbieri (agronomo di professione e archeologo amatoriale) e Giorgio
Pascolini (maestro disegnatore della Sovrintendenza di Ostia Antica) che negli anni ’50 effettuarono una
serie di ricerche sul territorio dell’odierno X Municipio, protrattesi nel tempo, che permisero ai due studiosi
di formulare un’avvincente tesi, supportata da rilievi topografici, archeologici e da studi geologici: secondo
la tesi di Barbieri e Pascolini l’Ostia regia fondata dal re romano si trovava presso la sponda meridionale
dello stagno di Ostia, laguna alimentata da un braccio del Tevere e collegata direttamente al mare da un
canale naturale, nella zona ora corrispondente alla Via di Castel Fusano, quartiere Longarina-Stagni. Lo
stagno di Ostia, bonificato in via definitiva grazie all’intervento dei ravennati nel 1884, costituiva in effetti
un approdo portuale ben più sicuro ed agevole di quello che si riteneva esser stato costruito alla foce del
Tevere, con le sue correnti tumultuose e il perenne problema dell’insabbiamento e dei detriti trasportati
dal fiume. I ritrovamenti archeologici compiuti da Barbieri prima e, negli ultimi anni, dalla stessa
Sovrintendenza nel luogo dove si estendeva lo stagno sono di particolare importanza: dove oggi è in
costruzione il nuovo campeggio Capitol sono state riportate alla luce una serie di costruzioni interpretabili
come banchine portuali di prima età repubblicana, una pietra di ormeggio e altri reperti che
confermerebbero la tesi Pascolini-Barbieri. Lo spostamento dell’insediamento portuale dalla laguna al sito
odierno fu dovuto al restringimento dello stagno, non più capace di accogliere la grande quantità di navi
che qui giungevano; fu perciò ri-fondata la colonia di Ostia. La storia di questi due studiosi è
particolarmente singolare: per anni i due hanno girato in lungo e in largo la zona dell’antico stagno,
potendo effettuare puntuali ricerche e studi anche in porzioni di territorio oggi inaccessibili a causa della
selvaggia urbanizzazione, senza essere mai ascoltati dagli accademici e tacciati di essere dei “visionari”. Solo
recentemente il lavoro di questi studiosi è stato ripreso ed approfondito, per la prima volta reso degno di
analisi scientifica.
Detto ciò, la parte più antica del Parco archeologico di Ostia Antica è il castrum. Il nome di questo primo
insediamento deriva dalla sua conformazione e dalla sua funzione: il castrum era l’accampamento militare
romano, costituito da una sorta di griglia ortogonale emanazione delle due principali vie, il cardo ed il
decumano massimi. Dunque la prima Ostia era in realtà un avamposto militare in funzione difensiva della
costa, definitivamente posta sotto il controllo romano dopo la sconfitta degli etruschi di Veio nel 396 a.C. Si
deve a questo proposito ricordare che la linea di costa attuale è in posizione molto più avanzata rispetto a
quella originaria, proprio a causa del continuo apporto di detriti trasportati dal fiume, così che la spiaggia in
epoca romana si trovava ai limiti degli scavi oggi visitabili. Pur non esistendo fonti documentarie che
informino in maniera precisa della costruzione di questo fortilizio, gli archeologi oggi tendono ad
individuare il momento di fondazione del castrum nella seconda metà del IV secolo a.C.
Sin dalle sue prime fasi di vita, la città di Ostia non si presentava come una tradizionale colonia romana.
Sappiamo infatti che alla creazione del castrum non seguì una lottizzazione dei terreni agricoli, come negli
atti di fondazione di tutte le altre colonie romane (e lo sappiamo perché nei terreni circostanti la città non
sono venuti alla luce resti di aziende agricole di questo periodo, piuttosto ville rustiche più tarde nella zona
di Dragoncello). Ostia aveva un’altra importantissima funzione, oltre a quella bellica (di difesa, con le navi
da guerra ormeggiate nel porto, tanto che da Ostia partirono le navi romane durante la prima guerra
punica): aveva funzione annonaria, ovvero di approvvigionamento della città di Roma. Essendo uno scalo
portuale, ad Ostia giungevano le grandi navi mercantili, cariche soprattutto di grano, olio e vino. Queste
grandi navi non erano in grado di risalire il corso del fiume per giungere direttamente agli scali fluviali di
Roma. Approdavano ad Ostia, scaricando le merci che venivano in parte direttamente trasportate su
imbarcazioni minori o su chiatte condotte per terra da buoi per arrivare a Roma. Oppure erano stoccate nei
magazzini ostiensi per poi essere rivendute nei mercati dell’Urbe. E’ questa la ragione principale della
sudditanza amministrativa di Ostia rispetto alla città di Roma nei primi periodi della sua storia: Ostia non
aveva un’amministrazione autonoma, ma dipendeva direttamente dai magistrati di Roma. Senza Ostia
Roma non mangiava. Successivamente, nel periodo di crescente prosperità di Roma (dagli ultimi decenni
della Repubblica fino alla fine del II secolo), Ostia si distaccò dall’Urbe dal punto di vista amministrativo:
venne creato un organo collegiale di decuriones e si istituirono magistrature autonome a cadenza annuale
come i duoviri e gli edili (i Fasti Ostienses ci informano sui nomi di tutti questi magistrati fino al 251). E’ a
partire dal III secolo che si registra un’inversione di marcia: la città tornò ad essere sotto il diretto controllo
di Roma, a causa della generale crisi che aveva investito l’impero. Tale crisi avviò la città ad una lenta ma
inarrestabile decadenza, tanto che in epoca tardoantica Ostia aveva ormai perso la sua principale
vocazione, quella commerciale, assunta in prima istanza dalla nuova città di Porto, nata in seguito alla
costruzione dei bacini portuali di Claudio e Traiano. Quando nel V secolo si registrarono a Roma le più
terribili scorribande dei popoli barbarici, Ostia, stando alle fonti, non sembra essere stata toccata da questi
devastanti saccheggi, nemmeno da quello dei Vandali del 455, unico popolo barbarico in grado di navigare
e che aveva raggiunto la città di Roma proprio attraverso il fiume, sintomo questo che la città aveva ormai
perduto di importanza strategica e di prestigio. Nei secoli seguenti venne quasi definitivamente
abbandonata tanto che rimasero funzionanti pochissimi edifici: quelli trasformati in senso cristiano (si veda
l’oratorio di san Ciriaco, tappa dell’itinerario proposto) e quelli utilizzati come calcare, sorta di officine della
calce, dove si realizzavano forni per la cottura dei materiali architettonici trasformati così in calce. I pochi
abitanti rimasti nel IX secolo si rifugiarono nel borgo fortificato fatto costruire da Gregorio IV (da cui la
denominazione di Gregoriopoli) in seguito alle incursioni saracene che sarebbe diventato il nuovo centro
abitato della zona. Lentamente si perse la memoria dei luoghi della fiorente città di Ostia, ormai sommersa
dai calcinacci e dai resti degli antichi grandiosi edifici, ricoperta dai detriti delle piene del Tevere, erosa
dall’azione del fiume. Due soli monumenti spiccavano ancora alla vista da quella che era ormai diventata
una campagna per il pascolo: il teatro e il Capitolium.
Scavi sistematici nella città antica ebbero inizio per volontà di Pio VII Chiaramonti (1824), pontefice
particolarmente sensibile alla questione delle antichità (fu infatti lui a promulgare il famosissimo chirografo
con cui si proibiva qualsiasi tipo di attività clandestina legata alle antichità, gli scavi, i commerci, i furti e gli
usi impropri, alla base del moderno concetto di salvaguardia del patrimonio culturale). Con Pio IX Mastai
Ferretti si ebbe invece la prima campagna di scavo vero e proprio, teso al recupero delle vestigia antiche. Il
grosso delle ricerche archeologiche furono realizzate dagli anni ’20 agli anni ‘40 del Novecento soprattutto
sotto la guida dell’allora Sovrintendente Guido Calza che procedette però, secondo metodologie in voga
all’epoca, all’eliminazione di tutto quello strato archeologico pertinente alla prima età medievale che non
essendo giunto fino a noi, lascia insolute alcune questioni relative alla storia della città.
Prima tappa - Necropoli della Via Ostiense
Il percorso di visita inizia dalla necropoli della via Ostiense poiché i ruderi di questo cimitero subdiale
danno l’opportunità di raccontare come fosse vissuta la morte dai romani ma soprattutto quali fossero i riti
funebri e religiosi connessi con questa tappa fondamentale della vita umana.
La necropoli della via Ostiense è il sepolcreto più antico della città di Ostia dal momento che le tombe più
longeve che vi si trovano risalgono al II secolo a.C., costruite perciò in un periodo in cui le mura della città
ancora non erano state realizzate (Ostia fu infatti fortificata nel I secolo a.C.). L’altra grande necropoli della
città, quella della via Laurentina, strada che conduceva alla città romana di Laurentum, sorse in un secondo
momento appena fuori la Porta Laurentina; nel complesso questo cimitero appare costituito da sepolture
appartenenti a ceti meno elevati di quelli presenti nella necropoli ostiense. Il fatto che questo fosse il più
antico e notabile cimitero fu probabilmente dovuto proprio al suo estendersi lungo la via Ostiense dal
momento che si trattava della strada più trafficata dell’epoca, collegando direttamente l’Urbe alla sua
colonia. Essendo il più antico e rinomato sepolcreto questo rimase attivo per lunghissimo tempo e dunque
non deve stupire che, durante le campagne di scavo susseguitesi negli anni, vennero portate alla luce circa
60 tombe, appartenenti a differenti epoche, testimonianze di usi funerari differenti. Tra queste la tipologia
più antica è costituita di un semplice recinto in muratura, chiuso da ogni lato ed accessibile soltanto per
mezzo di scale; all’interno del recinto venivano ospitate le ceneri dei defunti in urne deposte nel terreno. A
partire dalla prima età imperiale (epoca di Augusto) le tombe iniziarono a monumentalizzarsi e furono
sostituite dai colombari, camere sepolcrali, anche a due piani, nelle quali venivano realizzate nicchiette
sulle pareti in cui riporre le urne crematorie. I colombari maggiori, quelli appartenenti a personaggi
facoltosi o famiglie particolarmente numerose, erano provvisti di recinti per il rogo crematorio, il cosiddetto
ustrinum. In questo modo i colombari si qualificavano come vere e proprie cappelle di famiglia. Con l’età
aurea della Roma imperiale (II secolo d.C., soprattutto durante il principato di Adriano) i riti funerari
cominciarono a cambiare, preferendo tipologie sepolcrali legate all’inumazione. Le architetture funerarie
perciò si modificarono per poter accogliere nuovi tipi di sepolture: queste erano costruite per ospitare
sarcofagi in marmo o più spesso in terracotta (di cui si possono notare degli esempi seppur non pregiati tra
le stradine che compongono la necropoli) entro gli arcosoli, grandi nicchie a forma di lunetta o arco.
Ma quali erano gli usi funerari romani? Quali culti animavano le celebrazioni funebri? Quali erano le divinità
che sovrintendevano alla sfera della morte? La premessa più importante da puntualizzare è che i romani
non temevano la morte, in quanto parte del ciclo umano e soprattutto in quanto termine di un’esistenza
che doveva essere stata retta ed onorevole. Osservato ciò, appare naturale constatare che anche la divinità
preposta alla morte non era percepita né considerata come una divinità orrifica e crudele; in massima parte
poiché la dea Libitina più che alla morte era in realtà legata alle pratiche funebri: a lei venivano offerti vino
rosso e latte in luogo di sanguinari sacrifici. Il suo stesso nome secondo alcune tradizioni deriverebbe dal
termine libagione che designa l’atto di recare delle offerte durante il rito della sepoltura. Il maggior
santuario dedicato alla dea si trovava nel bosco sacro presso il colle Esquilino e lì venivano conservati i
documenti relativi alle statistiche di morte ma soprattutto gli strumenti usati dai professionisti delle
moderne onoranze funebri, chiamati per l’appunto libitinarii. Questi si occupavano di ogni aspetto
concernente la sepoltura dei defunti che poteva avvenire tramite pagamento privato, qualora la famiglia
avesse avuto la sufficiente disponibilità finanziaria oppure erano affidate ad un‘organizzazione statale che si
occupava di seppellire decorosamente i defunti non abbienti entro fosse comuni. Il rito funebre di un
notabile romano era elaborato. All’atto della morte un familiare baciava sulla bocca il proprio caro, in parte
per assorbire un poco della sua anima nella propria, in parte per non far subito fuggire l’anima del morto
nell’oltretomba. Dopo il bacio questo stesso parente chiudeva gli occhi del defunto ripetendo per tre volte
il suo nome. Solo a questo punto intervenivano i libitinarii che preparavano il corpo lavandolo, ungendolo,
vestendolo della toga (che solo i cittadini romani potevano indossare, essendo una sorta di veste
dichiarante l’autorevolezza della persona) e mettendogli tra i denti una moneta, l’obolo per il traghettatore
di anime Caronte. Il cadavere era poi trasportato nell’atrio della casa per essere esposto alla cittadinanza
per qualche giorno. Durante questa esposizione (che potrebbe definirsi quasi una veglia) avveniva il celebre
rito del lamento funebre; alle donne della famiglia toccava piangere e disperarsi: più era forte il lamento
più si rimpiangeva la perdita della persona. La naturale conseguenza era che, per esaltare il defunto, si
diffuse l’uso di pagare donne estranee alla famiglia, le cosiddette prefiche, per fornire il consono pianto di
disperazione durante la cerimonia. Trascorsi i giorni dell’esposizione si apprestava il corteo funebre. A capo
della processione vi erano gli uomini in toga che portavano le immagini degli antenati, calchi fatti realizzare
alla morte dei parenti che venivano custoditi nelle case dei romani. Del corteo facevano parte anche mimi e
danzatori, le donne piangenti, le personalità eminenti come i magistrati. Il corteo aveva termine presso il
cimitero, esclusivamente fuori le mura poiché nel diritto romano era severamente vietato seppellire i morti
all’interno della cinta muraria. Una volta giunti nel cimitero il defunto veniva adagiato sulla pira funebre
accesa da un congiunto per essere bruciato assieme a tutti gli oggetti che ne rappresentavano l’esistenza.
Dopo la cremazione il fuoco veniva spento con del vino e le ceneri raccolte per essere depositate nell’urna
da collocare nella tomba di famiglia. Una volta deposta l’urna, o il corpo inumato, si celebrava il banchetto
funebre a cui partecipava tutto il corteo che aveva luogo accanto alla tomba: venivano offerti cibi speciali in
parte sepolti assieme all’urna stessa.
Tra i sepolcri più interessanti della necropoli ostiense vi sono i cosiddetti Colombari Gemelli, due camere
sepolcrali simmetriche ed identiche risalenti al I secolo d.C. Originariamente questi erano costituiti da un
vestibolo cui si accedeva da una stretta vietta parallela alla via Ostiense in cui ancora oggi si possono notare
le scale che portavano alla terrazza superiore dove probabilmente si celebravano i banchetti ed i riti funebri
annuali nel giorno della ricorrenza della scomparsa. Attraverso il vestibolo si accedeva alla camera
sepolcrale vera e propria, in cui erano ricavate le nicchiette per le urne, che ancora oggi si vedono in
maniera assai chiara, spesso intonacate e decorate ad affresco. Le urne trovavano posto entro le nicchiette,
a volte accompagnate dai busti-ritratto dei defunti. Questi due sepolcri appartengono alla tipologia dei
colombari autarchici in quanto provvisti di apparati funebri autonomi: è infatti ancora visibile l’ustrinum tra
le due tombe (sul lato della Via dei Sepolcri) che nel II secolo fu trasformato in una sepoltura a inumazione
con l’aggiunta di un arcosolio.
Seconda tappa - Mura repubblicane e Porta Romana
Continuando sulla via Ostiense e lasciandosi alle spalle la necropoli si giunge alla Porta Romana, la porta di
accesso più importante della città presso la quale terminava la via Ostiense. Questa breve sosta non
riguarda strettamente l’itinerario religioso proposto ma serve a comprendere che da questo tratta in poi si
entra ufficialmente all’interno della città di Ostia, con la trasformazione della via Ostiense in decumano
massimo. La Porta Romana, come le altre porte principali della città (Porta Marina e Porta Laurentina), era
fiancheggiata da possenti torri quadrate di cui si scorgono ancora oggi i resti sulla sinistra. Le mura difensive
circondavano la città solo su tre lati dal momento che il lato settentrionale era quello adibito a scalo
portuale sul Tevere, si decise perciò di non costruirvi mura per non intralciare i lavori del porto.
Inizialmente si riteneva che le nuove mura della città (le originarie sono quelle del castrum, nel cuore più
antico di Ostia) fossero state costruite per volontà di Silla dopo che la colonia fu devastata dalle truppe del
suo avversario Mario durante la guerra civile dell’87 a.C. Si narra infatti che la città, che parteggiava per
Silla, fosse stata presa dai mariani grazie al tradimento del capitano della cavalleria posta a guardia della
città. In base al dato della presenza della cavalleria risulta che Ostia a quel tempo doveva essere ancora
sprovvista di mura. Oggi si tende invece a postdatare la costruzione delle mura all’età di Cicerone (prima
metà I secolo a.C.).
Terza tappa - Caesareum della Caserma dei Vigili
La Caserma dei Vigili apparentemente nulla ha a che fare con il percorso religioso all’interno dell’antica
Ostia. Una città così piena di magazzini e densamente popolata quale era al massimo apice del suo sviluppo
non poteva non avere un distaccamento di vigiles: la stessa parola latina ci suona molto familiare. I vigiles
erano un corpo di forze dell’ordine costituto da soldati che aveva la fondamentale funzione di prevenire e
spengere gli incendi che, in città come questa, erano frequentissimi. Senza scomodare il più famoso
incendio di Roma, quello sviluppatosi nel 64 allorquando bruciarono ben 11 regiones delle quattordici che
componevano la città (di cui tre completamente distrutte), pensiamo a quanto doveva essere frequente il
problema degli incendi soltanto per il fatto che l’illuminazione era garantita esclusivamente dalle torce a
fuoco. La caserma che si ammira oggi venne ricostruita da Adriano, seguendo l’iniziale progetto di
Domiziano, primo imperatore a dare il via ad un generale riordino urbanistico di Ostia. Ma ciò che
caratterizza il luogo tanto da inserirlo nell’itinerario religioso non è la caserma stessa, che tuttavia
rappresenta un bellissimo esempio di funzionalità architettonica (con il suo cortile centrale a pilastri,
attorno al quale si articolavano tutte le stanze dei soldati e con i due lavatoi semicircolari) bensì il piccolo
sacello che si trova in fondo al cortile dedicato al culto imperiale, che nelle maggior parte delle guide
archeologiche è segnalato con la denominazione di Caesareum. Che cosa era il culto imperiale? Quale era la
sua importanza all’interno del contesto religioso romano? Il culto imperiale può essere sinteticamente
definito come la speciale devozione riservata agli imperatori, i quali impersonavano la gloria e la potenza di
Roma che, una volta morti, venivano divinizzati. Culti simili erano già anticamente diffusi in Oriente, dove i
sovrani viventi erano spesso associati alle divinità e a questi si tributavano onori e sacrifici sulla scia della
concezione dell’uomo-dio (si pensi all’esempio più rinomato fra tutti, quello dei faraoni). Ma nella religione
romana questo aspetto si era manifestato soltanto in epoca arcaica (VIII secolo a.C.), con l’assunzione tra le
divinità di Romolo, fondatore della città di Roma, e soltanto dopo la sua morte, fattore questo molto
significativo. Sentori della tendenza a impiantare anche a Roma un simile culto della persona (pur associata
alla grandezza della città) vi erano stati nella tarda età repubblicana: Silla, Pompeo, Cesare. Fu quest’ultimo
che, riuscendo a ottenere la dittatura a vita, pose le basi per la nascita dell’impero e del culto imperiale.
Una volta morto Cesare venne divinizzato per volontà del Senato che lo dichiarò divus: entrò a far parte a
tutti gli effetti del pantheon romano, gli venne costruito e dedicato un tempio (il Tempio del Divo Giulio), fu
istituito ufficialmente il suo culto. Fu però con Augusto che il cerimoniale dell’apoteosi (divinizzazione) e
l’istituzione del culto imperiale si configurò come un vero e proprio sistema religioso. In quanto pacificatore
dell’impero (pax augustea) Ottaviano, che si era fatto tributare tutte le più importanti magistrature a vita
divenendo così Augusto e dunque imperatore, era già stato acclamato in vita come divus nelle province
orientali, avvezze a questo tipo di concezione del sovrano-dio. Ma a Roma tale principio religioso non
poteva essere accettato così che l’imperatore delineò un sistema che sarebbe stato ripreso dai suoi
successori. Seguendo l’escamotage augusteo all’imperatore ancora in vita non poteva essere associato
nessun culto della persona, eppure poteva diventare oggetto di culto il proprio nume tutelare, il genius (nel
caso di Augusto il Genius Augusti). Solo una volta deceduto, l’imperatore poteva finalmente essere
deificato dal suo successore attraverso una complessa cerimonia, nota come apoteosi. Durante questo
pubblico rito la sua immagine di cera era bruciata su una pira affinchè si sollevasse da questa un denso
fumo, simbolo dell’assunzione tra le divinità. Contestualmente veniva fatto edificare un tempio a lui
dedicato ed istituito il culto. La decisione circa la deificazione veniva presa dal successore al trono
imperiale, a volte per mera opportunità politica: ogni apoteosi aveva però l’obbligo di essere giustificata da
particolari meriti dell’imperatore nell’aver assicurato grandezza a Roma, alla cui divinizzazione spesso il
culto imperiale era associato, come si può notare all’interno della stessa Ostia nel Tempio di Roma e
Augusto.
Nella caserma fu ricavata questa piccola cappella per il culto imperiale, come spesso accadeva nelle sedi di
importanti istituzioni. Sul podio sono infatti presenti le are dedicate a cinque tra i più celebri ed amati
imperatori: Antonino Pio, Lucio Vero, Marco Aurelio in vita in quanto erede e già defunto, Settimio Severo.
Nella successione degli imperatori manca un nome noto, quello dell’imperatore Commodo, succeduto a
Marco Aurelio. Quest’ultimo aveva scelto suo figlio Commodo quale successore, mettendo definitivamente
fino al cosiddetto principato adottivo che si era imposto a partire da Traiano e che aveva donato all’impero
alcuni fra i sovrani più importanti della sua storia. La ragione della mancanza dell’ara dedicata a Commodo
sta nel fatto che dopo la sua uccisione (in una congiura ordita ai suoi danni) l’imperatore fu soggetto a
damnatio memoriae, ovvero alla cancellazione di qualsiasi sua immagine e memoria, per essere
condannato all’oblio. La condanna fu decisa per principale iniziativa del Senato, suo acerrimo nemico,
nonostante Commodo fosse stato un sovrano tollerante e munifico, soprattutto con le truppe. Il Senato
non poteva però accettare i suoi atteggiamenti dispotici e autoritari sul modello dei grandi sovrani
ellenistici.
Quarta tappa - Oratorio di san Ciriaco
Tornando lungo il decumano massimo, all’altezza del teatro ci si trova di fronte ad una delle più sicure e
durature testimonianze cristiane all’interno della città di Ostia. Le vicende che riguardano l’identificazione
di questi resti con l’oratorio di san Ciriaco prendono le mosse nel 1909-1910 quando vennero effettuati gli
scavi nella zona del teatro ed emersero resti pertinenti due costruzioni molto importanti, tramandate dalle
fonti cristiane: l’arco di Caracalla e il sacello dedicato a san Ciriaco. Documenti medievali come la Passio di
Aurea (le passiones sono racconti della vita e del martirio dei più importanti martiri cristiani) e il
Martirologio Geronimiano (calendario dei giorni di martirio dei santi con relativa tortura e morte) riportano
la storia di un famoso martire ostiense, tale Ciriaco vescovo, che insieme ad altri cristiani che si
adoperavano per la conversione della popolazione pagana di Ostia, vennero torturati e condannati a morte
proprio nella città marittima e sepolti nei cimiteri limitrofi. Secondo la tradizione cristiana Ciriaco visse
durante l’impero di Claudio e dedicò la sua vita, in quanto vescovo della comunità ostiense, alla
predicazione e alla conversione. Assieme a lui operava nella città un folto gruppo di cristiani ai quali si
aggiunse Aurea, conosciuta dalle fonti con il nome greco di Chryse (dorata), che era stata esiliata da Roma a
causa della sua fede cristiana ed era giunta ad Ostia rifugiandosi in una villa di sua proprietà. Aurea, Ciriaco
ed altri furono però arrestati dalle autorità cittadine poiché colpevoli di praticare la religione cristiana, il cui
culto non era ancora ammesso. Vennero perciò incarcerati e poi uccisi: mentre Aurea e gli altri furono
uccisi, secondo le fonti, davanti l’arco di Caracalla, rinvenuto proprio in questo luogo, a Ciriaco venne
invece concesso il privilegio di essere ucciso nella prigione stessa. Nel luogo in cui morirono martiri gli altri
personaggi di questa leggenda molto tempo dopo (nel tardo IV o nel V secolo) fu costruito questo piccolo
luogo di culto per onorarne la memoria dove fu probabilmente traslato il corpo di Ciriaco, prima sepolto
altrove. Dell’edificio sopravvivono poche murature, tutte di reimpiego (ovvero murature realizzate con
materiali utilizzati per altre costruzioni) e proprio in base a questo elemento si crede che l’oratorio sia di un
periodo piuttosto tardo. Questo sorge con la sua abside sopra un ninfeo (fontana monumentale) che
originariamente decorava il prospetto centrale del teatro. La sicurezza con cui si ritiene che l’edificio sia
tardo è giustificata non solo dalla muratura ma anche perché, al momento della scoperta, fu trovato a poca
distanza un sarcofago con la raffigurazione di Orfeo (assimilato a Cristo nell’iconografia paleocristiana) ed
un’iscrizione che recitava “Qui Ciriaco riposa in pace”: dal momento che nel diritto romano era
severamente vietato seppellire i morti all’interno delle mura si deve obbligatoriamente affermare che il
luogo di culto fosse stato realizzato in un momento in cui la città era ormai spopolata e non si badava più
alle regole precedenti. Questo piccolo oratorio costituito da una sola navata sopravvisse all’abbandono di
Ostia proprio perché divenne uno dei posti più venerati del territorio, in quanto legato alla memoria dei
martiri ostiensi. Quando infatti i pochi abitanti rimasti nel medioevo si trasferirono nel borgo fortificato di
Gregoriopoli (fatto realizzare da Gregorio IX per proteggere i residenti dalle incursioni dei pirati saraceni nel
luogo corrispondente all’odierno borgo di Ostia Antica) non dimenticarono la piccola chiesetta ed anzi
continuarono ad effettuare periodici pellegrinaggi alla sepoltura di Ciriaco.
Questo luogo di culto ci da l’occasione per aprire un piccolo excursus sul culto dei martiri e sul suo sviluppo.
Sappiamo che la religione cristiana ottenne l’autorizzazione al culto soltanto nel IV secolo quando per
volontà dell’imperatore Costantino fu emanato nel 313 l’Editto di Milano, togliendo il cristianesimo dalla
sfera della clandestinità (nel 381 invece con gli Editti di Tessalonica promulgati dall’imperatore Teodosio il
cristianesimo divenne religione di stato, causando la soppressione ufficiale di tutti gli altri culti). Prima di
tale data, al di là delle persecuzioni più o meno violente nei confronti dei cristiani, questo culto doveva
celebrarsi segretamente e privatamente. Per tale ragione non si ha prova archeologica certa dell’esistenza
di luoghi di culto cristiani prima del IV secolo (allorquando Costantino fece costruire le prime basiliche della
cristianità): il rito eucaristico, centrale nella liturgia cristiana, veniva celebrato all’interno di residenze
private, le famose domus ecclesiae, messe a disposizione della comunità dei fedeli dai patrizi convertiti al
cristianesimo, che in nulla si differenziavano rispetto alle altre residenze in cui tali liturgie non avvenivano.
Gli unici segni distintivi dei cristiani si trovavano nei cimiteri dove le camere sepolcrali in cui i defunti
venivano seppelliti con l’inumazione erano decorate con motivi che alludevano al messaggio salvifico di
Cristo. In questi stessi cimiteri (che potevano essere sotterranei, come le catacombe, o subdiali) divennero
ben presto meta di pellegrinaggi le tombe dei martiri, considerati dei veri e propri eroi cristiani. Queste
tombe non avevano particolari abbellimenti, a volta solo delle semplici iscrizioni commemorative e i viaggi
che i fedeli compivano verso questi sepolcri erano del tutto spontanei, perché mossi da sincera fede e
devozione. Solo in un secondo momento, dopo l’Editto di Costantino, le tombe dei martiri furono
monumentalizzate: spesso costruendo sopra i sepolcri delle chiese (ed è il caso delle basiliche di San Pietro
e San Paolo) oppure edificando nei pressi delle tombe degli oratori, come questo di san Ciriaco, in cui i
pellegrini potessero agevolmente pregare ed appellarsi ai santi martiri. Dunque è proprio in questo
momento che la devozione verso i martiri diventa un culto vero e proprio, regolamentato, gestito e
controllato dalla Chiesa.
Quinta tappa - Tempio di Cerere
Superato a destra l’oratorio di san Ciriaco si entra all’interno del teatro per dirigersi oltre la skenè, verso il
tempio che fa scenograficamente da quinta scenica. L’identificazione di questo tempio con un santuario
dedicato alla dea Cerere è oggi fortemente messo in discussione. La maggior parte degli archeologici ritiene
falsata l’attribuzione del tempio a questa divinità, che deriva dai primi scavi condotti ad Ostia, dal momento
che non vi sono prove documentarie che attestino l’appartenenza di questo tempio ad un’area sacra a
Cerere. Secondo recenti studi è piuttosto da preferire la dedicazione del tempio al Pater Tiberinus, ovvero
al fiume Tevere. I romani, come altre civiltà del passato, usavano attribuire status divino a diversi aspetti
della natura, tra cui spesso divinità fluviali a cui si conferiva valore creatore: sulle rive di moltissimi fiumi si
svilupparono le più antiche ed avanzate civiltà, basti pensare alla “mezzaluna fertile” tra i fiumi Tigri ed
Eufrate o il fiorente popolo degli egizi sulle rive del Nilo. Per i romani grandissima rilevanza aveva il Tevere a
cui non a caso avevano attribuito l’appellativo di pater (padre). Il Tevere (Tiber in latino) aveva avuto nella
stessa fondazione della città un grande ruolo se si pensa che i due gemelli Romolo e Remo secondo la
tradizione sopravvissero proprio perché trasportati dalle acque del fiume fino all’area dove sarebbe sorta
Roma. Ma il fiume ebbe fondamentale importanza anche per lo sviluppo economico della città che permise
a questo nuovo insediamento nato su sette colli di espandere il proprio dominio in breve tempo, entrando
in contatto con i più svariati popoli ma sempre mantenendosi al sicuro poiché nell’entroterra e sulle rive del
fiume. E’ dunque verosimile che in questa zona della città di Ostia le autorità avessero fatto edificare un
tempio in onore del fiume Tevere. Molto probabilmente l’approdo portuale si trovava proprio alle spalle
del tempio, nella parte settentrionale della città che confinava con l’antico corso del fiume. Si trattava di
un’area lasciata libera dalle costruzioni secondo precise norme (promulgate dal pretore Caninio che aveva
espressamente sancito che tutta l’area compresa tra il castrum e la Porta Romana dovesse essere lasciata
sgombra da costruzioni, probabilmente proprio per agevolare i lavori portuali) e che cominciò ad essere
edificata soltanto in epoca imperiale, età alla quale risale il nostro tempio. L’aspetto originario del tempio e
del complesso circostante noto con il nome moderno di Piazzale delle Corporazioni si mantiene abbastanza
integro ancora oggi. Il tempio sorgeva al centro di uno spazio quadrangolare che aveva i lati occupati da
una serie di piccole camere sede delle società commerciali stranieri che facevano affari con i mercanti
ostiensi (i mosaici che si vedono tutt’intorno raffigurano spesso i simboli di queste terre lontane, si vedano
gli elefanti che identificavano l’Africa). Lo spazio interno era occupato da uno spazioso giardino al centro
del quale spiccava il luogo di culto. Questo svetta ancora oggi sopra un alto podio; salendo le scale si accede
all’edificio vero e proprio attraverso un vestibolo (pronao) ornato, come in origine, da due colonne corinzie.
Quando la zona venne scavata per la prima volta il tempio fu identificato come un luogo di culto dedicato a
Cerere, dea delle messi e dell’abbondanza, della fertilità e della nascita poiché i frutti, i fiori, le piante, i
raccolti, in sostanza la vita, erano considerati suoi doni. Questa divinità è tra le più complesse del pantheon
romano dal momento che si può definire come la summa di numerose assimilazioni religiose. Cerere infatti
è in parte la trasposizione romana della dea greca Demetra (i romani importarono dalla Grecia anche i
misteri legati a questa divinità, particolari culti riservati solo ad iniziati) protagonista di uno dei principali
miti oggi conosciuti, quello del rapimento della figlia Persefone da parte di Ade, che venne trasposto dai
romani nel rapimento di Core o Proserpina. Ma in parte Cerere è anche il risultato dell’assimilazione di
divinità prettamente italiche legate al culto della terra (Liber, Libera, Tellus). Era una delle principali figure
divine romane, rappresentata spesso come una vera e propria matrona, severa ed austera ma accogliente e
propizia: veniva sempre raffigurata con una corona di spighe e con cesti di frutta e di grano. Agli archeologi
che riportarono alla luce il santuario parve plausibile assegnare il tempio a questa benevola dea: secondo
tali studiosi infatti i commercianti che si recavano a fare affari nelle sedi delle società mercantili straniere
tutt’intorno al tempio, qualora avessero ottenuto contrattazione favorevoli, si recavano immediatamente
presso il tempio al centro della piazza per offrire libagioni alla dea. Ma Cerere aveva anche un aspetto
ctonio (infero): era legata al mondo dei morti in particolare durante i tre giorni dell’apertura del mundus di
Cerere, buca circolare che secondo il credo romano rappresentava il punto di collegamento tra il mondo dei
vivi e quello dei morti. Durante questi tre giorni (24 agosto, 5 ottobre e 8 novembre) l’apertura, chiusa con
una pietra per tutto il resto dell’anno, permetteva la fuoriuscita delle anime dei defunti buoni, che
tornavano ad affiancare parenti e cari. Erano tre fra i più sacri giorni del calendario romano in cui era
assolutamente vietato fare attività politica, muovere guerra, armare l’esercito, far salpare le navi. Il tutto
sotto la protezione di questa importante dea che aveva un sacerdote specifico, il flamen minor o flamine
cereale.
Sesta tappa - Mitreo di Felicissimo
Tornando sul decumano massimo e compiendo qualche passo in direzione del foro, si troverà sulla sinistra
una piccola via che conduce dapprima ad una delle tante fullonicae di Ostia, gli impianti di lavorazione dei
tessuti. Affacciandosi sul complesso protetto dai tetti per osservare le diverse vasche di decantazione dei
tessuti che qui venivano tinti, si prosegue verso un piccolo passaggio che reca a sinistra una delle
testimonianze più preziose circa l’antico e misterioso culto del dio Mitra. Si tratta dei resti di un mitreo,
luogo adibito a questo culto di origine orientale (iranica) arrivato a Roma grazie alla mediazione dei
legionari romani stanziati in oriente. Il mitreo in questione possiede una particolare importanza per ciò che
si è conservato della decorazione pavimentale a mosaico che illustra i vari gradi di iniziazione mitraica, per
alcuni versi ancora avvolti nell’ombra. Il mitraismo si diffuse a Roma a partire dal I secolo d.C. ma le sue
origini si perdono davvero nella notte dei tempi (tracce tra le più antiche nei territori orientali risalgono al
1300 a.C.) per trasformarsi in uno dei culti più ampiamente praticati nella società romana (escludendo dal
computo le donne che non ne erano ammesse) nel III secolo. Ricostruire con esattezza la genesi di questo
culto, la sua trasformazione o la stessa identità del dio Mitra è questione intricata, ricca di rimandi
mitologici, di assimilazioni e mediazioni. Basti, per poter interpretare i preziosissimi mosaici, un racconto
sintetico dei tratti fondamentali di questo mito. Quando il mitraismo giunse a Roma (secondo Plutarco
attraverso il contatto tra i soldati romani ed i pirati cilici deportati in Grecia all’epoca di Pompeo) molto si
era già perduto dell’originario culto legato allo zoroastrismo che voleva il dio Mitra componente
fondamentale della triade persiana costituita anche da Ahura Mazda (il dio creatore) e Anahita (la Grande
Madre), in qualità di divinità della distruzione finalizzata ad un nuovo inizio. Il dio Mitra venne ben presto
profilandosi sotto un altro profilo, fortemente legato agli aspetti cosmologici ed in particolare alla figura del
Sole, tanto che nel momento del massimo apogeo Mitra venne assimilato al Sol Invictus. Il mito del dio che
è stato possibile ricostruire attraverso le sole testimonianze archeologiche, mancando del tutto fonti scritte
che spieghino rituali, gerarchie ed essenza del culto (essendo questa una religione misterica, riservata cioè
ai soli iniziati che dovevano compiere un vero e proprio viaggio attraverso i vari gradi d’iniziazione) ruota
intorno alla nascita del dio da una roccia armato di coltello e fiaccola e vestito del berretto frigio. Avendo
stretto un patto con il Sole Mitra, dio della salvezza, riceve attraverso un corvo messaggero il compito di
uccidere il toro per assicurare al mondo la vita. Aiutato da un cane il dio riesce ad intrappolare il toro
all’interno di una cavità e ad ucciderlo conficcandogli il coltello nel ventre: in questo modo dal suo midollo
nasce il grano e dal sangue la vite. Nelle raffigurazioni della tauroctonia (l’uccisione del toro che è il fulcro
del rituale mitraico) sono sempre rappresentati anche altri due animali, lo scorpione che punge i testicoli
del toro ed il serpente che si abbevera del sangue; la loro presenza è tra gli studiosi ancora molto dibattuta,
alternativamente interpretata come favorevole o avversa a Mitra. Ucciso il toro e sgorgata la vita, il Sole e
Mitra stringono un patto di alleanza attraverso un banchetto cibandosi delle carni del bovino. Ma cosa ci
raccontano i mosaici di questo mitreo? Chi erano gli iniziati? Il mitreo del Felicissimo, così chiamato per il
committente di cui ancora si può vedere la firma all’estremità del mosaico (Felicissimus ex voto fecit), non
conserva la tipica struttura interna dei mitrei. Questi, costruiti preferibilmente al di sotto di altri edifici ma
laddove non possibile spesso edificati senza aperture di sorta a riprodurre la vera cavità mitologica,
avevano sempre l’entrata in posizione defilata rispetto all’asse dell’aula affinchè il luogo di culto non fosse
sotto lo sguardo indiscreto dei non iniziati. L’aula rettangolare era composta da podi paralleli (praesepia)
provvisti di appoggi per le vivande e le lucerne su cui si disponevano i fedeli in ordine gerarchico,
generalmente distesi; da un thronum (sorta di rialzo) posizionato su uno dei lati corti dell’aula, sul quale
veniva apposta l’immagine del dio intento ad uccidere il toro (splendidi esempi si possono ammirare
all’interno del Museo ostiense); da due nicchiette opposte al rialzo che ospitavano solitamente statuette
dei geni portatori di torce Cautes e Cautopates. L’unica parte che si è ben conservata del mitreo è il lungo
corridoio tra un sedile e l’altro in cui sono raffigurate le sette tappe dell’iniziazione mitraica, attraverso i
propri simboli, le rispettive protezioni planetarie e gli oggetti rituali corrispondenti. Le raffigurazioni sono
racchiuse entro riquadri che suggeriscono l’idea di una scala bidimensionale in cui ciascun piolo
rappresenta una stazione verso il massimo grado di iniziazione, quello di pater (unico officiante). Il riquadro
più vicino a quella che è oggi l’entrata reca diverse raffigurazioni: un cratere simbolo dell’acqua, un’ara
infuocata simbolo del fuoco e due berretti frigi, simbolo dei Dioscuri che a loro volta rimandano ai due
emisferi celesti in cui l’anima dell’uomo deve viaggiare. Verosimilmente ai lati di questo riquadro dovevano
trovare posto i due dadofori (portatori di torce). Il successivo riquadro svela il primo grado di iniziazione,
quello del Corvo, accanto alla protezione del simbolo del pianeta Mercurio (caduceo) e all’oggetto rituale
della coppa, probabilmente per le abluzioni che ogni fedele doveva compiere prima di entrare all’interno
del luogo di culto (spesso i mitrei conservano presso l’entrata delle cavità interpretabili come piccole
vasche, forse in questo caso il buco circolare sulla destra). Il secondo grado è sovrinteso dalla protezione di
Venere (diadema) e consiste nel grado del Ninfo a cui corrisponde la lucerna. Marte (con il simbolo della
lancia) protegge il terzo grado, quello del Miles a cui è legata la bisaccia del soldato; il quarto grado è quello
del Leone (il cui simbolo è la paletta per trasportare il fuoco) a cui si connette il pianeta Giove (la saetta) ed
il sistro, oggetto rituale legato alla Magna Mater; il grado del Persiano (spada falcata tipica dei soldati
persiani) è il quinto, sotto la protezione della Luna, a cui è connessa la falce; il sesto riquadro è quello
dedicato al grado dell’Eliodromo, simboleggiato dalla frusta della quadriga solare, tutelato dal Sole, la
corona raggiata (si noti il numero dei raggi, sette come le sfere planetarie dell’iniziazione) e la torcia; il
settimo ed ultimo grado è quello del Pater simboleggiato dal berretto frigio, sotto la protezione di Saturno
(falcetto) a cui si abbinano gli oggetti rituali della patera per le libagioni e della bacchetta del comando. In
corrispondenza delle rappresentazioni trovavano posto i fedeli suddivisi a seconda del grado pronti a
partecipare alla cerimonia cultuale che si concludeva con un banchetto denominato agape.
Settima tappa - Capitolium e Foro
Tornando sul decumano massimo si procede verso il castrum, del quale sono ancora oggi visibili le mura
difensive in grandi blocchi di tufo. Superata l’entrata della prima Ostia si giunge presso il foro, punto
nevralgico di tutta la città. Dal punto di vista urbanistico il foro era uno slargo (poi diventato piazza
porticata nella tarda età repubblicana e imperiale) posto all’incrocio tra le due più importanti strade delle
città romane: il cardo e il decumano massimi. Queste due strade perpendicolari davano origine all’impianto
urbanistico a scacchiera delle città romane di nuova fondazione, riprendendo la classica disposizione degli
accampamenti militari. Il primo nucleo della città di Ostia si sviluppò proprio all’incrocio fra queste vie,
senza tuttavia mai realizzare una vera e propria piazza di rappresentanza. All’atto di fondazione di una
colonia i romani procedevano sempre attraverso le stesse tappe: si aprivano le due strade principali (cardo
e decumano), si cingeva l’area dell’insediamento con delle mura (quelle del castrum ostiense sono del IV
secolo a.C.) e si costruiva presso il foro il maggiore e più importante fra tutti i luoghi di culto appartenenti
alla religione ufficiale romana: il tempio della Triade Capitolina, dedicato alle principali divinità Giove,
Giunone e Minerva, sul modello del Tempio di Giove Ottimo Massimo sul Campidoglio, il colle di Roma che
prende il nome tempio (Campidoglio-Capitolium). Il foro e il tempio che oggi si ammirano non
appartengono alla prima fase di vita della colonia ostiense; acquisirono infatti questo aspetto soltanto nel II
secolo (120 d.C) per volontà dell’imperatore Adriano che aveva proceduto ad una generale sistemazione e
riedificazione della zona a nord del decumano massimo. Adriano fece dunque costruire l’attuale tempio che
mantiene ancora oggi l’impianto architettonico originale. Si ergeva e si erge ancora su un alto podio (gli
scalini sono stati in parte ricostruiti) ed era interamente realizzato in mattoni rivestiti da pregiate lastre di
marmo (oggi scomparse). Alla cella (naos) si accedeva tramite un portico a colonne corinzie (di cui rimane
qualche resto): all’interno dell’edificio erano posizionate le statue rappresentanti le tre divinità Giove,
Giunone e Minerva. Alcuni studiosi ritengono che la cella (il naos, la parte sacra del tempio) fosse tripartita,
divisa cioè in tre parti ciascuna delle quali dedicata ad un dio. Altri invece affermano che questo Capitolium
fosse a cella unica e che le statue delle divinità fossero collocate nello stesso ambiente ma in diverse
nicchie. La Triade Capitolina era il simbolo stesso della città di Roma, ed è per questa ragione che alla
fondazione di ogni colonia i romani rinnovavano la loro devozione nei confronti delle tre divinità (di cui la
più importante era il Giove Capitolino, ovvero Ottimo e Massimo) con la costruzione di santuari gemelli a
loro dedicati. Non è un caso dunque che il corteo che si snodava durante il trionfo (la più importante
cerimonia politica romana che celebrava le vittorie militari) e che attraversava tutta la città si concludesse
proprio davanti al Capitolium romano dove venivano offerti dei sacrifici alla Triade.