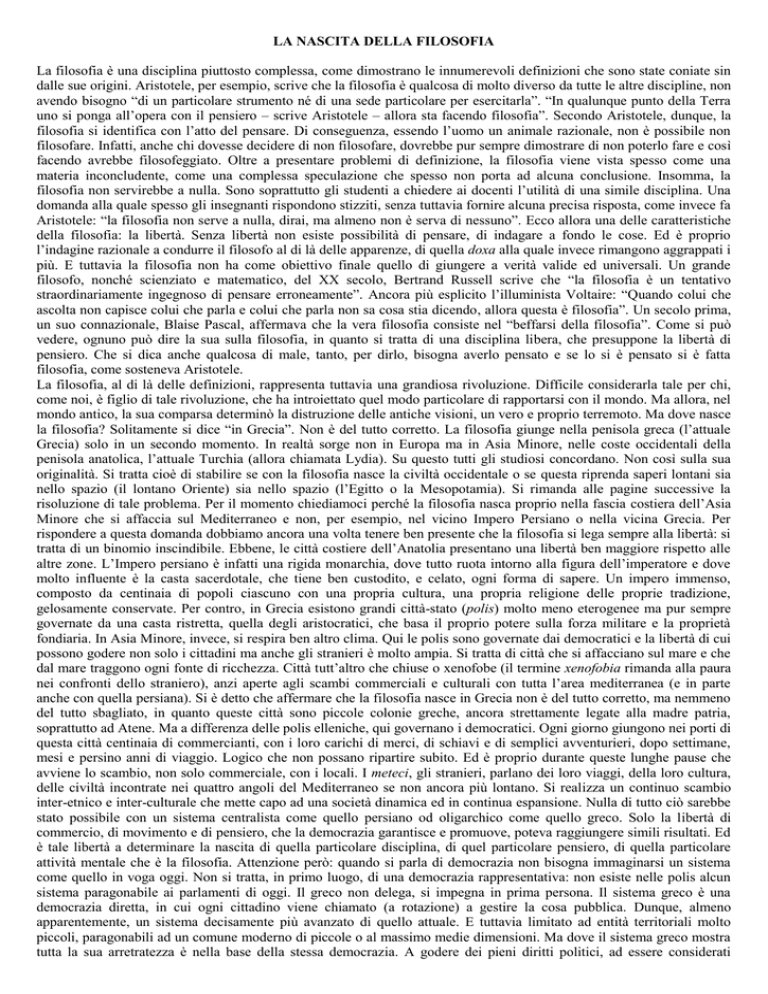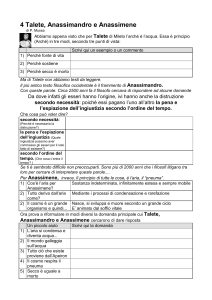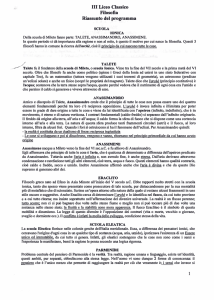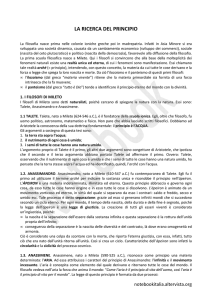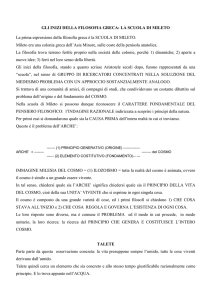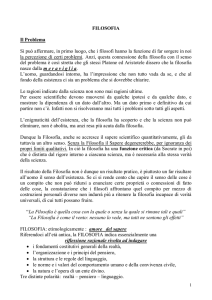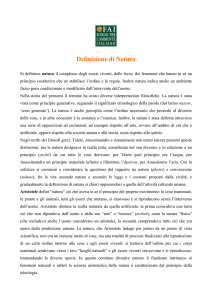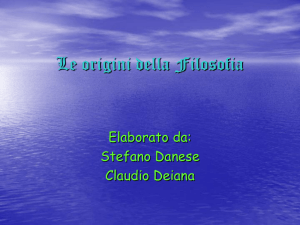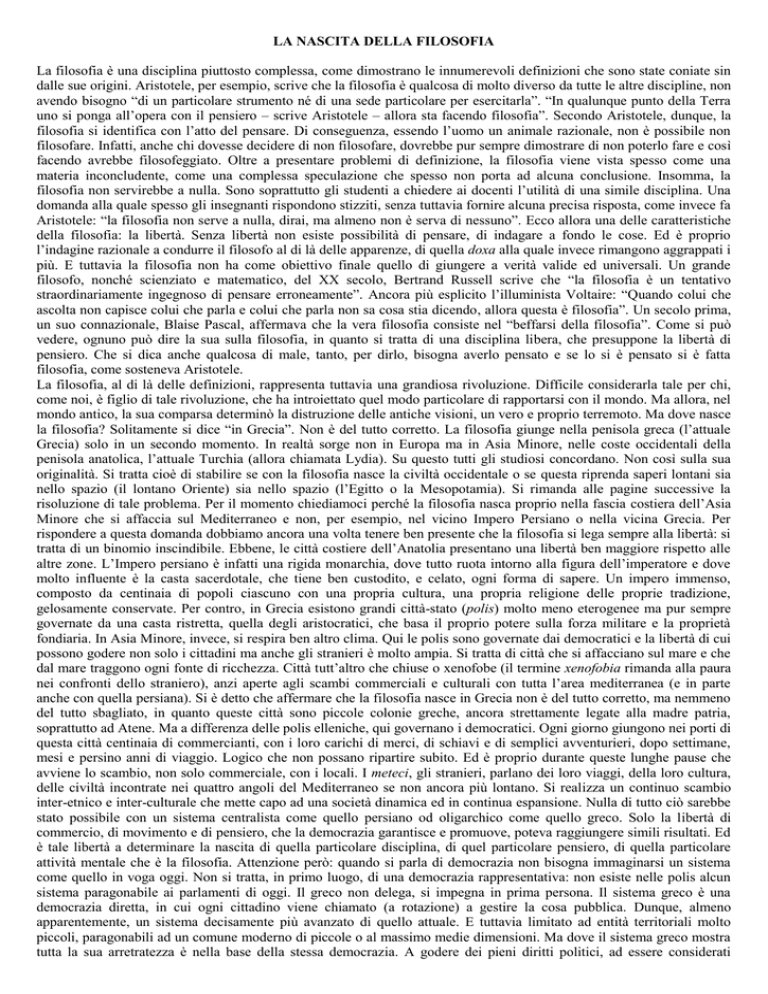
LA NASCITA DELLA FILOSOFIA
La filosofia è una disciplina piuttosto complessa, come dimostrano le innumerevoli definizioni che sono state coniate sin
dalle sue origini. Aristotele, per esempio, scrive che la filosofia è qualcosa di molto diverso da tutte le altre discipline, non
avendo bisogno “di un particolare strumento né di una sede particolare per esercitarla”. “In qualunque punto della Terra
uno si ponga all’opera con il pensiero – scrive Aristotele – allora sta facendo filosofia”. Secondo Aristotele, dunque, la
filosofia si identifica con l’atto del pensare. Di conseguenza, essendo l’uomo un animale razionale, non è possibile non
filosofare. Infatti, anche chi dovesse decidere di non filosofare, dovrebbe pur sempre dimostrare di non poterlo fare e così
facendo avrebbe filosofeggiato. Oltre a presentare problemi di definizione, la filosofia viene vista spesso come una
materia inconcludente, come una complessa speculazione che spesso non porta ad alcuna conclusione. Insomma, la
filosofia non servirebbe a nulla. Sono soprattutto gli studenti a chiedere ai docenti l’utilità di una simile disciplina. Una
domanda alla quale spesso gli insegnanti rispondono stizziti, senza tuttavia fornire alcuna precisa risposta, come invece fa
Aristotele: “la filosofia non serve a nulla, dirai, ma almeno non è serva di nessuno”. Ecco allora una delle caratteristiche
della filosofia: la libertà. Senza libertà non esiste possibilità di pensare, di indagare a fondo le cose. Ed è proprio
l’indagine razionale a condurre il filosofo al di là delle apparenze, di quella doxa alla quale invece rimangono aggrappati i
più. E tuttavia la filosofia non ha come obiettivo finale quello di giungere a verità valide ed universali. Un grande
filosofo, nonché scienziato e matematico, del XX secolo, Bertrand Russell scrive che “la filosofia è un tentativo
straordinariamente ingegnoso di pensare erroneamente”. Ancora più esplicito l’illuminista Voltaire: “Quando colui che
ascolta non capisce colui che parla e colui che parla non sa cosa stia dicendo, allora questa è filosofia”. Un secolo prima,
un suo connazionale, Blaise Pascal, affermava che la vera filosofia consiste nel “beffarsi della filosofia”. Come si può
vedere, ognuno può dire la sua sulla filosofia, in quanto si tratta di una disciplina libera, che presuppone la libertà di
pensiero. Che si dica anche qualcosa di male, tanto, per dirlo, bisogna averlo pensato e se lo si è pensato si è fatta
filosofia, come sosteneva Aristotele.
La filosofia, al di là delle definizioni, rappresenta tuttavia una grandiosa rivoluzione. Difficile considerarla tale per chi,
come noi, è figlio di tale rivoluzione, che ha introiettato quel modo particolare di rapportarsi con il mondo. Ma allora, nel
mondo antico, la sua comparsa determinò la distruzione delle antiche visioni, un vero e proprio terremoto. Ma dove nasce
la filosofia? Solitamente si dice “in Grecia”. Non è del tutto corretto. La filosofia giunge nella penisola greca (l’attuale
Grecia) solo in un secondo momento. In realtà sorge non in Europa ma in Asia Minore, nelle coste occidentali della
penisola anatolica, l’attuale Turchia (allora chiamata Lydia). Su questo tutti gli studiosi concordano. Non così sulla sua
originalità. Si tratta cioè di stabilire se con la filosofia nasce la civiltà occidentale o se questa riprenda saperi lontani sia
nello spazio (il lontano Oriente) sia nello spazio (l’Egitto o la Mesopotamia). Si rimanda alle pagine successive la
risoluzione di tale problema. Per il momento chiediamoci perché la filosofia nasca proprio nella fascia costiera dell’Asia
Minore che si affaccia sul Mediterraneo e non, per esempio, nel vicino Impero Persiano o nella vicina Grecia. Per
rispondere a questa domanda dobbiamo ancora una volta tenere ben presente che la filosofia si lega sempre alla libertà: si
tratta di un binomio inscindibile. Ebbene, le città costiere dell’Anatolia presentano una libertà ben maggiore rispetto alle
altre zone. L’Impero persiano è infatti una rigida monarchia, dove tutto ruota intorno alla figura dell’imperatore e dove
molto influente è la casta sacerdotale, che tiene ben custodito, e celato, ogni forma di sapere. Un impero immenso,
composto da centinaia di popoli ciascuno con una propria cultura, una propria religione delle proprie tradizione,
gelosamente conservate. Per contro, in Grecia esistono grandi città-stato (polis) molto meno eterogenee ma pur sempre
governate da una casta ristretta, quella degli aristocratici, che basa il proprio potere sulla forza militare e la proprietà
fondiaria. In Asia Minore, invece, si respira ben altro clima. Qui le polis sono governate dai democratici e la libertà di cui
possono godere non solo i cittadini ma anche gli stranieri è molto ampia. Si tratta di città che si affacciano sul mare e che
dal mare traggono ogni fonte di ricchezza. Città tutt’altro che chiuse o xenofobe (il termine xenofobia rimanda alla paura
nei confronti dello straniero), anzi aperte agli scambi commerciali e culturali con tutta l’area mediterranea (e in parte
anche con quella persiana). Si è detto che affermare che la filosofia nasce in Grecia non è del tutto corretto, ma nemmeno
del tutto sbagliato, in quanto queste città sono piccole colonie greche, ancora strettamente legate alla madre patria,
soprattutto ad Atene. Ma a differenza delle polis elleniche, qui governano i democratici. Ogni giorno giungono nei porti di
questa città centinaia di commercianti, con i loro carichi di merci, di schiavi e di semplici avventurieri, dopo settimane,
mesi e persino anni di viaggio. Logico che non possano ripartire subito. Ed è proprio durante queste lunghe pause che
avviene lo scambio, non solo commerciale, con i locali. I meteci, gli stranieri, parlano dei loro viaggi, della loro cultura,
delle civiltà incontrate nei quattro angoli del Mediterraneo se non ancora più lontano. Si realizza un continuo scambio
inter-etnico e inter-culturale che mette capo ad una società dinamica ed in continua espansione. Nulla di tutto ciò sarebbe
stato possibile con un sistema centralista come quello persiano od oligarchico come quello greco. Solo la libertà di
commercio, di movimento e di pensiero, che la democrazia garantisce e promuove, poteva raggiungere simili risultati. Ed
è tale libertà a determinare la nascita di quella particolare disciplina, di quel particolare pensiero, di quella particolare
attività mentale che è la filosofia. Attenzione però: quando si parla di democrazia non bisogna immaginarsi un sistema
come quello in voga oggi. Non si tratta, in primo luogo, di una democrazia rappresentativa: non esiste nelle polis alcun
sistema paragonabile ai parlamenti di oggi. Il greco non delega, si impegna in prima persona. Il sistema greco è una
democrazia diretta, in cui ogni cittadino viene chiamato (a rotazione) a gestire la cosa pubblica. Dunque, almeno
apparentemente, un sistema decisamente più avanzato di quello attuale. E tuttavia limitato ad entità territoriali molto
piccoli, paragonabili ad un comune moderno di piccole o al massimo medie dimensioni. Ma dove il sistema greco mostra
tutta la sua arretratezza è nella base della stessa democrazia. A godere dei pieni diritti politici, ad essere considerati
cittadini a tutti gli effetti, infatti, è solo una minoranza, composta da quei maschi che possono dimostrare di essere greci
da due o tre generazioni. Nel complesso non più del 25-30% della popolazione. Sono esclusi gli stranieri e le donne
(anche greche), che godono della libertà ma non dei diritti politici. Esclusi sia dalla libertà che dai diritti politici, invece,
gli schiavi, che rappresentano la fetta più ampia di popolazione. Ma non bisogna mai commettere l’errore di paragonare
due epoche troppo differenti. Per il mondo antico, tali percentuali di cittadinanza e tale libertà non hanno eguali. Le polis
dell’Asia Minore cominceranno a decadere allorquando la pressione del potente vicino, l’Impero Pressiano, si farà
asfissiante. I commerci cominceranno a restringersi e lo stato di emergenza determinerà una graduale riduzione delle
libertà personali. Per non soccombere, le polis anatoliche chiederanno aiuto alla madre patria. Ma solamente Atene si
impegnerà a fondo per la loro difesa. E sarà proprio la vittoria sull’Impero persiano a decretarne il primato nel mondo
antico. E lì la filosofia troverà nuova linfa.
LA SCUOLA DI MILETO
Mileto è la città natale della filosofia. Si tratta della polis più importante della Lydia nonché della più avanzata, della più
ricca, della più democratica. Ma parlare di una vera e propria Scuola filosofica nel suo territorio è improprio. Non
dobbiamo immaginarci, infatti, la presenza di un grande edificio, con centinaia di studenti che entrano ed escono, con un
corpo docente più o meno stabile, con programmi e orari ben definiti e diplomi alla fine dei corsi. Nulla di tutto questo.
Quella che viene definita “Scuola di Mileto” è in realtà un gruppo di giovani studiosi al seguito di un maestro che
passeggia per le vie di Mileto tenendo le proprie lezioni. Una scuola itinerante, insomma, che di sovente coinvolge nelle
lezioni anche la cittadinanza. Ma è davvero così originale quanto sta accadendo a Mileto? La filosofia è davvero qualcosa
di mai visto prima o altrove? Sono domande sulle quali ancora oggi si discute. D’altro canto, in gioco c’è l’originalità
della filosofia e con essa quella di tutta la civiltà occidentale. Difficile sostenere che a Mileto non si sia a conoscenza di
quanto avvenga o sia avvenuto nel resto del mondo appena conosciuto. I contatti con le altre zone del Mediterraneo e
anche dell’Asia sono continui. D’altro canto, le biografie di tutti i primi filosofi di Mileto mostrano questi studiosi
impegnati in lunghissimi viaggi intorno al mondo allora conosciuto. E tuttavia la filosofia e i filosofi rappresentano
qualcosa di nuovo nel panorama culturale dell’epoca. Gli scienziati e i sapienti egiziani, mesopotamici o anche cinesi
sono altra cosa rispetto ai filosofi: sono degli specialisti, che studiano ognuno una parte dell’universo e solitamente
appartengono ad una casta chiusa, al servizio di questo o quel potere costituito. Le loro ricerche, le loro scoperte, sono
gelosamente custodite e riservate agli iniziati o ai potenti. Il loro pensiero non è frutto della libera discussione, della
diatriba, della piazza, dell’agorà greca, ma spesso proviene dalla tradizione oralmente tramandata o da antichi manoscritti
segretamente custoditi. Un sapere iniziatico, dunque, che spesso si confonde con quello religioso. La filosofia al contrario
– come si è visto – si nutre del libero confronto delle posizioni, della pubblicità delle scoperte, dell’apertura nei confronti
del mondo, di cui è figlia. E i filosofi, lungi dall’essere organici al potere, si presentano spesso come veri e propri
anticonformisti se non veri e propri rivoluzionari, come rivoluzionaria è la filosofia. La filosofia imprime alla storia una
accelerazione sconosciuta altrove, un calendario denso di eventi e di rivolgimenti anche drammatici che non si riscontra
nel lontano Oriente. Lo stesso senso della storia come progresso è un prodotto della filosofia occidentale. E se in
Occidente tutto è storia, anche la filosofia si adegua al mutare dei tempi, a differenza dell’antica sapienza egiziana o di
quella cinese, presentandosi ogni volta con idee e proposte del tutto nuove e cercando il confronto con la realtà. La
filosofia non ha la pretesa di guidare la storia, ma di fornirgli un senso. Questa la rivoluzione che scoppia a Mileto intorno
al VII secolo dell’era volgare (vale a dire “avanti Cristo”) e che non si è ancora del tutto conclusa.
TALETE
Talete viene universalmente riconosciuto come il primo filosofo della storia. E tuttavia della sua vita si sa ben poco. La
sua biografia (frutto di una babele di fonti non sempre attendibili) è densa di aneddoti curiosi. Quello che sappiamo con
certezza è che nasce a Mileto intorno alla metà del VII secolo da genitori Fenici. Sin da giovanissimo, Talete si mostra
uno spirito libero, pronto all’avventura pur di soddisfare la sua sete di conoscenza. E così si imbarca alla volta dell’Egitto,
dove frequenta gli ambienti intellettuali, studiando soprattutto ingegneria, matematica, astronomia, tecniche di
navigazione e geografia. Pur essendo affascinato da quanto la civiltà egizia è riuscita realizzare, rifiuta ogni genere di
spiegazione mitologica o religiosa. Un atteggiamento sconosciuto ai sapienti egiziani. Tornato a Mileto con un enorme
bagaglio di esperienze, non riesce tuttavia a vincere la diffidenza e l’ilarità dei suoi concittadini, i quali non si capacitano
di come un uomo così intelligente non metta a frutto tutta la sua cultura. Con Talete si afferma nella pubblica opinione
(non solo di allora) l’idea che il filosofo sia un perdigiorno sempre con la testa tra le nuvole. Ed è proprio a causa di
questo peculiare atteggiamento che – narrano le fonti – un giorno Talete cade in un pozzo, tra le risate di una giovane
servetta. Talete sbeffeggiato da una servetta? Possibile? Egli è sicuramente un partigiano della democrazia e della
tolleranza, ma farsi prendere in giro da una sconosciuta servetta non è credibile. Senza volere dare torto a Platone e
Aristotele, che riportano l’episodio, è possibile tuttavia fornire un’altra spiegazione. Talete aveva sicuramente la testa tra
le nuvole, ma nel senso che le scrutava, perché si interessava di fenomeni meteorologici. Di notte, invece, scrutava le
stelle, per studiarne i movimenti. E quale migliore strumento di un pozzo, con la sua circonferenza come punto di
riferimento per stabilire come si muovono le nuvole o gli astri? E infatti, di lì a pochi anni, nel 585, Talete sarà in grado di
prevedere una eclissi di sole, come prima era stato in grado di prevedere un radicale mutamento nel clima. Eventi fino ad
allora terrificanti per il mondo antico. Prendiamo l’eclissi: vedere improvvisamente il sole oscurarsi gettava nel panico le
persone, che correvano a rintanarsi nella casi pregando gli dei o sacrificandogli qualche animale, se non anche qualche
essere umano. In questi casi ci si stringeva attorno al sacerdote, il medium tra i mortali e gli dei, il solo in grado di placare
l’ira divina. Tutto ciò scompare con Talete, con la sua pre-visione, la sua capacità di vedere prima i fenomeni, di
anticiparli e dunque di annullare in u solo colpo l’ansia, la paura e il dolore nonché il potere della casta sacerdotale.
L’altra previsione, quella di un radicale mutamente atmosferico, è invece frutto di una scommessa. Talete, stando delle
quotidiani critiche per l’inutilità del suo lavoro (a che cosa serve la filosofia?) decide di rispondere con i fatti. Decide di
acquistare tutti i frantoi della zona ad un prezzo bassissimo, dato che la stagione era stata pessima sino ad allora, tra lo
stupore e gli sfottò dei suoi concittadini. Poi però il clima cambia (come Talete aveva previsto attraverso le sue accurate
osservazioni) e si rivela ottimo per la produzione delle olive e così Talete rivende i frantoi ad un prezzo esagerato. Ma i
soldi non li tiene per sé: li regala alla città! Ecco una delle caratteristiche della filosofia, che non si riscontra in altre
culture precedenti o contemporanee: andare contro la doxa, contro il senso comune e nel contempo essere al servizio
dell’umanità. Lo storico Erodoto scrive che un giorno Talete decide di partecipare a suo modo alla guerra contro la Persia,
deviando il corso di un fiume per renderlo guadabile in entrambi i rami per le truppe lidie. Altro che uomo con la testa tra
le nuvole! Grazie a Talete i greci resistono ai persiani, decisamente più forti.
Grazie a queste imprese, Talete cessa di suscitare ilarità tra i suoi concittadini e la sua fama varca rapidamente i confini
della Lydia. E sono proprio i suoi concittadini a finanziargli gli studi e i numerosi viaggi che intraprende nel resto del
mondo. Talete, ormai intellettuale famoso ovunque, sbarca nuovamente in Egitto, recandosi presso quelle piramidi che
tanto lo avevano impressionato decenni prima. Qui riesce a misurarne l’altezza con incredibile precisione, calcolando la
proporzione tra le loro ombre e quelli di oggetti noti. Quindi scopre l’Orsa Maggiore, fondamentale per orientarsi nelle
notti buie. Infine la matematica, la sua grande passione. Ancora oggi si studiano i suoi cinque fondamentali teoremi: 1. Il
cerchio è diviso in due aree eguali da qualunque diametro; 2. Gli angoli alla base di un triangolo isoscele sono uguali; 3.
In due rette che si taglino tra loro, gli angoli opposti al vertice sono uguali; 4. Due triangoli sono uguali se hanno un lato e
i due lati adiacenti uguali; 5. Un triangolo inscritto in una semicirconferenza è rettangolo.
Chissà quante altre scoperte sono andate perdute, anche perché di Talete non ci è giunto nulla di scritto (difficile che non
abbia scritto nulla). Ma di questo straordinario personaggio si è soliti ricordare, ancora oggi, solamente la nota teoria
dell’acqua. Spariscono come d’incanto le scoperte astronomiche, gli studi matematici (quanto meno in filosofia, come se
il Talete dei teoremi e quello dell’acqua fossero due persone diverse), le tecniche di navigazione, le sfide aperte al sendo
comune eccetera e rimane quella scoperta del principio di tutte le cose che si identifica nell’acqua. Un po’ poco – e forse
anche un po’ banale – per un personaggio del calibro di Talete. Ma più che la risposta forse è meglio sottolineare la
domanda che ha messo in moto tale processo cognitivo: che cosa c’è dietro quello che vediamo? Cosa al di là della doxa?
La realtà mostra una pluralità di esseri. Ma da dove provengono? Ci deve essere un principio da cui tutto ha avuto inizio.
Memore dei suoi viaggi in Egitto, Talete comprende che l’acqua è il fondamento della vita. Lì, nel lontano Egitto, la
civiltà è stata possibile proprio grazie alla presenza di un grande fiume come il Nilo e la stessa cosa è successa in
Mesopotamia con il Tigri e l’Eufrate. E quale è il segreto della ricchezza di Mileto? Sempre l’acqua, sebbene quella salata
del mare. E di cosa è fatto l’uomo se non soprattutto di acqua? In estrema sintesi e cominciando ad utilizzare un lessico
più specifico: Talete ritiene che al di là della molteplicità degli enti (cioè degli esseri presenti nel mondo) esista un unico
principio (in greco arché, termine che verrà coniato da un discepolo di Talete: Anassimandro) dal quale derivano e tale
principio è l’acqua. Ma c’è dell’altro. Da una fonte sappiamo infatti che Talete sostiene che “ogni cosa è piena di dei”.
Non si tratta di una affermazione di stampo teologico: la teologia non esiste nella Grecia antica e tutta la prima fase della
storia della filosofia ha ben poco di religioso, anzi la filosofia nasce contrapponendosi a miti e religioni tradizionali.
Talete ritiene che le cose, tutte le cose, abbiano un’anima, sebbene anche in questo caso occorre fare molta attenzione ai
termini che si usano. Una delle difficoltà nel rendere ragione alla filosofia antica è che la si traduce con un linguaggio
completamente diverso da quello originale. Non si tratta semplicemente di passare dal greco al latino, ma di quel
particolare linguaggio che gli antichi greci utilizzavano e che già ai tempi di Socrate e Platone va scomparendo. Insomma,
ogni linguaggio porta con sé non solamente un universo di significati ma anche di visioni e di interpretazioni intorno alla
natura. Si prenda ad esempio il termine greco aletheia: solitamente lo si traduce con quello, di derivazione latina, “verità”.
Ora, a partire da Aristotele, sappiamo che la verità obbedisce al principio di identità e di non contraddizione, per cui se
“a” è uguale a se stessa non potrà nel contempo essere anche “b”. Ma cosa accadeva prima? I greci antichi (pre-aristotelici
o più in generale pre-socratici, perché è con Socrate che la filosofia intraprende una strada nuova) intendevano con il
termine aletheia qualcosa che nel momento stesso in cui si mostra tende a celarsi: un “nascondimento/svelamento” che
dunque contraddice la regola aristotelica e lo stesso nostro modo di intendere la verità. La cosiddetta verità è per i greci
antichi qualcosa che si può cogliere, ma mai catturare definitivamente. È come trovarsi davanti ad un fiume: non
potremmo mai impossessarcene del tutto, ma solamente bagnarci la mano. Avremmo modo di tornare su questo problema
affrontando di volta in volta i filosofi pre-socratici. Ritornando a Talete, quando egli afferma che le cose possiedono
qualcosa di non materiale, un’anima, si è detto in precedenza, non significa certo credere che tutte le cose abbiano una
sostanza immateriale, invisibile e immortale (le qualità che l’Occidente cristiano ritiene siano proprie dell’anima).
Piuttosto, da buon scienziato, pensa a forze oscure, cioè non visibili ad occhio nudo, che sfuggono ai sensi. Talete pensa a
quella particolare forza emessa da un minerale come la calamita, capace di attirare, per esempio, il ferro. E se si riuscisse
a catturare quella forza, si potrebbero mettere in movimento oggetti ben più pesanti. Questo è l’approccio, squisitamente
scientifico, di Talete. Del potere della calamita si occuperà secoli dopo, nel XIX secolo, un altro filosofo Schelling,
spalancando le porte all’elettromagnetismo.
Tutta la vita di Talete è costellata di episodi quanto meno curiosi. Idem per la morte. Stando a Diogene Laerzio (e ad altre
fonti), Talete muore improvvisamente in uno stadio mentre assiste a delle gare di atletica. Nessuno per ore fa caso a lui.
D’altro canto Talete era solito schiacciare un pisolino in simili competizioni. Quando però le gare sono finite appare
chiaro a tutti che il più grande filosofo di Talete ha lasciato questo mondo. Tra i tanti insegnamenti, questo è forse il più
significativo: “gli dei hanno fornito gli uomini di due orecchie ed una bocca: per potere ascoltare il doppio e parlare la
metà”.
ANASSIMANDRO
Anassimandro nasce a Mileto nel 610 a.C.. Più giovane di Talete di quasi vent'anni, ne diventa ben presto un discepolo
entusiasta. Anche con Anassimandro emerge molto chiaramente lo stretto rapporto che intercorre tra la filosofia e la città
di Mileto. Lo vediamo infatti redigere da giovanissimo una dettagliata carta geografica del Mediterraneo orientale che va
letteralmente a ruba tra gli operai del porto, come anche prendere parte alla contesa politica, come già il suo maestro,
dalla parte dei democratici. Anche su di lui si addensano una miriade di aneddoti non sempre credibili. Secondo Cicerone,
Anassimandro sarebbe stato in grado di predire addirittura un terremoto, cosa impossibile anche oggi. E tuttavia, se è
presente un vulcano in attività, non è da scartare una simile ipotesi. Altre fonti lo indicano come l’inventore del moderno
orologio e di altri oggetti decisamente troppo avanzati per l’epoca. La verità è che di Anassimandro sappiamo meno che
di Talete. È certo che ha viaggiato pochissimo, forse più del maestro, ma non sappiamo con precisione dove (anche se è
probabile che una delle mete fosse l’Egitto, tappa obbligata per tutti i filosofi del tempo). E, come Talete, è rimasto
vittima di un curioso incidente: mentre era intento a cantare, un gruppo di ragazzini impertinenti lo interrompe
prendendolo in giro. Che senso dare a questo episodio? Nessuno: è probabile che Anassimandro fosse davvero stonato. Si
sa, poi, che Anassimandro scrisse moltissimo, ma pochissimo è giunto fino a noi, solamente un pugno di frammenti, di
brevi affermazioni, di aforismi come quello che segue, sul cui significato ancora oggi si interrogano gli studiosi:
principio degli esseri è l’indeterminato ... da dove infatti gli esseri hanno l’origine, ivi hanno anche la distruzione
secondo necessità: poiché essi debbono pagare la pena e l’espiazione dell’ingiustizia secondo l’ordine del tempo.
La maniera giusta per interpretare un brano è sempre quella di andare a piccoli passi. Cominciamo con la prima
affermazione: “principio degli esseri è l’indeterminato”. Come il maestro, anche Anassimandro è alla ricerca di qualcosa
che vada al di là della doxa e della stessa molteplicità degli enti, qualcosa da cui tutto derivi, il principio primo, che in
greco si dice arché (e pare che sia stato lui a conniarlo) e lo riscontra nell’indeterminato, che in greco si chiama àpeiron.
Dunque non siamo di fronte a qualcosa di concreto, come l’acqua di Talete, ma ad un concetto filosofico ovvero ad un
principio fisico del tutto ipotetico. La seconda affermazione chiarisce ulteriormente i termini della questione: tutto deriva
dall’àpeiron e tutti vi deve fare ritorno. Si tratta di conseguenza di una visione ciclica del cosmo che ha l’inizio e la fine in
un medesimo punto: l’àpeiron. Ma i problemi sorgono dopo i due punti: “poiché essi [vale a dire gli esseri, nda] debbono
pagare la pena e l’espiazione dell’ingiustizia secondo l’ordine del tempo”. Che cosa significa? Perché gli esseri debbono
pagare una pena, espiare una colpa secondo un ordine temporale?
Per rispondere a questa domanda è bene tornare all’àpeiron, chiarendone la natura. L’àpeiron non è soltanto una sostanza
illimitata ma anche indefinita (a conferma di come il greco sia una lingua ben più complicata di quelle neolatine). Ora, se
tutti gli esseri derivano da tale sostanza, significa che un tempo, prima di nascere, erano, per così dire, fusi in quell’unica
sostanza. L’àpeiron, dunque, si configura come una “sostanza primordiale” che ha in potenza tutte le vite future. Un unico
essere, in pace con se stesso, che coincide con il tutto. Tanto per abituarsi ad una terminologia filosofica, un nulla che
coincide con il tutto. Ma questa unità, questa pace cosmica impedisce la vita degli esseri che pure contiene. Occorre
dunque che tali esseri si liberino dalla morsa dell’àpeiron, che dunque commettano una “ingiustizia” nei suoi confronti,
ancor più se si pensa che ogni essere è, in quanto tale, opposto all’altro, poiché se fosse coincidente non avrebbe vita
propria. Siamo dunque di fronte ad una cosmica lotta tra contrari (caldo/freddo, luce/tenebre, maschi/femmine). La nostra
vita e quella di tutti gli altri esseri (dalla più grande delle galassie alla più piccola delle cellule) è un vero e proprio atto di
ribellione nei confronti della sostanza primordiale. Ecco perché è “necessario” che si faccia ritorno ad essa, per poi dare
vita ad una nuova ribellione e così via. Ma questo processo avviene secondo l’ordine del tempo. Dunque è Cronos a
coordinare il tutto. Lui a decidere le tappe di questa ciclicità temporale. Per gli antichi greci, il tempo è qualcosa che
preesiste a tutto, dei e uomini compresi. Il tempo c’era, c’è e ci sarà sempre.
La visione ciclica di Anassimandro si sposa perfettamente con quella greca del suo tempo (che verrà gradualmente
smontata a partire da Socrate, Platone e Aristotele, per poi venire completamente stravolta dal Cristianesimo). L’uomo
greco, infatti, vive in perfetta simbiosi con la physis, la natura, la quale si presenta ai suoi occhi in maniera ciclica: con
l’alternarsi sempre uguale delle stagioni, con i movimenti, sempre uguali, degli astri, con le maree e via dicendo. La
visione di Anassimandro è davvero rivoluzionaria, al punto da essere ripresa nel XX secolo, con la teoria del Big Bang,
secondo la quale l’universo è nato da una “nebulosa” in cui erano contenuti tutti gli elementi vitali, liberati da una
mastodontica esplosione. Un atto di ribellione grazie al quale oggi possiamo dire di essere vivi.
Come si è visto in precedenza con Talete, la filosofia tende sin dai suoi esordi ad andare contro il pensiero comune, contro
la doxa. Con Anassimandro si raggiunge l’apice. L’àpeiron non solo non è una sostanza concreta come l’acqua di Talete,
ma nemmeno una forza oscura che i nostri sensi riescono a cogliere, come quella della calamita. Il piano della riflessione
si sposta di conseguenza dai sensi alla pura razionalità, alla logica. D’altro canto, è proprio sul piano astratto logicomatematico che avvengono le rivoluzioni scientifiche. Se dovessimo dare retta solamente ai nostri sensi continueremmo a
credere che sia il Sole a girare intorno alla Terra e non viceversa! Questo il grande insegnamento di Anassimandro.
Anassimandro però non si occupa solo dell’arché ma anche degli esseri concreti. In modo particolare di quel particolare
essere che è l’uomo. Egli è infatti convinto che l’uomo non abbia sempre avuto il medesimo aspetto, poiché la Terra non è
sempre stata la medesima. Come già con la teoria dell’àpeirone, Anassimandro anticipa teorie recenti, come quella
dell’evoluzione dell’uomo e del pianeta in cui vive. Il filosofo di Mileto immagina che la Terra agli inizi non fosse un
luogo ospitale per qualsiasi essere pretendesse di vivere: tutta terra e fuoco. Fortunatamente poi iniziarono a formarsi gli
oceani. Ed è proprio nell’acqua (retaggio della filosofia di Talete) che Anassimandro ritiene si sia formata la vita, al riparo
dall’atmosfera nociva della terraferma. Man mano che – ancora una volta grazie all’acqua – le condizioni atmosferiche
migliorarono (grazie alle piogge) questi esseri primordiali cominciano ad affacciarsi sulle coste, ma non riescono a
colonizzarle, in quanto privi di zampe. E tuttavia la legge della natura, che consiste nell’adattamento alle mutate
condizioni ambientali, consente gradualmente di sviluppare prima piccole zampe e poi sistemi corporali sempre più
complessi. Dunque, tutti gli esseri derivano da cellule primordiali che vivevano in acqua, poi divenuti pesci, quindi anfibi
e infine mammiferi. Tra questi ultimi, il più sviluppato è proprio l’uomo.
Spostiamo lo sguardo un po’ più in alto, verso quel cosmo che fin dall’inizio rappresenta il luogo privilegiato degli studi
filosofici. Secondo Anassimandro le stelle non sono altro che involucri d’aria a forma di fuoco, pieni di fuoco, dalle cui
aperture fuoriescono le fiamme. L’immagine è molto suggestiva. Uno scrittore di successo come Luciano De Crescenzo
paragona la visione di Anassimandro a quel particolare gioco di luci proprio dei presepi napoletani: se si fanno dei piccoli
buchi in un cartone di colore blu scuro dietro il quale vi sono delle lampadine, si rende molto realistica la volta celeste.
Per quanto concerne il Sole, Anassimandro afferma che esso è “una sfera ventotto volte maggiore della terra, molto simile
ad una ruota del carro, che in una parte, attraverso una apertura, mostra il fuoco, come attraverso la canna di un flauto”.
Curiosa – e ben poco scientifica, ma assai poetica – la spiegazione delle eclissi: quando quell’apertura si chiude ecco
allora che il sole si oscura. Sulle dimensioni della Luna, invece, Anassimandro si sbaglia di grosso, descrivendola come
“diciannove volte la Terra”, ma sempre simile alla ruota di un carro e il cui meccanismo è alla base delle eclissi.
Spiegazioni lontane dalla realtà, ma, oltre che affascinanti, lontane da miti e tradizioni religiose. Attento osservatore del
cielo, Anassimandro tenta di spiegare anche i fenomeni del lampo e del tuono: “fenomeni prodotti dal vento che, quando
chiuso in una spessa nuvola riesce, a causa della sottile leggerezza delle sue parti, a fuoriuscire con violenza, rompendo la
nuvola e producendo il fragore del tuono, mentre la dilatazione della massa nera produce il chiarore del lampo”.
ANASSIMENE
Anassimene è il terzo grande filosofo della Scuola di Mileto. Nasce intorno al 587 a.C., quando ormai la stella di Mileto è
al tramonto. La città è ormai assediata dal potente vicino persiano e lo stato di emergenza non si addice agli studi e alle
speculazioni filosofiche. Gli spazi di libertà si restringono, i cittadini sono chiamati alle armi per difendere la patria in
pericolo, gli stranieri (e non solo loro) scappano. D’ora in poi non sentiremo parlare più della Scuola di Mileto. La
filosofia si è trasferita nelle isole dell’Egeo e, soprattutto, in Italia Meridionale: la Magna Grecia.
Il pensiero di Anassimene si colloca a metà strada tra Talete ed Anassimandro. Egli infatti individua l’arché nell’aria, o
sarebbe meglio dire nel pneuma, che in greco significa “soffio”. Tutto l’universo risponde alle leggi meccaniche del
pneuma, il quale rarefacendosi si trasforma in fuoco e condensandosi in acqua e quindi pietra. Tra questi estremi si
collocano tutti gli esseri, dunque anche l’uomo. Siamo tutti “soffi” di un gigantesco organismo che respira. Una visione
affascinante, che verrà ripresa dal romanticismo del XIX secolo. Anche Anassimene è un attento osservatore del cielo.
Egli ritiene che la Terra sia di forma cilindrica, molto schiacciata, simile ad una enorme torta, posta al centro
dell’universo e sostenuta dal pneuma stesso. Anche Anassimene sposa la visione ciclica del cosmo di Anassimandro,
sostenendo che esiste un principio (probabilmente lo stesso pneuma) dal quale le cose hanno origine e al quale dovrano
fare ritorno.