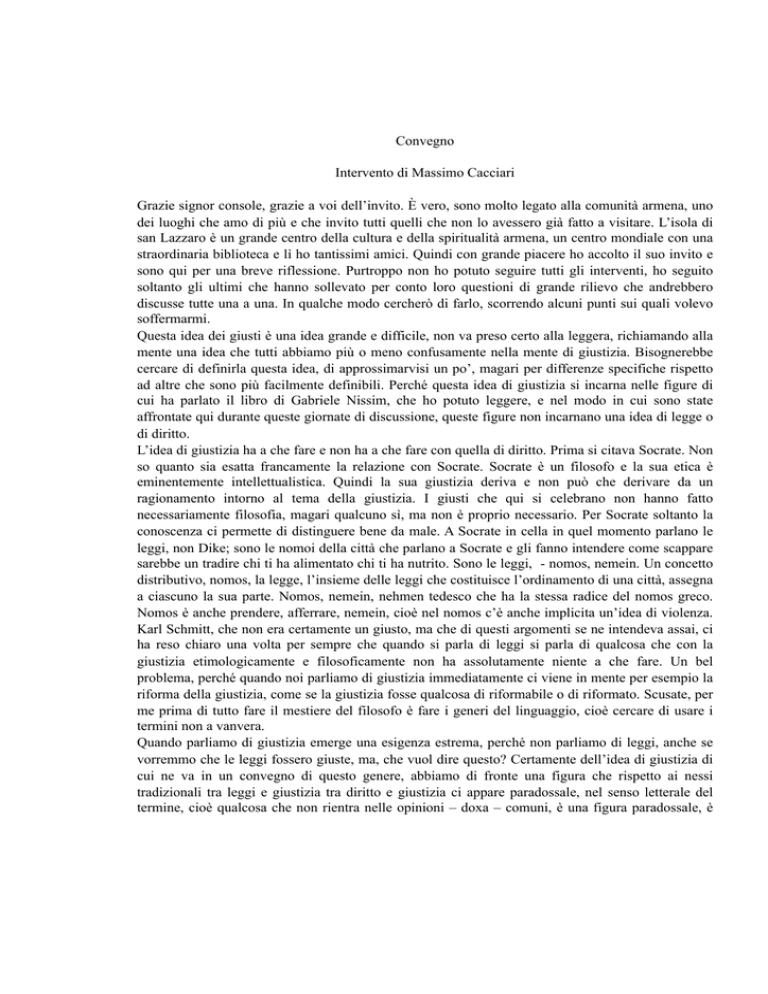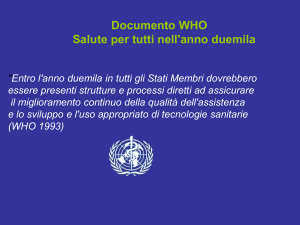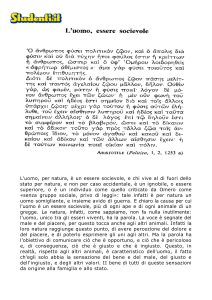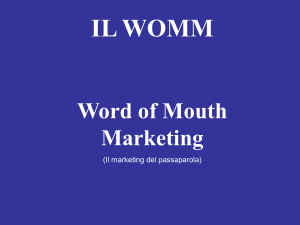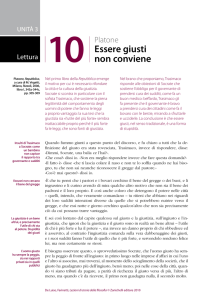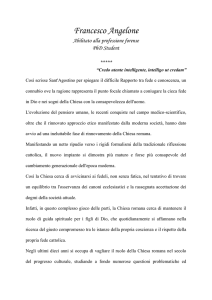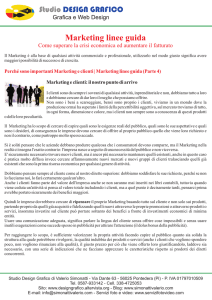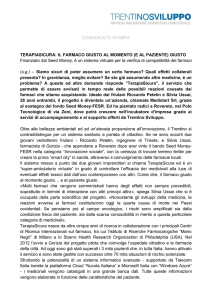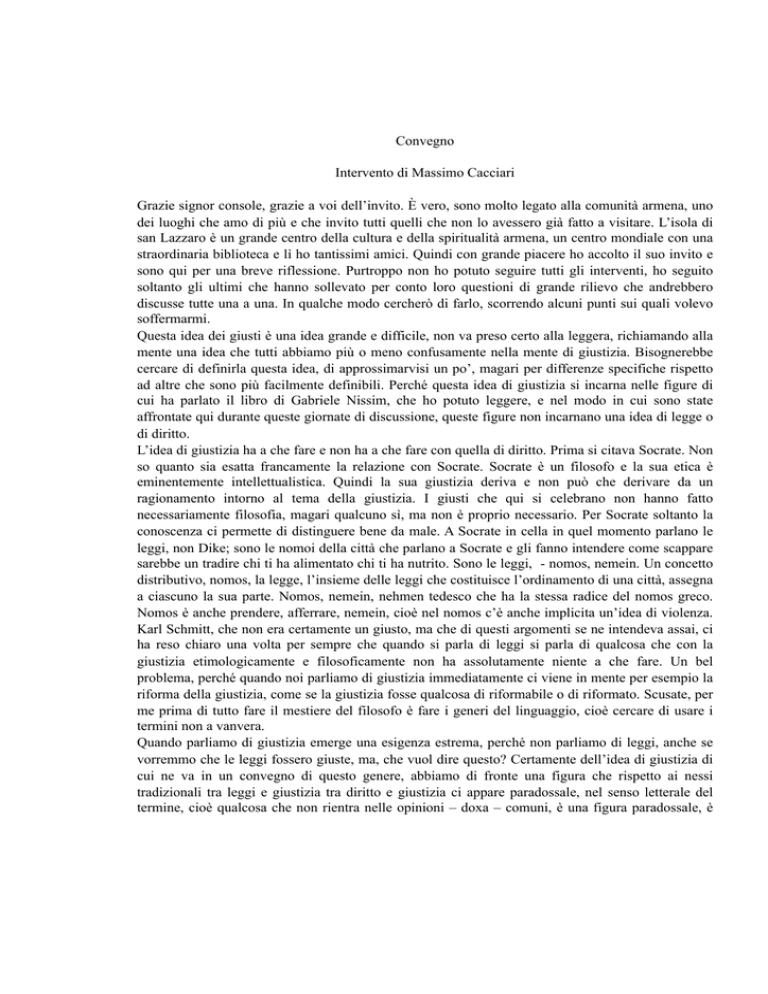
Convegno
Intervento di Massimo Cacciari
Grazie signor console, grazie a voi dell’invito. È vero, sono molto legato alla comunità armena, uno
dei luoghi che amo di più e che invito tutti quelli che non lo avessero già fatto a visitare. L’isola di
san Lazzaro è un grande centro della cultura e della spiritualità armena, un centro mondiale con una
straordinaria biblioteca e lì ho tantissimi amici. Quindi con grande piacere ho accolto il suo invito e
sono qui per una breve riflessione. Purtroppo non ho potuto seguire tutti gli interventi, ho seguito
soltanto gli ultimi che hanno sollevato per conto loro questioni di grande rilievo che andrebbero
discusse tutte una a una. In qualche modo cercherò di farlo, scorrendo alcuni punti sui quali volevo
soffermarmi.
Questa idea dei giusti è una idea grande e difficile, non va preso certo alla leggera, richiamando alla
mente una idea che tutti abbiamo più o meno confusamente nella mente di giustizia. Bisognerebbe
cercare di definirla questa idea, di approssimarvisi un po’, magari per differenze specifiche rispetto
ad altre che sono più facilmente definibili. Perché questa idea di giustizia si incarna nelle figure di
cui ha parlato il libro di Gabriele Nissim, che ho potuto leggere, e nel modo in cui sono state
affrontate qui durante queste giornate di discussione, queste figure non incarnano una idea di legge o
di diritto.
L’idea di giustizia ha a che fare e non ha a che fare con quella di diritto. Prima si citava Socrate. Non
so quanto sia esatta francamente la relazione con Socrate. Socrate è un filosofo e la sua etica è
eminentemente intellettualistica. Quindi la sua giustizia deriva e non può che derivare da un
ragionamento intorno al tema della giustizia. I giusti che qui si celebrano non hanno fatto
necessariamente filosofia, magari qualcuno sì, ma non è proprio necessario. Per Socrate soltanto la
conoscenza ci permette di distinguere bene da male. A Socrate in cella in quel momento parlano le
leggi, non Dike; sono le nomoi della città che parlano a Socrate e gli fanno intendere come scappare
sarebbe un tradire chi ti ha alimentato chi ti ha nutrito. Sono le leggi, - nomos, nemein. Un concetto
distributivo, nomos, la legge, l’insieme delle leggi che costituisce l’ordinamento di una città, assegna
a ciascuno la sua parte. Nomos, nemein, nehmen tedesco che ha la stessa radice del nomos greco.
Nomos è anche prendere, afferrare, nemein, cioè nel nomos c’è anche implicita un’idea di violenza.
Karl Schmitt, che non era certamente un giusto, ma che di questi argomenti se ne intendeva assai, ci
ha reso chiaro una volta per sempre che quando si parla di leggi si parla di qualcosa che con la
giustizia etimologicamente e filosoficamente non ha assolutamente niente a che fare. Un bel
problema, perché quando noi parliamo di giustizia immediatamente ci viene in mente per esempio la
riforma della giustizia, come se la giustizia fosse qualcosa di riformabile o di riformato. Scusate, per
me prima di tutto fare il mestiere del filosofo è fare i generi del linguaggio, cioè cercare di usare i
termini non a vanvera.
Quando parliamo di giustizia emerge una esigenza estrema, perché non parliamo di leggi, anche se
vorremmo che le leggi fossero giuste, ma, che vuol dire questo? Certamente dell’idea di giustizia di
cui ne va in un convegno di questo genere, abbiamo di fronte una figura che rispetto ai nessi
tradizionali tra leggi e giustizia tra diritto e giustizia ci appare paradossale, nel senso letterale del
termine, cioè qualcosa che non rientra nelle opinioni – doxa – comuni, è una figura paradossale, è
una figura stra-ordinaria, non ordinaria. Se la riduciamo, se la derubrichiamo a una figura quale:
Socrate rispetta le leggi ecc., il paradosso finisce. Siamo in molti, credo, a rispettare le leggi, ma
quanti di noi sarebbero stati giusti? Chiediamocelo. Giustizia ha questo valore paradossale, i grandi
giuristi ci dicono di lasciar perdere il diritto quando si parla di giustizia, col diritto la giustizia non
c’entra niente. Non solo parlando del diritto positivo, ma proprio concettualmente si tratta di ambiti
non necessariamente separati, ma certo che vanno tenuti rigorosamente distinti soprattutto quando tu
applichi l’idea di giustizia al giusto di cui ne avrà cura, perché allora si esalta questa dimensione di
paradossalità, si esalta questa dimensione di straordinarietà.
Allora prima distinzione da operarsi per avvicinarsi a questa figura reale che è il giusto e che è antica
in tutte queste tradizioni perché proprio idee e termini diversi li abbiamo in tutte le tradizioni fin
dall’antichità, il giusto è una figura veterotestamentaria, come giusto, secondo questo timbro, può
essere anche indicato Gesù, giusto è anche un concetto che ricorre nella tradizione mistica islamica,
ma sempre indica qualcosa che eccede la dimensione del diritto e della legge, senza necessariamente
contraddirla, ma pronti in ogni istante a contraddirla. È qualcosa di assimilabile al diritto naturale?
Cioè, assegniamo al nomos la dimensione della legge scritta ecc., per cui giusta è quella figura che
segue una giustizia non riducibile alla legge scritta? Grandi figure nella tradizione, ma neanche in
questo caso io ritroverei davvero in questo senso caratterizzata la figura del giusto di cui ne va nella
discussione che stiamo facendo, perché, che cosa ha di “naturale” questo giusto? Si appella a un
diritto naturale? Vi pare che le figure dei giusti di cui stiamo parlando siano incarnazione di un diritto
naturale? Nella nostra tradizione il diritto naturale è quello che dipende – qui sì davvero socratismo,
platonismo ecc. – da un ragionamento su ciò che è la nostra natura, e quindi un diritto che rispecchia
dei principi inviolabili riguardanti la nostra natura e quindi è qualcosa che non è assolutamente
declinabile in termini teoretico-filosofici, si appella a diritti che io ritengo propri, ragionando, della
mia natura che sono essenziali di questo ente che è l’uomo. Qui invece siamo in una situazione
completamente diversa, io ritengo, non di naturalità, ma se mai di soprannaturalità; cosa ha di
naturale il comportamento del giusto di cui stiamo parlando? Proprio niente. La sua testimonianza
non è la testimonianza di qualcosa che ci caratterizza in quanto uomini, siamo forse caratterizzati in
quanto uomini dal comportarsi come fa il giusto? Quindi ci troviamo in una situazione di autentica
paradossalità.
Come possiamo identificarla questa dimensione? Vedete, questo concetto non ha più nulla a che fare
neanche con la giustizia di cui ne va. Il termine giustizia è molto in voga nella filosofia politica, la
scienza politica a partire dai testi di Rawls, dove di parla di justice ecc., ma che cosa si intende? Si
intende, tutto sommato, sulla scia della filosofia pratica aristotelica, si intende temperanza, si intende
la capacità di temperare i diversi interessi e di trovare un equilibrio, proprio il concetto di mesòtes
aristotelico variamente trasformato, questa è l’idea di giustizia di cui si parla in filosofia politica da
un po’ di tempo a questa parte, qualcosa che con la dike classica, ma anche con il giusto di cui
parliamo, a mio avviso, non ha assolutamente niente a che fare. È un’idea di giustizia distributiva, i
medievali distinguevano, ci si muove in un ambito di giustizia distributiva, che ha come principio
“unicuique suum (tribuere)”, dare a ciascuno i l suo: giustizia distributiva. Nelle grandi raffigurazioni
medievali vedete la giustizia distributiva come la bilancetta che tempera, poi c’è quella che punisce,
con la spada ecc. Tutte stanno insieme. Mentre l‘aspetto punitivo nel giusto – è essenziale questo –
manca. Il giusto non chiede vendetta, non chiede punizione. Esula totalmente dal concetto di
giustizia distributiva, che è il modo in cui oggi si parla di giustizia in filosofia politica,sulla scia di
Rawls, degli americani e della filosofia analitica. Gli analitici arrivano perfino a calcolare –
calcoliamo per quanto possibile come a ciascuno vada distribuito il suo. Il giusto non ha un “suum”
il giusto è precisamente colui che si svuota del “suum” per svuotarsi tutto, per donarsi tutto, il giusto
è colui che si libera dal “suum” per essere giusto nei confronti dell’altro, quindi è qualcosa che
contraddice radicitus l’idea di giustizia distributiva così come, a mio avviso, quella di diritto naturale
così come, ancora di più, ogni idea di diritto positivo o di ossequio al diritto positivo, paradossalità
completa, che non è riportabile, come dire, a un contesto discorsivo, analitico, per non dire di un
contesto in cui i rapporti tra i termini possano essere calcolati.
Come indicare il giusto allora? Certo, l’elemento fondamentale è quello che anche qui è già stato
detto: cioè quello di qualcosa che eccede ogni idea retributiva, ogni idea di scambio, qualcosa che ha
profondamente a che fare con l’idea di dono, ma anche ma anche di perdono, perché manca
completamente l’elemento della giustizia punitiva all’interno della visione del giusto. Direi che si
potrebbe pensare così: il giusto ha a che fare con il bene, ma il bene in quell’accezione per cui il bene
eccede ogni calcolo e ogni misura. In termini più generali: il bene per il giusto è che ogni ente, ogni
ente, nel senso di ciò che mi sta di fronte, che mi si oppone e, quindi, che stando di fronte e
opponendosi – obiectum – in una forma o nell’altra non è mio, è bene che sia. È bene che l’ente sia,
quello è il bene, è bene che l’altro sia, è bene lasciare che sia, nella sua libertà rispetto a me, nella sua
autonomia, nella sua indipendenza. È bene che l’ente sia e che sia lasciato essere anche nel suo
opporsi rispetto a me. È bene che non venga escluso in nessun modo, “io nulla escludo”. Il mio
atteggiamento nel confronti dell’altro non è esclusivo né nel senso che io mi ritengo esclusivo
rispetto all’altro né che voglio escludere alcunché dall’altro. Nello stesso tempo è sempre un
riguardare l’altro.
Le figure dei giusti sono tutte figure che da un lato vogliono che l’altro sia, non ne vogliono in alcun
modo non dico l’l’eliminazione, ma l’esclusione, ma nello stesso tempo vogliono anche riguardarlo
in tutti i sensi, sono anche letteralmente curiosi dell’altro, ne hanno cura, non lo contemplano
semplicemente. L’altro riguarda profondamente il giusto, lo sta a vedere, lo ascolta, e ciò si oppone
proprio al male; se il bene è questo, il male è l’isolarsi, l’escludersi, il pensare che sarebbe bene “il
poter escludere l’altro”, che l’altro non sia, il male non è volere che l’altro non sia? Il bene è volere
che l’altro sia. Il bonum è sempre effusivum sui, dicevano i medievali; si dona, effonde sé; il male
invece vuole all’opposto tenersi, tenere il sé ed escludere l’altro. Questo è il polemos, questa è la
lotta. Il male non riguarda l’altro, il peccato è l’isolante estremo, il bene è esattamente la dinamica
opposta, il donarsi, per-dornarsi, donarsi al quadrato. Il bene è riguardare l’altro, averne cura, il male
è non guardarlo.
Qui c’è il grande dramma. Perché il riguardare l’altro, il lasciarlo essere, lasciare che sia, è straordinario, il non guardarlo è banale: la banalità del male. La radice del male non sta nel fare il male,
il male che rende possibile anche il mio fare il male è il male banale di quelli che non guardano. Il
male fondamentale è il male di quelli che non guardavano il fumo uscire da Auschwitz, è quello dei
turchi che non guardavano i militari fare il genocidio, i pogrom ecc. questa è la banalità del male di
cui parla la Arendt. Il male è comune. Perché continuamente noi non guardiamo, non riguardiamo,
cerchiamo di non guardare. Questo è il male proprio peccato originale. Altro che le palle sulle
antropologie positive e sulle bontà originarie dell’uomo. Questo è il male comune. Le antropologie
positive sono l’irrealismo totale che non va bene né in filosofia né in politica né da nessuna parte.
Quell’idea di giustizia, quel giusto, è straordinario, e tuttavia è il sale della terra.
Inutile farci illusioni, che il giusto possa curare questo male, il vero male, quello comune, che è
quello che rende possibile Auschwitz, i totalitarismi. Se tutti gli altri guardassero tutti, quel male
sarebbe inconcepibile, se fossero attenti, se avessero cura, se fossero buoni nel senso che è bene che
l’ente sia ed è bene lasciarlo essere. Se questo fosse il comune del nostro esserci come potrebbe
avvenire Auschwitz, come potrebbe avvenire la strage degli armeni, come potrebbero avvenire le
continue stragi cui assistiamo, come avrebbero potuto avvenire se l’Europa guardasse quello che è
avvenuto nei Balcani, in Jugoslavia, Sarajevo, dieci giorni fa. Come sarebbe stato concepibile che
avvenisse? Avviene perché c’è un male comune. Il giusto, nel momento stesso che lo sa, non vuole
che continui una catena della vendetta, perciò si dona e perdona nel tentativo, “spes contra spem”,
che si interrompa questa catena, che è poi anche la speranza fondamentale che animava la parola di
Gesù, quando diceva “mé antistenai tò oneròn”, non opporti al male: nelle beatitudini c’è scritto così.
Ma che vuol dire non opporsi al male? Vuole dire che tu non devi rispondere con i mezzi che usa il
male al male. Il giusto non fa così in qualche modo? Lotta contro il male, ma non facendo male,
cercando di salvare – è bene che l’ente sia, è bene custodire la verità, per giocare coi termini
tedeschi: Wahr Wahren, vero è il custodire l’ente, lasciare che l’ente sia, è bene che continui ad
essere – si oppone al distruttore, al male che esclude e distrugge senza volerlo distruggere, perché
vorrebbe interrompere questa catena di distruzioni su distruzioni. Questo è il sale della terra. Ma la
terra è pur sempre la terra, la terra del male comune, è la terra della banalità del male, è la terra dove
i genocidi o gli stermini continuano. I giusti cosa sono? I giusti sono, ahimé, il sale della terra.
DOMANDE
(Pietro Kuciukian)
C’è una questione alla quale sto girando attorno da una decina d’anni. Si tratta del bene e del male.
Faccio un esempio: al tempo del genocidio degli Armeni, Mustafà Aziz Oglù era il sindaco di
Malati(a), dove passavano le carovane dei deportati. Questo sindaco ha salvato molta gente ne ha
ricoverato altra nella sua casa, era quello che possiamo definire un giusto. Il figlio, lui che faceva
parte del partito “Unione e progresso”, il partito al governo, venuto a sapere quello che faceva il
padre, ha ucciso il padre. Ora per i turchi il giusto è il figlio, per gli armeni il giusto è il padre. Ecco
la questione del bene e del male: il motore della terra potrebbe essere il bene, quello che fa muovere,
perché tutti e due si sono mossi su un concetto di bene. Il male dove sta? Lo stesso si potrebbe dire
per Hitler, per Stalin ecc.
RISPOSTA
Ho detto che cosa è il male. Il giusto è il padre. Il figlio vuole lo sterminio, vuole che quell’altro non
sia. Si esclude dal prender parte all’altro, si esclude dall’approssimarsi all’altro, in qualsiasi senso,
anche il più polemico, ma in questo polemos io riconosco all’altro al limite il diritto di esistere, come
minimo. Quindi non c’è dubbio alcuno, è il padre nel giusto, il figlio sta dalla parte del male. Il
problema è che il figlio è il banale, il comune, al di là dell’atto eccezionale dell’ammazzare il padre,
che poi in tempi di guerra civile tanto banale non è, la guerra civile che è la guerra per antonomasia,
il modello di tutte le guerre, è fatta di parricidi, di fratricidi ecc. quello è il banale: la guerra, il
parricidio, il fratricidio, la guerra, volere che l’altro non sia, tentare di distruggerlo, annichilirlo, ci
sono solo io e gli altri devono diventare niente, oppure – se non niente- cerchiamo di non guardarli,
di non vederli: “non mi riguarda”, questa è la parola chiave del male, questo è il vero demonio,
questa è la vera separazione, il vero diavolo – diabolos, diaballein – questo il vero carattere del
diavolo, non è uno con le corna, il diavolo è colui che separa, non guardare l’altro, non ti riguarda,
non è affare tuo, pensa a te, chiuditi nella tua bella caverna egoica, come dice Hillmann, e vedrai che
lì stai bene. Come i prigionieri di Platone in fondo alla caverna che stanno benissimo e quando uno
gli dice guarda che fuori c’è il sole, lo ammazzano. Questa è la banalità dell’essere prigionieri, la
banalità del non essere liberi. Noi ci riempiamo la bocca della parola libertà, ma la libertà è qualcosa
di eccezionale, di straordinario, non è nulla di banale, tanto è vero che i filosofi non sono mai riusciti
a dimostrare che è. Per capirla si sono messi in testa di dimostrare che è, e hanno detto allora non
siamo liberi, tutti. infatti, come fai a dimostrarlo che sei libero? Non puoi. Che cosa puoi dimostrare
– almeno alcuni? Che se non ti senti libero non puoi vivere. Ma provate a fare una dimostrazione
logico-razionale della libertà. Anche Kant lo dice: è un fatto, non è la conclusione di un
ragionamento. Il sentirsi libero, ma volere che anche l’altro lo sia – non il sentirti libero tu nel senso
che domini l’altro, - voglio essere libero per annichilire il tuo essere libero - questo, ripeto, è il
banale, il comune. Tuttavia – spes contra spem – fintanto che vi è questo padre che si fa ammazzare
dal figlio, ma salva uno, uno solo, a rischio della propria vita, noi dobbiamo dire spes contra spem,
perché abbiamo questi testimoni, questi martiri che dimostrano che a noi questo esserci che siamo è
dato magari essere giusti perché dei giusti ci sono stati. Prendete il discorso delle beatitudini, chi lo
ha incarnato? Gesù è una figura anche storica quindi se c’è stato Gesù ce ne può essere anche un
altro. Non è dimostrabile l’impraticabilità di questa strada. Ma non c’è stato più nessuno… no, ci
sono i giusti, dunque ci è dato esserlo, però realisticamente bisogna riconoscere che il nostro mondo
è quello delle leggi, del diritto, e quasi sempre quello della banalità del male.