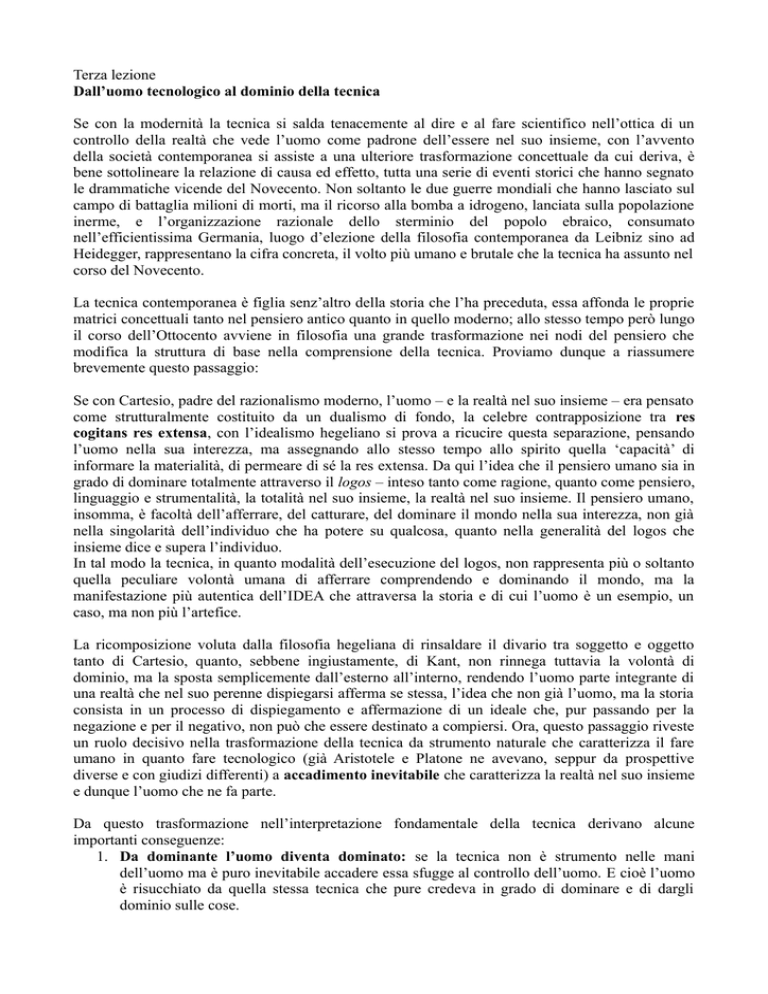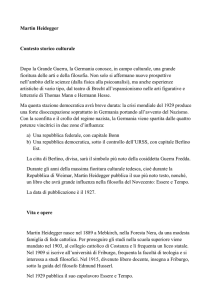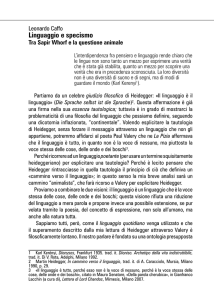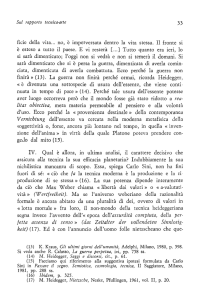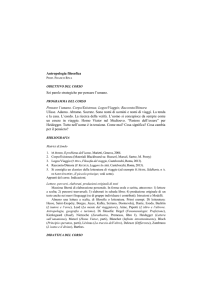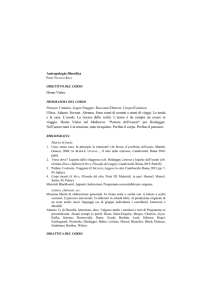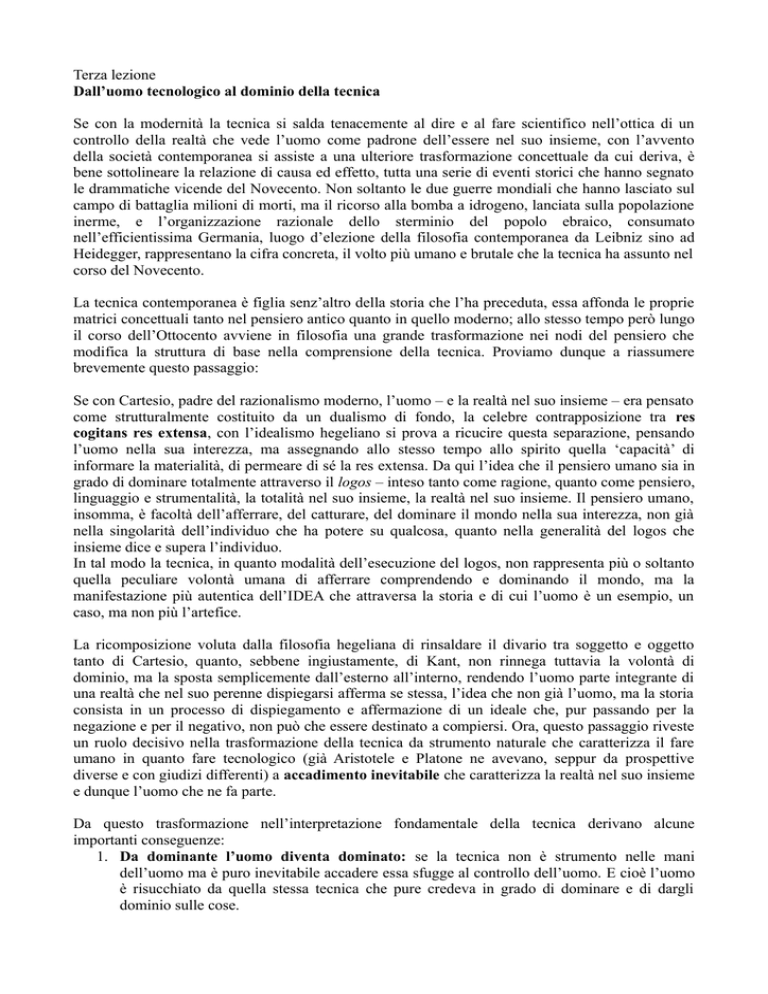
Terza lezione
Dall’uomo tecnologico al dominio della tecnica
Se con la modernità la tecnica si salda tenacemente al dire e al fare scientifico nell’ottica di un
controllo della realtà che vede l’uomo come padrone dell’essere nel suo insieme, con l’avvento
della società contemporanea si assiste a una ulteriore trasformazione concettuale da cui deriva, è
bene sottolineare la relazione di causa ed effetto, tutta una serie di eventi storici che hanno segnato
le drammatiche vicende del Novecento. Non soltanto le due guerre mondiali che hanno lasciato sul
campo di battaglia milioni di morti, ma il ricorso alla bomba a idrogeno, lanciata sulla popolazione
inerme, e l’organizzazione razionale dello sterminio del popolo ebraico, consumato
nell’efficientissima Germania, luogo d’elezione della filosofia contemporanea da Leibniz sino ad
Heidegger, rappresentano la cifra concreta, il volto più umano e brutale che la tecnica ha assunto nel
corso del Novecento.
La tecnica contemporanea è figlia senz’altro della storia che l’ha preceduta, essa affonda le proprie
matrici concettuali tanto nel pensiero antico quanto in quello moderno; allo stesso tempo però lungo
il corso dell’Ottocento avviene in filosofia una grande trasformazione nei nodi del pensiero che
modifica la struttura di base nella comprensione della tecnica. Proviamo dunque a riassumere
brevemente questo passaggio:
Se con Cartesio, padre del razionalismo moderno, l’uomo – e la realtà nel suo insieme – era pensato
come strutturalmente costituito da un dualismo di fondo, la celebre contrapposizione tra res
cogitans res extensa, con l’idealismo hegeliano si prova a ricucire questa separazione, pensando
l’uomo nella sua interezza, ma assegnando allo stesso tempo allo spirito quella ‘capacità’ di
informare la materialità, di permeare di sé la res extensa. Da qui l’idea che il pensiero umano sia in
grado di dominare totalmente attraverso il logos – inteso tanto come ragione, quanto come pensiero,
linguaggio e strumentalità, la totalità nel suo insieme, la realtà nel suo insieme. Il pensiero umano,
insomma, è facoltà dell’afferrare, del catturare, del dominare il mondo nella sua interezza, non già
nella singolarità dell’individuo che ha potere su qualcosa, quanto nella generalità del logos che
insieme dice e supera l’individuo.
In tal modo la tecnica, in quanto modalità dell’esecuzione del logos, non rappresenta più o soltanto
quella peculiare volontà umana di afferrare comprendendo e dominando il mondo, ma la
manifestazione più autentica dell’IDEA che attraversa la storia e di cui l’uomo è un esempio, un
caso, ma non più l’artefice.
La ricomposizione voluta dalla filosofia hegeliana di rinsaldare il divario tra soggetto e oggetto
tanto di Cartesio, quanto, sebbene ingiustamente, di Kant, non rinnega tuttavia la volontà di
dominio, ma la sposta semplicemente dall’esterno all’interno, rendendo l’uomo parte integrante di
una realtà che nel suo perenne dispiegarsi afferma se stessa, l’idea che non già l’uomo, ma la storia
consista in un processo di dispiegamento e affermazione di un ideale che, pur passando per la
negazione e per il negativo, non può che essere destinato a compiersi. Ora, questo passaggio riveste
un ruolo decisivo nella trasformazione della tecnica da strumento naturale che caratterizza il fare
umano in quanto fare tecnologico (già Aristotele e Platone ne avevano, seppur da prospettive
diverse e con giudizi differenti) a accadimento inevitabile che caratterizza la realtà nel suo insieme
e dunque l’uomo che ne fa parte.
Da questo trasformazione nell’interpretazione fondamentale della tecnica derivano alcune
importanti conseguenze:
1. Da dominante l’uomo diventa dominato: se la tecnica non è strumento nelle mani
dell’uomo ma è puro inevitabile accadere essa sfugge al controllo dell’uomo. E cioè l’uomo
è risucchiato da quella stessa tecnica che pure credeva in grado di dominare e di dargli
dominio sulle cose.
2. La tecnica da strumento diviene evento: la tecnica è il modo che ha il logos di relazionarsi
al mondo, ma il logos umano è espressione, momento, stadio di un processo più generale,
più universale che, sebbene dipendente, supera nella sua essenza le determinazioni concrete.
La tecnica, insomma, in quanto accadimento della storia, è neutrale, ovvero non dice una
modalità positiva o negativa del relazionarsi, perché precede di fatto le determinazioni
morali. La tecnica è neutrale.
3. La tecnica non indica più un agire, ma un patire: dal momento che la tecnica non è più
espressione di deliberazione e volontà, ma corrispondenza a un accadimento della storia,
l’uomo di fatto non può sottrarsi al dominio della tecnica, non può di fatto opporsi a questo
accadere, ma deve imparare a misurare le sue azioni in base all’accadimento tecnico che lo
circonda.
Il nostro filo conduttore per rintracciare le radici di questa trasformazione, il suo compiersi e, non
meno importante, la disamina di eventuali indicazioni morali che possano essere adeguate alla
modalità con cui l’uomo deve rapportarsi a questo nuovo evento, che non ha precedenti nella storia,
sarà un piccolo scritto di Heidegger composto appena dopo la fine del secondo conflitto mondiale,
nel 1946, La lettera sull’Umanismo1.
Scritto in risposta a una lettera del filosofo francese Jean Beaufret che domandava ad Heidegger se
era possibile ‘ridare un senso alla parola umanismo’, questo breve saggio affronta, seppur con un
tono meno sistematico di altri scritti heideggeriani, il tema della relazione dell’uomo al mondo, e
dunque all’essere nel suo insieme, nell’era attuale che dal filosofo friburghese è definita come
‘epoca del dominio della tecnica’. In esso Heidegger prova a mettere in luce, fin dalle prime battute,
una sostanziale, ma non altrettanto riflettuta, differenza tra il fare inteso come ‘produrre qualcosa’ e
il fare come ‘agire’ che è una modalità dell’azione propriamente umana, ovvero che lo caratterizza,
distinguendolo, rispetto agli altri esseri viventi. Per comprendere questa differenza capitale occorre,
tuttavia, anzitutto dare alcune tracce biografiche essenziali -tracce che saranno utili per
comprendere in quale clima e perché questo scritto può rappresentare uno dei momenti cruciali
della riflessione novecentesca sul destino dell’Europa 2 –, ma anche fare una breve premessa sulla
1 M. Heidegger, Lettera sull‘Umanismo, F. Volpi (a cura di), Adelphi, Milano 1987.
2 La comprensione della situazione esistenziale di Heidegger al tempo della composizione della Lettera, dunque negli
anni immediatamente seguenti al secondo conflitto mondiale, è determinante per noi. Bisogna comprendere che i
filosofi non sono individui avulsi dalla storia, dal contesto storico-fattuale in cui vivono e dagli stessi accadimenti che
nelle loro vite personali accadono. Vita e pensiero, sebbene non siano lo stesso, si muovono in una relazione di
reciproca contaminazione per cui è impossibile pensare l’una senza l’altra. Dopo una folgorante carriera universitaria,
che lo vide in pochi anni bruciare le tappe e occupare nel 1927 la prestigiosa cattedra di filosofia all’Università di
Friburgo in Bresgovia – cattedra che era stata del suo maestro, il fenomenologo Edmund Husserl –, Heidegger si
avvicinò alle posizioni politiche del nascente movimento nazista. Tale avvicinamento si trasformò al principio del 1933
in aperta adesione, segnato da due differenti episodi: il tesseramento al partito nazista e l’elezione a Rettore
dell’Università di Freiburg. Per l’inaugurazione dell’anno accademico del 1933 Heidegger tenne una celebre prolusione
intitolata ‘L’autoaffermazione dell’Università tedesca’ nella quale non pochi sono i riferimenti al destino della Germania
rispetto al mondo, alle sue potenzialità, alla sua storia. In essa Heidegger indicava ai suoi giovani studenti un cammino
da seguire, una presa di coscienza, un monito per prendere in mano la loro storia. Dopo pochi mesi dall’incarico,
tuttavia, a seguito anche di alcune rimostranze mosse tanto dalle organizzazioni studentesche naziste, quanto da quelle
ebraiche, Heidegger si risolse a dimettersi dall’incarico. Tali dimissioni coincisero con una interruzione delle relazioni
con i referenti culturali del partito nazista. Di fatto Heidegger venne osteggiato da quel momento in poi dai dirigenti del
partito, ma anche dagli stessi colleghi socialisti e comunisti che ne criticarono l’adesione al partito. Il filosofo continuò
a tenere corsi sino al 1941, ma fu emarginato dagli intellettuali del suo paese. Quando nel 1944 la Germania era
sull’orlo della disperazione e si risolse a chiamare tutte le forze in campo per difendere le posizioni, oramai fragili,
raggiunte in Europa, Heidegger fu l’unico accademico ultracinquantenne mandato a combattere al fronte. Non meno
duro fu il trattamento che gli riservarono gli occupanti americani durante il cosiddetto processo di ‘denazificazione’: la
sua casa venne occupata dagli americani e la sua enorme biblioteca sequestrata. Gli fu interdetto l’insegnamento
accademico. Per contro, lui decise di ritirarsi nella baita sulle colline della foresta nera che pochi anni prima si era fatto
costruire senza nessun ‘confort tecnico’ al suo interno. Nel 1946 alcuni intellettuali francesi meditano di reinserire
Heidegger nel dibattito culturale post bellico. La lettera sull’Umanismo è il segno di una ripresa dunque, della ripresa di
un dialogo che, sebbene fuori dalle aule dell’accademia, e contrassegnata da un ‘riserbo’ sulle snodi storici fondamentali
comprensione heideggeriana dell’uomo, ovvero sulla sua nuova interpretazione dell’essere umano
che mette in discussione anzitutto l’approccio di tipo metafisico e dialettico (cfr. uomo=animal
rationale=zoon logon echon).
Nell’opera maggiore del filosofo, Essere e tempo3, viene rigettata fin dalle prime pagine la classica
definizione dell’uomo come animal rationale; in questo rifiuto Heidegger respinge tanto la deriva
della cosiddetta essenza dell’uomo dall’animalità, quanto la focalizzazione della differenza, e
dunque della specificità umana, sulla razionalità in senso stretto, e cioè come quella facoltà di
ridurre i contenuti dell’osservazione a contenuti della ragione, facoltà che presiederebbe
all’atteggiamento teoretico (nella priorità assegnata in filosofia all’atteggiamento umano rispetto al
mondo come atteggiamento teoretico Heidegger vede una linea di continuità che da Platone
condurrebbe sino a Hegel e definita come ‘storia della metafisica’ ovvero storia nella quale
l’accento è posto più sul carattere gnoseologico dell’umano che non in quello pratico. Con modalità
teoretica si indica precisamente il mondo in cui l’uomo si rapporta ai contenuti del mondo
circostante mediate un processo scandito dai seguenti passaggi: osservazione della realtà, astrazione
in concetti base, incasellamento e catalogazione del reale in base a una relazione generalizzante e/o
formalizzante). Se la maggior parte dei filosofi ha insistito sul carattere razionale dell’uomo, e di
conseguenza sulla facoltà teoretico-conoscitiva che ne definirebbe essenzialmente l’essere, vi sono
di contro alcuni sporadici casi nei quali l’attenzione è rivolta più alla dimensione pratico-fattuale o
esistenziale (in linea di continuità Agostino, la mistica medioevale, Pascal, Kant, per certi aspetti lo
stesso Schelling). Kant, in questo quadro, costituirebbe la punta di diamante, ovvero il tentativo più
profondo e complesso di radicare l’eccezionalità umana nell’ambito pratico: l’essere umano, infatti,
e la sua ragione, è limitata fintano che han a che fare con ‘oggetti esterni’, laddove invece la ragione
si concentra su oggetti ‘interni’, oggetti cioè che derivano dalla ragione stessa e costituiscono
l’impalcatura della nostra soggettività, essa dischiude all’uomo gli orizzonti infiniti della libertà,
della metafisica, ovvero di quell’apertura che non è vincolata al mondo fenomenico ma si sporge,
comprendendolo a fondo e regolamentandolo, il mondo noumenico. Se nella tradizione metafisica,
insomma, l’uomo sarebbe un ente (Seiendes) pari agli altri enti e differente dagli altri
esclusivamente in virtù della sua ragione, con la proposta kantiana – letta evidentemente da una
prospettiva ontologico-esistenziale non usuale, ma pur sempre possibile – l’eccezionalità dell’uomo
rispetto agli altri enti sarebbe invece da rintracciarsi nella sua capacità di costruire un vero e proprio
regno dei fini morali: solo la ragione pratica, scrive Kant, è in se stessa pura, ovvero determina se
stessa e le sue potenzialità non già in virtù di un apparato teoretico, ma in ragione della sua libertà e
della perentorietà del dovere morale che, tuttavia, è pur sempre un prodotto del suo stesso essere.
Ora, con la filosofia di Heidegger, che risente nella sua prima fase di motivi esistenzialistici (c’è
molto Kierkegaard come è stato giustamente osservato dagli interpreti più attenti), si assiste a una
ulteriore determinazione in senso pratico-esistenziale della condizione umana. L’uomo, dal filosofo
definito Dasein (esser-ci), non è un ente tra gli enti, un oggetto al pari degli altri, ma nemmeno un
soggetto circondato da oggetti, piuttosto è un essere la cui eccezionalità e specificità consisterebbe
da un lato nell’occupare un determinato spazio nel mondo (nell’essere qui, intendendo il ci come un
locativo) e, dall’altro, di eccedere questa stessa spazializzazione (che non è dunque soltanto
locativa, ma esistenziale). Il mondo, tuttavia, non sarebbe un mero margine fisico che contiene la
vita umana, ma il raggio d’azione della sua esistenza
Il mondo, inteso come ciò in cui l’uomo viene ad essere, è ben più che un margine dell’azione ma
quel ventaglio di possibilità che gli sono offerte assieme a tutte le possibilità che gli sono precluse
(in primis la morte intesa come possibilità estrema, ovvero come ciò che nel suo compiersi estingue
la stessa possibilità). Di fronte a questa apertura, che l’uomo intende come la sua casa, in essa viene
‘al mondo’, si consuma certo un senso di peculiare appartenenza, ma anche, e qui s’insinua
dell’Europa durante il periodo bellico, Heidegger tenne con il mondo sino agli ultimi anni settanta. Sul silenzio di
Heidegger rispetto al nazismo e all’olocausto in particolare è possibile consultare moltissimo materiale in internet. Esso
appare a molti un tema cruciale per giudicare l’intera filosofia di Martin Heidegger.
3 M. Heidegger, Essere e tempo, P. Chiodi (a cura di), Longanesi 1976.
l’eccedenza dell’umanità, quel non sentirsi identici a tutte le cose che occupano lo spazio mondano,
al mondo nel suo insieme inteso come insieme oggettuale di utilizzabili, e cioè cose con cui ‘io mi
do da fare’. La distanza dalle cose, il sentirsi eccedenti rispetto ad esse, va di pari passo al
riconoscimento che altre identità, come me nel medesimo stato sospeso tra appartenenza ed
eccedenza, mi sono simili. I miei simili sono tutti coloro che mi circondano in questo spazio
mondano, che condividono il mio stesso destino e che, come me, sperimentano la differenza con la
mera oggettualità utilizzabile. Se dunque la prima modalità di relazione al mondo come insieme
oggettuale è una modalità del fare manipolante utilizzabile, di fronte all’apertura di un altro essere
come me, questo tentativo, che pure può accadere perché iscritto nella modalità primaria della
relazione, è destinato al fallimento: i miei simili, gli altri in quanto tali, non possono essere spogliati
da quel modo di essere apparentemente eccedente che li caratterizza e che non dipende dal mio
pensiero, dal mio fare, dal mio agire.
Per quanto si possa, non c’è alcun dubbio, trattare gli altri come semplici oggetti utilizzabili (fare
degli esempi), essi non si riducono a oggetti, essi non diventano oggetti solo perché io posso
pensarli tali (vanno inseriti dei rimandi a Sein und Zeit in fotocopia, bisogna far leggere loro
qualcosa!).
Vediamo dunque a vedere come si apre lo scritto di Heidegger di cui tratteremo. Al principio è in
discussione proprio il concetto di potere. Cosa significa avere potere? Fin dove ne abbiamo? Su
cosa, davvero?
‘Noi non pensiamo in modo abbastanza decisivo l’essenza dell’agire. Non si conosce l’agire se non
come produrre un effetto la cui realtà è valutata in base alla sua utilità. L’essenza dell’agire, invece
è il portare a compimento (Vollbringen portare a pienezza propriamente). Portare a compimento
significa portare qualcosa alla pienezza della sua essenza, condurre fuori a questa pienezza,
producere. Dunque in senso proprio può essere portato a compimento solo ciò che già è. Ma ciò che
prima di tutto è è l’essere. Il pensiero porta a compimento il riferimento (Bezug) dell’essere
all’essenza dell’uomo. Non che esso produca o provochi questo riferimento 4). Il pensiero lo offre
all’essere solo come ciò che gli è stato consegnato dall’essere. Questa offerta consiste nel fatto che
nel pensiero l’essere viene a linguaggio. Il linguaggio è la casa dell’essere. Nella sua dimora abita
l’uomo. I pensatori e i poeti sono i custodi di questa dimora. Il loro vegliare è il portare a
compimento la manifestatività dell’essere; essi, infatti, mediante il loro dire, lo conducono al
linguaggio e nel linguaggio la custodiscono. Il pensiero non si fa azione perché da esso scaturisce
un effetto o una sua applicazione. Il pensiero agisce in quanto pensa. Questo agire è probabilmente
il più semplice, ma forse il più alto’ 5.
In un rovesciamento apparentemente ardito tra pensare e fare, Heidegger colloca nel pensare
l’azione più significativa che spetta all’uomo rispetto al mondo che lo circonda. Tuttavia, lo stesso
pensare non è più inteso come una certa tradizione metafisica ha voluto intendere, ovvero come
quella disposizione teoretica di fissare oggettivamente i contenuti dell’esperienza, al contrario il
pensare è autenticamente un fare perché la prima modalità della relazione al mondo e agli altri è
tipo pratico.
Andiamo un passo per volta.
4 Evidentemente la relazione tra l’uomo e il suo essere, tra l’uomo e l’essere in generale, è un che di originario,
improducibile così come non riproducibile (l’essere non è un dato, certo, non un positum, ma ci è in qualche modo
sempre offerto, ovvero è ciò che ci precede e insieme rappresenta l’orizzonte significante della nostre nostra esistenza).
Con la sottrazione dell’essere dal dominio del pensare – l’essere come ciò che è indisponibile – Heidegger intende per
un verso sottrarre la questione dell’essere a una pura interpretazione gnoseologica, dall’altro però vuole caratterizzare
questa datità ontologica dell’essere come qualcosa di non totalmente dispiegato, ma aperto al senso, ovvero al modo
della relazione dell’uomo al suo stesso essere. Per sintetizzare: il fatto che l’essere non dipende da noi, ma come
l’essere è, ovvero quali sono le possibilità della sua attestazione dipende dal fare e dall’agire umani, attiene al regno
della libertà e, dunque, propriamente dell’etica.
5 M. Heidegger, Lettera sull’Umanismo, pp. 267-268.
Nella prima fase della sua riflessione filosofica Heidegger insiste, sebbene talora in modo
scomposto e non del tutto rigoroso, sulla necessità di tornare a ripensare su ciò che origina e
mantiene desto il pensiero. Egli individua nella riflessione sulla vita lo scopo primario della
filosofia. Siamo negli anni venti. L’Europa è appena uscita dal primo conflitto mondiale, tutti i
valori in cui credevano i giovani si sono frantumati contro il muro della violenza bellica che ha
lasciato sui campi di battaglia milioni di cadaveri. L’etica del padri vacilla ma un nuovo senso di
rinascita attraversa l’occidente. E un forte senso di riscatto si fa strada nella Germania sconfitta e
umiliata (siamo ai prodromi della nascita del nazionalismo sociale). La ragione hegeliana è incapace
di spiegare l’assurdo della guerra, ma di contro le filosofie del vitalismo sembrano scivolare proprio
nell’alveo dell’assurdo che ha generato la distruzione. La filosofia può ancora dire qualcosa sulla
vita?
Heidegger, a quanto pare, crede di sì. Crede che filosofia e vita sono saldate in modo tale che è
impossibile pensare l’una senza l’altra (sebbene FILOSOFIA E VITA NON SIANO LO STESSO).
Da qui l’esigenza di provare a capire cosa sta a monte della filosofia, da cosa essa si generi e se
questo legame sia recidibile a un certo punto.
‘la filosofia scaturisce dalla vita effettiva per poi farvi ritorno rimbalzando in essa’. Questa
definizione di un circolo che starebbe a monte del pensare, dalla vita alla filosofia e dalla filosofia
nuovamente alla vita, non è la mera assegnazione di un oggetto al pensare, ma la descrizione di un
modo proprio della filosofia che va indagato più a fondo.
Cosa è la vita? Per Heidegger la vita è l’esistenza umana, uno stare al mondo nel quale l’apertura
non indica semplicemente lo spazio che occupiamo ma il modo in cui veniamo e stiamo, ovvero ci
rapportiamo da sempre e per sempre al mondo. Il mondo, a sua volta, non indica semplicemente
un’indicazione locativa ma un insieme di significati e di rapporti e di legami dentro al quali ci
troviamo gettati.
Il mondo è l’insieme delle relazioni e dei rapporti dentro i quali la nostra vita sorge e si costituisce.
Il mondo non è neutrale, ma precompreso, caratterizzato in un modo o in altro: non è lo stesso il
mondo che davanti a sé un bambino padovano accolto dalle braccia della madre e ninnato al suono
di un carillon e quello di un bambino siriano che in questi giorni nasce stretto da un terrorizzato
abbracciato materno sotto il fragore delle bombe. Il mondo è l’insieme di ciò che intorno a noi gli
altri fanno e ciò che noi stessi facciamo, ovvero come a esso ci relazioniamo. Il pensiero è azione
perché i significati che attribuiamo alle cose del mondo creano il nostro mondo.
Ora, in questa visione d’insieme evidentemente Heidegger sta criticando ‘la modalità di
apprensione originaria dell’essere che noi stessi siamo’. Ovvero noi nasciamo e ci rapportiamo al
mondo non pensandolo astrattamente, ma vivendo in esso, agendo. L’insieme dei significati è dato
dalla modalità della relazione e la relazione è sempre pratica: il neonato pensa alla madre non come
a un oggetto sentimentale, ma come ciò grazie a cui si creano condizioni di benessere e di
soddisfazione, o piuttosto di insoddisfazione e malessere. Nell’intendere gli altri e gli oggetti del
mondo tendo a vederli sempre nell’uso che ne faccio, nel riferirli a me e alla finalità con cui io
posso raggiungere i miei scopi: le cose e gli altri, scrive Heidegger, sono degli utilizzabili.
Utilizzabile è lo strumento, il mondo è l’insieme degli strumenti che io posso utilizzare.
Si direbbe a questo punto che la tecnica è la modalità autentica del rapportarsi al mondo.
Sbagliato. La tecnica è potere, poter fare qualcosa, potere una cosa o un’altra, un’azione o un’altra.
Addirittura la tecnica è anche un poter essere qualcosa, un poter essere immortali, un poter creare la
vita. Noi possiamo creare la vita ma non il fondo da cui la vita proviene, possiamo generare
l’immortalità, la vita infinita ma non disegnare il margine entro cui a questa vita dare un senso. Noi
possiamo dominare le cose, è certo, ma anche nel dominio produttivo qualcosa CI è
INDISPONIBILE.
C’è un potere più autentico. È il potere della possibilità, il potere del possibile (Kierkegaard), il
potere della libertà del tutto simile a quello kantiano perché essa comincia solo a partire da un
dovere, ovvero da ‘un punto fermo’ che ci è indisponibile, non ritrattabile, non nelle nostre mani.
Nella Lettera sull’Umanismo Heidegger ci dice, quasi poeticamente, che l’essenza del potere non è
il produrre, cioè far diventare qualcosa, ma l’amare 6.
Io posso solo fintanto che qualcosa è, ma non posso agire sull’è. Posso produrre oggetti certo, ma
non posso, nemmeno nel caso della creazione di un altro essere umano, dare luogo a quell’è che lo
caratterizza. Nella nascita di una nuova vita io non sono padrone, ma custode, sono garanzia che la
vita venga a sé stessa. Posso anche immaginare la vita come la creazione fittizia in laboratorio di un
altro essere umano la cui cura non dipende dall’ospitalità all’interno di un essere umano ma nelle
fredde stanze di un laboratorio. Eppure, anche in quel caso, il sarei tutt’al più padrone del processo
che la conduce fuori al mondo, ma non padrona del senso che essa ha. Poiché il senso, il dare senso
a qualcosa dipende da ogni essere nel suo farsi e nel suo darsi. E questo poter dare senso è
strettamente connesso al potere dell’uomo, ovvero è qualcosa di cui l’uomo è in potere.
Torniamo dunque per un momento al potere.
Il potere è l’amare.
Heidegger scrive che il potere è un mögen (questo verbo indica tanto il volere quanto il desiderare e
l’amare. Rispetto al wollen, che nell’uso comune suona perentorio all’interno di una frase in cui si
richiede qualcosa a qualcuno – ich will noch wasser, suonerebbe scortese in una domanda perché
significa voglio ancora dell’acqua–, nel mögen è presente una cortesia e una cura del domandare,
ma anche un desiderare che è frutto di deliberazione. È sì certo anche un volere, ma un voler non
dettato dal bisogno, piuttosto dalla preferenza, dall’affinità), un voler bene e voler bene, ci dice
Heidegger, significa lasciare che qualcosa sia (rispettarne la differenza, la distanza, attenderne che
cresca e dispieghi appieno le sue possibilità più proprie, averne cura consegnandola alla sua stessa
cura, scriveva nel 1927 Heidegger in Sein und Zeit)7. Nella Lettera proseguendo scrive il filosofo:
‘prendersi a cuore una cosa o una persona nella sua essenza vuol dire amarla, volerle bene. Pensato
in modo più originario, questo voler bene significa donare l’essenza’ e ancora: ‘potere qualcosa
significa conservarlo nella sua essenza, mantenerlo nel suo elemento’ 8.
La filosofia può questo potere rispetto all’essere nel suo insieme, inteso non come un oggetto di cui
ricercare le cause ultime –se così fosse la filosofia sarebbe soltanto un habitus conoscitivo e non
avrebbe alcuna relazione con la vita se non estrinseca e oggettiva –, ma come quell’orizzonte
all’interno del quale è possibile dare e fare senso della propria strutturale relazione all’essere, e
dunque del proprio essere. Tuttavia, nella storia della filosofia, scrive Heidegger, le cose sono
andate diversamente, essa ‘si è procurata un valore come téchne, come strumento di formazione,
come attività culturale, come esercizio scolastico’, insomma ‘come tecnica della spiegazione a
partire dalle cause supreme’. Il linguaggio della filosofia è stato asservito a questa causa ed è
divenuto, tanto come il pensiero, strumento del dominio e non della custodia. Nel linguaggio della
filosofia si indica all’uomo come obiettivo quello di essere riportato alla sua humanitas, ma
l’humanitas è pensata come un modello universale fuori dalle possibilità concrete dell’uomo nel
6
7
8 Nei primi anni di lezione, quando ancora era un allievo del grande Husserl, Heidegger intesse una complicata
relazione con la filosofa Hannah Arendt, due personalità distanti, due caratteri opposti. Lei segue un corso su Agostino,
su cui ritornerà spesso e molto più tardi nella sue riflessioni filosofiche. In uno scambio epistolare Heidegger scrive alla
Arendt: non esiste l’amare, ma il tuo amare; non esiste l’amore ma il tuo amore. E richiamando Agostino prosegue
spiegando come l’essenza dell’amore che lei avrebbe per lui si potrebbe riassumere in un’unica proposizione: volo ut
sis, desidero che tu sia. Come si vede, il voler bene richiamato qui nella Lettera sull’Umanismo non ha nulla di
sentimentale o irrazionale, piuttosto coincide con il consegnare l’altro alla pienezza delle sue possibilità in quanto
esistente, fare spazio alla sua libertà affinché ne abbia cura e ancora lasciare che l’essere suo proprio sia responsabile
per un fare senso.
mondo, ovvero in un al di là pensato teoreticamente come contrapposto al di qua, o ancora come
pienezza immanente dell’umano, ma ancora una volta intesa come un universale sia esso storico o
sovrastorico. L’appello all’umanismo è dunque essenzialmente metafisico, cioè pensa l’essenza
dell’uomo come contrapposta alla sua esistenza, mentre invece l’essenza riposa nell’esistenza e
l’esistenza è la relazione all’essere come ciò rispetto al quale abbiamo il compito di fare e dare
senso, rispetto al quale abbiamo il potere dell’amare.
Pensare l’essenza dell’uomo significa, perciò, pensare la differenza tra essere ed ente, ovvero tra
l’orizzonte che abbraccia la nostra esistenza e gli oggetti che fanno parte del mondo. Ma pensare la
differenza tra essere e ente significa ancora pensare la distanza che intercorre tra ciò che ha valore
in sé, ciò che è degno di cura in quanto è, e ciò che viene valorizzato con un atto del pensiero e del
linguaggio, del fare o dell’usare, ovvero ciò a cui si consegna valore distogliendolo dal suo è. La
questione ontologica insomma è già di per sé una questione etica. La riformulazione della teoria del
valore e di cosa ha valore per l’uomo non può ripartire se non si è fatto chiarezza sulla struttura
metafisica di questo pensiero (cfr. 82-83).
Tra la critica alla metafisica e l’indicazione di un cammino da seguire in quella che Heidegger
definisce epoca del dominio della tecnica vi è quindi una relazione ben più che accidentale, dal
momento che la storia della metafisica viene a coincidere con l’epoca della tecnica. Noi abbiamo
appreso lungo il corso di queste lezioni che la tecnica caratterizza un modo di intendere la
conoscenza umana fin da Platone e Aristotel, figure chiave della filosofia occidentale, che hanno
fatto sentire le ripercussioni della loro visione dell’uomo e del mondo su tutto il pensiero che dopo
di essi è venuto. La scienza nel suo sorgere ha corroborato o estremizzato le posizioni degli antichi,
ma il nucleo più profondo resta legato alla modalità del pensiero e dell’espressione che la filosofia
ha consegnato alla storia. Per questo è necessario se si vuole ripensare l’essere ripensare anche il
linguaggio e forse provare a uscire dalla logica che ne è la forma essenziale. Ora, se la critica alla
metafisica restasse soltanto un momento di decostruzione sarebbe di un certo interesse dal punto di
vista storico, ma meno in senso filosofico. Heidegger, seppur con rimandi talvolta lievi e oscurati
senz’altro dalle sue vicende biografiche, ha indicato una via che certo necessita di essere
approfondita perché carente sotto tanti aspetti. Ma è una via che consegna al soggetto un posto nel
mondo non isolato dal mondo e dagli altri, ma intessuto fin dall’origine con gli uni e gli altri e
rimandato, tuttavia, a una ulteriorità che li contiene e li significa: l’essere.
Ebbene, la struttura più propria dell’esserci, ci dice Heidegger, chiama un potere della possibilità
che coincide con l’amare, con lasciar essere, eppure non vi è dubbio che lo spazio mondano che ci
circonda sia contrassegnato da una volontà di manipolazione e dominio che tenta di ridurre
l’interezza di ciò che è a prodotto dell’uomo, a uso dell’uomo – e può certamente farlo perché è
iscritto nella modalità fondamentale del suo essere al mondo usare l’ente –.
La tecnica, d’altra parte, è un destino. Ci incombe. Ma noi siamo allo stesso tempo nella possibilità
di disporci a questo destino. Non è in nostro potere certo cancellare o combattere il progresso della
scienza e della tecnica, ma possiamo ancora e sempre intendere la vita come ciò che si sottrae a
questo dominio, ovvero possiamo e dobbiamo comprendere che la vita nostra e altrui è libera, è in
nostro potere, ma non come ciò rispetto a cui tutto possiamo, ma come un orizzonte, finito nel
tempo ma infinito nelle possibilità, lungo il quale possiamo tracciare i solchi del senso. Perché il
fare senso – nelle azioni – e il dare senso – nel linguaggio – dell’essere è ciò che è in nostro potere.
La chiamata al fare e al dare senso è, in tal modo, chiamata alla responsabilità (responsus participio
passato di respondere), cioè invito a rispondere a un appello che ci precede. Un appello singolare
come lo è l’esistenza umana. Una filosofia che ‘opponga al dominio planetario della tecnica
l’inapparenza di un pensiero della meditazione e della riflessione’ – scriva Heidegger alla fine degli
anni sessanta – sembra ben poca cosa. Incapace di influire per davvero, incapace di cambiare.
Eppure è solo nella mobilitazione dei singoli che le trasformazioni sono possibili. Questa via non è
una semplice sottrazione alla tecnica, ma un invito a non fare della tecnica l’unico strumento di
relazione al mondo, ovvero di intenderla come non totalmente pervasiva seppure mondialmente
dominante9.
L’invito, dunque, che chiude la Lettera sull’Umanismo solo a un’interpretazione estrinseca suona
poetico o idealistico, ma a ben guardare esso è inserito nella pienezza di un percorso filosofico che
ha sempre fatto dell’esistenza singolare e della sua possibilità di dare senso un nucleo speculativo
principale: ‘Il linguaggio è la casa dell’essere così come le nuvole sono le nuvole del cielo. Con il
suo dire il pensiero traccia nel linguaggio solchi poco vistosi. Essi sono ancora meno vistosi dei
solchi che il contadino, a passi lenti, traccia nel campo. l’uomo non è il padrone dell’ente, ma il
pastore dell’essere’.
9 Un piccolo inciso sulla differenza di vedute tra Heidegger e Popper: «È inevitabile che sulla nostra Terra
sovrappopolata noi facciamo permanentemente tutti gli errori ecologici possibili, ed è innegabile che vigilare è
necessario; potremmo allora fare un buon uso di qualcosa come un movimento verde razionale. Ma è altrettanto chiaro
che in questo campo non si ottiene nulla senza l’aiuto delle scienze naturali e della tecnica». Questo il punto di avvio di
Karl Popper nel saggio Tecnologia ed etica (Rubbettino). Se pertanto è ragionevole pensare che i danni provocati da un
utilizzo non di rado prevedibilmente sconsiderato della tecnica possono e debbono in primo luogo e soprattutto venir
affrontati, nello sviluppo della ricerca scientifica, da ulteriori innovazioni tecnologiche, è anche vero, prosegue Popper,
che le esagerazioni dei Verdi dinanzi ai rischi ecologici – pur necessarie «per dare una scossa al mondo» – «sono assai
pericolose e hanno portato [...] a peggiori abusi». E qui Popper – siamo nel 1991 – viene al suo primo problema,
chiedendosi perché mai in Germania l’ostilità dei Verdi alla tecnica e alla scienza della natura sia tanto grande, mentre in
altri Paesi ha un ruolo, quando lo ha, del tutto insignificante. Alle radici dell’atteggiamento antiscientifico e
antitecnologico dei verdi tedeschi Popper scorge il pensiero di Heidegger: «È stata l’incomparabile fama mondiale di
Heidegger a conferire una certa autorità all’attacco verde alla tecnologia e alle scienze in Germania». Per Heidegger la
metafisica da Platone e Aristotele a Hegel e fino allo stesso Nietzsche avrebbe pensato l’essere sul modello dell’ente. Ma,
così, la metafisica è in realtà una "fisica" assorbita dalle cose e che ha obliato l’essere conducendo all’oblio di questo
oblio. Platone avrebbe degradato la metafisica a fisica capovolgendo il rapporto tra essere e verità: questa starebbe nel
pensiero che giudica e non più nell’essere che si dis-vela (verità come aletheia) all’uomo. In tal modo l’uomo, che
dovrebbe essere il «pastore dell’essere», si è trasformato in «padrone dell’ente», e questo proprio in forza di quella fisica
che si è presentata come metafisica. La svolta data da Platone al concetto di verità e con ciò il destino della metafisica
spiegherebbero, pertanto, il destino dell’Occidente con il primato della tecnica nel mondo moderno. La tecnica non è uno
strumento neutrale nelle mani dell’uomo né essa è un evento accidentale dell’Occidente. Per Heidegger, la tecnica è
l’esito scontato di quello sviluppo per cui l’uomo, obliando l’essere, si è lasciato travolgere dalla «volontà di potenza»,
rendendo la realtà e se stesso puro oggetto di un gigantesco "apparato" tecnologico. Ed è sullo sfondo del pensiero di
Heidegger, che si insiste sul fatto che la civiltà occidentale non conoscerà salvezza se non diventerà consapevole del suo
atteggiamento sbagliato nei confronti dell’essere, della realtà. Il mondo occidentale è un mondo costruito sulla
manipolazione delle cose, e dunque sull’idea che le cose siano trasformabili, prive di una propria consistenza, prive di
essere, ridotte a niente. Senonché siffatta riduzione delle cose a niente riduce l’uomo stesso a cosa manipolabile – oggetto
del potere politico o, per esempio, dell’ingegneria genetica – e porta alla devastazione selvaggia dell’ambiente naturale.
In questo modo, il problema della tecnica diventa il rifiuto della tecnica. E il rifiuto della tecnica (con il rifiuto dei suoi
presupposti "fisici" e "metafisici") si trasforma nella condanna e nel rifiuto della tradizione scientifica occidentale. Ma qui
Popper non esita a mettere le carte in tavola: «Io ritengo Heidegger un impostore, un falsario, e lo disprezzo perché lo
ritengo un vile e un opportunista. La sua fama mondiale è uno scandalo per la filosofia, sia tedesca o internazionale».