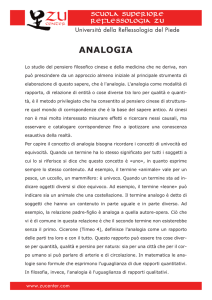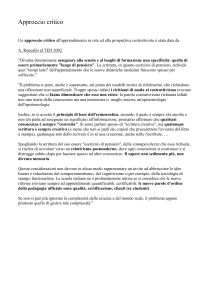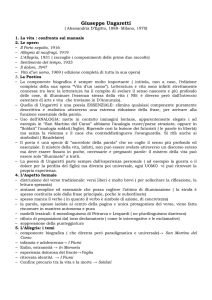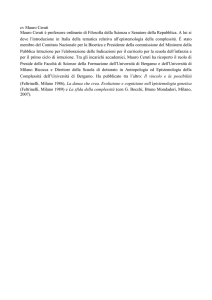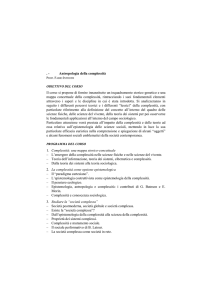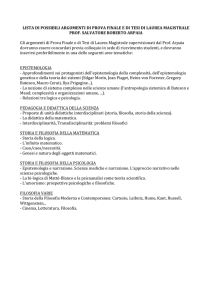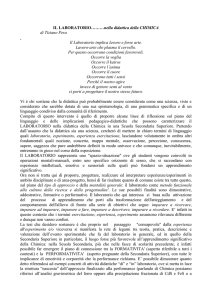ALESSIA SOLERIO
UN’ARCHEOLOGIA DEL PENSIERO ANALOGICO (O PROPORZIONALE)
Con questo intervento vorrei provare a portare in superficie una di quelle tracce che, volenti o nolenti,
ci formano e che costituiscono un aspetto irrinunciabile del nostro stare al mondo. Finora, tra
laboratoristi, abbiamo esplorato tratti fortemente visibili da un punto di vista culturale: il
cristianesimo, la mentalità scientifica, l’eredità greca, la logica che governa il pensiero. Accanto a questi
inalienabili momenti della storia d’occidente, alcuni sentieri hanno perso il diritto di emergere alla
soglia della consapevolezza, della teorizzazione intenzionale e della dignità scientifica; ma non per
questo ci animano e ci formano in misura minore e, come lascia intendere la letteratura
psicopatologica, quel che è rimosso dalla dimensione cosciente costituisce un fattore antropopoietico
altrettanto importante che, in assenza delle misure appropriate, sfiora i limiti del demoniaco.
Affiancandomi all’intervento di Stefania sulla chiusura logicistica della Grecia antica, vorrei proporre ai
laboratoristi di esplorare l’altra faccia della medaglia, ossia la grande rimozione che tale chiusura ha
decretato sul pensiero cosciente: quella del pensiero analogico. In filosofia, il metodo che permette di
risalire le rimozioni, inevitabilmente prodotte da una storia scritta in prospettiva parziale, si dice
archeologico. L’archeologia assomiglia ad una regressione psicoanalitica condotta non nella psiche
individuale, ma in quella, per così dire, collettiva o, in altri termini, nel sistema di conoscenza: è un
metodo congetturale che permette di regredire dalle nevrosi concettuali che incastrano il pensiero
negli stessi giri stereotipati, ai traumi gnoseologici che ne hanno decretato la fissazione; dai concetti
statici, cristallizzati in un rigido sistema semantico, al sostrato metaforico originario da cui sono
derivati, dinamico e plurisignificante, e di cui si è persa la traccia; dalle parole ingabbiate nello scritto
agli eventi evanescenti e sonori che caratterizzano l’oralità; e così via. Il fine dell’archeologia è liberare
il pensiero da ciò che lo condiziona tacitamente e di portare in luce quanto è dato per scontato, e
quindi è impercettibile, entro un punto di vista specifico. Non è comunque questa la sede in cui trattare
l’archeologia da un punto di vista teorico; più rilevante è casomai indicare alcune delle fonti principali
da cui muove la nostra regressione, le quali consentiranno di contestualizzare i nodi critici della
questione a livello epistemologico e di segnalare le connessioni tra il pensiero analogico,
un’epistemologia di ispirazione anarco-antropologica e una genealogia delle scienze della psiche.
COORDINATE BIBLIOGRAFICHE
Il sito in cui ci troviamo in questa breve esplorazione sta all’incrocio fra tre testi a prima vista piuttosto
distanti quanto a contenuti trattati, metodologia e ambito di ricerca, ma che, una volta accostati, si
incastrano come i pezzi di un puzzle. Ve li presento nell’ordine in cui sono entrati nella mia esistenza.
Il primo e il più recente testo tra i tre è Contro il metodo. Abbozzo di una teoria anarchica della
conoscenza (1975) di Paul Feyerabend, un epistemologo austriaco che fu allievo di Popper e che criticò
tanto il falsificazionismo del maestro, quanto il verificazionismo dei neopositivisti. Inserendosi nel
dibatto sull’ideale di un metodo scientifico universale, ricamato a partire da quello delle scienze
naturali, Feyerabend demolisce uno alla volta i principi metodologici che la filosofia della scienza ha
isolato riflettendo sulla conoscenza scientifica (ad esempio, la coerenza delle teorie, la loro
compatibilità con i fatti, etc.) mostrando che, a livello pragmatico, gli scienziati agiscono in modo
creativo e anti-conformistico e che quindi la scienza è un impresa essenzialmente anarchica. Asserire
l’anarchismo della pratica scientifica non equivale però a conclamarne un dilagante disordine, anche
se il nostro autore sottolinea il ruolo dell’irrazionalità nell’impresa scientifica; significa, al contrario,
discendere dal piano semantico della razionalità normativa a quello pragmatico del senso esistenziale
(e del non senso), in cui i suddetti principi svaniscono nella loro aleatorietà. L’anarchismo è il
manifesto dadaista dell’epistemologia, destinato a esprimere tanto l’interesse umanitario che viene a
mancare nella scienza dogmatica, quanto l’impulso creativo soffocato da ogni ideale di razionalità
imposto dall’esterno.
Innanzitutto, Feyerabend evidenzia come non esistano “fatti scientifici” in senso stretto, dati
sperimentali suscettibili di una lettura univoca, poiché ogni osservazione è costituita da ideologie
anteriori, spesso inconsapevoli, ma fortemente vincolanti. L’osservazione, proclamata neutrale e
irrevocabile dai neopositivisti, che tentano di ricondurre il linguaggio teorico a quello empirico, a loro
avviso universalmente condiviso, non è però mediata dalla teoria (theory laden), come
fraintenderanno altri autori successivi, ma da fattori antropopoietici inespressi che ci strutturano
dall’interno e che sfuggono ai confini del pensiero teorico; potremmo dire che l’osservazione sia poetry
laden, ossia carica di poetica (tradendo un po’ il nostro autore, che non si esprime affatto in questi
termini, ma predilige casomai la provocazione).
Feyerabend chiama interpretazioni naturali quelle abitudini linguistiche e percettive che conseguono
dalla dimensione del senso e che strutturano dall’interno ogni osservazione culturalmente specifica.
Nel passaggio dalla scienza aristotelica a quella galileiana, ad esempio, il mutamento radicale riguarda
proprio le interpretazioni naturali che intervengono nell’osservazione del fenomeno del moto.
L’argomento della torre, usato dagli aristotelici per confutare il moto terrestre (lanciando una pietra
da una torre, essa cade perpendicolarmente: quindi la terra non si muove), è interpretato da Galileo
come un moto solidale del sasso con la terra, così come avviene all’interno di una nave. Le
interpretazioni naturali vengono modificate in modo silente nel passaggio da una cosmovisione
all’altra poiché costituiscono dall’interno la prospettiva stessa, l’orizzonte di senso entro il quale
andranno a cristallizzarsi i concetti.
A partire dal punto di vista che costituiscono, le interpretazioni naturali possiedono due tratti
caratteristici. In primo luogo, le interpretazioni naturali sono indubitabili, non perché saltano
immediatamente agli occhi come vere, ma perché sono incorporate nell’agire umano culturalmente
specifico e forniscono le condizioni pragmatiche di esprimibilità del gioco linguistico a cui danno un
senso. In secondo luogo, le interpretazioni naturali sono invisibili poiché, così come l’occhio non vede
sé stesso, sono incorporate nel punto di vista che instaurano e dunque sfuggono all’orizzonte
percettivo che esse stesse sondano. Per mettere a fuoco le interpretazioni naturali occorre uscire da
punto di vista che codificano e di cui costituiscono la metaforica di sottofondo, rispetto al quale sono
impercettibili ed indubitabili: esse acquisiscono evidenza solo se messe in contrasto mediante un
sistema di pensiero alternativo. Qui entrano in gioco due concetti altamente rilevanti, i quali portano a
connotare l’anarchismo epistemologico di Feyerabend in senso antropologico: quello di
“incommensurabilità” e quello di “contro-induzione”. Per mettere a fuoco le interpretazioni naturali
occorre, infatti, scontrarsi con un’alterità radicale:
abbiamo bisogno di un modello di critica esterno, abbiamo bisogno di un insieme di assunti alternativi o, dal
momento che questi assunti saranno del tutto generali, di costruire, per dir così, un intero mondo
alternativo, abbiamo bisogno di un mondo di sogno al fine di scoprire i caratteri del mondo reale in cui
pensiamo di vivere (Feyerabend 1975, 28).
Incommensurabile significa radicalmente altro: questo concetto non può essere introdotto con una
semplice definizione, ma chiede la presentazione di casi concreti per renderne perspicuo il senso.
Poiché tutta la nostra esplorazione sarà dedicata all’incommensurabilità tra il pensiero logico e quello
analogico, per ora sorvoliamo sulla questione; in seguito gli esempi abbonderanno.
La contro-induzione è un metodo creativo introdotto da Feyerabend per svincolarsi dalle chiusure
sistematiche che solitamente affliggono la filosofia della scienza: essa consiste nell’inventare sistemi di
pensiero alternativi a teorie ben confermate e ipotesi contraddittorie con fatti ben stabiliti, o nel
prendere sul serio le testimonianze antropologiche di altre realtà incommensurabili alla visione
scientifica delle cose. Un esempio estremo: il dottor Faustroll, personaggio patafisico fuoriuscito dalla
mente di Alfred Jarry, oppone all’ipotesi di una forza di gravità che attira i pesi verso il centro, quella di
un fluire inarrestabile del vuoto verso la periferia, togliendo la coltre di ovvietà emanata da un
concetto scientifico consolidato!
Il fine della contro-induzione è rendere evidenti le interpretazioni naturali, le quali richiedono un
punto di vista esterno, essendo invisibili come l’acqua del pesce di Lindton. Incommensurabilità e
contro-induzione sono i presupposti che consentono a Feyerabend di introdurre, precorrendo Latour,
il metodo antropologico in epistemologia: vale a dire l’atteggiamento che, invece di squalificare
l’alterità a partire da un’ideale astratto di scientificità, da una conquista parziale e dogmatica di verità
e da un’imposizione unilaterale di conoscenza, ne sfrutta la retroazione, per mettere in luce quanto è
dato per scontato nel proprio modo specifico di stare al mondo. La contro-induzione assomiglia a tal
proposito allo scandalo antropologico dell’etnocentrismo critico di De Martino. L’analisi demartiniana
del mondo magico, invece di squalificare il magismo a pallida credenza, appellandosi al naturalismo
implicito alla cosmovisione scientifica, riesce a rendere costruttivo il feedback antropologico e a
riconoscere nel proprio modo di guardare e di descrivere l’alterità alcune categorie inconciliabili con il
dramma del magismo. Lo scandalo antropologico svela che la categoria di “realtà”, intesa come piano
di datità naturale i cui estremi sono un mondo deciso e garantito e un individuo atomico altrettanto
fatto e finito, sia una “categoria giudicante”, la cui relatività storica può essere resa evidente solo
mediante lo scarto che ci separa dall’alterità. La contro-induzione, al pari dello scandalo antropologico,
permette di individuare quelle abitudini linguistiche e percettive non suscettibili di critiche dirette, in
quanto invisibili dall’interno del proprio punto di vista, come le categorie di realtà e individuo rispetto
il fenomeno del magismo.
L’anarchismo introduce lo sguardo errante dell’antropologo in epistemologia e costituisce un antidoto
salutare contro ogni chiusura sistematica della conoscenza: invece di reagire alle contraddizioni
veicolate da punti di vista alternativi con squalifiche dogmatiche ed etnocentriche, ne sfrutta la
retroazione, relativizzando il punto di vista indossato, e così obbliga a mantenere aperti i sistemi di
pensiero.
Feyerabend fa però una cosa piuttosto sospetta da un punto di vista epistemologico, che rischia di
essere tacciata di irrazionalità: invece di arretrare dinanzi ad una contraddizione, squalificando come
superstizione le posizioni teoriche inconciliabili con la conoscenza scientifica, sfrutta il valore
antropologico insito nell’alterità radicale per mettere in luce i fattori antropopoietici e costitutivi del
punto di vista dominante. In generale, anche solo nell’affiancare antropologia ed epistemologia si
genera una contraddizione. L’epistemologia ricerca il fondamento normativo della conoscenza:
l’episteme è la conoscenza fondata in contrapposizione alla doxa, l’opinione mutevole; epi istemi
significa “stare sopra”, “tenersi saldi ad una verità stabile” ed è in contrasto ad esempio con l’ex stasi,
l’“uscire fuori”, l’estasi velata di irrazionalità e tecnica di impalpabili conoscenze sciamaniche.
L’epistemologia implica sempre una linea di demarcazione tra ciò che è fondato, razionale e
giustificato e ciò che non lo è e convoglia in sé l’obbligo di squalificare a opinione soggettiva quanto
non sia conforme ai suoi criteri di scientificità. L’antropologia, al contrario, ci offre le innumerevoli
varianti culturali del sapere, prescindendo, nella misura in cui è critica, da ogni ideale precostituito di
conoscenza. Le esigenze delle due discipline sono quindi in contraddizione e occorre un delicato
equilibrio per renderne “umano” il dialogo, evitando il rischio di sottomettere l’antropologia alle
esigenze dell’epistemologia, inglobandola in una muta alleanza al progetto di modernizzazione del
mondo e del sapere.
L’epistemologia è una disciplina che tende alle chiusure sistematiche; essa ha quindi difficoltà a
rendere costruttivo il dialogo con l’antropologia poiché, invocando il dualismo tra conoscenza
oggettiva e opinione soggettiva, tende a squalificare come superstizioni le variegate testimonianze di
saperi-altri che l’antropologia ci offre.
Abbiamo trovato nello spazio analogico esplorato da Enzo Melandri un luogo in cui il dialogo tra
antropologia ed epistemologia diventa possibile e produttivo per entrambe le discipline. Pur non
tematizzandolo esplicitamente, Feyerabend fa largo uso del pensiero analogico, poiché esso è un modo
del pensiero che si rivela indispensabile nel confronto di incommensurabilità. L’affinità tra Melandri e
Feyerabend, nel modo in cui agguantano il dogmatismo epistemologico per relativizzarlo, è forte al
punto da consolidarsi in un’equivalenza semantica. La contro-induzione di Feyerabend, il metodo
finalizzato a costituire sistemi di pensiero alternativi, in contraddizione con la conoscenza acquisita,
per metterne a fuoco la poetica di sottofondo, è un procedimento che non appartiene al pensiero
logico, rispetto al quale risulta irrazionale per l’uso che fa delle contraddizioni, ma a quello analogico.
In particolare, la controinduzione è analoga dal punto di vista del funzionamento con quella che
Melandri chiama la funzione derazionalizzante dell’analogia.
L’analogia ha le sue proprie tautologie che, pur essendo come tali altrettanto razionali che quelle in senso
stretto logiche, possono tuttavia costituirsi in sistemi alternativi rispetto a queste ultime (Melandri 1968, 47)
La funzione de-razionalizzante dell’analogia o, più carino, la sua funzione antropologica, concerne la
possibilità di far girare il pensiero su principi opposti e complementari rispetto a quelli logici; ne
consegue una cosmovisione incommensurabile rispetto a quella ereditata dall’epistemologia.
In generale, la logica funziona all’interno di un sistema di pensiero come controllore della coerenza
degli usi linguistici e della correttezza inferenziale; l’analogia, al contrario, permette la mediazione tra
due o più sistemi di pensiero, o di conoscenza, senza inciampare in indesiderati riduzionismi, come
implicito nella forma della proporzione: “a sta a b come c sta a d”. Ad esempio, nell’introduzione all’I
Ching, Jung sfrutta le potenzialità del pensiero proporzionale per introdurre la mentalità cinese nella
sua radicale alterità rispetto a quella occidentale: invece di squalificare la predittività dell’oracolo
ricorrendo ai preconcetti della fisica, lo psicologo afferma che “la causalità sta alla scienza come la
sincronicità sta alla conoscenza cinese”, indicando ciò che ha valore per le rispettive forme di vita: la
regolarità degli eventi VS la loro coincidenza. Il dogma della causalità impedisce di cogliere il senso
dell’oracolo divinatorio perché il lancio delle monete non è causalmente connesso con il futuro;
mentre, per la mentalità cinese, il lancio, effettuato in un preciso istante dell’esistenza, essendo in
armonia o in coincidenza con essa, ne costituisce una traccia interpretabile.
Se dunque l’epistemologia si fonda su un ideale logico del pensiero, tramite l’analogia possiamo
sopperire alla chiusure sistematiche che tale ideale impone e, attraverso il feedback antropologico,
mettere a fuoco le interpretazioni naturali che costituiscono la poetica del pensiero logico. L’analogia
introduce il metodo antropologico in epistemologia in modo ancor più profondo rispetto l’anarchismo
di Feyerabend, poiché in quest’ultimo l’incommensurabilità si dà al livello dei sistemi di conoscenza,
mentre in Melandri l’alterità radicale riguarda proprio i principi formali che sorreggono il pensiero.
Il nostro centro di gravità è quindi costituito dall’abissale La linea e il circolo. Studio logico-filosofico
sull’analogia (1968), un’opera variegata e complessa di quasi mille pagine, tutte dedicate al pensiero
analogico. Data la monotematicità dell’argomento, ci si può attendere un inventario enciclopedico
sull’analogia, noioso ed estenuante; invece, il testo di Melandri assomiglia più ad un romanzo di
avventura (con un po’ di fantasia!). L’autore, usufruendo dell’analogia come di una time machine, ci
accompagna in un viaggio a ritroso nel tempo filosofico, permettendoci di assistere ai dibattiti di tempi
remoti mediante l’artifizio della partecipazione simpatetica: con lo spirito dell’antropologo
demartiniano, o dell’anarco-epistemologo, Melandri porta sì con sé il proprio bagaglio concettuale o,
direbbe de Martino, la propria ombra culturale; ma aperto e disponibile com’è allo spaesamento,
riesce a rendere costruttivo il feedback antropologico e a sfruttarne la radicale alterità per mettere a
fuoco i tratti invisibili ed etnocentrici che connotano la modernità. Questo atteggiamento di umiltà
etnografica è indispensabile per recuperare il senso originario dell’analogia, al di là delle squalifiche e
dei riduzionismi che l’hanno afflitta nel corso della storia del pensiero d’occidente, impedendo oggi di
coglierne la frattale complessità.
A partire dall’ideale logico di razionalità che si è cristallizzato nella Grecia antica e che ha continuato, a
esercitare il proprio governo sull’epistemologia d’occidente, il pensiero analogico emerge come
primitivo, pre-logico e irrazionale. Melandri dunque torna alla filosofia antica, sospendendo il
pregiudizio logicistico della conoscenza. Invece di assumere la logica come criterio normativo per
discriminare ciò che razionale da ciò che non lo è, egli esplora l’illogico per mostrare come i suoi
confini non coincidano con l’irrazionale; l’illogico contiene un momento pragmatico di razionalità che,
per essere colto, richiede una modalità di pensiero non-logica. Ammettere che la logica e la razionalità
non coincidano senza scarti è solo l’ingresso nella dimensione del pensiero analogico. Riconosciuta la
potenzialità del razionale illogico, rimane ancora da vedere come la logica, burattinaia invisibile,
muova i fili del nostro pensiero.
Sia chiaro fin dall’inizio: non ci interessa qui fare una rivalutazione sentimentale dell’analogia,
finalizzata a dimostrarne la misconosciuta razionalità! Oltre all’indesiderato intento scientista di tale
proposito, il tema stesso dell’analogia ne uscirebbe tradito. L’analogia è un modo del pensiero che ha sì
un’intrinseca razionalità, incommensurabile rispetto a quella logica, ma essa è sempre esposta al
rischio di una degenerazione nell’irrazionale, nel regresso all’infinito e nella circolarità. Occorre invece
recuperare il senso proporzionale implicito in ogni analogia, il quale è stato compromesso,
dall’antichità ai giorni nostri, dalle norme logicistiche della conoscenza. Perdendo il senso
proporzionale dell’analogia si finisce per ammettere come legittime analogie sproporzionate, come nel
caso dell’esportazione del modello evolutivo in ambito storico o sociologico. Ci interesserebbe, al
contrario, scrivere una storia dell’analogia: ma questa impresa, oltre che inutile (che senso avrebbe
fare un inventario degli usi dell’analogia che sono stati fatti nella storia del pensiero?), è ostacolata dal
fatto che l’analogia è stata estromessa dal pensiero cosciente ad opera di un feedback normativo
esercitato dal monopolio della logica sul pensiero; occorre dunque farne una “storia critica” che sia in
grado di risalire le rimozioni o, in altri termini, un’archeologia.
Ma dove sta il problema dell’analogia? L’essere umano fa uso di analogie da tempi immemori
(parrebbe, per quanto concerne il cammino d’occidente, dalla lirica arcaica, almeno secondo il filologo
che introdurremo a breve, autore del terzo testo) e, di certo, essa non costituisce uno dei contenuti
rimossi dal pensiero cosciente, tant’è che la possiamo nominare, ne possiamo parlare e, soprattutto, ne
possiamo fare uso e consumo. Il fatto è che la rimozione dell’analogia non concerne la sua funzione, o
la possibilità di utilizzarla, bensì il rapporto che essa intrattiene con il pensiero teorico, in particolare
dinanzi a un ideale logico della razionalità, come quello che da Aristotele ai giorni nostri è stato
assunto dalla filosofia della conoscenza.
La rimozione dell’analogia dall’epistemologia è stata a tal punto tenace da rendere l’analogia un
impensabile del mondo moderno, nel senso in cui gli ibridi di Latour risultano impensabili a partire dal
dualismo natura/cultura su cui si articola la critica moderna: l’impensabile non è ciò che non è affatto
pensabile, ma è ciò che, in base ai concetti su cui si muove il pensiero, risulta pensabile solo al prezzo
di drastiche vivisezioni. L’analogia, al pari degli ibridi di Latour dinanzi al dualismo natura/cultura,
sfugge ai tagli concettuali su cui opera l’epistemologia contemporanea: quest’ultima, ad esempio,
separa categoricamente la materia e la forma della conoscenza, i contenuti empirici, molteplici e
sfuggenti, e il logos razionale che tenta di unificarli, mentre l’analogia abita proprio quel luogo di
transizione, oscuro ed impensabile, in cui si confondono la ragione e l’esperienza. Dividendo la ragione
dall’esperienza, l’epistemologia cristallizza l’analogia in due concetti statici che ne smarriscono il senso
proporzionale: l’analogia può essere intesa, prediligendo l’aspetto logico, come omologia strutturale,
nel senso in cui questa espressione è usata in biologia (eguaglianza di struttura), o come isomorfismo
sintattico, ossia come corrispondenza biunivoca degli elementi o delle proprietà appartenenti a due
classi o concetti; prediligendo invece il tratto empirico, l’analogia è declassata a relazione di
somiglianza (“a è analogo a b” come espressione sinonimica di “a è simile a b”), ed è così espunta da
ogni questione gnoseologica e riportata all’episteme rinascimentale pre-scientifica.
La logica che governa l’epistemologia esercita un feedback normativo sul pensiero analogico, sia a
livello concettuale, che a livello proposizionale. Per la logica è indispensabile che i concetti abbiano un
significato letterale univoco, altrimenti il sillogismo si arena nella fallacia del quaternio terminorum e
perde il proprio valore deduttivo; anche le inferenze della logica moderna (logica simbolica)
richiedono che uno stesso simbolo abbia sempre lo stesso significato, in ogni sua ricorrenza. I concetti
analogici sono invece metafore: essi comportano uno slittamento regolare dall’uso consueto di un
termine a un uso improprio poiché, trasferendo un termine di un dato sistema di pensiero ad un altro
ambito (ad es. il concetto di “campo” dalla fisica alla psicologia, con Kurt Lewin), il termine subisce una
variazione di significato, in quanto non verte più sullo stesso riferimento o sulla stessa classe di
fenomeni. Aristotele fu il primo ad escludere la metafora, e con essa l’analogia, dalla scienza, poiché
per la sua imprecisione semantica inficiava la teoria sillogistica. Ma ancora oggi l’epistemologia non
riesce ad ammettere che la scienza abbia una propria poetica e, qualora venga ammesso un ruolo
positivo della metafora, lo si ghettizza come momento pre-scientifico, appartenente al contesto della
scoperta, ma insignificante rispetto alle prove e alle giustificazioni razionali che consolidano la
conoscenza. In verità, tutti i termini tecnici delle scienze si sono cristallizzati a partire dagli usi
metaforici del linguaggio, attraverso un lento progresso di specificazione lessicale, di cui il concetto
finale costituisce solo la traccia ultimativa di un processo il cui senso complessivo sfugge. L’ostinazione
con cui l’epistemologia si oppone al tema di una metaforica scientifica impedisce di esplorare la
dimensione pragmatica della genesi dei significati.
Anche da un punto di vista proposizionale, le norme logiche generano una grave incomprensione del
pensiero analogico: λογος che oggi tendiamo a tradurre secondo i lessemi “ragione” o “discorso”,
significa la divisione matematica, ossia il rapporto, il quale si esprime nella predicazione di identità
(predicazione categorica): ‘a è b’ o ‘a sta a b’; άναλογία parola che oggi accogliamo con i significati
imprecisi della somiglianza o dell’omologia, significa invece la proporzione, ossia l’eguaglianza di due
logoi ο rapporti: ‘a sta in rapporto a b, così come c sta in rapporto a d’, oppure, ‘a/b = c/d’. Poiché nella
logica la proposizione standard è la predicazione categorica, ‘a è b’, costituita dallo schema “soggettopredicato”, assumere la logica come ideale normativo degli usi linguistici
fa pensare che l’analogia, la quale è invece a quattro termini, sia una specie di connessione esteriore,
superaddita e piuttosto vaga tra due proposizioni, ciascuna di due termini; mentre dovrebbe essere chiaro che
ogni proporzione costituisce da sola un’unica proposizione. Si tratta allora di una proposizione a quattro
termini, e non a due (Melandri 1968, 232)
Le grammatiche di logica e analogia si fondano su un’unità proposizionale differente: la predicazione
categorica e la proporzione; istituendo la predicazione categorica come norma proposizionale, la
proporzione non può più essere intesa nella sua totalità, ma viene scissa in due proposizioni atomiche,
estrinsecamente connesse, e se ne smarrisce la componente proporzionale.
Logica e analogia sono modi del pensiero che si fondano su principi opposti e complementari. In linea
generale, il pensiero logico procede in base a dicotomie radicali, sottomesse al principio di
contraddizione esclusa, e concepisce come esistenti solo quelle entità sorrette da un principio di
identità elementare. L’analogia, al contrario, in base al principio di di-polarità, traduce ogni dualismo in
una transizione continua e graduale tra due poli ideali, che non si oppongono più tra loro come termini
contraddittori, per cui l’ammettere l’uno equivale all’escludere l’altro, ma come termini contrari, in
eterno conflitto, sorretti da una relazione di proporzionalità inversa. Possiamo pensare al presupposto
di continuità tra psiche e cultura in etnopsichiatria e a come Devereux, introducendo il principio di
complementarità, sottolinei come la spiegazione psicologica e quella sociologica di un fenomeno
umano siano complementari, ossia inversamente proporzionali. Anche al principio logico di identità
elementare, per cui non si dà entità senza identità (no entity without identity, è uno slogan di Quine),
l’analogia oppone un contro-principio opposto e complementare, coerente con la grammatica
proporzionale: quello dell’identità funzionale. In una proporzione analogica, l’eguaglianza non
stabilisce un’identità tra due cose, ma tra due rapporti: l’identità analogica, espressa in modo
comparativo, è inafferrabile, poiché si basa sul confronto di entità appartenenti a forme di vita
differenti e richiede che ogni singolarità sia data entro l’orizzonte di senso che ne codifica il significato
esistenziale.
Ogni grammatica contiene una cosmologia: alle grammatiche differenti di logica e analogia
conseguono dunque due visioni del mondo incommensurabili. Così, il principio logico di identità porta
a una concezione atomica dell’esistente, inteso come punto-istante individuabile mediante coordinate
spaziotemporali, sempre identico a sé stesso. Mentre da un punto di vista analogico, l’esistenza si
trasforma in una grandezza intensiva, suscettibile di gradazione, secondo una transizione da un
minimo a un massimo di esistenza: non si tratta più, dunque, da un punto di vista ontologico, di fare un
inventario degli esistenti, discriminando ciò che esiste da ciò che non esiste in base al principio logico
di identità elementare, ma di trovare un’unità di misura per l’esistente, funzionale alle pratiche che
esso attiva e alle credenze che lo animano.
Allo stesso modo, in sede epistemologica, nel passaggio da un pensiero logico a uno analogico, si
produce un’analoga destrutturazione. Per ogni dualismo, prendiamo quello tra natura e cultura, non si
tratterà più di distribuire ogni entità in questi due grossi scatoloni, partendo dal presupposto che i due
poli del dualismo siano termini contraddittori (naturale = non-culturale) o, peggio ancora, di
vivisezionare ogni entità nelle sue componenti naturali e culturali, come accadeva agli ibridi di Latour;
ma si tratterà di trovare una misura per la naturalità delle scienze, o per la loro umanità (Latour ci
suggerisce la prima: la naturalità di una scienza risiede nel suo potere di mobilitare la natura; Melandri
la seconda, ma la trattazione è lunga e non sta in una parentesi). Né si tratterà più di stabilire dei
criteri normativi per discriminare univocamente la conoscenza oggettiva dalle credenze soggettive, in
base al principio logico di bivalenza tra vero e falso (vero = non-falso), ma di sostituire a questa
dicotomia una “logica del vero”, capace di restituire dignità ai saperi-altri. La conoscenza perde così il
suo valore simbolico, di rappresentazione oggettiva di fatti naturali, per acquisirne uno
sintomatologico: ogni conoscenza è un sintomo di verità rispetto alla realtà da essa stessa instaurata.
In generale, intrecciando il pensiero di Melandri e di Feyerabend, abbandonate dunque le distinzioni
categoriche e rifatte le proporzioni, l’epistemologia non sarà più una disciplina normativa, che assume
come metro universale la conoscenza occidentale rispetto al quale valutare gli altri sapere, bensì
comparativa: essa non porrà più come oggetto una singola scienza, da elevare a modello normativo
della conoscenza, ma almeno un minimo di due o più scienze, o saperi-altri. L’oggetto di
un’epistemologia comparata, o antropologica, è un’incommensurabilità, e il suo modo privilegiato di
pensare è offerto dal pensiero analogico o proporzionale.
Il terzo e ultimo testo fondamentale della nostra regressione è La cultura greca e le origini del pensiero
europeo (1963) del filologo Bruno Snell, il quale costituisce l’effettivo punto di contatto tra il pensiero
di Melandri e quello di Feyerabend. Quest’ultimo alimenta, infatti, la sua trattazione principale del
tema dell’incommensurabilità con le analisi del filologo, mostrando la radicale alterità che ci separa
dalla Grecia antica e rendendo consistente quel concetto (incommensurabilità) che è un insulto per
l’epistemologia classica. Melandri, invece, trova due spunti nel libro di Snell: innanzitutto,
l’opposizione tra pensiero logico e pensiero analogico ha basi grammaticali molto accentuate, che il
filologo spiega in maniera affascinante, ripercorrendo i poemi dell’antichità e gli scritti filosofici più
arcaici; in secondo luogo, tra le tante linee genealogiche tracciate dal filologo nella Grecia antica, una
riguarda proprio il pensiero proporzionale.
Snell muove da una prospettiva neo-humboltiana, consapevole dell’influenza che la grammatica
esercita sul pensiero, ma ne mitiga il determinismo mantenendo una stretta aderenza alla
fenomenologia degli usi linguistici, dalla quale ricava tre forme enunciative originarie, onnipresenti in
ogni manifestazione linguistica della nostra eredità culturale: la modalità sostantivale, l’aggettivale e la
verbale..
Tutte e tre le forme enunciative, secondo Snell, si rapportano in un certo modo all’atto del confrontare.
Indicando le cose del mondo con dei sostantivi operiamo dei confronti, nel senso che, chiamando con il
nome “cavallo” diverse entità individuali, le riconosciamo, malgrado piccole differenze, come eguali. Si
formano per questa via i concetti, i quali costituiscono le categorie universali a cui sussumere le
singole entità individuali, come gli oggetti ai nomi comuni. Qui vige una logica binaria, del “si-o-no”,
poiché ogni x è un cavallo, oppure non lo è, tertium non datur: la logica conosce solo la bipartizione.
L’aggettivo, invece, ammette anche la dimensione della gradualità, poiché l’azzurro, che sfuma nel
verde e nel viola, può essere più-o-meno intenso. La gradazione di una qualità può essere fissata
mediante comparazione: bianco come la neve, più pallido dell’erba, veloce come un uccello. Se
l’aggettivo ha una propria logica, questa non può essere una “logica del nome”, poiché la qualità risalta
quando è contrapposta al suo contrario: essa, quindi, include l’escluso, come misura di sé.
Infine il verbo, più difficile da caratterizzare, rimanda ad una dimensione di “idealità” o “tipicità”: tra le
infinite attività possibili, caratterizziamo mediante verbi solo alcune modalità tipiche e ricorrenti – il
“sedere” e lo “sdraiarsi” a scapito di tutte le posizioni intermedie.
Il sostantivo, dunque, sta alla bipartizione, come l’aggettivo sta alla gradualità e il verbo sta alla tipicità
o idealità.
Tra queste tre forme non si dà divisione categorica, poiché sono ammesse ibridazioni tipologiche, ma a
seconda della prevalenza tematica che una di queste forme assume sulle altre, ne consegue una
“grammatologia” dominante, che governa il modo di pensare.
La chiusura logicistica porta in primo piano la semiologia sostantivale, con diverse conseguenze sia sul
piano della cosmologia, sia sul feedback normativo esercitato sugli altri modi dell’enunciazione. Ad
esempio, un’ontologia sorretta da una semiologia sostantivale porterà a intendere gli esistenti in
termini di identità atomiche ed elementari e a sottomettere gli usi aggettivali ad una logica nominale:
questo è quanto mai evidente nella “logica delle classi”, in cui i predicati sono intesi come insiemi che
contengono, come elementi, le entità che esibiscono quelle proprietà lì. Quest’uso presuppone una
logica nominale poiché, data una qualsiasi proprietà P e un qualsiasi individuo x, siamo costretti a dire
che “x è P” (x appartiene all’insieme P) o che “x non-è P” ( x non-appartiene all’insieme P), tertium nondatur. La logica delle classi rimuove la gradualità implicita a una semiologia autenticamente
aggettivale e sottomette i predicati ad una logica sostantivale, sorretta esclusivamente dalla
bipartizione.
Logica ed analogia sembrano presupporre, rispettivamente, una semiologia sostantivale ed una
aggettivale. La simmetria logica si esprime, infatti, mediante un’opposizione per contraddittorietà: dato
il ‘bianco’, il complemento per contraddittorietà (o logico) è ‘non- bianco’. Il rapporto che si genera è di
tipo monovalente, in quanto verte su uno stesso riferimento: il bianco. Una simmetria monovalente è
rigida e dicotomica poiché oppone sempre, per così dire, l’essere al non-essere e non ammette una
terza possibilità: tolto l’ambito di spettanza del nostro referente, tutto il resto del mondo ci appare allora
‘non-bianco’ all’infinito.
La simmetria analogica è invece tensionale e di-polare e si esprime mediante un’opposizione per
contrarietà: dato il ‘bianco’, il complemento per contrarietà non è più ‘non-bianco’ ma, poniamo, il
‘nero’. Il rapporto che si genera è di tipo bi-valente o, meglio, di-polare, in quanto i riferimenti sono due
termini differenti e appartenenti al medesimo genere (in questo caso appartengono al genere dei
colori). Tra termini contrari si produce un gioco di forze che possiamo descrivere come un’insanabile
conflittualità, mentre due termini in contraddizione stanno in una relazione di esclusione reciproca. Lo
svantaggio dell’opposizione per contrarietà è il suo essere approssimativa, poco precisa, in molti casi
indefinita: non è sempre possibile indicare il contrario di un dato termine e, anche quando lo troviamo,
è necessario indicare la misura comune che regge il rapporto (nel nostro esempio, scegliamo ‘nero’
come contrario di ‘bianco’, per l’opposizione di-polare tra un massimo e un minimo di luminosità). Ma
l’opposizione per contrarietà ha anche un’inestimabile vantaggio: essa contente una misura
dell’opposizione.
Supponiamo di dover descrivere una certa tonalità di grigio nei termini del ‘bianco’ e del suo opposto.
Se l’opposizione è di tipo logico (per contradditorietà), dobbiamo dire che l’oggetto in questione è nonbianco e basta. Ma se l’opposizione è di tipo analogico (per contrarietà), allora possiamo dire in che
misura non è bianco – poniamo, del 5%. Ma allora implicitamente diciamo sia che è bianco al 95%; sia
che è nero al 5%: nel grigio considerato, il bianco e il nero sono inversamente proporzionali.
L’opposizione per contrarietà si esprime nella forma “né A, né B”: il grigio in sé non è né bianco, né
nero; qui l’esistenza del bianco non esclude quella del nero, anzi la include come misura di sé.
Già da queste righe possiamo intendere come la chiusura logicistica della Grecia antica abbia portato
in primo piano una semiologia nominale e abbia sottomesso alle proprie regole grammaticali le altre
modalità enunciative. A noi però interessa l’altro lato della questione, ossia la rimozione del pensiero
proporzionale e della semiologia aggettivale che sottintende; qui Snell ci viene in soccorso, perché
percorre quel brevissimo istante della storia d’occidente in cui è emerso il pensiero proporzionale, per
essere poco dopo spodestato, con l’avvento dello scritto filosofico, logico e scientifico.
In base allo studio del filologo, si può dare una duplice collocazione archeologica all’emergere del
pensiero proporzionale: da un lato, esso si situa nel momento di transizione dal mito alla logica, e alla
formazione dei primi concetti di tipo scientifico; dall’altro, esso si forma progressivamente nel corso di
quel processo che il filologo indica come “scoperta dello spirito”, e che consiste nel ripiegamento
riflessivo della coscienza greca su se stessa che, gradualmente, viene a riconoscersi come unita e
individuale, separandosi così dal restante contesto naturale. Quella tra un mondo esterno ed una
individualità interna è forse la prima forma di incommensurabilità nella storia del pensiero filosofico
e, poiché assieme ad essa emerge anche il pensiero proporzionale, riteniamo che la forma della
proporzione costituisca il ponte comparativo indispensabile, grazie al quale è possibile mediare tra
forme di vita incommensurabili.
Da questo punto proseguirà la nostra esplorazione.