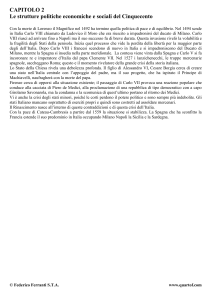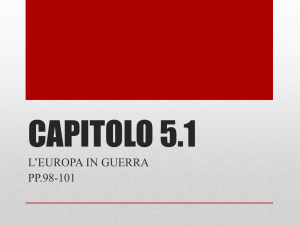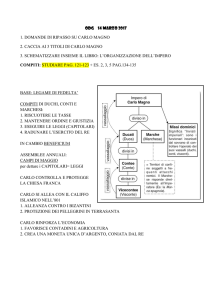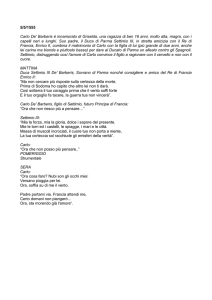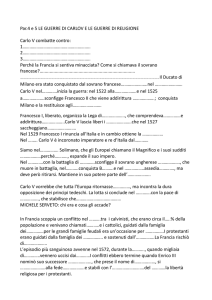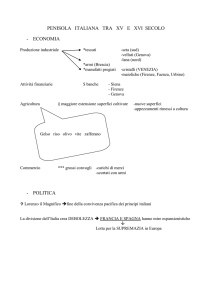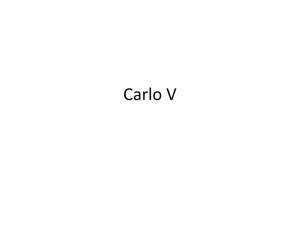Italian Warlords
of the Six ValoisValois-Habsbourg
Italian Wars
1521 - 1559
Dizionario Biografico degli Italiani and Wikipedia 2011
Ferrante e Alfonso d'Avalos. Malatesta IV e Rodolfo Baglioni. Prospero, Stefano, Ascanio e
Marcantonio Colonna. Francesco Maria I e Guidubaldo II della Rovere. Andrea e Giovanni Andrea
Doria. Francesco Ferrucci. Ferrante Gonzaga. Fabrizio Maramaldo. Giovanni, Cosimo e Giangiacomo
de Medici. Piero Strozzi. Emanuele Filiberto di Savoia
Avalos, Ferdinando Francesco d',
marchese di Pescara
(1489 - 1525)
Dizionario Biografico degli Italiani
di GG. De Caro
AVALOS, Ferdinando Francesco d', marchese di Pescara. - Nato a Napoli nel 1489 da Alfonso e da Diana de Cardona, e discendente,
quindi, da due tra le principali famiglie spagnole trapiantatesi in Italia, tutta la vita dell'A. fu improntata dalla fiera coscienza di queste
sue origini: egli si sentì sempre e volle essere considerato uno Spagnolo, e tenne costantemente verso gli Italiani, di cui si rifiutava
persino di parlare la lingua, l'altero disprezzo del conquistatore. La sua educazione fu quella tipica della nobiltà spagnola del tempo,
ispirata al culto degli ideali cavallereschi e feudali e indifferente ai valori della cultura umanistica italiana. Questa formazione dell'A.,
mentre fu di grande importanza per i suoi atteggiamenti politici, non impedì la felice riuscita del suo matrimonio (27 dic. 1509) con la
più notevole figura femminile della poesia rinascimentale italiana, Vittoria Colonna, alla quale era stato destinato sin dall'età di otto
anni dal re Ferrandino, che intendeva sancire con un vincolo di parentela i legami della potente famiglia romana con gli Spagnoli di
Napoli.
La parentela dell'A. con Raimondo de Cardona e con Prospero e Fabrizio Colonna gli aprì ancora molto giovane una brillantissima
carriera militare. Nel 1511 partecipò col Cardona, che era a capo dell'esercito spagnolo-pontificio, alla guerra contro il duca di Ferrara
e i Francesi, comandando un corpo di cavalleria leggera. Nella battaglia di Ravenna, l'11 apr. 1512, l'A. si distinse guidando una
furiosa carica di cavalleria contro le artiglierie di Alfonso d'Este, ma fu poi sopraffatto dalla più numerosa cavalleria francese, ferito e
preso prigioniero. Condotto a Milano, fu liberato alcuni mesi dopo per intervento di Gian Giacomo Trivulzio, che era suo parente. Il
Trivulzio pretese in cambio la promessa di non combattere più contro la Francia, ma l'A. già nel 1513 partecipava col Cardona, come
capitano della fanteria spagnola, alla campagna di Lombardia durante la quale conquistò Voghera e la sottopose a uno spaventoso
saccheggio in cui furono massacrati seicento cittadini. Passò poi agli ordini di Prospero Colonna nella campagna condotta nel Veneto
contro l'Alviano. Nella battaglia di Vicenza (7 ott. 1513) l'A., che comandava un quadrato di quattromila picchieri spagnoli, travolse il
quadrato veneziano di Babbone Naldi, assicurando così la vittoria dei collegati.
Questa campagna, in cui si trovavano di fronte i due più esperti condottieri del tempo, Bartolomeo d'Alviano e Prospero Colonna, fu
ricchissima di insegnamenti per l'A. che vi si addestrò a quella strategia logoratrice tipicamente italiana di cui egli stesso divenne poi
"la più alta e geniale espressione" (Pieri). Nel novembre 1515, in seguito alla conquista francese della Lombardia, ritornò a Napoli e
l'anno successivo ebbe dal viceré Cardona l'incarico di togliere il ducato di Sora al ribelle duca di Urbino Francesco Maria della
Rovere. La conquista della città fu compiuta dall'A. con un ardito impiego delle artiglierie fatte trasportare a forza di argani per quelle
impraticabili montagne. In seguito alla morte di Ferdinando il Cattolico l'A. si recò nel 1517 a Bruxelles a rendere omaggio al nuovo
sovrano in rappresentanza della nobiltà napoletana di parte aragonese. Per sé l'A., che era stato nominato il 29 luglio 1516 capitano
generale di tutta la fanteria dell'esercito d'Italia, otteneva la conferma del titolo marchionale di Pescara, di cameriere maggiore e di
consígliere del Collaterale, la contea di Loreto e la castellania di Ischia.
Alla ripresa della guerra contro la Francia, nel 1521, l'A. comandò la fanteria spagnola dell'esercito ispano-pontificio e partecipò
all'assedio di Parma: convinse Prospero Colonna e Francesco Guicciardini, commissario generale dell'esercito, che erano di contrario
parere, a rinunciareall'impresa rivelatasi pericolosa per il sopraggiungere da due diverse direzioni degli eserciti del Lautrec e di
Alfonso d'Este. Nel novembre dello stesso anno, posto l'assedio a Milano, l'A. a capo di un manipolo di archibugieri si impadronì del
bastione di Porta Romana permettendo l'ingresso nella città di tutto l'esercito spagnolo; quindi conquistò Como che mise a sacco. Alla
battaglia della Bicocca (29 apr. 1522) comandava il quadrato di fanteria imperiale costituito dagli Spagnoli, che con il fuoco efficace
dei loro archibugi misero in rotta gli Svizzeri, decidendo le sorti della battaglia. Il 4 maggio l'A. entrava in Lodi. Da Prospero Colonna
fu inviato quindi a Genova per stabilirvi la signoria di Antoniotto e Gerolamo Adorno. L'A. conquistò la città e la sottopose a un
saccheggio talmente efferato che, secondo una tradizione peraltro non del tutto attendibile, quando giunse a Genova Adriano VI, che
si recava a Roma per prendere possesso del soglio pontificio, il nuovo papa si rifiutò di concedergli l'assoluzione.
Alla morte di Prospero Colonna, nel dicembre 1523, l'A. assunse, insieme al viceré di Napoli Carlo de Lannoy e al connestabile di
Borbone, il comando dell'esercito imperiale. L'A. attaccò vittoriosamente l'esercito francese del Bonnivet a Robecco e a Romagnano e
l'inseguì sino ad Aosta. Passato in Provenza, si rifiutò di marciare su Parigi, come proponeva il Borbone, temendo di allontanarsi
troppo dalle basi imperiali e nutrendo scarsa fiducia nella collaborazione della popolazione promessa dal connestabile. Posto l'assedio
a Marsiglia, strenuamente difesa da Renzo Anguillara, dopo quaranta giorni dovette abbandonare l'impresa per il sopraggiungere del
potente esercito di Francesco I. Poiché l'armata francese, invece di rivolgersi contro gli imperiali, si affrettava ai valichi alpini per
entrare nella Lombardia indifesa, l'A. tentò di sventare la manovra con una precipitosa ritirata che non impedì però ai Francesi di
giungere per primi a Milano. Con un esercito stanco e numericamente inferiore all'avversario l'A. dovette rimanere in posizione
difensiva disponendosi a sostenere un urto decisivo a Lodi. Ma Francesco I non seppe profittare della situazione vantaggiosa e, in
attesa che l'opera dei suoi diplomatici riuscisse a staccare dagli imperiali gli alleati italiani, pose un infruttuoso assedio a Pavia.
L'A. si opponeva intanto al disegno del de Lannoy, preoccupato per la spedizione dell'Albany contro Napoli, di accorrere in difesa
dell'Italia meridionale: egli aveva chiara coscienza che le sorti del dominio spagnolo nell'intera penisola si sarebbero decise nella
pianura lombarda. Dopo settimane di attesa, durante le quali con una incessante opera di disturbo dell'avversario l'A. seppe
accortamente preparare all'esercito imperiale le migliori condizioni per lo scontro risolutivo, il 24 febbr. 1525, di fronte a Pavia, l'A.
sorprese Francesco I con una audace marcia notturna che portò l'esercito imperiale a ridosso del campo fortificato nemico. La sorpresa
impedì al re di Francia di coordinare l'azione dei propri reparti che furono affrontati e battuti separatamente dall'Avalos. Il trionfo,
insperato nelle sue proporzioni, stabiliva definitivamente la supremazia spagnola in Italia.
Le stesse dimensioni assunte dalla vittoria imperiale provocarono però la reazione degli stati italiani che si videro soffocati tra il
Mezzogiorno spagnolo e la Lombardia, dove il potere del duca di Milano non era più che un nome, in mano ai vincitori: ne nacque
quel complesso e laborioso tentativo che va sotto il nome del ministro di Francesco II Maria Sforza, Gerolamo Morone, e nel quale
l'A. ebbe una parte fondamentale.
L'iniziativa partì dalla Curia, soprattutto per impulso del datario Gian Matteo Giberti che progettò l'alleanza della Santa Sede, di
Venezia, Firenze, Genova, Lucca, Siena, Milano, con l'appoggio della Francia, per scacciare dall'Italia con un colpo a sorpresa gli
Spagnoli. Fu del Morone l'idea di chiamare a far parte del disegno l'A., che, considerato dopo la battaglia di Pavia il miglior
condottiero del tempo, avrebbe garantito, a capo dell'esercito dei collegati, la riuscita dell'iniziativa. Il Morone contava sul
risentimento dell'A. contro Carlo V e il de Lannoy, che aveva condotto in Spagna, nel giugno 1525, il prigioniero Francesco I e si era
presentato a corte come il vincitore della battaglia di Pavia. L'A., che aveva scritto vivacissime lettere di protesta a Carlo V, non aveva
ottenuto soddisfazione ed aveva visto ignorato anche il desiderio di essere insignonto della contea di Carpi in ricompensa delle
imprese compiute. Il Morone avvicinò l'A., offrendogli a nome di Clemente VII la corona di Napoli in caso di riuscita dell'impresa.
L'atteggiamento dell'A. fu estremamente incerto: alla luce degli avvenimenti posteriori molti contemporanei ritennero che sin dal
principio egli avesse stabilito di tradire il Morone, simulando di aderire alle sue offerte per poter con maggior sicurezza sventare il
complotto; e lo stesso A. spiegò poi in questo senso il suo ritardo nell'informare l'imperatore. In realtà la posizione dell'A. fu molto
più complessa: l'offerta di un regno lusingava troppo il suo orgoglio e la sua ambizione, pur se si trattava per l'A. di infrangere il
vincolo di fedeltà verso il suo signore e di incorrere in quel delitto di fellonia che nessuna ragione politica giustificava agli occhi dei
contemporanei. Di qui gli scrupoli che lo indussero a ricercare a Milano e a Roma il parere di illustri giuristi per sapere se "senza
maculare l'onore" potesse abbandonare il suo re. Da Roma i cardinali Cesi e Accolti diedero all'A. le più ampie assicurazioni,
sostenendo che come feudatario del Regno di Napoli egli era vassallo non dell'imperatore, ma del papa e pertanto "non solo poteva ciò
fare senza scrupolo di punto mettervi dell'onor suo, ma eziandio doveva, sì per ubbidire al Sommo Pontefice, e sì per acquistarsi
perpetuo titolo di liberatore d'Italia" (Varchi). Non dovevano tuttavia queste assicurazioni calmare i dubbi dell'A., tanto più che la
stessa Vittoria Colonna lo scongiurava a non mancare di lealtà verso il sovrano. Del resto l'impresa andava rivelandosi di sempre più
difficile attuazione, per i sospetti reciproci tra i vari stati italiani, e per l'orientamento, incline ad un accordo con Carlo V, assunto
dalla stessa reggente di Francia, Luisa di Savoia. L'A. comprese che un'ulteriore esitazione lo avrebbe compromesso definitivamente:
scrisse perciò a Carlo V, informandolo delle trattative intercorse col Morone e chiedendogli istruzioni (25 luglio 1525). Per mettersi al
riparo dei sospetti della corte mise al corrente della situazione gli altri esponenti della politica imperiale in Italia, il Borbone, il de
Leyva, il del Vasto, il de Naiera, con i quali decise, in attesa di istruzioni e rinforzi dalla Spagna, di continuare le trattative con il
Morone. Queste durarono tutta l'estate e l'A. riuscì a piu riprese ad ottenere dal Morone grosse somme di denaro, che gli erano
indispensabili per il pagamento delle truppe; ma nell'ottobre si decise a procedere all'arresto del ministro milanese. Questi, invitato
dall'A., con le più ampie assicurazioni, al campo di Novara, fu arrestato il 15 ottobre dal de Leyva. Agli Spagnoli venne offerto così il
pretesto per dichiarare la decadenza dello Sforza dal ducato di Milano. L'A. provvide subito ad occupare le fortezze di Cremona,
Trezzo, Lecco e Pizzighettone e ad entrare in Milano, richiedendo al popolo il giuramento di fedeltà all'imperatore e imponendo al
Senato di esercitare in nome di lui le sue funzioni.
Il giudizio dei contemporanei sull'A. fu pesante: mentre non riuscì a sottrarsi completamente ai sospetti della corte di Madrid, scrittori
e uomini politici italiani non gli risparmiarono il loro risentimento per quello che considerarono un tradimento della causa della libertà
italiana: così il Guicciardini, il Giberti, il Varchi, il Vettori. Questo giudizio è alla base anche dell'atteggiamento moralistico di alcuni
storici ottecenteschi e del primo Novecento, che fanno carico all'A. soprattutto del suo comportamento sleale nei riguardi del Morone,
considerato come una sua troppo ingenua vittima (cfr. Gioda, De Leva, Pandolfi). Come bene vide il Villari, invece, "sia il Pescara
che il Morone giocavano un doppio giuoco e n'erano consapevoli del pari". Il ministro milanese, che ancor prima della congiura
giudicava, come testimonia il Guicciardini, "non esser uomo in Italia né di maggior malignità né di minor fede" dell'A., non si
illudeva certo di poter contare su di lui se non nel caso che un felice esito del complotto aprisse all'ambizione del condottiero le più
grandi speranze; in caso di fallimento, invece, non soltanto il Morone era ben consapevole che l'A. lo avrebbe abbandonato ma egli
stesso era pronto a passare completamente dalla parte dell'imperatore, come in effetti accadde. Tuttavia il comportamento dell'A.
verso il Morone fu in tale contrasto con le rigide norme della morale cavalleresca nella quale egli era stato educato, che nel suo
testamento scongiurò l'imperatore di liberargliene la coscienza restituendo la libertà al ministro.
L'A. morì il 3 dicembre 1525, di tisi.
Fonti e Bibl.: L. Ariosto, Orlando Furioso,Canto XXXIII; G. Capra [G. Capella], Commentarii de rebus gestis pro restitutione
Francisci II Mediolani Ducis...,Venetiis 1535, passim;M. Du Bellay, Memoyres, Paris 1569, passim; Lettere di Principi, Venetia 1581,
pp. 170, 174 s.; U. Foglietta, Dell'Istorie di Genova..., Genova 1597, pp. 650 ss.; B. Ortiz, Descrizione del viaggio di Adriano VI...,
Roma 1790, pp. 52 e n., 55 s.; Batalla de Pavia y Prisión del Rey de Francia Francisco I...,in Colectión de documentos inéditos para la
historia de España,IX, Madrid 1846, pp. 406-486; Capítulo de carta de Lope de Soria à Carlos V, ibid.,XXIV,ibid. 1854, pp. 366 s.;
Cartas del Marqués de Pescara sobre la armada francesa..., ibid.,pp.385 ss.; Cartas del Abad de Nájera à Carlos V, ibid.,pp.42 s.;
Capítulo de carta del Abad de Nájera à Carlos V, ibid.,p.50; Quejas del marqués de Pescara, ibid.,pp.52-53; Historia de la Guerra de
Lombardia, Batalla de Pavia y Prisión del Rey Francisco de Francia, ibid.,XXXVIII,ibid. 1861, pp. 289-530; Captivité du Roi
Francois Ier,par M. A. Champollion-Figeac, Paris 1847, passim; Ricordi inediti di Gerolamo Morone, a cura di T. Dandolo, Milano
1855, passim; Lettere ed orazioni latine di Gerolamo Morone, a cura di D. Promis e G. Müller, in Miscell. di storia ital.,II,Torino
1863, passim; Documenti che concernono la vita pubblica di Gerolamo Morone,a cura di G. Müller, ibid., III, Torino 1865, passim;A.
Grumello, Cronicha,in Raccolta di cronisti e documenti storici lombardi inediti,a cura di G. Müller, I, Milano 1856, passim;M.Verri,
Relazione delle cose successe in Pavia dal 1524 al 1528, ibid.,II,Milano 1857, pp. 215 s.; B. Varchi, Storia fiorentina,a cura di A.
Racheli, in Opere,I,Trieste 1858, passim;D. Sauli, Autobiografia,a cura di G. Porro Lambertenghi, in Miscell. di storia
ital,XVII,Torino 1878, passim; Relazioni sull'assedio e la battaglia di Pavia inviate al marchese di Mantova,in C. Magenta, I Visconti
e gli Sforza nel Castello di Pavia,Milano 1883, II, pp. 542-553; Carteggio di Vittoria Colonna,a cura di E. Ferrero e G. Müller, Milano
1889, passim; Diario inedito dell'assedio e della battaglia di Pavia...,a cura di A. Bonardi, Pavia 1895, passim;I.Nardi, Istorie della
città di Firenze,Firenze 1888, I, pp. 400, 403; II, pp. 52, 53, 83-85, 88, 89, 94-98; F. Guicciardini, Storia d'Italia,a cura di C. Panigada,
Bari 1929, III, pp. 187, 189-191, 268, 279; IV, passim;V, pp.6, 48, 285; Id., Scritti politici e Ricordi, a cura di R. Palmarocchi, in
Opere,VIII, Bari 1933, pp. 151, 189, 203, 245, 305; IX, ibid. 1936, p. 276; P. Giovio, Le vite del Gran Capitano e del Marchese di
Pescara,a cura di C. Panigada, Bari 1931; J. E. Martinez Ferrando, Privilegios otorgados...,Barcelona 1943, nn. 202-215, pp. 25 s.; F.
Vettori, Storia d'Italia dal 1511 al 1527,in Arch. stor. ital., Appendice,VI, pp. 354, 357 ss.; G. M. Burigozzo, Cronaca di Milano,in
Arch. stor. ital.,1842, pp. 434, 448, 449; G. De Leva, Storia documentata di Carlo V in correlazione all'Italia,II,Venezia 1864,
passim;G. E. Saltini, Girolamo Morone,Firenze 1868, passim;C.Magenta, I Visconti e gli Sforza nel Castello di Pavia,Milano 1883, I,
passim;C. Gioda, Girolamo Morone e i suoi tempi,Torino-Roma-Milano-Firenze 1887, passim;A. Reumont, Vittoria Colonna
marchesa di Pescara,Torino 1892, passim;L. Beltrami, La battaglia di Pavia illustrata negli arazzi del marchese del Vasto,Milano
1896; T. Pandolfi, G. M. Giberti e la libertà d'Italia, in Arch. d. R. Soc. romana di storia patria, XXXIV (1911),pp.196 ss.; L. v.
Pastor, Storia dei Papi, III, Roma, 1612, p. 674; IV, 1, ibid. 1908, pp. 314, 319 s.; IV, 2, ibid. 1912, pp. 41, 135, 172 ss., 190 ss., 209;
G. Pasolini, Adriano VI,Roma 1913, p. 39, e n.; P. Villari, Niccolò Machiavelli e i suoi tempi,II, Milano 1913, p. 162; III, ibid. 1914,
pp. 27, 797-299, 304-314, 316 s.; B. Croce, Storia del Regno di Napoli, Bari 1925, pp. 105 s., 343, 346; G. Agnelli, Lodi e il suo
territorio, Lodi 1917, pp. 223, 224, 650, 651, 781; E. Rodocanachi, Le Pontificat de Léon X, Paris 1931, pp. 271-273; Id., Les
Pontificats d'Adrien VI et de Clément VII,Paris 1933, pp. 131, 133, 137, 172, 239; K. Brandi, Kaiser Karl V, München 1942, I e II,
passim;P.Pieri, Il Rinascimento e la crisi militare italiana,Torino 1952, pp. 493, 506-509, 512-514, 542-544, 548-568, 589, 613 e n.;
G. Franceschini, Le dominazioni francesi e le restaurazioni sforzesche,in Storia di Milano, VIII,s. l. [Milan0] 1957, passim.
Fernando de Àvalos
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre
Fernando Francesco de Àvalos (Ferdinand-François d'Àvalos), marquis de Pescara (en vieux françaix Pescaire), l'un des plus
grands capitaines de Charles Quint, né en 1490, d'une illustre maison du royaume de Naples et d'origine castillane Il avait épousé fort
jeune Vittoria Colonna, célèbre par sa beauté, sa vertu et son esprit. Fait prisonnier à la bataille de Ravenne (1512), Il composa dans
sa prison un Dialogue de l'amour, qu'il dédia à son épouse. Vittoria peinte par Michel Ange était nommée "La divine". Ses poèmes
sont encore édités Dès qu'il eut recouvré sa liberté, le marquis d'Àvalos reprit les armes contre la France, et eut beaucoup de part au
recouvrement du Milanais par l'Espagne : il défit en 1524 le chevalier Bayard à Rebec qui perdit la vie et comme général en chef de
l'armée de Charles Quint contribua puissamment à la victoire de Pavie (1525), après laquelle il fut nommé généralissime. Il reçut la
reddition de François Ier. Il mourut à Milan la même année.
Histoire de Pierre Terrail, dit LE CHEVALIER BAYARD sans peur et sans reproche. Par Guyard de Berville. A Reins (M.CCC.VII)
The Marquis del Vasto by Titian.
AVALOS, Alfonso d',
marchese del Vasto
(1502 - 1546)
Dizionario Biografico degli Italiani
di GG. De Caro
AVALOS, Alfonso d', marchese del Vasto. - Nacque a Ischia il 25 maggio 1502, da una delle più illustri casate del Regno di Napoli,
figlio di Iñigo (II), marchese del Vasto, e di Laura Sanseverino; rimasto molto presto orfano, fu educato dalla zia Costanza,
principessa di Francavilla, famosa per avere virilmente difeso l'isola d'Ischia contro i Francesi nel 1593. Legato da grande affetto e
amicizia al più anziano cugino Ferdinando Francesco, il famoso marchese di Pescara, l'A. prese a militare giovanissimo nell'esercito
di lui. Partecipò alla battaglia della Bicocca nel 1522 e si distinse nel corso di questa campagna alla conquista di Lodi e alla
occupazione di Genova. Al comando di un reparto di fanteria italiana prese parte alla sfortunata campagna di Provenza del 1524 e
combatté all'assedio di Marsiglia: durante la ritirata gli fu affidato provvisoriamente dal marchese di Pescara il comando della fanteria
imperiale e l'A. ne diresse con felice esito il ripiegamento da Acqui a Pavia.
Un ruolo di rilievo l'A. ebbe nella battaglia di Pavia (24 febbr. 1525), nella quale comandava l'avanguardia dell'esercito imperiale,
costituita da millecinquecento lanzichenecchi e altrettanti archibugieri: con queste forze l'A., praticata una breccia nel muro del parco
di Mirabello, attaccò l'ala sinistra dello schieramento avversario e sostenne poi validamente l'urto della gendarmeria e dei
gentiluomini francesi guidati dallo stesso Francesco I, sino a che l'intervento del grosso dell'esercito imperiale pose fine
vittoriosamente alla battaglia. Dopo di questa l'A. fu incaricato dal marchese di Pescara di provvedere all'occupazione del marchesato
di Saluzzo, compiuta entro il luglio 1525.
Per queste sue imprese, su istanza del cugino, l'A. ottenne dall'imperatore la nomina a capitano generale di tutta la fanteria
dell'esercito d'Italia (25 nov. 1525). Alla morte del marchese di Pescara, sopravvenuta nel medesimo anno, l'A. ne ereditò i feudi e il
titolo, cui più tardi (1528) si aggiunsero i titoli di principe di Francavilla e di conte di Montescaglioso e Belcastro, e la carica di
governatore d'Ischia, ereditati dalla zia Costanza.
Insieme con Antonio de Leyva l'A. costrinse nel 1526 il duca Francesco II Sforza ad abbandonare Milano e a rinunziare a ogni
tentativo antimperiale.
Durante la campagna contro l'esercito della lega di Cognac l'A., mosso da scrupoli religiosi, tentò invano, rivolgendosi a Carlo V e ai
vari comandanti imperiali, di impedire il Sacco di Roma, e a quella impresa non volle partecipare.
Nel febbraio 1529 condusse la fanteria spagnola e italiana da Roma in soccorso di Napoli, assediata dal Lautrec, ma qui i suoi dissensi
con l'Orange giovarono non poco ai primi successi dei Francesi. L'A. assunse la direzione dell'esercito imperiale contro le forze dei
coalizzati francesi, fiorentini e veneziani, che, al comando di Renzo da Ceri, avevano portato la guerra in Puglia. Durante questa
campagna, che fu durissima anche per l'appoggio dato da una larga parte della popolazione ai collegati, l'A. non riuscì a ottenere alcun
successo importante e assediò invano per due mesi Monopoli.
Influì anche sui cattivi risultati della campagna la rivalità dell'A. con Ferrante Gonzaga, che comandava la cavalleria: inimicizia
dovuta soprattutto al carattere suscettibile e alla grande ambizione dell'A., il quale considerò sempre come rivali tutti i capitani e i
funzionari imperiali che gli furono vicini con qualche autorità e prestigio, l'Orange, il Gonzaga, Maramaldo, il viceré Pietro de
Toledo, il de Leyva, il cardinale Caracciolo, Lope de Soria, importunando spesso Carlo V con le sue lamentele e non meno spesso
provocando con la sua gelosia seri inconvenienti nella condotta delle imprese militari.
Nell'aprile del 1528 il viceré Ugo de Moncada, nel tentativo di togliere il blocco posto dai Francesi a Napoli e di permettere l'afflusso
di cereali dalla Sicilia, decise di affrontare con i suoi migliori capitani, tra cui l'A., la squadra navale comandata da Filippino Doria. In
questa battaglia, combattuta nel golfo di Salerno il 28 apr. 1528 e detta della Cava o di Capo d'Orso, le navi imperiali furono sconfitte,
il Moncada stesso ucciso e l'A. fatto prigioniero. Condotto a Lerici, l'A. seppe abilmente sfruttare il malcontento antifrancese di
Andrea Doria ed ebbe non piccolo merito nella defezione di lui dal campo francese, che fu di così grande importanza nel risolvere
questa fase della guerra in favore degli imperiali.
Nella distribuzione voluta da Carlo V nel 1529 dei feudi della nobiltà filofrancese del regno di Napoli ai nobili rimasti fedeli alla
Spagna, toccarono all'A. i feudi di Montesarchio, Castel Pagano, Val di Vituiano, Bisaccia, Gragnano, Procida e altri minori.
Nel settembre 1529 l'A. condusse cinquemila fanti spagnoli dalla Puglia in Toscana, alla guerra per la restaurazione medicea in
Firenze: vi si distinse conquistando Cortona (14 sett. 1529), Prato (febbr. 1530) ed Empoli (29 maggio 1530), che mise a sacco.
Richiesto di aiuti da Fabrizio Maramaldo che assediava Volterra, preferì recarvisi di persona assumendo il comando dell'assedio. La
sconfitta inflitta agli imperiali da Francesco Ferrucci e, più, le beffe degli assediati vittoriosi, misero l'A. in tale stato di furore che con
un gesto tipico del suo carattere debole e morbosamente orgoglioso abbandonò la guerra e se ne ritornò a Napoli. Qui, nel 1532,
arruolò un corpo di seimila fanti da condurre in soccorso di Ferdinando d'Asburgo in guerra con i Turchi, ma l'arretramento di questo
sino a Belgrado lo dissuase dal progetto.
Quando nel 1535 Carlo V organizzò la grande spedizione contro Tunisi, ne affidò la direzione all'Avalos. Fu questa una delle migliori
imprese militari dell'A., che al comando di venticinquemila fanti e duemila cavalli italiani, tedeschi e spagnoli conquistò il 14 luglio la
Goletta, dopo averla sottoposta a un massiccio bombardamento; il 16 luglio affrontò e sconfisse di fronte a Tunisi gli ottantamila
uomini del Barbarossa e il 20luglio, anche per la contemporanea insurrezione degli schiavi cristiani, conquistò Tunisi compiendo uno
spaventoso massacro degli abitanti.
Da Tunisi l'A. raggiunse in Lombardia l'esercito imperiale, che si accingeva ad invadere la Provenza, e tentò invano di sconsigliare
l'impresa che per l'esperienza fatta nel 1524 giudicava di esito assai incerto. Carlo V preferì invece seguire i consigli del de Leyva e
nel luglio 1536 iniziò la spedizione: l'A. fu messo a capo delle fanterie sotto il comando generale del de Leyva. Le sue pessimistiche
previsioni furono ampiamente confermate.
Morto il de Leyva, l'A. assunse il comando supremo e ordinò immediatamente la ritirata dalla regione. Essa avvenne tra grandissime
difficoltà, perché i Francesi si erano impadroniti saldamente dei punti di passaggio e non fu certo tra le minori imprese dell'A. aver
ricondotto i resti dell'armata in Piemonte. Qui, sino alla interruzione delle ostilità per la tregua stipulata il 16nov. 1537e poi per la
pace di Nizza del 18 giugno 1538,l'A. venne riorganizzando le sue forze e rioccupando lentamente i territori conquistati dai Francesi:
introdotti in città dalla popolazione di Casale Sant'Evasio (Casale Monferrato) i Francesi, l'A. accorse immediatamente a soccorrervi il
presidio spagnolo, scacciò i Francesi e mise la città a sacco; ritiratosi quindi in Asti vi sostenne vittoriosamente l'assedio dell'esercito
del d'Humières; ottenuti rinforzi passò al contrattacco e conquistò Chieri, Cherasco e Alba. La tregua colse l'A. mentre dirigeva
l'offensiva contro Pinerolo e Torino.
Le maggiori preoccupazioni non vennero tuttavia all'A. dai Francesi, ma dall'indisciplina delle sue stesse milizie, che prive da tempo
delle paghe si abbandonavano a saccheggi e violenze d'ogni genere e si rifiutavano di combattere. Aspri contrasti sorsero per questa
situazione tra l'A. e il governatore di Milano, il card. Marino Caracciolo, che si opponeva alla richiesta di una pesante tassazione
straordinaria, per non esaurire le già provate risorse economiche dello Stato. Questo contrasto raggiunse punte drammatiche, sia per
l'insofferenza e l'incomprensione del militare verso l'amministratore, sia per il carattere dell'A., intollerante dei limiti impostigli da
un'autorità non inferiore alla sua. Nel giugno del 1537 la situazione precipitò per l'insorgere di una violentissima rivolta militare. Le
truppe misero a sacco Valenza, attaccarono ripetutamente Tortona, si abbandonarono a violenze senza precedenti nelle campagne di
Alessandria. Di fronte alla minaccia di vedere completamente devastato lo Stato, il Caracciolo dovette piegarsi ad imporre ai cittadini
un ulteriore gravissimo sforzo e lo stesso A., con iniziative che indubbiamente esulavano dai suoi poteri, intervenne personalmente a
controllare le esazioni.
Risolto momentaneamente il problema della rivolta dei militari, rimaneva aperto quello gravissimo del contrasto di competenze tra il
potere militare e quello civile, destinato inevitabilmente a rinnovarsi. Alla morte del Caracciolo, nel 1538, Carlo V decise di
assommare nell'A. le due cariche di governatore dello Stato di Milano e di comandante dell'esercito d'Italia: provvedimento dettato
dalla necessità di non far risorgere pericolosi contrasti tra i massimi esponenti della politica imperiale nell'Italia settentrionale, che
tuttavia fu preso molto malvolentieri e con notevoli limitazioni dall'imperatore.
Significative sono in questo senso le istruzioni imperiali all'A. al momento della sua nomina a govematore, nelle quali è evidente
l'intenzione di fare di lui un semplice esecutore con minime possibilità di iniziativa sul piano amministrativo. L'autorità dell'A. veniva
limitata in un duplice modo: da una parte attribuendo intera alle magistrature milanesi la responsabilità dell'amministrazione
giudiziaria e finanziaria, dall'altra riservando allo stesso imperatore la decisione nelle più varie questioni, anche di ordinaria
amministrazione. Indirizzo della politica di Carlo V ribadito nelle Constitutiones dominii Mediolanensis, promulgate dall'imperatore
durante il suo soggiorno a Milano nell'agosto 1541e riconfermato con i cosiddetti Ordini di Vormazia,con i quali Carlo V da Worms,
il 6 ag. 1545, insistette nel raccomandare all'A. il rispetto delle funzioni dei magistrati milanesi. L'A. sentì queste limitazioni alla sua
autorità (che pure furono una costante della politica di Carlo V nell'ambito dello Stato milanese), come un segno di scarsa fiducia
personale e non mancò di fame continuo lamento a corte, provocando repliche piuttosto dure dell'imperatore.
In pratica, però, le necessità della guerra davano all'A. molta di quella autonomia che gli era teoricamente negata. Specialmente nel
campo finanziario, per il pressante bisogno di denaro e la corrispondente insufficienza dei redditi ordinari dello Stato, l'A. finiva
spesso per assumere iniziative che scavalcavano il Magistrato milanese, sfuggendo anche al controllo dell'imperatore lontano. Di qui
contrasti continui con l'apparato burocratico dello Stato, in linea di diritto intoccabile nelle sue antiche prerogative, di fatto molto
spesso esautorato dalle decisioni personali del governatore. D'altra parte, il governo dell'A. non ebbe mai l'energia che caratterizzò
invece quello del suo successore, il Gonzaga, e sovente le magistrature milanesi finivano, creando ritardi d'ogni genere, per rendere
inefficaci le misure disposte dal governatore.
I provvedimenti drastici, cui l'A. talvolta ricorse, per la loro occasionalità apparivano, ed erano, piuttosto segni di debolezza che di
energia. Così, nel giugno 1538,dopo la stipulazione della pace di Nizza, avendo invano insistito per ottenere il denaro liquido
necessario al pagamento degli arretrati alle truppe, l'A. decise improvvisamente di congedarle. I soldati, esasperati, si abbandonarono
a terribili violenze, occuparono e misero a riscatto Vigevano e Gallarate e minacciarono la stessa Milano. Lo spavento fu tale che una
taglia straordinaria di 100.000 scudi imposta dall'A. fu pagata senza le consuete esitazioni e resistenze; ma ne nacquero contro l'A.
proteste a non finire che si moltiplicarono poi per tutto il periodo del suo governo. Lo stesso Carlo V ricevette in più occasioni accuse
circostanziate contro l'amministrazione dell'A., sebbene questi facesse di tutto per impedire che le proteste giungessero a corte,
togliendo, per esempio, nel 1541,la carica al tesoriere generale Tommaso Fornari, che aveva preparato un memoriale contro di lui, o
mandando alla berlina, nel 1543,un fra' Urbano da Landriano, che aveva inviato una denuncia contro l'amministrazione al confessore
dell'imperatore, Pedro de Soto. Le accuse erano effettivamente più che giustificate: non solo l'A., stretto dalla necessità, privava,
secondo un rovinoso espediente del tempo, lo Stato delle sue entrate future svendendone le fonti più cospicue di reddito, sino a
raggiungere nel 1546 l'enorme cifra di 800.000ducati di rendite vendute o impegnate, ma compiva gravissime irregolarità nella
vendita degli uffici, che finivano nelle mani di funzionari inetti o disonesti, causa non ultima del dissesto dell'amministrazione,
concedeva ad alcune delle più ricche famiglie dello Stato esenzioni ingiustificate dalle contribuzioni, e conduceva una vita
fastosissima, con la moglie, Maria d'Aragona, nipote del re di Napoli Ferdinando, entrambi proteggendo artisti e letterati, come
Tiziano, Pietro Aretino, che dedicò all'A. la Marfisa, l'Angelica e la Vita di Caterina, e Iacopo Nardi che gli offrì la sua traduzione di
Tito Livio.
Perciò sin dal 1539 Carlo V inviò a Milano un suo autorevole rappresentante, Lope de Soria, con l'incarico di controllare l'operato
dell'A., e successivamente altri commissari, le cui accuse non furono certamente meno pesanti di quelle dei privati. L'A. non mancò
naturalmente di protestare per questo sindacato, che riteneva irrispettoso, ma con tanto poco successo che, recatosi nel 1546 a Madrid
per giustificarsi con l'imperatore, fu rinviato bruscamente all'esame dei revisori dei conti e soltanto la morte poté sottrarlo alle accuse.
Questa severità colpì l'A. non soltanto nel suo orgoglio, ma nello stesso sentimento di personale devozione all'imperatore, che
costituiva, oltre che l'unico vincolo con lo Stato, in un modo di sentire tipicamente feudale identificato tuttora col sovrano, anche
"l'unica ragion morale" (Chabod, Lo stato di Milano nell'Impero di Carlo V)della sua vita: sentimento, questo, comune a tutta la
nobiltà italiana passata al servizio spagnolo e radicatissimo nell'A., che alla fedeltà a Carlo V non venne mai meno. I sondaggi
compiuti dall'A. nel marzo del 1540 con il residente veneziano per proporsi come capitano generale della Repubblica, nati dal timore
di dover improvvisamente lasciare Milano, sul cui possesso, ai fini delle esigenze politico-strategiche spagnole in Italia, si andava
molto discutendo in quel periodo alla corte di Madrid, non ebbero seguito; quella devozione era invece provata nei momenti di più
urgente bisogno finanziario dalla pratica di impegnare o vendere i propri beni, feudi, argenteria e gli stessi gioielli della moglie, per
anticipare i denari per il pagamento delle truppe o per altre urgenti necessità.
Ma la considerazione della corte per l'A. diminuì anche per gli insuccessi che a questo riservò la guerra con la Francia ripresa nel
1542. Se la ragione effettiva della rottura della tregua di Nizza da parte di Francesco I fu l'investitura del ducato di Milano concessa
da Carlo V l'11 ott. 1540 al principe Filippo, l'occasione fu offerta proprio dall'A., che aveva fatto catturare e uccidere due
ambasciatori del re di Francia, Antonio Rincon e Cesare Fregoso, mentre attraversavano lo Stato di Milano, per recarsi a
Costantinopoli a trattare l'alleanza con Solimano II.
L'A. ottenne, alcuni importanti successi agli inizi della campagna, respingendo l'offensiva condotta in Piemonte da Claudio
d'Annebaut e liberando Mondovì dai Francesi e Nizza dai Turchi nel 1543; ma mentre si proponeva di passare in Francia per sostenere
l'avanzata inglese da Calais e l'attacco dalla Germania condotto con l'aiuto dei principi tedeschi, fu fermato a Ceresole Alba dal conte
d'Enghien Francesco di Borbone: l'A. tentò di ripetere la medesima manovra della battaglia di Pavia, ma fu clamorosamente sconfitto,
perdendo dodicimila uomini e tremila lasciandone prigionieri (14 apr. 1544). Tra le conseguenze militari di questa sconfitta l'A. riuscì
a evitare le peggiori, giacché, se non riuscì a impedire che i Francesi occupassero il Monferrato, seppe, però, evitare la perdita di tutta
la Lombardia, che per un momento era sembrata inevitabile, opponendosi validamente sia all'esercito francese sia a Piero Strozzi, che
tentava di raggiungere Milano dalla Mirandola, sino a che la pace di Crépy (18 sett. 1544) tolse l'A. dalla difficile situazione.
Ma il prestigio militare dell'A. aveva ricevuto un colpo durissimo anche presso i suoi stessi soldati: perduto il favore dell'imperatore,
fatto oggetto alle più gravi accuse da parte della popolazione dello Stato, sottoposto a una inchiesta amministrativa che giudicava un
vero affronto, l'A. morì nella più grande amarezza a Vigevano il 31 marzo 1546.
Fonti e Bibl.: Un sonetto dell'A. in Marittimi e Pedanteschi del sec. XVI, Venezia 1787, p. 208; Roma, Bibl. Corsiniana. Vita di A.
d'A. d'Aquino Marchese del Vasto,in Relazioni e Vite di personaggi illustri,cod. 829 (34-E-23); M. Guazzo, Historia... dell'anno 1524
sino a questo presente,Vinegia 1546, passim;A.Ulloa, La vita del valorosissimo e gran capitano Don Ferrante Gonzaga...,Venetia
1563, passim; Lettere di Principi, Venetia 1581, I, pp. 102, 187-196 e passim;III, pp. 12, 13 e passim;G. M. Burigozzo, Cronica
Milanese.in Arch. stor. ital.,III (1842), pp. 450, 456, 541, 545, 548, 551, 552; Relación de lo que sucedió en la conquista de Tunez y la
Goleta,in Colección de documentos inéditos para la historia de España,I, Madrid 1842, pp. 159-207, passim; Capítulo de carta de Juan
Perez à Carlos V, ibid., XIV, Madrid 1854, p. 497; Copia de letra del Rmo. Colonna al Rmo. Campegio legato à Roma, ibid.,p. 500;
Capítulos de carta de Lope de Soria à Carlos V, ibid.,p.500; B. Varchi, Storia Fiorentina,in Opere,I,Trieste 1858, passim;I. Nardi,
Istorie della città di Firenze,Firenze 1888, II, pp. 105, 107, 161, 190, 290; Diario inedito dell'assedio e della battaglia di Pavia...,a cura
di A. Bonardi, Pavia 1895, pp. 22 s.; Les suites du Sac de Rome par les Impériaux et la campagne de Lautrec en Italie,par H. Omont,
in Mélanges d'archéologie et d'histoire,XVI(1896), pp. 13-61, passim;P. Aretino, Il primo Libro delle lettere, a cura di F. Nicolini,
Bari 1913, lett. XXVII, XXXII, LXXXII, CC; Id., Il secondo Libro…, Bari 1916, passim; Relazioni degli ambasciatori veneti al
Senato,a cura di A. Segarizzi, II, Bari 1913, pp. 39, 51, 61, 77; Correspondencia de Carlos V con el Marqués del Vasto, Gobernator
del Milanesado...,in Boletín do la R. Academia de la Historia,LXXXVIII (1926), pp. 71-145; P. Giovio, Le vite del Gran Capitano e
del Marchese di Pescara,a cura di C. Panigada, Bari 1931, passim;F. Guicciardini, Scritti politici e ricordi,a cura di R. Palmarocchi,
Bari 1933, p. 210; Feudi e feudatari napoletani della prima metà del Cinauocento,a cura di N. Cortese, in Arch. stor. per le prov.
napol., n. s., XV (1929), pp. 62, 67, 108, 131-136, 138; XVI (1930), p. 86; J. E. Martínez Ferrando, Privilegios otorgados...,Barcelona
1943, nn. 176-190, pp. 21-23; G. De Leva, Storia documentata di Carlo V in correlazione all'Italia,II, Venezia 1864, passim;III,ibid.
1867, passim;D. Muoni, Tunisi. Spedizione di Carlo V imperatore,Milano 1876, passim;G.Capasso, Don Ferrante Gonzaga
all'impresa di Puglia del 1529, in Riv. stor. ital.,XII(1895), pp. 419-449, passim;L. Beltrami, La battaglia di Pavia illustrata negli
arazzi del marchese del Vasto,Milano 1896, A. Segre, Emanuele Filiberto e le ultime relazioni del duca Carlo II di Savoia con A. d'A.,
marchese del Vasto,in Atti d. R. Accad. d. scienze di Torino,XXXVIII(1902-03), pp. 788-815; V. Vitale, L'impresa di Puglia degli
anni 1528-1529, in Nuovo Arch. veneto.n. s., VII (1907), t. XIII, pp. 5-68; L. v. Pastor, Storia dei Papi,IV,2, Roma 1912, pp. 298,
311, 314, 319, 347; V, ibid. 1914, passim;R. Bergadani, Alba e le guerre in Piemonte tra Francia e Spagna dal 1537 al 1559, Alba
1912, passim;L. Cardauns, Von Nizza bis Crépy.Rom 1923, passim;C. Roth, L'ultima repubblica fiorentina,Firenze 1929, passim;F.
Chabod, Lo Stato di Milano nell'Impero di Carlo V,Roma 1934, passim;Id., Per la storia religiosa dello Stato di Milano durante il
dominio di Carlo V,Bologna 1938, passim;Id., Usi e abusi nell'amministrazione dello Stato di Milano a mezzo il '500, in Studi storici
in onore di Gioacchino Volpe,Firenze 1958, I, pp. 93-194, passim;K.Brandi, Kaiser Karl V,I-II, München 1942, passim;J.Garcia
Mercadal, Juan Andrea Doria, Condotioro y almirante del Emperador Carlos V,Madrid 1944, pp. 89, 148; L. Simeoni, Le
Signorie,Milano1950, II, passim;F. Chabod, in Storia di Milano, IX,Milano 1961, passim.
Baglioni, Malatesta IV
(1491 - 1531)
Dizionario Biografico degli Italiani
di GG. De Caro
BAGLIONI, Malatesta. - Quarto di questo nome, nacque a Perugia nel 1491 da Giampaolo e da Ippolita Conti. Aveva poco più di
sette anni quando il padre, che militava al servizio dei Fiorentini, lo condusse con sé alla guerra contro Pisa. Scampato il 14 luglio
15oo alla strage dei suoi congiunti organizzata da Carlo e Grifonetto Baglioni e da Girolamo della Penna, Giampaolo, che era entrato
al servizio del duca Valentino, lo inviò poco dopo in ostaggio ai Fiorentini, come pegno di fedeltà verso la Repubblica. Nel 15o6 il B.,
prescelto dai Perugini tra i capitani del contado, ricevette in consegna la rocca di Castel della Pieve. Nel medesimo anno seguì il padre
nella spedizione voluta da Giulio II contro Bologna, sotto il comando del capitano fiorentino Bino Signorelli; in seguito venne
consegnato, insieme al fratello Orazio, in ostaggio al pontefice, quale garanzia della lealtà di Giampaolo.
Nel 1510 il B. sposò Monaldesca Monaldeschi: con questo matrimonio i Baglioni mirarono al dominio di alcuni castelli nel territorio
di Orvieto tanto è vero che l'anno successivo il B., vantando un diritto della famiglia della moglie su Colle Lungo, lo tolse agli
Orvietani riuscendo successivamente ad ottenere da Leone X la conferma del vicariato su alcune terre concesse ai Monaldeschi da
Bonifacio VIII. Nel 1511 entrò al servizio della Repubblica di Venezia, e con il grado di alfiere di cavalleria partecipò alla campagna
di Romagna e alla battaglia di Ravenna, dove fu gravemente ferito. Fu poi luogotenente del padre nel Veneto e nel marzo del 1513,
quando Giampaolo, alla morte di Giulio II, ritornò momentaneamente a Perugia per prendere possesso della città, ebbe il comando
dell'esercito che era acquartierato a Padova.
Sotto il comando del padre e poi di Bartolomeo d'Alviano il B. acquistò notevole fama come condottiero di cavalleria leggera. Tra il
1513 e il 1515 prese parte a importanti fatti d'arme nel Friuli, nel Veneto ed in Lombardia: partecipò alla conquista di Pordenone, il 29
marzo 1514; intervenne agli scontri di Muzzano, Comisano, Bevilacqua, all'occupazione di Rovigo, il 21 0t1. 1514, e alla battaglia di
Marignano contro gli Svizzeri e il duca di Milano, il 13 e il 14 sett. 1515. Nel 1516 ricevette da Leone X, insieme a Giampaolo ed
Orazio, l'investitura del feudo di Bettona. L'anno successivo tornò a Perugia dove collaborò con il padre alla preparazione delle difese
contro Francesco Maria Della Rovere, e, come il padre, non andò esente dal sospetto di una segreta intesa con il Della Rovere ai danni
dei Perugini e del pontefice.
Quando Giampaolo, l'11 giugno 1520, fu fatto decapitare a Roma da Leone X, il B., con Orazio, si rifugiò in territorio veneziano ove
prese contatto con altri fuorusciti dello Stato della Chiesa, Camillo Orsini, Fabio Petrucci e Sigismondo Varano, che sotto la direzione
dello spodestato duca d'Urbino Francesco Maria Della Rovere andavano preparando una spedizione nello Stato pontificio per
recuperare le proprie signorie e arginare le iniziative espansionistiche dei Medici. Alla morte di Leone X i fuorusciti ripresero
possesso di Urbino, Camerino e Pesaro, e nel gennaio 1522 entrarono in Perugia, scacciandone Gentile Baglioni, al quale Leone X,
dopo la morte di Giampaolo, aveva affidato il governo della città. Ma ritornato poco dopo Gentile con l'appoggio di milizie pontificie,
senesi e fiorentine, al comando di Giovanni de' Medici, i Baglioni, nell'ottobre 1522, furono costretti a un accordo con cui si
obbligarono a uscire dalla lega antimedicea. Poiché Orazio entrò al servizio dei Fiorentini e il B., invitato a fare altrettanto, non
oppose un esplicito rifiuto, i signori perugini sembravano totalmente attratti nell'orbita del cardinale Giulio de' Medici.
Tuttavia le dimostrazioni di omaggio del B. verso Firenze e verso i Medici non erano sincere: egli cercò contemporaneamente di
appoggiarsi al partito antimediceo del cardinale Soderini e contribuì all'impresa progettata dal Soderini contro Siena inviando a Renzo
da Ceri cento cavalli, duemila fanti e quattro falconetti. Il B. avvertiva nell'eventuale elezione a pontefice del cardinale de' Medici il
pericolo di una nuova lotta contro le signorie dell'Italia centrale sulla linea della tradizionale politica papale. In più, Perugia si sarebbe
trovata stretta tra la Toscana, controllata dal Medici, e lo Stato della Chiesa. Di qui la sua politica ambigua e il tentativo di spezzare il
blocco che si stava stringendo intorno al suo stato.
Nel 1525 il B. ritornò al servizio della Repubblica di Venezia, al comando di quattromila fanti; nella primavera dell'anno successivo,
nell'intento di impadronirsi di una base adatta a soccorrere Milano assediata dagli Spagnoli, attaccò Lodi difesa da Fabrizio
Maramaldo e la espugnò il 24 giugno. Dopo questa impresa il Senato veneziano lo elesse capitano generale delle fanterie. Il B. si
rivolse allora contro Cremona tentando di occuparla di sorpresa; fu invece costretto ad un lungo assedio, risolto soltanto
dall'intervento del grosso dell'esercito al comando del duca d'Urbino, Francesco, Maria Della Rovere. Tentò invano di opporsi di lì a
poco ai lanzichenecchi che il Frundsberg aveva portato nel territorio di Mantova. Autorizzato dal Senato veneziano, tornò a Perugia,
richiamatovi dalle spietate vendette cui si stava abbandonando il fratello Orazio contro Gentile e i suoi partigiani.
A Perugia, dove giunse il 2 sett. 1527, il B. si sforzò di moderare gli eccessi di Orazio, che avrebbero potuto costituire un pretesto per
l'intervento del pontefice o dei Fiorentini contro Perugia. La Repubblica di Firenze, invece, sin dalla fine dei 1527, preoccupata
dell'accordo tra il papa e gli Imperiali, allacciò trattative con il B. per affidargli il comando delle proprie truppe.
Vari motivi spingevano i Fiorentini a rivolgersi al B.: le antiche relazioni della famiglia di lui con la Repubblica, la sua ben nota
ostilità verso i Medíci, che avevano costantemente protetto i fuorusciti perugini e continuavano a minacciare la sua signoria, la buona
fama di condottiero, infine l'opportunità per la Repubblica di avere in Perugia un forte avamposto nello Stato della Chiesa. Da parte
sua il B. riteneva che il ritorno dei Medici a Firenze avrebbe ancora una volta ridotto Perugia fra due fuochi. Tuttavia egli esitava a
prendere un impegno che avrebbe potuto troppo scopertamente opporlo a Clemente VII e, mentre prendeva tempo nelle trattative con
i Fiorentini, si recava ad Orvieto a rendere omaggio al pontefice. Questi da una parte lo incaricò di ridurre alla ragione i ribelli
Guidone ed Ottavio de' Nepis, dall'altra, perfettamente al corrente delle trattative del B. con Firenze, cercò di arginare la situazione
finanziando e stimolando contro di lui i fuorusciti Sforza e Braccio Baglioni, che andavano compiendo scorrerie nei feudi del B. ed
erano arrivati ad impossessarsi di Norcia.
Resosi conto del gioco politico-militare a suo danno, il B. ruppe gli indugi: il 16 apr. 1529, ignorando le ripetute diffide del papa,
accettò dal legato di Firenze Bernardo da Verrazzano la carica di "governatore generale di tutte le forze fiorentine a cavallo e a piedi".
Secondo le richieste del B., la condotta fu firmata anche dal Velly, oratore francese a Firenze, a nome di Francesco I. Formalmente
l'incarico del B. era subordinato a quello di Ercole d'Este, capitano generale, ma la carica del giovane duca ferrarese era di puro
prestigio, sicché la responsabilità delle truppe spettò sin dal principio al Baglíoni. Questi, sin dal maggio, propose alla Repubblica di
prendere audacemente l'iniziativa, attaccando contemporaneamente le forze imperiali da Firenze e da Perugia prima che l'Orange
riuscisse a riunirle tutte. Ma la Repubblica, ancora fiduciosa nella possibilità di un accordo, respinse la proposta. Il B. dovette perciò
limitarsi a fortificare Perugia, alla quale del resto i Fiorentini inviarono aiuti abbastanza consistenti, sia in denaro sia in uomini.
Quando però l'Orange si presentò innanzi alla città, dopo una rapida campagna nel corso della quale aveva occupato Montefalco,
Bevagna, Assisi e Spello, il B. rinunciò ad ogni tentativo di difesa e venne a patti con il generale imperiale.
Alla luce del successivo comportamento del B. gli storici repubblicani fiorentini del tempo videro in questa inopinata decisione del
condottiero perugino un primo indizio di tradimento, tanto più evidente in quanto le condizioni furono singolarmente favorevoli al B.,
che ottenne di lasciare Perugia indisturbato con tutto l'esercito e le provvigioni, nonché, da parte del papa, l'autorizzazione a rimanere
al servizio dei Fiorentini e la promessa che i fuorusciti non sarebbero stati riammessi in Perugia. In realtà, mentre queste condizioni si
spiegano con la necessità degli Imperiali di impadronirsi ad ogni costo di Perugia per non esaurire le proprie forze in un lungo
assedio, la decisione del B. si configura alla luce dei nuovi criteri strategici dei fiorentini Dieci della guerra, i quali poco fiduciosi
nella fedeltà delle altre città dello Stato si andavano orientando verso una difesa concentrata intomo a Firenze richiamando quasi tutte
le guarnigioni periferiche. In effetti né il governo fiorentino né Francesco Ferrucci, che lo rappresentava in Perugia in questo periodo,
ebbero nulla da obbiettare di fronte al comportamento del governatore generale.
Uscito pertanto da Perugia l'11 settembre, il B. si portò a Firenze, dove, contrariamente alle versioni che lo vogliono sin dal principio
incline al tradimento, tentò con competenza ed onestà di trarre tutte le conseguenze della strategia prescelta dal governo fiorentino:
oltre a condurre i lavori di rafforzamento delle mura, cercò di rifornire la città di munizioni e di viveri. Per varie ragioni non tutte le
sue direttive furono eseguite dai Fiorentini, ma è indubbio che esse erano perfettamente adeguate alle prospettive della guerra. Anche
sul piano militare, sino al giugno del 1530 - allorché comincia effettivamente a delinearsi nel B. l'idea del tradimento - egli diede
ripetute prove di competenza e di lealtà: la sua replica alla sorpresa notturna tentata tra il 10 e l'11 sett. 1529 dall'Orange fu un
modello di tempestività e di capacità organizzativa, così come furono in gran parte merito del B. i successi delle numerose sortite
tentate dagli assediati. Tuttavia proprio mentre stava riportando i suoi migliori successi, i Fiorentini cominciarono a dubitare della
lealtà del B. che mostrava di non sfruttare a fondo le occasioni favorevoli.
In realtà l'entusiasmo e il patriottismo dei giovani repubblicani fiorentini doveva irrimediabilmente urtare con la prudenza del soldato
di professione, non disposto ai gesti temerari e poco fiducioso nelle qualità militari delle milizie cittadine. Del resto, tutto il sistema
difensivo del B. era guidato dall'idea che Firenze non sarebbe stata in grado di resistere vittoriosamente da sola all'agguerritissimo
esercito imperiale se non fossero giunti i soccorsi tante volte promessi da Francesco I. Conveniva dunque - secondo il B. - prolungare
il più a fungo possibile la resistenza, non insistendo in iniziative che potevano essere estremamente pericolose.
Il tradimento del B. divenne invece effettivo quando la situazione della città assediata gli apparve irrimediabilmente compromessa
dagli accordi separati conclusi da Venezia, Ferrara, Urbino e infine dalla Francia. Allora il B. cercò di scindere le proprie fortune da
quelle dei Fiorentini: alla fine del giugno 1530 prese i primi contatti con gli Imperiali attraverso il capitano Vincenzo Piccioni, detto
Cencio Guercio, contatti continuati poi da Bino Signorelli. Nel giro di un mese l'accordo fu realizzato: il B. si impegnava a
consegnare la città in modo da risparmiarle - come voleva Clemente VII - il saccheggio; l'Orange, da parte sua, gli prometteva, a
nome del papa, la conferma dei patti stipulati nel settembre dell'anno precedente allorché egli aveva abbandonato agli Imperiali
Perugia, e inoltre l'investitura del dominio di Bevagna, Limigiano e Castel Nuovo e una parte delle entrate ecclesiastiche delle terre
del Chiugi. Su questa base, il tradimento fu rapidamente consumato: il 3 agosto, mentre l'Orange marciava su Gavinana contro il
Ferrucci, il B. si rifiutò di attaccare il campo imperiale; nove giorni dopo, il 12 ag. 1530, puntava i suoi cannoni contro la città e
faceva aprire agli Imperiali la porta di San Pietro Gattolino. Il 30 settembre il B. rientrava in Perugia. Alla fine di ottobre si ritirò nel
suo feudo di Bettona, dove dettò al fedele Cencio Guercio alcune lettere a varie personalità politiche, nelle quali cercò di giustificare il
proprio tradimento. Morì, poco dopo, il 24 dic. 1531.
Fonti e Bibl.: F. Matarazzo, Cronaca della città di Perugia dal 1492 al 1503, a cura di A. Fabretti, in Arch. stor. ital.,XVI(1851), parte
2, pp. 1-243, passim;T. Alfani, Memorie Perugine dal 1502 al 1527, a cura di F. Bonaini, A. Fabretti, F. Polidori, ibid.,pp. 245-319,
passim;C.Bontempi, Ricordi della città di Peruzia dal 1527 al 155o, a cura di F. Bonaini, ibid.,pp.321, 401, passim;I. Nardi, Istorie
della città di Firenze,II, Firenze 1888, passim;G. Guicciardini, Storia d'Italia,a cura di C. Panigada, Bari 1929, passim;G. B.
Vermiglioli, La vita e le imprese militari di Malatesta IV Baglioni,Perugia 1839; A. Fabretti, Biografie dei capitani venturieri
dell'Umbria,III, Montepulciano 1846, Passim;L. Bonazzi, Storia di Perugia dalle origini al 186o,II, Perugia 1879, passim;F. T.
Perrens, Histoire de Florence depuis la domination des Médicis jusqu'à la chute de la Rèpublique,III, Paris 189o, passim;G. Sanesi, La
partenza di M. B. da Firenze,in Arch. stor. ital., s. 5, IX (1892), pp. 62-70; L. de Baglion, Pérouse et les Baglioni,Paris 1909,
passium;C.Roth, L'ultima repubblica fiorentina,Firenze 1929, passim;A. Valori, La difesa della repubblica fiorentina,Firenze 1929,
passim;P. Pieri, IlRinascimento e la crisi militare italiana,Torino 1952, pp. 512, 572, 576, 587-589, 592, 612.
Malatesta IV Baglioni (di Giampaolo)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Malatesta Baglioni il Giovane (Perugia, 1491 – Bettona, 24 dicembre 1531) è stato un condottiero italiano. Fu membro della nobile
famiglia dei Baglioni e figlio di Giampaolo Baglioni, Signore di Perugia, e di Ippolita Conti. Accompagnò suo padre nelle sue
imprese sin dalla tenera età, e all'età di 15 anni fu conte di Bettona. In seguito servì la Repubblica Veneziana catturando Lodi e
Cremona. Nel 1527 riuscì ad ottenere la Signoria di Perugia. Durante la Guerra della Lega di Cognac, Malatesta lasciò Perugia senza
combattere a Filiberto di Orange, capo dell'esercito Imperiale in Italia, e andò ad assumere il ruolo di difensore della Repubblica di
Firenze. Un accordo segreto con Papa Clemente VII e con gli Imperiali affermava che Malatesta avrebbe riottenuto la Signoria della
città al termine della sua condotta per Firenze. Il suo tradimento fu rivelato il 3 agosto, 1530, durante la Battaglia di Gavinana, in cui
le forze Fiorentine comandate da Francesco Ferrucci furono distrutte dall'esercito Imperiale anche grazie alle informazioni ricevute da
Malatesta. L'esclamazione di Ferrucci "Ahi traditor Malatesta!" è rimasta famosa. Avendo Baglioni rispettato il patto con il Papa
tradendo Firenze, gli fu permesso di tornare a Perugia il 20 settembre. Morì a Bettona l'anno seguente. È sepolto a Perugia nella
Basilica di San Domenico.
Collegamenti esterni Malatesta Baglioni, condottiero di ventura Giovanni Battista Vermiglioli, La vita e le imprese militari di
Malatesta IV Baglioni, 1838
Rodolfo Baglioni
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera
Rodolfo (o Ridolfo) Baglioni fu un condottiero dell'esercito del Sacro Romano Impero durante le Guerre Italiane del 1542. Nella
Battaglia di Ceresole, comandò la cavalleria leggera fiorentina. Partecipò anche alla Battaglia di Marciano nelle file dell'armata
fiorentino-Imperiale contro Siena. Inviato da Cosimo I fiorentino a sostenere Perugia nella sua resistenza all'assedio papalino, Rodolfo
Baglioni consegnò la città intera a Papa Paolo III tradendo le speranze di libertà dei perugini. Il 3 giugno 1540, presso il convento di
Monteluce, firmò il trattato di resa che permise al feroce Paolo III Farnese di impossessarsi della città e perpetrare stragi, ruberie,
distruzioni (oltre ottanta le torri abbattute, quelle delle famiglie nobili). Le truppe svizzere, fedelissime al papa furono squinzagliate
per la città, autorizzate ad ogni nefandezza. A sancire poi il dominio papale venne costruita la Rocca Paolina, artiglio simbolico che
l'odiato papa volle su Perugia, eretta proprio sulle rovine delle case della famiglia Baglioni.
Baglioni, Rodolfo
(1518-1554)
Dizionario Biografico degli Italiani
BAGLIONI, Rodolfo. - Nacque a Perugia il 1°luglio 1518 da Malatesta e da Monaldesca Monaldeschi di nobile famiglia orvietana.
Nel 1529, allorché Malatesta entrò al servizio della Repubblica di Firenze in lotta contro le forze congiunte imperiali e papali, al B.,
appena undicenne, fu affidato il comando di cinquanta cavalieri con una provvigione di 250 fiorini- Alla morte del padre (1531), il B.
si ritirò nel feudo di Bettona, avendolo Clemente VII bandito da Perugia e dichiarato ribelle. Solo con la morte del pontefice, il B. e il
cugino Giampaolo poterono rientrare nella città difesa da Braccio Baglioni espugnando il palazzo del governatore e uccidendo Cinzio
Filonardi, vescovo di Terracina, vicelegato pontificio. Le truppe inviate da Paolo III, nel 1535, per ristabilire la situazione,
sbaragliarono le forze del B. che, privato di feudi e castelli, entrò al servizio di Alessandro de' Medici. Combatté contro i fuorusciti
fiorentini a Montemurlo, al comando di novecento cavalieri, e assisté poi alla proclamazione di Cosimo a duca di Firenze, come si
osserva in un affresco del Vasari nella sala detta di Cosimo I in Palazzo Vecchio.
Scoppiata nel 1540 tra il papa e Perugia la "guerra del sale", il governo perugino si rivolse al B. per organizzare la difesa.
Il B., cui nel 1538 erano stati restituiti dal pontefice i beni confiscati, sconsigliò il - ricorso alle armi, ma Cosimo I, preoccupato delle
ambizioni espansionistiche di Paolo III, lo convinse a cedere alle pressanti richieste dei Perugini, nonostante le assicurazioni in
contrario inviate al papa. Salutato come un liberatore, il B. entrò a Perugia il 16 maggio 1540. Sebbene la situazione fosse ormai
disperata, il B. concentrò le forze contro le truppe pontificie, che marciavano su Perugia attraverso Ponte San Giovanni, e riuscì a
batterle a Fontenuovo, a Borgo Sant'Antonio e a Monteluce. Mancando però vettovaglie e denari, pattuì di lì a poco col commissario
pontificio Girolamo Orsini la resa della città, effettuatasi il 4 giugno, salvi la vita ed i beni dei cittadini. Il B. indirizzò
contemporaneamente al cardinale Alessandro Farnese una lettera che delinea abbastanza nettamente il suo atteggiamento ambiguo nel
desiderio di non compromettere i buoni rapporti col papa: il che tuttavia non gli valse la conservazione dei feudi.
Tornato al servizio del duca di Firenze, il B. fu inviato nel 1543 a fortificare Volterra e i luoghi vicini, in seguito alla congiura ordita
in Siena dai Salvi per cedere Porte Ercole ai Francesi. Nel 1544 prese parte alla battaglia di Ceresole come capitano generale della
cavalleria che Cosimo de' Medici aveva inviato al campo imperiale contro i Francesi. Sconfitto dal maresciallo Paul de Termes, il B.,
pur essendo ferito, riuscì a ricomporre le schiere, per impedire al vincitore duca d'Enghien di marciare su Milano, e partecipò alla
vittoria su Piero Strozzi avvenuta fra Novi e Serravalle nel giugno 1544. Condusse quindi la cavalleria medicea a Ratisbona, per
unirla alle truppe di Carlo V. Dopo la pace di Crépy, partecipò alla guerra smalcaldica al comando di duecentocinquanta cavalleggeri.
Ritornato in Italia dopo la vittoria imperiale, Giulio III gli affidò l'incarico di occupare Castro. In riconoscimento dei servigi resi,
ottenne finalmente la restituzione dei beni, con breve datato 16 ott. 1551;il 10 novembre ritornò a Perugia e provvide
all'amministrazione dei feudi, che il 7 settembre successivo affidò allo zio, Leone Baglioni.
Passato di nuovo al servizio del duca di Firenze, il B. fu inviato, al momento della sollevazione senese, a Colle Val d'Elsa e a San
Gimignano, allo scopo di prevenire eventuali attacchi delle truppe francesi. Scoppiata nel 1553 la guerra di Siena, restò al servizio del
duca di Firenze, ottenendo, oltre al comando della cavalleria ducale, anche quello delle milizie di Cortona, Arezzo, Montepulciano e
Val d'Arno.
Nel corso della guerra fu a Pisa, poi a Volterra, come comandante della piazza, a Staggia, a Montepulciano, e partecipò alla presa
dell'Aiuola e di Lucignano, avvenuta il 2 luglio 1553. Alla fine dello stesso anno gli fu affidata una parte di primo piano nell'attacco
che contro Siena avrebbero dovuto sferrare le truppe mediceo-imperiali: mentre a Federico da Montauto era affidato il compito di
attaccare dal litorale tirrenico le città di Massa, Grosseto e Castiglion della Pescaia, il B., al comando di tremila fanti, avrebbe dovuto
invadere la Valdichiana, occupare Chiusi, Pienza e Montalcino, quindi unirsi al terzo contingente rimasto nei pressi di Siena agli
ordini del marchese di Marignano. L'azione non ebbe tuttavia successo: il B., attraversata la Valdichiana e tentato invano di
impadronirsi di Pienza, si diresse contro Siena, senza aver potuto occupare alcuno dei luoghi prestabiliti, mentre le sue retrovie
dovevano subire l'attacco degli archibugieri senesi; anche il Montauto fallì la sua missione.
Nel marzo 1554 il B. partecipò all'azione militare organizzata da Ascanio Della Cornia in Valdichiana, Giunto sotto Chiusi, il Della
Cornia tentò di impadronirsi della città col tradimento, ma una spia, Santaccio da Cutignano, ne informò il difensore, Gìovacchino
Guasconi. I franco-senesi attesero che l'esercito mediceo passasse il ponte della Chiana per assalirlo improvvisamente, impedendo,
con l'occupazione del ponte, la ritirata. Durante questo scontro del 24 marzo 1554 il B. rimase ucciso da una archibugiata.
Fonti e Bibl.: A. Sozzini, Diario delle cose avvenute in Siena dai 20luglio 1550ai 28giugno 1555,in Arch. stor. ital.,II(1842), 193,
531, 534, 592; G. Roffia, Narrazione del tradimento fatto da Santaccio da Cutigliano, ibid. pp. 528-536; C. Bontempi, Ricordi della
città di Perugia dal 1527al 1550, a cura di F. Bonaini, ibid.,XVI,2 (1851), passim; La guerra del sale ossia racconto della guerra
sostenuta dai Perugini contro Paolo III nel 1540 tratto dalle memorie di Giacomo di Frolliere,a cura di F. Bonaini, ibid., passim;G.
Canestrini-A. Desjardins, Négociations diplomatiques entre la France et la Toscane,III,Paris 1865, pp. 67, 96, 98, 100, 101, 108,112,
114, 116, 117, 118, 129; G. Spini, Lettere di Cosimo de' Medici,Firenze 1940, pp. 46, 48, 132, 139, 141; G. De Leva, Storia
documentata di Carlo V in correlazione all'Italia,III,Venezia 1867, pp. 504, 5o6; IV, Padova 1881, V. 165; L. de Baglion, Histoire de
la maison des Baglioni,Poitiers 1907, passim; L. Fumi, Ragguaglio della ribellione di Perugia,in Bollett. d. R. Deput. di storia patria
per l'Umbria,XIV(19o8), pp. 69-81; L. de Baglion, Pérouse et les Baglioni,Paris 1909, passim;L. v.Pastor, Storia dei Papi,V,Roma
1914, pp. 196 s.; VI, ibid. 1922, pp. 93, 98; G. Prunai, Ascanio della Cornia e la sorpresa di Chiusi (22-23marzo 1554), in Bullett.
senese di storia patria,n. s., IX(1938), pp. 101, 172; P. Pieri, Il Rinascimento e la crisi militare italiana,Torino 1952, pp. 576, 583,
586; A. D'Addario, Il problema senese,Firenze 1958, pp. 153, 176, 272, 274, 295; L. Bonazzi, Storia di Perugia dalle origini al 186o,
a cura di G. Innamorati, II, Città di Castello 196o, pp. 103, 106, 107, 113, 117, 138-149, 162.
Colonna, Fabrizio
(1450/60 - 1520)
Dizionario Biografico degli Italiani
di FF. Petrucci
COLONNA, Fabrizio. - Nacque con ogni probabilità tra il 1450 e il 1460 da Odoardo, duca dei Marsi, e da Covella (Jacovella) di
Celano.
Nel 1465, alla morte del padre, Ferdinando d'Aragona, re di Napoli, gli confermò insieme ai cinque fratelli il ducato dei Marsi.
Destinato, a detta di tutti i genealogisti, alla carriera ecclesiastica, nel 1481 il C. fuggì di casa per unirsi alle truppe napoletane che
fronteggiavano i Turchi a Otranto. Con l'inizio delle ostilità nella primavera del 1482 fra Venezia alleata di Sisto IV, e gli Este,
sostenuti dal re di Napoli oltre che da Firenze e Milano, il pontefice richiamò al suo servizio i baroni romani al soldo del sovrano
napoletano. Aderirono all'invito soltanto gli Orsini, Mentre la maggior parte dei Colonna, fra cui il C., e i Savelli rimasero nel
Napoletano prima e seguirono subito dopo Alfonso, duca di Calabria, in armi nella Campagna romana. Il 26 ottobre il papa colpì con
la confisca dei beni il C., insieme con due fratelli e il cugino Prospero. Il rovesciamento delle alleanze, che portò alla pace fra il
pontefice e la lega nel dicembre 1482, e il soggiorno in Roma del duca di Calabria come alleato, indussero alla pacificazione i
Colonna e gli Orsini.
Si stipulò un accordo per cui il protonotario Lorenzo, fratello del C., sarebbe rientrato in possesso di Lavinio, purché avesse ceduto il
coontado di Albe e Tagliacozzo a Virginio Orsini, ricevendo da questo la somma di 14.000 ducati. Le trattative per la cessione di
questo contado, che era stato riconfermato dal re di Napoli al C. e ai fratelli con diploma del 15 nov. 1480, si prolungarono per
parecchio tempo, e, mentre Lorenzo era propenso a non rompere le trattative, il C. era contrario ad accettare la cessione del contado.
Nel 1483 il C. fu in Abruzzo per organizzare la difesa delle terre sue e dei fratelli, ma nel gennaio 1484 era di nuovo in arme a Roma
contro gli Orsini. Fallita nei mesi successivi ogni ipotesi di una nuova pacificazione, nonostante che ora il C. fosse disposto a cedere il
contado di Albe e Tagliacozzo, nel maggio fu preso prigioniero Lorenzo, le case dei Colonna furono distrutte e il C. fuggì a Marino,
difendendola strenuamente dagli attacchi delle truppe pontificie, guidate da Paolo Orsini e da Gerolamo d'Estouteville. Nel tentativo
di salvare il fratello, che venne invece ugualmente ucciso dopo cinque giorni, il 15 giugno il C. cedette la rocca della cittadina. Alla
fine di luglio, arresesi Cave, Capranica, Montecompatri, il C. si assoggettò al pontefice e il giorno 29, insieme con Antonello Savelli,
prestò giuramento di fedeltà alla Chiesa nelle mani del camerlengo.
La strenua difesa di Paliano e soprattutto la morte di Sisto IV capovolsero la situazione e, mentre Gerolamo Riario e gli Orsini
abbandonavano il campo precipitosamente, i Colonna, compreso il C., rientrarono a Roma con uno stuolo di armati, mentre le loro
terre nel Lazio tornavano sotto la loro potestà. Il conclave fu rimandato fino a che venne concluso il 25 agosto un accordo fra le varie
fazioni.
Innocenzo VIII non si mostrò sfavorevole ai Colonna, ma già nel marzo 1485 erano risorte le contese. Dopo un tentativo del papa di
interporsi per indurre i contendenti alla pace, cui più palesemente si opposero gli Orsini, in giugno i Colonna e i Savelli intrapresero
una spedizione contro Frascati, dove catturarono Gerolamo d'Estouteville, conducendolo prigioniero a Rocca di Papa. Si portarono
quindi a Nemi, ove era la moglie dell'Estouteville, prendendo prigioniera anch'essa. In questa operazione il C. fu ferito da una freccia.
Dopo questi episodi favorevoli ai Colonna le sorti della guerra parvero rovesciarsi in favore degli Orsini, che avevano preso le difese
degli Estouteville, e Solo il 20 luglio i Colonna furono in grado di riorganizzarsi, dopo un rovescio subito ad opera di Paolo Vitelli. A
questo punto il papa convocò il C. con il cugino Prospero e con Virgilio Orsini, riuscendo a far cessare le ostilità e a farsi consegnare i
castelli.
Poco prima che la ribellione dell'Aquila accendesse la miccia della rivolta dei baroni del Regno contro Ferdinando d'Aragona, che
provocò la guerra fra quest'ultimo, sostenuto da Milano e Firenze, ed il pontefice, alleato di Venezia e di Genova, i Colonna che
avevano combattuto contro gli Estouteville, insieme ai Savelli ed ai Caetani, si strinsero in un patto con questi ultimi e il 5 sett. 1485 il
C. con il cugino Prospero firmò un accordo secondo il quale le due famiglie si promettevano aiuto reciproco e i due Colonna si
impegnarono a non militare se non nello stesso campo di Nicola Caetani. E in effetti, mentre gli Orsini si schieravano con Ferdinando,
gli altri tre furono assoldati dal papa.
Il C. dapprima fu inviato a presidiare l'Aquila, dove era, insieme con Prospero, con Giovanni Savelli e con il legato pontificio quando
scoppiò la rivolta, ma poi fu richiamato nella Campagna romana, ove i Colonna e gli Orsini avevano ripreso la lotta, mentre Alfonso
di Calabria si dirigeva a Roma e Roberto Sanseverino era posto a capo dell'esercito pontificio. Il C. partecipò quindi alla battaglia di
Montorio (7 maggio 1486), che vide l'esercito pontificio comandato dal Sanseverino sconfitto di stretta misura.
Prima e dopo di essa, il C. tentò invano di riconquistare Albe e Tagliacozzo, concesse agli Orsini da Ferdinando. Non riebbe però la
contea neanche alla fine della guerra (11 agosto) e si dovette accontentare di avere in cambio Lavinio. Il papa volle anche che si
giungesse ad una riconciliazione e, ottenuta la consegna delle terre occupate dai Colonna, nominò una commissione di quattro uditori
di Rota per definire le questioni pendenti fra gli Estouteville e i Colonna stessi.
Successivamente il C. tornò ai servizi di Ferdinando d'Aragona, che mostrava di tenerlo in gran conto e nel marzo del 1492 gli mandò
in regalo un cavallo. Nello stesso anno, mentre a Roma era riunito il conclave successivo alla morte di Innocenzo VIII, il re ordinò al
C. e al cugino Prospero di avvicinarsi discretamente all'Urbe e di tenersi a disposizione del cardinale Della Rovere.
Ritiratosi quest'ultimo nel castello di Ostia, dopo l'elezione di Alessandro VI, il C. prese posizione in suo favore, ma nella primavera
fu richiamato da re Ferdinando nei suoi feudi napoletani, mentre il papa, Milano e Venezia si stringevano in lega.
Nel febbraio del 1494 erano in atto le trattative per la riconferma della condotta del C. e del cugino. Alfonso II, successo al padre un
mese prima, si diceva deciso ad averli ambedue o almeno uno al suo servizio, mentre anche Ludovico il Moro era desideroso di
assoldarli. Il C., allora a Napoli, pareva propenso a porsi agli stipendi dell'Aragonese, ma nel maggio gli ambasciatori di Carlo VIII a
Roma lo assoldarono insieme col cugino Prospero Colonna. Il mese prima il C. si era interposto con successo, dopo la fuga del card.
Della Rovere in Francia, fra il papa e i difensori del castello di Ostia; il che gli era valso l'acquisto di Grottaferrata.
Mentre Carlo VIII discendeva trionfalmente l'Italia, il C. e il cugino posero il campo vicino Frascati con 4.000 uomini e 600 cavalli. Il
18 settembre il C. assaltò il castello di Ostia, occupandolo in nome del re di Francia. Il 6 ottobre il pontefice intimò al C. e agli altri
baroni romani partigiani dei Francesi di tornare all'obbedienza entro sei giorni. Naturalmente nessuno di loro si presentò e Alessandro
VI fece distruggere le case dei Colonna. Nella città i due cugini tornarono soltanto con Carlo VIII, quando questi entrò nell'Urbe
l'ultimo giorno del 1494. Prima di riavviarsi verso il Regno, il re inviò il C. in Abruzzo, dove i Francesi furono accolti dalla
sollevazione dei contadini contro gli Aragona. Dopo l'ingresso di Carlo VIII a Napoli (22 febbr. 1495) al C. fu resa la contea di Albe e
Tagliacozzo, da lui preventivamente occupata.
Mentre stava terminando la breve avventura del sovrano francese in Italia e questi ripassava per Roma ai primi di giugno del 1495. il
C. era al suo seguito, ma molto probabilmente non fu presente alla battaglia di Fornovo (5-6 luglio). Il 5 agosto era in Abruzzo e
militava ancora nelle file francesi. Fu probabilmente nel mese successivo che si pose al soldo di Ferrandino.
Era a Napoli presso il re, quando il 10 ottobre questi affrontò il d'Aubigny, prima che i Francesi si rinchiudessero a Gaeta. Il 20
ottobre il sovrano francese dichiarava il C. decaduto dalla contea di Albe e Tagliacozzo, che passava a Virginio Orsini. Nel gennaio
1496 il C. combatteva davanti a Gaeta contro il presidio francese con centoventi uomini d'arme, trecento svizzeri e molti fanti, agli
ordini del principe di Altamura, Federico d'Aragona. Nel marzo era in campo contro Marzano e Conca e davanti a Pietra Melara il
principe Federico, chiamato a Napoli, gli lasciò il comando dell'esercito ed egli conquistò il castello della cittadina. Si preparò quindi
ad affrontare Virginio Orsini, che nel Regno sosteneva i Francesi. Nell'aprile. il C. assolse all'incarico di condurre a Foggia, ov'era il
re, seicento tedeschi, che erano a Troia; costoro però non vollero ubbidirgli e, presa la via di Nocera, vi incontrarono l'esercito
nemico, che li annientò. Dopo aver partecipato nel giugno-luglio al decisivo vittorioso assedio di Atella, il C. nell'agosto fu di nuovo
utilizzato contro Gaeta. Il 10 sett. 1496 era all'Aquila, che ridusse sotto il dominio degli Aragonesi.
Intanto Alessandro VI, che subito dopo il ritiro di Carlo VIII aveva infierito contro i Colonna, confiscando al C. la rocca di Ardea, con
tutta l'artiglieria che conteneva, nella sua avidità di arricchire i figli si era volto contro gli Orsini, di cui nel giugno aveva confiscato
tutti i beni. Il 26 ottobre il papa celebrò, dopo la decisione di iniziare una spedizione guidata dal figlio Giovanni e da Guidubaldo da
Montefeltro contro i baroni romani suoi nemici, una messa cui era presente anche il C., postosi al suo servizio. In breve caddero nelle
mani dell'esercito pontificio Anguillara, Formello, Cesano, Campagnano, Sacrofano, Blera, Bassano di Sutri, ma resistette Bracciano
e il 23 genn. 1497 avvenne la battaglia di Soriano, che vide i Pontifici - ed il C. - nettamente sconfitti dagli Orsini. Tornato
evidentemente al servizio degli Aragonesi, nell'aprile il C. ebbe da re Federico l'incarico di ricondurre all'Aquila i fuorusciti.
L'8 dello stesso mese il sovrano, alla cui incoronazione il C. avrebbe di lì a poco assistito, gli concesse la riconferma della contea di
Albe e Tagliacozzo, la baronia di Valle Roveto con il castello di Capistrello ed inoltre una pensione annua di 6.000 ducati, con
l'obbligo di mantenere quaranta soldati al suo servizio.
A metà agosto però riprese la lotta fra gli Orsini, desiderosi di vendetta, ed i Colonna; i Conti, infatti, partigiani degli Orsini,
occuparono allora Torre Mattia, riaccendendo la miccia fra le due fazioni. Dopo un fallito tentativo di riconciliazione fatto dal papa
nel gennaio 1498 i Colonna, con alla testa Fabrizio e Prospero, riconquistarono Torre Mattia e Zancato, misero a sacco Segni,
Gavignano, Valmontone, Ariccia. La lotta culminò con la vittoria dei Colonna nellabattaglia di Palombara (12 aprile). L'8 luglio 1498
le due parti, addivennero ad un altro patto diconcordia; furono restituite le terre conquistate da una parte e dall'altra e fu eletto arbitro
per l'assegnazione della contea di Albe e Tagliacozzo Federico d'Aragona, il quale il 3 febbraio dell'anno dopo l'assegnò al Colonna.
Dopo la conquista del Milanese da parte di Luigi XII e la conclusione del minaccioso trattato di Granada (11 nov. 1500), la spedizione
transalpina controil Regno si fece imminente. Mentre i Francesi cominciavano a dirigersi al Sud, i Colonna, compromessi con gli
Aragona, dovettero affidare al papa ed al Sacro Collegio le loro terre nel Lazio, ed il 22 giugno il C., dietro pagamento di 2.000
ducati, consegnò Marino, Rocca di Papa ed altre località a Alessandio VI, che insisteva per avere anche Ardea. Infatti come il
pontefice si mostrava antiaragonese, dichiarando il 25 giugno 1501 Federico decaduto, così era divenuto contrario ai Colonna.
Contemporaneamente il C. faceva uccidere a Roma i messi di alcuni baroni napoletani, che venivano a parlamentare con il d'Aubigny
e questi rispose facendo mettere a ferro e a fuoco Marino, Cave ed altre località dei Colonna e requisire poi la contea di Albe e
Tagliacozzo, concedendola a Gian Giordano Orsini, mentre Cesare Borgia si impadroniva di Rocca di Papa.
Affidatagli da re Federico la difesa di Capua, non poté impedire, che la città, dopo quattro giorni di bombardamento, fosse conquistata
e saccheggiata, il 10 luglio; egli stesso fu, fatto prigioniero da François de La Trémoille, che pretese per il riscatto 14.000 ducati.
Il suo nemico personale, Gian Giordano Orsini, ebbe modo di agire secondo i dettami della cavalleria, offrendogli i denari per pagare
il riscatto, ma il C. non accettò e, fatta vendere la sua argenteria, chiuse, pagando il riscatto, questo episodio poco glorioso della sua
carriera.
Nell'agosto del 1501, insieme al cugino Prospero, il C. accompagnò ad Ischia re Federico quando questi vi si trasferì, prima di
abbandonare definitivamente il Regno per il suo esilio francese. In quello stesso mese il papa, sempre desideroso di acquistare beni
per i figli e ormai nemico giurato dei Colonna, li bandì, insieme ai Savelli, agli Estouteville ed ai Caetani, e ne confiscò i beni, in
attesa di volgersi l'anno dopo contro gli Orsini.
Dopo questi episodi il C. associò le sue fortune a quelle degli Spagnoli e al soldo di questi entrò a far parte dell'esercito comandato da
Consalvo di Cordova.
Mentre si svolgeva fra Francia e Spagna con alterne fortune la campagna in Calabria, Consalvo di Cordova si asserragliò a Barletta,
mentre i Francesi, con alla testa il duca di Nemours, si disseminavano da Cerignola a Terlizzi. Nella guerra di colpi di mano che
dinecessità si svolse allora, ebbe un ruolo importante il C. alla testa della sua cavalleria leggera. Ai primi di febbraio del 1503 i
combattenti italiani della disfida di Barletta furono scelti nelle schiere del C., di Prospero Colonna e del duca di Termoli. Nello stesso
mese era avvenuta una puntata offensiva di Consalvo di Cordova contro Ruvo di Puglia, che, lasciata indifesa dall'esercito francese
spostatosi contro Castellaneta in rivolta, si lasciò sorprendere. Il C. si distinse nell'assalto della cittadina.
Il 27 aprile - avvenuta in Calabria l'ultima battaglia di Seminara, che aveva visto sgominato l'esercito francese - Consalvo di Cordova
prese l'iniziativa e uscito da Barletta con tutte le truppe affrontò, il 28, i Francesi a Cerignola. Il C., che con la sua cavalleria leggera
era all'ala sinistra, sostenne una parte secondaria nella vittoriosa battaglia, anche se alcune sue disposizioni difensive si rivelarono
importanti nell'andamento dello scontro. Il giorno dopo il C. fu inviato dal condotticro spagnolo in Abruzzo.
Il 18 agosto, tre mesi circa dopo l'occupazione di Napoli da parte degli Spagnoli, morì Alessandro VI. Immediatamante gli Orsini ed i
Colonna si portarono a Roma. Il C. vi giunse con molte genti d'arme, fornitegli da Consalvo di Cordova, rimanendovi finché le
trattative che il cugino Prospero conduceva con Cesare Borgia non fallirono ed il Collegio dei cardinali il 1° settembre non ingiunse al
Valentino e ai Colonna di lasciare la città entro tre giorni.
Alla medesima epoca Consalvo di Cordova aveva raggiunto Sessa, per muovere poi contro Gaeta, dove si erano concentrate le forze
francesi. Unitosi alle avanguardie spagnole, il C. fu incaricato di occupare Montecassino con un colpo di mano, che però non riuscì.
Quando, dopo l'accordo contro il Borgia stretto dagli Orsini e dai Colonna il 13 ottobre, i Francesi il 21 si accamparono a Pontecorvo,
il C. compì con la sua cavalleria leggera azioni di disturbo, molestando la retroguardia nemica e impedendo ai Transalpini di passare il
Garigliano presso Rocca d'Evandro. Ai primi di novembre i due eserciti finirono con l'attestarsi a Traetto, sulle opposte sponde del
fiume; il C. ricevette l'incarico di disturbare i Francesi che mettevano il campo e fu inviato a contrastarli quando il 6 novembre essi
riuscirono a costituire una testa di ponte dalla parte del Garigliano, dove era accampato l'esercito spagnolo. Ma quando il 28 dicembre
Consalvo di Cordova, fatto costruire un altro ponte, portò le truppe sull'opposta riva del fiume, dando inizio alla battaglia che avrebbe
risolto la guerra, il C., distaccato nel contado di Alvito, mancò un'altra occasione favorevole per distinguersi in una grande battaglia.
Quando il 23 marzo 1504 Francesco Maria Della Rovere, nipote di Giulio II, fece il suo solenne ingresso a Roma, il C., che aveva
recuperato tutti i possedimenti nella Campagna romana sottrattigli da Alessandro VI, fu uno dei personaggi che lo accolsero nell'Urbe.
Nel novembre il C., a ricompensa del suo fedele servizio, ebbe da Ferdinando il Cattolico la riconferma del contado di Albe e
Tagliacozzo, con altri feudi in Terra di Lavoro e in Abruzzo. Inoltre il 7 maggio 1507 ricevette la conferma dei 6.000 ducati annui, già
concessigli da Federico d'Aragona, ed il 14 giugno altri feudi in Abruzzo. Nel 1506 il C., il cui nipote Marcantonio, giusta il disegno
di Giulio II di amicarsi i baroni romani, sposò in quell'anno una nipote del papa, era stato ad accogliere a Napoli il sovrano spagnolo e
nella cavalcata che questi compì nella città aveva avuto l'incarico di sorreggere lo stendardo.
Dopo la lega di Cambrai (10 dic. 1508) Venezia avrebbe voluto assoldare il C., che però non accondiscese e rimase al servizio della
Spagna; peraltro, inviato in Puglia contro le città che i Veneziani avevano occupato otto anni prima, indusse il viceré a procedere con
lentezza nelle operazioni militari. Dopo il rovesciamento delle alleanze operato da Giulio II, il C., alla testa di un contingente di
truppe spagnole, fu inviato a dar man forte all'esercito pontificio. Così quando il 10 ott. 1510 i Francesi tentarono di impadronirsi di
Bologna, il C. al comando di trecento spagnoli riuscì - per quella volta - a farli desistere. Partecipò quindi all'assalto vittorioso del
castello della Mirandola, subendo poi però con l'esercito pontificio i rovesci che portarono alla perdita di Bologna (maggio 1511).
Dopo il tumulto sorto a Roma a metà agosto, alla falsa notizia della morte del papa, questi riuscì a mediare un ennesimo atto di
concordia fra i Colonna e gli Orsini, firmato per sé e per i parenti e per gli aderenti Il 28 agosto dal C., che il giorno successivo
partecipò nella chiesa romana dell'Aracoeli ad una cerimonia di pacificazione presente anche Giulio Orsini.
Conclusa il 5 ott. 1511 la lega santa, il C. fu nominato governatore generale dell'esercito della lega, alle dipendenze del viceré di
Napoli Raimondo Cardona, capitano generale. L'11 apr. 1512 partecipò alla battaglia di Ravenna, tentando invano di modificare le
disposizioni tattiche del Cardona, che costarono la disfatta agli Ispano-pontifici.
Fatto prigioniero dal duca di Ferrara, quando questi si recò a Roma per trattare direttamente con il pontefice la sorte del suo Stato, il
C. fece parte del corteggio estense, libero sulla parola, ma con l'obbligo di tornare a Ferrara se le trattative fossero fallite. Accolto
affettuosamente da Giulio II come "uno dei liberatori d'Italia", il C. si espose poi all'ira del papa tentando di perorare la causa di
Alfonso d'Este; e, temendo l'arresto del duca, con lui e con Marcantonio Colonna fuggì da Roma forzando il passaggio a porta S.
Giovanni.
Morto pochi mesi dopo Giulio II, il C. l'11 apr. 1513 si recò presso Leone X ad ossequiarlo e a congratularsi con lui per la sua
elezione. Anche con questo papa pero i rapporti del C. non furono senza contrasti, poiché nel 1516, durante la guerra d'Urbino, il
pontefice gli indirizzò contro dei monitori, perché aveva preso posizione in favore dei Della Rovere.
Nominato il 20 dic. 1515 gran connestabile del Regno di Napoli, il C. morì ad Aversa il 20 marzo 1520 e fu seppellito a Paliano.
Aveva sposato Agnese, figlia di Federico da Montefeltro, duca di Urbino; aveva avuto sei figli: Ascanio, Federico, che era morto
diciannovenne al servizio di Massimiliano, Camillo, Sciarra, figlio naturale, la celebre Vittoria, moglie di Ferdinando d'Avalos, e
Beatrice, moglie di Rodolfo da Varano.
Il C., un ritratto del quale è, secondo P. Colonna (I Colonna..., p. 105), nel palazzo Colonna a Roma, fu il protagonista dell'opera di A.
Nifo, De regnandi peritia e a lui N. Machiavelli nell'Artedella guerra fece esporre le sue opinioni sull'arte militare. L'Ariosto lo cita
nel XIV canto dell'Orlando furioso (4-5).
Il C., che, pur cadetto, divenne uno dei membri più importanti della sua potente famiglia, anche se non riuscì a compiere alcuna
impresa bellica veramente considerevole, seppe dare il suo apporto alla tattica se non alla strategia dell'epoca e fu considerato uno dei
maggiori capitani del suo tempo.
Fonti e Bibl.: G. A. Prato, Storia di Milano, in Arch. stor. ital., III (1842), p. 293; Cronica di Napoli di notar Giacomo, a cura di P.
Garzilli, Napoli 1845, pp. 239, 241, 261; F. Trinchera, Codice araconese, II, 1, Napoli 1868, pp. 46, 54 s., 141, 143, 366, 383; II, 2,
ibid. 1870, pp. 36, 43, 55, 70, 101 s., 112 s., 157, 159 s.; M. Sanuto: La spediz. di Carlo VIII in Italia, a cura di R. Fulin, in Arch.
veneto, III (1873), pp. 574 s., 632, 669; Id., Diarii, I-XXVIII, Venezia 1879-1890, ad Indices; S. de' Conti da Foligno, La storia de'
suoi tempi..., a cura di G. Racioppi, Roma 1883, I, pp. 132, 191, 193, 246; II, pp. 65, 238, 240, 308. 317, 319; P. Grassi, Le due
spediz. milit. di. Giulio II, a cura di L. Frati, Bologna 1886, pp. 203, 211; S. Infessura, Diario della città di Roma, a cura di O.
Tomasini, Roma 1890, pp. 112, 135, 148, 150, 164 s., 180, 185, 191, 199, 246, s., 274, 290; V. Colonna, Cart., a cura di E. Ferrero G. Müller, Torino 1892, ad Indicem; J. d'Auton, Chroniques de Louis XII, a cura di R. de Maulde La Clavière, II, Paris 1891, pp. 30,
61, 64; III, ibid. 1893, p. 390; Quattro cronache e due diarii inediti relativi ai fatti dell'Aquila, a cura di G. Pansa, Sulmona 1902, pp.
65, 70 ss., 75, 79; Crónicas del Gran Capitán, a cura di A. R. Villa, Madrid 1908, ad Indicem; Regis Ferdinandi primi instructionum
liber, a cura di L. Volpicella, Napoli 1916, pp. 319 s.; F. Guicciardini, Storia d'Italia, a cura di C. Panigada, I-III, Bari 1929, ad
Indicem; P. Giovio, Le vite del gran capitano e del marchese di Pescara, a cura di C. Panigada. Bari 1931, ad Indicem. B. Dovizi da
Bibbiena, Epistolario, a cura di G. L. Moncallero, I, Firenze 1955, pp. 47, 56, 239, 250, 360, 396, 410, 414, 423, 437, 441 s., 473; N.
Machiavelli, Legazioni e commissarie, a cura di S. Bertelli, Napoli 1964, I, p. 180; II, p. 864; III, p. 1325; Id., Arte della guerra e
scritti politici minori, a cura di S. Bertelli, Milano 1961, adIndicem; Il Diario romano di J. Gherardi, in Rer. Ital. Script. 2 ed., XXIII,
3, a cura di E. Carusi, p. 135; Diario romano di S. di Branca Tedallini, ibid., a cura di P. Piccolomini, pp. 291, 294 ss., 304, 307, 329
ss., 334, 341, 345; Il diario della città di Roma... di A. de Vasco, ibid., a cura di G. Chiesa, pp. 501, 527, 536 s.; I. Burchardi, Liber
notarum, I, ibid., XXXII, 1, a cura di E. Celani, p. 534; II, pp. 217, 284, 437; A. Coppi, Memorie colonnesi, Roma 1855, pp. 216, 220,
222, 228-36, 244 ss., 249 s., 252, 255-66, 268-71; F. Ranalli, F. C., in Vite di romani ill., IV, Roma 1891, pp. 189-204; F.
Gregorovius, St. della città di Roma, IV, Roma-Torino 1902, ad Indicem; A. Luzio, Isabella d'Este di fronte a Giulio II, in Arch. stor.
lomb., s. 4, XVII (1912), pp. 260, 272, 277, 285; XVIII(1912), pp. 79 s., 95, 102, 105 s., 427 s., 430 s.; A. Dina, Isabella d'Aragona...,
ibid ., s. 5, VIII, (1921), pp. 395 ss., 415-18, 437; G. Caetani, Domus caietana, I, 2, San Casciano Val di Pesa 1927, pp. 23, 187, 190,
193 s., 217, 222, 236, 260, 263 s.; P. Colonna, IColonna..., Roma 1927, pp. 91-117, 124-35, 147 s., 341 s., 344 s.; C. Argegni,
Condottieri, capitani, tribuni, I, Milano 1936, pp. 182 s.; P. Pieri, La battaglia del Garigliano del 1503, Roma 1938, pp. 5, 7, 16, 18,
21, 30, 63 s., 68, 80; P. Paschini, Roma nel Rinascimento, Bologna 1940, ad Indicem; J. E. Martinez Ferrando, Privilegios otorgados
por el emp. Carlos V en el reino de Nápoles, Barcelona 1943, pp. 80 ss., 146, 219; P. Pieri, La guerra franco-spagnuola..., in Arch.
stor. per le prov. nap., n. s., XXXIII (1952), pp. 31 ss., 41 ss., 46 s., 59 s.; Id., Il Rinascimento e la crisi militare ital., Torino 1952, ad
Indicem; Id., Consalvo di Cordova e la battaglia di Cerignola, in Arch. stor. Pugliese, V (1952), pp. 270 s., 275, 277; Id., Consalvo di
Cordova e i condottieri ital., in Quaderni ibero-americani, XIV (1953), pp. 343, 346 s.; A. Ilari, Docum. per la storia di Frascati, III, I
d'Estouteville ed i Colonna, in Archivi, XXIII (1956), pp. 154 s., 158; L. von Pastor, Storia dei papi, II, Roma 1961, pp. 560, 573; III,
ibid. 1925, ad Indicem; P. Litta, Le famiglie celebri ital., sub voce Colonna, tav. VII.
Colonna, Prospero
(1460 - 1522)
Dizionario Biografico degli Italiani
di FF. Petrucci
COLONNA, Prospero. - Nacque a Lavinio (Roma) da Antonio principe di Salerno ed Imperiale di Stefano Colonna, più
probabilmente che da Antonella Cantelmo, figlia del conte di Pepoli.
Sulla data di nascita del C. permangono molte incertezze: con ogni probabilità essa va posta intorno al 1460, ma non mancano storici
che la anticipano, di dieci anni alcuni, di venti altri. Allo scoppio della guerra di Ferrara il C. era agli stipendi della Chiesa, ma alla
pretesa di Sisto IV che egli consegnasse i suoi possedimenti nella Campagna romana, il 22 maggio 1482, pur avendo ricevuto parte
del soldo, si licenziò, passando al servizio di Alfonso d'Aragona, che si era portato nei dintorni di Roma.
Neanche al duca di Calabria, il C., che era al comando di cento uomini d'arme, con una provvisione annua di 13.000 ducati, volle
consegnare Marino e l'esercito napoletano si accampò vicino alla cittadina. Il 21 agosto il C. partecipò alla battaglia di Campomorto,
in cui il condottiero pontificio, Roberto Malatesta, riportò la vittoria sui Napoletani e sui Colonnesi. Dopo pochi giorni egli perdeva
Marino e Lavinio, che si arrendevano. Nonostante questi avvenimenti le scorrerie dei collegati, nella Campagna romana, favorite
anche dalla morte del Malatesta, ripresero, arrivando fino a Roma. Contro il C. e tre cugini di lui il 26 ottobre il papa decretava così la
confisca dei beni.
Quando pochi mesi dopo da nemici il pontefice e Ferdinando d'Aragona divennero alleati e il duca di Calabria venne in visita a Roma,
ricevuto da amico, anche l'atteggiamento reciproco fra Sisto IV ed i Colonna dovette mutare. In base a questa riconciliazione Lorenzo
Colonna, cugino del C., avrebbe dovuto restituire a Virginio Orsini Albe e Tagliacozzo. Le trattative si trascinarono ancora a lungo,
fino a che nel gennaio del 1484 gli Orsini ruppero gli indugi, cacciando Antonello Savelli, partigiano dei Colonna, da Albano. Il C.
prese attivamente parte agli scontri che si accesero allora fra le due fazioni e quando Lorenzo Colonna convocò tutti i consorti a Roma
anch'egli si unì ai parenti e aderenti.
Questi però il 30 maggio furono sbaragliati da un attacco in forze degli Orsini, i quali presero anche Lorenzo Colonna prigioniero.
Trasferitasi ancora una volta la lotta nella Campagna romana, le milizie pontificie si impadronirono di Marino prima, poi di
Montecompatri, Cave, Capranica, mentre le prede passavano da una mano all'altra. Il 5 agosto Gerolamo Riario e Virginio Orsini
posero l'assedio a Paliano, difesa dal Colonna. Uno dei primi provvedimenti preso dal C. fu quello di inviare a Genazzano i figli dei
maggiorenti del luogo, per indurre questi a desistere da ogni tentazione di tradimento. La determinazione e l'intransigenza del C. in
questo periodo sono notevoli. Sembra infatti che abbia ucciso di sua mano e fatto poi squartare un certo Romanello Corsetto, che non
aveva difeso con sufficiente decisione Capranica. Il C., che aveva l'aiuto di Girolamo Caetani con cinquecento fanti dell'Aquila, si
difese validamente effettuando anche abili sortite. La sua situazione non si presentava come estremamente pericolosa, ma non avrebbe
potuto probabilmente protrarsi per molto tempo. La morte di Sisto IV pose termine alla sua precarietà, poiché il campo pontificio alla
notizia del decesso cominciò a prepararsi precipitosamente alla partenza. Del che accorgendosi gli assediati passarono al contrattacco,
costringendo i Pontifici ad abbandonare le artiglierie ed i carriaggi. Mentre i possedimenti dei Colonna tornarono nelle loro mani, le
operazioni militari cessarono di colpo e tutti gli esponenti delle varie fazioni, compreso il C., si portarono a Roma, rimanendovi fino
al 25 agosto, quando acconsentirono per un accordo con il Sacro Collegio ad allontanarsi dalla città.
Il nuovo pontefice, Innocenzo VIII, sembrò, al contrario del predecessore, favorevole ai Colonna ed il 25 dic. 1484 prese al suo
servizio il C. con l'obbligo di tenere trenta uomini d'arme e con una provvisione di 4.000 ducati annui. Nel marzo 1485 i contrasti
armati fra gli Orsini ed i Colonna erano però già ripresi ed il papa si era invano interposto fra loro.
In giugno il C. capeggiò una spedizione a Frascati contro Gerolamo d'Estouteville, che fu preso prigioniero. Subito dopo i Colonna si
diressero a Nemi e si impadronirono anche della moglie, Ippolita Orsini, e del figlio dell'Estouteville. Nei pressi di Lavinio, dove i
Colonna si erano congiunti con forze di Nicola Caetani, il 28 giugno però gli Orsini, accorsi in difesa dell'Estouteville, distrussero il
campo degli avversari. Si venne così a determinare una netta prevalenza dei collegati, che militavano contro i Colonna. Si combatté a
Marino, Nemi, Genzano, finché il 20 luglio i Colonna, capeggiati dal C. e dal cugino Fabrizio, furono in grado di reagire e di portarsi
contro Isola, Campagnano, Bracciano. Tornati a Roma, trascinando le prede fatte in quei luoghi, i due Colonna furono costretti dal
papa a rilasciarle ed a presentarsi dinanzi a lui. Con questo intervento il pontefice riuscì a rappacificare i contendenti.
Il 5 settembre 1485 il C. e Fabrizio Colonna si strinsero in un accordo con Nicola Caetani, insieme con il quale avevano combattuto
contro l'Estouteville. Con questo patto essi si impegnarono a non servire se non tutti e tre insieme e si promisero aiuto reciproco.
Iniziata nel Regno la rivolta dei baroni, cui dette avvio l'insurrezione dell'Aquila il 17 ottobre, mentre il C. si trovava nella città, e
trovato i ribelli l'appoggio del papa, questi chiamò a sé il C. e Fabrizio Colonna che, insieme con i Savelli, si confermarono al suo
servizio. Mentre Alfonso d'Aragona in armi si portava nella Campagna romana, il papa attendeva l'arrivo di Roberto Sanseverino, che
doveva guidare le sue truppe. I due Colonna, mentre costui si avvicinava, furono inviati contro Castelnuovo, che era stata fortificata
dagli Orsini per contrastare la marcia del condottiero. Il C. partecipò poi alla battaglia di Montorio (7 maggio 1486), che vide
l'esercito, pontificio sconfitto di misura.
Sottoscritta la pace l'11 agosto, il pontefice volle anche che si concludesse un patto di concordia fra i Colonna e gli Orsini, cui in
effetti si pervenne nel 1487: il papa ricevette in consegna le terre occupate dai Colonna, che lasciarono in libertà l'Estouteville, e
nominò una commissione per definire le questioni ancora pendenti fra le due famiglie. I rapporti dei Colonna con gli Orsini conobbero
allora un periodo di tranquillità e quando nel luglio del 1492 Innocenzo VIII si ammalò, il C. e Gian Giordano Orsini si recarono nel
palazzo dei Conservatori ad offrire in piena concordia i loro servizi al popolo romano.
Morto il papa (25 luglio), al C., che da epoca imprecisata militava insieme con il cugino al soldo del re di Napoli, quest'ultimo dette
ordine di stazionare discretamente nei pressi dell'Urbe a disposizione del cardinale Della Rovere.
In favore dei Della Rovere il C., il cugino e gli Orsini si pronunciarono quando fra il nuovo papa, Alessandro VI, ed il cardinale si
vennero a creare quei contrasti che portarono il Della Rovere prima a rinchiudersi nel castello di Ostia nel dicembre dello stesso anno
e poi a fuggire in Francia. Egli nella primavera del 1494 lasciò in consegna Ostia e Grottaferrata al C., che, per interposizione del
cugino Fabrizio, le cedette al pontefice. Alfonso Il d'Aragona intanto, successo al padre nel gennaio del 1494, cercava di rinnovare la
condotta del C., e del cugino, il quale trattava la questione a Napoli per ambedue. Il pericolo incombente della spedizione francese in
Italia faceva sì che giungessero ai condottieri molte offerte. Anche il duca di Milano infatti li voleva ai suoi servizi. La spuntarono gli
ambasciatori di Carlo VIII, che a Roma nel maggio presero agli stipendi del re di Francia Prospero e Fabrizio Colonna. Essi posero il
campo nei pressi di Frascati con quattromila uomini e seicento cavalli, conquistando nel settembre il castello di Ostia per il sovrano
francese.
Il 6 ottobre il pontefice intimò ai Colonna, ai Savelli ed agli Estouteville di tornare all'obbedienza entro sei giorni e, rimasto ignorato
il suo appello, fece distruggere le case dei Colonna a Roma. L'avanzata incontrastata di Carlo VIII, già arrivato a Viterbo, rese però il
papa più propenso ad un accordo con il sovrano. Per questo erano venuti a Roma a nome di quest'ultimo il cardinale Ascanio Sforza, il
C. ed altri. Una possibilità di intesa pareva vicina e gli intermediari dovevano tornare a Viterbo dal re, quando il papa, nella speranza
che così facendo tutta la Campagna romana sarebbe insorta contro l'invasore, li fece arrestare tutti il 9 dicembre. La prigionia del C.
durò soltanto dieci giorni e non ebbe conseguenze per alcuno, anche se egli per essere liberato fece al papa parecchie promesse, poi
ovviamente non mantenute. Anche il C. poté quindi fare il suo ingresso a Roma l'ultimo giorno dell'anno al fianco di Carlo VIII.
Durante il soggiorno del sovrano a Roma ebbe modo di fargli le sue rimostranze per il modo in cui i Francesi trattavano la città.
Conquistato con estrema facilità il Regno, il re di Francia gli concesse il castello di Montefortino, tolto a Giacomo Conti, su cui il C.
avanzava diritti. Quando Carlo VIII ripassò il 1° giugno 1495 per Roma, diretto in Francia, il C. faceva ancora parte del suo esercito
ed aveva organizzato nella città i rifornimenti necessari, ma sicuramente lo aveva abbandonato prima della battaglia di Fornovo,
poiché quando il 7 luglio Ferrandino riprendeva possesso di Napoli, il C. lo accompagnava. In seguito combatté fedelmente al servizio
del sovrano aragonese, da cui fu nominato capitano generale nel settembre del 1495, operando prima intorno a Napoli dove il re
nell'ottobre batté i Francesi, poi in Puglia, dove dall'inizio del 1496 si svolse una guerra frantumata in piccoli scontri, culminati il 22
luglio di quell'anno con la resa di Atella. Nella stessa estate fu inviato in Calabria, dove stava affermandosi, anche sul piano
diplomatico, la riconquista aragonese.
Morto Ferrandino (7 ott. 1496), il C., avvolto in un mantello nero in segno di lutto per la scomparsa del giovane sovrano, fu uno dei
gentiluomini che accolsero Federico d'Aragona al suo arrivo a Napoli. Recatosi con il nuovo re contro Gaeta, nel novembre fu il
garante per parte napoletana degli accordi stipulati per la resa della guarnigione francese. Operò quindi agli inizi dell'anno successivo
nel contado di Sora in collaborazione con Consalvo di Cordova, rimanendovi anche dopo la partenza di re Federico per Napoli.
All'incoronazione di quest'ultimo a Capua il 26 giugno 1497, recava, indossando un vestito lungo di broccato, la bandiera. Il 20
maggio egli era stato creato duca di Traetto e conte di Fondi, dei quali mentre era in vita Ferrandino aveva avuto il possesso, ma non i
titoli.
A metà agosto dello stesso anno riprese a Roma la lotta fra i baroni delle diverse fazioni. L'inizio delle ostilità fu l'occupazione a
tradimento di Torre Mattia, luogo dei Colonna, da parte dei Conti, sostenuti dagli Orsini. Nel dicembre il C. era a Roma, dove
assoldava fanti, con il favore del papa, che gli prestò Giovanni Cerviglione con quattrocento cavalli, benché il 17 genn. 1498 tentasse
una riconciliazione fra i contendenti. Il 9 febbraio i Colonna, con alla testa Prospero e Fabrizio, riconquistarono Torre Mattia, presero
Zancato, bruciarono i molini di Segni, Gavignano, Valmontone, si impadronirono di Palombara e della torre di Ariccia. Dopo una
dura sconfitta subita dagli Orsini a Palombara il 12 aprile, si arrivò l'8 luglio a Tivoli ad una rappacificazione solenne fra le famiglie
in lotta, in base alla quale le due fazioni si restituirono reciprocamente tutte le terre conquistate.
Quando l'anno successivo la minaccia francese al ducato di Milano si andava concretizzando, il re di Napoli, un figlio del quale il 19
maggio era stato tenuto a battesimo dal C., promise a Ludovico il Moro di inviargli un buon numero di uomini d'armi guidati dal C.
stesso.
Tuttavia le difficoltà di reperirli e la crescente preoccupazione per i problemi che non avrebbero mancato di presentarsi al Regno
fecero sì che il C. si muovesse con eccessivo ritardo e con pochi aiuti dopo ordini e contrordini. La notizia dell'abbandono di
Alessandria da parte dell'esercito sforzesco alla fine di luglio convinse il C., che giudicò la situazione del ducato disperata, a tornare
indietro.
Nei frenetici quanto inconsistenti preparativi approntati da re Federico l'anno dopo per tentare di arginare il pericolo della nuova
invasione, il C. ci appare scettico sulle possibilità di difesa napoletane, se a Napoli nel maggio insisteva nel sostenere che tutta la
speranza aragonese era nell'aiuto turco. Allorché nell'estate del 1501 il Regno fu investito direttamente dalla guerra, fu preposto alla
difesa di Napoli, ma, dilagati rapidamente i Francesi, la città per volere del re si arrese senza combattere ed il C., con il cugino
Fabrizio, accompagnò il re ad Ischia, mentre il pontefice compiva l'opera di appropriazione dei beni dei Colonna nella Campagna
romana, bandendoli insieme con i Savelli, con gli Estouteville e con i Caetani, e ridistribuendone i beni confiscati fra i propri nipoti.
Partito re Federico per l'esilio francese, il C. con il cugino si pose al servizio degli Spagnoli, raggiungendo Consalvo di Cordova, che
intendeva compiere la conquista della Puglia per la Spagna. Era a Barletta, con il grosso dell'esercito spagnolo, nel febbraio del 1503,
al momento della disfida tra cavalieri italiani e francesi.
I tredici contendenti italiani furono scelti dalle squadre del C., del cugino Fabrizio e del duca di Termoli. Al. C. fu dovuta la scelta
delle armi, che ebbe un peso determinante; egli fece porre inoltre due spiedi in mezzo al campo, che furono di grande utilità ai
cavalieri disarcionati.
Mentre continuava la campagna in Calabria, il fronte pugliese sembrò rianimarsi, quando il 23 dello stesso mese di febbraio gli
Spagnoli compirono una rapida azione su Ruvo di Puglia - cui il C. partecipò distinguendosi - mentre il Nemours se ne era allontanato
per riportare Castellaneta all'obbedienza francese. Dopo la battaglia di Seminara in Calabria, vittoriosa per le armi spagnole, Consalvo
di Cordova condusse l'esercito fuori di Barletta e passò l'Ofanto, minacciando le comunicazioni nemiche con Napoli e Gaeta.
Ambedue gli eserciti si diressero verso Cerignola, ove arrivarono prima gli Spagnoli. Il luogo per accamparsi fu scelto da Fabrizio e
Prospero Colonna, che fecero anche approfondire un fosso che lo circondava, munendolo di un piccolo argine. Consalvo schierò con
sagacia gli uomini di cui disponeva, piazzandosi con quattrocento uomini d'arme, avendo accanto il C., dietro ai duemila lanzi, che
erano al centro dello schieramento. I Francesi attaccarono a schiera. Prima avanzò la cavalleria pesante che fu fermata dai tiratori e dal
fosso, poi un grosso quadrato, che incappò a sua volta nel fosso. A questo punto entrò in azione la riserva spagnola che, guidata dal
Consalvo e dal C., determinò la vittoria. La terza schiera francese non giunse a contatto con l'esercito nemico, preferendo ritirarsi,
visto compromesso il risultato della battaglia. Benché fosse ormai notte, il C. con parte della cavalleria pesante inseguì i Francesi per
sei miglia, prendendo parecchi prigionieri e raggiungendo l'accampamento nemico. Quella notte egli cenò e dormì nella tenda del
Nemours, rimasto ucciso sul campo di battaglia (28 apr. 1503).
Dopo una puntata del C. in esplorazione verso Capua, l'esercito spagnolo vi si trasferì, quando ormai però tutti i Francesi superstiti
dalla battaglia di Cerignola si erano rifugiati oltre il Garigliano; il 16 maggio Consalvo di Cordova entrò a Napoli. Gli era accanto il
Colonna. Mentre il gran capitano rimase nella città per la conquista dei castelli, il C. fu inviato con i lanzi e gli uomini d'arme a Sessa.
Avvenuto quindi un concentramento a Cassino, fu raggiunto da Consalvo verso la fine di giugno. Il 1° agosto gli Spagnoli sferrarono
una potente, ma sterile offensiva contro Gaeta, dopo di che si ritirarono a Mola.
Moriva intanto Alessandro VI (18 ag. 1503) e dopo quattro giorni il C., lasciato un distaccamento di truppe spagnole a Marino, era
alle porte di Roma con cento cavalli. Il Sacro Collegio tentò di impedirgli di entrare, ma egli non tenne conto del desiderio espresso
dai cardinali, anche se il giorno dopo fece loro porgere deferentemente le sue scuse.
Con l'intento di dividere i suoi nemici il duca Valentino offrì a questo punto al C. la restituzione dei beni suoi e dei consorti, in
cambio di un atteggiamento non ostile, ed il C. accettò invitando inoltre il duca a porsi al servizio della Spagna. Pochi giorni dopo il
Sacro Collegio riuscì ad ottenere però che ambedue i pericolosi personaggi lasciassero l'Urbe.
Intanto l'esercito francese che scendeva a fronteggiare quello di Consalvo era giunto sul luogo delle operazioni. Dopo vari tentativi i
due schieramenti finirono con l'attestarsi sulle due rive del Garigliano.
Il 6 novembre i Francesi riuscirono a creare una testa di ponte sull'altra parte del fiume, mentre il freddo, le malattie, i disagi di ogni
tipo cominciavano a logorare duramente gli uomini di entrambe le parti, finché il 28 dicembre gli Spagnoli gettarono un altro ponte
sul fiume. Passarono prima tremilacinquecento fanti, poi uomini d'arme, picchieri e duecento cavalli leggeri, guidati dal Colonna. I
Francesi non erano in grado di affrontare il nemico e abbandonato il campo si ritirarono cercando di raccogliersi a Mola. Al C. fu dato
l'incarico di gettarsi all'inseguimento con i suoi cavalli leggeri per impedire il concentramento. Si unì a lui anche Bartolomeo
d'Alviano. Egli raggiunse le retroguardie nemiche di fronte a Scauri e per due volte si ingaggiò battaglia. Mentre l'Alviano si era
separato dal contingente del C. per aggirare la posizione, vicino Mola il C. venne nuovamente in contatto con i Francesi, ma questa
volta questi reagirono con il coraggio della disperazione e non solo respinsero le sue forze, ma le travolsero, mettendo in pericolo tutto
l'esercito, colto in crisi di movimento. La situazione fu immediatamente controllata da Consalvo di Cordova ed il 31 dicembre, mentre
Gaeta stava per cadere, il C. rientrò a Fondi, suo feudo, che durante l'occupazione francese era stato riconsegnato ad Onorato Caetani.
Il 7 marzo dell'anno successivo il C., che il mese prima aveva ricevuto proposte di ingaggio da parte della Repubblica fiorentina, era a
Napoli ad accogliere Isabella d'Aragona, duchessa di Bari, che arrivava da questa città recando con sé il figlio del Colonna. Il C.
conosceva la duchessa almeno dal comune soggiorno ad Ischia nel 1501 e le era intimamente legato.
Quando il duca Valentino finì nelle mani di Consalvo di Cordova, che si affrettò ad inviarlo sotto scorta in Ispagna, fu il C. che lo
accompagnò.
Partì nell'agosto del 1504 con un gran seguito di gentiluomini romani e napoletani e, giunto nella penisola iberica alla fine del mese,
fu accolto con grandi dimostrazioni di stima. Tornò a Napoli il 7 apr. 1505, avendo ottenuto una condotta e la conferma del ducato di
Traetto e della contea di Fondi e di molte altre località minori, in data 15 e 28 novembre dell'anno 1504.
Il C., che aveva recuperato i suoi beni nella Campagna romana, si trattenne a Napoli fino all'agosto 1505, quando partì alla volta di
Roma. Qui un anno dopo rappresentò il nipote Marcantonio nelle nozze per procura con una nipote del papa. Nel novembre era ancora
a Napoli e partecipava alle cerimonie per l'arrivo di Ferdinando il Cattolico. Nell'agosto 1507, ammalato, ricevette la visita delle tre ex
regine che vivevano a Napoli. Nel novembre giunse a Roma, dove assistette ai festeggiamenti nuziali di Marcantonio. Nel luglio 1508
era di nuovo a Roma, ove visitò uno degli oratori di Castiglia, Enrico di Toledo.
Conclusa la lega di Cambrai (10 dic. 1508), cominciarono le pratiche della Repubblica veneta per prendere ai suoi stipendi il C., al
quale si faceva balenare la possibilità di impadronirsi di Urbino, su cui i Colonna avrebbero potuto vantare qualche diritto, essendo il
cugino del C., Fabrizio, sposato ad una Montefeltro. Le pratiche continuarono anche dopo che Venezia ebbe affidato il suo esercito a
Bartolomeo d'Alviano. Intanto, mentre questi veniva battuto ad Agnadello, la Spagna si accingeva a recuperare i porti pugliesi, che la
Repubblica deteneva da otto anni. Perciò nel maggio del 1509 il viceré convocò a Napoli il C., con il quale si recò in Puglia. Caddero
nelle mani degli Spagnoli Monopoli, Mola, Polignano, quindi Trani, ove il C. entrò per primo.
Mentre l'orientamento del papa nei confronti di Venezia andava lentamente cambiando, il C., che nell'ottobre era stato a Piombino ad
ossequiare la nuora dell'imperatore, era sempre sollecitato dalla Repubblica veneta ad entrare al suo servizio. Sembra che i suoi
legami con la Spagna non gli permettessero di accettare la condotta; d'altra parte non volle neanche far parte di contingenti che
Ferdinando il Cattolico fornì al papa, prima della lega santa, e dell'esercito della lega, comandato da Raimondo di Cardona, poi. Pare
infatti che nell'atto della sua condotta con il re di Spagna fosse incluso un capitolo, per cui egli aveva il diritto di non militare se non
come comandante in capo, che poteva ricevere ordini soltanto dal re. Non partecipò neanche personalmente alla cerimonia di
rappacificazione fra i Colonna e gli Orsini, che si celebrò il 28 ag. 1511 nella chiesa romana dell'Aracoeli. Così, mentre si concludeva
la lega santa, egli nell'ottobre del 1511 si ritirò a Genazzano e rimase assente dalla battaglia di Ravenna (11 apr. 1512), rifiutando,
chiamato dal papa, di muoversi poi da Marino, per abboccarsi con lui. Il mese dopo ribadì a Giulio II di volere, per combattere, la
carica di capitano dello Stato pontificio o quella di gonfaloniere della Chiesa, non potendole ottenere si allontanò ancora una volta.
Tuttavia, perché costretto o per sua volontà, nell'agosto il C., dopo essere stato a Napoli, era a Pescara con trecento uomini d'arme e
trecento cavalli leggeri, che doveva condurre in Lombardia. Avuta licenza il 20 settembre dal papa di passare per lo Stato Pontificio,
approfittò di questo transito per prendere con sé il duca di Ferrara, che fuggiva da Roma dopo tempestosi colloqui con il pontefice.
Fatta la via di Pontremoli, nella seconda metà dell'ottobre si congiunse oltre il Po con l'esercito spagnolo. Nel mese di dicembre egli
divenne capitano generale dello Stato di Milano. Quando il nuovo duca, Massimiliano Sforza, fece il suo ingresso nella città
lombarda, il 29 dic. 1512, il C. era al suo seguito.
Concluso il 23 marzo 1513 il trattato di Blois fra Venezia e Luigi XII, il ducato milanese dovette affrontare un'altra invasione dei
Francesi, che nel giugno passarono le Alpi. Vinta dagli Svizzeri dello Sforza la battaglia dell'Ariotta presso Novara (aprile),
nell'ottobre i collegati si portarono contro Venezia e Bartolomeo d'Alviano si ritirò a Padova.
Gli alleati non si lanciarono sulla città, ma devastarono sistematicamente il territorio, spingendosi fino al mare, incendiando Mestre e
Marghera, sparando per sfida colpi di cannone contro la Serenissima. Il C. aveva disapprovato questa azione, giudicandola pericolosa,
perché si lasciava un forte esercito nemico alle spalle. Infatti, direttisi i collegati verso Vicenza per ripararvi, si trovarono la via
sbarrata dall'Alviano. Il 6 ottobre arrivarono a La Motta, nella valle di Creazzo, e furono impossibilitati a proseguire. Il C. consigliò
una ritirata strategica, che l'esercito, abbandonato tutto il bottino, si apprestò a compiere; ma i Veneziani, anche se pare che egli
facesse pervenire all'Alviano l'invito a non combattere, perché questo sarebbe stato la sua rovina, inseguirono gli alleati e fu
ingaggiata la battaglia.
Il C. era al centro dello schieramento, insieme con il Cardona, con quasi tutta la cavalleria pesante. La manovra avvolgente ordinata
dall'Alviano risultò troppo complessa, e per il rinculo della cavalleria leggera e poi del quadrato veneziano e per il disordine provocato
nei ranghi dai predoni civili si verificò un grave cedimento che portò l'esercito veneziano alla rotta. Di qui gli alleati si portarono a
Vicenza e vuole il Barbaro (Della storia venez., p. 1010) che il C. facesse di tutto perché il viceré non approfittasse della vittoria,
proseguendo l'offensiva, poiché giudicava che l'annientamento di Venezia sarebbe stato deleterio per tutta l'Italia, caduta del tutto in
mano di "gente straniera e crudele".
Prima della fine, di ottobre il C. con le truppe del duca di Milano lasciò Vicenza e si portò nel Cremonese, ponendo l'assedio a Crema.
Dalla città però si reagì con vigore, tanto che il C. non solo non l'ottenne, ma fu messo in difficoltà. L'esercito sforzesco rimase un
anno intorno a Crema, senza averla, ma nel novembre del 1514 acquistò Bergamo a patti. Subito dopo il C. fece un viaggio ad
Innsbruck prima, dove ossequiò l'imperatore, e passò poi a Mantova per trascorrervi le feste natalizie.
Si era appena rinnovata la lega antifrancese, in vista di un'offensiva del nuovo re di Francia, Francesco I, quando il C., che era
considerato dalla voce popolare, che ne enumerava quattro, come uno dei duchi di Milano, offrì il 20 febbr. 1515 nella città lombarda
un magnifico convito, che rimase nelle cronache.
Infatti alla fine della raffinatissima cena, fu introdotto nella sala del convito un giovane che si fingeva gioielliere, dal quale il C. fece
vista di comprare tutte le gioie che portava seco, donandole alle dame convenute; ad ognuna di esse il giorno dopo egli mandò a
regalare un dolce di zucchero. Si disse che tutto ciò era stato da lui fatto per poter donare un gioiello alla donna che amava. Si sa del
resto che il C., che viveva lontano dalla moglie da moltissimi anni, fu un uomo galante. Nota è pure la sua relazione con Isabella,
duchessa di Bari, e il giudizio del contemporaneo Giovio del resto fu che egli "matronarum amoribus intemperanter indulsisse" (P.
Giovio, Elogia vivorum bellica virtute illustrium, Basileae 1575, pp. 251 s.); lo storico Gaudenzio Merula, di poco a lui posteriore, lo
definì nella sua Cronica "ad amores mulierum etiam senex propensus" (A. Butti, Vita e scritti di Gaudenzio Merula, in Arch. stor.
lomb., s. 3, XII [1899], p. 374).Ma era allora più tempo di guerra che di galanterie, e la nuova spedizione francese contro il ducato era
imminente, mentre fervevano al di qua delle Alpi i preparativi per fronteggiarla. I passi alpini furono presidiati da truppe svizzere. Il
C., che era uno dei conservatori dello Stato di Milano, era attivissimo, ma non seppe prevedere che i Francesi sarebbero passati dal
passo dell'Argentera, quasi inaccessibile, che non essendo sorvegliato permise loro la sorpresa più completa. Il 14 ag. 1515 egli era a
Villafranca ed ebbe anche notizia della presenza di truppe francesi, ma pensò che si trattasse di gruppi isolati e si limitò a far guardare
il ponte sul Po vicino alla cittadina. Divisi in due colonne i Francesi evitarono il ponte, traversando a guado il fiume a due miglia dalla
città ed attaccarono con ognuna delle schiere le due porte, avendole senza sforzo. Circondare la casa ove era il C. e prenderlo
prigioniero insieme con trecento uomini d'arme fu in seguito compito facile. Così, mentre i collegati erano sconfitti a Melegnano e si
compiva il destino di un altro Sforza, il C. rimase forzatamente inattivo.
Presentato al re, che lo trattò benevolmente, la taglia che si richiese per lui fu di 35.000 ducati, ma poi essa fu dimezzata per
intervento del sovrano francese, che ne pagò la metà, e nel marzo del 1516 il C. tornò libero. Si recò dapprima a Lodi, dove scongiurò
l'imperatore, sceso infruttuosamente in Italia, di non abbandonare l'impresa, poi, dopo essersi fermato a Busseto si recò a Modena e in
seguito a Bologna. Il suo intento era quello di occupare qualche città importante della Lombardia, ma questi propositi non furono
posti in atto perché, salvo per la guerra di Leone X contro i Della Rovere, si era in un clima di rappacificazione, che culminò nella
pace di Noyon il 13 ag. 1516.
Alla fine del 1516 si recò a Roma per risolvere alcune questioni economiche. Nel marzo del 1517 da Napoli si recò a Bari a visitare la
duchessa, che aveva allora fidanzato la figlia Bona Sforza a Sigismondo re di Polonia. Pare che le feste, che con grande magnificenza,
si protrassero per dieci giorni a Napoli per questo matrimonio, celebrato il 6 dic. 1517. fossero organizzate dal Colonna. Dopo i
festeggiamenti la sposa fu accompagnata a Manfredonia, ove si imbarcò per raggiungere il marito. Il C. la accompagnò fino a
Cracovia, da dove ripartì il 28 apr. 1518, colmo di doni del re, verso l'Ungheria. Tornò a Napoli alla metà di luglio.
L'anno precedente Carlo V, successo al nonno come re di Spagna, gli aveva confermato il feudo di Traetto, come tutti gli altri
privilegi concessigli da Ferdinando il Cattolico sui suoi possedimenti in Calabria e in Terra di Lavoro e l'assegno perpetuo di 2.000
ducati annui sulle rendite di Lecce e quello di 6.000 sopra feudi in Abruzzo. Inoltre, con privilegio del 20 ag. 1519 Carlo V gli
concesse un'altra rendita annua di 2.000 ducati.
Del 1519 è anche un breve viaggio del C. in Spagna, dove arrivò il 29 maggio e dove si recò con molti gentiluomini napoletani per
fatti privati, ma incaricato dai baroni di chiedere al re la conferma dei loro privilegi. Recò al sovrano in dono da parte della duchessa
di Bari un monile ornato, di uno smeraldo. Il 3 settembre era di ritorno a Napoli e da qui si portava il mese successivo a Roma, ove
sembra aver soggiornato anche l'anno dopo.
Il 1521 segna la ripresa della lotta antifrancese da parte di Leone X strettosi in lega con Carlo V. Alla fine di luglio partivano da
Napoli ottocento uomini d'arme spagnoli, che si dirigevano in Romagna, guidati dal C., nominato comandante supremo dell'esercito
imperialpontificio. A Castelfranco essi si riunirono con le truppe papali, alla cui testa era il marchese di Mantova. Alla fine di luglio il
C. era nei pressi di Parma, di cui chiese la resa, dopo un violento bombardamento, senza ottenerla.
Si rimase così inoperosamente davanti alla città, mentre i contrasti fra il C., il marchese di Mantova e Ferdinando d'Avalos,
comandante della fanteria imperiale, si acuivano sempre più, tanto che il C. si trovava "disperato". L'inattività, causata dai contrasti e
dalla sua "tardità naturale", rese evidente la pericolosità della posizione dell'esercito alleato, per cui tutti si trovarono d'accordo verso
la metà di settembre nel togliere il campo da Parma. La decisione, aspramente biasimata dal papa, che aspettava di giorno in giorno la
notizia del recupero della città, si rivelò poi positiva.
Il 1° ottobre il C. passò il Po a Casalmaggiore, aspettando l'arrivo di seimila svizzeri, con parte dei quali si congiunse a Gambara. La
defezione di molti di essi e la prudenza eccessiva fecero allora mancare al Lautrec l'occasione di una probabile vittoria sull'esercito
alleato. Dalla lentezza, che lo portava a voler "vincer senza far morir homeni" (Sanuto, Diarii, XXXI, col. 321), si riscattò invece il C.,
facendo passare di sorpresa ai primi di novembre l'Adda, senza informare neanche i suoi collaboratori, prima da alcune compagnie di
fanti, poi da tutto l'esercito. Il Lautrec dovette allora ritirarsi a Milano, dove il 19 novembre giunse l'esercito alleato, riuscendo a
penetrarvi con estrema facilità, mentre i Francesi l'abbandonavano uscendo da porta Comacina.
Morto Leone X, il C. tentò di influenzare il conclave, trattenendo nello Stato di Milano il cardinale d'Ivrea, perché filofrancese.
Intanto provvedeva a fortificare la città, restaurando i bastioni e facendo scavare due trincee, ciascuna munita di un argine, fra porta
Vercellina e porta Comacina. Si strapparono inoltre Alessandria ed Asti ai Francesi e si posero presidi a Novara ed a Pavia. Nel marzo
1522 il C. compì una sortita per rinfrancare gli animi dei cittadini e il 3 aprile ne fece un'altra per coprire l'ingresso nella città di
Francesco II Sforza, nuovo duca di Milano. Subito dopo si diresse contro il Lautrec, che era davanti a Pavia.
Fermatosi prima a Binasco, si portò poi alla Certosa, mentre il Lautrec si spostava a Landriano, provocando così il ritorno del C. a
Milano. Entrato il generale francese a Monza, il C. prese posizione alla Bicocca e lì il giorno 27 i due eserciti si affrontarono. Come al
solito il C. pose cura nella scelta del campo, che era protetto da un lato e alle spalle da due fossi, dall'altro lato da una palude ed era
accessibile solo dalla fronte, che peraltro presentava la protezione di una strada incassata per un metro. Il Lautrec dispose al centro gli
Svizzeri e gli uomini d'arme veneziani, che attaccarono frontalmente, venendo decimati da un rapido fuoco di moschetteria a scariche
successive e frantumati dal fossato costituito dalla strada. Inoltre il Lautrec aveva sperato di far penetrare trecento lance con l'inganno
da un ponte che immetteva nell'accampamento nemico, ma il C. ovviò anche a questo, ponendo il giovane duca, che era accorso da
Milano ad unirsi alla battaglia, a guardia del ponte stesso. Fu quella del C. una vittoria netta; tuttavia quella francese non fu una rotta,
ma una ritirata ordinata. L'azione antifrancese fu peraltro rapidamente perfezionata, con l'acquisto di Lodi, Cremona, Novara.
Il successo contro i Transalpini non poteva essere considerato completo se anche Genova non fosse stata strappata loro. Alla fine di
giugno l'esercitò alleato era davanti a Genova. Il doge tentò di parlamentare, chiedendo di capitolare con termine di quaranta giorni,
ma abbattuta dall'artiglieria una torre, in breve la città fu invasa, subendo un terribile sacco.
Il C. aveva assistito accanto allo Sforza alla scalata delle mura ed al dilagare dei soldati poi, probabilmente con rammarico, perché in
varie occasioni aveva dimostrato doti di umanità. Subito dopo egli si recò nel Monferrato e a Saluzzo a chiedere risarcimenti, perché
quei due marchesi avevano fornito il loro aiuto ai Transalpini. Il 19 ag. 1522 il C. era di nuovo a Genova ad accogliere Adriano VI al
suo arrivo dalla Spagna e, secondo il Pastor, non è vero che il papa gli negò il perdono per il sacco a cui era stata sottoposta la città
pochi mesi prima.
L'anno successivo Carlo V sollecitò il C. a fare infiltrare nello Stato di Milano milizie spagnole, ma egli, pur dichiarandosi fedele
servitore dell'imperatore, sostenne in una lettera del 22 aprile di esser capace di dargli in mano il ducato, ma "discopertamente" e non
per vie traverse. Non avrebbe dovuto invece presumere molto dalle sue forze, perché nell'agosto, mentre calava in Italia un nuovo
esercito francese, al comando dell'ammiraglio Bonnivet, il C. ebbe un attacco del male che lo avrebbe portato in pochi mesi alla
tomba. Tuttavia agli inizi di settembre uscì da Milano e si attestò sul Ticino, vicino alla Boffalora.
Il 14 settembre il Bonnivet varcò il fiume presso Vigevano, costringendo il C. a effettuare una vera e propria ritirata verso Milano. La
città non era abbastanza fortificata, poiché il C. non aveva creduto ad un'imminente spedizione francese, e i collegati decisero di
approntare le fortificazioni necessarie, pronti tuttavia ad allontanarsi se il Bonnivet avesse attaccato. L'ammiraglio francese però si
dimostrò ancora più prudente del predecessore e il C. poté non solo provvedere alla difesa, ma anche cercare di tagliare i
vettovagliamenti al nemico. Intanto però la sua salute declinava e nell'ottobre corse voce che era morto. Ciononostante ebbe la
soddisfazione di ricevere richieste di tregua da parte dei Francesi, per mezzo del padre di una sua amante, e di vedere infine il 17
novembre il Bonnivet togliere l'assedio a Milano e ritirarsi ad Abbiategrasso.
Il C., che aveva avuto dall'imperatore Carpi senza poterne ricevere l'investitura, morì a Milano il 31 dic. 1521, forse di apoplessia,
benché ci sia stato - come molto spesso accadeva - "sospetto di veleno o di medicamento amatorio" (Guicciardini, Storia d'Italia, IV,
p. 212).
Fu con Bartolomeo d'Alviano il maggior capitano italiano dei suoi tempi e di lui rimase confermato il giudizio dei Guicciardini:
"Capitano ... certamente, in tutta la sua età, di chiaro nome, ma salito negli ultimi anni della vita in grandissima riputazione e
autorità", perito ed esperto, ma non pronto ad afferrare le occasioni favorevoli, come del resto per la sua circospezione a non porgerne
ai nemici, prudentissimo guerreggiò "più co' consigli che con la spada", (ibid., pp. 212 s.), non esponendosi per quanto possibile
all'alea delle battaglie.
Il corpo del C. fu seppellito dapprima nella chiesa di S. Nazzaro a Milano e poi traslato a Fondi. Aveva sposato Covella Sanseverino,
da cui aveva avuto due figli, Vespasiano e Laura. Aveva protetto il poeta Pietro Gravina, che gli dedicò una ventina di composizioni
poetiche (P. Gravina, Poematum libri, Neapoli 1532).
Un ritratto del C. di anonimo è conservato nella Galleria Colonna e uno, secondo P. Colonna (I Colonna ..., p. 113), in palazzo
Colonna a Roma.
Fonti e Bibl.: G. A. Prato, Storia di Milano, in Arch. stor. ital., III (1842), pp. 309, 318, 325 s., 333 ss.; G. M. Burigozzo, Cronaca di
Milano, ibid., pp. 433 s., 436 s., 441, 443; D. Barbaro, Della storia venez., ibid., VII (1843-44), 2, pp. 995, 1005, 1010, 1013, 1057;
Cronica di Napoli di notar Giacomo, a cura di P. Garzilli, Napoli 1845, pp. 194, 250, 253, 261, 272, 295, 318; A. Desjardins,
Négociations diplom. de la France avec la Toscane, II, Paris 1861, pp. 706. s.; Docum. che concernono la vita pubblica di Girolamo
Morone, a cura di G. Müller, in Misc. di storia ital., III (1865), pp. 125, 303-308; Codice aragonese, a cura di F. Trinchera, II, 1,
Napoli 1868, pp. 46, 141, 143, 366, 383; II, 2, ibid. 1870, pp. 37, 43, 55, 70, 157, 159 s.; M. Sanuto, La spediz. di Carlo VIII in Italia,
a cura di R. Fulin, Venezia 1873, pp. 154 ss., 227, 364 s., 591, 593, 595 s., 632, 669; Id., I Diarii, I-XXXV, Venezia 1879-1892, ad
Indices; S. dei Conti da Foligno, Le storie..., a cura di E. Racioppi, Roma 1883, I, pp. 133, 137, 149, 191, 193 s., 199, 219; II, pp. 65
s., 83, 161, 308, 319, 321; V. Forcella, Iscriz. delle chiese ... di Milano, I, Milano 1889, p. 18; S. Infessura, Diario della città di Roma,
a cura di O. Tommasini, Roma 1890, pp. 91, 109, 120, 136, 146, 151 s., 165, 180, 183 ss., 191 s., 206 s., 212, 219, 276, 290; Quattro
cronache ... dell'Aquila, a cura di G. Pansa, Sulmona 1902, pp. 65, 70, 75; Crónicas del Gran Capitán, a cura di A. R. Villa, Madrid
1908, ad Indicem; Korrespondenzen und Akten zur Geschichte des Kardinals Matth. Schiner, a cura di A. Büchi, I, Basel 1920, pp.
263, 272, 297, 357, 382, 546, 562; II, ibid. 1925, pp. 74, 85 s., 427, 430 s., 439, 453, 461, 595, 597, 606; F. Guicciardini, Storia
d'Italia, I-V, Bari 1929, ad Indicem; P. Giovio, Le vite del gran capitano e del marchese di Pescara, a cura di C. Panigada, Bari 1931,
ad Indicem; Regesta chartarum, a cura di G. Caetani, VI, San Casciano Val di Pesa 1932, pp. 207 s., 259, 263, 294; J. E. Martinez
Ferrando, Privilegios otorgados par el emperador Carlos V, Barcelona 1943, pp. 53, 63, 50, 82 ss.; B. Dovizi da Bibbiena, Epistolario,
a cura di G. L. Moncallero, Firenze 1955, I, pp. 56, 359, 393, 423; II, pp. 58 ss., 70 s., 85; P. Giovio, Lettere, a cura di G. G. Ferrero,
I, Roma 1956, pp. 91, 104, 344; Il Diario romano di Jacopo Ghepardi da Volterra…, in Rerum Ital. Scriptores, 2 ediz., XXIII, 3, a
cura di E. Carusi, pp. 99, 101; Diario romano di Sebastiano di Branca Tedallini, ibid., a cura di P. Piccolomini, pp. 294 ss., 304 ss..
316, 335, 347, 353, 356, 363, 366; Il diario della città di Roma di Antonio de Vasco, ibid., a cura di G. Chiesa, pp. 498, 501, 527;
Diario ferrarese di B. Zambotti, ibid., XXIV, 7, II, a cura di G. Pardi, pp. 235 s., 242 s., 249; I. Burchardi Liber notarum, ibid.,
XXXII, 1, a cura di E. Celani, I, pp. 464, 545, 555; II, pp. 289, 358 s., 363 s., 427 s., 457, 491; A. Coppi, Mem. colonnesi, Roma
1855, pp. 221 s., 244 ss., 248 s., 254 s., 267, 274-280; E. Motta, Morti a Milano dal 1452 al 1552, in Arch. stor. lomb., s. 2, VIII
(1891), p. 283; F. Ranalli, P. C., in Vite di romani illustri, Roma 1891, pp. 155-186; L.-G. Pelissier, Louis XII et Ludovic Sforza, I,
Paris 1896, pp. 375-378, 437 s.; II, ibid. 1897, pp. 16, 405 s.; F. Gregorovius, Storia della città di Roma, Roma-Torino 1902, III, pp.
850, 858 ss.; IV, pp. 1, 28 s., 46 s., 58, 60, 118, 343, 346, 357, 390, 471, 478, 525, 634 s., 655; A. Galieti, La tomba di P. C., in Arch.
della R. Soc. rom. di storia patria, XXXI (1908), pp. 216, 218; A. Dina, Isabella d'Aragona..., in Arch. stor. lomb., s. 5, VIII (1921),
pp. 398 s., 403-406, 408, 415, 419, 428-431, 435-439, 448 ss.; P. Colonna, I Colonna..., Roma 1927, pp. 104, 107 ss., 112, 116, 118,
121, 124, 130 s., 135, 138-142, 149-159, 163 s.; G. Caetani, Domus Caietana, I, 2, San Casciano Val di Pesa 1927, pp. 23, 187, 189 s.,
192 ss., 217, 222, 245, 261-264; III, ibid. 1933, p. 5, 8, 27-31, 33, 37, 78; C. Argegni, Condottieri capitani tribuni, Milano 1936, pp.
189 s.; P. Pieri, La battaglia del Garigliano del 1503, Roma 1938, pp. 5, 36, 45, 51 s., 54, 56, 58 s., 64 s., 68, 71, 77, 80 s.; P. Paschini,
Roma nel Rinascimento, Bologna 1940, pp. 256, 263, 267 s., 281, 287 s., 293, 310, 326, 328-334, 341, 346, 349, 359, 373, 375 s.,
389, 394, 398 s., 401, 417, 419, 421, 429; P. Pieri, Il Rinascimento e la crisi militare ital., Torino 1952, ad Indicem; Id., Consalvo di
Cordova e la battaglia di Cerignola, in Arch. stor. pugliese, V (1952), pp. 270 s., 273, 275, 277, 279-82; Id., La guerra francospagnuola nel Mezzogiorno, in Arch. stor. per le provv. napol., n. s., XXXIII (1952), pp. 22, 31 ss., 41 s., 45-48, 53 ss., 59 ss., 65 s.;
Id., Consalvo di Cordova e i condottieri italiani, in Quaderni ibero-americani, XIV (1953), pp. 342-350; A. Ilari, Documenti per la
storia di Frascati, III, I d'Estouteville ed i Colonna..., in Archivi, XXIII (1956), pp. 154 s., 158; G. P. Bognetti, La città sotto i
Francesi, in Storia di Milano, VIII, Roma 1957, pp. 96, 144, 149, 167, 175, 198, 228, 230 s., 233 s., 236-239, 244, 246 s.; L.
Mazzoldi, Da Ludovico secondo marchese a Francesco secondo duca, in Mantova. La storia, II, Mantova 1961, pp. 271 ss., 276 ss.,
281 s., 324 s., 334 ss., 340 ss.; L. V. Pastor, Storia dei papi, II-IV, Roma 1961-1956, ad Indices; A. Ilari, Frascati fra Medioevo e
Rinascimento, Roma 1965, pp. 60 s., 67, 79 s., 88, 98, 125; C. Gennaro, La "Pax romana" del 1511, in Arch. della Soc. rom. di storia
patria, XC (1967), pp. 20, 23, 35; P. Litta, Le fam. celebri ital., s. v. Colonna, tav. IV
Prospero Colonna
(1452 - 1523)
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Prospero Colonna (né en 1452 à Lanuvio, dans la province de Rome, dans la région du Latium - mort en 1523 à Milan) est un
condottiere italien de la fin du XVe siècle et du début du XVIe siècle successivement au service du roi de France, des États pontificaux
et du Saint-Empire romain germanique durant les guerres d'Italie. Membre de la famille Colonna, il est le cousin de Fabrizio Colonna,
avec qui il combat souvent.
Biographie Il s'illustre pour la première fois en 1484 en défendant le château familial de Paliano contre les troupes des Orsini et des
Riario. Après quelques autres batailles, il rallie le parti du cardinal della Rovere (futur Jules II), et est emprisonné par l'ennemi de ce
dernier le pape Alexandre VI au Château Saint-Ange. Il est libéré puis emprisonné de nouveau pour s'être rallié à Charles VIII de
France pendant son invasion de l'Italie. Finalement, le roi vainc le pape et entre à Rome avec Prospero et son cousin Fabrizio en 1495.
Prospero obtient le duché de Trasetto et le comté de Forli, pendant que le roi contrôle Naples. Cependant, quand Charles quitte la
ville, il aide son rival Ferdinand II d'Aragon à évincer le vice-roi Gian Giacomo Trivulzio. La situation évolue encore avec l'invasion
dirigée cette fois par Louis XII. En 1501, alors que Frédéric II de Naples s'enfuit sur l'île d'Ischia, les cousins Colonna essaient de
défendre le royaume. Ils échouent et sont emprisonnés dans la ville tout juste capturée (dans le Castel Nuovo). Ils sont excommuniés
par Alexandre VI, qui prend leurs châteaux dans le Latium. Finalement, libérés contre rançon, ils se mettent au service de Gonzalve
de Cordoue, le nouveau vice-roi de Naples, au service de Ferdinand II. Prospero joue un rôle important dans la victoire espagnole de
Cerignola en 1503. La même année meurt Alexandre VI, ce qui lui permet de récupérer ses terres dans le Latium. Il commande
ensuite la cavalerie à la bataille du Garigliano. Il ajoute Itri, Sperlonga, Ceccano et Sonnino à son domaine, devenant un des plus
puissants seigneurs du sud de l'Italie, et épouse Covella di Sanseverino, qui lui donne un héritier, Vespasiano. En 1515, il commande
les troupes du pape Léon X dans le nord-ouest de l'Italie, près de Demonte. L'avant-garde de l'armée de François Ier, commandée par
le maréchal de La Palisse traversant les Alpes au col de l'Argentière, le capture à Villefranche, action au cours de laquelle sont pris
600 chevaux de prix et 150 000 écus. En 1522, il remporte la bataille de la Bicoque contre les Français. Sa santé décline et il meurt en
1523 à Milan.
Colonna, Stefano
(1490/99 - 1548)
Dizionario Biografico degli Italiani
di FF. Petrucci
Angelo Bronzino. Ritratto di Stefano Colonna (1546). Galleria Nazionale d'Arte antica, Roma
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://virtualmuseo.com/wp-content/uploads/2010/02/Angelo_Bronzino_056-452x580.jpg&imgrefurl
COLONNA, Stefano. - Del ramo di Palestrina, nacque da Francesco di Stefano e da Orsina Orsini probabilmente nell'ultimo
decennio del XV sec.
Sull'esempio del consorte Prospero intraprese la carriera militare, abbracciando, secondo l'orientamento della maggior parte dei
consorti, la causa imperiale. Con Prospero era nel 1522 alla difesa di Milano, minacciata da una spedizione francese, e quando il 27
aprile le forze imperiali e milanesi combatterono contro il Lautrec nella battaglia della Bicocca, il C. partecipò allo scontro al
comando di un reggimento. Due mesi più tardi era con l'esercito alleato a Genova, che fu allora sottratta ai Francesi; qui
probabilmente prese parte al sacco cui la sventurata città fu sottoposta. Dopo la morte di Prospero il C. rimase alla difesa di Milano,
minacciata da un'altra spedizione francese al comando dell'ammiraglio Bonnivet. Restò alle dipendenze dell'imperatore e del duca di
Milano almeno fino alla primavera del 1524. In seguito fu convinto da Clemente VII ad abbandonare il campo imperiale e a mettersi
al servizio della Chiesa.
Così quando nell'autunno del 1525 la maggior parte dei consorti, il cui capo era allora il cardinale Pompeo Colonna, abbandonò
l'Urbe, egli rimase al fianco del pontefice, la cui politica diveniva sempre più apertamente antimperiale. Allorché i Colonna il mattino
del 20 sett. 1526 penetrarono in Roma come ribelli, il C. al comando di cinquanta fanti fece fronte agli invasori attestandosi a porta S.
Spirito. Fu però preso in breve fra due fuochi, poiché gli assalitori erano riusciti a scalare il colle omonimo vicino alla porta,
bersagliando dall'alto i difensori. Al C. non rimase allora che ritirarsi, con l'intento di riunirsi agli Svizzeri, che egli credeva fossero in
piazza S. Pietro e che invece avevano seguito il papa in Castel Sant'Angelo. Le forze del C. allora si dispersero, lasciando il campo ai
nemici, che inflissero al Borgo e al Vaticano stesso un'anticipazione del ben più tremendo sacco cui sarebbe stata sottoposta la città
l'anno successivo. Quando dal novembre dello stesso anno il papa ordinò le rappresaglie contro i Colonna, il C. partecipò alle
operazioni contro i castelli dei parenti nella Campagna romana.
Cominciata intanto l'avanzata minacciosa del Lannoy dal Sud, il C. fu inviato a fronteggiare l'esercito imperiale. Nel gennaio del 1527
mosse, sotto il comando di Renzo da Ceri, in difesa di Frosinone, che sosteneva con difficoltà la pressione nemica. Al termine di una
tregua di otto giorni, il 4 febbraio le forze pontificie sferrarono un fortunato contrattacco, durante il quale il C. comandò le truppe
svizzere schierate all'avanguardia, che ebbero un notevole peso nello svolgimento della battaglia.
Prima che i lanzi travolgessero ogni resistenza e che Roma divenisse preda del sacco (6 maggio 1527), il C. difese il Vaticano e
trattenne gli assalitori mentre il pontefice si rifugiava in Castel' Sant'Angelo. Successivamente il C. riuscì a fuggire dall'Urbe e si recò
presso il duca di Urbino, dal quale implorò invano aiuti militari per recare soccorso al papa.
Quando la spedizione del Lautrec iniziò la sua marcia verso il Sud dirigendosi contro il Regno, il C. andò a incontrare il comandante
francese a Bologna e divenne uno dei gentiluomini del suo seguito. Prima della fine del 1528 passò alle dirette dipendenze del re di
Francia con una condotta di duemila fanti e di duecento cavalli leggeri. Nel 1529 era in Lombardia sotto il comando del conte di
Saint-Pol. Il 21 giugno partecipò alla battaglia svoltasi nei pressi dì Mandriano, durante la quale Antonio de Leyva inflisse ai Francesi
una dura sconfitta. Il C., caduto con il cavallo in un fosso, fu fatto prigioniero. Liberato probabilmente dopo la pace di Cambrai
ottenne dal sovrano francese di passare al servizio della Repubblica fiorentina. Si portò quindi alla difesa della città, il cui comando
generale fu tenuto prima da Mario Orsini e poi da Malatesta Baglioni; il C. aveva il governo della milizia.
L'11 dic. 1529, a dispetto dell'eccessiva circospezione, che gli venne rimproverata, il C. compì una sortita, la cui buona riuscita suscitò
vasta e positiva eco. Essa fu diretta contro una posizione tenuta da un consorte del C., Sciarra Colonna, attestato a S. Margherita a
Montici. Il C. dette ordine ai suoi che sui loro indumenti soliti indossassero una camicia bianca, perché potessero distinguersi
agevolmente dai nemici. Al comando di più di mille uomini attaccò la postazione e ne ebbe ragione, sbaragliando gli avversari,
infliggendo loro una perdita di duecento uomini e riuscendo a ritirarsi senza subire perdite.
In quel periodo il C.. si rese protagonista anche di un altro episodio non egualmente positivo, che gli alienò molte simpatie. Egli
accoltellò infatti, facendolo poi finire dalle sue lance spezzate, un capitano dei Fiorentini, Amico di Venafro, che aveva avuto il torto
di ignorare un suo ordine.
Il 21 giugno 1530 il C. tentò un'altra, meno fortunata sortita; nel corso di essa ricevette due ferite leggere. Con tre squadre il C. assaltò
i Tedeschi alloggiati nel monastero di S. Donato e, anche se la sorpresa non riuscì, egli conquistò la prima e la seconda trincea. A
questo punto i suoi uomini iniziarono il saccheggio, mentre invece gli avversari attendevano a riorganizzarsi. Il C. affrontò lo
squadrone formato dai nemici e a questo punto gli venne meno l'aiuto che aspettava da Malatesta Baglioni, che invece di sostenerlo si
era ritirato, temendo un attacco dell'Orange alla città. I rapporti fra i due comandanti non erano del resto molto buoni, ché anzi il C.
aveva aspirato al posto conferito invece al perugino. D'accordo con costui però, quando nell'agosto la situazione di Firenze divenne
insostenibile, inviò agli Imperiali due messi. In varie relazioni poi, sempre congiuntamente al Baglioni, il C. illustrò al governo della
Repubblica lo stato disastroso in cui versava la città, sconsigliando di continuarne la difesa e invitando i cittadini ad arrendersi.
Nei capitoli di resa del 12 agosto i due capitani furono sciolti dal giuramento prestato alla Repubblica e invitati a rimanere nella città
nei quattro mesi, durante i quali dovevano essere espletate tutte le convenzioni stabilite. Il C. però non attese lo scadere dei quattro
mesi e, dopo aver protetto dalle rappresaglie dei Medici alcuni cittadini fiorentini, si recò in Francia. Qui Francesco I lo insignì
dell'Ordine di S. Michele.
Tornò in Italia con l'esercito francese dopo la morte di Francesco II Sforza (10 nov 1535). Quando i Francesi occuparono il Piemonte
il C. fu creato governatore di Torino e attese, pare in modo ammirevole, a fortificare la città. Nel marzo del 1536 il C. era di nuovo in
Francia alla corte del sovrano, che gli concesse il comando di cinquanta uomini d'arme. Nell'estate era in Provenza a fronteggiare la
spedizione imperiale contro questa regione, ma ad Arles scoppiò un conflitto fra il contingente italiano e gli alleati, che causò più di
centocinquanta morti. Il C. si sentì oltraggiato e volle lasciare il campo. Si appellò al re, ma non ne ottenne soddisfazione. Deliberò
allora di chiedere licenza e l'ottenne. Tornò a Roma, dopo aver sostato, nell'ottobre, ammalato, a Ginevra.
Prima della fine dell'anno si trattò della sua nomina a capitano delle fanterie di Venezia, ma la proposta fu poi respinta in Senato con
ben centotrenta voti contrari contro trentuno. favorevoli. L'anno successivo alcuni esuli fiorentini, memori dei suo servizio sotto la
Repubblica, si rivolsero a lui, perché si ponesse al loro comando per rovesciare Cosimo de' Medici, ma egli declinò l'offerta.
Nel 1538 fu assoldato come capitano generale delle fanterie da Paolo III, che lo inviò contro Guidobaldo Della Rovere, colpevole ai
suoi occhi di voler insignorirsi di Camerino, avendo sposato Giulia da Varano, erede del ducato. Composta con un accordo questa
controversia, il C. fu richiesto al papa da Venezia, che temeva un attacco turco. Egli giunse nella città lagunare il 18 maggio.
Nello stesso anno fu definita una lite che aveva visto il C. da lungo tempo in causa con Vittoria Colonna di Pierfrancesco per l'eredità
di quest'ultimo, il quale secondo la consuetudine aveva lasciato i suoi beni al C. e al fratello, piuttosto che alla figlia femmina. A
Vittoria furono però allora concessi Zagarolo, Colonna, San Cesareo e al C., che da Clemente VII aveva avuto Stroncone, e al fratello
Alessandro vennero lasciati San Vittorino, Castelnuovo e Gallicano.
Nel 1541 Cosimo de' Medici, memore dell'attaccamento dimostrato dal C. a Firenze, lo chiamò nella città come luogotenente
generale. Accettando questo incarico il C. volle restituire a Francesco I l'Ordine di S. Michele; infatti i rapporti di Cosimo con
l'imperatore erano troppo buoni, perché egli non si sentisse obbligato a rompere definitivamente ogni rapporto con i Francesi. Con
licenza del duca egli nel 1543 andò anzi a combattere direttamente alle dipendenze dell'imperatore in Fiandra, ricoprendo la carica di
mastro di campo. La sua permanenza lì fu però breve e egli tornò in Toscana. Si aprì allora un periodo della vita del C. non tanto
dedicato agli affanni della guerra, quanto volto ai piaceri della letteratura e alla meditazione. Onorò e protesse i letterati, divenne
consigliere dell'Accademia Fiorentina e si dilettò di comporre versi.
Il C. morì a Pisa l'8 marzo 1548.
Cosimo de' Medici provvide a farlo seppellire con gran pompa, incaricando Benedetto Varchi di scrivere un'orazione funebre in suo
onore (B. Varchi, Orazione funerale sopra la morte del signore S. C. da Palestrina, Firenze 1548, poi ristampata in F. Sansovino, Delle
orationi volgarmente scritte da diversi huomini illustri..., I, Venezia 1584, pp. 227-32).
Aveva sposato Elena Franciotti, erede di Bassanello e Carbognano, da cui ebbe Francesco, primogenito, Mario, Giulio Cesare,
Giacomo e Stefano.
Un suo ritratto, opera del Bronzino, è ora conservato a Roma nella Galleria nazionale di arte antica. Forse è anche raffigurato in un
altro ritratto, nella galleria Colonna, opera di Benedetto e Gabriele Caliari.
Fonti e Bibl.: B. Varchi, Storia fiorentina, a cura di M. Sartorio, I, Milano 1845, pp. 332, 415, 453, 467 ss.; II, ibid. 1846, pp. 13, 16,
44 s., 58-61, 115, 138, 155; M. Sanuto, I Diarii, XXXV-LVIII, Venezia 1892-1903, ad Indices; B. Cellini, La vita…, a cura di A. J.
Rusconi - A. Valeri, Roma 1901, pp. 436, 444; M. e G. Du Bellay, Mémoires, a cura di V.-L. Bourrilly - F. Vindry, II, Paris 1910, pp.
121, 399 s.; III, ibid. 1912, pp. 113, 138 ss., 147, 254 s., 258-61; Nuntiaturberichte aus Deutschland, VII, Berlin 1912, pp. 455, 458,
461; F. Guicciardini, Storia d'Italia, a cura di C. Panigada, Bari 1929, V, pp. 79, 105, 108, 258, 264, 290 s., 296; P. Giovio, Lettere, a
cura di G. G. Ferrero, I, Roma 1956, pp. 55, 148, 266, 300, 314; II, ibid. 1958, pp. 221, 233; Nunz. di Venezia, a cura di F. Gaeta,
Roma 1960, pp. 69, 91, 96, 157, 160, 163, 166, 168 s.; A. Coppi, Memorie colonnesi, Roma 1855, pp. 287, 292, 302; G. G. Ferrero,
Manoscritti e stampe delle lettere di Paolo Giovio, in Giornale storico della letteratura italiana, CXXVIII (1951), pp. 393 s.; Mem.
stor. e doc. sulla città e sull'antico principato di Carpi, a cura di P. G. Baroni, XIII, Bologna 1962, pp. 46, 48, 57, 60 s., 64, 161, 166,
241, 245, 255, 296 s., 412, 415, 423 s., 461, 480, 496, 502, 521; G. Smith, Bronzino's Portrait of S. C., in Zeitschrift für
Vunstgeschichte, XI, (1977), pp. 265-69 (con ult. bibl.); P. Litta, Le fam. cel. d'Italia, s. v. Colonna, tav. VIII.
Colonna, Ascanio
(ca 1490/99 - 1557)
Dizionario Biografico degli Italiani
di RR. Petrucci
COLONNA, Ascanio. - Nacque nell'ultimo decennio del sec. XV da Fabrizio duca dei Marsi, gran connestabile del Regno, e da
Agnese figlia di Federico di Montefeltro duca di Urbino. Nel 1520, alla morte del padre, ne ereditò i titoli e i beni e l'anno dopo gli
successe nella carica di gran connestabile del Regno. Il 5 giugno 1521, il C., che aveva stipulato il compromesso di matrimonio l'11
nov. 1518, prendeva in moglie Giovanna d'Aragona, una delle più celebri dame, italiane del secolo.
Alcuni biografi del C. affermano che egli partecipò in quell'epoca alla guerra che portò alla restaurazione sforzesca in Lombardia, ma
la cosa sembra poco probabile perché altre fonti testimoniano la presenza del C. a Napoli prima, nei suoi feudi di Abruzzo ammalato
nell'agosto e quindi a Marino a settembre, a Roma nel dicembre.
Alla morte di Leone X il C., considerato il capo della fazione dei Colonna, fu convocato, insieme con gli Orsini, dal Sacro Collegio, al
quale si dichiarò pronto ad obbedire. Gli fu così affidata nel gennaio del 1522la guardia del conclave. Nel periodo che intercorse
dall'elezione di Adriano VI al suo arrivo a Roma, il C., mentre Francesco Maria Della Rovere recuperava Urbino, sottrattogli da
Leone X, fece mostra di aspirare al possesso di quel ducato, accampando diritti che gli venivano da parte della madre.
Quando nell'agosto di quell'anno Adriano VI giunse finalmente a Roma, il C., andando ad incontrarlo, non esitò a chiedergli ipso facto
la grazia per Lelio Della Valle in carcere per omicidio, ricevendo un rifiuto dal severo pontefice. Comunque il C. fu presente
all'incoronazione del ponrefice il 31 agosto. L'anno dopo egli fu similmente presente all'incoronazione del successore di Adriano,
Clemente VII.
Di fede imperiale come la maggior parte dei suoi consorti, il C. agli inizi del 1524era al servizio di Carlo V con sessanta uomini
d'arme e quando Francesco I, che aveva nell'ottobre riconquistato Milano, inviò alla fine dell'anno la spedizione del duca d'Albany
contro il Regno, il C. gli si oppose finché, dopo la battaglia di Pavia (25 febbr. 1525), l'Albany fu costretto a ritirarsi dal Regno.
Tornava intanto per un momento alla ribalta per il C. la ricorrente questione dei ducato di Urbino. Il papa infatti il 20 giugno 1525gli
conferì il ducato, come discendente dei Montefeltro, nel caso però che fosse stato da considerare decaduto Francesco Maria Della
Rovere, il che non avvenne.
La, politica di Clemente VII diveniva intanto sempre più filofrancese, e il C. si univa ai consorti che dall'estate del 1525 si strinsero
nell'opposizione al pontefice intorno al cardinale Pompeo. Quando questi capeggiò la spedizione che il 20 sett. 1526 vide i Colonnesi,
in nome dell'autorità imperiale e in odio al papa mettere a sacco i palazzi vaticani, il C. era con lui. Addivenuto Clemente VII a un
accordo con l'ambasciatore imperiale, Ugo de Moricada, i Colonnesi dovettero ritirarsi, ma il loro scontento era pari alla volontà del
pontefice di non mantenere la promessa di perdono nei loro confronti. Così il C. fu compreso nel monitorio che il papa lanciò ai primi
di novembre contro i Colonna. Partecipò quindi alla guerra che si scatenò nella Campagna romana fra il Vitelli, incaricato dal papa di
distruggere i possedimenti colonnesi e i Colonna stessi. Dopo la caduta di Gallicano e Zagarolo, il C. restrinse la difesa a Paliano e
Rocca di Papa, inseguì il Vitelli a Valmontone e lo attaccò quindi presso Tivoli, ma dovette poi ritirarsi a Paliano.
Quando il 1° dic. 1526 giunse a Gaeta il Lannoy, sia il C. sia il cardinale Pompeo erano ad accoglierlo per ossequiarlo, ma anche per
chiedere vendetta contro il pontefice. Subito dopo egli partecipò alla campagna condotta dalle truppe spagnole in difesa del Regno e
fu presente alla battaglia combattuta nei pressi di Frosinone, favorevole alle armi pontificie. Nel frattempo, il 20 febbr. 1527. il papa
aveva lanciato una nuova bolla contro i Colonna.
Il C. giunse a Roma con il cardinale Pompeo pochi giorni dopo l'inizio del sacco e ottenne immediatamente da Carlo V il titolo di
protettore e governatore di Velletri. Egli aveva un interesse particolare per questo incarico, in quanto voleva che i Velletrani
risarcissero i danni arrecati l'anno prima a Marino, che avevano incendiato quando il papa aveva inviato il Vitelli contro i
possedimenti colonnesi. Il C. ingiunse a Velletri il pagamento di 24.000 scudi, di cui 7.000 furono versati subito e per il resto fu
ipotecato Lariano.
Poco meno di un anno dopo il C. si trovò a difendere questa volta non gli interessi della famiglia, ma i suoi propri a proposito
dell'eredità del cugino Vespasiano, da questo lasciata alla sua unica figlia Isabella e rivendicata, oltre che dal C., dal papa stesso e da
Prospero di Cave. Paliano, la più importante località contesa, fu occupata dalle truppe pontificie, che furono però soppiantate dalle
forze di Prospero di Cave. Nella guerra che subito si accese (ma anche presto si spense) fra i Colonna e gli Orsini, che difendevano gli
interessi papali, Paliano pervenne e rimase al Colonna.
Subito dopo troviamo il C. con le forze imperiali che si opponevano nel Regno alla spedizione del Lautrec e quando nella primavera
del 1528 a Capo d'Orso avvenne la battaglia navale che vide prevalere le navi genovesi, alleate dei Francesi, sull'armata spagnola, egli
fu uno dei protagonisti dell'avvenimento, durante il quale il comandante spagnolo, Ugo de Moncada, fu ucciso. Il C., ferito a una
mano e coperto di sangue, caduti tutti i suoi compagni, la galea in fiamme, fu preso prigioniero da Niccolò Lomellino. Si sostiene che
durante la sua cattività a Genova i suoi colloqui con Andrea Doria, che non volle consegnarlo ai Francesi, influirono sulla decisione di
quest'ultimo di passare nel campo imperiale.
Riscattato dal cardinale Pompeo, il C. dopo la breve prigionia tornò a militare sotto l'Orange, che, creatolo viceré d'Abruzzo, lo inviò
al recupero dell'Aquila. Ricevuta il 14 febbr. 1529 la conferma della carica di viceré, dopo uno dei ricorrenti sussulti di pretese sul
ducato di Urbino, il 2 agosto il C, partecipò alla messa solenne celebrata a Roma per la pubblicazione della lega del pontefice con
l'imperatore. Vi presiedette accanto al principe d'Orange, che seguì poi all'assedio di Fitenze. Egli non assistette però alla conclusione
di questa campagna, poiché nel giugno del 1530, a capo dell'esercito pontificio, contrastava in Abruzzo e nella Campagna romana
Napoleone Orsini, Giulio Colonna e Giovan Battista Conti, ribelli alla Chiesa.
Nel gennaio dell'anno successivo egli sembrò finalmente mettere la parola fine alla questione di Urbino, accompagnando il futuro
genero del duca e suo cognato, Antonio d'Aragona, nella città, dove fu accolto con gran magnificenza e cordialità.
Nel 1533 si riaccese il mai sopito contrasto del C. con gli eredi di Vespasiano Colonna e ciò che è notevole è il fatto che a un breve
del papa, che gli imponeva di lasciare alcune terre, già appartenute a Vespasiano, al genero di questo, Luigi Gonzaga, marito di
Isabella Colonna, il C. non esitasse a impugnare le armi contro l'autorità pontificia, mentre l'oratore cesareo interveniva in suo favore.
La benevolenza di Carlo V per il C., del quale si esaltavano il valore, la prudenza e la fedeltà alla causa imperiale, si manifestò anche
nel dicembre del 1534, quando gli si concesse un aumento sulle rendite del Regno e gli si associò il figlio Fabrizio nella carica di gran
connestabile.
Intanto era salito al soglio pontificio Paolo III e il C. si era dimostrato entusiasta di questa elezione. Egli era stato uno di coloro che
avevano trasportato la sedia gestatoria per condurre il pontefice in chiesa. Inoltre aveva partecipato a due giostre in onore e in
presenza dei papa, una a piazza S. Pietro, dove due schiere avevano finto degli assalti e una ai SS. Apostoli, dov'era avvenuto un
combattimento con le lance.
Quando, dopo l'impresa di Tunisi, Carlo V, risalita l'Italia, giunse a Roma, egli fu prima accolto a Marino dal C., che lo accompagnò
nell'Urbe. Qui sua sorella e sua moglie ricevettero una visita di cortesia dall'imperatore, che pare gli richiedesse la mano di sua figlia
Vittoria per Filippo di Lannoy, principedi Sulmona, che finì poi, stante il rifiuto sostanziale del C., per sposare Isabella Colonna.
Dopo la partenza del sovrano il C. si assunse l'incarico di trarre dalla parte di Carlo V il pontefice nella nuova lotta franco-imperiale.
Poco si sa sull'attività pubblica dei C. in questi anni, salvo la richiesta nel 1534 al pontefice di creare cardinale Francesco Colonna, la
sua presenza il 31 genn. 1537 alla cerimonia del giuramento a S. Pietro di Pier Luigi Farnese, nominato gonfaloniere della Chiesa, la
sua aspirazione a ricevere l'investitura di Frascati. Comunque sembra di poter ipotizzare un accumularsi di astio del C. nei confronti
del papa, visto che quando questi impose nel 1537 un'imposta per fuochi per fronteggiare il pericolo turco, il C. si rifiutò di pagare
l'imposizione. Nell'estate dello stesso anno, inoltre, egli proibì ai propri vassalli di prestare la loro opera ai lavori di fortificazione a
Roma, come era stato richiesto dal governo pontificio.
Si arrivò quindi nell'anno 1539 al ratto che venne compiuto da Marzio Colonna di Livia Colonna, che doveva essere dotata dal C., il
quale sospettò la connivenza del papa in quest'episodio. Nello stesso anno il pontefice impose un aumento del prezzo del sale, dal
quale il C. sostenne di aver diritto ad essere esentato, in grazia dei privilegi concessi da Martino V alla famiglia. Paolo III non era di
quest'avviso, ma ambedue le parti rimasero ferme nelle loro posizioni. Il 10 giugno 1540 il papa si decise a emanare un breve, che
però non fu spedito, con il quale ingiungeva al C. di presentarsi a rendere conto delle sue azioni entro tre giorni. L'alta protezione di
cui godeva il C. da parte dell'imperatore e il fatto che proprio allora egli si stesse assoggettando a pagare l'aumento dovuto parevano
presagire che la controversia si sarebbe acquietata. Tuttavia, e a causa della predisposizione dei Colonna a un atteggiamento di sfida
nei confronti del potere temporale e forse per il carattere stesso del C., i rapporti fra lui e il papa non ridivennero normali. Nello stesso
anno infatti egli ostacolò l'importazione di granaglie a Roma e quando nel febbraio del 1541 alcuni vassalli colonnesi, che si erano
rifiutati di ottemperare all'obbligo di pagare il sale con il dovuto aumento, furono arrestati, egli operò rappresaglie su viaggiatori in
transito verso Roma e depredò il bestiame dell'appaltatore delle saline di Ostia.
Il 25 febbr. 1541 Paolo III emanò un breve che gli intimava di presentarsi a giustificarsi entro tre giorni. Questi, che aveva fortificato
Rocca di Papa e si era ritirato a Genazzano con duemila uomini, non assunse un atteggiamento di sfida nei confronti del pontefice,
dicendosi pronto a ubbidire, ma si guardò bene dall'ottemperare all'ingiunzione, continuando i preparativi di guerra e inviando
richieste di aiuto. Memore di quanto avevano intrapreso i Colonna, compreso il C., nel 1526 contro il suo predecessore, il papa fece
apprestare le truppe e ne affidò il comando a Pier Luigi Farnese. Invano si interposero per evitare il conflitto la celebre sorella del C.,
Vittoria, il viceré di Napoli e l'ambasciatore imperiale a Roma. Ognuna delle parti in contrasto pretendeva dall'altra, per recedere dalla
guerra, garanzie inaccettabili. Le ostilità cominciarono a metà marzo.
Mentre le località colonnesi cadevano l'una dopo l'altra, la resistenza si concentrò a Paliano, cui le truppe pontificie posero l'assedio,
anche se nel frattempo fervevano pratiche per arrivare a un accordo e da Ischia Giovanna d'Aragona scriveva al papa perché fosse
risparmiata la popolazione dalle rovine della guerra. Ai primi di aprile il C. lasciò Paliano, affidandone la difesa a Fabio Colonna e a
Torquato Conti. Probabilmente sperava di ottenere cospicui aiuti dal viceré di Napoli per soccorrere la cittadina, che però fu
conquistata il 9 maggio; la cittadella cadde il 26.
Il C. era stato schiacciato e invano si interpose per lui l'imperatore stesso. Il papa confiscò tutti i possedimenti colonnesi nella
Campagna romana e fece radere al suolo le fortificazioni di Marino, di Rocca di Papa e infine (gennaio 1543) di Paliano. Al C. si aprì
la via dell'esilio nel Regno, nei suoi feudi di Albe e Tagliacozzo, che aveva ereditato dal padre.
A nulla sortirono gli inviti alla clemenza di Carlo V, che a Lucca nello stesso anno non mancò di intercedere ancora una volta per il
suo protetto, suggerendo al papa la soluzione di restituire lo Stato anziché al C. al figlio e proponendo alleanze matrimoniali. Il C.
rimase bandito dai suoi Stati e per un lungo periodo di lui non si sa se non che nel 1547 ereditò Pescocostanzo dalla sorella Vittoria e
che non si astenne da liti e da atti di violenza sui possessi di Isabella Colonna e che probabilmente sotto il pontificato di Paolo III subì
un processo per eresia per essere sospettato di simpatie nei riguardi di Bernardino Ochino.
Alla morte di Paolo III, il 10 nov. 1549, mentre il C. si trovava a Venezia, Camillo Colonna gli recuperò i possedimenti intorno a
Roma. Giulio III, seguendo la politica alternativa dei papi nei confronti dei baroni romani e anche con lo scopo di ingraziarsi Carlo V,
reintegrò il C. nei suoi Stati, concedendogli il perdono, il 17febbraio del 1550.
I buoni rapporti dei C. con il pontefice sono provati anche dal magnifico dono, che egli fece a quest'ultimo nel 1553: una immensa
vasca di porfido, proveniente da scavi nella Curia del Foro romano. Essa era danneggiata e lo stesso Michelangelo fu consultato per il
restauro, anche se questo fu fatto poi piuttosto rozzamente. La tazza, posta dal papa nella sua villa fuori porta Flaminia (villa Giulia),
fu in seguito sistemata in Vaticano nel cortile del Belvedere per volere di Clemente XI, che la fece anche restaurare più
acconciamente. Essa è ora nella rotonda del Museo Pio-Clementino, dove fu fatta trasportare da Pio VI nel 1792.
Fin dal 1535 il C. era stato abbandonato dalla moglie Giovanna d'Aragona (dalla quale aveva avuto i figli, Fabrizio, Marcello,
Prospero, Marcantonio eVittoria, Agnese e Girolama), e a nulla erano valsi gli interventi di autorevoli personaggi per indurla a
riprendere la convivenza con il marito. Nel novembre del 1552 lo stesso Ignazio di Loyola si recò dall'Aragona, senza ottenere
peraltro alcun successo. Nel mese successivo il C. diseredava, qualificandolo ribelle e nemico, il figlio Marcantonio, destinato a
grandi imprese, che era l'unico maschio sopravvissuto e che faceva causa comune con la madre, e la moglie, anch'essa definita
"inobediens, inimica et rebellis". Salvo alcuni lasciti alle tre figlie, il C. aveva lasciato la Chiesa erede dei suoi beni.
Oltre al figlio, che lo incolpava fra l'altro di aver fatto abortire sua moglie, il C., sospettato anche di interessarsi di magia, aveva
contraria, come si è detto, la propria consorte e non favorevole gli era stata la sorella Vittoria, che gli aveva rimproverato non lievi
difetti. Il suo nemico capitale era comunque Marcantonio, che giunse a cercare di indurre un servitore del padre ad accusare il suo
padrone di aver fatto uccidere il figlio Fabrizio, di dilettarsi "di ragazzi attive et passive", di essere luterano. I rapporti fra i due
congiunti arrivarono così a un tal grado di inimicizia che quando nel 1553 Marcantonio, comandante della cavalleria imperiale, passò
nel Lazio diretto nel Regno dal Senese, si impadronì con la forza delle terre del C., il cui comportamento nei riguardi del figlio, della
moglie e della nuora era già stato deplorato dal papa nel settembre dello stesso anno.La sorte del C., rifugiatosi nei suoi feudi
d'Abruzzo, volgeva al peggio, poiché egli stava perdendo anche la protezione dell'imperatore, voltosi in favore di Marcantonio e forse
sospettoso di una sua connivenza con i Francesi. In effetti egli aveva avuto contatti con i Transalpini; sosteneva però di non essersi
allontanato dalla sua fede imperiale e temeva di essere stato calunniato dal figlio. Nel settembre del 1554 il viceré d'Abruzzo,
chiestogli un appuntamento vicino ad Avezzano, lo arrestò e lo condusse a Napoli. Portato a Castelnuovo, ricevette la visita di tutte le
personalità presenti nella città e anche della figlia Vittoria, che invano supplicò il viceré per lui. Benché alcuni storici lo dicano morto
nel marzo del 1555, pare che nel settembre di quell'anno fosse visitato anche dal figlio, che tentò invano di fargli cambiare il
testamento che lo diseredava.
Appunto allora Marcantonio aveva dovuto abbandonare Paliano, Genazzano e altri castelli, che Paolo IV aveva fatto occupare. I
Colonna infatti si erano schierati in favore di Carlo V nel contrasto sorto fra lui e il papa. Questi il 4 maggio 1556 emanava una bolla,
in cui dichiarava decaduti dal possesso dei loro feudi il C. e il figlio e concedeva Paliano e gli altri possedimenti al nipote Giovanni
Carafa. Neanche dopo la pace di Cave (settembre 1557) il papa si indusse a perdonare ai due Colonna, cui le pene non furono
condonate.
Il C. comunque era già morto il 24 marzo 1557a Napoli, nella sua prigionia di Castelnuovo tre giorni dopo aver revocato il suo
testamento, che del resto era già stato annullato da un breve del 6 nov. 1554.
Fu seppellito a Paliano e per la sua eredità sorsero violenti contrasti fra Marcantonio e la sorella Vittoria, anche se tutte le proprietà
erano gravate di enormi debiti, per pagare i quali Marcantonio dovette alienare parecchie località.
Il primogenito del C., Fabrizio, partecipò con il padre alla guerra del sale nel 1541. Dieci anni più tardi era all'assedio che le forze
pontificie e imperiali avevano posto a Parma, difesa da Ottavio Farnese. Qui si ammalò e, trasportato a Viadana, vi morì ventiseienne
il 24 ag. 1551. Aveva sposato Ippolita Gonzaga.
Fonti e Bibl.: C. Guidiccioni, Opere, a cura di C. Minutoli, II, Firenze 1867, pp. 371-402, 409-437; C. Corvisieri, Compendio dei
processi del Santo Uffizio di Roma, in Arch. d. R. Soc. rom. di storia patria, III (1880), pp. 268 s.; M. Sanuto, Diarii, XXVIII-LVIII,
Venezia 1890-1903, ad Indices; V. Colonna, Carteggio, a cura di E. Ferrero - G. Müller, Torino 1892, ad Indices; F. Guicciardini,
Storia d'Italia, a cura di C. Panigada, Bari 1929, IV-V, ad Indicem; J. E. Martínez Ferrando, Privilegios otorgados por el
emperadorCarlos V, Barcelona 1943, pp. 80 ss., 146; P. Giovio, Lettere, a cura di G. G. Ferrero, I, Roma (1956, pp. 1, 118, 121 s.,
265, 270; II, ibid. 1958, pp. 6, 12, 225; L. Santoro, La spediz. di Lautrec, a cura di T. Pedio, Galatina 1972, pp. 115 s.; F. Cancellieri,
Lettera intorno la maravigliosa tazzadi porfido..., Roma 1821, passim; P. Nores, Storia della guerra di Paolo IV S. P. contro gli
Spagnuoli, in Arch. stor. ital., XII (1847), pp. 21 s.; A. Coppi, Memorie colonnesi, Roma 1855, pp. 271 s., 280 s., 286 s., 292, 297 s.,
300, 303, 306-312; R. Ambrosi De Magistris, Documenti anagnini, in Arch. d. R. Soc. rom. di st. patria, IV (1881), pp. 326, 329 ss.;
A. Bertolotti, La prigioniadi A. C. (1553-1557), in Atti e mem. delle Deput. di storia patria per le prov. moden. e parmensi, s. 3, II
(1883), pp. 109-81; F. Gregorovius, Storiadella città di Roma nel Medioevo, IV, Roma 1902, pp. 703, 709, 735, 771; G. Tomassetti,
DellaCampagna romana, in Arch. della R. Soc. rom. distoria patria, XXVIII(1905), p. 121; XXIX (1906), pp. 60, 308, 332-335; XXX
(1907), p. 380; L. Cardaus, Paul III., Carl V. und Franz I. in den Jahren 1535 und 1536, in Quellen undForschungen aus ital. Archiven
und Bibl., XI (1908), pp. 199, 201, 239-244; P. Colonna, IColonna..., Roma 1927, pp. 159, 172 ss., 177 ss., 185-189, 191, 193, 346
ss., 35; ss., R. Delbrück, AntikePorphyrwerke, Berlin-Leipzig 1932, pp. XXIII, 189; L. v. Pastor, Storia dei papi, IV, 2, VI, Roma
1956-1963, ad Indices; R. Gnoli, MarmoraRomana, Roma 1971, pp. 105, 107; P. Litta, Le famiglie celebri ital., s. v. Colonna, tav.
VII.
Colonna, Marcantonio
(1535 - 1584)
Dizionario Biografico degli Italiani
di FF. Petrucci
COLONNA, Marcantonio. - Nacque il 26 febbraio del 1535 a Civita Lavinia da Ascanio, gran connestabile del Regno, e da Giovanna
d'Aragona. Il contrasto fra i genitori, culminato poco dopo la sua nascita nella definitiva separazione, influì negativamente sui suoi
rapporti con il padre. Nel dicembre del 1552 infatti quest'ultimo, che aveva visto fallire un ulteriore tentativo di riavere con sé la
moglie, diseredò il C., unico figlio maschio rimastogli.
Nell'atto, che fu poi annullato da un breve di Giulio III del 6 nov. 1554, il padre lo accusò non solo di disobbedienza e di ribellione,
ma anche di minacce e calunnie. In effetti l'inimicizia del C. verso il genitore fu confermata poco più di tre anni dopo da un
dipendente di Ascanio, che accusò il C. e la madre di aver tentato anche con la tortura di fargli confermare gravissime accuse contro il
padrone, delle quali questi era, a suo dire, innocente. Nel giudicare il comportamento del C. verso il padre - e alcuni contemporanei lo
fecero in modo negativo - c'è da tener presente comunque che la fama di Ascanio Colonna non fu quella di un uomo mite. Il C.
tuttavia aveva obbedito alla volontà del genitore dando l'anello, il 29 febbr. 1552, a Felice Orsini; le nozze erano state celebrate il 12
maggio (Vat. lat. 7975, c. 41).
Quando Carlo V all'inizio del 1553 inviò un esercito al comando del viceré di Napoli contro Siena, il C. si pose al servizio degli
Imperiali. Allorché costoro posero fine alla campagna, abbandonando l'assedio di Montalcino e si diressero verso il Regno, contro il
quale si temeva un attacco turco, il C., transitando per il Lazio, si impadronì con la forza dello Stato del padre, che non fece resistenza
e si rifugiò nei suoi feudi in Abruzzo, dove poco dopo fu arrestato ad opera del viceré per sospetto di tradimento.
Il C. cominciò quindi ad amministrare i feudi, che gli appartenevano di fatto se non di diritto, continuando però a usare i metodi di
brutale sfruttamento del genitore, come ebbero a sostenere gli abitanti di Nettuno qualche anno dopo in una supplica, in cui
chiedevano al papa di liberarli da tali angherie.
L'anno successivo il C. fece parte del contingente di truppe napoletane inviate a collaborare con quelle fiorentine di Cosimo de'
Medici, che aveva ripreso le ostilità contro Siena. Il 2 agosto partecipò alla battaglia di Scannagallo (Marciano), al comando di uno
squadrone di trecento uomini d'arme. Dopo la vittoria il C. fu lasciato a capo dell'esercito, mentre Giangiacomo de' Medici, marchese
di Marignano, si recava a Firenze con altri capitani a ricevere le ricompense per il conseguito successo. Il C. non rimase in campo fino
alla caduta di Siena; nel novembre infatti, quando un breve di Giulio III ratificava la sua occupazione degli Stati del padre, egli era a
Marino.
Eletto al soglio pontificio Paolo IV, di cui furono subito palesi le tendenze filofrancesi, nel luglio 1555 il C. partecipò alla riunione
indetta dal cardinale di Santa Fiora tra gli aderenti al partito filoimperiale. In essa il giovane C. si disse pronto a provocare una
sollevazione contro il pontefice, ma nell'agosto, quando quest'ultimo fece arrestare Camillo Colonna e il cardinale di Santa Fiora, il
C., cui intanto Filippo II aveva concesso il comando delle genti d'arme prima comandate dal padre e il possesso di Tagliacozzo, fuggì
tempestivamente da Roma, rifugiandosi a Paliano, ove si fortificò.
Nell'Urbe rimasero la madre, la moglie e due sorelle, alle quali il papa proibì di lasciare la città e la loro casa. Inoltre furono emessi
monitori contro il C., che poi, considerato ribelle, fu colpito dalla sentenza di confisca dei beni. Egli si rese conto allora di non poter
tenere testa alle truppe pontificie da solo e si decise ad abbandonare Poliano. Giacque qualche tempo ammalato a Gaeta, quindi si
portò a Napoli. Qui sì recò a visitare il padre prigioniero e lo pregò, senza che questi vi accondiscendesse, di revocare il testamento,
come invece finì per fare, il 21 marzo 1557, poco prima di morire. Alla fine dell'anno la madre e le altre colonnesi riuscirono a fuggire
da Roma, provocando le ire del papa, che intanto si era stretto in un trattato di alleanza con la Francia.
Il 1556 si apriva sotto cattivi auspici per il Colonna. Fuggiasco, aveva perduto le terre usurpate al padre ed era violentemente
avversato da Paolo IV, il quale il 7 gennaio a un intervento dell'ambasciatore cesareo, che intercedeva per lui, aveva risposto molto
duramente. Il 4 maggio la bolla di scomunica e di privazione dei beni contro il C. e il padre precedeva di pochi giorni l'investitura
dello Stato di Paliano, eretto a ducato, in favore di Giovanni Carafa.
Nel luglio il C., che il mese prima era stato a Venezia e forse alla corte dell'imperatore, era in Abruzzo, prima di portarsi a Napoli, ove
fervevano i preparativi per la guerra ormai imminente contro Paolo IV. Il 21 agosto il duca d'Alba gli conferiva il grado di generale
degli uomini d'arme, con il quale egli seguì l'esercito napoletano, cheil 5 settembre passò il confine dello Stato della Chiesa.
Gli Spagnoli occuparono Pontecorvo, Ceprano, Alatri, quindi Frosinone, Anagni, Ferentino, Terracina; giunsero fino a Tivoli. Tutte le
terre colonnesi si dettero all'esercito invasore al grido di "Colonna". Quando gli Spagnoli si accinsero alla conquista di Ostia, che
cadde il 18 novembre, il C. ebbe l'incarico di far costruire un ponte di barche. Il 29 novembre i Pontifici, dicendosi disposti a cedere
Paliano in cambio di Siena, ottennero una tregua di quaranta giorni.
L'avanzata in Italia del duca di Guisa capovolse però la situazione e quando nell'aprile del 1557 egli ruppe le ostilità nel Regno dalla
parte dell'Abruzzo, si riaccese la lotta anche nella Campagna romana, dove era rimasto il C. come capitano generale, con quattromila
fanti e sei pezzi di artiglieria. Gli venne incontro con tremila fanti italiani, due compagnie di tedeschi e sette cannoni Giulio Orsini,
che il C. sconfisse ad Acuto. Egli ottenne poi un'altra vittoria fra Valmontone e Segni, che fu saccheggiata dalle sue truppe. Si era
nell'agosto e il C., raggiunto dal viceré, si portò verso Roma, cercando di sorprenderne i difensori, ma la sorpresa mancò.
La pace di Cave, nel settembre, fu poco favorevole al C., cui non venivano condonate le pene. Gli accordi contenevano un capitolo
segreto, secondo cui Paliano, dopo che fosse stato adeguatamente indennizzato Giovanni Carafa, doveva essere concessa a una
persona indicata dal re e gradita al pontefice. Nei due anni successivi il C. si recò due volte alla corte dì Filippo II. Una prima volta
subito dopo la pace di Cave, mentre vi si trovava anche il cardinal Carlo Carafa, che in cambio di Paliano cercava di ottenere da
Filippo molto più dei 20.000 ducati di pensione per lui e del ducato di Rossano per il fratello, offerti dal re. Del resto il papa, sempre
decisamente avverso al C., intendeva che Paliano rimanesse libera e al nipote fosse dato il ducato di Bari. La presenza a corte del C.
non riuscì né nel primo, né nel secondo viaggio a far risolvere l'intricata questione.
Tre giorni dopo la morte di Paolo IV (18 ag. 1559) il C., che nell'aprile era stato compreso da Filippo II nel trattato di pace di CaveauCambrésis, giunse a Roma. Il 22, accolto con manifestazioni di simpatia, si presentò ai cardinali e si dichiarò pronto a obbedire al
Sacro Collegio e al futuro papa. Durante il lungo conclave Filippo II informò i porporati, con una lettera dell'ottobre, che era sua
opinione che Paliano dovesse tornare al C., perdipiù senza alcun compenso per i Carafa. Pio IV in un primo momento non accolse
l'ingiunzione del sovrano e il C. ritornò in possesso di tutto lo Stato e dei palazzi di Roma, ma non di Paliano.
Mentre la posizione dei nipoti del papa defunto si veniva facendo sempre più precaria, Giovanni Carafa, che si era rifugiato a Gallese,
intentò un processo contro il C., che egli accusava di aver tentato di avvelenarlo; ma questi erano gli ultimi tentativi per nuocergli. La
stella del C. stava infatti risalendo rapidamente. Nello stesso anno Filippo II lo insigniva dell'Ordine del Toson d'oro e nel maggio del
1560 lo creava connestabile del Regno di Napoli; il 3 febbr. 1561 il papa gli conferiva l'Ordine equestre dell'Aurata Milizia; il 25
maggio diveniva luogotenente del Regno di Napoli.
La completa reintegrazione del C., il cui primogenito Fabrizio aveva sposato il 4 maggio 1562 Anna Borromeo, nipote del papa e
sorella del cardinale Carlo, avvenne con la restituzione di Paliano, il 17 luglio. Per intercessione di Filippo II e dati anche i buoni
rapporti che si erano instaurati con il pontefice, questi anziché diroccarla, gli concesse la cittadina fortificata, completa dell'artiglieria
e delle munizioni. Lo stato finanziario della famiglia era però tutt'altro che florido, anche se Pio IV aveva favorito il C., rinunciando
alle clausole fidecommissarie su Paliano. Il C. fu così costretto a vendere Nemi ai Piccolomini, Civita Lavinia e Ardea a Giuliano
Cesarini, Caprinica, Pisciano, Ciciliano e San Vito a Domenico Massimo, mentre perdurava una lite con la sorella Vittoria, che
avanzava pretese su alcuni beni in Abruzzo.
Nell'estate 1564 il C. soggiornò a lungo a Madrid, alla corte di Filippo II, che il 1° agosto lo nominò consigliere di Stato del Regno di
Napoli.
I rapporti del C. con Pio V furono ottimi; il papa nell'ottobre del 1567 pensava di inviarlo in aiuto del re di Francia contro gli ugonotti
e a sua volta il C. preparò un progetto per istituire un corpo di milizia nello Stato pontificio. Il 30 marzo 1569 Pio V eresse Paliano a
principato.
Il 21 marzo di quello stesso anno il C. aveva intrapreso un altro viaggio in Spagna, dove rimase per parecchi mesi. La lunga inattività
pubblica cominciava evidentemente a pesare al C., che aveva desiderato essere impiegato dal sovrano nella guerra dei Paesi Bassi e
aspirava a divenire governatore di Milano. Caduto ammalato nel luglio, durante il soggiorno a Madrid, il C. ripartì verso l'Italia il 27
ottobre senza avere nulla ottenuto. Il 5 marzo 1570 presenziò all'incoronazione granducale di Cosimo de' Medici e prese parte alla
cerimonia porgendo la corona al papa.
Intanto il papa si stava adoperando per promuovere una lega contro i Turchi, i quali già dall'anno precedente avevano chiaramente
dimostrato di voler rimuovere l'ostacolo che Cipro rappresentava alla loro espansione militare. Pur non riuscendo per il 1570 a
costituirla, egli ottenne che Filippo Il desse ordine alla sua flotta di concentrarsi in Sicilia per unirsi eventualmente alle forze navali
veneziane e pontificie. Il pontefice, a cui Venezia offrì di fornire gli scafi di dodici galere da armare, scelse il C. quale capitano
generale della sua armata.
Nel breve dell'11 giugno sono genericamente indicati dal papa i motivi della nomina nella sua nobiltà, nel valore, prudenza, fede,
nella sua pratica di cose militari; non è menzionata l'esperienza nell'arte marinara, che non poteva considerarsi molto vasta,
limitandosi al possesso e all'amministrazione per un breve periodo di alcune galere, vendutegli dal cardinale Borromeo, che
parteciparono all'impresa del Pignone e che egli rivendette al granduca Cosimo. Probabilmente influirono sulla scelta un innegabile
prestigio personale e forse l'essere egli, come gran connestabile del Regno, suddito del re di Spagna, e dunque gradito a Filippo II,
anche se invece qualche critica a questa nomina fu subito espressa dai ministri spagnoli in Italia.
Il medesimo 11 giugno il C. prestò giuramento nella cappella papale e ricevette dal pontefice il bastone del comando e lo stendardo
della lega, che sarebbe poi stato donato dal C. alla cattedrale di Gaeta. Prima di partire da Roma il C. creò suo luogotenente Pompeo
Colonna, duca di Zagarolo, e nominò i capitani delle galere; quindi, ricevuti 10.000 scudi dal camerlengo, si mise in viaggio il 16
giugno alla volta di Ancona ove giunse il 19.
Nel porto pontificio il C. trovò solo otto galere anziché dodici, per cui si recò di persona a Venezia e ottenne le altre quattro, anche se
tutt'altro che in ottimo stato. Comunque all'inizio di agosto il C. aveva in punto, armate e approvvigionate, le galere pontificie. Nella
stessa epoca giungeva a Madrid un messo, che fece al sovrano da parte del C. una relazione minuziosa di quant'egli aveva operato e
anche del numero, della consistenza e dello stato dell'armata veneziana.
Mentre quest'ultima, composta di centotrentasette galere, al comando di Girolamo Zane, si concentrava a Corfù, Filippo II il 9 agosto
dette a Gianandrea Doria, capitano delle forze spagnole, l'ordine di partire, con le sue quarantanove galere, per il Levante. Il 6 dello
stesso mese il C. era giunto a Otranto e qui decise di attendere il Doria, che vi arrivò il 20.
Si vide subito quale sarebbe stata la nota dominante della spedizione, quando, giunto a Otranto, il Doria rimase all'ancora fuori del
porto, senza curarsi di presentarsi a quello che si considerava il suo comandante. Il C. effettivamente si considerava il comandante in
capo della spedizione; così mostravano di credere i Veneziani; inoltre Filippo II in una lettera, che il C. aveva trovato in porto
giungendo a Otranto, asseriva che il capitano spagnolo avrebbe dovuto prestargli obbedienza. Il Doria tuttavia lo contestò sempre e il
C. d'altra parte non seppe imporre la sua autorità al recalcitrante genovese. Doti che invece possedeva il C. erano quelle della pazienza
e della prudenza, che lo indussero, dopo un tentativo di attirare il Doria sulla sua galera, a recarsi egli stesso a visitarlo sulla capitana
spagnola.
Le due flotte giunsero nel porto di Suda, a Creta, dove le attendeva quella veneziana, l'ultimo giorno d'agosto. L'impreparazione dei
Veneziani, confermata al Doria da una rivista tenuta l'11 settembre, la sua determinazione di non mettere a repentaglio la flotta
affidatagli se non con la sicurezza della vittoria, la sua decisione di non rimanere in quelle acque oltre il 30 settembre rendevano il
capitano spagnolo molto cauto su ogni iniziativa, nonostante il comprensibile desiderio dei Veneziani di affrettarsi in aiuto di Cipro,
investita dall'attacco turco già dal 1° luglio. Si aggiunga poi che il Doria, quale che fosse la reputazione di gentiluomo e di militare del
C., non ne stimava affatto le capacità marinare. Non fu che il 17 settembre che l'armata congiunta salpò verso Cipro. Erano fermi per
una tempesta a 150 miglia circa dall'isola, quando, il 21, giunse la notizia della caduta di Nicosia e questo, anziché indurli ad
affrettarsi, ché ancora resisteva Famagosta, li fece desistere dall'impresa. Decisero di portarsi a danneggiare Valona e Durazzo, il che
avrebbe forse indotto i Turchi ad abbandonare l'assedio di Famagosta. Si volsero allora verso Scarpanto e si rifugiarono lì, mentre
erano sopraggiunte violente tempeste. Il maltempo e la temuta avanzata stagione indussero il Doria allora a chiedere licenza di tornare
in Italia.
Era il 26 settembre quando i tre comandanti si riunirono sulla capitana veneziana. Non volendo Gianandrea partire senza licenza né
volendo lo Zane concederla, si rimise la cosa al Colonna. E qui si ripresentò il problema della non riconosciuta autorità del C. su tutte
e tre le flotte. La discussione divenne penosa quando il C., per dimostrare di avere ricevuto dal re questa autorità, fece portare le carte
che lo provavano; invano, tuttavia, perché il Doria sostenne di possederne altre che lo smentivano. Sdegnosamente, ma in effetti
rendendo palese la sua sconfitta, il C. lasciò libero il Doria di fare ciò che voleva e questi infatti salpò cinque giorni dopo.
Il C. e i Veneziani rimasero insieme fino a Creta prima, ove giunsero ai primi di ottobre e poi fino a Corfù, dove si separarono. La
spedizione era conclusa, senza alcun risultato, né pratico né di prestigio.
Il 28 ottobre il C. fece vela per Ancona, ma il viaggio, pure piuttosto breve, fu disastroso. Egli fu obbligato a sostare a Casopo, a
Cattaro, ove un fulmine incendiò la capitana, a Ragusa, raggiungendo infine nel dicembre il porto marchigiano soltanto con quattro
galere.
Immediatamente il C. inviò a Roma Pompeo Colonna a fare relazione al papa di quanto era occorso e del comportamento del
comandante spagnolo. Il pontefice non considerò affatto imputabile al C. il fallimento dell'impresa e giudicò invece il Doria
responsabile di ogni risultato negativo. Anche Filippo II, presso il quale si recò subito dopo lo stesso Pompeo, mostrò di ritenere
scagionato il C. da ogni appunto che gli si potesse muovere.
Intanto nell'Urbe le trattative diplomatiche per giungere alla costituzione della lega continuavano. Stabilito che capo della futura
spedizione in Levante doveva essere don Giovanni d'Austria, una delle questioni che si dibattevano era quella della luogotenenza. Nel
marzo 1571 fu risolta anch'essa e si decise che in assenza di don Giovanni sarebbe subentrato nel comando il Colonna. Erano stati
concordati tutti i capitoli, quando si ebbe una battuta d'arresto e gli ambasciatori veneziani abbandonarono Roma. Pio V allora, vista
vana l'opera del nunzio a Venezia, vi inviò il C., che partì il 6 aprile.
Questi non aveva un compito facile, perché otto mesi di trattativa avevano messo in risalto le divergenze esistenti fra i Veneziani e gli
Spagnoli. Inoltre nella città lagunare continuava a sussistere, oltre che un partito della guerra, uno che invece, voleva l'accordo con la
Porta; si aggiungevano poi diffidenze ed effettive difficoltà per la suddivisione e l'anticipo della spesa. Ciononostante la missione del
C. ebbe pieno successo.
Egli, usando il prestigio di cui godeva a Venezia, la sua eloquenza e la sua abilità, rimuovendo alcuni ostacoli e dando così
efficacemente man forte ai partigiani della guerra, riuscì a fare approvare dal Senato i capitoli già trattati. Si era ormai nel maggio. Il
giorno 20 fu sottoscritta la lega di Roma, e il 25 pubblicata.
Quale comandante della flotta pontificia il C. si accinse ad assolvere ai suoi compiti. Confermò suo luogotenente Pompeo Colonna e
assegnò le altre cariche; provvide quindi ad armare le dodici galere, che il papa aveva noleggiato dal granduca di Toscana.
Il 21 giugno la flotta partiva da Civitavecchia alla volta di Napoli. Qui il C. avrebbe voluto attendere l'arrivo di don Giovanni, ma
ritardando questo ed essendosi verificati incidenti fra i soldati pontifici e quelli spagnoli, per ordine del papa si avviò a Messina, ove
giunse il 20 luglio. Il 23, pochi giorni prima cioè della caduta di Famagosta, fu raggiunto da una parte della flotta veneziana,
comandata da Sebastiano Venier. Don Giovanni non arrivò che il 24 agosto; il 2 settembre entrò in porto l'altra parte della flotta
veneziana. Otto giorni dopo si procedette alla mostra. Le navi veneziane, trovate in difetto di uomini, dovettero accogliere, per
volontà di don Giovanni e con la mediazione del C., quattromila soldati al soldo del re di Spagna. Riunitosi il Consiglio generale, non
senza che fossero proposti e discussi altri partiti, fu presa la decisione di avviarsi a cercare il confronto diretto con la flotta turca. A
metà settembre le forze cristiane lasciavano Messina dirette a Corfù, dove arrivavano dieci giorni appresso.
Durante la successiva sosta della flotta nel porto di Gomenizza si verificò un episodio increscioso, causato dalla presenza dei soldati
spagnoli sulle navi veneziane. Don Giovanni, irato contro il Venier, che con giustizia sommaria e diretta aveva fatto impiccare quattro
spagnoli colpevoli, di grave insubordinazione, aveva ordinato che il generale veneziano fosse processato. Il C. anche questa volta si
interpose fra i due, riuscendo a evitare l'inasprimento della situazione.
Da Gomenizza la flotta si avviò con decisione verso il golfo di Patrasso, dove si sapeva che erano i Turchi. Toccarono Nasso,
costeggiarono Cefalonia e la mattina del 7 ottobre all'imboccatura del golfo di Patrasso al largo di punta Scrofa, le due flotte si
avvistarono.
Fu dato il segnale di disporsi in ordine di battaglia. Il C., con la sua capitana, era nella squadra di centro alla destra di don Giovanni.
Davanti a questa squadra, come davanti all'ala sinistra, due delle sei galeazze veneziane; dietro di essa la squadra di riserva. Quando le
galere furono disposte secondo l'ordine stabilito, don Giovanni e il C. scesero su due imbarcazioni, che li portarono uno da una parte,
uno dall'altra, lungo la linea della battaglia, a salutare e incoraggiare i combattenti. Dopo che i Turchi ebbero superato con notevoli
danni la linea delle galeazze, il combattimento, che prese nome da Lepanto, iniziò dall'ala sinistra, ma il punto focale di esso fu
costituito dallo scontro fra i due schieramenti di centro, ove si affrontarono le due ammiraglie; intorno, o meglio agganciate a loro,
quella del C. e altre cristiane e turche. Qui si decisero, positivamente per le forze della lega, le sorti dello scontro. L'ala sinistra nel
frattempo aveva avuto ragione di quella destra turca; in soccorso dell'altra ala cristiana si portarono alcune galere del centro, fra cui
quella del C., e il successo fu completo. La battaglia era durata fino al tramonto. Allora i combattenti cristiani si ritirarono a Platea.
Nell'annunciare la clamorosa vittoria al papa il C. prometteva l'invio di Pompeo Colonna, che doveva narrare al pontefice ogni
particolare. In questa e in altre lettere che partecipavano il felice esito del combattimento, il C. si profondeva in ringraziamenti a Dio,
che aveva protetto la sua armata, faceva grandi elogi di don Giovanni, che aveva guidato con maestria e valore la flotta, ma non
dimenticava di sottolineare la sua positiva partecipazione alla vittoria.
La mattina dopo la battaglia il comandante supremo tornò a ispezionare lo specchio d'acqua dove si era combattuto e volle essere
accompagnato dal C. e da altri gentiluomini. Si discusse quindi dei progetti immediati. Alcuni, fra cui il C., avrebbero voluto che in
qualche modo si sfruttasse ancora il successo, ma prevalse il parere di disarmare, visto lo stato dell'armata, la carenza dei viveri,
l'avanzare della stagione. Con altri il C. fu incaricato di censire e dividere il bottino; a lui, per la parte pontificia, toccarono diciannove
galere, due galeotte, diciannove cannoni e milleduecento prigionieri.
A Corfù gli alleati si separarono e don Giovanni e il C. si diressero a Messina, ove giunsero il 1° novembre. Da Napoli, lasciando che
il naviglio proseguisse verso Civitavecchia, il C. si avviò a Roma, dove fu pregato di non entrare, poiché l'eccita-zione e la gioia dei
cittadini esigevano che egli lo facesse in modo solenne. Si fermò allora a Marino, non senza recarsi segretamente a Roma per parlare
con il papa.
In un primo momento si sarebbe voluto far entrare il C. come un antico imperatore romano, coronato di alloro, su un cocchio dorato.
Pio V, che aveva dapprima incoraggiato senza riserve questi festeggiamenti, che erano non solo il trionfo di un uomo, ma anche
l'esaltazione della sua tenace politica contro il Turco, poi li moderò e il 22 novembre il Popolo romano deliberò i particolari dello
svolgersi della cerimonia. Mentre il C. faceva qualche tentativo per esimersi, cominciarono alacri preparativi; le critiche però non
mancarono, da parte di alcuni nobili romani, gelosi della preminenza accordata a un loro pari. E da parte degli Spagnoli, per tanti
onori tributati a colui che era stato solo il luogotenente del capo della spedizione.
L'ingresso avvenne il 4 dicembre da porta S. Sebastiano. Il C., indossando un cappello e un mantello di velluto nero con le insegne
dell'Ordine del Toson d'oro, su un cavallo bianco donatogli dal papa, avanzò fino all'arco di Costantino; passando poi sotto quelli di
Tito e di Settimio Severo, giunse in Campidoglio, arrivando quindi in Vaticano. Lungo tutto il percorso trofei, fregi, scritte. Il corteo
contava più di cinquemila persone, tutte in livree rutilanti di colori o in ricchi abiti. Tutte le cariche cittadine erano rappresentate;
precedevano il C. centosettanta prigionieri turchi, anch'essi in livrea. Colpi di cannone, scariche di archibugi, musiche. Mancavano
soltanto, ed era significativo, moltissimi nobili romani e le famiglie dei cardinali. Alla fine il C. fu ricevuto dal pontefice.
Per il giorno 13 fu organizzata un'altra solenne processione, che condusse il C. nella chiesa dell'Aracoeli, dove si resero pubbliche
grazie a Dio e dove M. A. Muret recitò un'orazione in onore del C., che fu subito data alle stampe (M. A. Mureti Oratio mandatu
S.P.Q.R. habita in reditu ad Urbem M. A. Columnae post Turcas navali proelio victos, Romae s. d.). Il C., come aveva fatto a S.
Pietro, offrì una colonna rostrata d'argento.
Subito dopo il C. fu ammesso dal papa a partecipare ai lavori della commissione deputata. Agli affari della lega e nel gennaio
dell'anno successivo era già all'opera per preparare la nuova spedizione. Nel marzo infatti, secondo le convenzioni sottoscritte il 10
febbraio, le flotte pontificia e spagnola si sarebbero dovute trovare a Messina per poi riunirsi a Corfù con quella veneziana.
Quando dopo pochi mesi (1° maggio) moriva Pio V, l'armata pontificia non era ancora riunita. Ciononostante i membri del Sacro
Collegio si preoccuparono di mostrare a Venezia e a Filippo II che non se ne trascuravano i preparativi. Il 12 maggio inviarono il C. a
questo scopo a Gaeta e scrissero a Cosimo de' Medici per sollecitare l'invio delle galere da lui promesse. Il C. era appena partito
quando fu richiamato a Roma dal pontefice repentinamente eletto, Gregorio XIII, che lo riconfermò generale dell'armata pontificia e
gli ingiunse di continuare la missione.
A Gaeta il C. trovò dodici galere, che il viceré di Napoli aveva messo a disposizione del papa, quattro delle quali egli restituì subito,
poiché intanto stavano sopraggiungendone cinque del granduca. Il 26 maggio il C. sbarcava a Napoli, ove lo attendevano altre due
galere pontificie. Ripartiva dalla città dopo appena tre giorni, avendo avuto attriti con gli alleati. Pare infatti che avesse avuto motivo
di lamentarsi per le accoglienze poco deferenti e per il fatto che gli era stato negato il comando complessivo nel caso che, come era in
programma, la sua squadra e quella del marchese di Santa Cruz fossero partite insieme per Messina. In questa città dunque con la sola
squadra pontificia arrivò il 2 giugno.
A Messina il C. trovò riunita la flotta quasi al completo, cosicché sembrò imminente l'inizio della campagna. La decisione di don
Giovanni, il 14 giugno, giorno fissato per la partenza, di rinviarla al 22, allarmò oltremodo il C. e il Soranzo, comandante veneziano,
che chiesero spiegazioni al principe, restandone però in definitiva "malcontenti". Prima che si arrivasse al 29, nuova data fissata da
don Giovanni per la partenza, giunse la notizia della decisione di Filippo II di trattenere l'armata in Occidente.
Grandi furono le recriminazioni degli alleati e soprattutto del papa. Il C., pur non nascondendo a questo e ai Veneziani l'amarezza per
la mancata partecipazione della squadra iberica all'impresa, si mise subito in attività per ottenere dagli Spagnoli trenta o quaranta
galere. Scrisse inoltre a Filippo II, non lasciando trasparire il rammarico causatogli dalla decisione del sovrano e offrendo la sua
persona nel caso che il re fosse sceso in guerra con la Francia. Ottenne da don Giovanni ventidue galere e mille soldati, che con
bandiera spagnola avrebbero obbedito ai suoi ordini. L'armata, formata da parte delle galere spagnole, al comando di Gil d'Andrada,
dalle sedici veneziane, comandate dal Soranzo., e dalle tredici pontificie, partì da Messina il 7 luglio. Il C. si era premurato di ottenere
da don Giovanni d'Austria un parere scritto su quanto la flotta cristiana avrebbe dovuto operare in Levante.
Il 15 luglio il C. giunse a Corfù, ove si congiunse con il grosso delle forze veneziane. Informatisi della consistenza dei nemici, gli
alleati si portarono a Gomenizza, decisi a veleggiare verso Sud per ricercare la flotta turca, così come era previsto dalle istruzioni di
don Giovanni. In questo porto giunse al C. la nuova della decisione di Filippo II di revocare gli antecedenti ordini al fratello e di
imporgli invece la partenza verso Levante. Di questo don Giovanni faceva partecipe il C., ordinandogli altresì che non si
intraprendesse "cosa que pueda haver peligro", ma anche di provvedere a parare i danni che l'armata turca poteva arrecare alle terre
veneziane.
Il C. poteva dunque o aspettare passivamente don Giovanni a Corfù, con il danno che comportava perdere il prezioso tempo estivo,
rischiando la salute dei marinai con un'altra sosta, o attendere alla seconda parte delle istruzioni, impedendo ai Turchi, affrontandoli,
di apportare danni alle coste. Le istanze dei Veneziani e il suo desiderio di battersi lo convinsero che partire verso il nemico era
obbedire agli ordini, anche se tutto un settore filospagnolo di storici sostenne che egli fu invece animato dalla volontà di non
rinunziare al comando supremo finalmente conseguito e di conquistarsi direttamente e indipendentemente una porzione di gloria. Che
il C. desiderasse ardentemente misurarsi con il nemico pare evidente dalle mosse successive dell'armata.
Presa all'unanimità dai tre generali la decisione di partire, la flotta salpò il 29 luglio, raggiunse Cefalonia, superò Zante e arrivò a
Cerigo. Il capo Malea la separava da quella turca, che era a Malvasia.
Il 4 agosto le due armate si avvistarono. Sembrò che potesse rinnovarsi il combattimento dell'anno prima, ma i Turchi ricusarono la
battaglia e la flotta cristiana, dopo aver incrociato un altro giorno in quelle acque in ordine di battaglia, andò ad ancorarsi in un'isoletta
fra Cerigo e Creta. Il 6 di nuovo le forze, opposte si avvistarono al largo di capo Malea, ma anche per le condizioni sfavorevoli del
tempo non fu ingaggiata la battaglia. Parve che si arrivasse allo scontro il giorno dopo. Le due flotte si schierarono in ordine di
combattimento, ma il vento venne a mancare e anche se il C. fece rimorchiare dalle galere le navi fornite di sole vele, lentamente
l'armata turca senza voltare le poppe si defilò. L'8 un falso allarme, mentre la flotta cristiana si trovava impreparata e dispersa,
dimostrò soltanto che nell'armata la disciplina faceva difetto.
Intanto si prospettava ai comandanti la necessità di congiungersi con le galere di don Giovanni. Essi avevano la consapevolezza di
quanto fosse pericoloso affrontare lo scontro senza i rinforzi spagnoli, che ormai dovevano essere vicini; c'era inoltre la temibile
possibilità che i Turchi volessero impedire il congiungimento delle due flotte o magari assalire le forze di don Giovanni. Decisero così
di andare incontro al principe spagnolo e il 10 agosto tutta l'armata lasciò Cerigo, ma, doppiato capo Matapan, si trovò davanti la
flotta nemica. Dopo che una nave veneziana venuta a trovarsi fra i due schieramenti riuscì a portarsi al riparo, sembrò che potesse
iniziare il combattimento. In un primo momento i colpi di artiglieria disordinarono la flotta turca, ma proprio per approfittare di
questo i combattenti cristiani persero l'allineamento, cosicché alcune galere si trovarono avanzate rispetto alle navi senza remi, mentre
altre rimanevano attardate. Fu un momento critico e se i Turchi avessero sferrato l'attacco il C. avrebbe dovuto ben rimpiangere il suo
desiderio di combattere; ma essi ancora una volta ricusarono la battaglia e si defilarono.
Dopo una sosta a Cerigo il C. il 14 riprese il mare verso Zante; qui ebbe avvisi di don Giovanni, che, arrivato il 10 a Corfù, desiderava
incontrarsi con lui a Cefalonia. Quivi giunto il C. aspettò il principe e lo incontrò dopo vari contrattempi fra quest'isola e Corfù, dove
giunsero insieme il 1° settembre.
Don Giovanni, che aveva aspettato la flotta per venti giorni, senza essere informato a sufficienza di quanto essa stava compiendo, non
poteva che essere furioso nei confronti del suo luogotenente. Quando il C., che non restava di giustificarsi con il papa e con Filippo II,
si incontrò con lui, sostenne di aver agito osservando le disposizioni, ma in realtà egli aveva disobbedito se non alla forma certo alla
sostanza degli ordini e non poteva controbilanciare la disobbedienza con il conseguimento di una vittoria, che avrebbe di forza messo
a tacere le critiche.
Mentre il risentimento reciproco avvelenava i rapporti fra i generali, si ricominciò dalle operazioni preliminari. Ad una prima rivista le
navi veneziane risultarono troppo scarsamente fornite di uomini, ma il Foscarini si rifiutò recisamente di accettare su di esse soldati
spagnoli. Il C. fece allora opera di mediazione, accogliendo gli iberici sulle sue navi e offrendo ai Veneziani 1.600 dei suoi soldati.
Il 7 l'armata finalmente riunita partì da Corfù. A Gomenizza si fece la mostra generale e don Giovanni divise la flotta in tre squadre,
più un'avanguardia e una retroguardia; quella di centro era al comando del generale supremo, che aveva accanto il C. e il Foscarini.
Ripercorsero quindi il cammino inverso, giungendo a Cefalonia il 12 e portandosi poi a Zante. Di qui si diressero di notte a Navarino
con l'intento di sorprendere la squadra turca, che però, mancata la sorpresa, riuscì a rifugiarsi a Modone.
Durante la fuga degli Ottomani al C. fu dato l'incarico, strano in verità per un comandante, di avvicinarsi ai nemici e di individuarne le
intenzioni. Sembrò ad un certo punto che egli dovesse ingaggiare con nove galere turche un impari combattimento, ma, ricevuto il C.
l'aiuto di otto galere, i Turchi si allontanarono. Al sicuro nel porto i nemici, i comandanti formularono varie proposte sulle operazioni
da intraprendere. Il C. propose di assaltare Modone da terra con truppe sbarcate a poca distanza dal porto, ma il suo piano fu giudicato
irrealizzabile e troppo pericoloso per il naviglio e per i soldati.
Il 30 settembre fu iniziato un attacco contro Navarino, ma, mentre le vettovaglie cominciavano a scarseggiare, il 5 ottobre anche
questa impresa dovette essere abbandonata. Anche il C. partecipò alle operazioni di sganciamento e di reimbarco. Due giorni dopo,
nell'anniversario della battaglia di Lepanto fu presa all'unanimità dai tre comandanti la decisione, motivata soprattutto dalla mancanza
di vettovaglie, di abbandonare l'assedio di Modone e l'impresa di Oriente. La campagna si era dunque conclusa in modo
assolutamente negativo e aveva lasciato gli alleati reciprocamente diffidenti e quasi nemici.
Il C. rientrò a Civitavecchia a metà novembre. L'accoglienza del papa al suo ritorno non fu e non poteva essere quella tributatagli da
Pio V l'anno precedente, tuttavia, Gregorio XIII non ebbe bisogno delle giustificazioni del C., avendogli già accordato piena fiducia.
Al C. stava però a cuore che anche il sovrano spagnolo ritenesse legittimo e non pregiudizievole all'impresa il suo modo di procedere.
Alla fine dell'anno si recò quindi in Spagna.
Ufficialmente il C. doveva richiedere al re da parte del papa di aumentare l'apporto spagnolo di galere per la campagna del prossimo
anno e di esortare l'imperatore a scendere in campo con le forze cristiane. L'intento privato era di presentare a voce al sovrano la
relazione del suo operato e la difesa e giustificazione di esso. Recava anche lettere di don Giovanni che avrebbero dovuto dimostrare
il buon accordo fra lui e il principe, senza sapere che quest'ultimo aveva però scritto direttamente al fratello per indicare nel C. il
responsabile dell'esito negativo dell'impresa. Anche Filippo II del resto aveva cercato di evitarsi il peso di una sua visita, giudicata
inopportuna. Tuttavia il C. arrivato a Madrid il 18 genn. 1573, fu onorato e fatto segno di cortesie dal re e dai suoi consiglieri, come
era dovuto al suo rango e alla sua posizione.
Nelle quattro settimane che rimase alla corte il C. ottenne dal re l'impegno di inviare in Levante centodieci galere e l'assicurazione che
egli avrebbe ancora insistito presso l'imperatore per ottenerne l'intervento. Oltre alla formale approvazione della sua condotta, il
sovrano gli espresse il suo compiacimento a che egli continuasse a essere il comandante della flotta pontificia; gli promise poi che,
quando egli fosse stato libero da altri incarichi, sarebbe stato utilizzato in "governi particolarissimi".
Il C. giunse a Roma dopo un viaggio per mare travagliato, che lo costrinse a sbarcare a Savona e a proseguire da lì per terra. Firmato il
rinnovo della lega il 27 febbraio, il C. si era accinto a mettere di nuovo a punto la flotta, quando giunse la notizia della pace separata
di Venezia con i Turchi. Deciso dalla Congregazione della Lega il congedo delle truppe e delle galere, fu così repentinamente
interrotto il periodo dell'attività marinara del Colonna.
Per i successivi quattro anni si hanno del C. poche e frammentarie notizie. Certamente egli, che verosimilmente continuava, secondo
l'appalto concessogli dal 1571 a tutto il 1586, la produzione e la vendita di vetriolo, di cui aveva trovato una miniera nella terra di
Nettuno, alternò il soggiorno a Roma e nei suoi possedimenti nella Campagna romana con quello nel Regno. A Napoli era infatti
nell'autunno del 1573 e nel 1575, dalla primavera. Nell'agosto di quell'anno il viceré lo convocò perché si temeva un attacco turco
sulle coste pugliesi. Alla fine di settembre fu inviato a Brindisi e a Taranto, dove rimase un mese allo scopo dì mettere a punto la
cavalleria spagnola. Alla fine di settembre dell'anno successivo il C. si rimise in viaggio per la Spagna, conducendo con sé i figli,
Fabrizio e Ascanio, il quale ultimo avrebbe lasciato, tornando, in terra iberica.
Il 4 genn. 1577 il C. fu nominato da Filippo II viceré di Sicilia. Era l'incarico di grande rilievo politico a cui aspirava da tanto tempo e
che aveva sollecitato più volte al sovrano. Giunse a Palermo nell'aprile e il 24 fece il suo solenne ingresso nella città, prestando,
secondo la consuetudine, giuramento nella cattedrale.
Il C., cui tre anni dopo, il 19 ag. 1580, la carica venne rinnovata, prese subito l'abitudine di riunire i suoi principali consiglieri per
esaminare gli affari di Stato e di guerra e avrebbe voluto che questa abitudine fosse istituzionalizzata con la creazione di un Consiglio
di Stato.
Una delle opere cui si accinse il C. appena arrivato nell'isola fu quella di emanare provvedimenti atti a debellare la peste, che aveva
imperversato nei due anni precedenti. Con una serie di disposizioni, che si protrassero fino all'estate del 1579, egli riuscì, isolando e
debellando il contagio, a liberare il paese dall'epidemia, che non aveva mancato di causare riflessi negativi sull'economia isolana. Egli
si avvalse anche della collaborazione del protomedico Filippo Ingrassia.
Tra il febbraio 1576 e l'avvento del C. al governo di Sicilia un celebre avventuriero, Scipione di Castro, aveva scritto gli Avvertimenti
a M. A. Colonna quando andò viceré in Sicilia (S.di Castro, La politica come retorica, a cura di R. Zapperi, Roma 1978, pp. 82-140),
composti sicuramente non personalmente per il C., ma per chiunque fosse stato destinato a ricoprire la carica di viceré, in cui l'autore
offriva un quadro della situazione siciliana e i suggerimenti per affrontare i vari problemi.
S. di Castro iniziava il capitolo riguardante il Parlamento del Regno sostenendo che esso aveva "gran forza di travagliare un viceré
poco destro". Il C. convocò due Parlamenti, uno nell'aprile del 1579 e l'altro nel giugno 1582. In ambedue fu stabilito il pagamento del
donativo ordinario di 300.000 fiorini, di altri 100.000 per le "fabbriche" del Regno, di 48.000 per i ponti, di 20.000 per le "fabbriche
delli regii palazzi", di 10.000 per la riparazione e costruzione delle torri di avvistamento. In ambedue le assemblee i tre "bracci"
chiesero al re - senza ottenerlo - che con i denari da loro sborsati per trecento cavalli leggeri si mantenessero invece sei galere. Oltre
all'ordinario stanziamento di 5.000 fiorini per il viceré, al C. furono offerti 25.000 scudi nel primo e 35.000 fiorini nel secondo
Parlamento, che egli, secondo la consuetudine, rifiutò in entrambi i casi; l'offerta dimostra però come gli umori del Regno non gli
fossero contrari, anche nel secondo Parlamento, quando stava per arrivare nell'isola il sindacatore del re. Durante il primo Parlamento,
all'apertura del quale il C. aveva espresso il suo proposito di procurare e mantenere nel Regno la pace, nelle città e nelle campagne, la
giustizia "universale, recta et discreta" e l'abbondanza, egli accettò la cittadinanza siciliana.
Il Tribunale del Patrimonio, che si occupava della parte finanziaria dell'amministrazione era stato definito da Scipione di Castro
"noioso" per il viceré, ma il C. sembrò considerarlo alla stregua degli altri suoi doveri. Arduo tuttavia, poiché esso appariva al C. nel
1580 in uno stato caotico. Egli si accinse allora alla sua riorganizzazione. Fu aumentato il personale e i suoi emolumenti; si stabilì una
graduatoria precisa per le promozioni. Questo nuovo sistema, che pure non durò che pochi anni, sembrò dare risultati eccellenti dal
punto di vista organizzativo; rimanevano però invariati gli atteggiamenti di fondo del personale, che ai gradi più alti si disinteressava
dei propri doveri e a quelli più bassi arrivava addirittura a una sorta di boicottaggio. Con il decreto del 7 marzo 1584 il C. creò la
carica di consultore e protettore del R. Patrimonio.
Sosteneva Scipione di Castro: "Bisogna… che il viceré sempre intervenga… a tutte le cause…", e più oltre: "L'altro membro di
giustizia consiste in l'audienza così publica come privata che dà il viceré …". Il C. fissò questi doveri del viceré in una prammatica, la
prima delle Constitutioni prammaticali del Regno di Sicilia fatte sotto… M. A. Colonna (Palermo 1583): "del tempo di negotiare co'l
viceré", che indicò a esempio agli ufficiali, in modo che "ogn'uno sia sempre vigilante et sollecito nell'amministratione dell'ufficio
suo, udendo con patienza et facilità i negotianti, maturando con prudenza i negotii et essequendo con celerità le risoluzioni …". In
essa per tutti e sette i giorni della settimana era previsto l'abboccamento del viceré con tutti i rappresentanti delle istituzioni del
Regno; inoltre erano fissate udienze pubbliche e private; solo il giovedì pomeriggio era riservato alla redazione dei dispacci. Un
programma simile illustra l'impegno massimo che il C. intendeva mettere nell'assolvere al suo compito. C'è però da osservare che la
serenità che il C. si riprometteva di avere nel compiere il suo ufficio pare che in pratica gli venisse meno, se c'era l'uso di informarsi
del suo timore prima di chiedergli udienza e di rinunciarvi se egli sembrava maldisposto.
Scipione di Castro metteva in guardia il viceré dalle "artificiose malignità degli ufficiali", che erano soliti operare "artifici nocivi
molto alla riputazione del viceré". Anche il C. aveva ben presente il problema, se scrivendo al re nel 1579 sosteneva che era
necessaria una grande cura per non essere ingannati da loro. A questo proposito egli emanò nel 1582 insieme con il Senato di Palermo
una serie di ordini che definivano i doveri degli ufficiali municipali, determinandone minutamente le responsabilità. Dell'agosto
dell'anno seguente, autorizzata dal re nel 1581 e 1582, è la prammatica "del sindicato d'ufficiali" (Costituzioni…, cit., pp. 175-82).
Con essa si effettuava una riforma di grosso rilievo: dividendo l'isola in ventiquattro circondari, si cercava di sottoporre a un controllo
tutto il personale dell'ordine giudiziario, dai giudici della Gran Corte e della Sacra Coscienza agli ufficiali annuali e temporanei.
Exnovo il C. creò la carica di capitano degli algozini.
Il consiglio di Scipione di Castro a proposito degli inquisitori era stato quello di non entrare in contrasto con loro, ma di prospettare
eventuali screzi alla corte di Madrid, perché fossero ivi risolti e per il resto di "aiutarli e favorirli" sempre. L'operato del C. fu
diametralmente opposto a questi suggerimenti. Del resto all'inizio del suo mandato egli trovava la situazione già compromessa da
almeno quattro anni di contrasti fra il tribunale del S. Uffizio e la Gran Corte, attentando quest'ultima alla giurisdizione di quello sul
grande e mutevole numero dei suoi ufficiali e famigliari. Così già nell'estate del 1577 partiva verso il Gran Consiglio dell'Inquisizione
la prima denuncia, dell'inquisitore Bernardo Guasco, contro il viceré. Questi contrattaccò denunciando l'uso di alcuni giudici
inquisitoriali di esporre i propri emblemi nella sala delle udienze, che in effetti furono fatti togliere dal Gran Consiglio.
I due inquisitori succeduti al Guasco, Diego Haedo e Juan de Rojas, l'8 genn. 1578 spedivano al grande inquisitore, cardinal Quiroga,
una protesta, in cui si denunciava l'atteggiamento ostile del C. nei confronti del tribunale del S. Uffizio, che tendeva a sottoporre a
questo soltanto le cause di fede e di religione. L'Haedo, che non intendeva sottostare a una tale limitazione, finì per inviare il 1° marzo
1580 allo stesso sovrano un'ampia denuncia contro il viceré. Vi si narrava che il C., il quale aveva perseguitato dall'inizio del suo
incarico gli addetti al S. Uffizio e che era parziale a favore dei giudici della Gran Corte, tanto da aver dichiarato di preferire la
presenza di duecento eretici in Sicilia alla scomunica di questi, aveva accusato gli inquisitori di "mentire come tanti villani" quando
sostenevano che l'istituzione da essi rappresentata non poteva esercitare i propri diritti. Egli aveva sostenuto inoltre di aver fede non
nell'Inquisizione per mantenere la Sicilia fedele al sovrano, ma nei suoi soldati; facesse attenzione il re, continuava l'Haedo, poiché
costui, che governava troppo risolutamente, sembrava aver l'intenzione di impadronirsi del Regno.
Il sovrano nominò allora una giunta che avrebbe dovuto dirimere le controversie sorte in Sicilia fra il potere civile e quello
inquisitoriale. La "concordia", emanata dalla commissione il 4 luglio 1580, conferì una completa vittoria all'Inquisizione, che vide
accolte le sue richieste e giustificate le sue proteste. Non si deve credere tuttavia che questo eliminasse tutti gli attriti, tanto è vero che
il 2 ag. 1581 l'Haedo inviò a Madrid una nuova denuncia contro il viceré. Il contrasto del C. con l'Inquisizione fu dunque insuperabile,
né poteva essere altrimenti, vista la sua avversione verso il S. Uffizio, di cui pare che egli auspicasse la cessazione dell'attività
nell'isola.
Come si è già accennato, uno dei mezzi che il C. usò contro l'Inquisizione fu il tribunale della Gran Corte, che considerò lo strumento
per prevalere su quella e anche per affermare il proprio prestigio. Un altro fu il rafforzamento, perseguito del resto anche da Filippo II,
dell'istituto della Legazia. Nel giugno del 1579 l'ufficio del giudice della Monarchia divenne stabile e verso la fine del 1581, dopo il
fallimento dell'opera del delegato spagnolo a Roma presso Gregorio XIII, il re ordinò che esso dovesse essere affidato a un
ecclesiastico. Il C., insieme con l'arcivescovo di Palermo e con Niccolò Stizzia, compilò le istruzioni in sei punti per questo giudice.
Inoltre nel 1583 il C. emanò ventitré ordini, che naturalmente non trovarono il favore di Roma (editi in A. Forno, Storia della
apostolica Legazione…, a cura di G. M. Mira, Palermo 1869, pp. 282-285).
Nel complesso il C. lavorò intensamente nei sette anni in cui ricoprì la carica di Viceré, senza fermarsi davanti ad alcuna difficoltà
dando l'impressione però di sottovalutare i problemi locali, che ostacolavano la realizzazione di ogni iniziativa di governo, pur se
razionale e sensata. Tuttavia la sua condotta non fu immune da colpe: prevaricazioni, come sembra provare la sua esclusione dal
processo di appello di Juan Osorio, generale delle galere; leggerezze, come l'aver riposto eccessiva fiducia nel suo segretario Pietro
Cisneros, poi processato e condannato per falsi ed estorsioni; irregolarità, in cui fu sostenuto da Luca Cifuentes, presidente della Gran
Corte, e da Francesco Rao, avvocato fiscale. Comunque sembra di poter affermare che la sua lealtà nei confronti del sovrano fu
assoluta. Egli vedeva l'amministrazione di una provincia del dominio spagnolo, come quella di un membro di un unico corpo e
avrebbe voluto essere più libero nel compiere i suoi doveri verso il sovrano, senza dover sottostare al giudizio dei membri della corte
del Patrimonio ogni volta che egli inviava denari a Madrid. Per il governo di quella parte di un tutto unico, che era la Sicilia, egli si
prodigò, come ebbe a scrivere nel dicembre del 1581, sostenendo di aver contenuto le spese ordinarie e straordinarie, supplito alle
richieste di Madrid, liberato dai debiti la corte di Palermo. Al notevole bisogno di denaro il C. fece fronte dando un inusitato
incremento alla pratica di vendita del diritto di mero e misto imperio ai nobili e degli uffici, eccettuati quelli militari e giudiziari, ai
privati.
Sotto il suo viceregno fu proseguita la costruzione in Palermo della strada del Cassero, che fu conclusa da una porta, di cui il C. pose
la prima pietra nel 1580, chiamata Felice dal nome di sua moglie. Nella stessa città fece restaurare porta Nuova ed edificare la Vicaria,
destinata a Dogana, presso la chiesa di Porto Salvo. Nella cattedrale adornò e restaurò quattro cappelle, da gran tempo diroccate. A
Messina fece costruire una strada fra il mare e le mura.
Del 1582 è un viaggio del C. a Malta, contro cui si temeva allora un attacco dei corsari turchi. Egli si recò nell'isola scortato da cinque
galere siciliane e due di Malta e qui, onorato dal gran maestro Ugo de Verdala, fu prodigo di consigli e di aiuti, ritornando in Sicilia a
metà ottobre.
Uno dei suggerimenti indirizzati da Scipione di Castro al viceré di Sicilia era quello di costituirsi fama di "vigorosi". L'intento del C.
di mostrarsi solerte amministratore della giustizia, senza riguardo per la posizione sociale dei colpiti, travalicò molto il prudente
consiglio. Non bastò certo ad attenuare questo rigore che egli concedesse che ogni pomeriggio di festa fossero ammessi a visitarlo i
gentiluomini che lo desideravano o che egli facesse vita mondana dando pranzi e promuovendo recite. Nello stesso 1577 egli mostrò
di non voler continuare la politica in favore dei nobili dei suoi predecessori, facendo arrestare il marchese de La Favara, che aveva
fino ad allora agito senza temere di nessuno. Il suo modo reciso di procedere offendeva o danneggiava personaggi altolocati, fra cui
egli si faceva nemici. Così in breve si inimicò con Diego Enriquez, nobile iberico-siciliano; così si alienò Geronimo de Cordova e il
duca di Sessa, il duca di Medina di Riosecco, i quali andarono a costituire e ad alimentare un partito anti-Colonna, già formatosi in
Spagna alla sua nomina. Un altro nemico potente si procurava nel 1579 nel duca di Terranova, accusandone la sorella di veneficio nei
confronti del marito. Anche con i suoi ministri iberici, il conservatore Estevan de Monreal e il consultore Toboada, il viceré ebbe
relazioni pessime, che gli impedirono di instaurare con loro un rapporto di proficua collaborazione.
Un atteggiamento duro, che gli procurò altre inimicizie, fu quello avuto dal C. nel suo tentativo di reprimere il banditismo, che aveva
potenti connivenze. Specie durante il primo periodo del suo viceregno si eseguirono parecchie condanne capitali, che egli si rifiutò di
mitigare. Riuscì ad assicurare alla giustizia anche due banditi famosi, Girolamo Colloca, che fece giustiziare, e Rizzo di Saponara, che
però fu avvelenato prima che potesse essere giudicato.
Benché fosse tuttaltro che inusitato rivolgere a Madrid lagnanze e proteste contro il viceré in carica, tuttavia i memoranda contro il C.
e le contestazioni a corte, benché egli tenesse lì un suo agente fisso che ne curava gli interessi, giunsero a causare la somministrazione
di quella "buona medicina" (S. di Castro, La politica…, cit., p. 135) che era la sindacazione. Nell'ottobre 1582 arrivava infatti a
Palermo il visitatore Gregorio Bravo de Sotomayor. Secondo il di Castro l'opera di costui non portava il viceré se non o "a partir con
danno o a restar con vergogna", tuttavia il C. da principio offrì la sua collaborazione al Bravo, ma questa non fu accettata. In effetti
l'opera di quest'ultimo, anche se ufficialmente volta al controllo degli ufficiali del Regno, era nelle sue intenzioni diretta contro il
viceré, di cui egli non mancò di mettere in luce le responsabilità. Certo nelle eccessive elargizioni e nelle connivenze in vere e proprie
irregolarità amministrative e giudiziarie in cui risultò coinvolto il C. deve vedersi il bisogno che questi aveva di crearsi una rete di
aderenti per fronteggiare il notevole numero di nemici che si era creato. Quando venne citato davanti alla corte del visitatore Pompeo
Colonna, che era stato una sorta di vicario del viceré ed era allora straticò di Messina, gli avversari del C. esultarono. Si vennero così
a formare in Sicilia due partiti, uno a favore del C. e l'altro contro di lui, stretto attorno al visitatore. Queste due fazioni portarono
all'esaltazione le passioni che le animavano, prendendo posizione in modo opposto, nella vicenda che portò al richiamo del C. in
Spagna.
Eufrosina Zaragossa era la ricca moglie di Galcerano Corbera, figlio del barone di Miserendino, uomo stravagante e pieno di debiti.
Questi ultimi due, con la complicità di un parente, Ottavio Bonetta, si resero colpevoli dell'uccisione di un paggio, accusato di aver
avuto una relazione con la donna. Il delitto, non provato, fu archiviato e il barone di Miserendino, oberato di debiti, che la nuora non
volle pagare, fu inviato dal C. a Sciacca come capitano delle armi. Galcerano Corbera si imbarcò invece su una galera.
L'interessamento del C. per la famiglia, la solitudine della sposa, la fama di uomo licenzioso del viceré, che fu illustrata in un
memorandum inviato dal Monreal a Madrid, fecero sì che si cominciasse a mormorare dell'esistenza di una tresca fra i due. A questo
punto il barone di Miserendino tornò a Palermo e, escluso dalla giurisdizione dell'Inquisizione, con una leggerezza che l'Haedo si
rimproverò, fu arrestato per debiti. Questo il pretesto ufficiale, che poggiava certo su basi reali, ma l'Haedo nella già citata denuncia
del 12 ag. 1581 riferiva chiaramente che questo era avvenuto per "fine particolare". Pare inoltre che il viceré si opponesse a un
accomodamento fra i creditori e il barone, che morì in carcere entro pochi mesi. Il marito della baronessa, che non pareva sospettare di
lei, sempre nel 1581, quando Pompeo Colonna fu inviato dal viceré con tre galere a Malta, ove era in atto una rivolta dei cavalieri
contro il gran maestro, accettò l'invito ad accompagnarlo, ma qui il suo corpo crivellato di pugnalate fu trovato senza vita in una via
della Valletta. Sul C. cadde il sospetto di essere il mandante di questo assassinio. Ottavio Bonetta, che come si è visto già una volta
aveva intrigato a proposito di Eufrosina, cominciò ad avanzare rivendicazioni per ottenere giustizia per la morte dei congiunti o forse
per impadronirsi delle ricchezze della baronessa. Per prima cosa il Bonetta riuscì a togliere alla donna la custodia di un ragazzo,
fratello di Galcerano; ma ella ottenne di riaverlo con sé per l'intervento del Colonna. Nel settembre del 1582, poco prima dell'arrivo
del visitatore, il Bonetta fuggì da Palermo verso la Spagna, sostenendo di essere perseguitato dal viceré.
Quest'ultimo non si chiuse in sdegnoso silenzio, ma replicò a queste accuse con dignità e abilità; si appellò alla differente statura
morale fra lui e un uomo come il Bonetta, già condannato alle galere; difese l'onorabilità della dama accusata, sostenendo che ella era
al di sopra di ogni sospetto. Storicamente non fu provato, né è probabile che possa mai esserlo, anche se molto verosimile, che il C. e
la donna fossero amanti, né tanto meno che il Corbera fosse stato fatto eliminare dal viceré. Tuttavia, anche se l'azione del Bonetta
non sfociò in una vera e propria inchiesta contro il C., il considerevole numero di persone che presero posizione contro di lui, anche se
non mancò chi lo sosteneva, impressionò la corte, fino a causarne il richiamo.
Il 20 marzo 1584 il C. fu richiamato dal sovrano, i cui propositi nei suoi riguardi erano e sono rimasti ignoti a tutti. Alcuni giunsero a
pensare che il re divisasse di utilizzare il C. nella sua armata, altri invece che Filippo II volesse chiedere conto al C. della
corrispondenza avuta con Aluch 'Ali, capitano generale dell'armata turca, nel 1580, corrispondenza che però non gli era ignota e dalla
quale la lealtà del C. non era toccata. In ogni caso ufficialmente la partenza del C. dall'isola avvenne con gli onori dovuti al suo rango.
Lasciato come presidente del Regno il conte di Briatico, il C. iniziò il viaggio da Palermo il 1° maggio; si fermò a Messina fino al 16
e il giorno 25 era a Napoli, ove fu accolto con grandi manifestazioni di deferenza. Il 2 giugno era a Terracina. Dopo soste a Cisterna,
presso i Caetani, a Paliano, a Zagarolo e a Marino, arrivò il 6 a Roma. Gli andò incontro a quattro miglia dalla città l'ambasciatore
spagnolo con altre personalità. Nell'Urbe si fermò una settimana. Fu ricevuto naturalmente dal papa e, alloggiando nel palazzo
dell'oratore spagnolo, fu visitato da moltissimi gentiluomini, ma non mancò chi giudicò il suo modo di comportarsi piuttosto da
"spagnolo affettato che da cavaliere italianato" (Rossi, Le statue, p. 23) e chi lo giudicò altero e sdegnoso nel momento della fortuna,
"ma che nell'avversa fin dagli occhi se gli scorge la tenerezza della sua paura" (ibid., p. 24).
Accompagnato da cardinali ed estimatori fino a Galeria, dove gli fu offerto un rinfresco, il C. si rimise in viaggio il giorno 13,
fermandosi a Bracciano, presso il cognato, dieci giorni. Si imbarcò a Civitavecchia il 23 giugno. Lo scortavano dieci galere siciliane,
due di Napoli, cinque di Firenze e tre di Malta. Dopo una sosta a Genova arrivò a Barcellona l'8 luglio. Ricevute le debite onoranze si
avviò verso Madrid; ma il 1° agosto morì a Medinaceli, dopo essere stato ammalato una settimana (Bibl. Apost. Vaticana, Vat. lat.
7031, cc. 292r-293v: Relazione anonima sulla malattia e morte di M. A. Colonna). Fu sepolto a Paliano, nella chiesa di S. Andrea,
secondo quanto aveva disposto nel suo testamento.
La fulmineità della morte, epilogo di un dramma già fosco, il mistero delle intenzioni del re, la possibilità di eventuali mosse di difesa
del C., la sicura inimicizia di molti, la sempre sostenuta inimicizia del Granvelle alimentarono il sospetto, non provato e poco
plausibile, che il C. fosse stato vittima di un avvelenamento.
Nel testamento, datato 1569, egli aveva istituito erede universale il figlio primogenito Fabrizio, che, nato il 20 ott. 1557, era però
morto nel 1580. Altri beni andavano al figlio Federico, che era morto nello stesso 1569. All'unico figlio maschio che gli sopravvisse,
Ascanio, ecclesiastico, destinò Marino e Rocca di Papa, oltre al palazzo detto della Torre ai SS. Apostoli. Il C. aveva avuto inoltre tre
figlie femmine: Vittoria, Giovanna e Costanza.
Roma, presto dimentica, non dedicò al C. neanche un ufficio funebre e solo il 25 sett. 1595 fu inaugurata in Campidoglio una sua
statua bronzea, di modesta fattura e, pare, realizzata a spese della famiglia.
Di ben altra importanza sono i tre ritratti pervenutici, che del C. dipinse Scipione Pulzone. Di essi uno, conservato nella Galleria
Colonna, è una piccola tela dipinta in epoca imprecisata, che lo raffigura a mezzo busto. Un altro è una grande tela, conservata in
palazzo Colonna a Roma, che lo ritrae a figura intera, avvolto in un manto con accanto le insegne del comando. Il terzo (anch'esso
nella Galleria Colonna), che raffigura il C. in piedi, vestito di mezza armatura, è una perfetta testimonianza del genere del "ritratto di
Stato" della seconda metà del Cinquecento, in cui il pittore, pur non tralasciando le caratteristiche somatiche e la minuzia dei
particolari, mette in evidenza lo stato sociale del personaggio. Compiuto in poche ore durante il soggiorno del C. a Bracciano nel suo
ultimo viaggio verso la Spagna, esso non è una delle opere più felici del ritrattista aulico Gaetano, ma risponde perfettamente allo
scopo che il committente si prefiggeva. Con esso - e ne ordinò più copie in quell'occasione - il C. non voleva infatti consegnare ai
posteri le sue fattezze, ma piuttosto voleva che rimanesse testimonianza dei riconoscimenti ottenuti con la sua fedeltà al sovrano
spagnolo e ai papi e soprattutto della sua gloria militare.
Fonti e Bibl.: Roma, Arch. Colonna: materiale vario sul C.: II C D 1, 1 ss.; copialettere delle missive inviate a Filippo II durante il
viceregno: II CE, 1-3; ivi anche regesti Tomassetti su schede; Arch. Di Stato di Roma, Tribunale del Governatore, Processi sec XVI,
nn. 24 e 30; Bibl. Ap. Vaticana, lettere sue o a lui dirette di scarso interesse in Vat. lat. 6183, Vat. lat. 6194, Vat. lat. 6195, Vat. lat.
12.282, Vat. lat. 13.453, Urb. lat. 818; inoltre Urb. lat. 814: Informazione delle cose dell'armata dell'anno 1572, I, cc. 330-343v; Urb.
lat. 873: Manifesto di M. A. Colonna in giustific. per sua Maestà, cc. 356-361; Urb. lat. 870: Negoz. della conclusione della lega… in
Venezia, cc. 347-360; Barb. lat. 5370: Discorso del S. Officio di Sicilia, cc.60-69; Arch. Segr. Vaticano, Schedario Garampi,
Miscellanea, s. v.; P. Nores, Storia della guerra di Paolo IV S. P. contro gli Spagnuoli, in Arch. stor. ital., s. 1, XII (1847), pp. 21 s., 44
s., 67 s., 81, 110, 128, 133, 139, 146, 168, 196-212, 215, 229, 232, 253, 281; R. Ancel, Nonciatures de France. Nonciatures de Paul
IV, Paris 1911, ad Indicem;Correspondencia diplomatica entre España y la Santa Sede, a cura di L. Serrano, I-IV, Madrid 1914, ad
Indicem; Nunziature di Napoli, a cura di P. Villani, I, Roma 1962, ad Indicem; La corrispondenza da Madrid dell'ambasciatore
Leonardo Donà, a cura di M. Brunetti - E.Vitale, Venezia-Roma 1963, pp. XXIX ss., XXXIII s., XL, s., XLIII, XLVIII, 64, 66 s.,
147-152, 157, 217, 284, 378, 566, 629, 631, ss., 636, 642, 645, 650-653, 655 s., 800 s.; L'archivio dei Visitatori generali di Sicilia, a
cura di P. Burgarella - G. Fallico, Roma 1977, ad Indicem; A. Mongitore, Parlamenti generali del Regno di Sicilia, I, Palermo 1749,
pp. 383-393; G. E. Blasi e Gambacorta, Storia cronol. de' viceré… di Sicilia, II, 1, Palermo 1790, pp. 289-322; A. Coppi, Mem.
colonnesi, Roma 1855, pp. 311, 318 ss., 322-329, 339-354; A. Guglielmotti, M. C. allabattaglia di Lepanto, Firenze 1862; A. Forno,
Storia della apostolica Legazione…, a cura di G. M. Mira, Palermo 1869, pp. 44 s.; S. Cocchiera, L'entrata di M. A. C. in Palermo…,
Palermo 1870; A. Bertolotti, La prigionia di Ascanio Colonna, in Atti e mem. della R. Deputaz. di storia patria perle prov. moden. e
parmensi, s. 3, II (1884), pp. 109, 111 s., 120 s., 130, 133 ss., 139, 144, 147 ss., 153 s., 156 s., 163, 166 s., 171-174, 179 s.; I. Ciampi,
M. A. C., in Opuscoli vari, storici ecritici, e cura di P. E. Castagnola, Imola 1887, pp. 309-317; J. P. E. Julienne de La Gravière, La
guerre de Chypre et la bataille de Lépante, I, Paris 1888, pp. 113-148; II, ibid. 1888, pp. 3-9, 25 s., 31-36, 83, 126, 158, 174-177, 186,
244, 246; L. Vicchi, M. C. il vincitore di Lepanto…, Faenza 1890; C. Manfroni, La lega cristiana del1572, in Archivio della R.
Società romana distoria patria, XVI (1893), pp. 347-445; XVII (1894), pp. 23-67; P. Fedele, Lo stendardo diM. A. C. a Lepanto,
Perugia 1903; G. Tomassetti, Della Campagna romana, in Archivio d. R. Società romana di storia patria, XXIX (1906), pp. 333-338;
M. Crocicchiolo, Sul viceregno diM. A. C. in Sicilia, in Archivio storico sicil., XXXVII (1912), pp. 89-120; L. Serrano, La ligade
Lepanto, I-II Madrid 1918-19, ad Indices; C. A. Garufi, Contrib. Alla storia dell'Inquisizionein Sicilia…, Palermo 1920, pp. 261-324;
G. Navone, Paliano, in Arch. d. r. Soc. rom. di storiapatria, XLIII (1920), pp. 364, 372 s., 375 s.; P. Colonna, I Colonna…, Roma
1927, pp. 193-254; E. Rossi, Le statue di A. Farnese e di M. C. in Campidoglio, in Arch. d. R. Soc. rom. di storiapatria, LI (1928), pp.
19-32; F. Tomassetti, Il pittore Scipione Pulzone, in Roma, VI (1928), pp. 537-44; G. A. Quarti, La battaglia di Lepanto nei canti
popolari dell'epoca, Milano 1930, passim; G. B. Borino-A. Galietti-G. Navone, Il trionfo di M. A. C., Roma 1938; G. Barbieri,
Industria e polit. mineraria…, Roma 1940, adIndicem; T. Gasparrini Leporace, Aneddoti suM. A. C., in Atti del V Congresso naz. di
studiromani, III, Roma 1942, pp. 232-239; H. G. Koenigsberger, The Government of Sicily underPhilip II of Spain, London-New
York 1951, adIndicem; L. v. Pastor, Storia dei papi, VI-IX, Roma 1955-1963, ad Indices; F. Zeri, La Galleria Colonna a Roma, in
Tesori d'arte delle grandi famiglie, Verona 1966, pp. 24, 28, 37, 40; V. Cantagalli, La guerra di Siena…, Siena 1962, pp. 303, 330,
483, 485; U. Tucci, Il processo a G. Zane, in Il Mediterraneo nella seconda metà del '500…, Firenze 1974, pp. 413, 416, 419, 421,
423-427, 429 s.; F. Braudel, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II, Torino 1976, adIndicem; P. Litta, Le fam. celebri
ital., s. v. Colonna, tav. IX
Marcantonio Colonna
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Marcantonio Colonna (Lanuvio, 1535 – Medinaceli, 1º agosto 1584) è stato un ammiraglio italiano e viceré di Sicilia. Nacque a
Lanuvio (cittadina chiamata in quel tempo Civita Lavinia) da Ascanio Colonna, secondo duca di Paliano e conte di Tagliacozzo
(fratello della poetessa Vittoria Colonna) e da Giovanna d'Aragona, nipote del re Ferdinando I di Napoli; venne insignito del
cavalierato dell'Ordine del Toson d'Oro. In occasione della guerra di Siena (1553-1554) venne nominato comandante della cavalleria
spagnola e capitano generale dell'esercito. Nel 1570 venne nominato capitano generale della flotta pontificia da papa Pio V, mentre
l'anno successivo Don Juan d'Austria lo nominò Capitano generale della flotta alleata nella guerra contro i musulmani. Per togliergli il
Ducato di Paliano papa Paolo IV scatena una guerra al re di Spagna, re anche di Napoli, che si conclude con il trattato di Cave, alla
morte di Paolo IV Marcantonio Colonna rientra in possesso dei suoi feudi, tranne Paliano, che recupererà solo sotto Pio V. Durante la
battaglia di Lepanto, il 7 ottobre 1571, la nave ammiraglia di Colonna e la reale di Giovanni d'Austria catturarono l'ammiraglia della
flotta turca. Al suo ritorno a Roma, papa Gregorio XIII lo riconfermò capitano generale della flotta pontificia e cercò di proseguire la
guerra in Terra Santa sull'onda della vittoria di Lepanto. Questa intenzione fallì dopo la firma della pace tra Venezia e i Turchi (1573),
quando la Lega cristiana si sciolse. Soggiornò a lungo ad Avezzano dove era molto amato. Qui nel 1575 innalzò di un piano il castello
precedentemente edificato dagli Orsini, fece realizzare una loggia che si affacciava sul lago Fucino, trasformò il parco retrostante in
giardino all'italiana e fece realizzare un nuovo portale accanto a quello ogivale Orsini con iscrizione sovrastante a ricordo della
vittoria a Lepanto. Marcantonio Colonna fu anche signore di Marino. La battaglia di Lepanto fu di enorme importanza per la
popolazione marinese, tanto che a Marino viene ancora ricordata all'interno della Sagra dell'Uva, la festa profana che nell'ultimo
secolo si è andata a sovrapporre alla festa religiosa, istituita da papa Pio V a seguito della vittoria riportata contro i Turchi, in onore
della Madonna del Rosario, sotto la cui protezione era stata posta la spedizione navale. La Sagra dell'Uva, non a caso, si tiene ogni
anno a Marino proprio la prima domenica di ottobre. Nel 1577 Filippo II di Spagna lo nominò viceré di Sicilia. Nel 1584 fu
richiamato in Spagna, dove trovò la morte. La figlia Vittoria Colonna, Duchessa di Medinaceli, sposa nel 1587 Ludovico III Enriquez
de Cabrera, nominato Conte di Modica nel 1596. Morto nel 1600 il marito, Vittoria Colonna diviene Contessa di Modica in nome e
per conto del figlio minorenne Juan Alfonso Enriquez de Cabrera, destinato a diventare, con la maggiore età, dal 1617 Conte di
Modica, per poi assurgere alla carica, nel 1641, di viceré di Sicilia (lo stesso incarico posseduto dal nonno Marcantonio Colonna) fino
al 1644, quando fu nominato viceré del Regno di Napoli, fino al febbraio del 1646.
Voci correlate Famiglia Colonna Eufrosia Siracusa Valdaura Tor Caldara
Correlazioni Camillo Camilliani Tiburzio Spannocchi
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene file multimediali su Marcantonio Colonna
Francesco Maria I Della Rovere,
duca di Urbino
(1490 - 1538)
Dizionario Biografico degli Italiani
di GG. Benzoni
Portrait of Francesco Maria I della Rovere by Titian.
FRANCESCO MARIA IDella Rovere, duca di Urbino. - Figlio del prefetto di Roma Giovanni, duca di Sora e di Giovanna, figlia di
Federico da Montefeltro duca di Urbino, nasce a Senigallia - di cui il padre, dal 1474, è signore - il 25 marzo 1490 e quivi trascorre
l'infanzia divenendo, per la scomparsa, ancor piccoli, di due suoi fratelli, unico erede maschio. Morto, il 6 nov. 1501, il padre e
reggendo Senigallia, assistita da Andrea Doria, uno dei tutori di F., la madre, il fanciullo passa alla corte urbinate presso lo zio
materno il duca Guidubaldo che lo fa istruire da Ludovico Odasio, già suo maestro. Ingannevole tranello la nomina papale, del 24 apr.
1502, di F. a prefetto di Roma. Così Alessandro VI s'ingrazia Guidubaldo per renderlo meno vigile nei confronti degli appetiti del
figlio Cesare Borgia, il quale, il 22 giugno, piomba proditoriamente su Urbino, mentre F., fuggito nottetempo il 21, riesce, collo zio, a
scampare alla cattura. Una fuga affannata, coll'incubo di cadere in mano agli uomini del Borgia, sguinzagliati travestiti da pastori e
camuffati da cacciatori, girovagante per viottoli poco praticati, per zone impervie al fine felicemente conclusa ché, affidato dallo zio a
due fidi servitori, con questi F. raggiunge Valdibagno, di qui riparando a Savona presso lo zio paterno, il futuro Giulio II. Ma, con la
morte d'Alessandro VI, l'elezione di Giulio II, lo sfascio del dominio del Borgia e il conseguente reinsediamento di Guidubaldo ad
Urbino e della madre - anch'essa costretta alla fuga - a Senigallia, la situazione si capovolge a favore di Francesco Maria. Richiamato
dalla Francia - dov'è, nel frattempo riparato, quivi stringendo amicizia con Gastone di Foix e riconfermato da Luigi XII nella dignità,
già paterna, di duca di Sora - dal pontefice, questi punta anche su di lui per affermare ed estendere il ruolo della famiglia. Di qui
l'impegno nuziale con Eleonora Gonzaga, primogenita del marchese di Mantova, e, soprattutto, l'adozione - celebrata solennemente il
18 sett. 1504 - da parte di Guidubaldo, notoriamente impotente e senza figli, che innalza F. al rango d'erede. Vigoroso innesco
roverasco nello splendore della corte urbinate, il ragazzo ha di che sentirsi orgoglioso. E, quasi titolare dell'onore della famiglia,
ritenendo disdicevole la relazione della sorella Maria, vedova di Venanzio da Varano, col veronese Giovanni Andrea Bravo, un
favorito dello zio, spalleggiato da scherani uccide questo con le proprie mani; e viene pure assassinato un credenziere della sorella reo
d'aver favorito gli incontri tra i due. Un "dispiacevol caso"; così, in una lettera del 12 nov. 1507 di B. Castiglione, il quale,
successivamente, in una lettera del giorno 21, lo dà, comunque, per rientrato. "La novità… passata cum qualche disturbo" evidentemente ha suscitato clamore; il comportamento di F. non dev'esser stato approvato dallo zio - è, ormai, un incidente superato.
"Le cose sono acquetate" sicché "el signor prefetto" di Roma - questo il titolo di F. pel momento - "è qui", a Urbino, "senza altra
memoria de fastidio alcuno". Vuol dire che si è deciso di soprassedere, di dimenticare e di far dimenticare. Il fatto che si stenda un
velo di silenzio sull'assassinio dell'amante della sorella e del domestico, la stessa reticenza con cui Castiglione accenna all'episodio
sono, quanto meno, indicativi di un certo qual imbarazzo. L'assassinio è stato organizzato a freddo, con un tranello. Più che detergere
l'onore dei Della Rovere F. l'ha ulteriormente macchiato col delitto. Tant'è che la storiografia locale - con F. panegiristica - preferisce
ignorarlo.
Intanto il duca, ammalatosi, nel gennaio del 1508 si trasferisce a Fossombrone nella speranza che il clima più mite gli giovi; qui
muore, assistito anche da F., l'11 aprile. Solenni, il 2 maggio, le esequie a Urbino e concomitanti col subentro nel Ducato - ingrossato
questo dall'incorporazione di Senigallia che F. arricchirà d'ulteriori fortificazioni e d'un grandioso acquedotto - di F., ribadito, a ogni
buon conto, come successore nel testamento - cui si dà pubblica lettura - del 28 sett. 1507. Incontrata per la prima volta la sposa risale ancora al 2 marzo 1505 il matrimonio per procura a Roma - a Mantova il 25 ag. 1508 e, differite le effettive nozze, il 29
settembre, a Bologna, riceve dal legato Francesco Alidosi il bastone di generale della Chiesa.
A capo di 8000 fanti e 1600 cavalli F., nell'aprile del 1509, partecipa all'offensiva antiveneziana dei collegati di Cambrai: a lui arresasi
Civitella, anziché procedere all'espugnazione di Faenza - e ciò perché non adeguatamente sostenuto da Alidosi, col quale i rapporti
sono subito pessimi - s'accontenta di quella di Governolo, passando poi all'assedio di Russi che cede dopo la disfatta veneziana
d'Agnadello, del 14 maggio. Ma - ora che non c'è più da combattere, ora che c'è il recupero delle terre di Romagna e di Ravenna - si fa
aspro e palese il contrasto tra F. e Alidosi: il primo s'oppone all'arresto del veneziano Gian Giacomo Caroldo e disapprova, al
contrario del secondo, la smania di bottino delle truppe. Sciolto, comunque, l'esercito, F. torna ad Urbino, quivi raggiunto da
Eleonora, il matrimonio colla quale viene consumato - giusta l'informazione subito trasmessa alla suocera Isabella d'Este - il 25
dicembre. Dopodiché, attorno al 7 genn. 1510, la coppia si porta a Roma dove il papa desidera che le nozze vengano solennemente
riconfermate. Quindi, nell'agosto, F. riprende a combattere, come vuole Giulio II ora non più furente contro Venezia, ma contro la
Francia e Alfonso d'Este. Agevole, per F., la conquista di Cento, la pieve Cotignola, Bagnacavallo e Lugo. Ma lo ferma presso
Argenta l'allagamento delle acque del Po ad arte provocato. Connivenze interne gli permettono, in compenso, la conquista di Modena.
Ma non può poi procedere con decisione all'assedio di Reggio pel parere contrario d'Alidosi e il riattestarsi del grosso delle truppe nei
pressi di Ferrara. Posto quindi il campo a San Giovanni di Bologna, evitata la battaglia campale presso Modena, in questa F. si
rinchiude, sinché, rafforzato l'esercito pontificio, l'offensiva riprende coll'espugnazione di Sassuolo e coll'assedio di Mirandola alfine
costretta a cedere all'impetuoso attacco che vede in testa animosissimo lo stesso pontefice.
Segue, da parte di F., la pressione su Ferrara, ad alleggerire la quale i Francesi - che vanamente tentano di sloggiarlo - a loro volta
minacciano Bologna. Sicché pure F. abbandona la sua ben munita posizione per attestarsi a Casalecchio. Esiziale, però, l'odio tra lui e
Alidosi (questi non può certo dimenticare che F. il 7 ott. 1510 è giunto a farlo arrestare, peraltro senza esito) e tale da impedire malgrado l'incalzare del pericolo - un minimo accordo operativo. Sicché - per la mancata saldatura tra i due che avrebbero, invece,
dovuto sintonizzare le loro mosse, Alidosi difendendosi dentro e F. contrastando da fuori - Bologna, il 21 maggio 1511, apre le porte
ai Francesi. Uno smacco intollerabile per l'iracondo pontefice. Quando a lui ringhiante si presenta avvilito il nipote, il 24, a Ravenna,
gli s'avventa contro accusandolo d'inettitudine e codardia e cacciandolo in malo modo senza che possa pronunciare qualche parola di
giustificazione. Uscito, dopo la tremenda strapazzata, dal palazzo, F. incontra Alidosi che, a sua volta, si sta recando dal papa
incedendo a cavallo scortato da un centinaio d'armati. Questi guarda dall'alto, senza salutarlo, F., quasi a schernirlo. Il giovane, colto
dall'ira, afferra lo stocco e fendendo la scorta sconcertata si precipita sul rivale immergendoglielo nelle viscere. E, mentre Alidosi
cade privo di vita, F. scappa. Nessuno lo ferma. Così, fuggendo a rotta di collo, ripara ad Urbino, quivi attendendo trepidante
provvedimenti al proprio riguardo. Citato a giudizio, si reca a Roma e quivi - decaduto da ogni titolo e dignità - viene relegato in una
sorta di detenzione sin dorata, tanto è accompagnata da agi e conforti. Delegata la causa a quattro cardinali - e tra questi il futuro
Leone X - il relativo processo, dibattuto il 14 luglio, si trasforma in un elenco d'accuse all'ucciso con relativa larga comprensione per
l'uccisore. Evidentemente, nel frattempo, l'ira di Giulio II è sbollita, sicché si possono caricare sul morto le più varie imputazioni intrighi, ruberie, torve ambizioni, tradimenti, frodi, empietà - riabilitando nel contempo F. con una sentenza di piena assoluzione
approvata da tutto il Collegio cardinalizio il 5 dicembre. Sicché, reintegrato nella sua titolarità ducale, torna ad Urbino confortato
anche dal dono pontificio di 12.000 scudi. E poiché nella guerra antifrancese il comando generale compete al viceré di Napoli
Raimondo Cardona - ciò perché le milizie spagnole sono prevalenti - F. non partecipa, non volendo sottostare ai suoi ordini,
direttamente, limitandosi a concorrere con contingenti affidati alla guida di Donnino della Genga suo suddito. Partecipa, invece, a
capo di 400 uomini d'armi e di 800 fanti, alla fase del recupero pontificio successivo alla sconfitta subita a Ravenna il 6 apr. 1512.
Ripresa la Romagna, è a F. che si sottomette spontaneamente Bologna; dopo di che passa all'occupazione di Parma e Piacenza senza
procedere oltre, ché i Francesi, nell'impossibilità di mantenersi saldamente a Pavia, preferiscono lasciarla per rivalicare le Alpi.
Molti i crediti via via accumulati da F. nei confronti del, peraltro esausto, Tesoro pontificio. E, a risarcimento di quanto gli spetta, la
bolla papale del 20 febbr. 1513 gli attribuisce la signoria di Pesaro riaggregata temporaneamente alla Chiesa in seguito all'estinzione
del ramo degli Sforza di quella signoria. Un gesto di smaccato favoritismo da parte di Giulio II che muore il 21, il giorno dopo aver
firmato la concessione. Un duro colpo per la sorte di F. la scomparsa del papa zio, ma non immediatamente, ché il nuovo papa, Leone
X, per la cui elezione egli s'è adoperato, a tutta prima si mostra a lui favorevole: del 17 aprile il breve che lo conferma capitano
generale della Chiesa; del 4 agosto quello di conferma dell'investitura del Ducato urbinate. Troppo violenta, però, nel nuovo papa simile, d'altronde, per tal verso a Giulio II - la propensione a favorire la propria famiglia perché F. non debba temerla. Già
l'affidamento, del 29 giugno 1515, del comando dell'esercito pontificio a Giuliano de' Medici, fratello di Leone X, è per lui - che in
subordine dovrebbe accompagnarlo colle proprie truppe - preoccupante. Leale, ad ogni modo, con F. - che a suo tempo l'ha salvato dai
sospetti di Giulio II - quello e al punto da volerlo personalmente incontrare, ai primi di luglio, proprio per tranquillizzarlo. Per parte
sua - così Giuliano de' Medici - non si presterà a manovre contro di lui. Una iattura, allora, per F. che questi, una volta a Firenze, cada
ammalato e muoia alla fine di febbraio del 1516, essendogli già subentrato nel comando generale dell'esercito pontificio il nipote
Lorenzo (figlio di Piero, morto ancora nel 1503). Vittima designata F. - già dichiarato ribelle per il mancato apporto alla guerra
antifrancese - laddove il papa, conclusa la pace con la Francia e con questa alleatosi, ha già fatto rientrare la sua cacciata negli accordi
con Luigi XII, non a caso elusivo con F. quando questi si precipita a Milano a chiedere la sua protezione. E a legittimare lo scippo del
Ducato urbinate - di cui sarà investito, con bolla del 1° sett. 1516, Lorenzo de' Medici, il nipote di Leone X - l'antecedente enfiarsi
della montatura accusatoria (riesumato in questa sin l'assassinio d'Alidosi da parte del papa che, cardinale, di questo l'ha assolto)
finalizzata al crescendo sanzionatorio: prima il monitorio, poi la condanna in contumacia e la scomunica, quindi l'interdetto dalla vita
religiosa in tutto il territorio ducale. Isolato, senza appoggi F., privato anche, da parte del viceré di Napoli, del Ducato di Sora,
s'appella al "buon testimonio" del giudizio divino di contro all'iniquità d'una "potenzia", quella pontificia, misconoscente "in terra"
un'"innocenza" in ogni caso palese "in cielo".
Impensabile una resistenza di fronte al muoversi convergente del nemico che procede da Gradara con Lorenzo de' Medici, già
prossimo a Casteldurante con Vitello Vitelli, già avanzante da Gubbio con Gian Paolo Baglioni, già inoltrantesi da Camerino con altri.
A F. - che ha già provveduto a mettere in salvo la moglie col primogenito Guidubaldo - non resta, per non cadere nelle sue mani, che
imbarcarsi a Pesaro. Costretto dal mare grosso a riparare a Primaro, in terra pontificia, di qui, travestito, raggiunge i suoi a Mantova.
Ma, bersagliato com'è il suocero Francesco II Gonzaga da ingiunzioni a non accoglierlo, F. non può stare, come la moglie e il figlio, a
corte. Deve nascondersi a Goito. Occorre attendere la convenzione romano-gonzaghesca del 10 ag. 1516 perché l'asilo - sottoposto a
tutta una serie di restrizioni - sia formalizzato anche per lui.
Un leone in gabbia F. durante il soggiorno mantovano, che s'arrovella per risalire la china d'una disgrazia che pare definitiva. Da un
lato punta a guadagnarsi simpatie a Roma all'interno d'un Collegio cardinalizio non unanime nell'approvare il suo arbitrario
spodestamento. Dall'altro, aiutato dalla suocera Isabella d'Este che impegna, per soccorrerlo, i gioielli, mette assieme una sorta di
corpo di spedizione fatto di volontari mantovani e di spagnoli e guasconi rimasti senza paga dopo l'accordo franco-ispano, del 16
agosto, di Noyon. E, non appena con questo privato esercito raccogliticcio si presenta, ecco che la popolazione, insofferente del
governo dell'inviso usurpatore, è tutta dalla sua parte, ecco che nel territorio si scatena la guerriglia a suo favore, mentre l'intero
presidio d'Urbino si dà alla fuga. Costretto, allora, Lorenzo de' Medici, il duca posticcio, a rinchiudersi a Pesaro, donde, però, F. non
riesce a stanarlo. Ma, in compenso, penetra spavaldo in terra pontificia, si spinge, nelle sue incursioni, sino a Città di Castello, sino a
Perugia; saccheggia Jesi, Fabriano, Montenero di Todi e, dietro pagamento, risparmia, invece, Ancona, Osimo, Recanati, San
Severino, Montecchio. Per circa otto mesi, nel 1517, da solo, con mezzi scarsi e improvvisati, è in grado di dimostrare che
l'usurpazione medicea non ha attecchito, può tenere in scacco un nemico più potente; e ciò non senza scorno del pontefice, non senza
sua umiliazione. Un'incursione vincente quella di F., efficace sul piano della propaganda, atta, se non altro, ad attestare l'affezione
delle popolazioni. Ma più che tanto non può protrarsi. I rispettivi re vietano agli spagnoli e ai guasconi di militare ulteriormente per
lui. E sin disgregante sul suo irregolare contingente l'allettamento d'un inquadramento nell'esercito pontificio accompagnato
dall'offerta di tre paghe anticipate. L'oro - mediceo (è su Firenze che grava il costo della guerra d'Urbino) più che papale - sta avendo
la meglio sul ferro. Sicché F. preferisce addivenire ad un accordo con Leone X che contempli il suo dignitoso rientro a Mantova
avvolto dal conseguito prestigio di abile condottiero e di prode - ha ben sfidato a singolar tenzone, nel marzo del 1517, Lorenzo Orsini
(Renzo da Ceri), il comandante mediceo - e cavalleresco uomo d'armi.
Morto a Firenze, il 4 maggio 1519, Lorenzo de' Medici e integrato il Ducato urbinate con Pesaro e Senigallia (ma non la provincia di
Montefeltro con la pieve di Sestino assegnate a Firenze a parziale risarcimento delle spese sostenute), F. a Mantova non ha margini di
manovra dopo la sottoscrizione, dell'11 dic. 1520, dei capitoli della condotta del cognato Federico II Gonzaga, il nuovo marchese,
esitante nella nomina, del 1° luglio 1521, a capitano generale della Chiesa.
Imbalsamato e sin paralizzato sinché a Mantova, preferisce spostarsi a Verona, sotto la Serenissima, per recuperare un minimo di
libertà di movimento. Questa addirittura per lui si spalanca con la morte, sbloccante, di Leone X del 1° dic. 1521. Si reca a Ferrara,
luogo di raduno per quanti smaniano di vendicarsi dei soprusi subiti dal papa defunto. Tra questi Malatesta e Orazio Baglioni, figli del
Giampaolo fatto decapitare da Leone X, il loro cognato Camillo Orsini e Pirro Gonzaga. Tutti e quattro seguono F. che - a capo d'una
compagnia d'uomini d'armi e di 1.500 fanti e disponendo pure di quattro pezzi d'artiglieria donatigli da Alfonso d'Este - non solo
recupera in breve le proprie terre, ma facilita il reinsediamento a Camerino del nipote (è figlio d'una sua sorella) Sigismondo da
Varano e il rientro a Perugia dei due Baglioni. E al reinsediamento di fatto del 1522 segue, da parte d'Adriano VI, l'investitura del 27
marzo 1523. S'aggiunge, il 7 settembre, da parte della Serenissima, la nomina a governatore generale delle proprie truppe. In tale veste
partecipa all'offensiva antifrancese in Lombardia distinguendosi colla conquista di Gherlasco. Innalzato - a riconoscimento della sua
valentìa - a capitano generale della Repubblica, dopo il costituirsi, del 22 maggio 1526, della Lega di Cognac, è contro gli Imperiali
che deve combattere. Conquista Lodi e partecipa all'assedio - voluto questo da Francesco Guicciardini contro il suo parere - di
Milano, guidando poi, fallito l'assalto del 7 settembre, il ripiegamento. E, al calare di 14.000 lanzichenecchi, F. - che dispone di 8.000
fanti e 600 uomini d'armi - schivando lo scontro frontale, ne ritarda l'avanzata con intermittenti operazioni di disturbo, in una delle
quali resta mortalmente ferito, il 24 novembre, Giovanni de' Medici di cui F. è amicissimo. Manca, da parte dei collegati, un convinto
tentativo per sbarrar loro il passo. Né la Serenissima - ove prevale la linea d'un cauto attendismo - incita in tal senso Francesco Maria.
Sicché - avvistati, tallonati, punzecchiati, ma non arrestati da F. - i lanzi, varcato il Po, proseguono nella loro discesa. "Dove gli
imperiali pranzano, essi", i collegati, "cenano", s'ironizza. E facilitati i primi dall'intervento - fuorviante rispetto al suo compito primo
d'intercettare il procedere dei Cesarei - di F. a Firenze per bloccarvi un incipiente moto antimediceo. Se il "duca non era" - così Orazio
Florido, un cortigiano, in una lettera alla moglie del 26 apr. 1527 - "el stato de Fiorenza se mutava". Fatto sta che, anziché far
"l'alloggiamento a l'Ancisa", F., a controllo dell'"humor" della popolazione fiorentina che sembra proprio "non volere governo de
Medici", sposta le sue truppe nei pressi di Firenze. Un diversivo - forse suggerito dal desiderio d'ingraziarsi Clemente VII che non gli
ha ancora restituito San Leo e il Montefeltro - questo di F., che riporta sì l'ordine nella città in fermento, ma quasi dimentico dell'orda,
strada facendo sempre più famelica, che sta per avventarsi distruttiva su Roma.
È il 6 maggio che inizia l'assalto a questa, di cui è sin ridicolo difensore quel Renzo da Ceri che s'è sottratto alla sfida a duello di
Francesco Maria. Ed è soltanto ora che F. e gli altri generali sembrano percepire la gravità della situazione. Non arginata dal loro
temporeggiamento la valanga è ormai prossima a piombare su di una Roma terrorizzata. Il 25 F. - s'affretta a scrivere a Venezia un
suo agente lo stesso giorno - constatando, finalmente, "che senza combattere si venga ad ogni modo a perdere" e che l'esercito si sta
assottigliando per l'emorragia delle diserzioni - i soldati, attratti dalla prospettiva del saccheggio, passano addirittura al nemico propone "in consiglio la deliberation… d'avvicinarsi al nemico et con tutta forza combatterlo". Meglio confidare nella "fortuna con
qualche speranza" d'aiuto divino "che perdersi al certo senza alcun danno del nemico". D'accordo con F. il conte Ugo Pepoli, il
capitano Leonardo Romolo, il conte Filippino Doria, il provveditore generale Alvise Pisani e, naturalmente, Guicciardini da un pezzo
fautore d'una linea più aggressiva. Donde la decisione combattiva di spostarsi l'indomani "all'alloggiamento di la Croce di
Montemare", addentro nella Campagna romana. Ma raggelante, di lì a poco, la notizia dell'imminente arrivo in Italia di 10.000
svizzeri. Meglio, sostiene Guido Rangone, attendere i soccorsi, poiché, pel momento, è impossibile "aiutare ragionevolmente Nostro
Signore". Un "parere" che, condiviso, disdice l'impegno all'attacco. Sicché si decide di ripiegare a Viterbo per attendervi "soccorso".
Perplesso l'agente urbinate commenta: "non so mo' se Nostro Signore avrà tanto animo che voglia", a sua volta, "expectarlo". In effetti
Clemente VII, rinserrato a Castel Sant'Angelo, s'arrende il 5 giugno e il sacco si scatena. Un disastro d'addebitare a Francesco Maria?
Per Marcello Alberini è lui "la potissima cagione delli affanni nostri, poiché, per vendicarse contra la casa de' Medici, consacrò noi
alli tormenti et l'onor suo al tempio dell'infamia". Di proposito insomma F. non avrebbe fatto alcunché. Volutamente non si sarebbe
opposto. Un'ignavia la sua tacciabile di tradimento. E riconducibile questo al desiderio di vendicarsi così degli odiati Medici. E il
tradimento vendicativo è adombrato anche nelle pagine di Guicciardini. Indicativo, però, che un'accusa del genere non trapeli in
Francesco Vettori, pur parzialissimo dei Medici e pur esaltatore di Clemente VII: F. e il marchese di Saluzzo Michele Antonio - si
limita questi a riassumere - "pensarono bene di andare a soccorrere, ma con tutti quelli ordini e comodità con le quali vanno e' soldati,
quando vanno a soccorrere chi può aspettare". Imputabile, insomma, a F. (e, prima ancora, alla Serenissima) la sottovalutazione
dell'urgenza del soccorso. E ciò perché troppo abituato a giocare d'astuzia, e ciò perché difettante d'immaginazione. Il che, volendo,
vale pure per Clemente VII, anch'egli ignaro della portata della tempesta che si stava addensando sul suo capo. Esplosione di inaudita
violenza il sacco - vissuto come trauma lacerante, come fine d'un'epoca - coglie di sorpresa e spiazza lo stesso Carlo V, di per sé
intenzionato soltanto ad intimidire il pontefice. Impari, insomma, pure l'imperatore alla terrificante grandiosità d'un evento sfuggito
alle sue capacità di controllo e, prima, nella fase d'incubazione, alle sue capacità di previsione. Autentica protagonista della tragedia
una furia distruttiva di gran lunga eccedente le manovre e i calcoli che pur l'hanno occasionata. Ridimensionata, allora, la stessa
statura di Clemente VII e di Carlo V; F. si rimpicciolisce a comparsa in una tragedia più grande di lui. Una commedia, allora, il
precedente traccheggio; e in questa ha recitato la parte, involontariamente parodica, del Quinto Fabio Massimo in miniatura.
Spropositata, dunque, la statura in negativo conferitagli dalle accuse, esplicite o larvate, di proditoria perfidia camuffata da inerte
attendismo. È lo stesso Clemente VII ad assolverlo implicitamente, incaricandolo, con breve del 23 febbr. 1528, del recupero d'un
castello tolto alla duchessa di Camerino Caterina Cibo, confermandogli, con apposita bolla, la restituzione del Montefeltro già operata
da Firenze, conservandolo nel grado di prefetto di Roma. Ed invitato F. - che, nel frattempo, ha partecipato all'espugnazione di Pavia e
che, dopo la pace di Barcellona, sta vegliando sui confini della Serenissima - con breve del 7 febbr. 1530 all'incoronazione imperiale a
Bologna; e contemplata nei capitoli della pace generale quivi conclusa l'investitura del Ducato. E autorizzata - col breve papale del 26
genn. 1532 dispensante dalla parentela di quarto grado - Ippolita, figlia di F. e d'Eleonora Gonzaga, alle future nozze con Antonio
d'Aragona, figlio del duca di Montalto Ferdinando. Ma al di là dell'ormai consolidato profilo ducale di F., suo connotato precipuo è
l'essere - così Giovio - "capitano dell'esercito veneziano, secondo che richiedevano i tempi e i costumi di quella signoria". Finita, colla
sconfitta d'Agnadello, la fase espansiva, questa non abbisogna più d'un Bartolomeo d'Aviano, ma "piuttosto" - così acutamente ancora
Giovio - d'"un capitano eguale a Quinto Fabio che a M. Marcello". Per tal verso lo stesso tergiversare di F. nel 1526-27 si presta alla
rivalutazione.
La sua strategia e la sua tattica, allora di per sé inadeguate, non sono state che espressione delle limitate possibilità della Repubblica
ormai in fase d'autoconservazione e di ripiegamento difensivo. Calante il peso relativo della Serenissima epperò compensato da una
"reputation" riaccreditante - contro al ridimensionamento insito nei rapporti di forza - Venezia quale sapienza di Stato, quale aurea
mediocritas. La quale contempla la riorganizzazione difensiva del territorio affidata alla competenza di F. "Viva fiamma di Marte"
questi, nella generica definizione di Guidiccione. Meno lusinghiero epperò anche meno vago l'accostamento al romano Cunctator.
Professionista, comunque, dell'arte della guerra, propende ad un uso allargato dell'artiglieria, registra il ridursi del ruolo della
cavalleria, privilegia la fanteria che vuole equipaggiata, disciplinata, ben schierata, sì da essere ora cuneo penetrante ora muraglia
impenetrabile. A suo avviso dovrebbe essere altamente specializzata, capace oltre che di combattere d'adoperare la zappa e la pala, di
farsi, così, anche corpo di guastatori. Non stratega dalle fulminee intuizioni F., ma, piuttosto, propenso a valutare la guerra come
organizzazione, come ordine, come sistema riscontrabile nel marciare, nel campeggiare. E alla guerra c'è da pensare sempre. E il
territorio va strutturato ai fini dell'autodifesa. Ed è un vero piano di ristrutturazione difensiva globale che F. propone alla Serenissima.
Lo spazio va perimetrato, coordinato in un complesso di opere fortificatorie coerentemente collegate, attrezzato a mo' di macchina di
difesa sempre attivabile nella logica distribuzione dei presidi, nel costante alimento del munizionamento. Sin riplasmato, nell'organico
e articolato piano di difesa concepito da F., l'intero dominio della Serenissima. Ma questa - che si vale dell'assidua diligenza ispettiva
esercitata da F. su mura, fortezze, guarnigioni, artiglierie della Terraferma - rilutta a seguirlo laddove suggerisce una trasformazione
tanto radicale del territorio. Da Venezia - ora, in virtù della renovatio urbis grittiana, sfolgorante capitale illustrante con lo splendor
civitatis l'intima perfezione costituzionale d'un buon governo che è più prudenza civile che marziale disciplinamento - si guarda alla
Terraferma soprattutto come a sede di opere di pace. E, invece, F. la ridisegna con l'ottica del militare privilegiante l'eventualità della
guerra, a questa subordinante tutte le altre attività. Non è solo per ragioni di costo che Palazzo ducale sin qui non lo asseconda.
L'attuazione integrale d'un piano quale quello caldeggiato da F. avrebbe richiesto una tal determinazione nel comando del centro sulla
periferia da non escludere il ricorso alla forza pur d'imporre il piano. Il quale - c'è da aggiungere - è d'un tal impegno e d'un tal respiro
da conferire all'eventuale attuatore (e questi non può essere che F.) una statura anomala, un'autorità eccessiva. Forse anche
considerazioni del genere spingono il governo veneto a lasciar, sostanzialmente, cadere la proposta di Francesco Maria. Troppo
vincolante e irreversibile, ad ogni modo, la maglia dell'autotutela ch'egli vorrebbe far indossare alla Serenissima.
Quanto al Ducato urbinate, F. è da questo troppo assente fisicamente per un continuato impegno nel governo diretto. Grosso modo
rispettoso degli statuti, moderato nella pressione tributaria, ricettivo nel prestar ascolto alle richieste delle Comunità, tra le poche leggi
da lui promulgate si distingue l'editto del 9 ag. 1534 col quale vieta ai sudditi la milizia per altre bandiere. Da lui dettati gli
ordinamenti militari, mentre, per le fortificazioni, per le quali s'avvale di Battista Commandino, il criterio adottato è quello del
ripristino con ammodernamento di quelle fatte abbattere da Lorenzo de' Medici. Poco intendente di lettere, pago di farsi leggere
qualche nota pagina di qualche celebre storia per commentarla con qualche improvvisata riflessione, con F. certo non prosegue il
mecenatismo culturale montefeltresco. Né s'intende gran che d'arte, né, insieme, fa gran stima degli artisti, come s'evince dal suo
contrasto con Michelangelo a proposito del sepolcro dello zio. E se si fa ritrarre da Tiziano, non è perché entusiasta del suo pennello,
quanto per ragioni di prestigio, per poter anch'egli essere annoverato tra i grandi da quello dipinti. E la mobilitazione d'artisti per
decorare la villa dell'Imperiale a Pesaro si deve non a F., ma a sua moglie. Rientrato, il 30 maggio 1533, nel possesso del Ducato di
Sora, col matrimonio - imposto con la forza al figlio; innamorato di Clarice Orsini è con questa che voleva sposarsi; e poiché non
smetteva di frequentarla F. così l'aveva minacciato: "farò contra di te… quello che uomo" non osa immaginare sia fattibile da un
"padre" al "figliuolo" - celebrato segretamente (ad evitare l'ostilità della S. Sede) il 12 ott. 1534 di Guidubaldo e Giulia da Varano, F.
s'illude che Guidubaldo possa - in attesa di succedergli - essere, intanto, duca di Camerino. Sicché in prospettiva - ma Paolo III
provvederà a vanificarla - sarà il Ducato urbinate ad ingrossarsi. Reso omaggio a Napoli all'imperatore, di cui come duca di Sora è
feudatario, F. si reca quindi in Dalmazia ad ispezionarvi e rafforzarvi l'apparato difensivo. Di qui traghettato a Pesaro, raggiunge
quindi Venezia, che, aggredita collo sbarco a Cipro di Solimano a capo di 24.000 uomini, si collega col papa e Carlo V. E, in seguito
al repentino abbandono dell'isola da parte del Turco, la lega, stipulata il 31 genn. 1537, diventa offensiva; F. - con pieno assenso
dell'imperatore e del papa, dal quale ultimo, ad ogni buon conto, esige garanzia che non sarà molestato sinché impegnato contro la
Mezzaluna - ne diventa generalissimo. Iniziano con gran fervore i preparativi per l'offensiva, che però, poi, proseguono a rilento.
Pronta la flotta veneta; ma resta da attendere la comparsa di quella cesarea agli ordini d'Andrea Doria. Impaziente, comunque, F.
d'affrontare il cimento. Purtroppo s'ammala; trasportato a Pesaro, vi muore il 20 ott. 1538. E corre voce sia stato avvelenato, e Luigi
Gonzaga sarebbe il presunto avvelenatore.
Fonti e Bibl.: A. Brucioli, Dialogi, I, Venetia 1537, ded. a F. il 1° e interlocutore F. dell'8°, del 9°; Gl'ordini della militia… tratti da
Polibio…, Venetia 1573, tav. B3; Delle lettere di principi…, Venetia 1581, I, ff. 26v-27r; II, ff. 102v-104v; Francesco Maria I Della
Rovere, Discorsi militari… nei quali si discorrono molti avvantaggi e disavantaggi della guerra utilissimi ad ogni soldato, Ferrara
1583; Id., Discorso… sopra le cose di Dalmazia…, Venezia 1846; Rel. degli amb. veneti…, a cura di E. Alberi, s. 2, III, Firenze 1846,
pp. 47, 112 s., 267, 271, 323; M. Sanmicheli al servizio della Rep. ven. Documenti…, a cura di A. Bertoldi, Verona 1874, pp. VI, 22;
S. Vimercati, Informatione de la causa… aggiuntovi un parere del fu duca… F.M.…, s.n.t. (Lione 1561?); Vicende di Lodi dal 1528
al 1542 descritte dal cronista G.S. Brugazzi, a cura di A. Timolati, in Arch. stor. lomb., II (1875), p. 385; M. Sanuto, Idiarii, Venezia
1879-1903, IV-LVIII, ad Indices; V. Colonna, Carteggio…, a cura di E. Ferrero - G. Müller, Torino 1889, ad Ind.; Ven. Depeschen…,
a cura di S. Turba, Wien 1889-92, I-II, ad Indices; P. Aretino, Un pronostico satirico…, a cura di A. Luzio, Bergamo 1900, ad Ind.;
Cronachetta d'Urbino (1404-1578), a cura di G. Baccini, in Le Marche, I (1901), pp. 134-135; Francesco Maria I Della Rovere,
Discorsi sopra le fortificazioni di Venezia, a cura di E. Viani, Mantova 1902; Il libro di ricordi della fam. Cybo…, a cura di L.
Staffetti, in Atti della Soc. ligure di storia patria, XXXVIII (1908), ad Ind.; G. Guidiccioni - F. Coppetta Beccuti, Rime, a cura di E.
Chiorboli, Bari 1912, ad Ind.; P. Giovio, Le vite…, a cura di C. Panigada, Bari 1931, ad Ind.; B. Dovizi da Bibbiena, Epistolario, a
cura di G.L. Moncallero, Firenze 1955-65, ad Ind.; P. Giovio, Opera, I-II (= Epist.), a cura di G.G. Ferrero, Roma 1956-58, ad Ind.; F.
Guicciardini, Carteggi, a cura di P.G. Ricci, VIII-XIV, Roma 1956-69, passim; P. Aretino, Lettere sull'arte, a cura di E. Camesasca,
Milano 1957-59, ad Ind.; Nunziature di Venezia, I-II, a cura di F. Gaeta, Roma 1958-60, ad Ind.; P. Aretino, Lettere, a cura di F.
Flora, Milano 1960, ad Ind.; Trattati d'arte del Cinquecento…, a cura di P. Barocchi, Bari 1960-62, ad Ind.; N. Machiavelli,
Legazioni…, a cura di S. Bertelli, Milano 1964, ad Ind.; P. Aretino, Sei giornate, a cura di G. Aquilecchia, Bari 1969, ad Ind.; Id.,
Teatro, a cura di G. Petrocchi, Milano 1971, ad Ind.; F. Vettori, Scritti stor. e pol., a cura di E. Nicolini, Bari 1972, ad Ind.; Lett. del
Cinquecento, a cura di G.G. Ferrero, Torino 1977, ad Ind.; P. Giovio, Dialogo dell'imprese…, a cura di M.L. Doglio, Roma 1978, ad
Ind.; Consulte bilanci… di Napoli…, a cura di G. Coniglio, Roma 1983, ad Ind.; N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di T.
Livio, a cura di C. Vivanti, Torino 1983, ad Ind.; Id., Lettere, a cura di F. Gaeta, Torino 1984, ad Ind.; Novo libro di lettere scritte da i
più rari auttori… della lingua volgare ital., a cura di G. Moro, Bologna 1987, ad Ind. nell'indice dei nomi; F. Guicciardini, Storia
d'Italia, a cura di E. Mazzali, Milano 1988, ad Ind.; I Guicciardini e le scienze occulte. L'oroscopo di F. Guicciardini, a cura di R.
Castagnola, Firenze 1990, ad Ind.; A. Leonico, Il soldato, a cura di M. Milani, in Quaderni veneti, XIII (1991), giugno, pp. 36, 47, 50,
54, 97, 117, 119; F. Guicciardini, Autodifesa…, Roma-Bari 1993, pp. 221-222; Corrispondenze dipl. ven. da Napoli. Relazioni, a cura
di M. Fassina, Roma 1992, ad Ind.; P. Aretino, Lettere, I, a cura di F. Erspamer, Parma 1995, ad Ind.; Opusc. e lettere di
riformatori…, a cura di G. Paladino, II, Bari 1927, ad Ind.; G. Vasari, M. Sanmichele, Verona 1960, pp. 15, 74; Mem. concernenti la
vita di F.M.… ultimo duca scritte da se medesimo coll'aggiunta di A. Donato, a cura di F.S. Passeri Ciacca, Venezia 1776; F.
Sansovino, Venetia…, Venezia 1968, ad Ind. dell'indice a cura di L. Moretti; C. Lilli, Hist. di Camerino, II, Napoli 1601, pp. 245,
252-254; G. Leoni, Vita di F.M.…, Venezia 1608; Francesco Maria II Della Rovere, Diario, a cura di F. Sangiorgi, Urbino 1989, ad
Ind.; O. Olivieri, Monumenta Feretrana…, a cura di I. Pascucci, San Leo 1981, ad Ind.; P.M. Amiani, Mem.… di Fano…, Fano 1751,
ad Ind.; G.H. Gaillard, Hist. de François premier, Paris 1769, ad Ind.; R. Reposati, Della zecca di Gubbio e delle geste de' conti e
duchi di Urbino…, I, Bologna 1772, ad Ind.; G. Giordani, Della venuta… in Bologna del… pont. Clemente VII… Cronaca…,
Bologna 1842, ad Ind.; M. Leopardi, Annali di Recanati, a cura di R. Vuoli, Varese 1945, ad Ind.; F. Ugolini, Storia dei… duchi
d'Urbino, II, Firenze 1859, ad Ind.; G. De Leva, Storia… di Carlo V…, Venezia 1863 - Bologna 1894, I, p. 255; II, pp. 89, 145, 341,
347-348, 381, 399-401, 433, 602; III, p. 141; M. Mignet, Rivalité de François I et de Charles-Quint, II, Paris 1875, pp. 225, 244-252,
264 s., 331; L. Celli, Le ordinanze militari della Rep. veneta…, in Nuova Antologia, 1° ott. 1894, pp. 498-520 passim; L. Fumi, Rel.
della presa di Perugia…, in Boll. della R. Dep. di storia patria per l'Umbria, VI (1900), pp. 69-97; D. Orano, Il sacco di Roma, Roma
1901, ad Ind.; E. Viani, L'avvelenamento di F.M. I…, Mantova 1902; G. Grimaldi, L'assedio di Mondolfo nel 1517, in Le Marche, II
(1902), pp. 185-189; G. Luzzatto, Comune e principato in Urbino…, ibid., V (1905), pp. 196-199; R. Marcucci, F.M. I…, Senigallia
1905; A. Solerti, Musica… alla corte medicea, Firenze 1905, ad Ind.; G. Luzzatto, I banchieri ebrei in Urbino…, Padova 1908, pp. 29,
40, 51-52; A. Luzio, Isabella d'Este e il sacco di Roma, Milano 1908, pp. 30, 39, 71, 129; J. Dennistoun, Memoirs of the dukes of
Urbino…, a cura di E. Hutton, London 1909, ad Ind.; R. de la Sizeranne, C. Borgia et le duc d'Urbino, Paris 1924, ad Ind.; A. Otetea,
F. Guichardin…, Paris 1926, ad Ind.; G. Menichetti, Firenze e Urbino…, in Atti e mem. della R. Dep. di storia patria… Marche, IV
(1927), p. 254; V (1928), pp. 45 s.; U. Buoncompagni Ludovisi, Roma nel Rinascimento, Albano Laziale 1928-29, ad Ind.; Corpus
nummorum Ital., XIII, Roma 1932, ad Ind.; P. Pieri, La crisi militare ital.…, Napoli 1934, ad Ind.; O.F. Tencajoli, Principesse
sabaude in Roma, Roma 1939, ad Ind.; G. Gronau, Documenti artistici urbinati, Firenze 1936, ad Ind.; B. Ligi, Mem. eccl. di Urbino,
Urbino 1938, ad Ind.; G. Fatini, Cenni biogr.,in Giuliano de' Medici, Poesie, Firenze 1939, pp. XXV, XXXI-XXXIII, LV, LXXXII;
E. Bianco di San Secondo, B. Castiglione…, Verona [1941], pp. 21-189 passim; P.E. Vecchioni, Lettere… di F.… e di… sua moglie,
in Atti e mem. della R. Dep. di storia patria per le Marche, s. 6, I (1941), pp. 151-156; A. Mercati, Lettere di Elisabetta e Leonora… a
F.M.…, in Atti e mem. dell'Accad. Virgiliana…, n.s., XXVI (1943), pp. 3-53; Saggio di… bibliogr.… di Pesaro…, a cura di I. Zicari,
Città di Castello 1950, pp. 39, 59, 80; P. Pieri, Il Rinascimento e la crisi militare…, Torino 1952, ad Ind.; E. Bernareggi, Monete…
del Rinascimento ital.…, Milano 1954, pp. 88-90 tav. XIV, 187-188; G. Franceschini, Figure del Rinascimento urbinate, Urbino 1959,
passim; L. Moranti, Bibliografia urbinate, Firenze 1959, ad Ind.; R. Ridolfi, Vita di F. Guicciardini, Roma 1960, ad Ind.; P. Paschini,
Il card. M. Grimani…, Romae 1960, ad Ind.; C. Leonardi, L'architetto G. Genga…, in Atti e mem. della Dep. di storia patria per le
Marche, s. 8, V (1966-67), pp. 73-103 passim; G. Costa, La leggenda dei secoli d'oro…, Bari 1972, ad Ind.; Tiziano per i duchi di
Urbino, Urbino 1976, passim; A. Brancati, Le biblioteche e i musei… di Pesaro, Pesaro 1976, ad Ind.; A. Toaff, Gli ebrei a Perugia,
Perugia 1977, ad Ind.; A. Ballarin, Una… prospettiva su Giorgione…, in Giorgione…, Castelfranco Veneto 1978, pp. 234, 248-250; I.
Paccagnella, Le macaronee…, Padova 1979, adInd.; La corte e il cortegiano, a cura di C. Ossola - A. Prosperi, Roma 1980, ad Ind.
(ma il rinvio a I, p. 48 vale pel nipote omonimo); Images de la femme dans la littérature… de la Renaissance, a cura di A. Rochon,
Paris 1980; P. Larivalle, P. Aretino…, Roma 1980, ad Ind.; C. Dionisotti, Machiavellerie…, Torino 1980, ad Ind.; I Della Rovere…
catalogo della mostra, a cura di G.G. Scorza, Pesaro 1981, passim; G. Fabiani, Ascoli nel Cinquecento, I, [Ascoli Piceno 1982], ad
Ind.; Arch. di Stato di Firenze, Carteggio di Cosimo I. Inv., I, a cura di A. Bellinazzi - C. Lamioni, Firenze 1982, ad Ind.; E. Concina,
La macchina territoriale…, Bari 1983, ad Ind.; M.L. Mariotti Masi, Elisabetta Gonzaga, Milano 1983, ad Ind.; Urbino e le Marche
prima e dopo Raffaello, a cura di M.G. Ciardi Duprè Dal Poggetto - P. Dal Poggetto, Firenze 1983, pp. 263-409 passim;
Réécritures… commentaires… dans la littérature ital. de la Renaissance, I, Paris 1983, ad Ind.; M. Moranti - L. Moranti, Le leggi
suntuarie del Ducato di Urbino…, in Atti e mem. della Dep. di storia patria per le Marche, LXXXVIII (1983), pp. 140, 144, 165-166;
Ville e giardini, a cura di F. Borsi - G. Pampaloni, Novara 1984, ad Ind.; A. Ferrajoli, Il ruolo delle carte di Leone X, a cura di V. De
Caprio, Roma 1984, ad Ind.; "Renovatio urbis"…, a cura di M. Tafuri, Roma 1984, ad Ind.; E. Concina, L'Arsenale… di Venezia,
Milano 1984, ad Ind.; M.E. Mallett - J.R. Hale, The military organization of a Renaissance State…, Cambridge 1984, adInd.; C.
Cairns, P. Aretino… and Venice…, Firenze 1985, ad Ind.; Federico di Montefeltro…, a cura di S. Cerboni Baiardi - G. Chittolini - P.
Floriani, Roma 1986, ad Ind.; G. Luzzatto, Per una storia economica delle Marche, a cura di P. Giannotti, Urbino 1988, pp. 143-147;
"Familia" del principe…, Roma 1988, ad Ind.; A. Cernigliaro, Patriae leges…, Napoli 1988, ad Ind.; L'architettura a Verona…, a cura
di P. Brugnoli - A. Sandrini, Verona 1988, I, pp. 91-129, e II, p. 408; L'architettura militare veneta del Cinquecento, Milano 1988, ad
Ind.; F.M. Giochi, Di… trattatisti di "militaria" nelle Marche…, in Atti e mem. della Dep. di storia patria per le Marche, XCIV
(1989), pp. 179 s., 192, 210 s.; P. Zampetti, Pittura nelle Marche, Firenze 1989-91, ad Ind.; 1588-1988, le mura di Bergamo, Bergamo
1990, pp. 217-223, 269-299; Tiziano (catal.), Venezia 1990, pp. 224-229, 407; E. Concina, Navis…, Torino 1990, ad Ind.; E. Soletti,
Parole ghiacciate… liquefatte. Il secondo libro del "Cortegiano", Alessandria 1990, ad Ind.; A. Mattucci, Machiavelli nella
storiografia fiorentina…, Firenze [1991], ad Ind.; D. Cantimori, Eretici italiani, a cura di A. Prosperi, Torino 1992, ad Ind.; E.
Panofsky, Tiziano…, Venezia 1992, ad Ind.; P.G. Fabbri, La Romagna nel 1509, in Nuova Riv. stor., LXXVII (1993), pp. 1-36
passim; Studi per P. Zampetti, a cura di R. Varese, Ancona 1993, ad Ind.; P.O. Kristeller, Iter Ital., I-II, ad Ind.; G. Mazzatinti, Inv.
dei manoscritti delle Bibl. d'Italia, I, XXIX, XXXIII-XXXV, XXXVII-XXXVIII, XLII, XLVIII, LXXIII, LXXVII, LXXX-LXXXI,
LXXXV, LXXXVII, ad Indices.
Francesco Maria I della Rovere, Duke of Urbino
(1490 - 1538)
From Wikipedia, the free encyclopedia
Francesco Maria I della Rovere (22 March 1490 – 20 October 1538) was an Italian condottiero, who was Duke of Urbino from
1508 until 1538.
Biography He was born in Senigallia, the son of the Papal captain and lord of that city, Giovanni della Rovere, and of Giovanna da
Montefeltro, daughter of Federico III da Montefeltro. He was also the nephew of Giuliano della Rovere, pope as Julius II from 1503.
His uncle Guidobaldo I of Urbino, who was heirless, called him at his court, and named him as heir of that dukedom in 1504 through
the intercession of Julius II. In 1502 the della Rovere had lost the seigniory of Senigallia, occupied by Cesare Borgia, then the most
powerful figure in the Marche: Francesco Maria and his mother were saved from the slaughter perpetrated by Borgia's troops by the
then-land soldier Andrea Doria. When in 1508 Guidobaldo died, Francesco Maria became duke of Urbino; thanks to the support of his
uncle Giuliano della Rovere, now pope as Julius II, he could also recover Senigallia after Borgia's death. In 1508 he married Eleonora
Gonzaga (1493-1570), daughter of Francesco II Gonzaga, Marquess of Mantua and Isabella d'Este. In 1509 he was appointed as
capitano generale (commander-in-chief) of the Papal States, and subsequently fought in the Italian Wars against Ferrara and Venice.
In 1511, after he had failed to conquer Bologna, he had the cardinal killed by his troops, a cruel action for which he was compared to
Borgia himself. In 1513 he was created also lord of Pesaro. However, the death of Julius II deprived him of his main political patron,
and under the new pope, Leo X Medici, Pesaro was given to the latter's nephew, Lorenzo II de' Medici. In 1516 he was
excommunicated and ousted from Urbino, which he tried unsuccessfully to recover the following year (see War of Urbino). He could
return in his duchy only after Leo's death (1521). Della Rovere fought as capitano generale of the Republic of Venice in Lombardy
during the Italian Wars of 1521 (1523–1525), but with the new Medici Pope, Clement VII, the della Rovere were increasingly
marginalized. As supreme commander of the Holy League, his inaction against the Imperial invasion troops is generally listed as one
of the causes of the Sack of Rome (1527). He was a protagonist of the capture of Pavia in the late 1520s, and later fought for the
Republic of Venice. Later he arranged the marriage of son Guidobaldo to Giulia da Varano (belonging to another former seigniory
family of the region) to counter the Papal power in the Marche. He died in Pesaro, poisoned. Some scholars suggest that The Murder
of Gonzago, an unknown play referenced in William Shakespeare's Hamlet, Prince of Denmark, which is itself later reworked by
Hamlet into The Mousetrap (the play within the play), may have been a popular theatrical reenactment of Della Rovere's death and
may have been portrayed in England's early theaters during the Elizabethan Era.[1]
1.
^
McGee,
Arthur
(2007-09-01).
"The
Elizabethan
Hamlet".
http://arts.ucsc.edu/faculty/bierman/elsinore/poison/PoisonGonzago.html. Retrieved 2007-09-01.
2.
^ Note: Later legitimised and named Marchese di San Lorenzo. Ippolito's daughter Lucrezia married Marcantonio
Lante and their son assumed the new extended surname as Ippolito Lante Montefeltro della Rovere
Sources
• Rendina, Claudio (1994). I capitani di ventura. Rome: Newton Compton.
Guidubaldo II Della Rovere,
duca di Urbino
(1514 - 1574)
Dizionario Biografico degli Italiani
di GG. Benzoni
Portrait of Guidobaldo II della Rovere by Agnolo Bronzino. Coat of arms of the della Rovere family.
GUIDUBALDO IIDella Rovere, duca di Urbino. - Primogenito del duca di Urbino Francesco Maria I e di Eleonora Gonzaga, nacque
a Urbino il 2 apr. 1514; il 4 giugno 1516 giunse a Mantova, lì messo in salvo dal padre che, aggredito da Leone X, era ormai prossimo
a essere spodestato.
Affidato alle cure educative del pesarese Guido Postumo de' Silvestri, G. trascorse l'infanzia a Mantova anche oltre la partenza della
madre, alla quale, a informarla dei suoi progressi, così scriveva, il 16 ott. 1522, Felice da Sora: "egli sta, per Dio gratia, sano; questa
septimana ha cominciato a legere o, per dir meglio, ad odire el primo de Vergilio". Lo si avviava al latino con la lettura del primo
libro dell'Eneide e nel contempo era già iniziato all'equitazione se, nella stessa lettera, a Eleonora era raccomandato di non scordarsi
"de provederli del fornimento del cavallo" di cui G. abbisognava. E intanto - a corollario di un servizio mediceo prospettato al padre ventilata, per G., l'opportunità di un futuro accasamento con quella Caterina di Lorenzo de' Medici che sarà destinata a nozze ben più
prestigiose.
Non vi era però più ragione - dopo che Francesco Maria Della Rovere si era saldamente riattestato nel Ducato usurpatogli - che l'erede
rimanesse a Mantova. Sicché nel 1523 G. era alla corte roverasca - e più a Pesaro che a Urbino questa - a proseguirvi una formazione
fatta di latino con l'aggiunta di un po' di greco, di nozioni storiche, di una spruzzatura di etica nonché di quotidiani esercizi fisici,
specie di scherma ed equestri. E allorché, il 17 febbr. 1525, arrivò - diretta a Loreto - la nonna materna Isabella d'Este fu G. a farsele
incontro fuori Pesaro per accoglierla e scortarla, come scriveva, il 18, il segretario della marchesa al figlio di questa, e zio materno di
G., Federico Gonzaga.
Con la madre quindi, nel 1527, G. era a Venezia in un piacevole soggiorno che, interrotto in agosto da una puntata alle terme di
Abano, dall'inizio di maggio si protrasse per quasi tutta l'estate. Seguì, l'11 apr. 1529, in occasione del rinnovo da parte della
Serenissima della condotta paterna, la condotta, a decorrere dal 2 luglio, di G., a capo di 75 cavalieri pesanti oppure - a sua scelta - di
150 cavalleggeri con retribuzione di 1000 ducati annui più un contributo per 25 cavalli della sua stalla. Avvantaggiato G. dal risalto di
Francesco Maria è alla volontà di onorare questi con "tuta casa sua" che, il 5 giugno dello stesso anno, G. dovette l'invito, peraltro
indirizzato al padre, a far parte dell'appena costituita "compagnia di calza intitulata di Floridi" adunante i primi nobili giovani di
Venezia in qualità non di semplice "compagno", ma di "patron e signor di cadauno" dei componenti.
Tutto impegnato Francesco Maria nel riordino del territorio veneto pensato in funzione della guerra difensiva, più assente che presente
nel Ducato, non aveva modo di controllare e guidare i comportamenti di Guidubaldo. E questi - nel suo interessarsi a musiche e
musicisti, nel suo adunare strumenti musicali, nel suo commissionare recite e organizzare spettacoli, nel suo collezionare orologi, nel
divorante piacere di leggere le novità - da un lato dava sfogo alle proprie propensioni, dall'altro, con queste, tendeva a profilarsi
diversamente e autonomamente rispetto al padre. Evidente, nel ritratto di lui diciottenne eseguito da Agnolo Bronzino, la
determinazione a figurare per conto proprio. Una autovalorizzazione non certo assecondata da Francesco Maria che - lungi dal
responsabilizzare il figlio con incarichi precisi o con il riconoscergli un suo spazio - pretendeva solo obbedienza. Sicché si sdegnava
se, nel maggio del 1532, G. si portava a Venezia in incognito per l'annuale mostra militare; e vieppiù si adontò nell'apprendere che G.,
invaghitosi di Clarice Orsini - figlia di Gian Giordano e di Felice Della Rovere -, nutriva addirittura propositi matrimoniali al di fuori
della sua approvazione. Li troncò con una lettera sin brutalmente minacciosa. Nozze indegne quelle con la figlia di un "pazzo" e di
una bastarda (Felice era figlia naturale di Giulio II - prozio di G. - e in fama di essere fuori di senno il suo defunto marito), da
vergognarsi al solo pensarle. Non avrebbe esitato a diseredarlo, a essere con lui il più terribile dei padri. E peggio della minaccia il
disprezzo per G. che ne trasuda: "non avendo tu ancora potuto in alcuna parte onorar né exaltar casa tua" - sintomatico non ci sia
alcun riconoscimento per la capacità organizzativa di G. in fatto di feste e spettacoli; poco cale a Francesco Maria G. si sia messo in
contatto addirittura con L. Ariosto per averne una commedia inedita; né capiva Francesco Maria che la scelta di Bronzino, da parte di
G., per il proprio ritratto è indicativa di una committenza tutt'altro che priva di personalità - evita "almeno di abassarla", con un
accasamento così ignominioso. Per e pur di sventarlo così, esagerando ad arte, lo definisce Francesco Maria, deciso invece a fare
sposare il figlio con la nemmeno decenne Giulia da Varano, unica figlia di Caterina Cibo e del duca di Camerino Giovanni Maria da
Varano, scomparso ancora nel 1527. Appetibile come nuora la ancora bambina - poco gli importa sia nata il 24 marzo 1533; G. deve
sposarla al più presto - per Francesco Maria, perché succeduta, sotto la tutela della madre, al padre. Indubbiamente conveniente come spiegherà lo stesso Francesco Maria, il 18 ott. 1533, alla Serenissima - l'acquisizione, per via matrimoniale, di uno "stato"
garantente "rendita assai bona" nonché "di popolo numeroso e armigero" e con Camerino "molto forte […] quasi nel mezzo della
Marca".
G. si piegò ai voleri del padre, non senza, tuttavia, rispondendogli il 25 dic. 1532, fargli osservare, con pungente sarcasmo, che le
nozze impostegli non erano, con il criterio dell'onore adottato a svalutare quelle con la Orsini, gran che meno disonoranti.
Notoriamente amante - e già con "saputa" del consorte sinché vivo - di un fratello ecclesiastico di Giovanni Maria la futura suocera. È
il cognato, insomma, il marito di fatto di Caterina Cibo. Ad esecuzione del contratto stipulato nell'ottobre del 1533, le nozze di G. con
l'appena fanciulla Giulia da Varano furono celebrate il 12 ott. 1534. A G. toccò - per 4 anni - stare a Camerino, ove, costretto
dall'angustia delle finanze locali a un tenore di vita modesto e sotto tono, salvo tornare a respirare d'estate quando, come sortito di
"preggione", si rinfrancava con le musiche e le feste continue di Urbino. Scarsa, invece, come gli rimproverava il padre, si mostrava la
sollecitudine di G. nell'adempimento del debito contratto con la ben pagata condotta veneziana.
Da un lato gli pesava la subordinazione ulteriore a Francesco Maria che la condotta comportava, dall'altro lo feriva la disistima per lui
del padre che scrupolosamente evitava di associarlo in iniziative di rilievo, di responsabilizzarlo in qualche scenario con effettivo
sentore bellico. Impossibilitato, per il momento, a grandeggiare con il mecenatismo, vagheggiava un allevamento di cavalli pregiati,
non rinunciava alla committenza più selettiva, sicché si rivolse a Michelangelo per una saliera d'argento e un sigillo d'oro, volle fosse
Tiziano - il rapporto con il quale fu una costante nella vita di G. che potrà vantare una collezione di dipinti tizianeschi tra le più ricche
del tempo - a ritrarlo e a dipingere per lui quella "donna nuda" che sarà famosa come Venere d'Urbino. E intanto già guardata con
occhio cupido Camerino da Paolo III, il quale - come si premurò di scrivere, ancora il 6 febbr. 1535, G. a Francesco Maria - a un
inviato dalla cittadina aveva manifestato la propria opposizione alla possibilità di un suo assorbimento nell'ambito urbinate.
Dopo la morte del padre, del 20 ott. 1538, colpito G. - appena insediatosi il 26 - dal breve papale del 15 novembre privante lui e la
moglie - bollati come ribelli - dello Stato di Camerino e minacciati con scomunica quanti, in questo, si fossero ostinati a prestargli
obbedienza. Tentato a tutta prima G. a non cedere a un Paolo III che, accusandolo di "mal animo", pur vantando "la bona et sincera
mente" propria, assicura che sarà "potente a castigarlo". Ma ben presto indotto a desistere dall'impuntarsi specie dalla madre, se, l'8
marzo 1539, Paolo III si compiacque, per iscritto, con lei sapendola lieta del rasserenamento in corso tra il figlio e la S. Sede. A
succedere tranquillamente al padre necessitava la bolla di investitura pontificia del 27 aprile, previa la rinuncia a Camerino
contraccambiata con 160.000 scudi e la promessa del cappello cardinalizio per il fratello minore Giulio che, nato nel 1533, avrà in
effetti la porpora il 27 luglio 1547. Vassallo pontificio G., la ricondotta paterna del 18 marzo 1534 da parte della Serenissima
contemplava, a mo' di corollario, anche la sua partecipazione. E, per riguardo alla memoria di Francesco Maria, conferita a G. il 20
marzo 1539, che, autorizzato il 26 dal papa, iniziò a servire la Serenissima in prima persona, non più ingombrato dalla sovrastante
figura del padre. Sicché lo fece di buon grado. E, a sempre migliori condizioni (e giocava a suo vantaggio l'offerta francese della fine
del 1541 - stando alla lettera del 29 dicembre del nunzio a Venezia Giorgio Andreassi al cardinale Alessandro Farnese - nella quale gli
si proposero 10.000 ducati "pel suo piatto", 100 "huomini d'arme", 200 "cavai leggieri", 200 "fanti per la guardia di Pesaro" con
promessa di protezione; e anche se la declinò, poté aumentare le sue pretese colla Serenissima), fu ricondotto nel dicembre del 1542 e
di nuovo, il 17 giugno 1546. E in quest'ultima conferma lo si impegnava a servire con il prestigioso titolo di "governatore generale di
tutte le genti da guerra" - ma si crucciò, ché voleva la qualifica già del padre di capitano generale - con l'onore dello stendardo e del
bastone.
Doveva garantire la disponibilità in tempi di pace di 100 uomini d'arme e 100 cavalleggeri cui si aggiungeranno 200 cavalleggeri in
tempi di guerra. Di 15.000 ducati annui il compenso più 5000 per il "piatto dell'eccellenza soa" nonché - in caso di guerra - altri
10.000 ducati e 70 tasse mensili per stalla. Non meramente nominali queste condotte di G. comportanti periodi di residenza a Venezia
e a Padova (e qui, nel 1545, prese stanza nella "regia casa" di Giovanni Corner Piscopia, il genero di Alvise Corner, avendo presso di
sé l'Aretino) e più ancora a Verona con funzioni ispettive e direttive assolte con scrupolo e competenza, come attesta - in merito alle
fortificazioni friulane da lui ispezionate, nel 1543, con Michele Sanmicheli - il relativo Parere (Udine 1859) nel quale la sua
valutazione si differenzia in più parti da quella dell'architetto veronese. Se, nell'aprile del 1545 quando rivedeva città e fortezze della
terraferma veneta, i deputati di Verona lo omaggiarono, ciò significa che godeva di un certo prestigio. E lo si evince anche dal fatto
che - transitando nel 1543 Carlo V per Peschiera - è G., con quattro patrizi veneti e con Aretino costantemente al suo fianco, a riverire
l'illustre ospite. Forse quel complesso di inferiorità misto a timore e rancore che aveva reso difficili i rapporti con suo padre non aveva
più ragion d'essere. E, comunque, di quello non c'è traccia nel dialogo di Antonio Brucioli Del capitanio, ove G. e il padre sono
interlocutori e il primo chiede e il secondo risponde. E con l'andar degli anni ci deve essere, da parte di G., un riaccostamento alla
figura paterna se - come osserva nel 1571 l'ambasciatore veneto Lazzaro Mocenigo - G., che "è molto intelligente delle cose di
guerra" (un intendimento donde stimola Federico Commandino, entrato al suo servizio alla fine degli anni '40 e al suo seguito quando
era nel Veneto, alla matematica applicata; e, grato, Commandino, nel dedicargli l'edizione bolognese da lui curata delle Coniche di
Apollonio, del 1566, lo dice padrone dell'arte militare), in queste si avvale non solo del giudizio proprio, ma pure di ricordi e scritture
del padre, dalla riflessione sui quali "è molto aiutato".
Indicativo, altresì, che, nel predisporre l'offensiva antiottomana e sin scontato in questa il ruolo di Giovanni d'Austria, ritenendosi
opportuno affiancarlo con un collega, si faccia, nella corte madrilena, anche il nome di Guidubaldo. Un minimo di credito
evidentemente ce lo aveva, anche se la candidatura fu lasciata cadere perché - come scriveva, il 18 sett. 1570, l'ambasciatore veneto
Leonardo Donà - "non è tenuto per soldato". G., infatti, al contrario di Francesco Maria, non diresse mai operazioni in un conflitto,
mai combatté in battaglia. E se il padre fu duca intermittente e spesso soldato a tempo pieno, egli di contro fu soprattutto duca, e in ciò
impegnato a fortificare di una nuova cinta Senigallia, a proseguire le fortificazioni a Pesaro, ad avviarvi il baluardo del porto - al
governo di uno Stato parte montuoso, parte pianeggiante e vallivo, "con pianure e colli dilettevoli", con "terreni molto fertili d'ogni
qualità di grani", dall'"aere buono e salutare", giusta la sintetica descrizione, del 1547, dell'inviato veneziano Federico Badoer, in
"buona parte" - aggiungerà nel 1571 Lazzaro Mocenigo - "posto alla marina" adriatica. Sette, nel Ducato, i centri vescovili - e
altrettante, per questo, le città - e 52 le terre fortificate, mentre i villaggi oltre 200. Di poco superiore ai 100.000 abitanti la
popolazione, di cui circa 20.000 a Urbino, 15.000 a Pesaro, almeno 30.000 tra Senigallia (e paventato Paolo III voglia "ad ogni modo
far l'impresa di Sinigaglia" contro G., come scriveva, il 7 maggio 1541, il nunzio a Venezia Giorgio Andreassi ad Alessandro
Farnese), Gubbio, Cagli, Fossombrone, San Leo, Casteldurante e gli altri sparsi nel contado e nei borghi. G. - già ritratto da Tiziano,
suo ospite, con il figlio Orazio, nel settembre del 1545, prima di raggiungere, il 9 ottobre, Roma - agli occhi di Badoer, appariva,
quando era sui 33 anni, piuttosto basso di statura, piuttosto tozzo, sano, robusto, "forte e destro" negli esercizi corporali, abitudinario
nel comportamento e formalmente religioso e, nell'ortodossia più tranquilla (sarà a sua totale insaputa che il suo segretario a Venezia
Gian Francesco Agatone darà ricetto in casa sua a un "redutto d'heretici" come lamenterà, il 12 giugno 1574, il cardinale Scipione
Rebiba, presidente dell'Inquisizione romana, in una lettera al nunzio a Venezia Giovan Battista Castagna).
Tutte eguali le sue giornate: iniziano con la messa; proseguono coll'ispezione alle "stalle de' cavalli", quindi una passeggiata premiata
dalla colazione; dopo di che "ragiona", visita l'armeria, si intrattiene al gioco della palla con l'archetto; si concede quindi una cavalcata
e poi, "negozia", si occupa delle faccende di governo e a fine giornata la cena preceduta da qualche lettura. Passa per ponderato, per
prudente, prima di decidere suole consultarsi con i pochi che ritiene capaci di consigliare saggiamente. E, una volta da lui deciso, una
volta chiara la risoluzione, non tollera indugi nell'esecuzione. La pretende immediata. Se così non avviene, si adira. Non è, per
temperamento, uomo allegro. Facile a incupirsi, stenta a sorridere. "Desiderosissimo" d'onore, su di questo disegna i propri
comportamenti, con questo misura i personaggi antichi e moderni. Un'ottica e sinanco un'etica che lo spinge a puntigliosamente
chiedersi "qual sia l'officio del buon capitano". Brucioli, allora, era stato verosimile nel farlo dialogare in proposito con il padre. Su
quel che, invece, sia l'ufficio del principe G. non s'interroga. Evidentemente - proclamandosi "virtutis amantissimo" - è convinto di
saperlo. E l'identifica con il diritto e dovere a tener alto l'"onore". Ma l'onore nella misura in cui costringe a figurare degnamente,
imbalsama G. in una contegnosità sussiegosa. Non può essere alla mano, affabile. Non può abbandonarsi a confidenze né tollerarle. È
sempre sostenuto, irrigidito, impettito. Artificioso "nel suo parlare", quasi debba apparire eloquente, sentenzioso, quasi debba
pronunciare detti memorabili, da tramandare ai posteri. Ciò per ben figurare. Ma con quelli della corte (stando a un registro di spese
del 1545, i salariati della "famiglia" roveresca a Pesaro erano circa 158; e 20, tra questi, gli ufficiali, 11 gli staffieri, 12 gli addetti a
camera e persona, 23 gli addetti alla cucina, 65, tra stallieri, cocchieri e mulattieri, quelli addetti alla stalla; e stipendiato pure
l'architetto Girolamo Genga, al servizio di G., come già di suo padre, sino alla morte, nel 1551), con i cortigiani, con i domestici solo
"ragionamenti" dettati dalla necessità, solo ordini come dall'alto di un'"alterezza" chiusa in se stessa, gelida e raggelante.
Questa, almeno, l'impressione di Badoer, spedito da palazzo ducale - e qui l'alterezza non è una virtù personale, anzi è una colpa - a
condolersi, a nome della Repubblica, con G., per la morte, a Fossombrone, del 18 febbr. 1547, della giovane moglie Giulia da Varano,
che gli aveva dato un figlio morto ancora infante e una figlia, Virginia (1544-71; sposerà nel 1560 Federico Borromeo, nipote di Pio
IV e, vedova di questo, nel 1568, il duca di Gravina Ferdinando Orsini). Sino a che punto G. - al quale durante questo suo primo
matrimonio nacquero due figlie naturali, Felice che si mariterà con Guidobaldo Del Monte e Camilla che si accaserà con il conte
Antonio Landriani e, morto questi, con Pier Antonio Lunati - soffrisse del lutto Badoer non se lo chiede. Nota, piuttosto, che i 10.000
scudi spesi per le esequie della moglie erano tanti, forse troppi per le forze finanziarie del duca. Funzionali le dispendiosissime
esequie a un'enfatizzazione del dolore del vedovo che ben poco tale rimase se già il 1° giugno si impegnò a nuove nozze con Vittoria
Farnese, nipote di Paolo III e figlia del Pierluigi già collocato dal papa nel Ducato di Camerino sottratto a Guidubaldo. Celebrate per
procura, il 29, le nozze a Roma, rispetto a tanta velocità il resto seguì un po' a rilento se solo il 30 genn. 1548 - dopo il trionfale
ingresso nel Ducato e il transito per Gubbio e Cagli - la sposa (la cui dote è sugli 80.000 scudi: 60.000 da versarsi in due rate e il resto
in gioielli) giunse a Urbino, accolta da G. con grandi apparati. Seguì, esaltata da archi trionfali, il 31 maggio, l'entrata della nuova
duchessa a Pesaro. E qui, il 20 febbr. 1549, nacque l'erede Francesco Maria. E dopo di lui videro la luce Isabella (1554-1619), sposa,
nel 1565, del principe di Bisignano Niccolò Bernardino Sanseverino, e Lavinia (1559-1638) moglie, nel 1583, del marchese del Vasto
Alfonso d'Avalos.
Nominato, il 10 apr. 1550, da Giulio III governatore di Fano, G. continuò a servire la Serenissima. A Verona da metà ottobre a
dicembre, dopo la licenza trascorsa a Pesaro, il 9 giugno 1551 fu ricondotto alle condizioni antecedenti, non senza che - circolando la
voce i Francesi lo vogliono "lor generale in Italia" - egli ne approfitti per tentare, come informa il nunzio Beccadelli il 10 sett. 1552, di
elevare il prestigio del servizio con la qualificante timbratura del generalato. Un'innovazione della condotta in corso che suscitò
perplessità e irritazione nei confronti di G., il quale da un lato fece presente che l'impegno gli pesava, dall'altro insistette per la
promozione a capitano generale. Sorda a questa richiesta, e sensibile, invece, alla manifestata esigenza "che sua eccellenza se ne possa
stare a casa sua in libertà" - così, il 9 nov. 1552, il residente urbinate Giovan Giacomo Leonardi - la Repubblica sciolse il rapporto.
Ma non in termini di brusco licenziamento, bensì di comprensione per quel che G. pareva soprattutto desiderare: più stare che andare.
Una soluzione consensuale, insomma, non una rottura. E senza strascico di rancori: tant'è che - nel giugno del 1564, in occasione
dell'arrivo a Venezia di G. con il figlio e il fratello cardinale - un "teatro del mondo" galleggiò in suo onore, dall'11 al 14, in bacino S.
Marco. Sempre lieto G. di far, "per spasso", qualche puntata a Venezia, come quella, dell'ottobre del 1566, di una quindicina di giorni.
Designato, in compenso, con bolla papale del 28 febbr. 1553, G. capitano generale della Chiesa, senza obiezioni da parte della
Serenissima, laddove, invece, vivo era il disappunto francese. E se, nel 1555, fu Giovanni Carafa a subentrargli in questa carica, gli
restava quella di prefetto di Roma, assunta il 19 giugno. La scoperta congiura, del 1550, di Antonio Passeri - un gentiluomo pesarese
che tramava l'eliminazione di G. e la conseguente fagocitazione del Ducato da parte dello Stato pontificio - era ben stata un segnale
inquietante. Sempre a rischio lo Stato vassallo, sempre sotto tiro. Un'insicurezza di fondo, non tacitata con l'eliminazione del traditore.
E nell'allentarsi del legame con la Serenissima - che sottintendeva la sua autorevole protezione - G. si accostò vieppiù a Roma. Ma era
strutturale, rispetto a questa, la sua debolezza, anche se - effetto di ricaduta delle sue seconde nozze -, rispetto al titolo ducale
conferito per tre generazioni, il 23 ag. 1474, a Federico da Montefeltro, precluso nelle successive formule di investitura di Sisto IV e
Adriano VI alla facoltà di subinfeudazione, la bolla del 27 apr. 1548 conferì al titolo una portata più ampia: fu esteso a tutto il
territorio dello Stato a vantaggio pure della discendenza maschile; e vietata la subinfeudazione soltanto nei confronti di principi
stranieri e di personalità più potenti del duca.
Il G. rimaneva bisognoso di una protezione autorevole esterna rispetto alla S. Sede. Fu benvenuto, allora, il conferimento, da parte di
Filippo II, del 4 dic. 1558, della carica (già detenuta da Giovanni Vincenzo di Capua) di capitano generale delle genti d'arme
napoletane comportante una compagnia di questo nel Regno e una di "celate" nel Ducato. Non che dovesse far conto sicuro sui 12.000
scudi annui della promessa retribuzione - pessima pagatrice la Spagna -, ma poteva, in compenso, sentirsi garantito con questo cambio
di casacca, per il quale soprattutto si adoperò il duca d'Alba Fernando Álvarez de Toledo (il viceré di Napoli che non esitò a muovere
contro Paolo IV) e del quale fu intermediario Cosimo de' Medici, rispetto a quella veneziana. E, decorato, ancora il 14 sett. 1557,
dell'ispanico Toson d'oro, un po' può pavoneggiarsi. E con il suo situarsi nel quadro della Corona di Spagna G. - pesantemente
condizionato nella politica interna nella misura in cui tante sue decisioni dovevano sottostare all'approvazione romana; e, a ogni buon
conto, egli stesso, prima di decidere, chiedeva il relativo permesso - faceva, in certo qual modo, della politica estera che un po'
alleggerisse l'onere dell'ubbidienza a ogni pontefice. Un po' meno vassallo della Chiesa G., nel dichiararsi servidor del re di Spagna.
.
Sul versante della gestione dello Stato non pare attribuibile a G. un sistematico disegno d'assieme. Da registrare piuttosto
provvedimenti in più direzioni all'insegna di una empiria ora dettata dal buon senso ora suggerita da orgoglio signorile, da un'altra
concezione di sé e del proprio onore, fermo restando che questo secondo aspetto è una costante esplicitata anche nel primo caso. Per
cui G. è per autodefinizione e per definizione dei sudditi "prencipe prudentissimo giustissimo et ottimo" - conseguentemente "per una
lingua", per voce unanime, da tutti i suoi "popoli chiamato padre dei suoi soggetti" - come recita il proemio dei capitoli, del 9 sett.
1555 dell'arte della lana a Urbino, materialmente redatti dal senese Antonio Capacci imposto da G. quale sovrintendente al Comune
della città.
Con perentorio interventismo G. dispose che la produzione fosse locale, essendo disdicevole che la capitale del Ducato l'acquistasse
da altri centri dello Stato o da città straniere. Trasformati, così, d'un tratto, i mercanti di lana urbinati - tenuti in sei mesi a smaltire le
giacenze di magazzino - in imprenditori della lavorazione in proprio, ricorrendo, all'occorrenza, anche a manodopera forestiera. E
riserbato, nel contempo, ai mercanti fattisi produttori il diritto esclusivo di vendita in città dei panni, laddove al contado era fatto
obbligo a far riferimento - per la collocazione della lana filata, del guado e di altri coloranti - esclusivamente a Urbino. E volendo
lavorare, tenuti i contadini a venire nella città a impiegarvisi nella fabbricazione di panni, "rascie", "saie"; concessa a quanti si
ostinassero a lavorare nei loro castelli solo la lavorazione di "panni bassi". E, una volta ottenuta da Pio IV, con bolla del 9 marzo
1564, facoltà, per il Collegio urbinate dei dottori, di laureare, G. ne approfittò per decretare, nel 1565, l'obbligo, per i sudditi aspiranti
alla laurea, di conseguirla a Urbino, ancorché la parvenza universitaria vi fosse fantasmatica; e vigente, naturalmente, il divieto di
laurearsi altrove. Propenso G. a imbrigliare i comportamenti; sicché, nel 1561, non gli bastò fissare in quattro classi la cittadinanza
eugubina; concesse soltanto alla prima, quella dei nobili, abbigliamento con stoffe preziose e uso dei gioielli. Trovava inoltre
preoccupante l'allargarsi, con le donazioni testamentarie, della proprietà ecclesiastica e depauperanti, per il Fisco, le esenzioni fiscali
di cui il clero godeva. G. cercò di contrastare e quello e queste. Ma dovette al consenso, del 1562, di Pio IV, il papa che il 14 febbr.
1561 lo fece cavaliere della milizia aurata, se poté procedere alla tassazione dei beni degli ecclesiastici di Gubbio in via di crescita sin
vistosa.
Oscillante l'atteggiamento di G. nei confronti degli ebrei; strattonato dalle esigenze dell'economia locale e dagli ordini della Chiesa,
sembra procedere contraddittoriamente quasi barcollando ora pencolando ora accodandosi alla persecuzione romana e, insieme, ai
rancori locali. Del 20 ott. 1548 un suo bando che proibiva agli ebrei di Pesaro il prestito a interesse. Del 6 nov. 1549 un altro suo
bando favorevole agli ebrei di Urbino. E tuttavia l'11 nov. 1553 decretò la confisca e la distruzione dei testi talmudici. Poi, nel 1555,
quando Paolo IV cacciò gli ebrei da Ancona, fu a Pesaro che parecchi di loro ripararono un minimo protetti da Guidubaldo. Però
questo era lo stesso che, il 6 ott. 1570, avrebbe emesso un bando contro la coabitazione per colpa della quale "una entrata medesima"
era occasione di conversazione e di familiarità tra "ebrei et cristiani". E fu ancora G. che, il 16 ag. 1571, espulse gli ebrei immigrati
"da tre o quattro anni in qua". Così si piegò alle insistenze di Pio V. Ma di tanta pieghevolezza un po' dovette vergognarsi - e
senz'altro gli dovette dispiacere espellere, nel 1558 coi marrani, Amato Lusitano che, peraltro, lo celebrò l'anno dopo come principe
giusto; e si dimostrò benevolo con i medici ebrei a più riprese -, se motivò l'espulsione quale sollecitudine di buon principe per i
propri sudditi, cui la concorrenza ebraica avrebbe tolto "il pane di mano". E, forse, per non continuare a intimamente vergognarsi, di lì
a poco, il 1° ottobre, vietò alla popolazione ingiurie e molestie agli ebrei. Troppo ricattabile da Roma, a ogni modo, G. - per cui se
disattesa a Pesaro la bolla, del 1566, di Pio V Romanus pontifex, dal momento che gli ebrei non vi vivevano in luogo separato e non
vi erano costretti ai berretti distintivi, ecco che, ciò denunciato dal visitatore apostolico Girolamo Ragazzoni, G. si affrettò, con bando
del 12 maggio 1574, a prendersela con l'"insolenza degli ebrei" e a imporre loro "il segno giallo" - per decidere in reale autonomia.
Era troppo congenitamente subalterno per non essere facilmente intimidibile, anche se - lungo il suo governo - la consistenza della
milizia ducale sale dai 6000 uomini riscontrabili nel primo '500, a 10-12.000 comandati da una sorta di stato maggiore formato da
quattro colonnelli. Ma, al di là di questo - sino a un certo punto a lui imputabile ché la ricattabilità e l'intimidibilità sono connotati
permanenti del suo stato, tratti costitutivi persistenti da G. ereditati e da G. trasmessi -, quel che, piuttosto, a G. va addebitata è la
sindrome dell'"onore", sin paralizzante a impostare lucidamente un meditato e lungimirante programma di buon governo o, per lo
meno, di governo efficiente. Ma alle faccende di Stato G. più che tanto non si dedicava.
Ancora ragazzo vuole un'armatura da parata. E ancora da quando è duca di Camerino sta dietro a Tiziano, lo tallona dappresso perché
dipinga per lui, anche se l'artista si fa sempre più caro, anche se tende - pur assicurando che quanto gli fa arrivare è, almeno
parzialmente, "di mano soa", profondendosi in autenticazioni di autografia - a rifilargli dipinti di bottega, come capita, nel 1573, con
la Madonna della Misericordia richiesta da Guidubaldo. In compenso è tutto di mano di F. Barocci "un quadretto da camera", con la
Vergine che, nella fuga in Egitto, si riposa, da G. commissionato. E protetto da G. il pittore Timoteo Viti; utilizzato da G. lo scultore
Tiziano Aspetti detto Minio. Merito precipuo di G. è avere costretto Michelangelo a ultimare la tomba monumentale di Giulio II, sia
pure con la rinuncia a che tre statue (in compenso aumentate a quattro) delle sei strapagate anni prima in anticipo allo scultore siano
da questo personalmente eseguite. È firmato da G., il 6 marzo 1542, il permesso del ricorso ad altro artista. Ma così sbloccata
l'inadempienza di Michelangelo vincolato, altresì, a sorvegliare l'altrui lavoro. È nella committenza che G. focalizza la propria
personalità. Animato dal "fare di quelle cose" che "ha sempre desiderato", attira artisti, recluta musici, va a caccia di strumenti,
promuove musiche e spettacoli, feste e apparati, recite e messe in scena. Propulsiva la consapevolezza che l'incoraggiamento e la
protezione di arti e lettere fanno lievitare la sua immagine, la proiettano ben oltre il peso specifico e il peso relativo cui - nel mero
terreno dei rapporti di forza politici economici militari - è, altrimenti, inchiodato. Piccolo, piccolissimo G. e in secondo piano nella
scena tutta ingombrata dal protagonismo di papi e sovrani. Ma non tanto minuscolo e, quanto meno anch'egli in primo piano in virtù
di una surrogatoria visibilità che, culturalmente, è tra le prime della penisola. La committenza artistica e musicale solleva G. agli
occhi dei contemporanei. Gli fanno da piedestallo le tante dediche in opere a stampa (di Aretino, di Francesco Sansovino, di Sperone
Speroni) e manoscritte (di Annibale Romei, di Gian Giacomo Leonardi, di Pietro Caetano) i tanti versi a lui indirizzati, gli elogi a lui
rivolti, le orazioni al suo cospetto pronunciate. Addirittura, nel prologo dell'Orazia d'Aretino, è la Fama a lodare G. e sin conteso e
disputato l'onore dei suoi favori, al punto che Anton Francesco Doni - proprio perché li avverte intercettati da Aretino - con questo
rompe clamorosamente. "Idol mio", G. per Aretino, deciso a non spartirlo con altri. "Qual più fido albergo oggi è tra noi?". Così la
domanda retorica di un giovanile sonetto di Torquato Tasso che non ancora ventenne a G. dedica Il Gierusalemme, primissimo
abbozzo del suo capolavoro ove ha modo di asserire che la "quercia d'auro", sua protettrice, è "spiegata a trionfar per l'Asia intorno" e
che il "gran Nilo" si inchina "al bel Metauro". Scontata la risposta: il "nido" ai raminghi lo offre la corte roverasca. Già cantata da suo
padre Bernardo in un'ode a G. la "cortesia" che l'ha accolto "cacciato". Per oltre due anni, dall'ottobre del 1556 a tutto il 1558,
Bernardo Tasso è signorilmente ospitato a Pesaro. Con agio vi ha finito l'Amadigi sottoponendo a G. "le stanze" concernenti la
"reputazion" sua e "de' suoi". Prestato il nome di G. a un valoroso capitano che figura nel poema. Questo l'autore lo stamperà a
Venezia, sempre memore di come, sballottato "nelle tempeste" della più dura "calamità", è stato "nel tranquillo porto raccolto dalla
liberalità e magnanimità" di Guidubaldo. È in atto - non senza enfatizzazione mitizzante; ma è ben per questo che G. gode, nella
penisola, di una nomea ulteriore rispetto al suo consistere di duca con modesto Ducato - la celebrazione della "gran quercia d'oro"
elargente "alimento, ombra e ristoro" alle "anime belle e di virtute amiche". Così Dionigi Atanagi, per il quale G. è il "signor placido e
benigno". Sotto il suo regno fioriscono "le buone arti" e "i nobili costumi", sono valorizzati "senno, fede e valor", muore "il vizio" e la
"virtù" splende. Esagerazioni incensatorie di un cortigiano turibolante, che peraltro preferirà di lì a poco trasferirsi a Venezia. Tuttavia
non cestinabili nella misura in cui documentano come - agli occhi di una intellettualità ondivaga e infelice o, quanto meno, per tale
lamentantesi - G. appaia appiglio salvifico, approdo sicuro, ancoraggio rasserenante. G. ai letterati - nell'accezione di gentiluomini
coltivanti le lettere e, pure, di uomini di lettere con tratti da gentiluomo - è venuto incontro effettivamente. E a quelli in difficoltà, in
angustie ha dato una mano. E i 50 scudi annui a Torquato Tasso studente a Bologna non sono certo spiaciuti. E il gruppo intellettuale Girolamo Muzio precettore dell'erede; Antonio Gallo; Giosico Netta; Vincenzo Bartoli; Lodovico Corradi; Federico Commandino;
Paolo Animuccia maestro di cappella; Pietro Bonaventura; Paolo Casale; Felice Paciotto; Marco Montano; Bernardo Cappello stazionato a corte più o meno a lungo non risulta insoddisfatto. Da chiedersi, invece, se ciò vale anche per i sudditi, per quanti hanno
avuto la fortuna - se si bada ai versi di Atanagi - di nascere nel Ducato e di vivere durante il governo di Guidubaldo. Di questo è
senz'altro scontenta Urbino, che da G., che la usa come dimora solo estiva, si sente e trascurata e fiscalmente pressata. G. non è
peraltro dimentico del palazzo ducale: ultimata, per lo meno, sotto di lui la sopraelevazione verso il prospetto orientale; e vari gli
interventi dello scultore e stuccatore Federico Brandani specie nella decorazione del sacello presso lo studiolo divenuto cappella di G.
e della stanza dell'appartamento degli ospiti in seguito chiamata, per via del soggiorno di Giacomo Stuart, stanza del re d'Inghilterra.
Tant'è che gli Urbinati chiamano G. "Guidobaldaccio". Essendo egli "povero" e del pari "poveri noi" abitanti d'Urbino - così riassume
la situazione un notabile locale processato per ribellione - "stavamo male insieme"; noi "avevamo bisogno di un principe che avesse
bisogno delle persone, non delle ricchezze" come Guidubaldo. Età aurea, nelle affabulazioni della memoria locale, quella federiciana.
"Al tempo del duca Federico si trionfava", si esultava, "perché era ricco". In effetti il duca feltresco, strapagato uomo d'armi, poteva
permettersi di non calcare troppo la leva fiscale.
Se ad Urbino l'antipatia per G. cresceva, non così avveniva a Pesaro, dove lo si chiamava "padre della patria". Laddove a Urbino a un
certo punto diminuì la cura per la stessa manutenzione del palazzo e la vita intellettuale si accontentava del costituirsi della locale
Accademia degli Assorditi, Pesaro, sotto G. e anche grazie a G. che decisamente, serbandole le funzioni di nuova capitale già
assegnatole dal padre, la privilegiava, fioriva: configurata esagonalmente dalle mura, vi aumentavano le attività, vi ferveva l'edilizia,
vi sorgevano chiese e palazzi, il porto aveva una vita promettente, e l'attorniavano ville teatro di amene villeggiature della nobiltà
locale con frequenti trattenimenti musicali. E ridondava a beneficio della città tutta la presenza della corte, non solo a palazzo ducale,
ma pure alla villa imperiale, sede di vita mondana e di soggiorni, anche invernali, di G. - a villa Miralfiore acquistata da G. e fatta
restaurare da Filippo Terzi, l'interprete della politica urbanistica di G. a Pesaro. Se G. spendeva più di quanto la situazione di cassa
concedesse, erano peraltro spese di cui Silvestro Gozzolini, in un Discorso del 1559-64 circa sottolineava la funzione, per Pesaro,
positiva.
Sin rigogliosa, per Gozzolini, Pesaro è: "piacevole e bella", c'è il "foro"; ci sono "offici"; ci son "mercadanti"; c'è il "monte da
prestare"; ci sono "i banchi hebrei", la "pescaria", la "zecca"; bisettimanale il mercato; ci sono "fondachi, merci et artefici"; c'è la
"scala del mare"; ma anzitutto, "primieramente" vanta "il palagio e la corte ducale", la quale "tira il denaro a sé da tutto lo stato"; e si
deve aggiungere che, specie nel 1555-59, è attiva la tipografia; si intensifica la produzione ceramistica, abbellita dall'impulso dato da
G. alla maiolica istoriata. Non così altrove, dove si avverte come vessatorio l'accentuarsi della pressione fiscale. Lungi da Pesaro G.
non è il principe benvoluto per il suo paterno governo, ma il duca esoso nelle inasprite sue pretese contributive. Durante il suo
governo - per esempio - l'entrata camerale eugubina sale da 3500 scudi annui a 6000. Naturalmente anche Pesaro subisce imposizioni,
dazi, prelievi. Solo che se G. - confortato dal consenso dell'aprile del 1552 di Giulio III - esige due bolognini per ogni collo di
mercanzia in entrata e in uscita, la città non protesta: comprende che il ricavato servirà alla costosa manutenzione del porto.
Preoccupante, nel 1571, la situazione delle finanze ducali: le entrate annue ammontavano a 45.690 scudi e le uscite a 54.290 scudi; di
8600 scudi il disavanzo annuo. Né alleggeriva l'esposizione debitoria la rendita annua di 10.000 scudi che competeva alla nuora di G.,
Lucrezia d'Este entrata solennemente a Pesaro il 9 genn. 1571. Non era una spesa accantonabile, rimandabile. L'"onore" gli imponeva
- se non altro a sgravio di "coscienza" - di onorare, appunto, i debiti, di "non far patire più tanti creditori". Ne conseguiva, per i "buoni
sudditi", così a essi si rivolse G. il 28 sett. 1572, il "debito" e l'"obbligo" di "aiutare nei bisogni i loro padroni". Forte delle larghissime
facoltà impositive concessegli, ancora nel 1562, da Pio IV, G. fece piombare su tutto il territorio, il 28 sett. 1572, la perentoria
imposizione del dazio di due bolognini per ogni soma di vino di due "barili", di un grosso per ogni staio di grano, di un quattrino per
ogni libbra di carne salata venduta, di un giulio per ogni maiale esportato, di uno scudo per ogni bestia grossa. Puniti, nel decreto, i
trasgressori con il pagamento del doppio della gabella dovuta, con il sequestro della merce, con la multa di 25 scudi da destinarsi metà
alla Camera, un quarto all'accusatore - con il che il decreto incentiva la delazione - e un quarto all'esecutore. Il provvedimento,
tassante generi di largo consumo quali il grano, il vino, la carne salata, i bovini e i suini, calò sui sudditi come un'improvvisa
grandinata.
La costernazione fu generale. E differenziata la reazione, pur nello scontento di tutti, più forte all'interno del Ducato che nei centri
costieri. Pesaro subisce anzi: vi è chi - come il gentiluomo e letterato pesarese Ludovico Agostini, che pure, nel 1560-62, è stato
personalmente danneggiato dalla requisizione di frantoi con cui G. aveva impoverito la sua famiglia - caldeggia la severità nella
punizione della disobbedienza. Gubbio mugugna rassegnata. Urbino, ferita nei suoi commerci, protesta a gran voce per l'offensivo
spregio dei privilegi a suo tempo concessi al Comune e ratificati dallo stesso Guidubaldo. Il municipalismo alza la testa contro il duca
dispotico. Il particolarismo si oppone alla logica uniformante di un accentramento appiattente. Contro il parere del luogotenente
Niccolò Tenaglia (che, nativo di Fossombrone, d'un tratto è percepito come elemento estraneo), il 26 dicembre il Consiglio cittadino
elegge una delegazione di 40 nobili che protesti direttamente con Gregorio XIII. Ma non si osa scavalcare immediatamente il duca.
Sicché la rappresentanza, il 27, si porta a Pesaro a sottoporgli le rimostranze di per sé indirizzate al pontefice.
G. si riservò di decidere e, intanto, inviò in tutta fretta a Urbino il conte di Montebello Antonio Stati a pubblicarvi un editto di
momentanea sospensione del decreto del 28 settembre. Quel che paventava era il dilagare della protesta. Mirava perciò a
circoscriverla a Urbino, sicché, anziché capeggiare una disobbedienza generalizzata, fosse in questa isolata. Diffidente Urbino della
dicitura "dazi sospesi". Li voleva aboliti. E contava sull'interessamento comprensivo dell'erede Francesco Maria. Sordo però G.
all'accenno del figlio aspirante mediatore. Rinviò la risposta e, intanto, preparò un corpo di spedizione contro Urbino che, a sua volta,
mentre Stati se ne andò ormai "ribelle", si accinse a resistere: serrate le porte, ammassati i viveri, distribuite armi. Così a fronteggiare
l'eventualità dell'assedio, non senza, per sventarla, spedire un'ambasciata a Gregorio XIII, che si limitò a un generico auspicio di pace.
Fatto, comunque, proprio l'invito pontificio, Urbino - non senza che così già iniziasse la smobilitazione - era disposta a ricevere, per
un colloquio di chiarimento, G. o il cardinale Giulio suo fratello. Arrivò, invece, il 29 genn. 1573, Vittoria la duchessa, e non già a
trattare ma a pretendere che la città si prosternasse.
A tale punto Urbino non si umilia. E Vittoria torna a Pesaro sdegnatissima. Ma svuotante, per la combattiva determinazione alla
resistenza della città motivata dalla convinzione di essere nel giusto, il breve papale del 7 febbraio ingiungente la deposizione delle
armi e, insieme, la supplica di perdono. Nel frattempo circondata da truppe e bloccata, Urbino non osa disubbidire al papa. Atterrita
dalla prospettiva del sacco, si arrende, mentre G. - a tutta prima limitandosi alla destituzione dei magistrati comunali -, avvolto da
impenetrabile silenzio, recita la parte della maestà offesa che muta assiste, da fuori, alle genuflessioni della città pentita. G. assapora
la vendetta e, insieme, la rimanda. Piantonata in albergo, a Pesaro, dai suoi sgherri la folta delegazione di nobili urbinati per tre giorni.
Quindi l'umiliarsi di questa prosternandosi in fila, due alla volta, prima di rientrare - non al completo; sei vengono trattenuti, rinchiusi
nella rocca Costanza e qui, senza processo, giustiziati - in una Urbino avvilita e tremebonda. In questa sono decapitati altri due nobili.
La vendetta continua a incrudelire. E il panico dilaga. Parecchi si danno alla fuga. E atterrate le case e confiscati i beni degli indiziati.
A questo punto G. ritiene di essersi adeguatamente vendicato. E, intascato da G. il dono propiziante di 20.000 ducati, a fine anno
un'altra delegazione urbinate può rientrare da Pesaro ad annunciare il perdono del duca. E ripristinati, allora, in una Urbino riportata
all'ordine, il Collegio dei dottori e il Consiglio, mentre non ricompaiono i disciolti Assorditi.
Sfiorato dal dubbio di star troppo infierendo, G., a ogni buon conto, aveva chiesto lumi a Roma. Approva, tutto sommato, il breve del
24 luglio 1573 di Gregorio XIII. Se aveva agito con rigore - lo rasserenò il papa - non l'aveva fatto per acrimonia vendicativa, ma per,
appunto, rigoroso senso di giustizia. E fu con la coscienza sgombra da rimorsi che - dopo essersi preoccupato a che il carnevale avesse
le sue recite nella corte pesarese: e rappresentata, in effetti, l'Aminta di Tasso e l'Erofilomachia di Sforza Oddi - G., il 14 giugno 1574,
gratificò Urbino della sua benevola presenza. Rientrato a Pesaro, vi cadde malato, sicché non poté - come avrebbe voluto - portarsi,
nel luglio, a omaggiare a Venezia o a Ferrara Enrico III, il nuovo re di Francia.
A Pesaro G. morì - come riferisce nel Diario il figlio Francesco Maria - di febbre, pare quartana, il 28 sett. 1574: solenni le esequie
seguite da sepoltura nella chiesa del Corpus Domini, come disposto da G. nel testamento per riaffermare la propria predilezione per
Pesaro.
Scontata, nell'orazione funebre di Iacopo Mazzoni, la celebrazione della sua figura. Ma se il figlio, nel succedergli, si sentì in dovere
di promettere il "buon governo" - e a prova dell'intento licenziò i ministri del padre taluno sin condannandolo -, è evidente che così
segnalò la volontà di prendere le distanze dal malgoverno paterno. E abolì, con editto del 13 ottobre, le gabelle e i dazi per cui questo
era divenuto odioso.
Fonti e Bibl.: Venezia, Biblioteca naz. Marciana, Mss. it., cl. VII, 164 (=7306): P. Gradenigo, Memorie del passaggio di… principi…,
c. 49; A. Brucioli, Dialogi della morale philosophia, Venetia 1544, cc. 69-78r; F. Sansovino, Del secretario, Venetia 1564, c. 99v (una
lettera di G. all'autore); Lettere di principi…, a cura di G. Ruscelli, I, Venetia 1570, cc. 175v-176r; J. Mazzoni, Oratio in funere G.…,
Pisauri 1574; F. Sansovino, Della origine et… fatti delle famiglie illustri…, Vinegia 1609, c. 103; B. Tasso, Delle lettere, Padova
1733-51, I, ad ind. e pp. 33 s.; II, ad ind. e pp. 237, 242-245, 338 s., 376, 443, 457; Cronache e storie inedite… di Perugia…, in Arch.
stor. italiano, XVI (1850-51), ad ind.; M. Sanuto, I diarii, XXVII, XXIX, XXXII, XLIII-XLVI, XLIX-LVII, Venezia 1890-1902, ad
ind.; I Libri commemoriali della Repubblica di Venezia, VI, a cura di R. Predelli, Venezia 1904, ad ind.; Relazioni degli ambasciatori
veneti, II, a cura di A. Segarizzi, Milano 1913, ad ind.; L. Agostini, La repubblica immaginaria, a cura di L. Firpo, Torino 1957, ad
ind.; A. Caro, Lettere familiari, a cura di A. Greco, Firenze 1957-61, ad ind.; L. Agostini, Esclamazioni a Dio, a cura di L. Firpo,
Bologna 1958, ad ind.; Nunziature di Savoia, I, a cura di F. Fonzi, Roma 1960, ad ind.; Nunziature di Napoli, I, a cura di P. Villani,
Roma 1962, ad ind.; Nunziature di Venezia, Roma 1960-77, II, V-VI, a cura di F. Gaeta; VIII-X, a cura di A. Stella; XI, a cura di A.
Buffardi, ad indices; L. Donà, Corrispondenza da Madrid, a cura di M. Brunetti - E. Vitale, Venezia-Roma 1963, ad ind.; Lettere del
Cinquecento, a cura di G.G. Ferrero, Torino 1967, ad ind.; F. Patrizi, Lettere ed opuscoli…, a cura di D. Aguzzi Bargagli, Firenze
1975, ad ind. (errato il rinvio alle pp. 77 s.); G. Muzio, Lettere, a cura di L. Borsetto, Bologna 1985, ad ind.; Lettere di, a, su Pietro
Aretino…, a cura di P. Larivaille, Nanterre 1989, ad ind.; Diario di Francesco Maria II Della Rovere, a cura di F. Sangiorgi, Urbino
1989, ad ind.; La cronaca perugina cinquecentesca di Giulio di Costantino, a cura di G. Rossetti - G. Scantoni, Spoleto 1992, ad ind.;
Storici e politici fiorentini del Cinquecento, a cura di A. Baiocchi - S. Albonico, Milano-Napoli 1994, ad ind.; P. Aretino, Lettere, a
cura di P. Procaccioli, Roma 1997-2002, ad ind.; A.F. Doni, Contra Aretinum…, a cura di P. Procaccioli, Manziana 1998, ad ind.; P.
Pellini, Della historia di Perugia (sec. XVI), III, Perugia 1970, pp. 554, 613, 768, 833, 882, 946, 967, 1123; A. Vernarecci,
Fossombrone dai tempi antichissimi ai nostri, II, Fossombrone 1914, pp. 294-341 passim; V.M. Cimarelli, Istorie dello Stato
d'Urbino, Brescia 1642, pp. 98, 114, 126; C. Lilii, Dell'historia di Camerino, Macerata 1652, pp. 295, 322-330, 334-337, 357; B.
Baldi, Memorie concernenti la città di Urbino, Roma 1724, pp. 55, 57, 65-67; G. Marini, Saggio di ragioni… di Sanleo…, Pesaro
1758, pp. 157 s.; R. Reposati, Della Zecca di Gubbio, II, Bologna 1773, ad ind.; A. Abbati Olivieri Giordani, Memorie di Novillara…,
Pesaro 1777, pp. 70-75; A. Lazzari, Vita di G.…, in Antichità picene, XXII, Pesaro 1794, pp. 76-82; Id., Discorsi dello Studio… e
degli uomini illustri d'Urbino, Fermo 1796, pp. 6, 29-38, 166, 243, 282, 295-297 e nell'aggiunta relativa a F. Paciotti, F.
Commandino…, alle pp. 3-79 passim; E.A. Cicogna, Delle inscrizioni veneziane, III-VI, Venezia 1824-53, ad indices; F. Ugolini,
Storia dei… duchi d'Urbino, II, Firenze 1859, ad ind.; C. Marcolini, Notizie… di Pesaro e Urbino…, Pesaro 1868, pp. 252, 284-317;
V. Rossi, Appunti… della musica alla corte di Francesco Maria e di G. …, Modena 1888 (estratto dalla Rassegna emiliana, I, 8); L.
Celli, Tasse e rivoluzione, Torino-Roma 1892; G. Scotoni, La giovinezza di Francesco Maria II e i ministri di G.…, Bologna 1896; G.
Luzzatto, I banchieri ebrei in Urbino…, Verona-Padova 1903, pp. 43 s., 52-54; Id., Per una storia economica delle Marche… 19021908, a cura di P. Giannotti, Urbino 1988, pp. 108-130; J. Dennistoun, Memoirs of the dukes of Urbino…, a cura di E. Hutton,
London 1909, ad ind.; G. Drei, La politica di Pio IV e… del card. Ercole Gonzaga…, in Arch. della R. Società romana di storiapatria,
XL (1917), pp. 69, 77, 79, 90-95, 111 s., 206, 225 n.; G. Menichetti, Firenze e Urbino…, in Atti e memorie della R. Dep. di storia
patria delle Marche, s. 4, IV (1927), pp. 251-259; G. Gronau, Documenti artistici urbinati, Firenze 1936, ad ind.; Archivo general de
Simancas, Papeles de Estado.Sicilia…, a cura di R. Redondo Magdaleno, Valladolid 1951, ad ind.; Genova…, a cura di R. Redondo
Magdaleno - A. González Vega, ibid. 1972, ad ind.; Estados pequeños de Italia, a cura di R. Redondo Magdaleno - A. González Vega,
ibid. 1978, ad ind.; E. Williamson, Bernardo Tasso, Roma 1951, pp. 112-116, 140; S. Caponetto, Due relazioni… al duca di Urbino
sugli avvenimenti romani dopo la morte di Paolo IV…, in Studia Oliveriana, I (1953), pp. 25-40; A. Brancati, Bernardo e Torquato
Tasso alla corte di G.…, ibid., pp. 63-75; J. Zicàri, G.… e lo stemma di Pesaro, ibid., pp. 93-101; L. Firpo, Lo Stato ideale della
Controriforma, Bari 1957, ad ind.; C. Ricottini Marsili-Libelli, A.F. Doni…, Firenze 1960, ad ind.; R. Paci, Politica ed economia in
un Comune del Ducato d'Urbino: Gubbio tra '500 e '600, Urbino 1966, pp. 25, 34 s., 65 s., 71, 73 s.; F. Sangiorgi, Sul G.… del
Bronzino, in Antichità viva, VIII (1969), 4, pp. 25-27; R. Pallucchini, Tiziano, I-II, Firenze 1969, ad ind.; O. Pinto, Nuptialia…,
Firenze 1971, ad ind.; L. Puppi, Michele Sanmicheli architetto di Verona, Padova 1971, pp. 85, 159 (relative a G. e non, come
erroneamente nell'indice dei nomi, al padre); Les écrivains et le pouvoir en Italie…, II, a cura di A. Rochon, Paris 1974, ad ind.; P.L.
Menichetti, Medici e speziali in Gubbio, Città di Castello 1974, pp. 67, 73; G. Padoan, Momenti del Rinascimento veneto, Padova
1978, ad ind.; Tiziano e Venezia, Vicenza 1980, ad ind.; Archivo general de Simancas, Titulos y privilegios de Nápoles…, I,
Onomástico, a cura di R. Redondo Magdaleno - A. González Vega, Valladolid 1980, ad ind.; L. Padoan Urban, Gli spettacoli urbani,
in Architettura e utopia nella Venezia del Cinquecento (catal.), Milano 1980, pp. 147-151; P. Larivaille, P. Aretino tra Rinascimento e
manierismo, Roma 1980, ad ind.; Carteggio universale di Cosimo I de' Medici. Inventario, Firenze 1982-2001, ad ind.; A. Daniele,
Capitoli tassiani, Padova 1983, ad ind.; G. Da Pozzo, L'ambigua armonia…, Firenze 1983, ad ind.; M. Moranti - L. Moranti, Le leggi
suntuarie… di Urbino…, in Atti e memorie della Deputazione di storia patria delle Marche, LXXXVIII (1983), pp. 141 s., 145-151,
168-170; Il palazzo di Federico da Montefeltro, a cura di M.L. Polichetti, Urbino 1985, specie pp. 65-90; C. Cairns, Pietro Aretino
and… Venice…, Firenze 1985, ad ind.; Federico di Montefeltro: lo Stato, le arti, la cultura, a cura di G. Cerboni Baiardi - G.
Chittolini - P. Floriani, Roma 1986, ad ind.; L. Benevolo - P. Boninsegna, Urbino, Roma-Bari 1986, ad ind.; Archivo general de
Simancas, Consejo de Juntas…, I, a cura di M. Cuartas Rivero, Madrid 1987, s.v.Urbino; "Familia" del principe…, a cura di C.
Mozzarelli, Roma 1988, ad ind.; E. Gamba - V. Montebelli, Le scienze a Urbino…, Urbino 1988, ad ind.; B. Brumana, Tecnica
policorale nel repertorio… della cattedrale di Gubbio, in Storici, filosofi e cultura… a Gubbio…, a cura di P. Castelli - G. Pellegrini,
Spoleto 1988, pp. 603-606; C. Fiocco - G. Gherardi, Ceramiche umbre…, Faenza 1988-89, ad ind.; Sperone Speroni, Padova 1989, ad
ind.; S. Eiche, Juli 1547 in palazzo Farnese, in Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, XXXIII (1989), pp. 395-401;
Il libro di poesia…, a cura di M. Santagata - A. Quondam, Modena 1989, ad ind.; F. Negroni, Piazze del Rinascimento… in Urbino,
in Notizie da palazzo Albani, XIX (1990), 2, pp. 31-44; Tiziano (catal.), Venezia 1990, pp. 18, 20, 24, 81, 409 s., 414; Lettere italiane.
Indice trentennale, a cura di N. Giannetto, Firenze 1991, ad ind.; M.C. Clementi, La Cappella musicale del duomo di Gubbio…,
Perugia 1994, ad ind.; Michele Sanmicheli…, a cura di H. Burns - C.L. Frommel - L. Puppi, Milano 1995, ad ind.; Pesaro, I-III,
Venezia 1995-2001, ad ind.; M. Casini, I gesti del principe: cerimonie e rituali del potere politico a Venezia e Firenze nel Cinquecento
(1530-1609), Venezia 1996, ad ind.; F. Piperno, G. … la musica…, in Il Saggiatore musicale, IV (1997), pp. 249-270; P.D.
Napolitani, Le edizioni dei classici. Commandino e Maurolico, in Torquato Tasso e l'università, a cura di W. Moretti - L. Pepe,
Firenze 1997, pp. 124 s., 128 s.; P. Larivaille, Pietro Aretino, Roma 1997, ad ind.; R. Goffen, Titian's women, New Haven-London
1997, ad ind.; A. Daniele, Nuovi capitoli tassiani, Padova 1998, ad ind.; B. Levergeois, L'Arétin, Paris 1999, ad ind.; F. Piperno,
Diplomacy and musical patronage…, in Early Music History, XVIII (1999), pp. 259-285; Il merito e la cortesia. Torquato Tasso e la
corte dei Della Rovere…, a cura di G. Ardizzoni et al., Ancona 1999, passim; Torquato Tasso e la cultura estense, a cura di G.
Venturi, Firenze 1999, ad ind.; Gli ultimi Della Rovere. Il crepuscolo del Ducato di Urbino: in occasione di due importanti acquisti, a
cura di P. Dal Poggetto - B. Montevecchi, Urbino 2000, pp. 25 s., 65, 68, 92; A. Toffoli, La Tipocosmia di A. Citolini, in Atti e
memorie dell'Ateneo di Treviso, n.s., XVIII (2000-01), pp. 210 s.; F. Piperno, L'immagine del duca…, Firenze 2001; E. Graziosi,
Aminta… Amore e matrimonio in casa d'Este, Pisa 2001, ad ind.; D. Sogliani, Le collezioni Gonzaga…, Cinisello Balsamo 2002, ad
ind.; A. Forcellino, Michelangelo Buonarroti: storia di una passione eretica, Torino 2002, ad ind.; R. Hatfield, The wealth of
Michelangelo, Roma 2002, ad ind.; S. Ricci, Il sommo inquisitore: Giulio Antonio Santori… (1532-1602), Roma 2002, ad indicem.
Agnolo Bronzino, Ritratto dell'ammiraglio Andrea Doria come Nettuno. Pinacoteca di Brera a Milano. 1540-1550 ca.
Doria, Andrea
(1466 - 1560)
Dizionario Biografico degli Italiani
di EE. Grendi
Portrait of Andrea Doria, c. 1520, by Sebastiano del Piombo
DORIA, Andrea. - Nacque a Oneglia il 30 nov. 1466. Il casato era illustre, ma distintamente feudale, di mediocrissima fortuna. Il
padre Ceva aveva sposato Caracosa dei Doria di Dolceacqua. Indubbiamente le acquisizioni territoriali dei Doria non avevano avuto
la rilevanza di quelle dei Fieschi e degli Spinola di Luccoli che gestivano centri appenninici di grande rilevanza strategica: nulla
sappiamo dell'effettiva coesione del gentilizio (Doria di S. Matteo e Doria dei feudi) che si era consolidato all'inizio del Trecento e
aveva formato "albergo" unificando i blasoni. C'era una forte tradizione del casato nell'armamento navale militare (Meloria, Curzola,
Tenedo) ma non fu questa la strada che si offerse al giovane D., e neppure la tonsura o la mercatura. I "feudali" erano del resto i
parenti poveri, né probabilmente erano forti le ragioni della colleganza come nel caso dei Fieschi, già alla testa di un forte Stato
territoriale con forti posizioni nella Curia romana: un'influenza in declino eppur in grado di organizzare nella splendida dimora di via
Lata un centro di vita cosmopolita che sarà unico nella Genova del primo Cinquecento. Gli stessi Grimaldi, corsari a Monaco, erano
pienamente inseriti nella vita economica europea tramite il controllo delle allumerie di Tolfa. Ed è a questa Roma dei Fieschi e dei
Grimaldi che approda il D. nel 1484, orfano diciottenne e senza titolo giacché la madre prima di morire ha ceduto i suoi "carati" del
feudo onegliese al cugino Gian Domenico.
Gian Domenico, tramite i buoni uffici dei Cibo (Innocenzo VIII), imparentati coi Doria, e di Nicolò Doria, capitano al servizio del
papa, riuscì a ottenere per il D. un posto in quel corpo militare.
Succeduto al pontificato Alessandro VI (1492), il D. "fu costretto a pigliar nuovi partiti ai casi suoi" (Sigonio): fu a Urbino presso
Guidubaldo (e non Federico, come scrive il non sempre esatto Sigonio) da Montefeltro e poi a Napoli, dove gli fu data "una piazza
d'uomini d'arme". Liberato dagli incarichi per la fuga di re Alfonso dinnanzi a Carlo VIII (1495), il D., dopo un viaggio in Terrasanta,
si presentò con 26 balestrieri a cavallo pagati per tre mesi a Giovanni Della Rovere, prefetto dell'Urbe, che gli assegnò la difesa di
Rocca Guglielma presso il Liri, contro le milizie spagnole di Gonzalo Fernandez de Cordoba.
Qui la narrazione del Sigonio assume un colore cavalleresco: la valorosa difesa, l'ammirazione e lo scambio di cortesie con Gonzalo,
la fedeltà ai Della Rovere che lo mandarono in missione presso Luigi XII di Francia. Tutore del figlio e protettore della vedova del
Della Rovere, il D. sarebbe riuscito a giocare d'astuzia lo stesso duca Valentino a Senigallia e a sventare i piani di Giuliano Della
Rovere (poi Giulio II) che ambiva impossessarsi dei castelli del fratello defunto.
Ancora privo di mezzi, il D. accettò l'invito del Banco di S. Giorgio e si arruolò nella condotta di Nicolò Doria contro Ranuccio Della
Rocca, ribelle in Corsica. Nel 1507, mettendo a frutto il nuovo favore dei nobili genovesi (esiliati durante il dogato popolare di Paolo
da Novi) cui fu prodigo di efficaci consigli, il D. ebbe una condotta per sé contro lo stesso Ranuccio: con 200 fanti e 40 cavalieri
invase lo Stato dei Della Rocca, bruciò, imprigionò e uccise, sicché Ranuccio, appoggiato dalla Francia, si salvò solo attraverso un
salvacondotto rilasciatogli dal Banco. Fondamentale fu questa saldatura con interessi genovesi che lo portò ad allearsi coi Fregoso e,
forse per la mediazione di Nicolò tornato a comandare le truppe papali, con la politica della Lega santa di Giulio II. Era del resto la
politica dei Doria alleati dei Fregoso e avversi ai Francesi: partecipò così alla spedizione del Contarini contro Genova e con Giano
Fregoso rimise piede in città nel giugno 1512, prese parte all'assedio del Castelletto e nell'ottobre assunse l'incarico dell'allestimento
di due galere.
Il 6 marzo 1513, seguendo ancora una volta Nicolò Doria, che, dimesso da Roma, aveva assunto il comando di una flotta genovese a
tutela della navigazione, entrò al servizio della Repubblica come capitano delle due galere da lui fatte costruire. Ferito nell'azione
guidata da Emanuele Cavallo per impedìre che la fortezza della Lanterna, tenuta dai Francesi, fosse adeguatamente approvvigionata,
riprese il mare dopo un mese: 950 lire al mese per ciascuna delle galere (una metà dello stipendio da riscuotere a sue spese per una
tassa posta sulle Riviere protette dalle sue navi), onere suo il provvedersi di salnitri e palle di cannone, regolata la spartizione del
bottino di guerra.
Fu il peggior contratto che avesse mai firmato e dovette esibire i suoi garanti. Dopo che Adorno, Fieschi e Francesi ebbero rioccupato
temporaneamente Genova, il 17 giugno tornarono i Fregoso che con Ottaviano tennero la città fino al sacco del 1522 perpetrato
dall'alleanza ispano-pontificia che restituì il dogato agli Adorno. Nel frattempo Ottaviano aveva clamorosamente invertito le alleanze
ed era divenuto governatore per il re di Francia.
La strategia dei Fregoso concedeva ampio spazio all'iniziativa navale e non solo per difendersi dai tradizionali nemici, ma anche per
contrastare l'intensificata presenza turco-barbaresca nel Mediterraneo.
Sotto il comando di Federico Fregoso, il D. aveva preso parte alla spedizione di Biserta contro il pirata Cotorgoli: poi, sempre nel
1516, proprietario di tre galere, aveva firmato un contratto con Ottaviano che gli riconosceva i pieni frutti della guerra di corsa. Ed è
questa la direzione verso la quale si orientò sempre più l'attività militare del D. che nel 1519 Poté riportare alla Pianosa una vittoria
importante e lucrosa con la cattura di Gad Alì.
Intanto Khair ad-dīn Barbarossa di Algeri era stato riconosciuto da Selim come luogotenente generale dell'Impero osmano in Africa e
questa saldatura nel Mediterraneo delle forze turco-berbere evidenziava appieno ai sovrani europei l'importanza fondamentale del
potere navale nel quadro delle rivalità italiane. Sconfitti i Fregoso, il D. offrì i suoi servizi al re di Francia e ai suoi alleati e questa
opzione politica durò fino al 30 giugno 1528, anche nel periodo in cui il D. fu al soldo di Clemente VII (1526-27).
Questo significa che le sue operazioni navali erano in buona parte vincolate a operazioni militari complessive nell'area mediterranea:
in difesa di Marsiglia, contro la flotta imperiale di Ugo de Moncada, contro Genova, contro Napoli. Ciò non vietava colpi occasionali
contro le navi spagnole e barbaresche, ma implicava una pluralità di comandi e la subordinazione a una direzione superiore. Era un
tipico difetto dell'azione militare cristiana nel Mediterraneo, più spesso azione di forze alleate che occorreva radunare e conciliare in
una difficile unità di obiettivi. Già sotto Francesco I balzarono in chiara luce questi difetti di coordinamento, motivazioni politiche
diverse, difformità di valutazioni militari, materia di contrasto che finì per compromettere la posizione del D. alla corte di Francia. In
particolare la questione del diritto del corsaro al beneficio del riscatto dei prigionieri fu materia di ampia contestazione: Francesco I
esigeva la consegna dei prigionieri di riguardo e non pagava. Il re aveva scarsa comprensione per il carattere mercantile del servizio
del Doria.
In realtà l'unico scontro navale di un qualche rilievo fu la battaglia di Capo d'Orso (Paestum) nell'aprile 1528, quando otto galere
guidate da Filippo (Filippino) Doria sconfissero sei galere del Moncada che fu ucciso in battaglia. La vittoria tuttavia non ebbe
conseguenze politiche: Napoli fu salva e per le diffidenze dei Veneziani e per il disimpegno del Doria che aveva preferito rimanere a
Genova, riconquistata ai Francesi nell'agosto 1527.
Fin dal 1525 Carlo V aveva cercato di stornare il D. dall'alleanza antimperiale. Il cancelliere M. Arborio marchese di Gattinara fu
tenace assertore di questa esigenza politico-militare presso l'imperatore: il D. e Genova erano elementi decisivi nel rapporto di forza
militare. Il mare in mano ai Francesi comprometteva gli approvvigionamenti spagnolì. Francesco I aveva nominato il D. suo
luogotenente nel Mediterraneo e lo aveva insignito dei cavalierato di S. Michele. Rimanevano però antiche e nuove pendenze: i crediti
del D., la questione di Savona, l'opposizione all'"Unione" cittadina secondo il programma dei Dodici riformatori, pur particolarmente
attivi sotto il governatore T. Trivulzio. Fu proprio la prontezza imperiale a sciogliere questi nodi che indusse il D. ad accantonare gli
ultimi dubbi. Così come dal punto di vista del D., anche dal punto di vista imperiale l'opzione dell'ammiraglio era vista come omologa
dell'opzione di Genova.
La carriera del D. segui davvicino quella di Nicolò Doria ed entrambe si iscrivono nell'ambito di influenza della politica pontificia:
Ottaviano Fregoso era un protetto di Leone X. E tuttavia decisivi per le fortune del D. furono i contatti presi con gruppi politici
genovesi a partire dal 1506: furono questi con qualche importante appoggio economico che gli aprirono la carriera del mare.
L'opzione per questo tipo di imprenditoria militare aveva certamente delle motivazioni mercantili (guerra di corsa, stipendi). Tuttavia,
almeno fin dalla missione presso Luigi XII del 507, il D. coltivò tenacemente il proprio ruolo politico: la scelta della dimora a Fassolo
fu compiuta già nel 1521 quando non aveva che quattro galere. Per quanto avesse reclutato persone del casato, vi è qualche
testimonianza che il voltafaccia del '28 avesse causato in esso dei malumori: i Fregoso rimanevano esiliati e ostili alla Repubblica
"ispanizzata". E tuttavia la risoluzione del 1528 aveva segnato il pieno sequestro "personale" del mito antico dell'"Unione" ravvivato
come non mai dall'opera dei "riformatori".
La gestazione della riforma costituzionale del 1528 è ancora avvolta in molte oscurità, cosi come in generale il quadro sociopolitico
urbano fra Quattro e Cinquecento. La "rivolta delle capette" - il dogato del tintore Paolo da Novi (1506) - può esser letta come
l'anticlimax della serrata del '28 e della nuova costituzione aristocratica. Tuttavia il quadro da dipanare e ben altrimenti ricco. Fin
dagli ultimi decenni del Quattrocento ci sono ampie testimonianze di un movimento di giovani, associati fuori della solidarietà degli
"alberghi", che esprimono nel titolo delle loro società l'aspirazione alla unione e alla concordia, proprio mentre enfatizzano la
concorrenza cerimoniale fra nobili e popolari compartecipi del governo genovese. Sono poi molto probabili i legami della compagnia
dei giovani del Divino Amore, radicalmente novatrice della carità nei primi decenni del Cinquecento, con gli ambienti umanistici in
cui si fece strada, attorno a Ottaviano Fregoso, il progetto della Riforma. Il D., che non era certo un umanista, non fece che secondare
un progetto lungamente in gestazione, dandogli lo sbocco della indipendenza.
Enorme dovette essere il prestigio derivante dalla realizzazione di quel lungo mito dell'Unione secolarmente frustrato nella città
divisa. L'"Unione" fu un'operazione politica conservatrice: non una restaurazione del Comune originario gestito in forma senatoria dai
maggiorenti, ma una Repubblica aristocratica che definiva una volta per tutte i quadri della civilitas come l'insieme delle famiglie di
coloro, di parte nobile e popolare, che avessero ricoperto le cariche politiche maggiori prima del 1506. Nasceva così la moderna
nobiltà genovese col suo "Libro d'oro", una nobiltà caratteristicamente "politica", proclamata classe con diritto esclusivo alle cariche
repubblicane. Si trattava di un sottile ricalco della costituzione politica del Banco di S. Giorgio ove la selezione e le differenziazioni
erano fra luoghisti comunque e classi di luoghisti, cioè di detentori dei titoli del debito pubblico.
La soluzione istituzionale seguiva una logica appropriata: incremento delle strutture rappresentative (i Consigli) con funzioni elettive,
consultive e talora anche deliberative; collegializzazione del potere del doge fatto pari ai senatori affiancati dai procuratori: i
serenissimi Collegi; istituzione di una suprema magistratura di controllo, i Supremi sindacatori, il cui sindacato era a sua volta
giudicato dal Consiglio minore. Ed è qui che il D. scelse di collocarsi nel 1528 come membro a vita del Collegio dei supremi
sindacatori: con lui Sinibaldo Fieschi e altri tre nobili "vecchi", certamente non "a vita". La scelta è significativa come scelta
d'intenzione. In ogni caso più dei fattori e dei ruoli istituzionali continuarono a contare quelli personali. La presenza di un tradizionale
avversario come il Fieschi testimonia dell'unanimismo di facciata del 1528, ma in effetti è necessario rintracciare la formazione e la
presenza di un "partito del Doria". La formidabile posizione dell'ammiraglio e l'indipendenza formale del governo comportavano un
certo dualismo: la Repubblica e il luogotenente imperiale ci appaiono come due corpi politici diversi e in ogni caso due centri distinti
di iniziativa politico-diplomatica.
Ma l'asimmetria era netta e qualificata dal ruolo di mediazione esclusiva fra la Repubblica e l'Impero che l'asiento del 1528
riconosceva all'ammiraglio. Materia del contratto infatti non erano soltanto questioni di stipendi, di assicurazione sulla regolarità
bimestrale dei pagamenti, del placet imperiale alla guerra di corsa, ma anche il riconoscimento della preminenza genovese su Savona
e dell'indipendenza della Repubblica sotto la sovranità nominale dell'imperatore. Successivamente il D. otteneva il titolo di capitano
generale dell'armata imperiale marittima (26 agosto) e, latore il nuovo ambasciatore G. Suárez de Figueroa, garanzie
sull'approvvigionamento granario dalla Sicilia (per le galee e la città) e il riconoscimento di un ruolo di mediazione per gli asiento de
dineros che Carlo V avrebbe negoziato con gli uomini di negozio genovesi. Il D. era così posto nella condizione magnanima e
prestigiosa di offrire la libertà alla Repubblica sostanziando questo atto con la demolizione della fortezza del Casteltetto, simbolo del
dominio straniero. I primi capitoli dell'asiento del1528 guidano l'iniziativa diplomatica genovese, i temi della libertà e
dell'indipendenza della Repubblica ne sono la base ispiratrice, integrata più tardi dal tema classico della neutralità.
Questo consenti ai Collegi di presentarsi su tale piano sia pure formale come liberi dal riferimento troppo ovvio alla personalità
dominante dell'asientista che del resto non era giuridicamente riconosciuta come tale. Le preoccupazioni dello Stato mercantile (non
compromettere gli interessi esteri), la stessa formula di darsi in signoria personale a un principe straniero, soluzioni di difesa e di
compromesso, si evolvevano in programma politico-diplomatico di una personalità statuale autonoma che vedeva riconosciuto il suo
rango negli accordi internazionali. Mito diplomatico? E possibile: ma questo è appunto il livello operativo del gioco politico, quello
delle formulazioni giuridiche. L'interlocutore non può appellarsi alla sostanza delle cose e la sostanza non v'è dubbio era quella di un
governo strettamente condizionato dalla volontà del D. che agiva d'accordo con lui e che, lui assente, era tenuto a inviargli
circostanziate relazioni. L'asimmetria risulta evidente sul terreno cerimoniale. Non v'è dubbio che il cerimoniale privato e quindi il
prestigio del principe era clamorosamente esaltato dalla sua preminenza nei rapporti con la corte e i governatori spagnoli, ricevuti
sistematicamente nel palazzo di Fassolo. Da questo punto di vista il D. non faceva che portare a compimento, esemplificare nel modo
più brillante e assoluto, una costante della storia politica genovese: quella di una tradizione di cerimoniale privato in concorrenza
vittoriosa con lo sviluppo, promosso e insieme bloccato, di un cerimoniale pubblico.
Il segno più vistoso della supremazia doriana è da individuare nelle vicende del palazzo di Fassolo, un sito già scelto nel 1521 e la
prima fase dei lavori conclusa già nel 1529. Il palazzo doveva crescere per un secolo: moltiplicarsi le fabbriche, i porticati, gli
affreschi, le decorazioni, i giardini. Il corsaro poteva secondare i suoi gusti, formatisi nella giovinezza romana: come i Gonzaga
avevano chiamato a Mantova Giulio Romano, egli chiamò Pietro Buonaccorsi (Perin del Vaga), anch'egli un discepolo di Raffaello,
che lavorò a Fassolo fra il 1528 e il '36. Non vi fu unità organica nella costruzione architettonica: da un'iniziale massa squadrata, quasi
di fortezza, si sviluppò - tramite espansione della linea orizzontale in armonia con lo spazio e la natura circostante - la villa
cinquecentesca d'ispirazione rinascimentale.
Così il D. offriva un modello nuovo alla classe dirigente genovese: l'immagine di un reggente illuminato e umanista che s'adoperava a
trasformare il cantiere di Fassolo in un'occasione culturale internazionale rompendo decisamente con gli schemi tradizionali della
conimittenza genovese. Il contraltare era il palazzo Fieschi di via Lata, anch'esso dotato di accesso al mare. Ma la decorazione di
Fassolo esprimeva decisamente nella figurazione mitologico-storica l'incomparabile posizione di potere e prestigio del residente e,
nello stesso linguaggio artistico, la dimensione internazionale della corte doriana che ospitò Carlo V (1533), Paolo III, e il futuro
Filippo II (1548): principi, generali, ambasciatori e artisti di fama europea.
Fu un episodio unico nella storia di Genova, quello di una dimora regale, di una corte internazionale, espressioni del ruolo eccezionale
del principe, signore di Genova e luogotenente di Carlo V. Il linguaggio pittorico e decorativo ne esprimeva il programma politico con
la caratteristica enfasi retorica della celebrazione di un apogeo, i trionfi del D. e di Carlo V posti sul medesimo piano. In particolare
l'iconografia del Doria-Nettuno si affermava in Genova e fuori Genova ora nell'accentuazione mitologica, ora in quella realistica, a
seconda delle esigenze.
Non v'è dubbio che la società genovese, nobile e popolare, recepisse questo messaggio. Il prestigio personale era chiaramente un
instrumentum regni e il D. ne aveva coscienza.
Egli prendeva cura di ospitare alla sua corte i nobili genovesi, a cominciare dai figli di Sinibaldo Fieschi. Conviti, intrattenimenti
musicali, giostre e tornei, gioco della palla: il rampollo della nobile casata genovese poteva aver la ventura di conversare con i principi
d'Italia e dell'Impero, di giocare a palla col marchese di Pescara, gran generale di Carlo V. Naturalmente il vecchio ammiraglio si
costruì anche la famiglia che non aveva, giacché il suo matrimonio con Peretta De Mari (Usodimare), vedova Del Carretto, era
rimasto sterile. Ma non mancavano i figli di primo letto di Peretta: il D. adottò Marc'Antonio, nominato nel '34 erede del principato di
Melfi e andato sposo alla figlia di don Giovanni de Leyva. Nominò poi suo luogotenente imperiale, ed erede, Giannettino Doria, figlio
di Tomaso, suo cugino di primo grado.
La serie degli onori e dei titoli aumentava continuamente: cavaliere di S. Michele, principe di Melfi (con rendita di 3.000 scudi),
cavaliere del Toson d'oro, duca di Tursi, protonotaro di Napoli. Si aggiungano le prestigiose relazioni personali: non mancavano
davvero le possibilità per l'esercizio di un efficace patronato.
La straordinaria ascesa sociale e politica dei Barbarossa e dei Dragut è stata posta in connessione con le fortune della pirateria, la
pirateria "mondo americano" come ha scritto Braudel. Il "norne" chiaramente distingueva il D. da quegli ammiragli barbareschi e quel
nome fu certamente un prezioso strumento politico per l'inserimento nei quadri della vecchia nobiltà genovese. In ogni caso del tutto
eccezionale fu la fortuna che gli concesse d'imporsi su quell'aristocrazia avviata verso uno strepitoso ruolo di egemonia sulla finanza
europea e pronta a prender ispirazione da Fassolo nella splendida vicenda architettonica di strada Nuova.
A Fassolo i segni della eccezionalità, l'isolamento e il fasto si sposavano con l'ubicazione strategica, lontano dalle risse cittadine,
vicino alle sue galere. Figueroa, il maggior conoscitore spagnolo delle cose di Genova, poteva ancora sostenere nel 1559 che il
comando delle galere rappresentava la chiave di volta della situazione politica genovese. Indubbiamente questa era stata l'intuizione
fondamentale del Doria. E nondimeno quello stuolo di galere doveva esser redditizio: la crescita delle entrate era necessaria a
sostenere il carisma.
Accanto al D. spicca la figura di uno straordinario mercante e banchiere, Adamo Centurione, che appare come l'attento gestore degli
affari del D.: un'impresa quella dell'asientode galeras che richiedeva spese ingenti, anticipazioni di danaro, sollecitazioni e
trasferimenti dei pagamenti. Verso il 1540-50 Francesco Lomellini e i suoi fratelli appaiono come gli abituali fornitori di biscotto per
le galere, Francesco Grimaldi fornitore di tela e carne, ma Adamo deve firmare tutte le cedole relative.
In un'occasione almeno fu inviato a discutere con l'imperatore i termini del nuovo contratto di asiento. Sitrattava di un'azienda come
un'altra e non v'è dubbio che il D. la considerasse come tale: il D. come altri suoi contemporanei "ammiragli", un Barbarossa, un
Paolo Vettori, uno Strozzi. Come ogni altro mestiere poi questo dell'imprenditore di guerra comportava una logica, le regole di un
gioco, un gioco singolare fra corsa e guerra, della cui natura il D. era perfettamente consapevole.
Le entrate, cioè i pagamenti di Carlo V, erano stabilite come anticipi, ma a rate brevi e certamente non corrispondenti alla dinamica
della spesa. A probabile che l'imperatore assegnasse carattere di priorità a questi pagamenti: le difficoltà per il D. erano piuttosto
quelle poste dalle esportazioni di numerario dalla Spagna. Nel 1552, ad esempio, l'ammiraglio lamentava che dei 123.000 ducati
pattuiti egli riusciva a rimborsarne soltanto 96.170.
La struttura della spesa si articolava nelle voci: corpo della nave, cioè costi dello scafo e dell'armamento coi relativi tempi di
ammortamento, e costi di riparazione e sostituzione più il mantenimento, cioè il soldo pagato a marinai e "buonavoglia" e il vitto
necessario a tutti. Nel caso di impiego di schiavi al remo l'acquisto degli stessi comportava un massiccio investimento. I rematori
potevano comunque esser razziati o ottenuti come preda di guerra, mentre i forzati potevano esser ottenuti per la benevolenza di
qualche sovrano fin dalla lontana Ungheria.
La galera, lunga e sottile, non più di 3.000 cantari di portata, raccoglieva a bordo 250-300 uomini e più (a seconda del carico di
soldati) in 250 mq: il nucleo prevalente era composto dai rematori disposti a 3 0 4 per banco per 3 0 4 remi, poi un remo solo col
successo, tardo, del sistema "alla galozza". Questi rematori, 150-170, erano sulle galere del D. soprattutto schiavi. A metà secolo uno
schiavo poteva valere 40 scudi per un totale di 6.000 0 7.000 scudi mentre un buonavoglia era pagato 6 lire al mese, cioè 13 scudi
all'anno (7-8 mensilità): 170 costavano così 2.200 scudi all'anno. Bastava quindi che un rematore schiavo vogasse per tre anni e la
preferenzialità economica del suo impiego era assicurata. Inoltre poteva non costare nulla: per i forzati si raccomandava di non
accettarne se non fra i condannati a più di sei anni.
L'incidenza dei costo-nave non era elevata: lo scafo rappresentava il 40-50% di un costo complessivo dato nel 1552 a 1.600 scudi.
Calcoli di poco successivi stimano il rapporto fra costo dell'imbarcazione armata e costo della ciurma schiava a un terzo verso due
terzi: la nostra valutazione abbassa ulteriormente l'incidenza della prima voce di costo. In ogni caso s'aggiungeva alla seconda voce il
pagamento del soldo, per prodieri, nocchieri, artigiani, "uomini di cavo" e i costi del vitto per tutti sicché il costo del mantenimento
era valutabile a 3.000-3.500 scudi. A metà secolo quindi l'incidenza delle tre voci di costo - armamento, schiavi e mantenimento - era
rispettivamente del 14, 54 e 31%. Ma le prime due voci vanno frazionate nel bilancio annuale secondo un quoziente dato dal tempo di
ammortamento. La galera poteva reggere il mare 4 0 5 anni: calcoliamo così 320 scudi all'anno. Più aleatoria la durata dello schiavo al
remo: se calcoliamo una media di dieci anni avremo 600-700 scudi all'anno. In totale quindi 1.000 scudi, cosicché il costo prevalente
appare nel bilancio annuale quello del matenimento (il 75%). Rispetto a un costo annuo di 4.000-4.500 scudi abbiamo un pagamento
che nell'asiento del 1528 si poneva già al di sopra: 5.000 scudi e non più di 6.000 alla metà del secolo. Il margine era dunque di 1.500
scudi per galera (massimo 2.000). Le difficoltà di estrarre il numerario dalla Spagna appaiono così decisive per l'equilibrio economico
dell'azienda. Questa era cresciuta rigogliosamente: dodici galere nel 1528, quindici nel 1530, diciassette in azione a Tunisi nel '35,
ventidue nel '38 alla Prevesa e nel '41 ad Algeri, venti nel 1547 e nel '52: diciamo un "esercito" di 6.000 marinai e rematori, un
capitale di 150.000 scudi. Osserviamo che nella Genova della metà del secolo solo quattro cittadini erano accreditati di una fortuna
superiore alle 300.000 lire.
Il "teorico" capitale del D. dava un reddito, sempre teorico, del 20%: un buon investimento si direbbe, ma, in un'epoca in cui gli
operatori economici erano soliti variare i propri investimenti, quello del D. era un investimento di capitale eccezionalmente univoco e
in un settore esposto ai temporali, ai pirati, alle flotte nemiche e in ogni caso governato dall'esterno, cioè dall'iniziativa politica
dell'imperatore.
Quanto tempo gli era lasciato per la favorita guerra di corsa o per qualche prezioso carico di seta e d'argento da prendere a nolo?
Trasporto di soldati, di principi, di sovrani; pattugliamento di coste; azioni contro corsari; partecipazione ad assedi e imprese militari a
grande raggio; lunghe soste nei porti l'inverno o al riparo di flotte nemiche strapotenti. Le immense cure del luogotenente generale di
Carlo V nel Mediterraneo, nella scia di una politica continentale, mediterranea e italiana sempre alla ricerca di una difficile egemonia
imperiale, era un castello che appena puntellato sembrava crollare di colpo. E proprio sul mare il più duro e terribile dei nemici, la
flotta di Solimano, alleata dei corsari barbareschi di Algeri. Un sistema di guerra oramai antico: sempre più uomini negli stessi spazi
di una volta e pochi cannoni perché appunto lo spazio era ridotto; guerra crudele e astuta, condotta dagli ammiragli indigeni con
accortezza mercantile, nel dispregio assoluto di qualsiasi convenzione cavalleresca che sul mare non aveva mai attecchito. Del resto
come rimproverare al D. e al suo rivale di avere anch'essi una propria Realpolitik che s'identificava con la cura dei propri interessi?
Carlo V doveva aver comprensione per questo "interesse".
Il legame stretto nel 1528 fra un giovane imperatore e un ammiraglio già sessuagenario doveva durare fino alla morte. Il D. entrava
così nella "grande storia" del suo secolo: come interprete sul mare della politica imperiale e come signore di Genova. L'uomo grave e
appassionato che fu Carlo V non manifestò mai dubbi di sorta nei confronti del suo ammiraglio. Fin dal 1528 aveva dunque perfetta
consapevolezza dei servizi che poteva attendersi: l'egoismo mercantile del D. gli appariva del tutto logico e accettabile. Gli assicurava
comunque il controllo di Genova e una guida per una flotta sempre composita: galere di privati e di Genova, di Napoli e di Sicilia,
galere spagnole, pontificie e di Malta. Tale ricorrente sforzo navale rappresentava una componente non secondaria nel complesso
gioco politico e militare internazionale che riguardava la Berberia e tutto il continente fino alle pianure danubiane e richiedeva quindi
una straordinaria mobilitazione di energie militari, diplomatiche e finanziarie. In effetti non si può isolare la vicenda mediterranea dal
contesto di questa politica che fissava volta a volta all'imperatore priorità diverse. Fu sul Mediterraneo comunque che prese corpo
l'alleanza franco-turca; era nel Mediterraneo verso il Magreb che gravitava la tradizionale politica spagnola e verso Oriente (Cipro e
Corfù) che gravitava invece la neutralità armata di Venezia, non riconducibile alla egemonia imperiale ma naturalmente nemica del
grande Impero osmano. Ancora: era sul Mediterraneo che ancora poteva pulsare il grande progetto storico della crociata, ripresa nel
vario contesto dei rapporti fra Impero e Papato e in grado di vincolare temporaneamente anche i nemici cristiani di Carlo V.
Se lette nel più ampio contesto politico-diplomatico le campagne mediterranee del D. ritrovano una loro razionalità "di congiuntura":
considerate per se stesse, secondo un'ottica strategica di più lungo periodo, esse indicano certamente un insuccesso, sottolineano
l'ascesa turco-barbaresca e la situazione di scacco della flotta imperiale dal 1538 al 1560 e oltre. La caduta di Rodi (1522) aveva
aperto il Mediterraneo ai mussulmani. Algeri si affrancava direttamente nel 1529 e diventava sotto il Barbarossa la capitale militare
nel Mediterraneo. Per qualche tempo il D. mantenne una certa iniziativa: nel 1530 muoveva alla testa di trenta galere (tredici francesi)
contro Scercel, ma la spedizione non ebbe esiti molto positivi; nel 1532 fu la volta della Morea con la conquista di Corone e Patrasso,
ma il mancato accordo coi Veneziani fece sfumare l'occasione per battere la flotta di Ahmed. Nel '33 ancora Corone fu soccorsa con
successo. L'anno seguente tuttavia il Barbarossa assumeva il comando della flotta mussulmana: alleato coi Francesi, saccheggiava
indisturbato l'Italia meridionale e conquistava Tunisi. A questo punto l'imperatore reagì e nel '35 organizzò la liberazione di Tunisi,
senza riuscire però a catturare Barbarossa che sfuggì alla sorveglianza di Adamo Centurione. Nel 36 il D. era impegnato in Provenza;
nel 37 i Veneziani investirono Corfù e poi conquistarono le Cicladi: il D., forte di trentadue galere, sconfisse dodici galere turche ma
il prezzo pagato fu molto alto.
Nel '38 lo scacco della Prevesa: la lega antimussulmana, forte dell'appoggio veneziano, si dissolse in una parodia di battaglia che
inaugurò l'egemonia mussulmana sul Mediterraneo. Ormai la sproporzione delle forze era evidente: Antonio Doria in una relazione
del 1539 sostenne che per contrastare il Turco occorrevano duecentocinquanta galere e a questo fine era necessaria l'alleanza con
Venezia. L'Impero avrebbe dovuto tenere in campo centoventicinque galere invece delle sessantadue che teneva abitualmente. Era
necessario che lo stuolo restasse unito a lungo, che avesse un suo porto fisso. Il necessario sforzo finanziario era stimato ammontare a
430.000 scudi all'anno. Ormai la carta dell'alleanza veneta era stata buttata via alla Prevesa e non sarà più disponibile fino ai giorni di
Lepanto. Il D. era sulla difensiva. Ancora uno sporadico successo nel 1540 quando Giannettino Doria catturò Dragut che venne
incatenato al remo. Ma subito dopo fu il disastro di Algeri: la spedizione imperiale naufragò miseramente sulla spiaggia africana. In
quei giorni il D. salvava l'Impero e Carlo V riconoscente lo nominava protonotaro del Regno di Napoli e marchese di Tursi. Ormai la
partita mediterranea era ampiamente compromessa e di conseguenza scemò l'impegno nel Mediterraneo. Ancora nel '43 il D. poteva
battere la squadra francese isolata, ma l'arrivo di Barbarossa capovolse la situazione: Nizza fu saccheggiata, Genova risparmiata. P un
fatto che l'oro genovese aveva cominciato a "correre", che rapporti più o meno segreti erano mantenuti con la Porta e con i pascià
dagli stessi Imperiali. Si spiega così la liberazione di Dragut, la cui vita valeva bene un sacco di Genova. Accordi personali o accordi
politici? Il confine è sfuggente e comunque pedantesco. I tornaconti del D., come quelli della Repubblica, sono evidenti: Barbarossa
era corruttibile come più tardi lo furono i pascià, né l'ammiraglio poteva opporsi alla soverchiante forza mussulmana.
Le successive spedizioni contro Dragut, il più famoso corsaro mediterraneo, furono infruttuose. Nel periodo di pace militare sul mare
fra il 1545 e il 1550 era divampata la guerra di corsa: tipica risorsa dei tempi di magra quando non era possibile sostenere lo sforzo
grandioso della guerra di flotta e le priorità sono diverse (i Turchi impegnati in Persia).
L'azione militare del D. si caratterizza così per l'estrema prudenza. Il capitale in gioco era prezioso e dopo il 1538 il rapporto di forze
era decisamente sfavorevole. D'altra parte una clamorosa disfatta era pregiudizievole anche per gli interessi imperiali. Certamente
anche il destino di Genova era direttamente coinvolto da questa vicenda militare, la minaccia corsara sempre viva sulle Riviere,
soprattutto dopo il 1540, una sorta di "grande paura" che non favoriva certo il carisma del Doria.
Poteva d'un colpo cessare la passione faziosa proprio quando la mobilità della situazione internazionale, la grande volatilità delle
fortune militari, gli interessi e gli intrighi dei papi, dei re e dei principierano all'opera sulla società genovese, questo sensibile nervo
dell'egemonia italiana di Carlo V? L'episodio classico fu la congiura del conte Gian Luigi Fieschi del 1547, ma essa rivelava appunto
un "nido di vipere".
Fu una classica tragedia rinascimentale, di quelle care alla sensibilità romantica. Cominciava con una rivalità di giovani: il colto e
sensibile Gian Luigi e il rozzo Giannettino Doria, balzato dalle povere rendite onegliesi ai fasti della luogotenenza imperiale per il
favore dello zio. In un certo senso la riproduzione di un contrasto stereotipo: l'aristocratico raffinato e il parvenu politico che tutto si
permetteva, perfino di insidiare la moglie del primo. Orgoglio di casato, invidie marinare, gelosie di marito alimentati dalla
frequentazione stessa e strumentalizzati dalle corti di Roma e di Francia. La rivalità acquista presto risvolti politici, stimolati dalle
tradizioni di ostilità familiari e da un certo clima culturale: "popolo e libertà contro tirannide", l'esempio antico di Bruto. Il passaggio
all'azione è fatale a entrambi i contendenti nella stessa notte fra il 2 e il 3 gennaio: Gian Luigi morto affogato per una banale caduta in
mare e Giannettino morto ammazzato mentre accorre alle grida. Un fulmine a ciel sereno che coglie il principe impreparato ma lesto
comunque a sellare un cavallo per Masone.
Morti i protagonisti, il gioco delle parti si rivela solo lentamente in un lungo stillicidio di quadri: diffidenze e connivenze, alternative e
continuità. Notiamo anzitutto la preoccupazione generale per quel che sarebbe accaduto con la morte del vecchio principe
ottuagenario. Che occorresse agire subito era opinione diffusa, tanto da parte spagnola quanto da parte genovese. La linea apologetica
di Scipione Fieschi fu quella che Gian Luigi volesse evitare una signoria di Giannettino.
L'ambasciatore Figueroa del resto aveva posto il problema della successione fin dal 1533. Ma c'erano diverse tendenze attorno alla
congiura e una faceva capo a Spinola e Adorno, nonché a un popolare influente come Lasagna. All'indomani dei fatti di gennaio
questo gruppo si presenta come oltranzista filoispanico e Agostino Spinola come l'uomo di Figueroa. E ovviamente c'erano anche i
"fregosardi". Ma le forze dell'opposizione non riuscirono a coagularsi. Un'iniziativa di famiglia quella di Gian Luigi, i fratelli, i
cognati Niccolò Doria e Giulio Cibo. I primi furono subito compromessi, ma ottennero l'indulto da un Senato diviso e spaurito, purché
abbandonassero Genova. Ma risulteranno coinvolti anche uno Spinola, un Giustiniani e l'ex doge G. B. Fornari. Ancorché la frattura
fra nobili vecchi e nobili nuovi fosse già in atto - com'è dimostrato dall'elezione a sorpresa dello stesso Fornari nel '45 - la loro
collaborazione nelle diverse fazioni traspare tuttavia chiaramente. C'è il sospetto di un sostegno plebeo all'azione dei Fieschi: con
riferimento al Verrina e al suo seguito nonché alla benevolenza del conte Fieschi verso i tessitori di seta. Il 1546, occorre ricordare era
stato anno nero per gli approvvigionamenti granari. L'interrogativo rimane.
Anche il Lasagna vantò al Figueroa un sostegno di massa alla causa spagnola. Nel febbraio del 1547 l'ambasciatore comunicava a
Carlo V la notizia di un moto fomentato in borgo S. Donato da un tale di casa Doria contro la minaccia "Spagna e Adorno", "y como
en atiquella parte son Fregosos, facilmente se alborotaron todos". L'antica tradizione del governo "a cappellaccio", cioè di fazione,
poggiava su sentimenti ancora ben vivi di partigianeria rionale. Il D. ne era consapevole e ribatteva all'ambasciatore che era meglio
che fossero disuniti con le loro passioni particolari cosicché non avrebbero fatto novità. Certo il processo dell'"Unione" che aveva
preso corpo nella costituzione del '28 non era molto avanzato e la signoria informale del D. appariva come una pausa nel gioco
politico decisivo delle fazioni.
Su di esse lavoravano tanto Adamo Centurione che si proclamava come vero interprete dell'umore dei cittadini per conto
dell'ammiraglio, tutto preso dalle cose militari, quanto il Lasagna per Agostino Spinola.
Di fatto gli avvenimenti del 1547-48 riportavano in primo piano il ruolo delle grandi famiglie Fieschi, Doria, Spinola con qualche
frattura interna, più vistosa nel caso dei Doria forse per la rivalità acuta fra il D. e il cugino cardinale Gerolamo, padre di Nicolò
imparentato coi Fieschi.
Figueroa e Ferrante Gonzaga sembravano puntare sugli Spinola, più pronti ad accettare il progetto della fortezza che avrebbe dovuto
garantire il controllo della città all'Impero: contro, Adamo Centurione, che appare il vero capofila del partito del principe, controllava
col figlio Marco le galere ed era in effetti il più probabile successore del Doria. Del resto i funzionari imperiali non potevano
trascurare la volontà del D. che non consentiva che uno Spinola occupasse il posto di capo militare di una più sostanziosa guarnigione
a Genova. In questi mesi critici il suo predominio era garantito dalle venti galere ancorate nel porto e pagate da Carlo V: 125.000
scudi all'anno - annotava Ferrante Gonzaga - assai più di quanto sarebbe occorso per costruire la fortezza. Francesco Grimaldi e
Adamo Centurione con due successive missioni per conto del principe presso Carlo V erano riusciti a stornare la minaccia immediata.
Tutto era stato rimandato alla imminente visita del principe Filippo a Genova. Filippo venne infatti verso la fine del novembre 1548,
ospite del D. a Fassolo: lungo la via, cosparsa di archi di trionfo, le "imprese" pitturate su enormi pannelli di legno ripetevano i motivi
celebrativi ormai tradizionali, e una di queste invitava il giovane ingegno a cedere di fronte alla matura esperienza.
Bernardino Mendoza, in un suo classico ragionamento, difendeva l'indipendenza di Genova: "giuri fiscali e feudi" legavano sempre
più la nobiltà, la "vecchia" soprattutto, ai destini della Corona spagnola. Era "l'invisibile ma inespugnabile fortezza dell'interesse" più
solida e duratura di quella del Castelletto: una giusta intuizione dei tempi nuovi che erano maturati con la più recente e massiccia
partecipazione dei capitali genovesi ai prestiti imperiali. Il D. rimaneva probabilmente legato alla simbologia del 1528, quando egli
aveva fatto abbattere la fortezza. In ogni caso l'autorità ufficiale della Repubblica fu chiaramente coartata e la diplomazia parallela del
principe si rivelò ben più decisiva che non l'iniziativa dell'ambasciatore Ceva Doria. L'indulto concesso ai fratelli Fieschi era stato
revocato; Montoggio assediata e i colpevoli, a cominciare da Gerolamo Fieschi, messi a morte. Così nella corsa alla spogliazione dei
feudi Fieschi le aspirazioni della Repubblica su Torriglia e Montoggio erano state frustrate: il D. ottenne, a titolo di risarcimento per i
danni subiti e per la benevolenza imperiale, questi e altri feudi dei Fieschi. Antonio Doria ebbe Santo Stefano e la Repubblica dovette
accontentarsi di Roccatagliata e Varese (Varese Ligure), centri non altrettanto importanti dal punto di vista strategico.
La cronaca di questi mesi cruciali getta luce sul carattere della signoria doriana: in ultima istanza l'elemento decisivo è rappresentato
dal "rapporto speciale" con l'imperatore. Per quanto ostili e critici, soprattutto il Gonzaga, i funzionari imperiali non potevano
prescindere dalla sua volontà e neppure dai suoi umori. L'asientista tenevain sella il signore. L'esito interno fu la creazione di una
maggiore solidarietà fra i nobili "vecchi": da questo punto di vista la riforma costituzionale del 1547 fu un chiaro atto di partigianeria
politica. "Vecchi" erano tutti gli asientistas de dineros. Al di là della semplice riforma del sistema elettorale il D. tendeva a una
drastica riduzione dei membri dei serenissimi Collegi e cioè a un potenziamento dell'esecutivo in senso oligarchico.
La riforma detta "del garibetto" creò un forte scontento fra i nobili "nuovi" e polarizzò il contrasto sociale e politico nella classica
linea storica del contrasto fra nobili e popolari smentendo l'"Unione". I nodi sarebbero venuti al pettine nel 1575.
Per il momento la stella del D. poteva continuare a brillare. Beninteso si continuò a parlare del problema della successione. Non è
chiaro quanto questo problema fosse o restasse legato con quello del comando delle galere: il D. era comunque il più grosso
proprietario di galere su piazza e questo era un patrimonio ben suo, che egli poteva risolvere in termini di delega e successione.
Intanto nel 1551 riapparve la flotta di Siman pascià che conquistò Tripoli: il D., rinchiusosi in Villafranca, rifiutò perfino lo scontro
con lo stuolo francese dello Strozzi. Nel 1552 Siman investì Reggio e Napoli e fu giocoforza operare in soccorso di Napoli - quaranta
contro centoventi galere - e il D. ne perse sette a Ponza.
Nel 1553 Dragut ebbe il comando della flotta turca e con i Francesi investì la Corsica. Ma Genova e gli Imperiali organizzarono
un'efficace riscossa: si attese che la flotta turca rientrasse alle basi per svernare e si riprese l'iniziativa. Così si operò anche negli anni
seguenti. Il D. e Cosimo I, un'alleanza certo poco sincera, erano in questi anni i protagonisti della politica imperiale in Italia. Il debutto
di Gian Andrea Doria, figlio del defunto Giannettino, non avvenne sotto buoni auspici: ben dieci galere furono perse per mera
imperizia di manovra.
La rinnovata minaccia della flotta turca e l'invasione della Corsica crearono probabilmente negli anni Cinquanta un certo clima di
emergenza a Genova. Pur impotenti contro il Turco, la flotta del D. e l'alleanza con l'Impero e la Spagna rappresentavano per la
Repubblica l'unica possibilità di colpire a sua volta, di lanciare la sua controffensiva per la difesa di un possedimento ritenuto vitale.
D'altronde fu proprio in questi anni che Genova poté tornare a rifornirsi di grano orientale entrando in qualche modo nel gioco della
stessa "enipia alleanza" franco-turca. L'oro genovese fece ancora miracoli nel 1558: "lavorato" dal denaro genovese, Piali pascià
risparmiò ancora una volta le Riviere e frustrò i più ambiziosi disegni politico-militari del re di Francia.
Sicché la pace di Cateau-Cambrésis del 1559, riconoscendo a Genova il possesso della Corsica, concludeva questo capitolo dei
controversi rapporti storici fra metropoli e colonia (1553-59). Pertanto iniziate in Corsica contro Ranuccio Della Rocca le sue imprese
genovesi, ancora nella Corsica doveva concluderle il D. (per delega beninteso) contro Sampiero di Bastelica.
Nel novembre dello stesso anno Medinaceli e Giovanni (Gian) Andrea Doria guidavano la flotta e un esercito al disastro delle Gerbe
(2 marzo 1560). Come venti anni prima ad Algeri. Il vecchio ammiraglio stava vivendo l'ultimo anno di vita nella sua reggia di
Fassolo: la notizia del disastro sancì il suo ambiguo destino militare. Il suo, oramai proverbiale, consiglio di prudenza era rimasto
inascoltato. Il destino dell'astro Doria nella politica genovese era fatalmente segnato dalla morte del D. avvenuta a Genova il 25 nov.
1560. Filippo II poteva riconoscere la successione del pupillo Gian Andrea nella luogotenenza del Mediterraneo, ma la signoria su
Genova restava un fenomeno eminentemente personale. La dinastia stessa, quel ramo dei Doria, sarà fatalmente spinta verso un
destino cosmopolitico, soprattutto romano.
L'esperimento della signoria informale non era riproducibile per successione: questo era chiaro fin dal 1547. Angoscia terribile per un
principe, questa di un patrimonio esclusivamente personale, di una continuità impossibile in termini dinastici. Il D. aveva potuto
trasmettere il comando delle galere, perfino la luogotenenza imperiale, ma non una signoria mai riconosciuta come tale. Accostumato
al ruolo decisivo dei rapporti personali e speciali, egli non aveva probabilmente alcuna fiducia nella nuova costituzione repubblicana,
nelle istituzioni che erano state sperimentate sotto la sua tutela. Ed è per questo forse che negli ultimi anni della sua vita il D. giunse a
proporre che la Spagna s'insignorisse di Genova. La testimonianza è ancora del Figueroa, ma essa, a ben considerare, non fa stupore.
Quando nel 1547-48 egli si era opposto a un atto di volontaria dedizione di Genova agli Spagnoli, un gesto che implicava per lui, così
come il consenso alla fortezza, la rinuncia al proprio "onore", ma non alla possibilità che l'imperatore prendesse di propria iniziativa
una decisione di signoria. L'onore di un corsaro? Piuttosto il puntiglio e l'orgoglio di un principe che non voleva rinunciare al
"miracolo" del 1528, al suo personale capolavoro politico.
Certamente il D. non era persona che s'abbandonasse a scrivere ragionamenti sui tempi suoi, ma ovviamente aveva una sua personale
saggezza. Franzino Della Torre riportava così a Federico Gonzaga nel 1535 un colloquio avuto col D.: "che oggi tutta la Christianità
sia divisa in due affetti, l'uno de lo Imperatore, l'altro di Franza et che quasi sia necessario passare per uno di questi camini ad ogni
persona di momento. Che quello dello imperatore mo sia il migliore non gli pare... gli sia dubio". Già Ottaviano Fregoso aveva
operato questa scelta nel 1515 offrendo la signoria a Luigi XII. Diviso in due il "mondo politico", era necessario scegliere bene la
propria parte: alla propria opzione, non ulteriormente giustificata, il D. era riuscito a congiungere l'idealità della "libertà e
indipendenza" della Repubblica, come piattaforma di governo idonea a uno Stato di mercanti, un'idealità subordinata al realismo
politico e non una idea-guida.
Grande asientista di Carlo V e suo luogotenente nel Mediterraneo egli possedeva l'unico esercito di una Repubblica quasi disarmata,
cioè le galere, cosicché, offrendole la libertà, le imponeva di fatto la propria egemonia. Del resto solo la sua posizione militare nel
sistema imperiale era in grado di garantire quella indipendenza, entro i limiti ben chiari di un'opzione, una scelta necessaria fra le due
grandi potenze.
Per il doppio apporto di prestigio la sua figura pubblica ne risultava ingigantita e il palazzo-corte di Fassolo esprimeva appunto questa
esaltazione. Le vicende militari sul mare, poco brillanti nel complesso, potevano oscurare la fama dell'ammiraglio: egli rimaneva il
garante della fedeltà di Genova e l'esecutore di direttive imperiali. Se la sua signoria scricchiolava come nella crisi del 1547-48
rivelando che quella garanzia non era più cosi solida, il D. era purtuttavia il luogotenente dell'Impero, il padrone di venti galere,
l'estremo baluardo di fronte alla assoluta supremazia franco-turca sul mare. Così le sue due "dignità", i suoi due ruoli si sostenevano a
vicenda e sostenevano le fortune di un uomo ormai vegliardo.
L'impressione che se ne ricava è quella di una mirabile costruzione politica della propria fortuna personale: approdato relativamente
tardi alla imprenditoria della guerra navale il D. stabilizzò per sempre il suo rapporto col committente imperiale col contratto del 1528
proprio in virtù delle straordinarie clausole politiche che erano comprese nel medesimo.
L'ammiraglio operava in un quadro preciso: asiento, politica imperiale e sforzi finanziari navali diversi. Il politico ebbe il merito
indubbio di costruire attorno alla sua persona una straordinaria retorica protettiva (unione e indipendenza). Per il resto la congiura del
Fieschi ha rivelato sentimenti e strutture di alleanza assai tradizionali, il gioco delle fazioni, dei "colori" e delle famiglie per nulla
superato dalla sperimentazione costituzionale. L'oligarchia degli amici del D., un direttorio del principe si formò a latere dello Stato
come esito della speciale posizione di predominio del principe, senza connessione diretta con le istituzioni: rientrava nella tipologia
delle "signorie informali" caratterizzate da forti elementi di prestigio e di potere personali. Qui è chiaro che il giudizio sommario
anticipa lo studio analitico di un sistema di potere che non è ancora stato tentato. La formula interpretativa della figura del D. che si e
proposta è sufficientemente utile per sgombrare il campo da molti falsi problemi, sufficientemente rispettosa verso la migliore
tradizione degli studi su quel periodo storico. E soprattutto è solo una formula, oltre la quale cioè la ricerca e l'analisi storica possono
proseguire su un più moderno terreno di concretezza.
Fonti e Bibl.: Genova, Bibl. univ., 3, VII, 5: G. Cibo Recco, Historie che trattano la guerra di Corsica in tempo di Sampiero di
Bastelica; Ibid., E, IV, 5-10: A. Doria, Relazione delle cose turchesche; A. Capelloni, Vita del principe A. D., Venezia 1565; A. P.
Filippini, La historia di Corsica, III, Toumon 1594; G. Sigonio, Della vita e dei fatti di A. D., Genova 1598; F. Casoni, Annali di
Genova nel secolo XVI, Genova 1800, ad Indicem; M. Spinola-L. T. Belgrano-F. Podestà, Documenti ispano-genovesi dell'Archivio
di Simancas, in Atti della Soc. ligure di storia patria, VIII (1868), pp. 1-291 passim; A. Gavazzo, Nuovi documenti sulla congiura del
conte G. L. Fieschi, Genova 1886; E. Bernabò Brea, Sulla congiura del conte G. L. Fieschi, Genova 1863; E. Celesia, La congiura di
Gian Luigi Fieschi, Genova 1865, pp. 3 ss.; A. Merli-L. T. Belgrano, Il palazzo del principe Doria a Fassolo, ibid., X (1874), pp. 2 ss.;
C. Manfroni, Storia della marina italiana, III, Roma 1897, ad Indicem; A. Neri, A. D. e la corte di Mantova, Genova 1898; G.
Manfroni, Le relazioni fra Genova, l'Impero bizantino e i Turchi, in Atti della Soc. ligure di storia patria, XXVIII (1898), pp. 757-763,
768, 777, 779, 837 s., 847; E. Pandiani, Il primo comando in mare di A. D., ibid., LXIV (1935), pp. 344-358; A. Neri, I negoziati per
attirare A. D. al servizio di Carlo V, in Giorn. stor. e letter. della Liguria, XVIII (1942), pp. 51-75; E. Pandiani, Genova e A. D. nel
primo quarto del '500, Genova 1949; G. Oreste, Genova e A. D. nella fase critica del conflitto franco-asburgico, in Atti d. Soc. ligure
di storia patria, LXXII (1950), pp. 3-69; V. Piergiovanni, Il Senato della Repubblica di Genova nella riforma di A. D., in Annali d.
Facoltà di giurisprudenza d. Univ. d. studi di Genova, IV (1965), I, pp. 230, 233, 235, 275; F. Braudel, La Méditerranée et le monde
méditerranéen à l'époque de Philippe II, Paris 1966, ad Indicem; E. Parina Armani, Il palazzo del principe A. D. a Fassolo, in L'Arte,
1970, n. 10, pp. 12-63; E. Grendi, Genova alla metà del '500: una politica del grano?, in Quaderni storici, XIII (1970), pp. 106-109,
121, 149, 157, 160.
Born November 30, 1466 Oneglia, Died November 25, 1560 (aged 93) Genoa
From Wikipedia, the free encyclopedia
Parents
Ceva Doria and Caracosa Doria
Andrea Doria (or D'Oria) (30 November 1466 – 25 November 1560) was an Italian condottiere and admiral from Genoa.Early life
Doria was born at Oneglia from the ancient Genoese family, the Doria di Oneglia branch of the old Doria, de Oria or de Auria family.
His parents were related: Ceva Doria, co-lord of Oneglia, and Caracosa Doria, of the Doria di Dolceacqua branch. Orphaned at an
early age, he became a soldier of fortune, serving first in the papal guard and then under various Italian princes. In 1503 he was
fighting in Corsica in the service of Genoa, at that time under French vassalage, and he took part in the rising of Genoa against the
French, whom he compelled to evacuate the city. From that time onwards, he became famous as a naval commander. For several
years he scoured the Mediterranean in command of the Genoese fleet, waging war on the Turks and the Barbary pirates.
Wars between France and the Holy Roman Empire In the meanwhile Genoa had been recaptured by the French, and in 1522 by
the armies of the Holy Roman Emperor. But Doria joined the French or popular faction and entered the service of King Francis I of
France, who made him captain-general; in 1524 he relieved Marseille, which was besieged by the Imperialists, and later helped to
place his native city once more under French domination. Dissatisfied with his treatment at the hands of Francis, who was mean about
payment, he resented the king's behavior in connection with Savona, which he delayed handing back to the Genoese as he had
promised. Consequently, on the expiration of Doria's contract he entered the service of Emperor Charles V (1528).
Re-establishment of the Genoese Republic Doria ordered his nephew Filippino, who was then blockading Naples in alliance with a
French army, to withdraw; Doria then sailed for Genoa where, with the help of some leading citizens, he expelled the French and reestablished the republic under imperial protection. He reformed the constitution in an aristocratic sense, most of the nobility being
Imperialists, and put an end to the factions which divided the city, by creating 28 Alberghi or "clans". The 28 Alberghi that formed
this new ruling class included the Cybo, Doria, Fieschi, Giustiniani, Grimaldi, Imperiale, Pallavicino, and Spinola families.[1][2] He
refused offers to take the lordship of Genoa and even the dogeship, but accepted the position of "perpetual censor", and exercised
predominant influence in the councils of the republic until his death. The title "censor" in this context was modeled on its meaning in
the Roman Republic (i.e. a highly respected senior public official - see Roman censor), rather than its modern meaning having to do
with censorship. He was given two palaces, many privileges, and the title of Liberator et Pater Patriae (Liberator and Father of his
Country).
Doria as imperial admiral As imperial admiral he commanded several expeditions against the Ottoman Empire, capturing Koroni
and Patras, and co-operating with the emperor himself in the capture of Tunis (1535). Charles found him an invaluable ally in the
wars with Francis I, and through him extended his domination over the whole of Italy. In February 1538, Pope Paul III succeeded in
assembling a Holy League (comprising the Papacy, Spain, the Holy Roman Empire, the Republic of Venice and the Maltese Knights)
against the Ottomans, but Hayreddin Barbarossa defeated its combined fleet, commanded by Andrea Doria, at the Battle of Preveza in
September 1538. This victory secured Turkish dominance over the Mediterranean for the next 33 years, until the Battle of Lepanto in
1571. He accompanied Charles V on the ill-fated Algiers expedition of 1541, of which he disapproved, and which ended in disaster.
For the next five years he continued to serve the emperor in various wars, in which he was generally successful and always active,
although now over seventy years old.
Later years After the Peace of Crépy between Francis and Charles in 1544, Doria hoped to end his days in quiet. However, his great
wealth and power, as well as the arrogance of his nephew and heir Giannettino Doria, had made him many enemies, and in 1547 the
Fieschi conspiracy to dislodge his family from power took place. Giannettino was killed, but the conspirators were defeated, and
Doria showed great vindictiveness in punishing them, seizing many of their fiefs for himself. He was also implicated in the murder of
Pier Luigi Farnese, duke of Parma and Piacenza, who had helped Fieschi. Other conspiracies followed, of which the most important
was that of Giulio Cybo (1548), but all failed. Although Doria was ambitious and harsh, he was a patriot and successfully opposed
Emperor Charles's repeated attempts to have a citadel built in Genoa and garrisoned by Spaniards; neither blandishments nor threats
could win him over to the scheme. Nor did age lessen his energy, for in 1550, aged 84, he again put to sea to confront the Barbary
pirates, but with no great success. In 1552 the Ottoman fleet under the command of Turgut Reis defeated the Spanish-Italian fleet of
Charles V under the command of Andrea Doria in the Battle of Ponza (1552). War between France and the Empire having broken out
once more, the French seized Corsica in the Invasion of Corsica (1553), then administered by the Genoese Bank of St George. Doria
was again summoned, and he spent two years (1553-1555) on the island fighting the French with varying fortune. He returned to
Genoa for good in 1555, and being very old and infirm, he gave over the command of the galleys to his great-nephew Giovanni
Andrea Doria, the son of Giannettino Doria, who conducted an expedition against Tripoli, but proved even more unsuccessful than his
great-uncle had been at Algiers, barely escaping with his life after losing the Battle of Djerba against the Turkish fleet of Piyale Pasha
and Turgut Reis. Andrea Doria left his estates to Giovanni Andrea. The family of Doria-Pamphili-Landi is descended from Giovanni
Andrea Doria and bears his title of prince of Melfi. Judged by the standards of his day, Doria was an outstanding leader.
Ships Several ships were named in honour of the Admiral:
• The liner SS Andrea Doria, which was launched in 1951, had her maiden voyage in 1953 and sank in 1956.
• The battleship Andrea Doria, completed in 1891, which served in the late 19th and early 20th century, was stricken in 1911,
and served as the floating battery GR104 during World War I before being scrapped in 1929.
• The battleship Andrea Doria, completed in 1916, which served in both World War I and World War II and was stricken in
1956.
• The Italian missile cruiser Andrea Doria built in 1964 and decommissioned in 1991.
• The Italian Horizon-class frigate Andrea Doria, commissioned in 2007.
• Two United States Navy ships named USS Andrew Doria.
References
1.
^ “The Grimaldis of Monaco”, Anne Edwards, HarperCollins, 1992, [1], ISBN 0002151952
2.
^ “Genoa and the sea : policy and power in an early modern maritime republic, 1559-1684”, Thomas Allison Kirk,
Johns Hopkins University Press, 2005., pg. 25 [2], ISBN 0801880831
Wikimedia Commons has media related to: Andrea Doria
•
•
This article incorporates text from a publication now in the public domain: Chisholm, Hugh, ed (1911). Encyclopædia
Britannica (Eleventh ed.). Cambridge University Press.
"Andrea Doria" in the 1913 Catholic Encyclopedia.
Doria, Giovanni Andrea
(1539-1606)
Dizionario Biografico degli Italiani
di RR. Savelli
DORIA, Giovanni Andrea (Gian Andrea). - Nacque a Genova agli inizi del 1540, da Giannettino e da Ginetta Centurione, figlia di
Adamo, il famoso uomo d'affari e banchiere. Per la data di nascita ci si è rifatti alla tradizione e a quanto afferma in apertura della sua
autobiografia, anche se in altri passi della stessa sembra anticiparla al 1539.
I destini del personaggio sono tutti racchiusi nell'origine familiare e negli avvenìmenti che segnarono i primi anni della sua vita. Il
padre Giannettino, figlio di Tomaso, cugino di primo grado di Andrea Doria, del quale fu uno dei più stretti collaboratori, morì infatti
nel 1547, ucciso durante la congiura di Gian Luigi Fieschi. Il vecchio Andrea Doria si prese cura del giovane D. e lo allevò
destinandolo alla sua successione: come narra lo stesso D. nell'autobiografia (un interessantissimo testo redatto alla fine della vita,
probabilmente agli inizi del '600, quando - come scriveva al granduca di Firenze - viveva da "vecchio retirato": cfr. Archivio di Stato
di Firenze, Mediceo del principato 2834) dall'età "d'otto anni mi condusse seco il Prencipe mìo Sig.re e di continuo mi fece, in tutte le
occasione s'offersero, navigare con se". Le preoccupazioni di Andrea non si limitarono però solo a formare un comandante di galere,
un ammiraglio per la Spagna (incarico che il D. raggiunse solo molti anni dopo la morte dell'avo); Andrea curò che nella persona del
D. si ricostituisse anche un'unità patrimoniale e di potere, quale egli era riuscito a costruire dopo la grande alleanza con Carlo V.
Esemplare quindi la "programmazione" matrimoniale: già nel 1550 furono definiti i termini del contratto matrimoniale con Zenobia,
figha di Marc'Antonio Doria Dei Carretto (figlio di Peretta De Mari [Usodiniare], sposata in seconde nozze da Andrea); uno dei
caposaldi di questo contratto era che il principato di Melfi (trasferito da Andrea a Marc'Antonio) sarebbe passato per successione a
Zenobia, in modo da ritornare nella famiglia di origine alla sua morte. Non fu questo però solo un matrimonio "dinastico" e di
interessi; l'essere cresciuti per anni da giovani nella stessa casa fece si che si formasse una salda e duratura unione: nella sua
autobiografia il D. non solo scriverà "dell'inclinatione grande che hebbi sempre di maritarmi con D. Zenobia", ma ricorderà anche
"l'esser stato dall'undici anni in sino alli quattordici sempre molti giorni, settimane e mesi in una casa come persone che havevano da
essere marito e moglie". Nelle disposizioni che diede per il suo funerale nel 1604 ordinò che nella mano sinistra fosse posta una
ciocca dei capelli di Zenobia (che era già morta nel dicembre del 1590).
L'educazione del D. fu affidata alle cure del bolognese Plinio Tomacelli, suo "aijo", dai dieci ai diciassette anni (ma che lo seguì
anche dopo, alle Gerbe, ad esempio, dove si meritò la definizione di "maestro di grammatica" da parte di Pietro Machiavelli,
appellativo che egli rifiutò sdegnosamente).
Dell'opera pedagogica del Tomacelli non sono rimaste altre testimonianze che gli inediti Ragionamenti morali dedicati appunto al D.,
allora in "tenera età": non è questo un testo particolarmente originale, ma è un significativo modello di educazione basata sulle virtù
del nobile, di carattere filosofico-morale, e poco connotato in senso religioso.
Risale probabilmente a questi anni la passione del D. per il gioco, che gli fece perdere, e guadagnare, migliaia di scudi, così come
racconta in gustosi passi della sua autobiografia. Tanto si dimostrò negli anni oculato amministratore di sé e delle sue richezze, tanto
però vi fu anche nella sua personalità una componente di amore del rischio: non a caso su una sua medaglia era scritto il motto "omnia
fortunae committo".
Ma la fortuna all'inizio non lo assisté certo nelle prove sul mare: nel 1556, sostanzialmente alla sua prima uscita con ruolo di
responsabilità, la flotta di dodici galere da lui comandata finì in gran parte sugli scogli della Corsica (salvandosi solo la sua
"Patrona").
Nell'autobiografia il D. sembra incolpare dell'accaduto i piloti delle galere, aggiungendo poi considerazioni di carattere più generale
sul problema del ruolo del comando: "risolsi io fra me stesso all'hora il poco si può nessun generale riposare in questa profession di
gente ordinaria, bassa e mercenaria, et cominciai ad usare maggior fatica in sapere e veder ogni cosa, et pensare introdurre giovani
nobili che imparassero".
Certo è che questo incidente, così come il di poco successivo disastro delle Gerbe, fece si che si diffondessero ben presto voci sulle
sue capacità di condottiero: qualcuno dei suoi avversari doveva avere aggiunto anche voci sulla sua "sfortuna", se in un articolato
Discorso sopra il generalato del mare (scritto, probabilmente agli inizi degli anni Sessanta, da qualche suo collaboratore, forse il
Tomacelli stesso: Genova, Bibl. Durazzo, A.IV.2; Bibl. ap. Vat., Barb. lat. 5367) si doveva dedicare spazio a controbattere le
affermazioni di coloro che "sogliono ... porre fra le buone parti che il generale ha d'haver, la buona fortuna".
Comunque questi primi anni di apprendistato non furono tutti negativi, poiché il D. seppe rendersi utile sia nella guerra di Corsica, sia
in quella di Siena, sia ancora in quella che gli Spagnoli condussero da Napoli contro Paolo IV sotto il comando del duca d'Alba. Con
le sue galere il D. contribuiva fattivamente al trasporto dei tercios sui diversi fronti del conflitto che vedeva protagonista la Spagna. È
vero comunque che al servizio regolare il D. faceva talvolta succedere periodi in cui "atterideva a giochi e a piaceri", o in cui andava
"in corso", per rimpinguare le casse di famiglia, allora, a suo giudizio, del tutto dissestate dalla munifica politica di Andrea e dai
ritardati pagamenti spagnoli: in una "istruzione" del 1568 scriveva che negli ultimi anni di vita di Andrea "incominciò la casa nostra a
declinare, et poco manco che non andasse a fondo".
Nelle pagine dell'autobiografia questo problema ricorre con frequenza quasi assillante, anche perché a fronte del grande Andrea stava
il suocero Marc'Antonio Doria Del Carretto ("suspettoso, parco e desideroso di quiete") che con Andrea mostrava avere poco in
comune. Il D., invece, desiderava "acquistare honore et robba". Avendo presente questa dichiarazione quasi "programmatica" si può
forse capire il personaggio, che ha suscitato sempre giudizi non molto elogiativi, e spesso del tutto critici.
I contrasti all'interno della famiglia giunsero a un punto tale che si profilò una rottura tra Andrea e Marcantonio, tanto da spingere
Andrea a cercare di togliere lo Stato di Melfi al Del Carretto, per investirne il D.; questi però riuscì (grazie anche ad un viaggio nella
primavera del 1558 a Bruxelles, dove allora era la corte imperiale) a riappacificare i due e a celebrare finalmente il matrimonio con
Zenobia ("senza nessuna sorte di festa").
In questi anni a Genova iniziavano a coagularsi e a manifestarsi diverse forme di critica e di opposizione all'egemonia della nobiltà
"vecchia" e al ruolo preminente di Andrea Doria nel panorama cittadino. Sicuramente si riferisce alle difficoltà politiche di Andrea
l'invio del D. a Bruxelles, nel gennaio 1559, per una missione, di cui si trovano solo scarni accenni nella sua autobiografia. Il D.,
giunto a Bruxelles il 19 gennaio, era latore di una "instruttione" che avrebbe dovuto leggere segretamente al re di Spagna. Cosa
contenesse questo documento il D. non dice, ma confrontando quello che egli scrive con quanto risulta da fonti spagnole, risulta
evidente che il vecchio Andrea chiedeva a Filippo II un intervento militare a Genova. Il conflitto franco-spagnolo tuttavia aveva preso
ormai altre strade: la pace si profilava vicina e, come si scriveva nella Cancelleria spagnola, una spedizione militare contro Genova
sarebbe stata troppo pericolosa e costosa. Era meglio tenere Genova con le buone e non con la violenza.
Il profondo affetto per il D. emerge con chiarezza dal testamento che Andrea redasse proprio quando questi si trovava a Bruxelles: a
lui sarebbero andate le galere, il ducato di Tursi, la carica di protonotario del Regno di Napoli, mentre al fratello del D., Pagano,
destinava i feudi appenninici e quello di Loano, una volta appartenenti ai Fieschi. Ma colpiscono soprattutto le parole con cui
giustificava il fatto che non voleva che il D., avesse curatori testamentari: "et quia cognoscit dictum ill.mum D. Io. Andream iam
virtutibus et prudentia virili preditum et ornatum ita ut alieno regimine non indigeat, cum sit ipse aptus ac idoneus alios regere et
gubernare, ita non vult quod sit sub cura alterius curatoris" (Sigonio, III, coll. 1259-1272).
Il D. trascorse il resto dell'anno (che avrebbe potuto essere fatidico per la disarmata Repubblica genovese) secondo moduli e scansioni
che sarebbero da allora diventate per lui abituali: a corte d'inverno, preparativi nella primavera, con la flotta nell'estate e nel primo
autunno; come egli stesso sintetizzò nella autobiografia: "mi fu sempre honorato sperone ad uscire l'estate a servire con le galere e ad
andar l'inverno in corte", quella corte così piena di intrighi, divisa tra le diverse fazioni (egli allora si appoggiava a Ruy Gómez,
mentre il suocero faceva riferimento al concorrente duca d'Alba), quella corte in cui ritualità e precedenze la facevano da padrone, ma
"dove - egli scrisse - sono si può dir allevato".
La fine del 1559 vide però il D. impegnato con il resto della flotta nei preparativi della spedizione che avrebbe dovuto portare in
Africa un grosso contingente di truppe, per la più volte progettata conquista di Tripoli, e che si tramutò poi nel disastro delle Gerbe.
Dopo un lungo soggiorno a Malta, finalmente nel febbraio del 1560 il corpo di spedizione partì per l'Africa settentrionale. Già durante
il viaggio di trasferimento il D. si ammalò gravemente tanto da pregiudicare radicalmente la sua partecipazione effettiva al comando
dell'impresa. L'autobiografia è naturalmente ricchissima di dettagli nella ricostruzione minuta degli avvenimenti che portarono la
flotta e le truppe spagnole nel cul-de-sac delle Gerbe. La malattia del D. comportò palesi divisioni di valutazione e di comportamento
tra i capitani delle galere genovesi; e un ruolo di mediazione, cui forse non era preparato, assunse il ricordato Tomacelli. Certo è che il
D., resosi conto della possibilità dell'arrivo delle galere turche, cercò in ogni modo di convincere gli altri comandanti, e soprattutto il
Medinaceli, a partire e a togliersi da una posizione in cui era difficile difendersi. La storiografia ottocentesca, nelle spiegazioni del
disastro, ha puntato il dito accusatore sul D. e sugli altri genovesi "interessati" a portare in salvo le loro galere piuttosto che a
combattere; in realtà la spedizione era partita troppo tardi, senza poter contare su quell'elemento di sorpresa che avrebbe potuto invece
(forse) essere risolutivo.
Salvatosi con pochi altri, il 25 maggio il D. scriveva a Filippo II: "mi duol bene assai l'havere perduto robba, ma dall'altro canto mi
consolo di non havere perduto honore essendomi sempre protestato et havendo antiveduto quel che potea intervenire, né potendo io
rimediare se non con disubidire et fare di mia testa" (Archivo general de Simancas, Estado 1389). La "robba" persa era costituita da
sette galere "rinforzate" (tanto che il vecchio Andrea, nei codicilli testamentari del 24 settembre, stabili che al D., per la ricostruzione
della flotta, andassero anche tutti i crediti che aveva, oltre a Fassolo, vero e proprio simbolo materiale della successione).
Con quattro galere rimaste, insieme con una di Stefano De Mari - con cui era allora in ottimi rapporti, guastatisi poi irrimediabilmente
negli anni Ottanta - il D. si mise nuovamente "in corso" sperando in qualche "notabile fattione". Ma, di fatto, poco o nulla concluse.
Il 25 nov. 1560 venne a morte Andrea. E si aprì così un difficile problema di "successione": il D. si sentiva Perede non solo e tanto dei
beni ("posso dir con verità che tutto quello che restò a me non valeva cento milla scudi ... e sopra essi v'erano anche qualche debiti",
scriveva nell'autobiografia), quanto del ruolo politico-militare ricoperto dall'avo, soprattutto in rapporto alla Spagna, più che verso la
realtà cittadina genovese: nella sua autobiografia (arrivando questa solo fino 1562) pochi sono i riferimenti alle lotte politiche, che
pure erano allora vive, in quanto il D. aveva vissuto fino ad allora gran parte del tempo fuori Genova o sulle galere. Andrea l'aveva
nominato da qualche anno suo luogotenente, ma ciò valeva finché era vivo il vecchio condottiero. Alla sua morte si presentarono tutti
i problemi e le obiezioni prevedibili in un caso come questo: la giovane età del R; il fatto che non si fosse distinto in qualche "notabile
fattione"; il fatto della nazionalità italiana per una alta carica spagnola, per la quale vi erano molti altri concorrenti, dotati di lignaggio
oltre che di esperienza.
Il D. intraprese subito il viaggio per la corte, con la speranza di poter conseguire immediatamente l'obbiettivo della nomina - "tanto
ingannato in me medesimo che mi pareva meritarlo" -, nonostante che prima della partenza il potente ed esperto nonno materno,
Adamo Centurione, l'avesse apertamente dissuaso.
Vi era stato anche chi aveva, forse in questa occasione, redatto il già ricordato Discorso sopra il generalato, in cui non solo si
controbattevano le possibili obiezioni alla sua nomina, ma soprattutto si adducevano i motivi per cui era bene attribuire ad un
"privato" genovese tale carica: si ricordavano le scelte di Carlo V, uso ad attorniarsi di collaboratori delle più diverse nazionalità;
l'importanza strategica di Genova ("per quella strada si soccorre e provvede e in un certo senso silegano tutti li stati di S. M.");
l'esigenza che "il generale sia potente per forze sue proprie e per aderenti di stato, d'amici et di parenti", evidente richiamo a
quell'integrato sistema creditizio-navale che i patrizi genovesi erano riusciti a costruire.
Il viaggio si risolse per certi aspetti in un vero e proprio insuccesso, perché la posta era troppo alta, perché il D. stesso annotò come
fosse "una pazzia ... pretendere essere di 21 anno Generalissimo". Sul momento la sconfitta gli sembrò cocente, perché in fondo gli
furono solo riconosciuti diritti nei trattamenti a corte, che lo ponevano in alto nella gerarchia delle ritualità e del protocollo; a corte si
adeguò a usi e modi, sia spendendo migliaia e migliaia di scudi al gioco, sia imparando la sottile arte dell'intrigo e della
dissimulazione.
Lasciato a Madrid Plinio Tomacelli ("perché desiavo levarmi dappresso chi mi diceva alle volte liberamente li miei errori"), il D.
tornò a Genova con l'intento di mettere in ordine la propria situazione economica; gli Spagnoli avevano si pagato una parte dei
precedenti debiti accumulati verso Andrea Doria, ma bisognava rimettere in ordine la flotta, che non aveva più svernato a Genova
dopo le Gerbe.
Nel contempo il D. prese ad occuparsi anche della sistemazione della villa di Fassolo, iniziando una serie di lavori di ampliamento
dell'ala verso la città; Fassolo costituì sempre per lui qualcosa di essenziale e di centrale, sia come simbolo del potere e del prestigio
raggiunti, sia come elemento rappresentativo della continuità familiare (e dell'adesione, quindi, al progetto di Andrea). Fino alla sua
morte non smise mai di ampliarla, acquisendo, via via, proprietà confinanti, trasformando il giardino (che era considerato uno dei più
interessanti nell'Italia del tempo), introducendo elementi nuovi nell'architettura della villa, così come nel sistema della decorazione.
Valutando l'insieme degli interventi, G. Gorse ha parlato di "change towards a more cosmological-imperial interpretation", ma ha
sottolineato come nel complesso il D. abbia svolto un ruolo di conservatore dell'impianto originario progettato da Andrea, quando
ormai il gusto del tempo evolveva verso altri moduli stilistici.
Il D. passò l'estate-autunno nel Regno di Napoli con le quattordici galere che gli erano rimaste (mentre a capo della squadra per
quell'anno si trovava il suocero Marcantonio Del Carretto), impegnato anche in qualche scorreria per cercare di ripianare i propri
debiti. Passato poi da Roma ("in 8 giorni che vi stetti non desinai mai in casa, essendo stato convitato da Cardinali che all'hora
facevano vita più da secolari e homini di mondo, che da preti religiosi"), raggiunse nuovamente Genova, dove trovò la scoraggiante
notizia che Filippo II intendeva ridurre le galere in asiento a dieci sole. La decisione di ripartire per la Spagna fu rapidamente presa;
questo nuovo soggiorno a corte non solo gli permise di limitare in parte i danni del nuovo asiento (riuscì infatti a strappare la
concessione che le galere fossere nuovamente aumentate a dodici), ma gli servì anche per entrare in relazione con uomini di corte
"che mi parevano suggetti da passar avanti sebene all'hora non lo erano"; il suo occhio cadde così su due personaggi che saranno
emblematici della Spagna di Filippo II, Gaspar de Quiroga e Antonio Perez.
Il 1562 passò senza particolari novità, se non il rinnovarsi del problema della disponibilità finanziaria. Il sistema di consumo
familiare, il mantenere in efficienza dodici galere (a fronte di un già cronico ritardo spagnolo nei pagamenti e di una litigiosità spinta
dei viceré di Napoli e di Sicilia) fecero si che in questo periodo una delle preoccupazioni fondamentali del D. fosse proprio quella dei
soldi.
L'autobiografia del D. si chiude con l'inverno del 1562, quando, tornato a corte, cercava di strappare qualche nuovo incarico nella
flotta ("mi saria contentato di commandar le galere che servivano in Italia"); da questo punto in avanti manca quindi una fonte
primaria per poter seguire gli spostamenti e le motivazioni dei suoi interventi sui diversi fronti dello scacchiere spagnolo nel
Mediterraneo.
Nel 1563-1564 fu variamente impegnato, al seguito della flotta, senza particolari incarichi (aveva affidato le sue galere al fratello
Pagano, proprio per non dover ubbidire ad altri comandanti spagnoli, che precedentemente, quando era luogotenente di Andrea, gli
erano stati in sottordine). Dall'Africa settentrionale alla Corsica, e poi all'espugnazione di Peñon de Velez, seguendo i diversi e vari
spostamenti dei fronti militari, ora contro i pirati barbareschi, ora direttamente contro la flotta turca, il D. cercò di distinguersi e
guadagnare l'encomio per i servigi resi (come appunto fu a Peñon, dove si meritò le lodi di don Garcia de Toledo).
Nel 1565, dopo un soggiorno primaverile a Madrid, ove non riuscì a strappare nuove condizioni per l'asiento delle galere, fu
impegnato sia in attività di supporto alla repressione della rivolta in Corsica sia, successivamente, nella più complessa e difficoltosa
impresa di portare soccorso a Malta, assediata dai Turchi, dove ebbe modo di palesare capacità e coraggio. Solo nel 1566 potrà
finalmente rinnovare le condizioni dell'asiento per le sue galere. Dalla corrispondenza, così come da altri documenti, risulta evidente
come queste fossero senz'altro una importante fonte di guadagni, ma anche origine di preoccupazioni, e di continue liti e cause con
l'amministrazione spagnola: ora erano i ritardi nei pagamenti, ora si trattava della questione dei diversi e aggiuntivi diritti legati al
contratto di asiento (adesempio, importantissime, le licenze di esportazione di grano; o tutto ciò che era connesso al consumo di
biscotto); ora la valutazione o il rifornimento di forzati. Quindi le galere rendevano, ma potevano anche essere fonte di problemi,
soprattutto in un periodo in cui il D. doveva avere notevoli preoccupazioni di liquidità.
Per il 1568, ad esempio, abbiamo un interessante documento conservato tra le sue carte: si tratta di una istruzione data a Giovan Paolo
Pianta (uno dei tanti dottori di cui sempre il D. si avvalse e si attorniò, cosi come in parte aveva già fatto Andrea), inviato a Madrid
per ridiscutere le condizioni dell'asiento: dopo aver riassunto le vicende passate, il D. mette in evidenza alcuni punti dell'opera che il
Pianta avrebbe dovuto svolgere a Madrid, soprattutto con coloro che tenevano il controllo dei cordoni della borsa ("a me più importa
il consiglio d'azienda che quello di stato"), visto che vantava nuovamente un credito di 100.000 scudi. Lo illuminava sui diversi
"partiti" allora attivi a corte, e gli rammentava infine l'importanza di un continuo e preciso rifornimento di forzati dallo Stato di
Milano e da quello di Napoli (per queste citazioni cfr. Roma, Archivio Doria Pamphili, 75.36).
Ma, prova evidente delle difficoltà in cui il D. si trovava, il 1568 è anche l'anno in cui egli ottenne l'assenso regio alla vendita del
ducato di Tursi (lo comprò, sembra per 55.000 scudi, Galeazzo Pinelli che ne sarà compiutamente investito con il titolo di marchese
nel 1572; ma quando gli affari si erano ormai nuovamente riassestati, dopo una lunga trattativa conclusasi nel 1594, il D. lo riacquistò
per il figlio Carlo).
Nel 1569 nacque la figlia Vittoria, la prima (a differenza di precedenti figli maschi) a sopravvivere oltre la più tenera età, e nel 1570
nacque Andrea, anch'egli destinato a vivere e a succedere al D. come primogenito.
Intanto la diplomazia pontificia e quella veneziana cercavano di organizzare una spedizione navale in Levante, che avrebbe dovuto
alleggerire la pressione turca sulle colonie veneziane, allora concentrata soprattutto contro Cipro; il problema più difficile era
coinvolgervi anche la Spagna, la cui attenzione era invece prevalentemente rivolta verso l'Africa settentrionale e il Mediterraneo
centroccidentale. Quando nel luglio del 1570 Leonardo Donà, ambasciatore veneziano in Spagna, riuscì a scrivere che finalmente era
stato dato ordine al D. di riunirsi alla flotta della Lega, allora si poté dire che il lungo lavorio diplomatico era stato coronato da
successo.
Alla spedizione il D. partecipava con undici galere sue; ve ne erano inoltre ai suoi ordini quattro di Ambrogio Negrone e una di
Giorgio Grimaldi, mentre con le altre squadre di Napoli e di Sicilia (sempre sotto il suo comando), ve ne erano sette di altri genovesi.
Nonostante i buoni auspici della partenza, l'impresa si rivelò presto difficile, per poi tramutarsi sostanzialmente in un nulla di fatto. I
problemi erano molteplici: vi era innanzitutto la questione del comando della flotta, attribuito a Marcantonio Colonna, e questo, come
scriveva il cardinal Ch. d'Angennes de Rambouillet a Carlo IX, avrebbe potuto creare problemi di rapporto con il D., "ayant de
longtemps commandé en chef, esté général de bonne partie de galères de son maitre, et tenu le premier homme de mer qui soit
aujourd'hui en Italie" (Charrière, III, p. 119). Vi era poi la questione degli ordini spagnoli: si è a lungo favoleggiato di ordini segreti di
Filippo II, ma l'ipotesi più verosimile è che questi fossero sostanzialmente poco chiari: da un lato si indicava al D. di congiungersi con
la flotta della Lega, ma dall'altro di mantenere le forze intatte per una progettata spedizione a Tunisi. Si aggiunga poi che la flotta
veneziana palesò subito gravi mancanze nell'organizzazione, soprattutto a livello di equipaggi; e si aggiunga inoltre che una parte di
questi cadde malata già nella navigazione di avvicinamento.
Le previsioni del Rambouillet si rilevarono presto esatte: sorsero contrasti sulla gestione della spedizione tra il D., da un lato, e il
Colonna e i Veneziani, dall'altro; i motivi su cui il D. fondava il suo rifiuto di proseguire la spedizione, e soprattutto di andare a
combattere a Cipro, erano essenzialmente fondati sulla stagione avanzata e sul pessimo stato delle galere veneziane: in una allarmata
lettera a J. de Zuñiga, ambasciatore spagnolo a Roma, rilevava come i Veneziani fossero con pochi rematori, e come le loro galere si
muovessero quindi con grande lentezza e disordinatamente (cfr. G. Molini, Documenti di storia italiana, Firenze 1836, II, pp. 481-84).
1 contrasti si risolsero quando il 10 ottobre a Creta il D. decise di abbandonare il resto della flotta e di ritornarsene in Italia, dove
giunse il 18.
Iniziò allora una battaglia di scritti accusatori e denigratori, che vedevano il D. parzialmente sulla difensiva, imputato di aver
abbandonato gli alleati in un momento critico. La storiografia più recente ha in parte rettificato il giudizio di molta storiografia
ottocentesca, riprendendo quello che era stato un commento a caldo dell'informato Gabriele Salvago: "è stato buon consiglio non
aggiungere con nuovo pericolo maggior danno al nome cristiano". E così, se il Serrano ha parlato di "cautelosa conducta", il Braudel
non solo ha sottolineato l'improvvisazione nella preparazione della spedizione, ma anche il fatto che, in conseguenza del maltempo e
della stagione così avanzata, solo al D. "réussit l'exploit de ramener toutes ses galères à Messine", mentre le altre squadre subirono
notevoli perdite.
Nonostante le voci circolate, il D. in dicembre si recò a corte, dove il suo comportamente non sembra abbia ricevuto critiche
particolari; e anzi fu lui a porre in discussione la prosecuzione del suo rapporto con la Spagna: i 6.000 scudi all'anno per galera non
erano sufficienti (tanto che si continuava a parlare di un suo indebitamento per 200.000 ducati), e il D. iniziò a prospettare l'idea di
vendere le galere allo stesso re di Spagna.
Leonardo Donà avvertiva subito Venezia, pur sottolineando i dubbi di un progetto del genere: "se ben questo ... partito è offerto in
parole, non vedo già io però che l'intentione sua sia di privarsene, perché veniria insieme a perdere la maggior parte della riputatione
che ha, essendo che con un corpo de armata de undici galere che possede, mette quasi in necessità questa corona di valersi di lui"
(Lacorrispondenza di Leonardo Donà, p. 169). Come osserverà lo stesso Donà in un dispaccio successivo vi erano anche altri motivi
che lo spingevano a dubitare di un simile progetto: "riesca pur il partito quanto largo si voglia, egli con questa vendita vien ad liaver
perso et in Genoa et da per tutto molto della sua prima reputation" (ibid., p. 270).
Il Donà aveva ben compreso la duplice importanza che ricoprivano le galere per il D.: da un lato, grazie ad esse, possedeva una
notevole capacità di pressione nei confronti della Spagna; dall'altro, la base del suo potere a Genova si fondava essenzialmente sul
rapporto che sarebbe riuscito a mantenere con gli Spagnoli, e quindi sul fatto di essere il pffi forte asentista. Ementre il D. si faceva
abbellire e dorare la poppa della capitana dall'artista genovese Lazzaro Calvi, tra le corti europee si metteva a punto la "santa lega"
che avrebbe dovuto finalmente affrontare in uno scontro frontale la flotta turca.
Il 5 maggio 1571 il D. fu chiamato da Filippo II a far parte del comando del corpo di spedizione spagnolo: al primo posto don
Giovanni d'Austria, al secondo L. de Zuñiga y Requeséns e al terzo il Doria. Mentre fervevano i preparativi per l'allestimento della
flotta e il trasporto delle truppe in Italia meridionale e in Sicilia, il D. viveva giorni contradditori: agli inizi di agosto era tutto proteso
al futuro confronto con il nemico, desideroso di far vedere le proprie capacità, alla ricerca dell'agognato "honore", ma al contempo
non aveva certo scordato la "robba". Stipulava così un primo accordo per la vendita delle galere; però, quando venne a sapere che il re
aveva intenzione di rivenderle al ricco banchiere Nicola Grimaldi (detto il "Monarca"), cercò ogni modo per ritornare sulla decisione.
Il 5 settembre Andrea Provana di Leynì scriveva ad Emanuele Filiberto di Savoia: "qua è venuto nova che S. M. vende le galee dil
signor Gio Andrea Doria al signor Nicolò de Grimaldo, il che ha dato già disgusto et alteratione al detto signor Gio Andrea et a tutti
suoi amici, credo che poi non si è ancora fata la consegna, s'andara buscando modo et via di romper la prima vendita acciochè questa
non habbi effetto, et pur che si possi fare non mancheranno dinari et amici. Pagano suo fratello per ciò li ha fatto donatione di tutto il
suo, et dice di voler andar a Malta et pigliar quel habito" (Promis, p. 625).
Il Provana era ben informato, perché proprio lo stesso giorno il D., in una lettera alla madre (Roma, Arch. Doria Pamphili, 69.24),
scriveva che, a fronte della sua decisione di vendere le galere, il fratello Pagano si era offerto di cedergli tutti i suoi beni, e di farsi
cavaliere di Malta, non volendo che "cose tanto antiche della nostra casa dovessero cadere in altre mani, che in quelle del Re". Ma è
soprattutto in una lettera indirizzata al colto e potente Giulio Claro (ibid.) che il D. palesa i suoi sentimenti (e, di fatto, riconosce di
dover subire l'astuta contromossa di Filippo II).
"Estrema fu la necessità et impossibilità che mi astrinse a disfarmi delle galere, ma se mi fosse mai caduto in pensiero che con le
medesime si dovesse cercare di far grande nella mia terra persona di così poca parte e di si bassa professione come è Nicola di
Grimaldo, et che non ha servito al Re, se non con infinito danno delli regni di S. M.tà o delle rendite di essi, havrei più tosto sofferto
(mettendole fuoco) di rovinare a un tempo la casa mia et quelle degli amici et parenti miei, che per haver poste tutte le facultà loro per
aiutarmi a sustentarle, corrono meco una medesima fortuna" (ibid.).
Così al D. non restava altro che "correre la sua fortuna"; rotto il contratto, incaricò Agostino e Nicolò Lomellini e Nicola Spinola di
assicurare le galere per i mesi di ottobre e di novembre per 100.000 scudi (e il giorno dopo la battaglia di Lepanto si affrettò a scrivere
ai Lomellini: "poscia che le cose stanno in questo termine, non accaderà che si prenderà più fastidio di fare assicurare le mie galee per
il mese di novembre": ibid., 69.24).
Gli ordini che don Giovanni d'Austria promulgò il 14 settembre sottolineavano l'importanza del ruolo del D.: gli era infatti affidato il
corno destro dello schieramento (in cui erano anche tutte le sue galere, oltre a quelle di un nutrito gruppo di altri genovesi).
La battaglia di Lepanto non fece che rinnovare le voci dell'anno prima: il fatto che il D. avesse impostato grandi evoluzioni delle
galere a lui affidate, per evitare l'accerchiamento da parte del ben più nutrito e poderoso corno sinistro turco, fece gridare allo
scandalo.
Sottilmente velenose sono le parole con cui il pur posato Paolo Paruta commenta la tattica del D.: "quasi uscendo dal pericolo, volesse
mettersi in luogo di poter accomodarsi a qualunque evento in quella giornata. Quale in ciò si fusse l'animo di lui è troppo difficile cosa
l'investigare".
Anche negli ambienti pontifici gli umori non erano dei migliori nei confronti del D.; e non è da escludere che vi siano state pressioni
romane in una decisione spagnola che di lì a poco lo amareggiò non poco. Tra ottobre e novembre, infatti, gli fu si rinnovato l'asiento
per le galere (con le prede di Lepanto sperava, tra l'altro, di armarne una dodicesima), ma gli fu anche comunicato che, nonostante
L'espresso desiderio di don Giovanni (con cui restò sempre in ottimi rapporti), era tolto dal numero di coloro che dovevano affiancare
il giovane principe nelle progettate spedizioni dell'anno successivo (e al suo posto, come era stato suggerito dal papa, venne invece
nominato l'anziano Antonio Doria, con il quale i rapporti erano da tempo piuttosto tesi).
Il 1572 passo senza incarichi particolarmente gravosi, in parte a corte a ridiscutere l'asiento (il D. ottenne che le galere impegnate
fossero dodici "che si contano per 13"), in parte a Genova dove la situazione finanziaria non si presentava, nonostante tutto, delle più
rosee (il D. accese diversi censi sul feudo di Torriglia che gli era stato dato dal fratello Pagano); nell'estate fu presente insieme al duca
di Sessa ad alcune fasi della spedizione di don Giovanni d'Austria, spedizione che però non portò a nulla, anche perché i membri del
suo consiglio erano divisi tra chi propendeva per una ripetizione delle mosse dell'anno precedente verso Levante e chi voleva, invece,
che la flotta si dirigesse in Africa, come in effetti avvenne l'anno successivo con la spedizione di Tunisi.
Nel 1573 nacque il figlio Giannettino (destinato alla carriera ecclesiastica, dopo gli studi all'università di Salamanca), e don Giovanni
d'Austria rinnovò al D. tutta la sua stima, chiedendogli di accompagnarlo appunto nell'impresa di Tunisi (a capo della fanteria andrà il
fratello Pagano); ma il 1573 è anche l'anno in cui a Genova vennero a maturazione i processi di crisi all'interno del sistema di potere
patriziale e in cui le soluzioni istituzionali escogitate tra il 1527 e il 1547 mostrarono tutti i loro limiti.
Il D. si sentì investito di nuove responsabilità: alle prime notizie che non vi era stato accordo nel rinnovo dei governatori, nel luglio
del 1573, scrisse una preoccupata lettera alla Repubblica, lamentandosi della "poca conformità" seguita nelle procedure elettorali (cfr.
Arch. di Stato di Genova, Archivio segreto 1967). Nel settembre partì da Savona con venti galere per raggiungere don Giovanni a
Tunisi, ma il maltempo impedì il congiungimento delle squadre. E così decise di far svernare le galere nel porto di Genova; e, mentre
scriveva a Filippo II di credere che la situazione genovese si sarebbe evoluta per il meglio, al contempo, memore di quello che era
successo nel 1547, decise anche di assoldare un centinaio di fanti da porre a guardia delle galere.
Il 1574 si presentò come un anno difficile, nonostante fosse allietato dalla nascita della figlia Artemisia, che sarà poi la sua figlia
prediletta (nel 1576 nascerà l'ultimo figlio, Carlo), e nonostante il fatto che il D. ricevesse un importante riconoscimento da parte
spagnola, con la nomina a membro del Collaterale di Napoli (cui era legato un compenso di 3.000 ducati, che gli furono però tolti nel
1579 quando fu investito della commenda di Caravaca). Si è detto un anno difficile, in quanto la situazione genovese non evolveva
certo per il meglio, anzi, molteplici erano i segni del radicalizzarsi dei rapporti tra nobiltà "vecchia" e "nuova"; e il D. (insieme col
suocero Marc'Antonio Del Caretto ed Antonio Doria) si sentì investito di responsabilità di direzione all'interno della nobiltà "vecchia";
per il momento le responsabilità politiche furono assunte maggiormente da Marc'Antonio, il quale infatti elaborò anche un progetto di
riforma costituzionale, che fu oggetto di ampie ed aspre discussioni cittadine.
Anno difficile anche per quanto riguardava la questione dell'impresa di Tunisi: infatti, quando agli inizi di settembre il D. partì in
soccorso del corpo di spedizione con una flotta di quaranta galere, non sapeva ancora che in realtà il forte era già caduto e il fratello
Pagano era morto.
Con la fine del 1574 e gli inizi del 1575 divenne palese a Genova che la situazione non era più risolvibile entro gli schemi del
tradizionale conflitto politico; i "vecchi" si armavano e reclutavano uomini nei loro feudi; il D. mantenne la guardia armata alle galere,
ma agli inizi di febbraio, insieme agli altri asentistas, decise di non lasciarle più in darsena per non correre troppi pericoli. A quel
punto il D. non poteva più restare sullo sfondo dello scontro politico e partecipò così direttamente alle riunioni della deputazione dei
"vecchi" (una specie di organizzazione di tipo partitico) e agli incontri che avvennero con la deputazione dei "nuovi", anche perché
era opinione diffusa (come pensava ad esempio Marco Gentile) che lui fosse "capo di tutta la Nobiltà"; e delegati dei "vecchi" a
trattare espressamente con lui furono Stefano De Mari e Giorgio Doria, entrambi esperti in questioni militari.
Anzi, quando ormai tutto lasciava presagire che si sarebbe arrivati allo scontro, il D. si fece protagonista di un'iniziativa che sarebbe
dovuta servire a creare divisione tra ceti popolari e nobiltà "nuova": convocò i consoli delle arti e pronunciò un discorso fortemente ad
effetto. Secondo un'altra fonte (la cronaca redatta dall'ex doge G. B. Lercari) con il discorso fatto ai tessitori di seta, la più numerosa e
temuta corporazione di lavoranti, entrò ancor più nel merito della polemica, affermando che "con il favore de vecchi havevano
ottenuto che non fussero obbligati a lavorare salvo al pretio che convenissero e che dovessero essere pagati in denari e non in grano ne
robbe" (essendo a tutti noto che gli imprenditori tessili erano soprattutto tra i nobili "nuovi").
Nonostante questi tentativi, l'insurrezione vi fu egualmente, anche se non accaddero fatti di sangue particolarmente gravi; i soli morti
furono proprio alcuni soldati del D., assaliti dalla folla, quando si allontanavano dalla darsena, per ottemperare agli ordini del Senato.
Subito dopo l'insurrezione iniziò l'esodo della nobiltà "vecchia" dalla città, e, come annota un'anonimo, "le galere del S. Gio. Andrea
sono hora mai diventate le gondole di Venetia poiché ogni giorno non fanno altro che traghettare per la rivera robe, famiglie di questo
et di quello" (cfr. Arch. di Stato di Mantova, Arch. Gonzaga, Corrispondenze estere, 766).
Il D. non si preoccupò solo di aiutare a mettere in salvo famiglie e masserizie; iniziò subito una articolata manovra di contrattacco
politico e, in prospettiva, militare. Trasferitosi a Napoli, insieme con Antonio Doria cercò di convincere il viceré a non autorizzare
esportazioni di grano verso Genova. suscitando l'allarmata reazione del nunzio Antonio Sauli (Nunziatura di Napoli, I, Roma 1962, p.
324), che scriveva a Roma: "questo è mettere in disperatione quel popolo ... et sarà interpretato in Genova questo fatto intimatione di
guerra". Il D. sviluppò un'accorta propaganda, scrivendo e facendo circolare lettere e corrispondenze, come quella con l'ambasciatore
genovese in Spagna, Marcantonio Sauli, in cui metteva in evidenza i pericoli derivanti dall'affermarsi in città dei gruppi radicali ("se
quei di S. Luca [i "vecchi"] sono ora fuori, si può temere che un'altra volta vi saranno quei di S. Pietro [i "nuovi"], o saranno tutti
insieme a termine che non potranno dire questo è mio!": cfr. Olivieri, 1857, pp. 562 s.). Al contempo il D. riaffermò in ogni modo il
principio che nel sistema di governo della Repubblica si doveva trovare un modo di garantire una sostanziale equipartizione tra
"vecchi" e "nuovi".
Il concetto è molto ben spiegato in una lettera al cardinale B. Lomellini, che rappresentava gli interessi dei "vecchi" alla corte
pontificia (non aliena, in realtà, da simpatie per i "i nuovi"): "non voglio dire ne pretendere che il governo sia partito per metà fra le
due parti, ma si bene che si acautelli che alcuna di loro non possa essere esclusa come si va camino manifesto di fare con
l'osservatione della nuda legge del 528" (cfr. Roma, Arch. Doria Pamphili, 84.32).
Soprattutto a partire da metà giugno diventò evidente per il D. che l'unica soluzione praticabile era quella militare, sebbene non si
presentasse di facile attuazione. Anche perché al momento non era ancora del tutto chiaro l'atteggiamento spagnolo: il D. aveva gia
quasi reclutato un reggimento di fanti da tenere sulle galere, ma sollecitava una formale autorizzazione da don Giovanni d'Austria. E
con l'arrivo a Genova di due inviati francesi, Gian Galeazzo Fregoso e Mario Birago, diventava evidente la possibilità di una
internazionalizzazione del conflitto.
Tardava in realtà l'autorizzazione spagnola, anche perché difformi erano i pareri all'interno del Consiglio di Stato; e se vi era chi,
come il duca d'Alba, non sarebbe stato alieno da un colpo di mano, vi era anche chi ricercava una soluzione tutta politica. Il D. in
luglio era ormai pronto a intervenire; a Napoli, però, don Giovanni e il Granvelle insistevano per rinviare tutto all'arrivo della formale
autorizzazione regia. In agosto il D. ritornò al Nord, dove a Finale erano riuniti i capi dei "vecchi" e li sollecitò a pagare le quote
stabilite ("avendo esagerato molto sopra il particolare dei denari", come scrisse un osservatore; cfr. Olivieri, 1857 p. 167), e intanto
mandava per il mar Ligure le sue galere a svolgere opera di intimidazione e pressione.
Faceva senz'altro parte dei preparativi politici della guerra anche la lettera che il D. scrisse il 20 agosto al Senato della Repubblica (e
che provvide a diffondere in stampa) in cui invitava i "nuovi" al governo ad accettare la proposta di compromesso. E agli inizi di
settembre incaricò Giacomo Di Negro di preparare una lettera-manifesto indirizzata al "popolo", da far diffondere in città.
Tutta l'attenzione era pero rivolta ai preparativi militari: i "vecchi" erano ormai riusciti a mettere assieme venti galere, erano riusciti ad
assoldare altre fanterie, licenziate temporaneamente dal governatore di Milano; e così il 4settembre il D. stilò gli ordini di
combattimento, benché non fosse stato ancora formalmente autorizzato da don Giovanni.
Probabilmente vi fu qualche doppiezza da entrambe le parti nel decidere i tempi della guerra; don Giovanni infatti autorizzò la mossa
d'armi il 13 settembre (e decidendo di sospendere da quella data il "soldo" per le galere); ma a Madrid il 1º settembre era già stato
stabilito di rimettere in discussione tutti i debiti contratti con i banchieri genovesi, che erano esclusivamente nobili "vecchi", i quali
d'altronde non aspettarono l'autorizzazione di don Giovanni.. L'11 settembre il cardinale G. Morone, legato pontificio a Genova,
scriveva preoccupato al D., chiedendogli i motivi per cui i deputati dei "vecchi" avevano improvvisamente lasciato la città. E infatti il
12, a Finale, i "vecchi" decisero di aprire le ostilità nominando il D. comandante in capo dell'impresa.Le operazioni militari furono
condotte all'inizio con notevole abilità: fu occupata la Riviera di Levante e contemporaneamente fu portato l'assalto da terra contro
Novi; all'interno della stessa nobiltà "vecchia" emersero però tendenze critiche (di cui è testimone Giovanni Salvago) per la piega che
successivamente presero gli avvenimenti.
"Arrivò Giovanni Andrea nel golfo de la Speza, dove alzò il stendardo de la croce rossa di Sancto Georgio, pottendosi con verità dir
quello de la vera republica, essendo nobili più interessati in quella che populari et plebei ... si fermò nel locho di Vado alle speze de
poveri nobili, facendo scaramuze vane con quelli contadini et con li soldati erano in Savona".
In effetti, i contendenti in lotta erano poco preparati a condurre una guerra di lungo periodo: i "nuovi" a Genova non disponevano di
una flotta militare e avevano problemi politici al loro interno; i "vecchi" sapevano di dover pagar di tasca propria i costi della guerra e
la sospensione dei pagamenti voluta da Filippo Il poneva grosse ipoteche alla loro capacità di movimento. Lo schieramento politico
italiano si era poi pronunciato unanime contro i pericoli di una guerra che turbava profondamente gli equilibri ormai consolidati degli
Stati.
Prevalse così la linea della trattativa diplomatica: dopo che fu stipulato il compromesso e deciso il trasferimento delle trattative a
Casale, il D. si spostò a Napoli, da dove, con il consiglio dell'esperto Granvelle, seguiva l'operato dei deputati dei "vecchi", non
lesinando loro consigli, come quando scrisse che non era il caso di rendere troppo difficoltoso l'accesso alle magistrature cittadine, ma
"già che si vogliono l'unico ordine, sia la riforma tale che l'ordine sia unico in effetto, et per questo è di necessità, a parer mio, che si
levino i mecanici" (Roma, Archivio Doria Pamphili, 84-32). Il D. interpretava bene la sensibilità della nobiltà "vecchia"; e l'esclusione
delle frange "artigiane" dal corpo della nobiltà fu in effetti uno dei risultati delle Leges novae, stabilite a Casale, che furono poi
promulgate nel marzo dell'anno successivo.
La fine della guerra civile permise al D. di dedicarsi con maggiore tranquillità a problemi patrimoniali, e anche domestici: pensò di
ingrandire i propri possedimenti appenninici, mettendo gli occhi sul marchesato di Santo Stefano, allora infeudato all'anziano Antonio
Doria (riuscirà ad acquistarlo solo nel 1592, per più di 290.000 lire, grazie anche al fatto che nel 1591 la popolazione del luogo si era
ribellata a G. B. Doria, e il D. era riuscito ad impedire che se ne impadronisse la Repubblica di Genova). Fece eseguire diversi lavori
di ristrutturazione e di decorazione alla villa di Fassolo: si ampliò l'ala occidentale, si iniziarono a costruire le logge laterali (lavori che
farà poi eseguire anche nella villa Centurione di Pegli e nel palazzo Grimaldi di strada Nuova, acquistata l'una nel 1584, e l'altro nel
1596; l'acquisizione di questo palazzo, destinato al figlio Carlo, rappresenta molto bene il permanere di un interesse per gli
investimenti immobiliari di grande prestigio). Commissionò a Lazzaro Calvi cicli di affreschi, e allo stesso (insieme a Luca
Cambiaso) darà l'incarico negli anni successivi di preparare cartoni per arazzi, che risultano essere una delle forme d'arte da lui
preferite: dai "libri d'azenda" così come dagli inventari post mortem risulta evidente come di non grande importanza fosse la
quadreria, mentre risaltavano per il loro valore sia le collezioni di arazzi sia quella di oggetti d'oro e d'argento.
Gli anni successivi non si segnalano per episodi di rilievo: il D. continuò a ricoprire l'incarico di maggior asentista di galere e ad
essere a Genova il punto di riferimento centrale per la Spagna: le sue galere, oltre ad essere impegnate nella normale attività di
salvaguardia delle coste nella lotta contro la pirateria barbaresca e turca, contribuirono al trasporto di contante per l'esercito spagnolo
impegnato nella guerra delle Fiandre (dalle quali don Giovanni d'Austria gli scriverà accorate lettere, lamentando lo stato di
isolamento politico e diplomatico in cui si trovava); servirono a traghettare personaggi di prestigio, come l'imperatrice (e tutti
ammirarono lo sfarzo esibito nelle livree delle ciurme, tutte vestite di velluto verde); o servirono a trasportare con sicurezza e
discrezione le reliquie di s. Lorenzo destinate all'Escorial.
Certo è che non c'era più spazio a grandi iniziative militari e il D. si rendeva conto che forse un ciclo della storia economico-militare
delle galere si stava per concludere: agli inizi degli anni Ottanta il fulcro della guerra spagnola si spostò verso il Mare del Nord e
l'Atlantico, in cui le galere non erano facilmente impiegabili. All'interno della stessa amministrazione spagnola si confrontavano le
diverse posizioni di coloro che erano favorevoli al sistema degli asientos e di chi invece pensava che fosse più conveniente dare le
galere, proprie, in administración; si aggiunga poi che i ritardi nei pagamenti erano ormai tali da rendere non sempre appetibile per un
privato la gestione di uno stuolo di galere.
Così nel 1582 il D. si liberò di quella che era stata considerata fino ad allora la principale base del suo potere: vendette dieci galere
alla Spagna, che provvide poi a cederle a tre genovesi (due a G. A. De Marini e quattro ciascuno ad Agabito Grillo e Cosma
Centurione). Per sé ne riservò due (pagate "come tre") e si orientò verso una partecipazione più personale alla politica spagnola.
Era stato lo stesso Granvelle ad osservare che il D. sarebbe stato utile anche senza lo stuolo delle dodici galere e che avrebbe potuto
essere un buon "consigliere". E infatti nel 1582 iniziarono a circolare le voci di una possibile nomina del D. a "generale del Mare".
Nel febbraio del 1583 Filippo II gli scrisse prospettandogli, finalmente, l'agognata nomina. Nel settembre il D. si trasferì in Spagna e
tra novembre e dicembre la pratica, grazie anche al fattivo contributo del Granvelle, venne conclusa. Il D. fu così nominato generale
del Mare con le stesse "preminenze" che avevano avuto don Giovanni d'Austria e don Garcia de Toledo; gli fu dato allora un assegno
di 12.000 scudi per sé, Più 4.000 per i suoi gentiluomini (a Madrid, in effetti, aveva un piccolo seguito composto da un numero
imprecisato di "intrattenuti", diciotto "creati", la guardia, un medico e una persona di fiducia, che era allora il genovese Pietro Serra).
Tra gli anni Ottanta e Novanta il D. condusse un'accorta politica matrimoniale per figli e figlie: Vittoria sposò Ferrante Gonzaga, ad
Andrea andrà Giovanna Colonna, Artemisia si unirà con Carlo Borgia di Gandia e solo Carlo sposerà una genovese, Placidia Spinola.
Nonostante il chiaro impianto politico di questi matrimoni, il D. si manifesta nelle lettere (come poi nei testamenti) un padre molto
affettuoso e attento, preoccupato di tutto ciò che succedeva nelle famiglie, in specie delle figlie.
Nonostante questa proiezione italiana ed europea del D. e della famiglia, restavano però anche problemi connessi alla presenza in città
di un potere personale così chiaramente "ingombrante" nella piccola, e pur faziosa, Repubblica genovese.
Questioni puramente protocollari si intrecciavano con temi di maggiore rilevanza politica. Ad esempio l'annalista Antonio
Roccatagliata (un nobile "nuovo") scriveva che, nel 1584, in città vi era "odio universal de cittadini verso del Doria" per i suoi
portamenti altezzosi, susseguenti appunto alla nomina a generale del Mare (e un altro incidente protocollare avvenne nel giugno dello
stesso anno nel mar Ligure con Marcantonio Colonna, allora in trasferimento verso la Spagna). Ma insieme con questioni puramente
di forma si trovano questioni più iniportanti: ora gli si vietava di entrare in città scortato dai suoi alabardieri (soprattutto finché non
avesse dato del "serenissimo" al doge), ora si apriva addirittura un procedimento penale contro uno dei suoi ufficiali, Leonardo
Spinola, perché aveva minacciato la galera capitana della Repubblica, sempre per questioni di saluti.
Ma nonostante questi attriti la presenza del D. nella vita cittadina restava dominante, nonostante l'informalità degli interventi:
nell'elezione di dogi e governatori l'appoggio del D. diventava necessario, o, al contrario, ci si schierava contro questo o quello,
proprio perché appoggiato da lui. Certo è che pure alcuni esponenti della nobiltà "nuova" (un David Vaccà o un Matteo Senarega)
raggiunsero la carica di doge grazie anche ai buoni rapporti che avevano saputo mantenere con il D., nonostante il loro passato di
capifazione; mentre il D. entrerà in aperto dissidio con altri esponenti dei "vecchi", come un Giorgio Doria, uno Stefano De Mari o un
Ambrogio Spinola.
Ma al D. si guardava come interlocutore possibile anche dalla lontana Inghilterra: quando l'abile, e transfuga, Orazio Pallavicino nel
1586 cercò di riattivare canali di comunicazione con la Spagna, per discutere delle possibili condizioni di pace, mandò il fratello
Fabrizio, rimasto a Genova, con il potente suocero di questo, Lazzaro Grimaldi, a discutere proprio con il D.; il quale farà sapere che
finché fossero continuate le scorrerie di F. Drake, sarebbe stato molto difficile intavolare serie trattative.
Con gli anni Novanta iniziarono a palesarsi nel D. i primi segni di invecchiamento, legati anche alla salute malferma; tanto che fu lui
stesso a chiedere nel 1594 di essere sostituito al comando delle galere, ma per il momento non se ne parlò più oltre; anzi, proprio in
quell'anno il D. aggiunse una nuova e ambita qualifica al suo cursus honorum. essendo stato nominato membro dei Consiglio di Stato.
Si può dire che a questo punto il D. aveva raggiunto l'ambito obbiettivo di avere "honore et robba". Ascoltato membro del Consiglio
di Stato, generale del Mare, insignito di onorificenze e titoli (ma non ebbe il Toson d'oro, che andò invece al figlio Andrea), aveva
saputo mantenere, prima, e mettere assieme, poi, un ingente patrimonio. Il suo patrimonio immobiliare era estesissimo: andava dallo
Stato di Melfi (di cui era entrato nel pieno possesso alla morte di Zenobia, avvenuta il 18 dic. 1590) ai numerosi feudi appenninici, a
Loano; in città e dintorni non sembra avesse una proprietà immobiliare diffusa, ma questa era concentrata attorno alla villa di Fassolo
(dove a partire dagli anni '90 lavorarono Marcello Sparzio e il Brandimarte), il palazzo di strada Nuova, la villa di Pegli, oltre alle due
case avite di "piazza Doria"; nel 1593 i soli "mobili di casa" erano valutati a più di 500.000 lire (più del doppio in valore, per fare un
paragone, del feudo di Tursi, o del palazzo di strada Nuova).
Meno presente, ovviamente, sul fronte militare navale, partecipava però - se così si può dire - alla vita politica spagnola stilando
relazioni, pareri, consigli, come quelli pubblicati nell'Ottocento nella Colección de documentos inéditos... relativi a questioni di
armamento, o al problema dell'oro e dell'argento americani (in uno di questi, nonostante l'ufficialità del rapporto, affermava che nel
Consejo de hacienda "no hay hombre ninguno que sepa de la materia que alli se trata" cfr. Codoin, II, pp. 171-74).
Le condizioni di salute, però, spingevano il D. a ritirarsi, tanto che nel 1599 (morto nel frattempo Filippo II) ne chiese l'autorizzazione
al nuovo re; ma Filippo III per il momento respinse le dimissioni; e, anzi, circolò a Genova la voce che gli fosse stato raddoppiato lo
stipendio (sarebbe stato portato alla cospicua cifra di 40.000 scudi annui). Fedele all'immagine di difensore degli interessi spagnoli
(anche i più miopi), nel 1600 fece si che si giungesse all'espulsione da Genova di monsignor Goffredo Lomellini, ben noto per le sue
iniziative in favore di Enrico IV (e così negli anni successivi metteva in guardia il Senato sulle relazioni di Claudio De Marini con il
granduca di Toscana, a suo parere troppo strette).
Ma fu col 1601 che si prospettò al D. la possibilità di legare il proprio nome a qualcosa di veramente "honorato". A giugno chiese al
Senato il permesso di far transitare da Vado 4.500 fanti per imbarcarli sulle galere; per il momento era tutto segreto ("disegnando fare
un'impresa non penetrata" annota Giulio Pallavicino), e tale resterà almeno fino a metà luglio. Il progetto, per riuscire, doveva
rimanere il più possibile riservato, trattandosi, in effetti, di un'impresa altamente difficile e rischiosa, vale a dire occupare Algeri.
I preparativi per armare un'armata di circa 70 galere e 10.000 fanti non potevano passare del tutto inosservati; ben presto si conobbe
anche l'obbiettivo (ed Enrico IV commentò: "j'ay l'opinion que le bruit en sera plus grands que l'effet"). In realtà, sembra che anche i
preparativi non fossero all'altezza dell'impresa (il Conestaggio nella sua Relazione insisté molto sulle gelosie dei viceré spagnoli), ma,
nonostante ciò, il D. non desistette. Secondo il Conestaggio, "in ogni luogo conobbe che non si corrispondeva a gl'ordini del Re ne a'
suoi ... ma come la cupidità della gloria si stenda più oltre che quanto è lungo lo spatio dell'humana vita, il Principe (se ben vecchio)
avido di gloria volle superar con la diligenza e con la virtù quando fosse possibile ogni difficultà".
Il progetto era di giungere nei pressi di Algeri, sbarcare di notte compagnie scelte di archibugieri che occupassero una delle porte
della città, e poi intervenire massicciamente con la flotta. Giunti però in vista della città nemica, si alzò una bufera di vento, e, scrive
ancora il Conestaggio, "convenne ... correr anche con le galee dove il maledetto vento voleva"; la flotta si ritrovò il 3 sett. 1601
nuovamente a Maiorca, da cui era da poco partita, senza poter concludere niente.
E cosi svanì l'ultima speranza di una "notabile fattione". Le conseguenze furono rapidamente tratte; il D. presentò nuovamente le
dimissioni da generale del Mare (chiedendo però che gli fosse conservata più della metà dello stipendio, affinché Potesse far vedere al
"mondo" di essere ancora in grazia del re), e questa volta furono accettate. Il 12 dicembre il Senato di Genova gli decretò onori
particolari, tra cui l'erezione di una statua analoga a quella di Andrea, con il titolo di "patriae libertatis conservator" (la statua fu
scolpita da Taddeo Carlone, che già aveva lavorato per lo stesso D., ad esempio nei lavori di abbellimento del palazzo di strada
Nuova).
La vita del D. lentamente si chiudeva, anche se occupava sempre la scena politica: nel 1602 ereditò il marchesato di Finale, ma
essendo già occupato dagli Spagnoli, non poté venime in possesso (e sarà quindi solo rimborsato); nel 1604 si occupò ancora per
conto degli Spagnoli dei disordini scoppiati a Monaco dopo l'uccisione di Ercole Grimaldi; ma le sue giornate passavano
prevalentemente tra Fassolo e la bella villa di Loano.
Nel gennaio del 1606 le condizioni di salute si aggravarono; dettava incessantemente codicilli e codicilli, ricordando e
raccomandando i suoi segretari e collaboratori ai figli, disponendo lasciti (per la figlia Vittoria, che non doveva avere avuto un
matrimonio felice; 1.000 scudi per Artemisia per le spese che avrebbe affrontato per il lutto). Morì a Genova nella notte del 2 febbr.
1606.
Al primogenito Andrea andava il fedecommesso (comprensivo, tra l'altro, di Melfi, Fassolo, i feudi appenninici), a Carlo il palazzo di
strada Nuova, il ducato di Tursi, le due galere; a Giannettino, ormai cardinale, diverse rendite. Il patrimonio complessivo viene
valutato in 1.620.000 scudi d'oro.
Fonti e Bibl.: La vita del D. copre tempi e spazi politici molto vasti; in questa sede si daranno solo alcune indicazioni sulle principali
fonti inedite. In particolare presso l'Archivio Doria Pamphili di Roma è conservato quanto resta dell'archivio del D., che è di
dimensioni straordinarie, per cui se ne è potuta consultare solo una piccola parte, vale a dire: Bancone: 62.29, 65.1-65-9, 68.7-68.10,
72.1, 72.4-72.6, 73.17, 75.4, 79.35-36; Scaffali: 18.26-27, 22.40, 38.32, 38.43 (l'int. 16 contiene l'autobiografia del D.), 38.44, 39.6,
64.69, 69.12, 69.24-69.25, 69.29-69-30, 69.32-69-33, 70.24-70.25, 75.1, 75.4-75.5, 75.11-75.13, 75.15, 75.25, 75.36-75.37, 75.40,
76.26, 76.37, 77.25, 77.36, 77.39, 77.50, 79.53, 80.22, 81.15-81.16, 81.36-81.37 (questa serie delle lettere ricevute continua ancora
per diverse dicine di numeri ed è di grande interesse, come quella qui ricordata successivamente che contiene una parte delle minute
delle lettere in partenza), 84.30-84-32, 93.35, 93.37, 93.39-93.40.
Un discorso analogo va fatto sia per i fondi conservati all'Archivo general de Simancas, ricchissimi, naturalmente, di materiale
relativo al D. e ai suoi rapporti con la Corona spagnola sia per quelli conservati a Genova. Centinaia e centinaia sono, ad esempio, le
lettere conservate nella sola serie Estado dal n. 1400 al 1433 (cfr. R. Magdaleno, Papeles de Estado. Genova, Valladolid 1972).
Segnaliamo qui solo alcuni documenti utilizzati per la redazione di questa voce: Archivo general de Simancas, Estado 1384, 1388,
1389, 1401, 1403, 1408, 1420, 1422, 1425, 1431, 1433, 1544; Archivio di Stato di Genova, Archivio segreto 818, 844, 1960A, 19651972, 2328; Ibid., Senato, Sala Senarega 1563; Ibid., Notai: G. Villamarino sc. 191 f. 22; G. G. Cibo Peirano, sc. 195 ff. 20-22; D.
Conforto, sc. 272 f. 30; A. Vernazza, sc. 278 f. 1; L. Chiavari, sc. 288 ff. 22-24; sc. 289 f. 29; D. Tinello, sc. 384 ff. 10-11; sc. 385 f.
19; G. A. Morinello, sc. 436 f. 3; A. Casareggio, sc. 531 f. 5; G. B. Cangialanza, sc. 583 f. 15; ibid., mss. 437, 801, 859 (p. 234);
Archivio storico del Comune, mss. 92, 337, 339, 415; ibid., Mss. Brignole Sale, 103.A.3, 109.D.4; Genova, Univ., facoltà di econ. e
commercio, Archivio Doria: sc. 646, n. 1: G. Salvago, Historia di Genova, cc. 95v, 107, 132r, 136v, 138r, 146r, 151v, 152v; Ibid.,
Biblioteca civica Berio, m. r. XIV, 3, 13 (vi è conservata una copia dell'autobiografia del D.); Ibid., Biblioteca Durazzo Giustiniani,
mss. A.IV.2, AA.VI.9; Ibid., Bibl. giuridica P. E. Bensa, ms. 92.4.10: M. Gentile, Diario, pp. 27 s., 35, 37, 39, 45, 50, 58 ss., 255, 301,
373 ss., 383 ss.; Ibid., Biblioteca universitaria, ms B.I.19 (c. 34v), B.VI 29, C.IV.22; Archivio di Stato di Firenze, Malaspina 190, cc.
23v e ss., 298v e ss.; Ibid., Mediceo del principato 2834; Ibid., Miscell. Medicea, 97/8, 97/13; Ibid., Carte Strozziane 269; Ibid.,
Urbino, CI. I, Div. G, 249; Firenze, Bibl. naz., Palatino Graberg 11, vol. V; Londra, British Library, mss. Add. 28416-28417; Madrid,
Biblioteca nacional, ms. 783, cc. 647-674; Milano, Bibl. naz. Braidense, ms. AE.XII.31, e. 74rv; Ibid., Bibl. Ambrosiana, mss. D 191
inf, cc. 4r-19v, G.151 inf, G. 169 inf, G. 170 inf, G. 191 inf; Modena, Bibl. Estense, Fondo Campori, Y.4.14; Ibid., Autografoteca, sub
voce; Arch. segr. Vaticano, Segreteria di Stato, Genova, 4 e 6; Ibid., Miscell., Arm. II, 130; Bibl. ap. Vaticana, Barb. lat. 5302, 5303,
5367; Ibid., Chigi F.V.27; Ibid., Urb. lat. 816 II, 818 II, 848, 873, 874, 1044, 1115; Savona, Bibl. civica, ms. IX.III.2.3: P. Tomacelli,
Ragionamenti morali... all' ill.mo Sr G. A. D.; Archivio di Stato di Torino, Lettere particolari, D.22.
Nei testi (e negli indici dei nomi) si confonde spesso Giovanni Andrea con Andrea; in questa bibliografia i rinvii sono solo alle opere
e alle pagine in cui si tratta effettivamente del D.: Lettere di principi... libro primo, Venetia 1564, cc. 209v-212v; libro secondo, ibid.
1575, cc. 247v e ss.; G. A. Doria, Lettera scritta ... All'ecc.mo duce e ill.mi governatori della Rep. di Genova, s.n.t. [Lucca 1575]; M.
A. Sauli, Lettera ... scritta a l'illustriss. Sig. G. A. D., Milano 1575; Lettere di principi... libro terzo, Venetia 1581, cc. 233v-242r; J. C.
Lünig, Codex Italiae diplomaticus, Francofurti-Lipsiae 1725-1726, I, coll. 1963-1974; II, coll. 2374-2407; G. Molini, Documenti di
storia italiana, Firenze 1836, II, pp. 481-484; Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato, a cura di E. Alberi, s. 2, V, Firenze 1841,
pp. 282, 294; Colecciòn de documentos inéditos para la historia de España, Madrid 1843, II, pp. 171-195; III, pp. 17, 20, 36, 39, 45,
68, 184 s., 196, 358 s.; VI, pp. 106 ss.; XI, pp. 362, 369, 395, 401; XXVIII, pp. 196, 220 ss., 231, 251-262; XXIX, pp. 34, 65, 218,
238, 246, 263, 479-482; XXX, pp. 25, 87, 142, 237, 288, 293, 328, 331 ss., 336, 392 s., 395; XXXVII, pp. 8, 13; XLII, p. 308; LI,
p.231; XCVII, p. 495; CII, p. 179; E. Charrière, Nègociations de la France dans le Levant, Paris 1848, III, pp. 116, 118 ss., 124 s.,
127, 145, 159, 187, 189, 263, 617, 619; IV, pp. 303, 634, 687 s.; A. Theiner, Annales ecclesiastici, Romae 1856, I, pp. 363 s., 487; II,
pp. 140 s., 143 ss., 147, 516-520; Calendar ofState papers. Foreign series..., Elizabeth, London 1865-1927, 1560-61, pp. 148, 157,
255; 1561-62, pp. 132-139, 142 s., 146, 242, 254 s.; 1562, p. 38; 1563, pp. 131, 357, 490; 1564-65, pp. 36, 194; 1569-71, p. 349;
1572-74, pp. 286, 421, 437; 1578-79, pp. 225, 513; 1579-80, p. 254; January 1581 - April 1582, pp. 381, 535; May-December 1582,
pp. 104, 111; 1583-84, pp. 107, 133, 229, 585, 608, 643, 650; 1585-86, ad Indicem; 1586-88, ad Indicem; V. Promis, Cento lettere
concernenti la storia del Piemonte dal MDXLIV al MDXCII, in Miscell. di storia patria, IX (1870), pp. 611, 616, 625, 627 s.; E.
Poullet, Correspondance du cardinal Granvelle, Bruxelles 1877, II, IV, VI-XII, ad Indices; A. Ceruti, Gabriele Salvago patrizio
genovese. Sue lettere, in Atti d. Soc. lig. di st. patria, XIII (1880), pp.759 s., 827 ss., 831 s., 834, 852, 885; P. Paruta, La legazione di
Roma, in Deputazione veneta di st. patria, s. 4, Miscellanea, VII-IX, Venezia 1887, ad Indicem; Documentos escogidos del Archivo
de la casa de Alba, Madrid 1895, pp. 305, 308, 341, 349, 358, 373 s., 377; Documents historiques relatifs à la Principauté de Monaco,
a cura di G. Saige, III, Monaco 1891, pp. CXIV, CXXVII, 301, 354, 367 s.; G. B. Carinci, Lettere di Onorato Caetani capitano
generale delle fanterie pontificie nella battaglia di Lepanto, Roma 1893, pp. 67, 77, 97-100, 103; Lettere di D. Giovanni d'Austria a G.
A. D., I, a cura di A. Doria Pamphilj, Roma 1896; L. Serrano, Correspondencia diplomatica entre España y la S. Sede durante el
pontificado de s. Pio V, Madrid 1914, ad Indices; J. Lefevre, Correspondance diplomatique de Philippe II sur les affaires des Pays.
Bas, Bruxelles 1940, I, pp. 222, 227, 298, 343; V. Fernandez Asis, Epistolario de Felipe II sobre asuntos de mar, Madrid 1943; J.
Olarra Garmendia-M. L. Larramendi, Indices de la correspondencia entre la nunciatura en España y la Santa Sede, durante el reinado
de Felipe II, Madrid 1948-1949, ad Indices; Istruzioni e relazioni degli ambasciatori genovesi, I, Spagna (1494-1617), a cura di R.
Ciasca, Roma 1951, ad Indicem; Epistolario del III duque de Alba don Francisco Alvarez de Toledo, Madrid 1952, ad Indices;
Nunziature di Napoli, I, a cura di P. Villani, Roma 1962, ad Indicem; G. Oreste, Una narrazione inedita della bataglia di Lepanto, in
Atti d. Soc. lig. di st. patria, LXXVI (1962), 2, pp. 220-223, 228, 230; La corrispondenza da Madrid dell'ambasciatore Leonardo Donà
(1570-1573), a cura di M. Brunetti-E. Vitale, Venezia-Roma 1963, ad Indicem; Nunziature di Napoli, III, a cura di M. Bettoni, Roma
1970, ad Indicem; Nunziature di Venezia, IX, a cura di A. Stella, Roma 1972, ad Indicem; XI, a cura di A. Buffardi, ibid., ad Indicem;
G. Pallavicino, Inventione ... di scrivere tutte le cose accadute alli tempi suoi (1583-1589), Genova 1975, pp. 14, 30, 45, 49, 53, 79,
108 s., 141-146, 151, 157, 232, 242; R. Magdaleno, Titulos y privilegios de Napoles. Siglos XVI-XVIII, I, Onomastico, Valladolid
1980, ad Indices.
Cfr. inoltre: A. F. Cimi, Successi dell'armata della Maestà cattolica. Destinata all'impresa di Tripoli di Barberia, della presa delle
Gerbe, e progressi dell'armata turchesca, Venetia 1560, passim; G. Mutio, Fonte di nobiltà, Genova 1570, passim; L. Pallavicino,
Lettera... sopra la vittoria di Don Giovan' d'Austria, s.n.t. [Genova 1571-1572], passim; M. A. Montiflori, De pugna navali cursularia,
Genuae 1572, passim; U. Foglietta, Clarorum Ligurum elogia, Romae 1573, cc. n.n. e 160 ss.; Id., De sacro foedere in Selimum ...
Variae expeditiones in Africa ... Obsidio Melitae, Genuae [1585], passim; G. Catena, Vita del gloriosissimo papa Pio quinto, Roma
1587, pp. 170 s., 212, 218, 222; G. Conestaggio, Relazione dell'apparecchio per sorprendere Algieri, Genova 1601, passim; M.
Merello, Della guerra fatta da' Francesi e de' tumulti suscitati poi da Sampiero della Bastelica nella Corsica, Genova 1607, pp. 240,
242, 295, 336; P. Paruta, Della historia vinetiana parte seconda, Vinetia 1645, pp. 37, 39, 46, 72 s., 145, 154 ss., 160; C. Sigonio, De
vita et rebus gestis Andreae Doriae, in Opera omnia, III, Mediolani 1739, coll. 1221 ss., 1259 ss.; G. B. Spinola, Commentarii delle
cose occorse a Genovesi dal 1572 al 1576, Genova 1838, pp. 30, 55, 62, 80, 83, 86, 90, 92 s., 96 ss.; A. Roccatagliata, Annali della
Rep. di Genova dall'anno 1581 all'anno 1607, Genova 1873, ad Indicem; A. Jal, Archéologie navale, Paris 1840, I, pp. 13 s., 405; C.
Rosell, Historia del combate naval de Lepanto, Madrid 1853, pp. 34-37, 44, 46, 167 s ., 171-180; A. Olivieri, Le discordie e le guerre
civili dei Genovesi nell'anno 1575 descritte dal doge G. B. Lercari. Arricchite di note e documenti inediti, Genova 1857, pp. 32, 47,
50, 76, 126, 137, 144, 146 s., 151-167, 263 s., 268 ss., 285, 292 s., 407, 556-567, 705; Id., Monete medaglie e sigilli dei principi Doria
che serbansi nella Biblioteca della R. Università ed in altre collezioni di Genova, Genova1858, pp. 9 ss., 30-33, 59 s.; A. Guglielmotti,
Marcantonio Colonna alla battaglia di Lepanto, Firenze 1862, ad Indicem; M. Spinola, Considerazioni su vari giudizi di alcuni recenti
scrittori riguardanti la storia di Genova, in Atti d. Soc. lig. di st. patria, IV (1867), pp. 376, 412; N. Giuliani, Notizie sulla tipografia
ligure sino a tutto il secolo XVI, ibid., IX (1869), pp. 176, 203, 266, 357 ss., 365-369, 374, 382 s., 389, 394, 396, 504 ss.; M. Spinola,
Relazione sui documenti ispano-genovesi dell'Archivio di Simancas, ibid., VIII (1872), pp. 388, 402; G. Avìgnone, Medaglie dei
liguri e della Liguria, ibid., pp. 521 s.; A. Merli-L. T. Belgrano, Il palazzo del principe D'Oria a Fassolo in Genova, ibid., X (1874),
pp. 45-82, 93-96; A. Guglielmotti, La guerra dei pirati e la marina pontificia dal 1500 al 1560, Firenze 1876, ad Indicem; Id., La
squadra permanente della marina romana. Storia dal 1573 al 1644, Roma 1882, pp. 11, 17, 119 s., 150-154; B. Veroggio, G. D. alla
battaglia di Lepanto, Genova 1886; C. Manfroni, La lega cristiana nel 1572. Con lettere di M. A. Colonna, in Archivio della Soc.
romana di st. patria, XVI (1893), pp. 349-352, 382, 387; XVII (1894), pp. 52 s., 57; Id., Le relazioni fra Genova, l'Impero bizantino e
i Turchi, in Atti d. Soc. lig. di st. patria, XXVIII (1896), pp. 760, 768, 774, 782; Id., Storia della marina italiana dalla caduta di
Costantinopoli alla battaglia di Lepanto, Roma 1897, pp. 366, 390, 394 ss., 411 ss., 425 ss., 431 ss., 447 ss.; A. Neri, Andrea Doria e
la corte di Mantova, in Giorn. ligust. di archeol., storia e lett., XXIV (1898), pp. 116-121; G. Ceci, I feudatari napoletani alla fine del
sec. XVI, in Arch. st. p. le provv. napol., XXIV (1899), p. 125; C. Manfroni, G. A. D., in Rassegna nazionale, 1º luglio 1901, pp. 2543; L. Serrano, La liga de Lepanto entre España y la Santa Sede (1570-1573), Madrid 1918, ad Indicem; L. v. Pastor, Storia dei papi,
VIII, Roma 1924, pp. 515, 525, 538 ss., 543; E. Pandiani, Arredi ed argenti di Andrea Doria da un inventario del 1561, in Atti d. Soc.
lig. di st. patria, LIII (1926), pp. 244, 285, 287; F. Poggi, Le guerre civili di Genova in relazione con un documento economico
finanziario dell'anno 1575, ibid., LIV (1930), 3, pp. 101 s., 104, 122, 148; A. Salimei, Gli Italiani a Lepanto, Roma 1931, passim; G.
A. Quarti, La guerra contro il Turco a Cipro e a Lepanto MDLXX-MDLXXI, Venezia 1935, ad Indicem; S. Rebaudi, Le statue
dinanzi la facciata del palazzo ducale di Genova, in Atti d. Soc. lig. di st. patria, LXVII (1938), pp. 216 ss.; V. Vitale, Breviario della
storia di Genova, Genova 1955, ad Indicem; A. Sisto, Ifeudi imperiali del Tortonese (secc. XI-XIX), Torino 1956, pp. 89, 91 s., 94,
96-100, 112, 171; L. Stone, An Elizabethan. Sir Horatio Palavicino, Oxford 1956, p. 260; M. van Durme, Elcardinal Granvela (15171586). Imperio y revolución bajo Carlos V y Felipe II, Barcelona 1957, pp. 364 ss.; M. Gasparini, La Spagna e il Finale dal 1567 al
1619, Bordighera 1958, pp. 49 ss., 63, 226-233; R. Bracco, Il principe G. D. patriae libertatis conservator conte di Loano fondatore di
S. Agostino, Genova 1960, pp. 85-210; R. Emmanuelli, Gines et l'Espagne dans la guerre de Corse. 1559-1569, Paris 1964, ad
Indicem; A. Stella, G. A. D. e la "sacra lega" prima della battaglia di Lepanto, in Riv. di storia della Chiesa in Italia, XIX (1965), pp.
378-402; F. Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, Paris 1966, ad Indicem; G. Rosso Del
Brenna, L'iconografia del principe Doria nella letteratura cinquecentesca, in L'Arte, X (1970), pp. 61 s.; V. Borghesi, Il magistrato
delle galee (1559-1607), Miscell. di stor. ligure, III, 1, s.n.t. [1971], pp. 208, 210, 217; R. Bracco, Donna Zenobia Del Carretto Doria,
Genova 1971, passim; M. Firpo, Pietro Bizzarri esule italiano del Cinquecento, Torino 1971, pp. 243, 249, 272; R. Colapietra, Dal
Magnanimo a Masaniello, Salerno 1972, ad Indicem; E. Poleggi, Strada nuova. Una lottizzazione del Cinquecento a Genova, Genova
1972, pp. 223 s., 304, 318, 351; M. Aymard, Chiourmes et galères dans la seconde moitié du XVIe siècle, in Il Mediterraneo nella
seconda metà del '500 alla luce di Lepanto, a cura di G. Benzoni, Firenze 1974, pp. 81, 83 s.; U. Tucci, Il processo a Girolamo Zane
mancato difensore di Cipro, in Il Mediterraneo, cit., pp. 410, 413, 426 s., 429; J.-F. Guilmartin, Gunpowder and galleys. Changing
technology and Mediterranean warfare at sea in the Sixteenth Century, Cambridge 1974, ad Indicem; I. A. A. Thompson, War and
government in Habsburg Spain 1560-1620, London 1976, pp. 32, 78, 174, 178, 263; C. Costantini, La Repubblica di Genova nell'età
moderna, Torino 1978, ad Indicem e p. 512; S. Zotta, Momenti e problemi di una crisi agraria in uno "stato" feudale napoletano
(1585-1615), in Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen Age. Temps Modernes, XC (1978), 2, pp. 715-796 passim; E. Grendi,
Andrea Doria, uomo del Rinascimento, in Atti della Soc. lig. di st. patria, XCII (1979), I, pp. 110 s.; G. Gorse, The Villa Doria in
Fassolo, Genoa, tesi di dottorato, Brown University, Providence 1980, pp. 120-177, 244-267, 310 ss.; R. Savelli, La pubblicistica
politica genovese durante le guerre civili del 1575, in Atti della Soc. lig. di st. patria, XCIV (1980), 2, pp. 83, 86, 93, 102, 105; R.
Colapietra, Recenti studi sul principato di Meffi, in Arch. stor. per la Calabria e la Lucania, XLVIII (1981), pp. 195 s., 198 s., 202; Id.,
Genovesi in Calabria nel Cinque e Seicento, in Riv. stor. calabrese, n. s., II (1981), 14, pp. 37, 71; R. Mantelli, Burocrazia e finanze
pubbliche nel Regno di Napoli a metà del Cinquecento, Napoli 1981, pp. 124, 412; R. Savelli, La Repubblica oligarchica.
Legislazione istituzioni e ceti a Genova nel Cinquecento, Milano 1981, ad Indicem; S. Zotta, Rapporti di produzione e cieli produttivi
in regime di autoconsumo e di produzione speculativa. Le vicende agrarie dello "stato" di Melfi nel lungo periodo (1530-1730), in
Problemi di storia delle campagne meridionali nell'età moderna e contemporanea, a cura di A. Massafra, Bari 1981, pp. 228, 248 ss.,
253; L. Secchi, Appunti per B. Brandimarte, in Boll. dei Musei civici genovesi, IV (1982), 10-12, pp. 6, 11; R. Savelli, Tra
Machiavelli e S. Giorgio. Cultura giuspolitica e dibattito istituzionale a Genova nel Cinque-Seicento, in Finanze e ragion di Stato in
Italia e in Germania nella prima età moderna, a cura A. De Maddalena-H. Kellenbenz, Bologna 1984, pp. 259, 261, 275 s., 280; P.
Boccardo, Fonti d'archivio per una storia degli arazzi a Genova, in Studi di storia delle arti, V (1983-1985 [ma 1986]), pp. 122 s., 127;
P. B[occardo], Scheda sugli arazzi della serie della battaglia di Lepanto, in Venezia e la difesa del Levante da Lepanto a Candia,
Venezia 1986, pp. 22 ss.; G. Doria, Investimenti della nobiltà genovese nell'edilizia di prestigio (1530-1630), in Studi storici, XXVII
(1986), pp. 15 s., 20; F. R. Pesenti, La pittura in Liguria. Artisti del primo Seicento, Genova 1986, pp. 12, 14-18; La scultura a
Genova e in Liguria dalle origini al Cinquecento, Genova 1987, ad Indicem; L. Magnani, Il tempio di Venere. Giardino e villa nella
cultura genovese, Genova 1987, passim, in specie pp. 115 ss.; F. Caraceni Poleggi, La committenza borghese e il manierismo a
Genova, in La pittura a Genova e in Liguria dagli inizi al Cinquecento, Genova 1987, pp. 272, 289, 291, 295, 297 s.; P. Torriti,
Apporti toscani e lombardi, in La pittura a Genova e in Liguria dal Seicento al primo Novecento, Genova 1987, pp. 48 s.; S. Zotta, G.
F. De Ponte. Il giurista politico, Napoli 1987, ad Indicem.
From Wikipedia, the free encyclopedia
Giovanni Andrea Doria, also Giannandrea Doria (1539–1606), was an Italian admiral from Genoa. He was the son of Giannettino
Doria and the great-nephew of the famed Genoese admiral Andrea Doria, by whom he was later adopted. He became the Admiral of
the Genoese Fleet in 1556, and commanded the combined Christian fleet of the Holy League at the Battle of Djerba in 1560, which
was won by the Ottoman Turks under the command of Piyale Pasha. He also participated in the Battle of Lepanto (1571), which was
won by the Christian forces and signaled the first ever defeat of the Ottoman Turks at sea. One of his children was named Giovanni
Doria, (24 March 1573 - Palermo, Sicily, 19 October 1642), called Giannettino, the son of Giovanni Andrea I Doria, 6th Prince of
Melfi, and Princess Zenobia Doria del Carretto, 5th Princess of Melfi, who studied philosophy and theology in Spain being promoted
to the Cardinalate at the instance of King Felipe II of Spain. Once king Philip II died, he was created cardinal deacon, aged 31, in the
consistory of June 9, 1604. Granted permission to receive the sacred orders outside the Ember days, December 9, 1604. Participated in
the first conclave of 1605, which elected Pope Leo XI. Participated in the second conclave of 1605, which elected Pope Paul V.
Received the red hat and the deaconry of S. Adriano, December 5, 1605. Abbot commendatario of San Fruttuoso di Camogli. Elected
titular archbishop of Tessalonica and named coadjutor, with right of succession, of Palermo, February 4, 1608. Consecrated, May 4,
1608, Rome, by Pope Paul V. Succeeded to the see of Palermo, Sicily, July 5, 1608. Viceroy of Sicily and lieutenant of the king of
Spain , February 8, 1610 - March 1611 , July to August 1616, from August 1, 1624 to 1626 and from 1639 to June 1641. Participated
in the conclave of 1621, which elected Pope Gregory XV. Participated in the conclave of 1623, which elected Pope Urban VIII. Opted
for the order of cardinal priests and the title of S. Pietro in Montorio, October 2, 1623. Discovered the relics of S. Rosalia and
promoted her cultus. He died November 19, 1642, Palermo. Buried in the chapel of S. Rosalia, in the metropolitan cathedral of
Palermo. Bibliography. Cardella, Lorenzo. Memorie storiche de' cardinali della Santa Romana Chiesa. Rome : Stamperia Pagliarini,
1793, VI, 113-115; Gauchat, Patritium. Hierarchia Catholica Medii et Recentioris Aevi, Münich : Sumptibus et Typis Librariae
Regensbergianae, 1935; reprint, Padua : Il Messagero di S. Antonio, 1960, IV, 8, 47, 50, 272 and 335.
Sources
• Bracco, Raffaele (1960). Il principe Giannandrea Doria: patriae libertatis conservator, conte di Loano, fondatore di S.
Agostino. Genoa.
• Cardella, Lorenzo. Memorie storiche de' cardinali della Santa Romana Chiesa. Rome : Stamperia Pagliarini, 1793, VI, 113115
• Gauchat,Patritium. Hierarchia Catholica Medii et Recentioris Aevi, Münich : Sumptibus et Typis Librariae Regensbergianae,
1935; reprint, Padua : Il Messagero di S. Antonio, 1960, IV, 8, 47, 50, 272 and 335.
Ottavio Farnese
(1523 - 1586)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Busto di Ottavio Farnese, di Annibale Fontana. Milano, Castello Sforzesco
Ottavio Farnese (Valentano, 9 ottobre 1523 – Piacenza, 18 settembre 1586) fu il secondo duca di Parma e Piacenza e il secondo duca
di CastroI primi anni Ottavio era il secondogenito di Pier Luigi Farnese e Gerolama Orsini, nipote di papa Paolo III e fratello dei
Cardinali Ranuccio Farnese e Alessandro Farnese. Nel 1538 Ottavio accompagnò il papa a Nizza per la tregua, ottenendo da Carlo V
sua figlia naturale Margherita d'Austria, che sposò il 4 novembre 1538. Ottavio aveva 15 anni, mentre Margherita, che era rimasta da
poco vedova di Alessandro de' Medici, ne aveva 16. Il matrimonio fu celebrato nella Cappella Sistina alla presenza del papa, che
troncò in favore della nipote acquisita le contestazioni sull’eredità romana dei Medici. Con questo matrimonio Ottavio entrò nella
cerchia ristretta delle famiglie sovrane europee. Questo sodalizio non fu, però, dei più felici, sia per la scarsa comprensione e
delicatezza d’animo di Ottavio che per il continuo sognare della corte medicea che faceva lei, a cui gli ambienti romani sembravano
angusti e noiosi. La situazione cambiò quando Ottavio ritornò ferito da una spedizione ad Algeri nel 1541 e la sua avversione si
trasformò in affetto.
I primi onori Nel 1540, in un concistoro segreto, Ottavio fu creato duca ereditario di Camerino e signore di Nepi a discapito dei
Varano, ma lasciò questo feudo quando suo padre divenne duca di Parma nel 1545. Tale decisione non piacque ad Ottavio che doveva
rinunciare ad uno Stato Sovrano per la prospettiva di una successione, così con l’appoggio di Paolo III, ebbe dal padre il ducato di
Castro. Nello stesso anno la famiglia fu allietata dalla nascita di due gemelli, Carlo, che sarebbe morto giovanissimo, e Alessandro, le
cui imprese avrebbero dato lustro alla famiglia Farnese in tutta Europa. Il battesimo dei gemelli avvenne a Sant’Eustachio, alla
presenza del papa, di 19 cardinali e come padrino Carlo V e come madrina la regina di Francia
Duca di Parma Dopo che la nobiltà Piacentina, probabilmente d'accordo con il governatore di Milano Ferrante I Gonzaga, ebbe
assassinato Pierluigi Farnese nel 1547, le truppe dell'Imperatore, sotto la guida del Gonzaga, occuparono Piacenza. Paolo III senza por
tempo in mezzo riunì il concistoro e dichiarò espressamente che Ottavio sarebbe stato duca di Parma e feudatario della Chiesa
secondo l’investitura effettuata da lui stesso. Nello stesso concistoro lo investì anche della carica di Gonfaloniere della Chiesa. Il
papa, comunque, continuava a mediare con l’imperatore e giunse alla conclusione che Carlo V considerava il Ducato di Parma e
Piacenza come una dipendenza dell’impero, così decise di esigere Parma per la Chiesa e di dare Castro e Camerino ai suoi due nipoti.
Paolo III, approfittando dell’assenza di Ottavio, mandò Camillo Orsini, come legato, per prendere possesso della città. Appena saputa
la notizia Ottavio si precipitò a Parma per reclamare il suo, ma non raggiunse lo scopo. Cercò, così, di riconquistare Parma con la
forza ed avendo fallito iniziò dei negoziati con Ferrante Gonzaga. Si ritiene che la sua ribellione contro il nonno abbia accelerato la
morte del papa che avvenne il 10 novembre 1549. Poco prima della morte, il nipote Alessandro lo convinse ad inviare un Breve
apostolico al legato in cui gli ingiungeva di ritirarsi da Parma su Bologna, consegnando la città ad Ottavio. Ma la notizia della sede
vacante giunse a Parma ed il legato si rifiutò di eseguire l’ordine a meno che non gli fosse stato impartito da un altro papa. Nel
frattempo, durante il conclave, l’appoggio del cardinale Farnese al cardinale del Monte, risultò decisivo per la sua elezione. Giovanni
Maria del Monte venne eletto col nome di Giulio III. Il nuovo papa non si dimostrò ingrato e ingiunse a Camillo Orsini di rimettere
Parma nelle mani di Ottavio. Alcuni giorni più tardi il duca faceva un ingresso trionfale in città e, con l’appoggio del pontefice, alcuni
mesi dopo rientrava in possesso di Piacenza, mettendovi delle guarnigioni. Questo fatto fu riportato in maniera negativa da Don
Ferrante a Carlo V.
La guerra di Parma Don Ferrante instillava dei terrori nella mente di Ottavio, facendogli credere che il suocero gli volesse togliere il
ducato, così il duca si abboccò con i fratelli e di comune accordo decisero di appoggiarsi al re di Francia, Enrico II. Quando il papa,
mal informato dal Gonzaga su questo accordo tra il Farnese ed il re di Francia, ingiunse ad Ottavio di restituire Parma in cambio di
Camerino, questi rifiutò. Lo stesso giorno, il 27 maggio 1551, Enrico II ed il duca di Parma firmarono un trattato nel quale il duca
prometteva di non abbandonare l’alleanza con i Valois ed il re prendeva casa Farnese sotto la sua protezione, assicurando il concorso
delle sue truppe e del suo tesoro. In conseguenza di questo accordo Giulio III dichiarò il duca ribelle e lo spogliò delle sue dignità e
del suo ducato. Suo fratello Orazio raggiunse immediatamente il fratello e il papa gli tolse la prefettura do Roma e mise sotto
sequestro il ducato di Castro. La guerra iniziò male per i Farnese: il Gonzaga si impadronì subito di Colorno e, poco dopo, Orazio fu
battuto presso Mirandola .[1]. Per rendere la sconfitta dei Farnese più cocente, Don Ferrante iniziò a devastare le campagne parmensi
incorrendo nell’ira papale e provocando la carestia, facendo però arrivare regolarmente delle provvigioni a Margherita per non
incorrere nelle sanzioni dell’imperatore. Il 12 settembre un esercito francese valicò le Alpi ed il Gonzaga dovette ritirare le sue truppe
per difendere la Lombardia. Da questo momento le prospettive della guerra cambiarono. Il 29 aprile 1552 i rappresentanti del papa,
della Francia e di Parma firmarono una tregua che doveva durare due anni e Carlo V ratificò la sospensione del conflitto. L’accordo
prevedeva la restituzione ai Farnese di tutti i loro beni, onori e privilegi. Durante la tregua Carlo V si preparò alla ripresa del conflitto,
mentre il re di Francia si occupò dell’organizzazione del matrimonio tra Orazio e sua figlia. A causa della morte di Orazio, il
matrimonio durò solo pochi mesi e, nonostante il re di Francia scrivesse ad Ottavio che voleva allevare il figlioletto Alessandro e gli
inviasse il collare dell’Ordine di San Michele, i rapporti tra Parma e la Francia si affievolirono sempre più. Il 15 settembre 1556
Ottavio, dopo la restituzione di quasi tutte le città occupate dal padre, Pier Luigi, si mise sotto la protezione di Filippo II di Spagna
rinnegando la Francia e mandando il figlio Alessandro presso la corte iberica. Tra le clausole del trattato c’era quella che avrebbe
ricevuto Piacenza come feudo spagnolo, infrangendo così i diritti di sovranità della Santa Sede. I rapporti fra la Spagna e la Santa
Sede iniziarono a deteriorarsi, così il papa mandò un suo emissario in Francia per indurla alla guerra. Tale guerra fu disastrosa per i
francesi e consolidò le frontiere spagnole. A seguito della guerra Ottavio ricevette il Toson d’Oro e la patente di capitano generale di
guerra spagnolo, mentre Margherita ebbe la reggenza dei Paesi Bassi.
Gli ultimi anni e la morte Dopo la partenza della moglie e del figlio, Ottavio rimase solo a Parma. Si sforzò di rendere prospero il
ducato, di accattivarsi la benevolenza del popolo applicando le sagge misure già prese dal padre e di blandire la nobiltà locale usando
più moderazione di Pier Luigi. Perdonò il conte di Sanseverino che lo aveva combattuto nella guerra di Parma, ma confiscò il feudo di
Borgotaro, che era proprietà della famiglia Landi. Egli elevò a propria residenza la città di Parma, che così divenne la capitale del
ducato a discapito di Piacenza che fino ad allora era stata la città principale; si installò perciò prima nel palazzo episcopale di Parma e
quindi in uno fatto costruire appositamente. Parteciparono all’opera artisti del calibro del Bertoja, del Mirola, di Raffaello Peri e di
Giovanni Boscoli. Si dilettò anche di scienze e studiò Euclide con il Paciotto, che gli dedicò anche un libro. In questo periodo Ottavio
ebbe anche relazioni extraconiugali, da cui nacquero dei figli naturali, tra cui Lavinia, Ersilia ed Isabella, che sposarono
rispettivamente un Pallavicini, un Borromeo ed un conte di Borgonuovo. Alla fine della sua vita, il duca si innamorò anche della
bellissima Barbara Sanseverino. Dopo molti anni di tranquillità, in cui il duca seppe consolidare il ducato, promuovendone
l’economia e gli scambi finanziari, commerciali e culturali, nel 1582 Ottavio fu oggetto di una congiura. Due Scotti ed un Anguissola
furono arrestati e torturati. Dopo aver confessato il loro crimine, furono giustiziati nel dicembre dello stesso anno. Nel 1586, poco
prima della sua morte, Filippo II gli restituì ufficialmente Piacenza, non per sua preghiera, ma come compenso delle vittorie riportate
dal figlio Alessandro, che gli succedette alla guida del ducato.
Note
1. ^ Il negoziato con cui Ottavio si assicura l'alleanza di Mirandola, e il ruolo di Mirandola nella guerra è stato narrato, sulla
base di una minuziosa analisi delle cronace, nel romanzo di Antonio Saltini, L'assedio della Mirandola, Reggio E. 2003.
Bibliografia Edoardo del Vecchio, I Farnese, Istituto di Studi Romani Editore, 1972
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene file multimediali su Ottavio Farnese
Predecessore:
Duca di Castro
Successore:
Pier Luigi Farnese
1545-1547
Orazio Farnese
I
Orazio Farnese
1553-1586
Alessandro Farnese
II
Predecessore:
Duca di Parma
Successore:
Pier Luigi Farnese
1547-1586
Alessandro Farnese
Ferrucci, Francesco
(1489 - 1530)
Dizionario Biografico degli Italiani
di II. Cotta
FERRUCCI, Francesco. - Nacque il 14 ag. 1489, come risulta dalle Ricordanze del padre, a Firenze nel "popolo" di S. Frediano, da
Niccolò di Antonio e da Piera Guiducci.
La famiglia ebbe quattro gonfalonieri di Giustizia e venti priori tra il 1299 e il 1515. Il nonno Antonio era stato sostenitore dei Medici.
Il padre Niccolò fu invece antimediceo.
All'abbondanza di notizie sul F. per gli ultimi due anni della sua vita fa riscontro per gli anni precedenti una conoscenza estremamente
lacunosa, e comunque non documentata con precisione.
Il primo dato certo di cui disponiamo è che il F. fu estratto nel 1519 come podestà di Larciano; sappiamo però che non poté risiedervi
essendo il suo nome inserito quell'anno nei libri dei Divieti (Arch. di Stato di Firenze, Tratte, 175, c. 20v). Tenne invece la podesteria
di Campi dal 30 maggio al 30 nov. 1523 e quella di Radda dal 14 febbr. 1527 (1526, stile fiorentino), al 14 agosto dello stesso anno.
Nel 1528 troviamo il F. a Napoli come pagatore delle Bande nere che la Repubblica aveva mandato a combattere a fianco dei Francesi
di O. de Foix, visconte di Lautrec. Preso prigioniero dopo la sconfitta del Lautrec, il F. fu liberato dietro pagamento di un riscatto.
Tornato comunque a Firenze, nel giugno 1529 il F. ebbe l'incarico di recarsi a Pesaro e di qui negli Abruzzi con la somma di 4000
fiorini necessaria per assoldare, insieme con Venezia e con la Francia, 1500 lanzichenecchi per ritentare l'impresa del Regno di
Napoli. Ma la conclusione della pace di Cambrai mise fine a questo impegno della Repubblica e di conseguenza alla missione del
Ferrucci.
Nei mesi seguenti il commissario in Valdichiana T. Soderini, avendo bisogno di un uomo di fiducia, si servì in più occasioni del
Ferrucci. Rimase poi a collaborare col successore del Soderini, Z. Bartolini, e in particolare servì come collegamento con i Dieci di
balia a Firenze e con M. Baglioni a Perugia, per portare lettere, istruzioni, denari.
Nel 1529, iniziata la campagna degli Imperiali e dei Pontifici contro la Repubblica, a M. Baglioni, governatore generale delle forze
fiorentine, assediato in Perugia, i Dieci di balia inviarono a più riprese il F. con lettere di istruzioni e il 31 agosto con 900 ducati per
poter arruolare nuovi soldati. Nonostante ciò il Baglioni reputò impossibile resistere all'assedio dell'esercito imperiale e il 10
settembre, con l'autorizzazione dei Dieci, concluse un accordo con il principe d'Orange e abbandonò la città dirigendosi su Arezzo e
subito dopo su Firenze. Anche il F. rientrò a Firenze, dove restò momentaneamente privo di qualsiasi incarico. Fu D. Giannotti, allora
segretario dei Dieci, che lo segnalò per un compito questa volta di maggior rilievo, come commissario a Prato a fianco di L. Soderini,
il cui comportamento suscitava molte lamentele. L'incarico fu però di breve durata (dal 4 al 12 ottobre) perché il Soderini non
apprezzò di dover condividere la responsabilità del comando e il F. per parte sua si trovò in totale disaccordo col collega, in
particolare nel definire i criteri di disciplina dei soldati. I Dieci richiamarono quindi il F., ma avendo avuto modo di sperimentarne le
capacità lo mandarono come commissario a Empoli, con pieni poteri in campo militare.
Il F. si rese subito conto dell'importanza della città e con grande energia si diede a rafforzarne le difese con bastioni e terrapieni.
Dedicò poi particolare impegno alle truppe di cui curava l'addestramento, la disciplina e l'armamento. Per questo nelle sue lettere ai
Dieci insisteva sempre sulle richieste di denari, per le paghe dei soldati e degli informatori, e sull'invio di munizioni e di altri armati.
Pur con gli scarsi mezzi a sua disposizione il F. intraprese una serie di scorrerie nel territorio circostante per disturbare le forze
nemiche e, quando possibile, per riconquistare quei luoghi che erano passati agli Imperiali. Primo ad essere ripreso fu
Castelfiorentino, il 25 ott. 1529, poi la spedizione più importante il 10 novembre fu contro San Miniato al Tedesco. Si trattò di una
spedizione in piena regola con 400 fanti e tutti i cavalli disponibili; il F. stesso assunse il comando, guidò l'assalto e fu tra i primi a
scalare le mura. Dopo un'accanita difesa gli Imperiali si arresero e la città restò presidiata da una guarnigione comandata da Goro da
Montebenichi.
La volontà del F. di non dare tregua al nemico lo portava a presidiare incessantemente la valle dell'Arno ma anche a organizzare
spedizioni più lontano, come a Certaldo. E intanto continuava a ragguagliare i Dieci sul proprio operato e a chiedere quei rinforzi che
gli avrebbero consentito di riconquistare il controllo sul Valdarno, allentando di conseguenza la pressione nemica su Firenze. Ma le
sue insistenti richieste restavano per lo più inascoltate: i soldi arrivavano con tale ritardo che più volte dovette contrarre debiti per
pagare i soldati. Anche il suo piccolo esercito fu più volte assottigliato per provvedere di uomini Pisa e Fucecchio. Così dopo un
ultimo successo riportato ai danni di Pirro Colonna, nei pressi di Montopoli, per il resto dell'inverno il F. dovette sospendere le azioni
militari. Le conseguenze negative di questa politica non tardarono a manifestarsi: gli Imperiali intensificarono i loro sforzi e, forti di
una netta superiorità numerica, ripresero gradualmente le posizioni perdute. San Miniato si arrese ai primi di febbraio 1530, seguita da
Pomarance e da Montecatini.
Contemporaneamente a questa avanzata nemica un nuovo duro colpo alla Repubblica fiorentina veniva da Volterra, dove la
popolazione si accordava col commissario del papa, T. Guiducci, e abbracciava la causa medicea. Solo la fortezza in cui si era chiusa
la guarnigione guidata dal commissario B. Tedaldi restava fedele a Firenze, da cui aspettava soccorsi. La perdita di Volterra, dopo
Pisa la città più importante rimasta ai Fiorentini, era particolarmente grave e di conseguenza la Signoria decise di fare ogni sforzo per
riprenderla. Dell'impresa fu dato il comando al F., cui fu conferito il titolo di commissario generale di campagna delle genti dei
Fiorentini.
Per consentire al F. di compiere la spedizione senza lasciare Empoli sguarnita di uomini e priva di comando, da Firenze gli furono
inviate cinque compagnie insieme col commissario A. Giugni che lo avrebbe sostituito in città. Il 26 aprile il F. lasciò Empoli con
2000 fanti e 150 cavalli; giunto a sera a Volterra, riuscì a entrare nella fortezza e subito, senza dare tempo al commissario pontificio di
organizzare la difesa, fece prendere d'assalto l'abitato. Si combatté accanitamente fino a notte inoltrata; il mattino seguente prevalse
tra la popolazione il parere di venire a un accordo per evitare una totale distruzione. Il F. pretese e ottenne una resa a discrezione e
d'accordo col commissario Tedaldi e dietro precise richieste dei Dieci di balia impose ai Volterrani severe misure fiscali.
La reazione degli Imperiali alla conquista di Volterra non si fece attendere. Il capitano F. Maramaldo che già da tre mesi era in
Toscana con le sue soldatesche, predando e saccheggiando tra Pienza, San Quirico e Buonconvento, si portò sotto la città e l'8 maggio
forzò la cinta esterna di mura, molto ampia, e pose il campo nel borgo di San Giusto, dalla parte opposta rispetto alla fortezza. Ma
constatando che, contrariamente alle sue aspettative, non era sufficiente la sua sola presenza per far ribellare i Volterrani, si limitò a
qualche scaramuccia senza osare un attacco deciso. Questa situazione di stallo, provvidenziale per il F. che ne approfittò per
migliorare e potenziare le difese della città, si protrasse fino al 12 giugno quando D. Sarmiento e Alfonso d'Avalos, marchese del
Vasto, arrivarono da Empoli con un esercito forte di 5000 uomini tra Spagnoli e Italiani. Due giorni dopo iniziarono un intenso
bombardamento che aprì nelle mura una breccia tale da consentire alle truppe cesaree di entrare in città. Sembra che una disputa per la
precedenza tra il marchese del Vasto e il Maramaldo ritardasse l'assalto e permettesse ai difensori di richiudere la breccia e di
riorganizzarsi. Infatti, per quanto violento, l'attacco imperiale fu respinto e il bilancio delle perdite fu per gli assalitori di 300 0 400
uomini, mentre tra i Fiorentini caddero solo una ventina. Tra i feriti fu anche il F., colpito mentre guidava i suoi uomini.
Nei giorni seguenti gli Imperiali ritentarono, ma ancora senza risultato, nonostante il consistente impiego di artiglieria e 400 morti; il
29 giugno, spinti dalla mancanza di viveri e ormai anche di munizioni e dalla preoccupante indisciplina dei soldati, abbandonarono il
campo, dopo aver riportato la più bruciante sconfitta di tutta la guerra.
Questo brillante successo non mutava pero la drammatica situazione della Repubblica che aveva perso tutti i suoi possedimenti
(ultimo e importantissimo Empoli) tranne Volterra e Pisa, dove erano radunati gli uomini comandati da G. Orsini.La Signoria concepì
a questo punto un piano audace: far convergere sulla città tutte le forze disponibili e spezzare il blocco degli assedianti, e decise di
affidarne l'esecuzione al Ferrucci, nominato commissario generale per l'esercito esterno, con autorità assoluta per tutto quanto
riguardava la guerra Il F., lasciando a Volterra una guarnigione sufficiente a difenderla, doveva raggiungere a Pisa le forze di G.
Orsini e messi così insieme circa 4000 uomini muovere su Firenze. Al suo arrivo, dalla città si sarebbe fatta una sortita generale,
prendendo tra due fuochi gli Imperiali.
Nella notte del 15 luglio il F. si mise in viaggio per Pisa lungo la strada di Rosignano e Livorno; il Maramaldo, che non era in grado di
fermarlo, si limitò a sorvegliare le mosse inviando pattuglie in tutte le località che il F. avrebbe attraversato nella sua marcia su
Firenze. Il 18 luglio il F. entrava in Pisa, dove si dava febbrilmente inizio ai preparativi per la spedizione, perché dalla rapidità di
questa poteva dipendere il successo. Ma la speranza di far partire subito il F. non poté realizzarsi, perché questi, ancora sofferente al
ginocchio per una brutta caduta da cavallo avvenuta a Volterra, fu colto da una febbre persistente di cui i medici pisani non riuscirono
a venire a capo se non dopo parecchi giorni.
Effettivamente la sosta forzata del F. a Pisa ebbe gravi ripercussioni sull'esito della spedizione, compromettendone la già problematica
riuscita. Infatti il principe d'Orange, informato dei piani del F. e della Signoria da numerose lettere intercettate, aveva avuto modo di
organizzare la controffensiva che consisteva nel sorprenderlo a mezza strada con il suo esercito molto superiore numericamente e con
in più la sicurezza alle spalle garantitagli dagli accordi presi nel frattempo col Baglioni.
Finalmente il 31 luglio il F., guarito, fu in grado di partire alla testa di 3000 fanti per la maggior parte armati d'archibugio e di 300
cavalli leggeri. La mattina del 2 agosto proseguì per Calamecca, come informa l'ultima lettera da lui inviata ai Dieci. Il 3 agosto arrivò
a Lari e da qui deviò verso il villaggio fortificato di San Marcello, aderente alla fazione nemica dei Panciatichi, che assalì e prese
senza eccessiva difficoltà. Dopo una sosta per rifocillarsi proseguì verso Gavinana. Il Maramaldo, che aveva seguito a distanza il F.
per tutto il cammino di montagna, riuscì a raggiungerlo e a portarsi sul suo fianco sinistro, mentre A. Vitelli con le sue truppe si
teneva sulla destra e la fazione dei Panciatichi, con circa 1000 uomini, era alle spalle. Il principe d'Orange, che si era mosso da
Firenze il 1º agosto con circa 4500 uomini, era giunto nel frattempo sulle alture che dominano Gavinana. Il piano del F. basato sulla
sorpresa era già fallito: in effetti gli si stava chiudendo intorno la trappola preparata dalle preponderanti forze nemiche.
Lo scontro avvenne il 3 ag. 1530 a Gavinana (San Marcello Pistoiese) e nei boschi circostanti, dove si combatté aspramente e con
alterne vicende. In una prima fase le forze del F. riportarono un netto successo sulla cavalleria dell'Orange che, dopo la morte del
principe, che aveva combattuto in prima fila, si sbandò e si diede alla fuga. Nel paese invece lo scontro fu più duro e di esito più
incerto: a parecchie riprese i fanti del F. e quelli del Maramaldo, combattendo con le picche, con le spade, con gli archibugi, perfino
con i sassi in un crudele corpo a corpo, si impadronirono dell'abitato, respingendo fuori delle mura l'avversario.
Il tempo però era dalla parte degli Imperiali, che nonostante le forti perdite potevano contare su truppe non ancora logorate dal
combattimento. Invece l'unico soccorso che poteva venire al F. era la retroguardia dell'Orsini, rimasta però a lungo bloccata
dall'attacco del Vitelli e giunta a Gavinana quando ormai le sorti della battaglia erano decise. Dopo ore di combattimento le truppe del
F. erano allo stremo: moltissimi i morti e i feriti, molti i dispersi, molti infine coloro che si arresero e furono fatti prigionieri. Il F.
continuò a combattere fino all'ultimo senza volersi arrendere; infine, fatto prigioniero e condotto in presenza del Maramaldo, fu da
questo ferito e poi abbandonato ai soldati perché lo uccidessero.
Il comportamento spietato del Maramaldo fu del tutto inconsueto negli usi militari del tempo. Forse nella sua ostilità si potrebbe
leggere quella dell'uomo d'armi, del condottiero di professione, contro il semplice mercante e cittadino che nella guerra vedeva solo
l'ideale difesa della patria. E così in effetti l'intesero molti contemporanei, tra cui D. Giannotti, il quale nel suo elogio del F. ("ha
mostrato più perizia nell'arte della guerra che qualunque altro capitano de' tempi nostri") vide in lui la dimostrazione che "ogni
cittadino che abbia nelle altre cose prudenza si può intendere della guerra ed amministrarla molto meglio e con maggior frutto
pubblico che qualunque altro capitano mercenario" (in Opere...,a cura di F. Polidori, Firenze 1850, I, p. 303).
Fonti e Bibl.: Presso l'Archivio di Stato di Firenze si conserva un'ampia documentazione: le Ricordanze del padre Niccolò in Archivio
Galletti, 39; in Tratte, 988 sono documentati i primi incarichi pubblici; in Otto di pratica. Responsive, 42 e Dieci di balia. Responsive,
122 alcune lettere in cui il F. rende conto della sua attività come podestà. Per la missione in Abruzzo l'istruzione è in Dieci di balia.
Legazioni e commissarie. Istruz. e lettere a oratori, 47, cc. 9 s. Per l'azione di collegamento del F. tra il Baglioni e il commissario in
Valdichiana si hanno notizie dalle lettere ai Dieci del Soderini e poi del Bartolini e del Baglioni: cfr. Ibid., 48, passim. La patente per
la missione a Perugia del 31 ag. 1529 è in Dieci di balia. Missive, 108, c. 111v. Le patenti per l'incarico prima a Prato (4 ott. 1529) e
poi a Empoli (12 ottobre) ibid., cc. 122, 124v. Da questo momento la documentazione aumenta considerevolmente perché le lettere
del F. ai Dieci sono molto frequenti: cfr. Dieci di balia. Responsive, 146-149, 151, passim. Un altro gruppo di lettere è indirizzato a C.
Tosinghi, commissario a Pisa, in Strozziane, s. 1, 65 e 66, passim. Per le lettere da Volterra cfr. Otto di pratica. Responsive, 53,
passim; in Signori. Dieci Otto. Legazioni e commissarie. Responsive, 27, c. 288rv le copie di due lettere del F. da Pisa del 20 e 22
luglio (tra le ultime quindi inviate) non pubblicate in F. F. e la guerra di Firenze del 1529-1530. Raccolta di scritti e documenti rari,
Firenze 1889. In Balie, 53, c. 241bis v, in una nota di spese sostenute dai Dieci durante l'assedio, la provvisione del F. dal 5 ott. 1529
al 3 ag. 1530. La bibliografia sul F., della quale vanno comunque ricordate le biografie cinquecentesche di D. Giannotti, Sulla vita e
sulle azioni di F. F., Pisa 1818 e F. Sassetti, Vita di F. F., con centoventi lettere del F. al magistrato dei Dieci, ed altre, a cura di C.
Monzani, in Arch. stor. ital., s. 1, IV(1853), 2, pp. 422-683, e che comprende anche studi sull'assedio di Firenze e sulla fine della
Repubblica fiorentina, è molto vasta. Storici, cronisti, anche semplici contemporanei testimoni di tali vicende ne lasciarono memoria
anche in poesia: cfr. ad esempio M. Roseo da Fabriano, Lo assedio di Firenze, Perugia, 1530. Una ripresa degli studi, accompagnata
per lo più dalla pubblicazione di documenti inediti, si ebbe nell'Ottocento, con un'accentuata finalità celebrativa: si rimanda al cit. F.
F. e la guerra di Firenze... per la bibliografia fino al 1889. Per quella successiva cfr. F. Ferrucci, Le lettere, a cura di A. Valori, Roma
1938; Brevi cenni sulla vita di F. F., a cura di G. Romagnoli, Firenze 1897; C. Roth, The last Florentine Republic, London 1924,
passim; A. Valori, La difesa della Repubblica fiorentina, Firenze 1929, passim; E. Mazzoni, F. F. nel racconto dei contemporanei,
Firenze 1930; C. Masi, Empoli nella gesta fiorentina del 1529 e del 1530, in Miscell. stor. della Valdelsa,XXXVIII(1930), pp. 119154, e ibid., pp. 155-172: G. Pilastri, Le spoliazioniferrucciane in Volterra; P. Pieri, Rassegna ferrucciana, in Riv. stor. ital., XLVIII
(1931), pp. 208-220; Id., Il Rinascimento e la crisi militare italiana, Torino 1952, pp. 585-593.
Francesco Ferrucci
(1489 - 1530)
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Francesco Ferrucci (Florence, 1489 - Gavinana, 3 août 1530) était un militaire italien qui fut condottiere de la République de
Florence. Il personnifie la résistance à l’empereur Charles Quint lors du siège de la ville en 1530 où, blessé et prisonnier après la
bataille de Gavinana, il meurt assassiné. Biographie Il naît à Florence, en 1489, dans le quartier de l'Oltrarno, dans un palais de la via
dei Serragli. Les événements qui le virent se distinguer se déroulèrent pendant le siège de Florence (12 octobre 1529 - 12 août 1530),
opéré par les milices impériales de Charles V, constituées principalement d'italiens recrutés. Pendant ce siège de Florence, le
secrétaire du gouvernement florentin, lui délivre une lettre de créance l'autorisant à se rendre partout où il voudra pour réunir les
hommes et les fonds indispensables à la protection et à la survie de l'éphémère République de Florence. Ensuite il devient célèbre
pour sa vaillante défense à la tête de l'armée de la République florentine et qu'il opposa aux impériaux. Après une victoire à Volterra
(et à San Miniato qu'il délivre aussi) qui l'oppose à Fabrizio Maramaldo qu'il bat la même année, il est finalement vaincu à Gavinana
par les forces impériales, sur la montagne pistoiese, blessé et capturé le 3 août 1530. il meurt assassiné par Maramaldo, capitaine et
l'homme d'armes calabrais aux services des impériaux (qui avait pris part au sac de Rome en 1527) et auquel Ferrucci aurait dit :
« Maramaldo, tu tues un homme mort ». En argot, maramaldo signifie lâche, violent, qui n'hésite pas à tuer des hommes sans défense.
Dans la même bataille le commandant de l'armée impériale, Philibert de Châlon, prince d'Orange, perdit également la vie.
Hommages Le sacrifice de Ferrucci est devenu, à l’époque de l'Unification italienne, l'emblème du sentiment d'orgueil national et le
nom de son agresseur devenu, par antonomase, synonyme de traître, de félon. Sur la place centrale de Gavinana, aujourd'hui une
frazione de la commune de San Marcello Pistoiese, on peut admirer, depuis 1913, la statue équestre du condottière florentin, une
œuvre du sculpteur Emilio Gallori, son concitoyen. En août 1929, en vue du quintuple centenaire de sa mort, fut acquise et restaurée
la maison ex-Battistini de la place principale de Gavinana, sur le seuil de laquelle Ferrucci a été tué. Il est cité dans une strophe de
l'Inno di Mameli, l'hymne national italien :
Ogn’uom di Ferruccio, Chaque homme a le cœur,
Ha il core, ha la mano, la main de Ferruccio,
Francesco Ferrucci
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Francesco Ferrucci (Firenze, 14 agosto 1489 – Gavinana, 3 agosto 1530) fu un condottiero italiano, al servizio della Repubblica di
Firenze. Biografia Le vicende che videro protagonista Ferrucci si svolsero durante l'Assedio di Firenze (12 ottobre 1529 - 12 agosto
1530), ad opera delle milizie imperiali di Carlo V, costituite però prevalentemente da italiani. Ferrucci divenne celebre per la strenua
difesa che l'esercito della Repubblica Fiorentina, da lui guidato, oppose agli imperiali. Ferrucci il 3 agosto 1530 uscì in campo aperto
e tentò un ultimo scontro per spezzare l'assedio in quella che divenne la battaglia di Gavinana. Il capo delle truppe imperiali Filiberto
di Chalons, principe d'Orange, venne ucciso nel combattimento da due colpi di archibugio, ma Ferrucci venne sopraffatto da forze
preponderanti, rimase ferito e con i pochi superstiti si arrese decretando la fine della battaglia. Fabrizio Maramaldo un soldato di
ventura al soldo dell'esercito imperiale spagnolo, si fece condurre il prigioniero sulla piazza di Gavinana, lo disarmò e contro tutte le
regole della cavalleria si vendicò delle offese precedenti, ferendolo a sangue freddo e lasciandolo poi trucidare dai suoi soldati.[1] Le
cronache tra loro non concordano sul tipo di ferita inferta a Ferrucci, che viene indicata alternativamente al petto, o alla gola, o al viso,
mentre tutte riportano che Francesco Ferrucci prima di spirare gli abbia rivolto con disprezzo le celebri parole: Vile, tu uccidi un
uomo morto. Dieci giorni dopo Firenze si arrese agli imperiali e dovette accettare il rientro dei Medici. Il sacrificio di Ferrucci è
diventato, in epoca risorgimentale, emblema del sentimento di orgoglio nazionale, e il nome del suo aggressore (Maramaldo) è
divenuto, per antonomasia, sinonimo di "uomo malvagio, spavaldo e prepotente soprattutto con i deboli, gli indifesi, gli sconfitti"[2]
(essere un maramaldo).
Commemorazioni Il condottiero fiorentino è citato nella quarta strofa dell'Inno di Mameli:
« Ogn'uom di Ferruccio
Ha il core, ha la mano»
•
•
•
•
Nella piazza centrale di Gavinana, oggi una frazione del comune di San Marcello Pistoiese, si può ammirare, dal 22 agosto
1920[3][4], la statua equestre del condottiero fiorentino, opera dello scultore suo concittadino Emilio Gallori.
Nell'agosto 1929, in vista del cinquecentenario della morte, fu acquistata e restaurata la casa ex Battistini nella Piazza
principale di Gavinana, sulla cui soglia, secondo la tradizione, Ferrucci morì.
La sua casa natale si trova a Firenze in via Santo Spirito (zona Oltrarno) ed è segnalata da una targa commemorativa.
A San Marcello Pistoiese, una targa commemorativa di un edificio sito in via Roma, ne ricorda il suo breve passaggio in
paese.
Note
1.
^ Deputazione napoletana di storia patria, Naples, Società napoletana di storia patria, Archivio storico per le province
napoletane, Volume 3, Detken & Rocholl e F. Giannini, 1818.
2. ^ voce: maramaldo, Treccani.it
3. ^ Gravinana: Monumento Equestre a Francesco Ferrucci. URL consultato il 17/03/2009.
4. ^ Miliziade Ricci, Per la gloria di Francesco Ferrucci: inaugurandosi il monumento equestre a Gavinana, Gavinana:
Comitato dei festeggiamenti a Ferrucci, 1920 (Pistoia: Pacinotti) [1920], 76 pag.. URL consultato il 17/03/2009.
Bibliografia
• Giorgio Batini, Capitani di Toscana, Firenze, Edizioni Polistampa, 2005, pp. 158 - 169, ISBN 8883049152.
• Alessandro Montevecchi, Biografia e storia nel Rinascimento Italiano, Gedit, Bologna, 2004, ISBN 8888120459.
Altri progetti
Wikiquote contiene citazioni di o su Francesco Ferrucci
Collegamenti esterni L'Inno Nazionale - Sito del Quirinale
Effigie di Francesco Ferrucci in un francobollo coloniale italiano del 1930. Statua di Ferrucci agli Uffizi
Raffigurazione di Francesco Ferrucci all'assedio di Volterra in un francobollo coloniale italiano del 1930. Maramaldo uccide Ferrucci,
francobollo delle poste italiane emesso per il 4º centenario della morte di Francesco Ferrucci - 10 luglio 1930
Gonzaga, Ferrante
(1507 - 1557)
Dizionario Biografico degli Italiani
di GG. Brunelli
GONZAGA, Ferrante. - Nacque a Mantova il 28 genn. 1507, terzogenito del marchese Francesco II e di Isabella d'Este.
Nell'adolescenza mostrò predilezione per gli esercizi cavallereschi. Già nel 1523, forse a causa di una condotta a tratti irrequieta, fu
inviato alla corte di Carlo V, accompagnato da P. Pico della Mirandola. La decisione fu anche politica: suo fratello, il marchese
Federico, già comandante generale delle truppe del papa e della Repubblica fiorentina, si stava infatti schierando fra i partigiani
dell'imperatore in Italia.
Giunto nell'estate 1523 a Valladolid, il G. comprese presto che l'esperienza poteva riuscirgli "de honore et de utile" (a Isabella d'Este,
Burgos, 29 maggio 1524, in Tamalio, 1991, p. 167). Si adeguò al sobrio stile della corte imperiale, acquistando rapidamente credito.
Mentre progressivamente allentava i legami con Mantova, mise a punto una strategia modellata sui cardini della cultura cortigiana:
sapendo che Carlo V faceva "più conto deli homini da guerra che de altra sorte che siano", il G. si preparò, attraverso la carriera
militare, a offrirgli esempi di "tal servitù" da ottenerne adeguata "mercede" (a Isabella d'Este, Burgos, 18 luglio e Valladolid, 9 ag.
1524: ibid., pp. 185 e 189). Nell'agosto 1526 vi furono i primi segni che Carlo V era disposto ad assecondare queste ambizioni: non
concedette al G. licenza di partire per sposarsi e gli assegnò una condotta di 100 uomini d'arme per passare in Italia, dove il conflitto
franco-imperiale era sul punto di riprendere.
Il G. si imbarcò poche settimane più tardi con i rinforzi destinati alla penisola, sotto il comando di Ch. de Lannoy, viceré di Napoli.
Giunto in Italia in novembre, visitò a Mantova i congiunti e prese servizio a Reggio Emilia presso il comandante delle truppe
imperiali nel Milanese, il conestabile Ch. de Bourbon-Montpensier, cui era legato da parentela. Quindi mosse col grosso dell'esercito
che, dopo la congiunzione con i lanzichenecchi (febbraio 1527), iniziava la marcia verso Sud, ottenendo i primi incarichi di comando
superiore. Fu l'assalto alle mura di Roma (6 maggio 1527) a offrirgli la migliore occasione di emergere: trovandosi sulla breccia
aperta nella cinta della Città leonina poco dopo l'inizio dell'attacco decisivo, contribuì a dissipare lo sbandamento seguito nelle truppe
alla morte del Bourbon-Montpensier. Ebbe invece scarso successo il suo tentativo di evitare il successivo sacco della città. Versando
una cospicua taglia alla soldatesca riuscì solo a salvare palazzo Colonna, dove dimorava la madre Isabella, permettendole a metà
maggio di uscire da Roma per raggiungere Mantova. Secondo i contemporanei il G. non ebbe parte del ricchissimo bottino ottenuto
nel sacco; nondimeno si procurò alcuni arazzi della cappella Sistina, della serie degli Atti degli apostoli (da cartoni di Raffaello),
riscattandoli da soldati spagnoli. Lasciò Roma alla fine del giugno 1527 per raggiungere Velletri col compito di tenere unite le genti
d'arme, ancora non pagate. Cadde quindi malato, accusando per tutto il successivo autunno violenti attacchi di febbre.
Quando gli Imperiali lasciarono Roma per muovere in soccorso del Regno di Napoli minacciato dai Francesi (gennaio 1528), il G. fu
nominato capitano generale dei cavalleggeri e divenne stretto collaboratore di Ph. de Chalon principe d'Orange, comandante in capo.
Nell'assedio imposto alla capitale da Odet de Foix, visconte di Lautrec, si distinse in azioni di disturbo all'approvvigionamento degli
assedianti, esponendosi tanto che in una delle sortite, alla fine del giugno 1528, cadde nelle mani dei nemici e solo "la furia de'
tedeschi lo liberò" (Guicciardini, p. 1953). Infine prese parte allo scontro di dimensioni più vaste, che, a fine agosto 1528, dopo la
morte del Lautrec, provocò la rotta dei Francesi.
A guerra conclusa il G. ottenne il ducato di Ariano (attuale Ariano Irpino), già del ribelle A. Carafa, provvisto di circa 12.000 ducati
di entrata. Nell'ottobre 1528 passò a combattere in Puglia, dove numerosi centri del litorale rimanevano in possesso di nobili e fazioni
locali ribelli all'autorità imperiale, appoggiati da forze francesi e veneziane. Al G., alla fine di febbraio 1529, fu affidato l'assedio di
due dei maggiori punti di resistenza, Barletta e Trani, mentre contro Monopoli si dirigeva Alfonso d'Avalos, marchese del Vasto.
Radunati circa 1500 cavalleggeri e un numero non inferiore di fanti, nella seconda metà di aprile 1529 il G. prese posizione in
Capitanata. Costretto a far fronte ai disordini fra le truppe e le popolazioni (soprattutto in Ascoli Satriano) e alle tensioni originate dai
mancati pagamenti, poté solo tentare qualche operazione in avanscoperta presso Barletta. Il marchese del Vasto, invece, riconquistò
alcuni centri del Gargano (Vieste, Vico e Monte Sant'Angelo) e, ottenuta dal principe d'Orange autorità sul contingente del G., decise
l'assedio di Monopoli. Il G. non accettò questa subordinazione e alla fine di maggio si recò a Napoli, dove iniziò trattative
matrimoniali con Isabella Di Capua, orfana ed erede di Andrea, duca di Termoli e principe di Molfetta. Rientrato a Venosa, pur
recando circa 20.000 ducati per i pagamenti alle truppe, ne mantenne a stento il controllo, tentando comunque azioni contro Barletta.
Quando però, all'inizio di luglio, giunse notizia della campagna decisa dall'imperatore contro Firenze (in seguito alla richiesta di
Clemente VII di riportare i Medici al governo), il G. subito manifestò il proposito di passare a quell'impresa, nonostante Molfetta e
Giovinazzo, feudi della sua promessa sposa, fossero cadute nelle mani dei nobili ribelli e dei Veneziani.
In un primo momento parve che egli dovesse rimanere a presidio del Regno di Napoli come luogotenente generale. Ma, pacificata
l'Italia meridionale (assegnata a Carlo V dalla pace di Cambrai del 5 luglio 1529), si affrettarono i preparativi delle operazioni contro
la Repubblica fiorentina e il G. fu chiamato dall'Orange come comandante dei cavalleggeri. Alla fine di luglio si recò a Napoli, dove
non poté superare difficoltà relative al contratto di matrimonio (concluso in segreto e per procura solo nell'agosto 1530, dopo che
erano fallite altre trattative con Isabella di Vespasiano Colonna). Quindi, alla fine di settembre 1529, il G. raggiunse il grosso delle
truppe, che aveva completato la marcia attraverso l'Umbria e si era impadronito della città (non della rocca) di Arezzo.
Mentre i Fiorentini apparivano intenzionati a concentrare le difese, le truppe dell'Orange si impadronirono del Valdarno superiore,
giungendo a metà ottobre nella pianura di Ripoli (oggi Bagno a Ripoli), sotto Firenze, per iniziare l'assedio. Il G. contribuì ad allestire
le posizioni offensive, posizionando batterie di artiglieria e durante le rare operazioni a fine 1529 si distinse per il deciso contrasto ai
tentativi di introdurre viveri nella città. Nello stesso periodo incontrò anche a Bologna l'imperatore e Clemente VII, dal quale ottenne
finanziamenti. Quindi l'assedio entrò nella fase decisiva. Nella prima metà del 1530 gli Imperiali bloccarono la città con rigore sempre
maggiore; gli assediati poterono solo tentare sortite, efficacemente contenute dalle truppe del Gonzaga. Respinto un primo tentativo di
accordo, nei primi giorni di agosto (a Gavinana) fu annientata una spedizione di soccorso, che doveva spezzare le linee degli
assedianti. Morto in questa occasione il principe d'Orange, il G., succeduto nel comando generale, trattò con Malatesta Baglioni,
comandante generale dei Fiorentini, ottenendo la resa della città con condizioni apparentemente moderate: i Medici sarebbero rientrati
in Firenze, che avrebbe conservato la propria libertà, ed entro quattro mesi Carlo V avrebbe determinato la nuova forma di governo.
L'ambiguità dei termini del trattato non nascondeva l'imminente fine della Repubblica; il G. ammise esplicitamente che suo fine era
stato "far questo honore" a Carlo V e "far che la satisfation de Nostro Signor [Clemente VII] segua sotto questa coverta" (lettera a
Federico II Gonzaga, duca di Mantova, 10 ag. 1530, in Sanuto, LIII, col. 462). Così, superate residue opposizioni interne dal Baglioni
stesso e dagli aristocratici fiorentini, il 10 ag. 1530 furono stabiliti i patti concordati.
L'operato del G. fu molto gradito a Clemente VII, soprattutto per il fermo controllo delle truppe imperiali che volevano il sacco della
città: così fu nominato governatore di Benevento, enclave pontificia nel Regno di Napoli. Anche Carlo V gli manifestò concretamente
la propria stima e nel dicembre 1531 lo insignì dell'Ordine del Toson d'oro. Quando poi, nella primavera 1532, riprese l'avanzata
ottomana in Ungheria, al G. fu assegnato il comando della cavalleria. Condotto a Vienna un corpo di circa 2500 uomini, nel settembre
1532 giunse a Linz, dove fu subito impegnato nel mantenere il controllo dell'esercito, scosso da contrasti fra soldati delle diverse
nazionalità e da ammutinamenti. Quanto alla condotta della guerra, il G. convenne con l'ipotesi di porre il campo sotto Vienna, ma si
trattò di una scelta non molto felice: i Turchi, infatti, non accettarono battaglia e, durante la ritirata, Carinzia e Croazia furono
devastate.
Il G. tornò in autunno presso Carlo V e lo precedette in Italia: quindi accompagnò l'imperatore all'incontro di Bologna con Clemente
VII e lo seguì a Milano. Solo nell'aprile 1533 ebbe una licenza, ma l'inattività durò pochi mesi: pur senza alcun incarico, infatti, non
rinunciò a prendere parte all'impresa contro Tunisi. Nel giugno 1535, per controbattere i pirati barbareschi e riprendere il controllo del
Mediterraneo, Carlo V aveva riunito a Barcellona un'armata da dirigere contro Khair ad-Dīn, il Barbarossa. Il G. giunse in Nordafrica
qualche giorno dopo la presa della Goletta da parte degli Imperiali. Accolto calorosamente, si distinse per valore nella battaglia del 20
luglio, vinta dalle forze di Carlo V. Presa la rocca di Tunisi e fuggito il Barbarossa, gli Imperiali si impadronirono facilmente della
città: il G. ne diede conto in una lettera data alle stampe, che ebbe vasta circolazione (Copia di una littera dil s. don Ferando
Gonzaga… de la presa de Tunizi…, s.n.t. [ma A. Blado], 1535).
Consapevole dell'importanza strategica che la Sicilia assumeva a seguito delle nuove conquiste, Carlo V ne nominò viceré il G. (2
nov. 1535), dandogli istruzione di rafforzarne le difese. Ebbe però appena il tempo di insediarsi, perché la morte del duca di Milano,
Francesco II Sforza, e la conseguente crisi negli equilibri della penisola lo allontanarono subito dal governo dell'isola. Nel dicembre si
recò a Napoli e seguì poi Carlo V a Roma (aprile 1536); l'occupazione francese della Savoia e del Piemonte lo richiamò al servizio
attivo nell'esercito imperiale.
Carlo V progettava di assalire alle spalle i Francesi, irrompendo in Provenza e a Nord, nella Piccardia. Il G. sconsigliò una mossa così
impegnativa, essendo la stagione troppo inoltrata, ma quando l'invasione fu decisa entrò in Provenza alla testa del contingente
d'avanguardia (fine luglio 1536). Mentre i Francesi, devastata la regione, si ritiravano per evitare una battaglia campale, gli Imperiali
(guidati dallo stesso Carlo V) avanzavano lungo il litorale. Il G. si distinse nella conquista di Brignoles, che permise all'imperatore di
impadronirsi anche di Aix-en-Provence (5 ag. 1536), ma si segnalò soprattutto per fatti non militari. Fu accusato infatti, insieme con
Antonio de Leyva, di aver fatto avvelenare il delfino di Francia, Francesco (deceduto il 10 agosto), e l'imperatore stesso intervenne
pubblicamente per allontanare i sospetti. Esaurita (inizio settembre 1536) l'avanzata e decisa la ritirata, il G. si recò a Mantova.
Nel marzo 1537 tornò in Sicilia e, trovato esausto l'Erario, convocò il Parlamento. Il generale colloquium aveva competenze su molte
materie (difesa e ordine pubblico, giustizia, amministrazioni locali) e determinava ammontare e modalità di riscossione del donativo,
la più importante imposta. Aperta la sessione il 10 apr. 1537, il G. ottenne cospicui finanziamenti per far fronte alla minaccia di
un'invasione ottomana; alla fine dell'estate, cessato l'allarme, poté dedicarsi a importanti questioni di governo: ispezionò le difese dei
principali centri, predisponendo gli interventi necessari, prese provvedimenti risoluti contro il banditismo e approntò una riforma
dell'amministrazione della giustizia civile. Perdurava però l'emergenza finanziaria. Il sistema di governo prevedeva, infatti, che il
Regno di Sicilia provvedesse in proprio alle spese correnti e a quelle militari, compresi i costi delle guarnigioni della Goletta e di
Bona, in Tunisia. Così, per soddisfare il fabbisogno, il G. programmò vendite di "terre" demaniali e uffici pubblici, tentò riforme dei
tributi sulla esportazione e il commercio interno dei cereali, appaltò le entrate fiscali a privati, ricorse persino a prestiti e a
composizioni di gravi vicende giudiziarie.
Nel contempo non rinunciò a iniziative più ampie, come la proposta di un accordo tra Khair ad-Dīn e Carlo V. Si trattava d'una mossa
del tutto aderente alla visione politica generale del G., che riteneva necessario consolidare il dominio imperiale nel Mediterraneo,
abbandonando progressivamente i teatri di conflitto nelle Fiandre e in Germania. Così, nell'aprile 1537 egli sostenne presso Carlo V le
proposte del Barbarossa, che si impegnava a lasciare il servizio della Porta se fosse stato posto a capo di uno Stato barbaresco da
Algeri a Tunisi, alleato della Spagna e legato all'imperatore da vincoli vassallatici. La trattativa durò nei mesi seguenti, mentre
riprendeva lo scontro militare. Il G., infatti, per non lasciare inoperosi i contingenti che presidiavano la Sicilia, aveva allestito una
spedizione in Nordafrica per sottomettere Hammamet, Sfax, Susa e Monastir, avvalendosi di un accordo politico e finanziario col re
di Tunisi, Muley Hassan (reinsediato nel 1535). L'operazione ebbe inizio a fine febbraio 1538; tuttavia, per il maltempo, fu possibile
sbarcare solo un esiguo contingente che nel maggio seguente tentò, senza esito, di porre l'assedio a Susa. I timori del G. circa i disagi
delle truppe, mal pagate, si dimostrarono fondati. Nello stesso maggio 1538, infatti, egli dovette affrontare l'ammutinamento del
presidio spagnolo della Goletta, che col pretesto della richiesta degli arretrati era sbarcato sul litorale ionico e depredava i paesi alle
falde dell'Etna. Dopo abili trattative riuscì a ricondurre all'obbedienza il grosso delle truppe e punì i responsabili della sollevazione.
La dura repressione provocò in Spagna risentite reazioni, che però non trovarono ascolto: l'imperatore intendeva servirsi del G. negli
impegni militari programmati nel Mediterraneo. Infatti, conclusa la lega tra Venezia, Paolo III e Carlo V (8 febbr. 1538), egli fu
nominato comandante delle truppe in caso di sbarco a terra e luogotenente del generale Andrea Doria, ricevendo istruzioni di condurre
a Messina le galere della Sicilia, unendole al resto della flotta. A fine luglio del 1538 fece salpare l'armata verso il golfo di Corfù.
Dato che la stagione era molto avanzata, gli stati maggiori imperiali ritenevano che si potesse solo conquistare qualche posizione a
terra, dalla quale lanciare la campagna la successiva primavera. I comandanti delle squadre navali pontificia e veneziana premevano
invece per un'azione immediata. Il G., dovendo attendere l'arrivo di A. Doria, non partecipò a un primo tentativo dell'agosto 1538,
rimasto senza esito, di conquistare Prevesa, all'imbocco del golfo di Arta. Riteneva, peraltro, che fosse troppo rischioso affrontare il
Barbarossa, coperto dalle artiglierie disposte a terra, e che si dovesse attaccarlo solo se fosse uscito allo scoperto. Lo scontro del 27
sett. 1538 (dopo che era giunto A. Doria) avvenne invece proprio nelle condizioni sfavorevoli da lui presagite e la flotta cristiana
eseguì un'affrettata ritirata che originò un clima di sospetti e di accuse (amplificato dalle notizie di nuovi contatti fra gli Imperiali e il
Barbarossa). Lo stesso G. criticò il comportamento di equipaggi e capitani, censurò l'irresolutezza dell'ammiraglio Doria e sollecitò a
tentare nuovamente la battaglia quando le navi ottomane si presentarono davanti all'isola di Paxo. Prese quindi l'iniziativa di assediare
Castelnuovo di Cattaro (Herceg Novi), che conquistò il 27 ott. 1538: non riteneva per questo opportuno impegnarsi in un teatro di
guerra come il golfo di Cattaro, più adatto ai Veneziani e sarebbe stato pronto a cedere loro la piazza. Nelle stesse settimane peraltro
esplorava le possibilità di passare al servizio della Serenissima, essendo insoddisfatto del suo ruolo nell'organizzazione militare
imperiale.
All'inizio del successivo dicembre il G. tornò a Messina. Subito dovette far fronte all'ammutinamento dei reduci della spedizione
contro Castelnuovo, che, non pagati, erano sbarcati sulla spiaggia messinese e vessavano le popolazioni. Egli ne ebbe di nuovo
ragione pagando parte degli arretrati e procedendo risolutamente a esecuzioni dei maggiori responsabili. Nel contempo riprese i
contatti col re di Tunisi per impadronirsi delle città del litorale tunisino ancora fuori controllo. Anzitutto tentò di provvedersi di mezzi
finanziari, non esitando a imporre in Sicilia (gennaio 1539) un dazio straordinario sui cereali. Il quadro politico generale, però,
conclusa la tregua tra Turchi e Veneziani, appariva incerto. Così, dopo che l'imperatore aveva accolto il disegno con freddezza, A.
Doria, comandante supremo sul mare, palesò il suo disaccordo (settembre 1539), vanificando il progetto.
Le proposte del G. trovavano ormai scarso ascolto. Nella stessa estate aveva invano esortato a soccorrere il presidio spagnolo di
Castelnuovo assediata dai Turchi (caduta all'inizio di luglio). Anche nuovi tentativi per concludere l'accordo col Barbarossa, che al G.
pareva vicino, si erano infranti. Così, alla fine dell'ottobre 1539 egli si recò nelle Fiandre per trattare con Carlo V delle possibili
iniziative militari e delle difficili condizioni finanziarie del Regno di Sicilia. Tornato nell'isola nell'aprile 1540, convocò il
Parlamento, dal quale ottenne un donativo di 300.000 fiorini e un aumento delle imposte sulle esportazioni di cereali. Poi A. Doria lo
chiamò all'azione contro le città della costa tunisina. Era un'iniziativa che aveva apertamente sconsigliato: avendo ancora ordini di
"concludere la pratica con Barbarossa" non gli sembrava opportuno assalirlo per "levarli le cose sue" (a Carlo V, Messina, 2 ag. 1540,
in Capasso, 1906, p. 451). Si preparò comunque a combattere: mosse con 51 galere (settembre 1540) e riconquistò Monastir,
Hammamet, Susa, Sfax, sottomettendole al re di Tunisi. Rientrato a Palermo in novembre, tentò di porre rimedio alle drammatiche
condizioni dell'Erario siciliano. Non esitò a ricorrere a composizioni finanziarie di vicende giudiziarie anche gravi, ma non poté
comunque pagare i presidi spagnoli nelle città tunisine conquistate, dei quali ordinò il reimbarco nell'aprile 1541. Fervevano, nel
contempo, i preparativi per la spedizione contro Algeri, personalmente diretta da Carlo V. Alla metà di agosto del 1541 il G. partì per
Maiorca, punto di riunione, a capo di un contingente di 8000 fanti; ebbe di nuovo il comando generale delle truppe da sbarco (circa
24.000 uomini). L'esercito imperiale si presentò a fine ottobre davanti ad Algeri; dopo scontri di lieve entità, un violento attacco
barbaresco contro il campo delle truppe italiane fu respinto a fatica: quindi le proibitive condizioni meteorologiche obbligarono gli
Imperiali a ritirarsi, palesando l'insuccesso completo dell'impresa.
A fine novembre il G. tornò in Sicilia, dove la crisi dell'economia aveva conseguenze esiziali sulle entrate fiscali; egli accrebbe il
numero di uffici pubblici in vendita, ipotizzò aumenti del donativo e un tributo progressivo sulle esportazioni di grano. Poté quindi
dedicarsi a lavori di fortificazione già avviati (a Palermo, Messina, Trapani, Siracusa) e ne programmò altri a Catania e Lentini.
Credeva ancora possibile stringere un patto col Barbarossa; nel luglio 1542 intavolò trattative, giungendo perfino a verificare gli spazi
per una tregua triennale con il sultano: di una proposta in tal senso (approvata da Carlo V e firmata dal G.) diedero successivamente
notizia gli osservatori a Costantinopoli, ma non ne scaturì alcun risultato.
Nella stessa estate del 1542, le ripetute frizioni tra Francesco I e Carlo V lasciavano presagire una nuova guerra con la Francia. Così,
al G. fu ordinato di unire le galere siciliane in azione contro i pirati con il grosso della flotta (a Genova) e di prepararsi a spedire in
Spagna un cospicuo contingente di fanti. Carlo V prevedeva, infatti, che l'attacco dei Francesi e dei loro alleati sarebbe stato sferrato
nei Paesi Bassi e in Navarra (il che avvenne alla fine del luglio 1542), mentre il G. considerava più esposta la penisola. Recatosi a
Palermo a metà del successivo ottobre, ebbe due mesi di licenza all'inizio del 1543 (durante i quali trattò del matrimonio del figlio
Cesare con Diana Cardona). Quindi, alla fine di marzo, presieduto il Parlamento siciliano e ottenuti cospicui finanziamenti, lasciò
l'isola per assumere il comando degli eserciti imperiali. Raggiunto a Genova Carlo V, fu con lui all'incontro di Busseto con Paolo III
(22-25 giugno 1543); allora, come altri consiglieri dell'entourage imperiale, si schierò contro la proposta del pontefice di assegnare
Milano a Margherita d'Austria, sposa di Ottavio Farnese, in cambio d'una forte somma di denaro. Gli sembrava infatti che Carlo V
avrebbe dovuto continuare a difendere il Ducato, mentre investendone i Farnese non ne avrebbe mantenuto stabilmente il controllo.
L'offerta del papa fu lasciata cadere, ma l'aperta presa di posizione del G. gli attirò l'ostilità della famiglia di Paolo III. Alla ripresa
della guerra Oltralpe egli prese servizio come luogotenente generale dell'esercito. La campagna era condotta contro Guglielmo III di
Kleve-Jülich, alleato di Francesco I, che reclamava il possesso per diritto ereditario della Gheldria e aveva sconvolto i Paesi Bassi con
una veloce campagna militare, guidata da M. van Rossem. Il G. pose un duro assedio a Düren, presso Liegi, conquistandola
nell'agosto 1543; il feroce saccheggio che seguì consigliò di pattuire la resa ai difensori di Jülich e delle città della Gheldria fedeli al
duca Guglielmo. Quest'ultimo, allora, all'inizio di settembre chiese e ottenne il perdono di Carlo V.
Teatro delle azioni successive furono l'Hainaut e il Lussemburgo, caduti nelle mani dei Francesi nella stessa estate 1543. Il G. tentò di
conquistare Guise, entrando in contatto con le truppe nemiche; quindi, congiunse le sue forze con quelle che assediavano Landrecy.
La piazza appariva molto ben difesa e, a fine ottobre, mosse in suo soccorso un potente esercito guidato dallo stesso Francesco I. La
stagione avanzata sconsigliava uno scontro di grandi proporzioni, cui non avrebbe potuto partecipare Enrico VIII, alleato
dell'imperatore. Così, per decidere le strategie future e concordare gli apprestamenti necessari, il G. fu inviato in Inghilterra, insieme
con G.B. Castaldo. Le istruzioni dategli all'inizio del dicembre 1543 insistevano sulla necessità anzitutto politica di neutralizzare
l'espansionismo di Francesco I sfidandolo con un'azione militare decisa, guidata personalmente dai due sovrani e diretta al cuore del
territorio francese, fino a Parigi. La missione, rapida, ebbe esito positivo: fu stabilito che Carlo V ed Enrico VIII sarebbero entrati in
Francia al più tardi alla fine di luglio, con 20 o 25.000 fanti e 5000 cavalieri. Il primo avrebbe marciato attraverso la Champagne, il
secondo attraverso la Piccardia.
Le operazioni iniziarono nel maggio 1544. Al G., col grado di luogotenente generale, fu dato il comando delle truppe concentrate in
Cambrai, con l'ordine di riconquistare Lussemburgo e di muovere dentro il territorio francese devastando le campagne, in attesa che
Carlo V completasse i preparativi e si ponesse a capo dell'esercito. Fu una campagna brillante: nel giugno 1544, dopo Lussemburgo, il
G. conquistò Ligny e Commercy; quindi, posto l'assedio a Saint-Dizier, cedette il comando del campo all'imperatore e - espugnata
questa piazza - lo accompagnò mentre tentava l'avanzata verso Parigi, dapprima lungo la Marna poi (all'inizio di settembre) puntando
a Nord verso Soissons. Il G. si distinse in questa occasione nelle conquiste di Château-Thierry ed Épernay. Nondimeno, la stanchezza
degli eserciti, la difficoltà degli stati maggiori imperiali di garantire approvvigionamenti alle truppe, lo spavento delle masse nella
capitale francese favorirono la ripresa delle trattative di pace, delle quali il G. fu protagonista.
Già alla fine del luglio 1544 i Francesi avevano intavolato negoziati con N. Perrenot de Granvelle, al quale, insieme con il G., Carlo V
concesse poco dopo poteri di plenipotenziari. Tra la fine di agosto e l'inizio di settembre 1544 entrambi, con il vescovo di Arras (figlio
del Granvelle) e il segretario A. de Idíaquez, incontrarono a Saint-Amand, presso Châlons, la delegazione francese guidata
dall'ammiraglio C. d'Annebault. Le trattative erano ostacolate dalle onerose condizioni poste dai Francesi: solo dopo la conquista di
Boulogne da parte degli Inglesi (sbarcati alla fine di giugno) se ne affrettò la conclusione. Il trattato di Crépy, firmato da Granvelle e
dal G. il 18 sett. 1544, ristabilì lo status quo ante, cancellando le modifiche territoriali seguite alla pace di Nizza del 1538; Francesco I
rinunciò definitivamente al Regno di Napoli, alle Fiandre, all'Artois e s'impegnò a partecipare a un'impresa contro il Turco. Asburgo e
Valois stringevano, altresì, un legame matrimoniale: il duca Charles d'Orléans, figlio di Francesco I, avrebbe preso in moglie la figlia
maggiore di Carlo V (con in dote i Paesi Bassi e la Franca Contea), oppure la seconda figlia del re dei Romani (Ferdinando), cui
sarebbe stata assegnata Milano. L'alternativa doveva essere sciolta entro pochi mesi. Il G. si espresse apertamente per la cessione delle
Fiandre: mentre lo Stato di Milano gli sembrava indispensabile per mantenere il controllo della penisola, giudicava impossibile
consolidare il dominio dei Paesi Bassi, privi peraltro di eguale importanza strategica. Egli rimase però isolato: lo Stato di Milano fu
ceduto e solo la repentina morte dell'Orléans (1545) vanificò il trattato.
Tornato in Sicilia, il G. presiedette nel marzo 1546 le sessioni del Parlamento, in uno dei suoi ultimi atti come viceré: nel maggio
1546, infatti, lasciò l'isola essendo stato nominato governatore di Milano. Le sue ambizioni a riguardo erano note: dopo che, nel 1536,
aveva addirittura esplorato le possibilità di divenirne duca, nel maggio 1542 aveva inviato un suo uomo presso Carlo V per avvertirlo
che negargli quell'incarico sarebbe stato "far[gli] un frego in faccia per quanto durasse la vita [sua]" (Memoriale et instruttione
secreta… circa le vacantie che accascheranno…, in Capasso, 1905, p. 461). Così, nel 1543 era stato candidato a sostituire Alfonso
d'Avalos, marchese del Vasto, responsabile dei rovesci militari in Piemonte, ed era stato effettivamente nominato nell'aprile 1546.
Il 19 giugno il G. fece il suo ingresso a Milano. Subito impostò un'energica azione di governo, impegnandosi nella politica fiscale.
Introdusse un'imposta straordinaria (un "servizio" di 220.000 scudi) e insistette affinché fosse reintrodotto e accresciuto il "mensuale"
(tassa abrogata nel 1545). Come in Sicilia, però, non riuscì a finanziare stabilmente l'Erario: per pagare le truppe prese più volte
somme in prestito a Genova e impose prelievi forzosi al ceto dei notabili, mettendo in vendita censi e redditi della Camera milanese.
Si distinse, nondimeno, per iniziative prestigiose, soprattutto urbanistiche: a Milano commissionò l'ampliamento e il restauro del
palazzo ducale, avviò la risistemazione dell'area monumentale del duomo, dotò la città di un ampio circuito di mura bastionate.
Cospicui lavori interessarono anche le strutture difensive di Cremona, Alessandria, Novara, Lodi, Pavia sotto la sovrintendenza
dell'ingegnere G.M. Olgiati, mentre l'architetto personale del G., D. Giunti, progettò la risistemazione della Gualtiera, villa suburbana
acquistata nel 1547 (l'attuale villa Simonetta).
Il G. condusse altresì una politica estera di respiro molto ampio. Progettò di conquistare Bellinzona e di porre Chiavenna e la
Valtellina sotto il controllo imperiale, prospettando a Carlo V, a partire dal 1547, diverse ipotesi a riguardo. Verificò quindi le
possibilità di sottrarre a Venezia le più prossime città della Terraferma (Brescia, Crema, Bergamo): solo un espresso intervento
dell'imperatore lo obbligò alla massima prudenza nei rapporti con la Serenissima. Egli comunque non si limitò a immaginare azioni
sulle tradizionali linee di espansione dello Stato di Milano; proponendosi, più in generale, la tutela degli interessi asburgici nell'Italia
settentrionale, raccomandò all'imperatore di rafforzare il dominio su Genova e (contro Andrea Doria) sostenne la necessità di
costruirvi una fortezza in cui insediare un presidio militare permanente; quindi si ingerì nel confuso stato della Repubblica dopo la
congiura dei Fieschi (gennaio 1547), da lui presagita, impadronendosi di gran parte dei domini della famiglia ribelle e occupando
Pontremoli e la Val di Taro. Infine affrontò con decisione la questione del marchesato di Massa e Carrara, preteso da Giulio Cibo
Malaspina, che aveva occupato le due città nell'ottobre 1546. Il G. dapprima sequestrò lo Stato conteso in attesa che si pronunciasse
Carlo V; poi, quando si scoprì che il Cibo preparava, con l'aiuto francese, un colpo di Stato a Genova, lo fece arrestare a Pontremoli
(gennaio 1548), lo tradusse a Milano e lo condannò a morte.
Ancora più pesante e determinato parve l'intervento nella questione di Piacenza e di Parma, sfuggite nel 1512 al dominio degli Sforza
ed entrate nello Stato della Chiesa. L'eventualità che le due città potessero cadere sotto influenza francese teneva in scacco la
sicurezza del Milanese. Per questo, negli anni Trenta del Cinquecento, tanto Francesco II Sforza quanto gli stati maggiori imperiali
avevano sentito l'esigenza di recuperarne il dominio. Per gli stessi motivi, quando nell'agosto 1545 Paolo III aveva costituito Piacenza
e Parma in Ducati e le aveva infeudate al figlio Pier Luigi Farnese, Carlo V aveva disapprovato la spregiudicata mossa dando al G.,
dopo il suo insediamento al governo di Milano, disposizioni di preparare un colpo di mano da effettuare dopo la morte di Paolo III. Il
G. fu esecutore sollecito, anche perché sul piano personale avversava il Farnese. Condivideva, infatti, sulla rapida fortuna dei Farnese,
il severo giudizio dei casati regnanti italiani e aveva mal tollerato resistenze e opposizioni del duca alle sue ambizioni di acquistare un
feudo nel Parmigiano (Poviglio prima, poi Soragna). L'ostilità del G. era però anche nutrita da fatti politici: era già stata deplorata
l'assistenza del Farnese ai movimenti delle truppe francesi nella campagna del 1544, e allarme ancora maggiore destarono, nel 1547,
le voci d'un suo accordo con il re di Francia e del coinvolgimento nella congiura dei Fieschi a Genova. Inoltre, Pier Luigi perseguiva
una politica di compressione della nobiltà feudale che aveva colpito anche alcuni sudditi milanesi. In questo clima, si erano verificati
persino incidenti di confine tra Piacenza e Cremona. Il G. riteneva dunque indispensabile affrettare i tempi per liberarsi del duca di
Piacenza e verificò presso l'imperatore l'opportunità di agire "vivente il papa […] con dar nome dapoi che fosse fatto […] senza
ordine" (a Carlo V del 1° febbr. 1547, in Capasso, 1923-24, II, p. 599 n. 2). Gli sembrava che Farnese, prevedendo il delicato
momento alla morte del padre, si sarebbe allora difeso più efficacemente, mentre al presente appariva ancora piuttosto tranquillo.
Ottenuto l'assenso di Carlo V per un'iniziativa (alla condizione che il Farnese non fosse ucciso), nell'aprile 1547 avviò contatti con
nobili piacentini affinché ordissero una congiura contro il duca.
Si ebbero, nel contempo, le prime manifestazioni di ostilità: dopo concentramenti di truppe da entrambe le parti, il Farnese, alla fine di
maggio 1547, fece iniziare i lavori per una nuova fortezza a Piacenza. Quindi, nella tarda estate successiva, maturò la congiura: attesa
la partenza da Piacenza di Ottavio Farnese, genero dell'imperatore, il 10 sett. 1547 i congiurati (G. Anguissola, A. Landi e G.L.
Confalonieri) uccisero il duca. Ne scaturì un tumulto, in un primo momento favorevole ai Farnese. Poi il piano procedette secondo
quanto concordato con il G.: il Consiglio generale piacentino, paventando un'invasione francese, gli inviò messi per trattare delle sorti
della città, dove entrarono truppe imperiali; il G. stesso giunse a Piacenza il 12 sett. 1547 e subito concluse patti con i rappresentanti
locali, perché accettassero la sovranità imperiale. Il piano non ebbe però piena riuscita: era stato occupato solo il territorio fino al Taro
(meno Roccabianca e Fontanellato) e O. Farnese era riuscito a entrare in Parma già il 16 settembre. Efficaci, invece, le risposte
previste dal G. alla reazione della diplomazia pontificia: quando il nunzio presso Carlo V, F. Sfondrato, chiese conto dell'occupazione
di Piacenza, gli fu mostrata una sua lettera all'imperatore datata 10 sett. 1547, in cui definiva l'evento "impensato et inaspettato"
(Nuntiaturberichte aus Deutschland, p. 113 n. 3). Il G. non riuscì, però, con questi mezzi ad allontanare i sospetti: a Roma si seppe
presto che egli aveva fatto preparativi militari il giorno prima dell'uccisione del duca di Piacenza e fu denunciata la sua avanzata nel
Parmigiano, condotta "con ogni modo di guerra scoperta in pigliar et dimandare altri castelli" (il card. A. Farnese al card. F.
Sfondrato, Roma, 13 ott. 1547: ibid., p. 143). Il G. si mostrò vieppiù deciso: già nel novembre 1547 trasmise alla corte imperiale un
progetto per iniziare la guerra contro la Francia e lo Stato della Chiesa, quindi prese contatti anche in Parma con i nobili della fazione
"ghibellina", preparandosi a recuperare la città alla morte di Paolo III. Parma però, soprattutto dopo l'arrivo del generale Camillo
Orsini (febbraio 1548), appariva sotto il saldo controllo del pontefice.
In questo contesto, il G. elaborò piani per consolidare il dominio imperiale sull'Italia. In particolare, riteneva opportuno rinnovare
l'alternativa sui Paesi Bassi, cedendoli ai Savoia (per mezzo di nozze tra Maria d'Asburgo e il principe Emanuele Filiberto); in cambio
Carlo V avrebbe subito preso in consegna le fortezze del Piemonte e l'intero Stato dopo la morte di Emanuele Filiberto. Se poi
l'imperatore, assicuratosi di Genova, si fosse impadronito anche di Siena, Lucca e Piombino, sarebbe giunto a controllare il Ducato
fiorentino e lo Stato della Chiesa. Si trattava di un disegno coerente, che tendeva a imporre all'eterogeneo sistema dei domini
imperiali, legati solo nella persona del sovrano, una nuova fisionomia. Il G. premeva, infatti, affinché Carlo V, pacificata in qualche
modo la Germania e abbandonati i teatri di conflitto europei, eleggesse la "Monarquía" spagnola a centro dei propri interessi politici,
puntando alla formazione di un vasto Stato, padrone (una volta radicato e ampliato il dominio sul nord Africa) di tutto il Mediterraneo
occidentale. Tuttavia nei Consigli imperiali simili disegni non potevano trovare consenso. Concordava solo il duca d'Alba (F. Álvarez
de Toledo), che rammentò le proposte del G. di abbandonare i Paesi Bassi durante la prima fase della rivolta fiamminga. Il Granvelle,
invece, invitò esplicitamente il G. a non insistere su questa ipotesi. L'isolamento del G. in questioni più ampie limitò la sua azione
all'Italia. Per risolvere definitivamente la questione dei Ducati di Parma e Piacenza, nell'aprile 1547 e nel novembre 1549 propose di
offrire ai Farnese uno scambio con Siena ed elaborò piani per impadronirsi dei Cantoni svizzeri confinanti con lo Stato di Milano, non
esitando (nel 1550) a premere su P.P. Vergerio, passato Oltralpe, perché favorisse il disegno.
Dovette però concentrarsi su problemi di governo: l'Erario milanese era in condizioni assai difficili per le enormi spese della
spedizione di Piacenza, del mantenimento d'un presidio nella città emiliana e del rafforzamento delle difese ai confini. All'inizio del
1550, per un forte decremento delle entrate ordinarie, il G. poté far fronte al fabbisogno solo con prestiti garantiti dalle entrate
tributarie future; nel 1551 il debito toccò la cifra esorbitante di 750.000 scudi. In questo dissesto finanziario emersero nuovi impegni
militari, perché la questione di Parma dominava ancora lo scenario italiano. Giulio III, succeduto a Paolo III, aveva confermato uno
degli ultimi atti di papa Farnese, la restituzione della città a Ottavio Farnese, che pareva incline a porsi sotto la protezione del re di
Francia. Papa Del Monte avversava con decisione tale esito ma, non intendendo riaccendere un conflitto in Italia al momento della
riapertura del concilio di Trento, premeva sul Farnese alternando misure rigide a proposte di accordo. Il G., invece, riteneva
necessario un intervento militare, poiché il Ducato emiliano costituiva una minaccia per lo Stato di Milano e per gli altri domini
asburgici in Italia: così, già nell'aprile 1551, sollecitò l'imperatore e il papa a stringere la città d'assedio, devastandone i dintorni e
impedendone il vettovagliamento. La proposta non fu accolta: Giulio III non si risolveva alla guerra e Carlo V intendeva procedere
solo in aiuto alle armi pontificie, per non violare la pace di Crépy. In questo quadro, il G. prese l'iniziativa di impadronirsi di
Brescello, feudo imperiale in territorio estense, per controllare gli accessi dal Po a Parma. Da parte francese, poiché quel centro era
tenuto dal card. Ippolito d'Este, schierato con i Valois, la mossa fu considerata una rottura della pace e il clima si deteriorò
rapidamente: a fine maggio 1551 O. Farnese, che aveva stretto una formale alleanza con Enrico II e accettato aiuti militari francesi,
venne dichiarato decaduto dal feudo; il pontefice, allora, senza abbandonare le vie di accordo, affrettò i preparativi militari e, all'inizio
del giugno 1551, nominato il G. capitano generale di Santa Chiesa, diede inizio alla guerra ordinando di muovere contro Castro (feudo
farnesiano nel Lazio) e Parma.
Il G. passò il Taro e, occupato il castello di Noceto, il 17 giugno 1551 si unì all'esercito pontificio comandato da G.B. Del Monte,
nipote del papa. Devastate le campagne intorno a Parma assediò Colorno, che riuscì a prendere agli inizi di luglio, ma le scorrerie nel
Bolognese di un grosso contingente al comando di P. Strozzi lo distolsero dall'obiettivo più ambizioso, l'assedio di Mirandola, dove si
concentravano i rinforzi francesi. Il pontefice, sostenuto finanziariamente solo in parte da Carlo V e timoroso delle conseguenze della
rottura delle relazioni diplomatiche con la Francia, volle presto disimpegnarsi dal conflitto e la campagna dell'estate del 1551 rimase
infruttuosa. Affidato l'assedio di Mirandola a G.B. Del Monte, il G. continuò la sistematica distruzione dei raccolti intorno a Parma,
intenzionato a rimandare all'anno seguente le azioni decisive. L'irruzione dei Francesi in Piemonte, all'inizio del settembre 1551, lo
obbligò ad accorrere su quel teatro: affidato l'assedio di Parma a G.G. Medici, marchese di Marignano, partì per Asti con un
contingente di fanti tedeschi.
Ch. de Cossé, signore di Brissac, aveva conquistato Chieri e San Damiano; le sue truppe scorrevano l'Astigiano e il Monferrato, ma il
G. riteneva che il suo vero obiettivo fosse soccorrere il Farnese assediato in Parma. Così egli propose il mero contenimento
dell'avanzata nemica e, riconquistata Chiusano, si limitò a far presidiare le vie d'accesso all'Emilia attraverso l'Adda e il Ticino.
Accampatosi tra Casale e Vercelli, non mostrò intenzione di accettare uno scontro campale con truppe inferiori di numero, esauste e
pagate in modo solo sporadico. Il G. temeva, altresì, che Giulio III fosse vicino all'accordo con i Francesi e stimolava l'imperatore a
concentrare le forze contro Parma. Tuttavia lasciò cadere l'ordine di Carlo V (fine ottobre del 1551) di tornare sul teatro di guerra
emiliano, convinto che fosse prioritario bloccare l'avanzata francese. La tregua fra Giulio III e Ottavio Farnese, conclusa nell'aprile
1552 dopo la morte sul campo di G.B. Del Monte, e la nuova, risoluta offensiva in Germania dei principi ribelli a Carlo V, mutarono
gli scenari. Subito il G. si disse pronto a guidare l'assedio di Mirandola, assoldando per l'imperatore le truppe pontificie. Queste,
invece, lasciati i posti prima dell'arrivo degli Imperiali, permisero l'approvvigionamento della fortezza e passarono anzi, in gran
numero, con i Francesi. Così, richiesto da Carlo V di un parere, il G., conoscendo gli impegni militari dell'imperatore, consigliò di
aderire alla tregua per concentrare gli sforzi in Piemonte. Tuttavia Carlo V, che combatteva contro Enrico II nelle Fiandre e in Lorena
e, in Germania, contro Maurizio di Sassonia e i principi tedeschi ribelli, non poteva raccogliere la richiesta del G. di privilegiare il
teatro italiano: così l'imperatore (ormai favorevole alla pace) non solo ratificò la tregua promossa da Giulio III (10 maggio 1552) ma
richiamò le truppe impegnate sotto Parma, ordinando al G. di tenersi sulla difensiva in Piemonte.
Questi, invece, con le sole sue forze, aveva intrapreso una decisa avanzata, occupando parte del territorio del marchesato di Saluzzo,
dal 1549 annesso al Regno di Francia. Si fermò solo dopo aver constatato di non avere truppe sufficienti per riprendere Savigliano,
centro strategico per il controllo del Piemonte meridionale, o per impedire i movimenti dei Francesi, che a metà giugno si
impadronirono di Verrua. Nuovamente esortato a porsi sulla difensiva, per salvaguardare la linea di comunicazioni tra la Penisola e i
domini imperiali Oltralpe, il G. si ritirò ad Asti, disponendo presidi nei centri più importanti; quindi, malato, rientrò in Milano.
Tentò di nuovo, senza esito, di convincere l'imperatore della priorità del teatro di guerra italiano, consigliandolo (luglio 1552) di
accordarsi con i principi tedeschi ribelli per concentrarsi contro Enrico II. Quando poi, nella tarda estate, i Francesi ripresero
l'iniziativa (conquistando Busca, entrando nel marchesato di Saluzzo e assediando Volpiano), il G., alle prese con gravi disordini
nell'esercito, non poté impedire la caduta di Ceva. Subito concentrò gli sforzi per riacquistare questo centro, che apriva la strada verso
Genova e Milano, e ne ebbe ragione alla fine dell'ottobre 1552. Nello stesso autunno conseguì nuovi successi a difesa di Ivrea,
Volpiano e Asti, ma una rapida azione francese contro Alba lo colse impreparato, mentre il sopraggiungere d'un inverno
particolarmente rigido lo costrinse ad acquartierarsi.
Nella prima metà del 1553 il teatro di operazione furono le Langhe: caduta di nuovo Ceva (con Cortemilia), si trovavano esposte la
Riviera ligure e la stessa Cuneo, ma il G. constatò di non avere forze, approvvigionamenti, mezzi finanziari per tentare un'offensiva.
Così, dopo reiterate richieste di sussidi indirizzate alla corte imperiale - che non potevano trovare ascolto, essendo l'imperatore
massicciamente impegnato -, percorse vie per giungere a una tregua. Dei negoziati erano stati avviati nell'agosto 1553 per lo scambio
di prigionieri; tuttavia solo dopo che i due eserciti si erano trovati vicini alla battaglia campale (presso Buttigliera d'Asti) il G. parve
impegnarsi più a fondo. Accettata una breve sospensione, incontrò (tra agosto e settembre 1553) il generale francese Brissac,
dichiarandosi disponibile alla pace nel caso gli fossero restituite le conquiste del 1552-53. L'eventualità non soddisfaceva l'imperatore,
perché la chiusura del fronte italiano avrebbe rafforzato i Francesi sugli altri teatri di guerra. Così, a metà settembre 1553, Carlo V
sconfessò la sospensione, concedendo solo facoltà di prolungarla. Il G. tentò di difendere la propria decisione ma, dopo una proroga,
riprese la guerra: all'inizio del novembre 1553 occupò Valfenera, presso Villanova d'Asti, ma i Francesi riuscirono a compiere una
scorreria in Vercelli. L'occupazione della città durò solo pochi giorni, ma esacerbò i malumori nella corte imperiale.
Sopraggiunsero accuse al G. di malgoverno del Milanese. Carlo V si era disposto a ordinare un'ispezione sin dal 1552, dopo che una
prima, sommaria inchiesta aveva rivelato episodi di corruzione e malversazioni. Il G. si era difeso inviando un proprio emissario, il
cap. F. Gazino, a corte nel gennaio 1553, ma non aveva potuto impedire che nell'autunno successivo J. de Luna, castellano di Milano,
G.F. Taverna, gran cancelliere, e F. de Ibarra, tesoriere dell'esercito, presentassero esposti contro il suo operato. Così, a fine gennaio
1554, col pretesto di trattare della guerra di Fiandra, il G. fu chiamato alla corte, dove giunse il 17 aprile. Tra i numerosi capi d'accusa,
furono provati casi di corruzione nell'assegnazione di magistrature e uffici amministrativi dello Stato milanese, frequenti
malversazioni, tangenti imposte al commercio col Piemonte e la Francia. Non si trattava di delitti in grado di intaccare autorevolezza e
prestigio del G., che di continuo era ricorso a denaro proprio per far fronte alle spese di guerra, vantando così circa 70.000 scudi di
credito nei confronti dell'Erario. Il rovescio delle sue fortune era di colore eminentemente politico: oltre agli insuccessi della guerra
con i Francesi in Piemonte e alla tregua dell'agosto 1553, egli scontava l'avversione di Emanuele Filiberto, duca di Savoia, giovane
comandante militare in vista nella corte imperiale, e l'inclinazione del principe Filippo d'Austria - investito del Ducato di Milano e
della reggenza di Spagna - a insediare al governo dei domini italiani il fedele duca d'Alba, suo oppositore personale.
Il G. si concentrò nella difesa del suo operato come generale; avvalendosi di una memoria stesa da un suo segretario, G. Gosellini
(Compendio storico della guerra di Parma e del Piemonte. 1548-1553), ribadì di aver sostenuto le ultime campagne senza
finanziamenti adeguati, scontando il minore interesse dell'imperatore per il teatro di guerra italiano. Proprio l'esito sfavorevole della
campagna militare nelle Fiandre dell'estate 1554 provocò, a fine luglio, il suo rientro in servizio attivo, ma solo con limitati incarichi
di comando, mentre la guida dell'esercito imperiale rimaneva nelle mani di Emanuele Filiberto. Terminate le operazioni militari per
spossatezza dei contendenti, il G. cercò di ottenere l'appoggio del principe Filippo, sposato alla regina d'Inghilterra Maria Tudor, alla
propria causa e, nell'ottobre 1554, inviò propri emissari in Inghilterra. Incontrò egli stesso Filippo, poco più tardi, ma senza risultati.
Nel gennaio 1555 il duca d'Alba fu deputato a capo di tutti i governi d'Italia, compreso il Ducato di Milano. Caduto ammalato, il G. si
dispose a tornare in Italia senza alcun incarico.
L'imperatore, tuttavia, non era intenzionato a interrompere bruscamente un rapporto di servizio che durava da tre decenni, soprattutto
per il rischio che il G. o suo fratello, il cardinale Ercole (impegnati dal 1540 nella reggenza dello Stato mantovano), passassero nella
rete di alleanze francesi. Sentenziò quindi l'innocenza del G., gli promise adeguate riparazioni finanziarie e gli fece altresì offrire il
titolo di maggiordomo del figlio Filippo o di presidente di uno dei più importanti consigli imperiali (il Consiglio di guerra o quello di
Stato). Il G. tuttavia non accettò: preso congedo dall'imperatore all'inizio dell'aprile 1555, tornò in Italia, prendendo dimora in
Mantova e non in Guastalla, che aveva acquistato dagli eredi di casa Torelli nel giugno 1539 e che, dichiarata alle dirette dipendenze
di Carlo V, gli era stata infeudata il 6 sett. 1541. Rifiutata, nel 1556, una proposta di passare al servizio dei Veneziani, rientrò al
servizio degli Asburgo nel 1557, nella guerra mossa da Paolo IV a Filippo II, operando a Napoli come consigliere militare. Fu poi
nelle Fiandre, partecipando alla preparazione della campagna culminata con la battaglia di San Quintino (10 ag. 1557). Ammalatosi,
tornò a Bruxelles, dove morì il 16 nov. 1557. Fu sepolto a Mantova, nella sacrestia del duomo.
Dei figli, Cesare gli succedette nel titolo di Guastalla, mentre Francesco e Giovanni Vincenzo furono avviati alla carriera
ecclesiastica, giungendo entrambi al cardinalato (nel 1561 e nel 1578); la primogenita Isabella, sposa a Fabrizio Colonna, mostrò
spiccati interessi culturali. Questi non furono altrettanto solidi nel G., il cui ruolo di committente fu per lo più legato a compiti di
rappresentanza. Quanto alle arti figurative, ebbe contatti con Tiziano, conosciuto in gioventù (è stata proposta una sua identificazione
nel Ritratto di giovane con il guanto e nel Ritratto di giovane in armatura) e nel 1534 gli richiese "due quadri da camera di pittura […]
quali vorria mandar a donare in Spagna" (Brown - Delmarcel, p. 56). Ancora come dono a F. de los Cobos, segretario di Carlo V, il G.
commissionò a Sebastiano dal Piombo una Pietà. Appariva, d'altro canto, inclinato alle arazzerie di Bruxelles tratte da cartoni italiani
o fiamminghi: possedeva la prima edizione (perduta) dei Fructus belli, da disegni di Giulio Romano o della sua scuola, i Giochi di
putti (ora nella raccolta Marzotto a Trissino), le Storie di Mosè (ora a Châteaudun), una serie (di 14 soggetti) con le Storie di Enea.
Interessato alla numismatica, tenne rapporti con lo scultore e medaglista L. Leoni.
Le speranze suscitate fra i letterati dalla sua nomina a governatore di Milano furono appagate solo in parte. Ebbe i maggiori contatti
con L. Contile e P. Giovio, che consultò anche per i progetti di risistemazione della Gualtiera, ma non corrispose alle attese di chi gli
aveva indirizzato componimenti (come, fra gli altri, P. Aretino e G.G. Trissino). Mostrò piuttosto gusto per le arti teatrali e la musica,
prendendo ai suoi stipendi R. de Lassus (Orlando di Lasso) e chiamando a Milano il madrigalista Hoste da Reggio.
Fonti e Bibl.: M. Sanuto, I diarii, Venezia 1879-1903, XL, XLII-XLVI, XLVIII-LVIII, ad indices; G. Gosellini, Congiura di Piacenza
contro Pier Luigi Farnese, Firenze 1864; Id., Compendio storico della guerra di Parma e del Piemonte. 1548-1553, a cura di A. Ceruti,
in Miscellanea di storia italiana, s. 2, XVII (1878), pp. 103-357; Nuntiaturberichte aus Deutschland, s. 1, X, Legation des Kardinals
Sfondrato, 1547-48, a cura di W. Friedensburg, Berlin 1907, ad ind.; Registri di lettere di Ferrante Gonzaga, viceré di Sicilia, a cura di
E. Costa, Parma 1889; Relazione delle cose di Sicilia fatta da don Ferrante Gonzaga all'imperatore Carlo V (1546), a cura di F.C.
Carreri, Palermo 1896; Relazione di don Ferrante Gonzaga governatore di Milano inviata all'imperatore Carlo V nel 1552 in difesa
della progettata cinta dei bastioni, a cura di L. Beltrami, Milano 1897; P. Giovio, Lettere, a cura di G.G. Ferrero, I-II, Roma 1958, ad
ind.; F. Guicciardini, Storia d'Italia, a cura di S. Seidel Menchi, Torino 1971, ad ind.; A. Ulloa, Vita del valorosissimo e gran capitano
don F. G., Venetia 1563; G. Gosellini, Vita del prencipe don F. G., Milano 1574; I. Affò, Istoria della città e del Ducato di Guastalla,
I-IV, Guastalla 1785-97, passim; F. Capasso, Don F. G. all'impresa di Puglia del 1529, in Riv. stor. italiana, XII (1895), pp. 419-449;
A. Segre, Un episodio della lotta tra Francia e Spagna a mezzo il Cinquecento. Carlo duca di Savoia e le sue discordie con F. G., in
Arch. stor. lombardo, s. 3, XIII (1900), pp. 357-384; Id., Il richiamo di don F. G. dal governo di Milano e sue conseguenze (15531555), in Memorie della R. Accademia delle scienze di Torino, s. 2, LIV (1904), pp. 185-257; G. Capasso, Il governo di F. G. in
Sicilia dal 1535 al 1543, in Arch. stor. siciliano, XXX (1905), pp. 405-470; XXXI (1906), pp. 1-112, 337-461; Id., Paolo III, I-II,
Messina 1923-24, passim; Id., Barbarossa e Carlo V, in Riv. stor. italiana, s. 4, II (1932), pp. 181-186, 192 s., 195, 197, 201-207, 307,
310, 312-314, 322-332; F. Chabod, Storia di Milano nell'epoca di Carlo V, Torino 1961, ad ind.; Id., Usi e abusi nello Stato di Milano
a mezzo il '500, in Istituzioni e società nella storia d'Italia, a cura di E. Fasano Guarini, III, Potere e società negli Stati regionali
italiani fra '500 e '600, Bologna 1978, pp. 99-131; F. Chabod, Carlo V e il suo Impero, Torino 1985, ad ind.; Il tempo dei Gonzaga,
Guastalla 1985, ad ind.; Grandi artisti in una piccola corte dei Gonzaga, Guastalla 1990, ad ind.; R. Tamalio, F. G. alla corte spagnola
di Carlo V nel carteggio privato con Mantova, 1523-1526. La formazione da cortegiano di un generale dell'Impero, Mantova 1991; N.
Forti Grazzini, Un contesto per l'arazzo con "Enea davanti a Didone" delle Civiche raccolte d'arte applicata, in Rassegna di studi e
notizie, 1993, n. 17, pp. 99-146; C. Mozzarelli, Patrizi e governatori nello Stato di Milano a mezzo il Cinquecento. Il caso di F. G., in
Cheiron, IX (1992), pp. 119-134; M.J. Rodríguez Salgado, Metamorfosi di un Impero. La politica asburgica da Carlo V a Filippo II
(1551-1559), Milano 1994, ad ind.; C.M. Brown - G. Delmarcel - A.M. Lorenzoni, Tapestries for the courts of Federico II, Ercole,
and F. G., Seattle-London 1996; La corte di Mantova nell'età di Andrea Mantegna, 1450-1550. Atti del Convegno, a cura di C.
Mozzarelli - R. Oresko - L. Ventura, Roma 1997, ad ind.; R. Tamalio, La memoria dei Gonzaga, repertorio bibliografico
gonzaghesco, 1473-1999, Firenze 1999, ad indicem.
Ricostruito il volto di Ferrante Gonzaga
http://gazzettadimodena.gelocal.it/provincia/2008/02/17/news/ricostruito-il-volto-di-ferrante-gonzaga-1424377
GUASTALLA. Palazzo dell’Accademia Nazionale Virgiliana, a Mantova. Sala Ovale con il pubblico numericamente delle grandi
occasioni: alle 19.15 il presidente Giorgio Bernardi Perini ha tolto i teli che lo avevano tenuto nascosto fino a quel momento e
Ferrante Gonzaga è apparso, dal collo in su, come lo ha potuto ricostruire Gabriele Mallegni. Adesso può rappresentare la base, il
termine di confronto con i ritratti pittorici o con il “Frantón”, la statua di Leone Leoni che si trova in piazza, a Guastalla, dove il figlio
di Isabella d’Este e Francesco II Gonzaga fu principe.Il volto di Ferrante, infatti, è stato ricostruito sulla base delle analisi scientifiche
eseguite sulle sue spoglie mortali. A esporre i risultati della ricerca, svolta in occasione del V centenario della nascita (1507-2007),
dopo l’introduzione di Giorgio Bernardi Perini, sono stati lo storico dell’arte Paolo Bertelli, coordinatore dell’o perazione (Università
di Verona), monisgnor Giancarlo Manzoli (delegato vescovile per i Beni Culturali della Diocesi di Mantova), Francesco Mallegni,
paleoantropologo dell’Universià di Pisa e Loredana Olivato, Ordinaria di Storia dell’Arte dell’Università di Verona. Hanno
partecipato anche le paleoantropologhe Barbara Lippi ed Elena Bedini, la storica dell’arte Paola Artoni (Università di Verona).
Fiorello Tagliavini, responsabile dell’ufficio Cultura del Comune di Guastalla, ha spiegato al pubblico il significato dell’i niziativa per
la nostra città, ricordando un anno di celebrazioni appena concluse nel segno dei Gonzaga.Dopo la presentazione, è stato svelato il
volto di Ferrante, realizzato dallo scultore Gabriele Mallegni sulla base dei dati antropometrici forniti dalla tac eseguita all’ospedale di
Mantova.Riaperta dopo 450 anni la tomba di Ferrante Gonzaga (1507-1557) primo cavaliere italiano che ottenne il Toson d’Oro
dall’imperatore Carlo V, la ricognizione ha riservato sorprese e curiosità. Il metodo di conservazione e trasporto del corpo sono
risultati singolari: il corpo era avvolto in un telo di lino e la cassa toracica era piena di rosmarino. Ma l’analisi dei resti ha fornito una
quantità di dati importantissimi per la comprensione dello stile di vita e degli accadimenti che hanno caratterizzato l’e sistenza di
Ferrante.
17 febbraio 2008
Maramaldo, Fabrizio
(ca 1494 - 1552)
Dizionario Biografico degli Italiani
MARAMALDO, Fabrizio. - Nacque a Napoli da una famiglia nobile appartenente al seggio di Nido, primogenito di Francesco,
signore di Lusciano, e di Francesca Aiossa. La data esatta della nascita è sconosciuta ma, considerando la sua carriera militare, assai
probabilmente essa fu di pochi anni antecedente al 1500.
Per quanto non verificabile, la data del 28 ott. 1494, citata in una laconica e anonima biografia del M. (Firenze, Biblioteca nazionale,
Mss. II.IV.382, c. 203r), non dovrebbe essere comunque troppo lontana dalla realtà.
Quasi nulla si sa degli anni giovanili a Napoli. Egli ricevette senz'altro una educazione all'altezza delle sue origini nobiliari, come
dimostra anche la sua capacità di muoversi a proprio agio nelle principali corti dell'epoca, e crebbe come leale suddito prima di
Ferdinando il Cattolico e poi di Carlo V d'Asburgo. Con ogni probabilità, iniziò la sua carriera militare come esule, dopo aver ucciso
nei primi mesi del 1522 la prima moglie "sforzato dal honor suo" (Arch. di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, copialettere, 2965,
25, c. 67r).
Le cause e le circostanze di tale delitto d'onore rimangono ignote, come pure il nome della moglie. Bandito dal Regno, si rifugiò
presso Ferdinando Francesco d'Avalos, marchese di Pescara, uno dei comandanti dell'esercito imperiale che nel 1521 aveva invaso il
Ducato di Milano, allora in mano francese. La scelta del M. non fu certo casuale: anche i d'Avalos appartenevano al seggio di Nido, e
la protezione prima di Ferdinando Francesco e poi di suo cugino Alfonso, marchese del Vasto, fu di fondamentale importanza per la
sua carriera militare.
In Lombardia, il marchese di Pescara abbandonò momentaneamente il campo imperiale a causa dei contrasti con il capitano generale
Prospero Colonna. Alla ricerca di un nuovo protettore, il M. entrò al servizio di Federico II Gonzaga, marchese di Mantova e capitano
generale della Chiesa, all'epoca alleata dell'Impero contro la Francia. Il M. servì bene i Gonzaga, che si adoperarono presso la corte
spagnola perché gli fosse mitigato, se non revocato, il bando dal Regno di Napoli. Il nome del M. acquistò una certa notorietà quando,
il 3 ag. 1523, egli uccise in duello il nobile napoletano Giovanni Tommaso Carafa, conte di Cerreto e famoso spadaccino che, durante
un banchetto a Milano, aveva pubblicamente denigrato il suo lignaggio. Nel corso della campagna del 1523-24 contro i Francesi in
Lombardia partecipò alla difesa di Lodi e poi a quella di Cremona, e alla conclusione delle operazioni si trovava al comando di 1000
fanti, "prestati" dal marchese di Mantova alla Serenissima. Nel maggio 1524 il M. lasciò il servizio di Federico Gonzaga e tornò a
quello dell'imperatore, seguendo il marchese di Pescara durante l'invasione della Provenza e combattendo a Pavia (24 febbr. 1525),
dove le fanterie italo-spagnole di Ferdinando Francesco e Alfonso d'Avalos dettero un contributo determinante alla disfatta
dell'esercito francese. Poco prima di morire (3 dic. 1525), Ferdinando Francesco d'Avalos conferì al M. il titolo di colonnello delle
fanterie napoletane veterane dell'esercito imperiale.
All'epoca del M. la fanteria aveva già da tempo sostituito la cavalleria come nerbo degli eserciti europei. La fanteria italiana si era
adattata al nuovo modello di fanteria tattica impostosi nel corso delle guerre d'Italia e composto da percentuali variabili di picchieri e
di tiratori, prevalentemente archibugieri. La necessità di integrare efficacemente l'azione di queste due componenti aveva portato
anche in Italia alla creazione di strutture intermedie tra la singola compagnia - fino ad allora la sottounità di base della fanteria - e la
fanteria nel suo insieme, con la costituzione di unità tattico-amministrative autonome composte di più compagnie. In questo contesto
nacque una nuova figura di imprenditore militare, denominato colonnello - termine che indicava sia l'unità sia il suo proprietariocomandante - destinato a organizzare e guidare tali strutture intermedie.
Come colonnello di fanteria il M. fu uno degli imprenditori militari italiani di maggior successo della sua generazione, riuscendo a
organizzare intorno a sé per più di un decennio la parte più solida delle fanterie italiane del Regno di Napoli, uno dei pilastri del
sistema militare asburgico in Italia. Il suo "colonnello" (reggimento) - che giunse a superare le 3000 unità - fu al tempo stesso unità di
élite, scuola militare ed espressione degli interessi politici ed economici di una parte importante della nobiltà napoletana.
Le vittorie dei generali di Carlo V e l'occupazione militare del Ducato di Milano (dicembre 1525) da parte imperiale portarono alla
formazione di un vasto fronte antiasburgico. Francia, Roma, Venezia, Firenze, Mantova e Ferrara - sostenute esternamente
dall'Inghilterra - si unirono (22 maggio 1526) nella Lega santa di Cognac, destinata a scongiurare l'affermarsi dell'egemonia asburgica
sulla penisola.
Dopo aver partecipato con alterna fortuna alla difesa del Ducato di Milano dagli attacchi delle truppe pontificie, veneziane e francesi,
nel febbraio 1527 il M. e i suoi fanti si unirono all'esercito comandato dal connestabile Carlo duca di Borbone nella sua avanzata
verso il Mezzogiorno d'Italia, partecipando al sacco di Roma, iniziato il 6 maggio 1527. Solo il 17 febbr. 1528 le truppe imperiali
lasciarono la città per spostarsi nel Meridione allo scopo di fronteggiare l'invasione del Regno di Napoli da parte di un esercito della
Lega di Cognac. Quando iniziò l'assedio di Napoli, i primi di aprile del 1528, il colonnello del M. era l'unica unità di fanteria italiana
dell'esercito imperiale: tutte le altre erano state sciolte per mancanza di denaro e, soprattutto, di fiducia.
Fu proprio per aprire una grave spaccatura nel fronte imperiale che alcuni nobili napoletani filofrancesi fecero cadere (23 giugno) in
mano imperiale alcune lettere che svelavano inesistenti trattative avviate dal M. con gli assedianti. Philibert de Châlon, principe
d'Orange, comandante in capo imperiale, avrebbe voluto sbrigativamente giustiziare il M., ma l'opposizione di gran parte della nobiltà
napoletana lo costrinse a ordinare un'accurata indagine che si concluse con la totale assoluzione dell'accusato e il reintegro al
comando del suo colonnello.
Due mesi dopo, il M. uscito da Napoli con i suoi, occupò prima Somma (8 agosto) e poi Capua (28 agosto), contribuendo in misura
rilevante alla conclusione dell'assedio e al collasso dell'esercito avversario (30 agosto). Come compenso per i suoi servigi e la sua
fedeltà, ricevette dal principe d'Orange - nuovo viceré di Napoli - il feudo di Ottaviano. Nel maggio del 1529 guidò il suo colonnello
in Puglia per unirsi alle truppe del marchese del Vasto, Alfonso d'Avalos, impegnate ad annientare le ultime sacche di resistenza dei
baroni filofrancesi e della Lega nel Regno di Napoli. Nel febbraio 1530, regolata la questione delle paghe arretrate sue e delle sue
truppe, e preso formalmente possesso del suo feudo, alla testa di 3000 fanti marciò verso la Toscana per unirsi all'esercito imperiale
che già da mesi assediava Firenze allo scopo di costringere il locale regime repubblicano - ostinatamente filofrancese - ad accettare il
ritorno dei Medici al potere.
Da metà maggio a fine giugno 1530 il M. pose l'assedio alla città di Volterra, ma la vigorosa difesa delle truppe fiorentine, guidata e
animata dal commissario Francesco Ferrucci, determinò il fallimento dell'impresa anche dopo che alle forze del M. si erano unite
quelle di Alfonso d'Avalos. Il 3 ag. 1530 il colonnello del M. fu però tra le unità imperiali che intercettarono e sconfissero, presso il
borgo di Gavinana, le residue forze fiorentine che, guidate dal Ferrucci, tentavano di raggiungere Firenze per stringere gli assedianti
tra due fuochi. A combattimento concluso, il comandante fiorentino, ferito e prigioniero, fu portato di fronte al M. che, dopo un breve
scambio di battute, lo ferì mortalmente e ordinò poi ai propri uomini di finirlo.
Lo scontro di Gavinana era stato inaspettatamente violento e sanguinoso - il principe d'Orange fu tra i caduti - e sin dal suo inizio
quella campagna era stata condotta in modo particolarmente brutale da entrambe le parti, senza rispettare molte delle convenzioni che
regolavano i conflitti armati. Nel caso specifico, la particolare animosità del M. contro il Ferrucci era alimentata dalla recente
memoria dei molti insulti personali che il commissario gli aveva rivolto durante l'assedio di Volterra - in particolare l'impiccagione di
un emissario mandato dal M. ai Priori di Volterra - e del grave smacco professionale che gli era derivato dall'essere stato obbligato a
togliere l'assedio a quella città da un funzionario "civile" e non da un militare par suo. Ben difficilmente il M., celebrato già in vita
come uno dei soldati e gentiluomini migliori e più famosi della sua epoca, avrebbe potuto immaginare che il suo illustre cognome
avrebbe indicato per antonomasia "uomo malvagio, spavaldo e prepotente soprattutto con i deboli, gli indifesi e gli sconfitti"
(Vocabolario della lingua italiana, diretto da A. Duro, III, Roma 1989, p. 75). E ancora meno avrebbe potuto immaginare che l'essere
assunto a modello di uomo vile e spregevole sarebbe derivato - fra i molti deboli, indifesi e sconfitti su cui pure si era trovato
effettivamente a infierire nel corso della propria carriera - proprio dall'uccisione di un nemico che aveva praticato la "cattiva guerra"
contro lui e i suoi, ma che secondo il suo punto di vista non aveva nessun diritto di essere trattato come un suo pari, visto che "di
mercatante s'era fatto soldato" (Nardi, p. 207). Nonostante l'ostilità degli storici fiorentini filorepubblicani, all'epoca dei fatti e per
molto tempo dopo, l'uccisione del commissario fiorentino non pesò in alcun modo sulla figura e la reputazione del condottiere
napoletano. I valori "aristocratici" di cui il M. era espressione si erano già imposti su quelli "repubblicani" difesi dal Ferrucci già
molto prima della battaglia di Gavinana.
Le cose cambiarono radicalmente al principio del XIX secolo, con l'inizio del processo di elaborazione del mito fondativo dell'identità
nazionale italiana. A quel punto fu la visione del cittadino-soldato Ferrucci, visto come l'estremo difensore della libertà della propria
patria a prendere il sopravvento su quella del M., un "mercenario" (termine che all'epoca dell'apoteosi degli eserciti nazionali, fondati
sulla coscrizione obbligatoria, era considerato sinonimo di miserabile venduto allo straniero) al servizio di un oppressore degli
Italiani. In base a questa inversione di parametri, e grazie alle opere di scrittori come Francesco Domenico Guerrazzi e Massimo
d'Azeglio, ogni atto del M. precedente o successivo al 3 ag. 1530 è stato studiato e presentato come la necessaria premessa o la logica
conseguenza del "delitto" da lui commesso nelle ore che seguirono la conclusione della battaglia di Gavinana. Nella voce a lui
dedicata nell'Enciclopedia biografica e bibliografica "Italiana", ben poco viene detto della sua vita e della sua carriera, se non che egli
fu "l'uccisore di Francesco Ferrucci a Gavinana. Tutta la sua vita è concentrata, si può dire, in questo suo atto crudele, in questo inutile
scempio". Anche quegli intellettuali italiani che, con motivazioni diverse e a volte opposte - citiamo emblematicamente Vittorio
Imbriani da una parte e Antonio Gramsci dall'altra - si sono trovati a difendere o a rivalutare la figura del M., lo hanno fatto per
contrapporla a quella di Ferrucci. Questa situazione si è protratta fino al periodo successivo alla fine della seconda guerra mondiale,
quando profondi mutamenti negli orientamenti, nelle metodologie e negli obiettivi della ricerca storica italiana hanno fatto scivolare
entrambi i personaggi in un sostanziale oblio.
Dopo la resa della Repubblica fiorentina, congedate le sue truppe, il M. tornò brevemente a Napoli, per poi recarsi nel marzo del 1531
presso la corte imperiale a Bruxelles. Qui rimase per alcuni mesi, godendo del favore di Carlo V e coltivando amicizie e contatti utili
per la prosecuzione della propria carriera. Nel 1532 il M. comandava 3000 dei più di 14.000 fanti italiani che varcarono le Alpi per
unirsi all'esercito imperiale destinato a difendere Vienna dall'imminente attacco turco. Sfumata la possibilità di affrontare l'esercito
ottomano in campo aperto, Carlo V destinò le truppe italiane alla riconquista di Buda in Ungheria, nominando il M. loro "capitano
generale". Tuttavia, il malcontento degli altri comandanti italiani, risentiti per essere stati scavalcati dal M., e quello dei soldati, già
esasperati dalle pessime condizioni di vita e dai ritardi delle paghe - nonché dall'idea di servire sotto un comandante dalla reputazione
tirannica - fecero sì che, fatta eccezione per le truppe napoletane, i fanti degli altri colonnelli si ammutinassero quasi tutti e si
mettessero in marcia alla volta dell'Italia.
Il 26 sett. 1533 il M., tornato a Napoli, sposò la nobile napoletana Porzia Cantelmo. Nel 1535 partecipò alla spedizione di Carlo V
contro Tunisi col rango di "maestro di campo generale", ufficiale incaricato di mettere in pratica le decisioni del comandante in capo,
gestendo l'acquartieramento delle truppe e il loro dispiegamento durante le marce e sul campo. Il M. ricoprì lo stesso ruolo l'anno
seguente nell'esercito comandato da Alfonso d'Avalos e destinato alla riconquista del Piemonte, invaso dai Francesi nel marzo 1536.
Per i servigi resi durante questa campagna ricevette dall'imperatore una rendita annuale e la nomina a suo gentiluomo di camera.
Rientrato in patria nel 1538 dopo l'armistizio decennale stipulato tra imperatore e re di Francia a Nizza (18 giugno 1538), non
partecipò attivamente a nessuna altra impresa militare.
Quella conclusiva è una delle fasi meno conosciute e studiate della sua vita. La saggistica risorgimentale, sempre alla ricerca di prove
della debole fibra morale del M., lo ritrasse come un gaudente intento solo a sperperare le proprie sostanze e quelle della moglie in
una Napoli che sprofondava in una secolare decadenza sotto il peso dell'oppressione straniera che lui stesso aveva contribuito a
instaurare; una figura ridicola destinata a rimanere viva nella memoria del popolo in alcune filastrocche e nei panni di una maschera
della commedia dell'arte napoletana. In realtà, il M. si ritirò dal servizio attivo dopo aver raggiunto il grado più alto a cui potesse
aspirare. Ricco, ammirato dai contemporanei, celebrato da scrittori e poeti, nominato infine anche membro del Consiglio di Stato e
della Guerra del Regno di Napoli, il M. fu un personaggio influente e attivo della società napoletana in un periodo in cui questa era
scossa da una serie di profonde trasformazioni istituzionali, culturali e religiose. Arrivato in alto grazie all'appoggio dei d'Avalos,
avversari tradizionali dei Toledo, nel 1536 egli fu tra i baroni che chiesero, senza successo, all'imperatore di rimuovere il viceré di
Napoli don Pedro de Toledo dal suo incarico, e che nel 1547 cercarono di usare i gravi tumulti scoppiati a Napoli per provocarne la
destituzione.
Il M. morì a Napoli, probabilmente alla fine del 1552.
Fonti e Bibl.: Firenze, Biblioteca nazionale, II.IV.382, c. 203r; sebbene menzionato spesso dagli storici della sua epoca, per molto
tempo il M. non ha però avuto un vero biografo. Possono servire come introduzione alla sua carriera militare: B. Varchi, Storia
fiorentina, a cura di L. Arbib, II, Firenze 1844, pp. 136, 322, 421, 429, 438-441, 487, 491, 566; P. Giovio, Delle istorie del suo tempo,
II, Vinegia 1572, pp. 47, 68, 75, 194, 198-201, 209-211, 223, 259, 263; I. Nardi, Istorie della città di Firenze (1582), a cura di A.
Gelli, Firenze 1858, II, pp. 106, 176, 190, 207; G. Rosso, Historia delle cose di Napoli sotto l'imperio di Carlo quinto, cominciando
dall'anno 1526 per infino all'anno 1537, Napoli 1635, pp. 15, 23-25, 45 s., 78, 89, 129; L. Santoro, Dei successi del sacco di Roma e
guerra del Regno di Napoli sotto Lotrech, Napoli 1858, pp. 38, 117 s., 137; M. Sanuto, I diarii, Venezia 1879-1902, ad indices. Per
orientarsi nella bibliografia risorgimentale e novecentesca, risultano particolarmente utili le seguenti opere, contenenti a volte
riferimenti archivistici e appendici documentarie: F.D. Guerrazzi, Vita di Francesco Ferruccio, II, Milano 1865, pp. 213-244, 247,
302, 307-318, 321; G. De Blasiis, F. Marramaldo e i suoi antenati, in Arch. stor. per le provincie napoletane, I (1876), pp. 747-778; II
(1877), pp. 301-381; III (1878-79), pp. 315-387, 759-829; E. Alvisi, La battaglia di Gavinana, Bologna 1881 (nonostante il titolo, si
tratta di una biografia del M.); A. Luzio, F. M., nuovi documenti, Ancona 1883; C. Vassallo, Matteo Prandone, difensore d'Asti nel
1526 contro F. M., Torino 1890; G. Sforza, F. M. governatore di Pontremoli, in Arch. stor. delle provincie parmensi, IV (1895), pp.
27-53; V. Imbriani, M. e Ferrucci, in Studi letterari e bizzarrie satiriche, a cura di B. Croce, Bari 1907, pp. 308-316; G. Paladino,
Nuove notizie su F. Marramaldo, da note e appunti del De Blasiis, in Arch. stor. per le provincie napoletane, XL (1915), pp. 180-252;
A. Gramsci, Il Risorgimento, Torino 1949, pp. 9 s.; Enc. biografica e bibliografica "Italiana", C. Argegni, Condottieri, capitani,
tribuni, II, p. 198. M. Arfaioli
Fabrizio Maramaldo
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Fabrizio Maramaldo (1494 – dicembre 1552) è stato un condottiero italiano, soldato di ventura, celebre per aver ucciso il capitano
Francesco Ferrucci il 3 agosto 1530 a Gavinana, prigioniero, ferito ed inerme.
Biografia Le origini di Fabrizio Maramaldo sono controverse, originario del Regno di Napoli[1], non si conosce la sua città natale.
Anche se Jeno de' Cornonei riferisce che fosse originario di Tortora [2]. Alessandro Luzio traducendo alcune lettere dell'archivio
Gonzaga di Mantova, scoprì che Maramaldo fuggì da Napoli dopo aver trucidato la moglie e chiese protezione presso il Marchese
Federico di Mantova. Combatté al soldo dei Gonzaga e della Repubblica Veneta. In occasione dell'assedio di Asti (1526), il
condottiero subì una cocente sconfitta; dopo aver cannoneggiato la città per una settimana cercò di penetrarvi attraverso la breccia
aperta, ma gli astigiani comandati dal capitano Matteo Prandone, ricacciarono i mercenari fuori dalla cinta della città dopo un accanito
combattimento. Narra la leggenda che l'apparizione nel cielo del patrono san Secondo, mandò in rotta l'esercito di Maramaldo. Gli
astigiani, a ricordo del pericolo scampato, nel 1592, in corrispondenza della breccia aperta dal Maramaldo, eressero un tempietto
votivo denominato San Secondo in Vittoria[3] (demolito all'inizio del XIX secolo nell'ambito del riassetto urbano della città) Fu
assoldato dall'imperatore Carlo V del Sacro Romano Impero. Nel 1527, prese parte al sacco di Roma. Al soldo dell'imperatore durante
l'assedio di Firenze (1530) cercò invano di scacciare i fiorentini di Francesco Ferrucci da Volterra, poi partecipò alla battaglia di
Gavinana al comando di una delle colonne imperiali, combatté i Turchi in Ungheria ed i Francesi in Piemonte in particolare ad Asti ed
Alessandria.
L'uccisione di Francesco Ferrucci La vicenda che tristemente ha tramandato ai posteri la figura di Fabrizio Maramaldo è quella che
portò all'uccisione del capitano fiorentino Francesco Ferrucci. Maramaldo era schierato con i Medici contro l'esercito della
Repubblica Fiorentina durante l'Assedio di Firenze e desiderava vendicarsi degli scherni ricevuti dal Ferrucci, che fece anche
impiccare un messo-spia inviato dal Maramaldo, dopo averlo però precedentemente avvertito di non tornare sotto pena del capestro [4].
Ferrucci il 3 agosto 1530 uscì in campo aperto e tentò un ultimo scontro per spezzare l'assedio in quella che divenne la battaglia di
Gavinana. Il capo delle truppe imperiali Filiberto di Chalons, principe d'Orange, venne ucciso nel combattimento da due colpi di
archibugio, ma Ferrucci venne sopraffatto da forze preponderanti, rimase ferito e con i pochi superstiti si arrese, decretando la fine
della battaglia. Fabrizio Maramaldo si fece condurre il prigioniero sulla piazza di Gavinana, lo disarmò e contro tutte le regole della
cavalleria si vendicò delle offese precedenti, ferendolo a sangue freddo e lasciandolo poi trucidare dai suoi soldati [5]. Le cronache tra
loro non concordano sul tipo di ferita inferta a Ferrucci, che viene indicata alternativamente al petto, o alla gola, o al viso; tutte però
riportano che Francesco Ferrucci prima di spirare gli abbia rivolto con disprezzo le celebri parole: «Vile, tu uccidi un uomo morto!» o
più fiorentinamente «Vile, tu darai a un morto!» [4]. Dieci giorni dopo Firenze si arrese agli imperiali e dovette accettare il rientro dei
Medici. La per lui fortunata conclusione dell'assedio fu il trampolino di lancio per Maramaldo, che ormai godeva del favore di Carlo
V e di altri alti personaggi. Ma, mentre la sua fama di condottiero e le sue finanze prosperarono, la sua reputazione, già dubbia, veniva
sempre più macchiata dai resoconti degli storici e dalla voce popolare. Famoso all'epoca, che sia vero o no [6], l'episodio di Giulia,
figlia di Salvestro Aldobrandini, richiesta di un ballo ad una festa di corte, che fece al Maramaldo la seguente risposta: «Né io, né
altra donna d‘Italia che non sia del tutto svergognata, farà mai veruna cortesia all‘assassino di Ferrucci.» — Di che il rodomonte
restò mutolo e confuso, e la bella giovane da tutti manifestamente lodata. [7].
Ritiro a Napoli e morte Nel 1537, lo scontro tra la Francia e l'imperatore Carlo V di Spagna, diminuì di intensità in Piemonte. In
conflitto con altri condottieri al servizio degli spagnoli, Maramaldo cessò le sua attività di guerra e si ritirò a Napoli, rimanendo nella
considerazione dell'imperatore spagnolo che lo nominò ciambellano. Senza famiglia e figli, trascorse gli ultimi anni della sua vita,
dissipando progressivamente i suoi beni. Le cronache dell'epoca, riportano infatti i suoi frequenti litigi con il fisco. La data di morte
non è certa, ma viene collocata non oltre il 1555. Negli ultimi tempi, si legò ai frati Teatini e ad alcuni santoni, e finì per lasciare loro i
suoi residui averi, con lo scopo di donarli in opere di bene.[5]
Maramaldo di nome e di fatto Le imprese del condottiero napoletano rimasero così impresse nelle popolazioni della penisola da
trasformare il nome Maramaldo in un sostantivo che ancora oggi indica una persona che infierisce sui più deboli, gli inermi, o è
pronta a sopraffare, a tradire qualcuno non appena ne scorga i punti deboli o l'impossibilità di difendersi. Anche il verbo
"maramaldeggiare" è sinonimo dell'atto di infierire sugli inermi.
Note
1.
^ Giuseppe de Blasiis, Marammaldo ed i suoi antenati, archivio storico napoletano anni 1876-1877-1878, tratto da Carlo
Vassallo, Fabrizio Maramaldo e gli agostiniani in Asti, Torino 1889.
2. ^ Giuseppe, Guida, Amedeo Fulco, Napoli, Loffredo Editore, 1982.
3. ^ Stefano Giuseppe Incisa, Asti nelle sue chiese ed iscrizioni, Asti 1974.
4. ^ a b A. Valori, La difesa della repubblica fiorentina, Firenze, Vallecchi, 1929
5. ^ a b Deputazione napoletana di storia patria, Naples, Società napoletana di storia patria, Archivio storico per le province
napoletane, Volume 3, Detken & Rocholl e F. Giannini, 1818,
6. ^ Il Valori ne dubita, riconoscendo però che, se una simile storia venne inventata, non mancavano persone che non
rispettavano granché il Maramaldo. In La difesa della repubblica fiorentina, op. cit.
7. ^ Filippo Ugolini, "Storia dei Conti e Duchi d'Urbino", Tipografia Grazzini, Giannini e C., Firenze 1859.
Bibliografia
• Bera G., Asti edifici e palazzi nel medioevo. Gribaudo Editore Se Di Co 2004 ISBN 88-8058-886-9
• Gabiani N., Asti nei principali suoi ricordi storici vol 1, 2,3. Tip.Vinassa 1927-1934
• Grassi S., Storia della Città di Asti vol I,II. Atesa ed. 1987
• Incisa S.G., Asti nelle sue chiese ed iscrizioni C. R.A. 1974
• Vassallo C., Fabrizio Maramaldo e gli agostiniani in Asti, Torino 1889
• Vergano L., Storia di Asti Vol. 1,2,3 Tip.S.Giuseppe Asti1953, 1957
• Raviola P., "Asti, la sua storia, il suo Palio" Promo Pubblicità Edizioni 2006
Altri progetti
Wikizionario contiene voci che citano il termine «Maramaldo»
termine «Maramaldeggiare»
Wikizionario contiene voci che citano il
Giovanni dalle Bande Nere
(1498 - 1526)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Ritratto ad opera di Gian Paolo Pace
Giovanni dalle Bande Nere oppure delle Bande Nere al secolo Giovanni di Giovanni de' Medici (Forlì, 6 aprile 1498 – Mantova,
30 novembre 1526) è stato un condottiero italiano del Rinascimento.
Biografia Figlio del fiorentino Giovanni de' Medici (detto il Popolano) e di Caterina Sforza, la signora guerriera di Forlì e Imola, una
delle donne più famose del Rinascimento, che si era strenuamente difesa da Cesare Borgia nella sua rocca forlivese. Venne chiamato
Ludovico in onore dello zio Ludovico il Moro, duca di Milano, ma alla morte del padre, avvenuta quando aveva pochi mesi d'età, la
madre gli cambiò il nome in Giovanni. Fu ritenuto da Niccolò Machiavelli come l'unica figura capace di difendere i regni italiani dalla
discesa di Carlo V. Giovanni passò la propria infanzia in un convento, poiché la madre era prigioniera di Cesare Borgia. Nel 1509
Caterina Sforza morì, ed essendo morto anche Luffo Numai, primo tutore di Giovanni, la tutela del giovane passò al canonico
Francesco Fortunati e al ricchissimo fiorentino Jacopo Salviati, marito di Lucrezia de' Medici, figlia di Lorenzo il Magnifico. Jacopo
Salviati dovette spesso rimediare con la propria autorità e fama alle numerose intemperanze del ragazzo, ma nel 1511 non poté
evitargli il bando da Firenze, per l'uccisione di un suo coetaneo in una lite tra bande di ragazzi, bando ritirato l'anno successivo.
Quando il Salviati fu nominato ambasciatore a Roma nel 1513 Giovanni lo seguì, e qui fu iscritto nelle milizie pontificie grazie
all'intercessione del Salviati presso papa Leone X, fratello di Lucrezia de' Medici. Il suo battesimo del fuoco nel nuovo ruolo di
soldato papale avvenne il 5 marzo 1516 nella guerra contro Urbino al seguito di Lorenzo de' Medici. La guerra durò solo ventidue
giorni, dopo i quali Francesco Maria I della Rovere si arrese; nonostante la propria indole irrequieta, Giovanni riuscì a insegnare agli
uomini della sua compagnia - indisciplinati, rozzi e individualisti - disciplina e obbedienza. Ebbe anche modo di osservare, con acume
caratteristico, il declino della cavalleria pesante. Al momento di crearsi una propria compagnia Giovanni scelse perciò di impiegare
cavalli piccoli e leggeri, preferibilmente turchi o berberi, adatti a compiti tattici quali schermaglie d'avanguardia o imboscate;
individuò nella mobilità l'arma più utile da usare. Un accento particolare fu messo sullo spirito di corpo, allora assai carente. I nuovi
venuti ricevevano un addestramento particolare, spesso impartito da Giovanni personalmente; sovente i traditori erano condannati a
morte. Sposò Maria Salviati, figlia di Jacopo, che gli diede un figlio, Cosimo, destinato un giorno a diventare Granduca di Toscana.
Nel 1520 sconfisse diversi signorotti ribelli marchigiani, tra i quali Ludovico Uffreducci che restò ucciso in battaglia presso Falerone.
Nel 1521 Leone X si allea con l'imperatore Carlo V contro Francesco I, per consentire agli Sforza di tornare padroni di Milano e per
occupare le città perdute di Parma e Piacenza; Giovanni è assoldato e posto sotto il comando di Prospero Colonna. Partecipa in
novembre alla battaglia di Vaprio d'Adda: oltrepassa il fiume controllato dai francesi e li mette in fuga, aprendo la strada per Pavia,
Milano, Parma e Piacenza. Il 1º dicembre muore Leone X, e Giovanni per manifestare il lutto fa annerire le insegne, che fino ad allora
erano a righe bianche e viola, diventando così famoso presso i posteri come Giovanni dalle Bande Nere. Nell'agosto 1523 Giovanni
viene ingaggiato dagli imperiali, e nel gennaio del 1524 attacca di notte il campo del francese Cavalier Baiardo, mentre questi
dormiva e lo mette in fuga, facendo prigionieri oltre trecento soldati. Successivamente affronta gli Svizzeri, la più temuta fanteria
dell'epoca, che intanto sono calati dalla Valtellina in aiuto dei Francesi; Giovanni li sconfigge a Caprino Bergamasco, costringendo
l'armata francese a lasciare l'Italia. Intanto a Roma diviene papa Clemente VII, della famiglia Medici, cugino della madre di Giovanni,
Caterina; il nuovo pontefice paga tutti i debiti di Giovanni, chiedendogli, però, in cambio, di passare con i Francesi. Questo accade nel
novembre-dicembre 1524 quando Francesco I entra nuovamente in Italia per una campagna militare e ritorna in Lombardia
schierandosi sotto Pavia, dove subirà la celebre cocente sconfitta e la prigionia. La compagnia di Giovanni non partecipa alla
battaglia: in una scaramuccia il 18 febbraio 1525 Giovanni "fu da uno archibuso in uno stinco di gamba gravemente ferito" (G. G.
Rossi, Vita di Giovanni de' Medici). Spesso vengono confusi i fatti e gli "attrezzi" del febbraio 1525 con quelli del novembre 1526,
quando, effettivamente, Giovanni verrà ferito ad una coscia da un colpo di falconetto. Anche Pietro Aretino, nella famosissima e
suggestiva lettera (la n. 4 del primo libro) dà la medesima versione" "... ecco (oimè) un moschetto che gli percuote quella gamba già
ferita d'archibuso..."). Allo stesso modo, nel descrivere i momenti ed i luoghi delle cure la storiografia corrente pare non aver tenuto
più di tanto in considerazione i documenti e le testimonianze ufficiali. In effetti Giovanni viene subito trasportato a Piacenza, come
relaziona Maestro Abramo, il medico inviato dal marchese di Mantova. Ma il 7 di marzo (in M. Tabanelli, Giovanni de' Medici dalle
Bande Nere) Giovanni arriva nel parmense: "... si fece portare nel parmigiano a i castelli della sorella" (G.G. Rossi, cit.). Solo nel
mese di maggio Giovanni si recherà a Venezia, dove potrà giovarsi, nell'ultima parte della convalescenza, dei benefici bagni termali
della vicina Abano. Le sue Bande Nere in parte lo seguono, in parte si sciolgono. A Venezia Giovanni potrebbe mettersi al servizio
della Serenissima, ma è tipo troppo ribelle e declina con la frase: «Né a me si conviene per esser io troppo giovane, né ad essa perché
troppo attempata». Nel 1526 re Francesco I torna libero e in maggio, nasce la lega di Cognac contro l'Impero; papa Clemente si
schiera con il re Francesco ed a Giovanni è affidato il comando delle truppe pontificie. Il 6 luglio il capitano generale Francesco Maria
I della Rovere, di fronte alle soverchianti forze imperiali, abbandona Milano, ma Giovanni rifiuta l'ordine di fare la stessa cosa e
attacca la retroguardia del nemico alla confluenza del Mincio col Po, sconfiggendo i lanzichenecchi, mercenari tedeschi capeggiati da
Georg von Frundsberg. La sera del 25 novembre, nelle vicinanze di Governolo, Giovanni viene colpito allo stinco da un colpo di
falconetto, (probabilmente fornito da Alfonso I d'Este) che gli procura una gravissima ferita.
« ... Giovanni de' Medici co' cavalli leggieri; e accostatosi più arditamente perché non sapeva che avessino avute artiglierie,
avendo essi dato fuoco a uno de' falconetti, il secondo tiro roppe la gamba alquanto sopra al ginocchio a Giovanni de' Medici; del
quale colpo, essendo stato portato a Mantova, morí pochi dí poi,... »
( Francesco Guicciardini - Storia d'Italia, lib. 17 cap. 16)
Viene subito trasportato a San Nicolò Po ma non si trova un medico perciò è trasportato a Mantova presso il palazzo di Luigi Gonzaga
detto "Rodomonte", dove il chirurgo Abramo, che già lo aveva curato con successo due anni prima, gli amputa la gamba. Per
effettuare l'operazione il medico chiede che 10 uomini tengano fermo Giovanni. Pietro Aretino testimone oculare, descrive le sue
ultime ore in una lettera a Francesco Albizi:
« «Neanco venti» disse sorridendo Giovanni «mi terrebbero», presa la candela in mano, nel far lume a sé medesimo, io me ne
fuggii, e serratemi l'orecchie sentii due voci sole, e poi chiamarmi, e giunto a lui mi dice: «Io sono guarito», e voltandosi per tutto
ne faceva una gran festa. »
La cancrena è però inarrestabile e nel giro di pochi giorni lo porta alla morte. Il valoroso condottiero si spegne il 30 novembre 1526, e
viene sepolto tutto armato nella chiesa di San Francesco a Mantova. Giovanni, in agonia, aveva inizialmente pensato di affidare il
comando delle truppe a Lucantonio Cupano, uno dei suoi più fidi soldati o al nipote Pier Maria III Rossi di San Secondo Parmense,
figlio della sorella Bianca Riario, ma è tutto inutile: prive del loro capo e del suo carisma, le bande si sciolgono.
Sempre Pietro Aretino testimonia:
« Si mosse a ragionar meco, chiamando Lucantonio con estrema affezione; e dicendo io: «Noi manderemo per lui», «Vuoi tu»,
disse, «che un par suo lasci la guerra per veder amalati?». Si ricordò del conte di San Secondo, dicendo: «Almen fusse egli qui,
che gli restarebbe il mio luogo». »
E anche Giovan Girolamo de' Rossi, nipote di Giovanni e fratello del Conte di San Secondo, conferma:
« Esso signore le raccomandò nella morte sua al conte Pietromaria Rosso di San Secondo, suo nipote, scrivendo a papa Clemente
che non poteva darle più concenevolmente ad altri che a lui, il quale, per essere suo nipote e continovamente nutrito da lui nella
guerra, sarebbe da i suoi soldati temuto e amato più d'ogni altro. »
Le Bande Nere L’origine delle Bande Nere può farsi risalire alle compagnie che il giovane Giovanni de’Medici comandò durante la
guerra di Urbino del 1517. Questo breve conflitto fu per Giovanni una “scuola militare” nella quale egli si formò per la fase cruciale
delle guerre d'Italia, quella compresa tra il 1521 e il 1527, dove si guadagnò grande fama prima di essere mortalmente ferito a
Governolo. Durante questi anni Giovanni e le sue Bande cambiarono ripetutamente campo, passando prima al servizio di Carlo V, poi
di Francesco I, poi ancora di Carlo V e quindi nuovamente di Francesco I. Ferito alcuni giorni prima della battaglia di Pavia, Giovanni
fu portato a Piacenza per esservi curato. Le sue Bande, rimaste senza il loro capitano, nulla poterono contro la massa dei
Lanzichenecchi imperiali sortiti dalla città assediata. La guerra, ripresa con la Lega di Cognac, vide nuovamente Giovanni schierato
dalla parte del pontefice Clemente VII. Le Bande operarono come una forza distaccata dal grosso dell’esercito della Lega, guidato da
Francesco Maria della Rovere, duca d’Urbino. Il “Gran Diavolo” con i suoi cavalieri e archibugieri tormentò gli imperiali diretti a
Roma, creando loro grosse difficoltà. La sua morte rivelò la pochezza delle virtù militari del duca d'Urbino che lasciò via libera al
nemico. Le Bande Nere sopravvissero alla morte di Giovanni per quasi due anni. All’inizio del 1527 diedero ancora una volta prova
della loro efficienza difendendo Frosinone dall’esercito del Viceré di Napoli. Nell'aprile dello stesso anno Clemente VII, ansioso di
alleggerirsi delle gravose spese che il mantenimento di truppe mercenarie comportava, fidandosi dell’accordo con Carlo di Lannoy e
ingannato da Carlo di Borbone, licenziò “imprudentissimamente - scrive il Guicciardini - quasi tutti i fanti delle bande Nere”. Un
migliaio di questi, raccolti da Renzo da Ceri dopo che il pontefice ebbe finalmente realizzato che gli imperiali avrebbero investito
Roma, tentarono di difendere la città dall'assalto nemico venendo in gran parte uccisi sulle mura. Le Bande, passate al soldo di
Firenze, furono affidate ad Orazio Baglioni e parteciparono alla sciagurata spedizione guidata da Odet de Foix, visconte di Lautrec,
per la conquista del regno di Napoli. Nel corso di questa campagna ebbero modo di distinguersi più volte per il loro valore. Non
mancarono comunque dimostrazioni di crudeltà e ferocia, come avvenne in occasione della presa di Melfi “ dove - così ci informa il
Sanuto - introno per forza dentro amazando tutti chi trovorono, fanti homeni et done, fino i putti, et fatti presoni, et sachizato la terra,
nè alcun si salvò se non quelli se butorono de muri, quali si amazavano et erano etiam presi et morti”. Orazio Baglioni cadde in una
scaramuccia sotto Napoli il 22 maggio 1528. Alla fine di agosto le Bande, falcidiate dai continui combattimenti e dalla peste, si
arresero agli imperiali insieme ai resti dell’esercito della Lega, cessando definitivamente di esistere. Il nome di “Nere” con cui le
bande di Giovanni de’Medici passarono alla storia, e con cui esse stesse cominciarono a nominarsi dopo la morte del loro condottiero,
era dovuto al colore delle loro bandiere che Giovanni aveva cambiato da bianco e violetto in nero in segno di lutto per la morte dello
zio, il papa Leone X. Le Bande Nere rappresentarono la migliore espressione della strategia e tattica “all’italiana” emerse nel corso
delle guerre rinascimentali. Composte in gran parte da archibugieri, si trattava di truppe leggere molto mobili, particolarmente adatte
alla “piccola guerra”. Mentre negli scontri campali non erano in grado di sostenere l’urto dei massicci quadrati di picchieri se non
erano sostenute a loro volta da fanterie inquadrate in ordine chiuso, nella guerriglia, nei colpi di mano, nelle azioni di avanguardia o di
copertura erano tra il meglio che il “mercato” potesse offrire. Non per niente le parti in lotta si contesero sempre i loro servigi a suon
di ducati. Giovanni era d’altra parte un professionista della guerra e anche molto abile, e come tale si faceva pagare profumatamente
per il suo servizio. Tuttavia non era solo il denaro ad attirarlo ma anche la speranza che, alleandosi ora all’una ora all’altra parte, gli
riuscisse prima o poi di ritagliarsi un feudo tutto suo. Il denaro, e si trattava di cifre enormi, gli era d’altronde indispensabile per
pagare i soldati e mantenere così unita la compagine delle sue Bande. In un’epoca dove tutto era in vendita egli restò comunque
sempre fedele a Firenze e alla casata dei Medici, rappresentata per l’occasione dai pontefici Leone X e Clemente VII. Finché il primo
fu in vita, Giovanni rimase a fianco degli ispano-imperiali, alleati della Chiesa. Morto Leone X passò dalla parte dei francesi, poi
ancora con gli spagnoli e quindi allettato dalle ricche offerte di Francesco I, ritornò con i francesi, tanto più che il nuovo papa,
Clemente VII, propendeva per il re di Francia. Da quel momento diventò l’implacabile nemico dei lanzichenecchi tedeschi che lo
gratificarono con il significativo soprannome di Gran Diavolo. La fama di Giovanni e delle sue Bande si diffuse rapidamente. In esse
si arruolarono, come ci testimonia ancora Guicciardini, i “migliori fanti Italiani che allora prendessero soldo”; molti vi entrarono più
per spirito di avventura che per vera sete di guadagno, visto che la disciplina vi era più severa che nelle altre formazioni e il soldo il
più delle volte era lento ad arrivare e sovente non arrivava affatto. Nelle loro file vi erano letterati falliti o velleitari, cadetti di famiglie
nobili squattrinati e in cerca di riscatto, avventurieri professionisti, disperati e rifiuti della società, contadini che per non morire di
fame si arruolavano per fare ad altri quello che era stato fatto a loro. Abili con l’archibugio e con la spada, questi soldati si
trasformavano da Gran Diavoli del campo di battaglia a diavoli della rapina, della violenza e del saccheggio quando se ne presentava
l’occasione e soprattutto quando le paghe tardavano troppo ad arrivare. Tra essi vi erano anche disertori e traditori. I primi una volta
ripresi, venivano impiccati mentre i secondi, non appena scoperti, venivano inesorabilmente ”passati per le picche” dai loro stessi
compagni, a simboleggiare la punizione collettiva che colpiva chi era venuto meno al giuramento di fedeltà al capitano e al vincolo
solidale verso i propri compagni d’arme. Le Bande Nere non furono mai molto numerose. Anche nei loro momenti migliori non
superarono le 4000 unità. A Caprino contro gli Svizzeri vi erano 200 cavalieri pesanti, 300 leggeri e 3000 archibugieri; a Pavia 50
cavalieri pesanti, 200 leggeri e circa 2000 fanti. A Governolo Giovanni attaccò gli imperiali con 400 archibugieri, che furono
trasportati a cavallo sul campo di battaglia da altrettanti cavalieri. Frosinone fu difesa da 1800 fanti. Le Bande erano costituite quasi
interamente da italiani, per lo più toscani e romagnoli, con la probabile aggiunta di lombardi durante il periodo nel quale Giovanni
operò nell’Italia del nord. Ciò perché i paesi dell’Appennino tosco-emiliano fornivano uomini che costavano poco ed erano, almeno
all’inizio della loro carriera di soldati, di poche pretese; inoltre i mercenari stranieri, lontani da casa, erano meno fidati e più propensi
alla diserzione e a cambiare padrone. Nel volgere di breve tempo, sotto la guida di Giovanni, la Bande diventarono una formazione
d’elite, con pochi riscontri nel panorama delle compagnie di ventura italiane, di cui costituirono l’ultimo e più importante esempio.
Ebbero vita breve, come il loro giovane condottiero. Con lui entrarono nella storia, dopo la sua morte diventarono leggenda.
« Non mi snudare senza ragione. Non mi impugnare senza valore. »(Scritta riportata sulla spada visibile nella statua degli Uffizi
Un ritratto di Giovanni dalle Bande Nere, dipinto da Gian Paolo Pace è conservato presso la Galleria degli Uffizi a Firenze. Il dipinto
fu regalato da Pietro Aretino a Cosimo I de' Medici, figlio di Giovanni, ed era stato, in un primo tempo, commissionato a Tiziano, che
però non poté realizzare il ritratto per altri impegni. La notizia ci arriva da Giorgio Vasari (Vite de' più eccellenti architetti, pittori, et
scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri). La statua che lo ritrae seduto in Piazza San Lorenzo a Firenze fu commissionata
da suo figlio Cosimo I de' Medici a Baccio Bandinelli. Un suo ritratto ottocentesco si trova anche in una nicchia nel lato corto degli
Uffizi verso l'Arno, accanto ad altri famosi condottieri fiorentini (Francesco Ferrucci, Pier Capponi e Farinata degli Uberti).
Filmografia
• Giovanni dalle Bande Nere, regia di Mario Caserini (1911)
• Condottieri conosciuto anche come Giovanni dalle Bande Nere, regia di Luis Trenker e Werner Klingler (1937)
• I condottieri, Giovanni delle bande nere, regia di Luis Trenker (1950)
• Giovanni dalle Bande Nere, regia di Sergio Grieco (1956)
• Il mestiere delle armi, regia di Ermanno Olmi (2001)
Bibliografia
• Mario Scalini, Giovanni delle Bande Nere, Milano, Silvana editoriale, 2001
• Giorgio Batini, Capitani di Toscana, Firenze, Edizioni Polistampa, 2005, pp. 150 - 157 ISBN 88-8304-915-2
• Giovangirolamo de Rossi, "Vita di Giovanni de Medici detto delle bande nere", Roma, Salerno Editrice, 1996.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene file multimediali su Giovanni dalle Bande Nere
Collegamenti esterni Approfondimento Approfondimenti e Curiosità
Il monumento a Giovanni delle Bande Nere di Baccio Bandinelli in piazza San Lorenzo a Firenze Giovanni dalle Bande Nere agli
Uffizi
http://www.palazzo-medici.it/mediateca/it/schede.php?id_scheda=60&sezione=1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.cinemedioevo.net/Film/AC/condottier01
www.compagniabandenere.it
Jean des Bandes Noires
(1498-1526)
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Jean des Bandes Noires, en italien Giovanni dalle Bande Nere, né à Forli le 6 avril 1498 et mort à Mantoue le 30 novembre 1526,
fut un célèbre condottiere italien de la famille Médicis durant la Renaissance. Fils de Jean de Médicis dit le Popolano et de Catherine
Sforza, il passa son enfance dans un couvent, sa mère étant prisonnière de César Borgia. Prénommé à l’origine Ludovico en l’honneur
de l'oncle de Catherine, Ludovic le More, duc de Milan, sa mère le renomma Giovanni en mémoire de son père, à sa mort en 1498. À
la mort de sa mère, en 1509, sa tutelle fut confiée au chanoine Francesco Fortunati et à Jacopo Salviati, mari de Lucrèce de Médicis,
fille de Laurent de Médicis. Quand Salviati fut nommé ambassadeur à Rome en 1513, Jean le suivit et fut engagé dans la garde
pontificale. Son baptême du feu eut lieu le 5 mars 1516 dans la guerre contre Urbino et son duc François Marie Ier della Rovere,
guerre qui dura seulement 22 jours. Il créa sa propre compagnie et réussit à imposer discipline et obéissance à ses hommes. Il épousa,
en 1516, Maria, fille de Jacopo Salviati, qui lui donna un fils, Cosme, qui deviendra grand-duc de Toscane sous le titre de Cosme Ier.
En 1520, il soumet des seigneurs rebelles au pape. En 1521, le pape s’allie avec l’empereur Charles Quint contre François Ier. Jean est
sous les ordres de Prospero Colonna. Il participe à la bataille de Vaprio di Adda, franchit le fleuve contrôlé par les Français et les met
en fuite ouvrant la route pour Pavie. A la mort du pape en 1521, il fait noircir ses bannières qui étaient blanches et violettes : il en
tirera son surnom de Jean des Bandes Noires. En 1523, il est engagé par les Impériaux et, en juin 1524, il attaque de nuit le camp de
Bayard faisant trois cents prisonniers. Blessé le 18 février 1525 d’un coup d’arquebuse au cours d’une escarmouche, il est transporté à
Plaisance, puis le 7 mars dans le château de sa soeur (Blanche Riario épousée Rossi) à San Secondo près de Parme; enfin (mois de
mai) il va aux bains d'Abano près de Venise. Sa compagnie ne participa pas à la bataille de Pavie. En 1526, le commandement des
troupes pontificales lui est confié. Le 6 juin, François Marie Ier della Rovere, commandant en chef, décide l’abandon de Milan mais
Jean refuse d’exécuter l’ordre et attaque les arrières-gardes de l’ennemi au confluent du Mincio avec le Pô mettant en déroute les
troupes de Georg von Frundsberg. Le 25 novembre au soir, près de Governolo, hameau de Roncoferraro, il est gravement blessé au
tibia d’un coup de fauconneau. Il est transporté à Mantoue au palais de Frédéric Gonzague où il est amputé. Mais il meurt de gangrène
le 30 novembre 1526. Il fut inhumé dans l’église Saint-François de Mantoue. Ayant perdu leur chef, ses troupes se dispersèrent. Il
changea à plusieurs reprises de camp : 1516 au service du pape contre Urbino, juillet 1521 au service de Florence contre la France et
Venise, mars 1522 au service de la France contre les Impériaux, 1523 au service de Milan contre la France, novembre 1524 au service
de la France, juillet 1526 au service de l’Église et de Florence, novembre 1526 au service de la France contre les Impériaux.
Machiavel le considéra comme la personne capable d’unifier l’Italie.
Au cinéma
• Giovanni dalle bande nere, de Mario Caserini (1911)
• I condottieri, Giovanni delle bande nere, de Luis Trenker (1950)
• Giovanni dalle bande nere de Sergio Grieco (1956)
• Le Métier des armes (titre original : Il mestiere delle armi) d'Ermanno Olmi, 2002
Giovanni dalle Bande Nere
From Wikipedia, the free encyclopedia
Spouse(s) Maria Salviati
IssueCosimo I de' Medici, Grand Duke of Tuscany
Father
Giovanni de' Medici il Popolano
Mother
Caterina Sforza
Born
5 April 1498 Forlì, Papal States
Died
30 November 1526 (aged 28) Mantua, Duchy of Mantua
Giovanni de' Medici, also known as Giovanni dalle Bande Nere (April 5, 1498 – November 30, 1526) was an Italian condottiero.
Biography Giovanni was born in the Northern Italian town of Forlì to Giovanni de' Medici (also known as il Popolano) and Caterina
Sforza, one of the most famous women of the Italian Renaissance. From an early age, he demonstrated great interest and ability in
physical activity, especially the martial arts of the age: horse riding, sword-fighting, etc. He committed his first murder at the age of
12, and was twice banished from the city of Florence for his unruly behavior, including involvement in the sodomitical rape of a
sixteen-year-old boy, Giovanni being about thirteen at the time.[1] He had a son, Cosimo (1519-1574), who went on to become Grand
Duke of Florence. Giovanni became a condottiero, or mercenary military captain, in the employ of Pope Leo X (Giovanni di Lorenzo
de' Medici) and underwent his baptism by fire on March 5, 1516 in the war against Francesco Maria I della Rovere, duke of Urbino.
Giovanni won after 22 days. He thenceforth formed a company of his own, mounted on light horses and specializing in fast but
devastating skirmishing tactics and ambushes. In 1520 he defeated several rebel barons in the Marche. The following year Leo X
allied with Emperor Charles V against King Francis I of France to regain Milan, Parma and Piacenza; Giovanni was called in under
the command of Prospero Colonna, defeating the French at Vaprio d'Adda in November. As a symbol of mourning for the death of
Pope Leo X (December 1, 1521), Giovanni added black stripes to his insignia, whence comes his nick-name, Giovanni dalle Bande
Nere (or Giovanni of the Black Bands). In the August 1523 he was hired by the Imperial army, and in January 1524 he defeated the
French and the Swiss at Caprino Bergamasco. In the same year another Medici, Giulio di Giuliano, became Pope, and took the name
of Clement VII. The new Pope paid all of Giovanni's debt, but in exchange ordered him to switch to the French side of the ongoing
conflict. He did not take part in the battle of Pavia, but was soon severely wounded in a skirmish and later had to move to Venice to
be cured. In 1526 the War of the League of Cognac broke out. The League's captain general, Francesco della Rovere, abandoned
Milan in the face of the overwhelming superiority of the Imperial army led by Georg von Frundsberg. Giovanni was able to defeat the
Landsknechts rearguard at the confluence of the Mincio with the Po River.
Death On the evening of November 25 he was hit by a shot from a falconet in a battle near Govérnolo. The ball shattered his leg
above the knee and he had to be carried to San Nicolò Po, where no doctor could be found. He was taken to Luigi Gonzaga's palace in
Mantua, where the surgeon Abramo, who had cared for him two years earlier, amputated his leg. To perform the operation Abramo
asked for 10 men to hold down the stricken condottiero. Pietro Aretino, eyewitness to the event, recalled in a letter to Francesco
Albizi:
«Not even twenty» Giovanni said smiling «could hold me», and he took a candle in his hand, so that he could make light onto himself,
I ran away, and shutting [sic] my ears I heard only two voices, and then calling, and when I reached him he told me: «I am healed»,
and turning all around he greatly rejoiced.[2] »
Giovanni de' Medici died five days later, of septicemia, on November 30, 1526.
Legacy Giovanni's premature death metaphorically signaled the end of the age of the condottieri, as their mode of fighting (which
emphasized armored knights on horseback) was rendered practically obsolete by the introduction of the mobile field cannon. He is
therefore known as the last of the great Italian condottieri. His lasting reputation has been kept alive in part thanks to Pietro Aretino,
the Renaissance author, satirist, playwright and "scourge of the princes", who was Giovanni's close friend and accompanied him on
some of his exploits.
Ancestors Lodovico de' Medici (Giovanni dalle Bande Nere) in four generations
Mother:
Paternal
Great- Paternal
Great-greatGiovanni
dalle
Caterina
Father:
grandfather:
Paternal Grandfather: grandfather:
Bande
Nere
Sforza
Giovanni
the Pierfrancesco de' Medici Lorenzo di Giovanni de' Giovanni di Bicci de'
(Lodovico
de'
Countess of Popolano
(the Elder)
Medici
(the
Elder) Medici
Medici)
Forlì
Medici Popolani line
Founder of the Medici
Descendants Descendents of Lodovico de' Medici (Giovanni dalle Bande Nere) in four generations
Son:
Grandson:
Cosimo I de' Francesco I de' Great-granddaughter:
Great-Great-granddaughter:
Lodovico
de'
Medici
Medici
Medici
Marie
de'
Medici Henrietta
Maria
of
France
Giovanni dalle Bande Nere
Grand duke of Grand duke of Queen of France
Queen of England
Tuscany
Tuscany
Later references
• A cruiser of the Regia Marina was named after Giovanni delle Bande Nere in 1930.
• Ermanno Olmi's 2001 film, Il mestiere delle armi, faithfully follows Giovanni dalle Bande Nere in his last week of life, as he
engages in battle with the Imperial forces amidst the cold, damp fields of the Lombard countryside.
See also Italian Wars Condottieri Black Bands
References
1.
^ Rocke, Michael, Forbidden Friendships: Homosexuality ans Male Culture in Renaissance Florence. New York,
Oxford University Press, 1996, p. 229.
2.
^ http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_dalle_Bande_Nere#Biografia
Il mestiere delle armi (2001)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Una scena del film
Italia
2001
100 min
colore
sonoro
avventura, guerra, drammatico, storico
Ermanno Olmi
Ermanno Olmi
Ermanno Olmi
Luigi Musini, Roberto Cicutto, Ermanno Olmi (Cinema11undici), RAI Cinema, Studio Canal,
Taurusproduktion
Fotografia Fabio Olmi
Montaggio Paolo Cottignola
Effetti speciali Fabio Traversari
Musiche Fabio Vacchi
Scenografia Luigi Marchione
Costumi Francesca Sartori
Trucco Giulio Pezza
Interpreti e personaggi
• Hristo Jivkov: Giovanni De' Medici
• Desislava Tenekedjieva: Maria Salviati
• Sandra Ceccarelli: Nobildonna di Mantova
• Sasa Vulicevic: Pietro Aretino
• Sergio Grammatico: Federico Gonzaga
• Dimitar Ratchkov: Luc'Antonio Cuppano
• Aldo Toscano: Loyso Gonzaga
• Fabio Giubbani: Matteo Cusastro
• Franco Palmieri: Paolo Giovio
Premi
• 9 David di Donatello 2002: miglior film, miglior regista, migliore sceneggiatura, migliore produttore, migliore colonna
sonora, migliore fotografia, migliore montaggio, migliore scenografia e migliori costumi
• 3 Nastri d'argento 2001: miglior fotografia, migliore scenografia e migliori costumi
Il mestiere delle armi è un film del 2001 diretto da Ermanno Olmi, presentato in concorso al 54º Festival di Cannes.
Trama Il mestiere delle armi narra degli ultimi giorni di vita di Giovanni dalle Bande Nere, pseudonimo di Giovanni De' Medici,
soldato di ventura italiano al servizio dello Stato Pontificio durante le guerre d'Italia nella prima metà del XVI secolo. Dopo la
formazione della Lega di Cognac tra Papato, Francia e Repubblica di Venezia contro lo strapotere di Carlo V, re di Spagna e
imperatore del Sacro Romano Impero, un'armata imperiale di lanzichenecchi luterani al comando del veterano Georg von Frundsberg
scende in Italia con l'obiettivo di saccheggiare Roma e punire il voltafaccia del Papa. Consapevole della scarsità delle proprie truppe,
Giovanni adotta una tattica basata sull'impiego di un manipolo di cavalleggeri e archibugeri a cavallo. Attacca con brevi schermaglie i
vettovagliamenti degli imperiali in modo da ritardarne la marcia. Il marchese di Mantova Federico Gonzaga, intenzionato ad evitare la
guerra sui suoi territori, sceglie di lasciare via libera ai lanzichenecchi. Li lascia transitare attraverso la porta fortificata di Curtatone
negando il passo, poche ore dopo, alle truppe pontificie guidate da Giovanni. Contemporaneamente il Duca di Ferrara Alfonso I
d'Este, in cambio del matrimonio di suo figlio con una principessa imperiale, dona a Frundsberg quattro pezzi di artiglieria (falconetti)
in grado di perforare qualsiasi tipo d'armatura. Giovanni riesce tuttavia a raggiungere un gruppo di soldati imperiali presso la fornace
Paese
Anno
Durata
Colore
Audio
Genere
Regia
Soggetto
Sceneggiatura
Produttore
di Governolo, tra i quali vi è lo stesso generale Frundsberg. L'attacco si risolve in un fallimento: dietro le barricate di mattoni sono
nascosti i cannoni e il capitano italiano è ferito gravemente ad una gamba. La ferita profonda si infetta rapidamente provocando una
cancrena. Nonostante l'amputazione dell'arto, Giovanni morirà di sepsi. L'esercito dei lanzichenecchi di Frundsberg ha così via libera
verso Roma, che sarà saccheggiata dagli imperiali il 6 maggio 1527.
Commento La compassione che Ermanno Olmi rivolge al suo personaggio sul letto di morte non è inferiore a quella rivolta ai poveri
soldati che bruciano un crocifisso per riscaldarsi. Per descrivere la guerra il regista non ha bisogno del sangue. La sofferenza viene dal
freddo, dalla fame e dal peso delle armi e delle armature trascinate sulla neve nella pianura padana.[1] Perché "il mestiere delle armi"?
Perché Giovanni è un soldato e come tale rifiuta di essere uno strumento nelle mani della politica. Nonostante gli inganni ed i
tradimenti, sceglie comunque di andare incontro al suo destino perché, come diceva George Orwell, le azioni anche se sono prive di
effetto non per questo risultano prive di significato.[2] Di fronte alla morte la sua preoccupazione non è quella di un'improbabile
salvezza eterna ma solo quella del suo ricordo e della sua integrità riassunta nella bella semplicità di una frase: «Vogliatemi bene
quando non ci sarò più». Nel film non è da trascurare inoltre l'aspetto storiografico. Il mestiere delle armi di Giovanni dalle Bande
nere è ormai sorpassato dai nuovi strumenti di morte: le armi da fuoco come i cannoni dell'esercito di Georg von Frundsberg, di fronte
ai quali nulla possono più le armature. Non si tratta soltanto di una innovazione tecnologica dell'arte della guerra, ma di una crisi di
quei valori che prima ispiravano il combattimento; ormai non conta più il coraggio individuale o l'abilità dello stratega; non ci sono
più scontri corpo a corpo dove vince il più valoroso, la morte ora viene da lontano e non ti lascia scampo; ciò che importa sono le
capacità tecniche, saper usare le nuove armi e, soprattutto, avere denari per acquistare le nuove potenti e costose artiglierie. Ormai
(FR) « c'est l'argent qui fait la guerre »
(IT) « è il denaro che fa la guerra »
I falconetti del generale Georg von Frundsberg segnano la fine di un'epoca: il medioevo e l'età dei cavalieri e dei loro castelli sta
finendo sotto i colpi dei cannoni che mettono presto fine ai lunghi assedi feudali. Giovanni dalle Bande Nere si batte per il vecchio
stato papale, per sostenerne il potere temporale e spirituale che sta ormai finendo con l'avvento dello stato moderno, delle nuove
monarchie nazionali. Anche il grande Impero di Carlo V, ora vincitore con le armi contro il papato di Clemente VII, sarà col tempo
sconfitto dalla nuova Francia nazionale dei successori di Francesco I ed Enrico II. La vecchia idea dell'Impero universale dovrà
arrendersi alla nuova idea di nazione.[3].
Note
1. ^ «...è un bellissimo film sulla guerra combattuta a distanza con le prime artiglierie e sulla morte collettiva nella guerra, sulla
politica come altra forma bellica e distruttiva, sulla morte individuale e l'alta dignità nel viverla.»(Lietta Tornabuoni, La
Stampa)
2. ^ «La guerra è un lavoro, una professione (il denaro per i soldati consente ai capi di avere prestigio, autorevolezza e una
fragile forma di fedeltà), una vocazione (il pensiero della morte non sfiora la filosofia dell'esistenza), uno strumento della
politica (sotterfugi, doppio gioco, voltafaccia e menzogne degli alleati), un laboratorio di tecnica bellica (dalle spade, dalle
lance, dagli archibugi ai falconetti, nuovissime bombarde capaci di colpire i soldati avversari con palle da due libbre)» Enrico
Magrelli (Film TV)
3. ^ Nonostante la sconfitta di Enrico II nella battaglia di San Quintino, «la superiorità degli spagnoli era più apparente che
reale: invece di essere una giustapposizione di popoli e di paesi agglomerati tra di loro dal caso dell'eredità [...] esse [Francia
e Inghilterra] possedevano quella coscienza collettiva data dalla comunità dei destini, la costanza degli sforzi, l'armonia della
politica dei re con le tendenze nazionali» (Cfr.H. Pirenne, Storia d'Europa dalle invasioni barbariche al XVI secolo, Sansoni,
Firenze 1956)
Altri progetti
Wikiquote contiene citazioni di o su Il mestiere delle armi
Collegamenti esterni Scheda su Il mestiere delle armi dell'Internet Movie Database
Cosimo I de' Medici,
duca di Firenze, granduca di Toscana
(1519 - 1574)
Dizionario Biografico degli Italiani
di EE. Fasano Guarini
Ritratto del granduca Cosimo I de' Medici in armatura, di Angelo Bronzino. Galleria degli Uffizi, Firenze
COSIMO I de' Medici, duca di Firenze, granduca di Toscana. - Nacque a Firenze, il 12 giugno 1519, da Giovanni, detto delle Bande
Nere, discendente da un ramo cadetto della famiglia Medici, e da Maria Salviati, discendente per via materna dal ramo principale di
quel casato e nipote di Leone X. Trascorse buona parte della sua infanzia e lunghi periodi dell'adolescenza nella villa paterna del
Trebbio, situata nel Mugello, non distante da Cafaggiuolo.
Qui con la moglie Maria Soderini ed i figli Giuliano e Lorenzo (il futuro uccisore del duca Alessandro) viveva Pierfrancesco, cugino
di Giovanni ed amministratore del non vasto patrimonio comune, lasciato in fedecommesso dal nonno. Gli ultimi discendenti del
ramo cadetto dei Medici possedevano ed abitavano a tratti anche un palazzo a Firenze, in via Larga; ma nella loro marcata preferenza
per le dimore lontane dalla città si palesava la loro sostanziale estraneità dalla vita politica fiorentina e la loro emarginazione dalla
compagine familiare.
Al Trebbio C. godette di una vita libera, ricca di esercizi all'aria aperta; praticò la caccia, l'uccellagione, la scherma, la lotta, il
maneggio dei cavalli, la pesca, il nuoto; crebbe, come apparirà da adulto a Filippo Cavriana, suo biografo, "statura procera, firmis
torosisque membris".
La presenza del padre, che pur è stato descritto nell'atto di trasmettere precocemente a C. il culto dell'ardimento ed il gusto dei rischio
propri del mondo della milizia (avrebbe ordinato che il figlio di un anno gli fosse lanciato tra le braccia dall'alto di una finestra di
palazzo Salviati a Firenze, rallegrandosi che non avesse pianto), fu in realtà assai fugace; tenuto lontano dalla famiglia dai suoi
impegni di condottiero e dalla sua vita dissipata, morì il 30 dic. 1526, allorché C. aveva appena sette anni. Ben più forte fu l'impronta
della madre, donna austera e profondamente religiosa, orgogliosa della propria appartenenza alla famiglia Medici, attenta alle vicende
fiorentine e romane, e dispiaciuta, come essa stessa scriveva, dell'indifferenza del marito per "le cose della banda di qua", che a lei
apparivano "molto più stabili" che non quelle cui Giovanni legava le proprie fortune oltre gli Appennini; preoccupata per la situazione
finanziaria della famiglia, che la vita dispendiosa di Giovanni e la cattiva gestione patrimoniale del cugino avevano minato; ansiosa di
trovare per i suoi benessere, sicurezza e prestigio sotto la protezione medicea.
Fin dalla prima infanzia C. condivise con la madre una vita segnata dalle difficoltà economiche e dai debiti, e la seguì nei viaggi che
ella fece ripetutamente a Firenze e nel 1524 a Roma, in cerca di aiuto. A Roma fu presentato a Clemente VII, da cui Maria ottenne il
pagamento dei debiti del marito, ma per il figlio soltanto carezze non impegnative.
La madre affidò l'educazione di C. al "piovano" pratese Pierfrancesco Ricci. Più tardi, quando C. lo nominerà proprio segretario ed
incaricherà di trattare gli affari concernenti letterati ed artisti, il Ricci risulterà un personaggio di un certo interesse in campo culturale
e religioso, vicino all'evangelismo italiano, immeritevole dei giudizi acri formulati su di lui con qualche animosità personale dal
Cellini, dal Varchi e dal Vasari. Quando fu scelto come precettore era però persona modesta ed oscura, conunisurata alle ridotte
possibilità della famiglia. C. ricevette da lui un'istruzione limitata al latino, ad un po' di greco, alla lettura del Petrarca come buon
modello di lingua italiana; né molto di più dovette imparare dalla "radunanza de' più dotti e buoni uomini secolari e frati della città",
che, secondo un biografo più tardo, Lorenzo Cantini, presiedette alla sua educazione a Firenze dopoil 1530, se nella sua maturità al
Cavriana appariva "literis mediocriter imbutus".
Più importanti per la sua formazione furono le vicende stesse della sua infanzia e della sua adolescenza, trascorse sullo sfondo delle
guerre d'Italia, ed investite, seppur indirettamente, dai rivolgimenti che segnarono in quegli anni la storia di Firenze. Il giorno stesso in
cui ricevette ia notizia della morte del marito, Maria Salviati fece partire C. per Venezia, insieme al Ricci ed ai cugini Lorenzo e
Giuliano, o non havendogli detto - narra Scipione Ammirato - cosa veruna": decisione precipitosa, accolta con acuto turbamento dal
bambino e dettata probabilmente dai timori che suscitavano nella madre la minacciosa avanzata dei lanzichenecchi, sotto i cui colpi
era caduto Giovanni, l'incertezza dei dominio mediceo a Firenze, ed infine la freddezza, se non addirittura l'ostilità, che Clemente VII,
nel suo affetto esclusivo per i nipoti illegittimi Alessandro ed Ippolito, manifestava per i discendenti legittimi del ramo cadetto dei
Medici. A Venezia C. fu accolto con la simpatia e gli onori dovuti al figlio del defunto capitano generale della Repubblica: festeggiato
dalle più eminenti famiglie patrizie, ricevuto dal doge, solennemente introdotto presso il Consiglio dei dieci. Nel maggio del 1527 i
giovani Medici furono raggiunti dalle madri, e poco più tardi dalla nonna Lucrezia, indotte a fuggire a loro volta da Firenze dalla
restaurazione della Repubblica; ma ben presto il peggioramento dei rapporti tra Venezia e Clemente VII costrinse tutto il gruppo ad
una nuova avventurosa fuga. Mentre Lucrezia riparava ad Imola, C. e la madre ritornavano al Trebbio. Di qui dovettero allontanarsi
ancora una volta nel 1529, in seguito allo sconfinamento di alcune bande bolognesi ed alla spedizione diretta contro di queste per
conto della Repubblica da Otto di Montauto, gravida di pericoli per chiunque portasse il nome dei Medici. Questa volta la meta fu
prima Bologna, dove C. ebbe occasione di assistere all'incoronazione di Carlo V e di incontrare Clemente VII ed i cugini Ippolito ed
Alessandro, poi Roma.
La restaurazione del dominio medicco a Firenze nel 1530 segnò anche per C. tempi più sereni. Incluso, seppur in posizione remota, tra
i successori di Alessandro dal diploma imperiale che nominava quest'ultimo duca di Firenze (maggio 1530, C. alternò da allora i
soggiorni al Trebbio con quelli alla corte ducale. Nel 1532 seguì Alessandro a Bologna, dove questi incontrò Carlo V, e scortò poi con
lui l'imperatore fino a Genova. Nel 1536 ebbe modo di assistere allo scontro che si svolse a Napoli davanti a Carlo V tra il duca e gli
ambasciatori inviati dai fuorusciti a denunciarne il malgoverno, ed al trionfo politico del primo, unito allora in matrimonio alla figlia
illegittima dell'imperatore, Margherita d'Austria. Nel 1536 a Genova fu presente ad un altro incontro tra l'imperatore ed il genero.
Testimone di eventi importanti, C. fu tuttavia cortigiano appartato ed oscuro; superato di gran lunga nel favore del duca dal cugino
maggiore Lorenzo; dal papa considerato con perdurante diffidenza e richiamato all'osservanza della sua condizione subalterna. Così
l'orgoglioso ricordo delle proprie origini diverse ed il nebuloso disegno di ricostruire intorno a sé le milizie paterne, che C.
manifestava, a quanto racconta Scipione Ammirato, con il vestire e procedere o in tutte le sue azioni da cavaliere" e con il tenere
"continuamente appresso di sè molti soldati et capitani del padre" - dovettero cedere all'ordine di Clemente VII di "lasciar quelle
usanze forastiere et volgari e vestir l'abito civile che gli altri cittadini della sua patria costumavano". Soltanto dopo la morte del
pontefice C. poté abbandonare l'umiliante "lucco" per la cappa e la spada.
La mediocrità della sua posizione si rifletteva anche nell'incertezza delle prospettive che sembravano aprirsi per il suo futuro e nelle
difficoltà che incontravano i progetti. pur relativamente modesti, accarezzati per lui dalla madre.
Così il disegno di matrimonio con Maddalena Sanseverino, figlia di Maddalena Cibo e del defunto conte di Caiazzo ed erede del
feudo materno, perseguito da Maria e dallo stesso giovanissimo C. durante il suo soggiorno a Bologna nel 1532, non si realizzò, per le
resistenze della Cibo e la mancanza di pressioni adeguate da parte dei Medici e dei Saiviati. Non più fortunato C. fu nei confronti di
Elisabetta Guicciardini, agli occhi dei cui padre, Francesco, egli appariva pretendente scarsamente qualificato, a causa della sua
sisituazione patrimoniale. Solo negli ultimi anni del principato di Alessandro, infatti, C. riuscì a superare le difficoltà finanziarie che
avevano pesato sulla sua infanzia e la sua adolescenza, grazie alla conclusione favorevole di una causa in corso da tempo contro i
cugini Lorenzo e Giuliano per la divisione dei patrimonio comune.
L'assassinio di Alessandro ad opera di Lorenzo de' Medici (detto Lorenzino), avvenuto il 6 genn. 1537, aprì a C. orizzonti del tutto
imprevisti. Poiché il duca non lasciava discendenza maschile legittima e Lorenzino ed il fratello Giuliano decadevano ovviamente dal
loro diritto, la sua designazione alla successione scaturiva dallo stesso diploma imperiale del 1531. Essa però non fu automatica né
incontrastata. Costituì invece lo sbocco di una crisi breve ma acuta che, se non mise immediatamente in questione la sopravvivenza
del principato, investì per certo i rapporti che si erano instaurati al suo interno.
La restaurazione di un governo repubblicano popolare, pur vagheggiata dagli ultimi seguaci del Savonarola ed agitata in conventicole
di piazza, fu forse sogno per gli uni e spauracchio per gli altri assai più che non possibilità reale, "non havendo il popolo - scriverà G.
B. Adriani - nè armi nè guida nè aiuto". Tra gli ottimati rimasti a Firenze anche dopo che il carattere "tirannico" del principato di
Alessandro si era fatto palese, le correnti antimedicee erano d'altra parte nettamente minoritarie, e dalle riunioni tenute in casa dello
zio dello stesso C., il repubblicano Alamanno Salviati, emerse un attendismo rassegnato. Inoltre, prima ancora che si diffondesse la
notizia dell'assassinio (tenuta accuratamente segreta per parecchie ore), i consiglieri ducali avevano fatto affluire a Firenze le milizie
fedeli ai Medici e si erano assicurati l'appoggio del loro comandante generale, Alessandro Vitelli, garantendosi così gli strumenti per
far fronte ad eventuali disordini. Tuttavia l'esistenza di forti nuclei di fuorusciti fiorentini a Roma, Venezia, Bologna ed altrove; la
ripresa fin dalla primavera del 1536 della guerra tra Francia e Spagna e le minacce che tornavano quindi a gravare sulla stabilità
dell'area di influenza spagnola in Italia; l'ostilità del pontefice Paolo III Farnese verso i Medici, la sua aspirazione a creare uno Stato
farnesiano nell'Italia centrale e la politica di neutralità attiva tra le grandi potenze da lui perseguita aggravavano la pericolosità del
momento.
In questo quadro la successione fu al centro di un conflitto sotterraneo ma aspro. Da un lato il gruppo dei consiglieri del duca defunto,
guidati dal "forestiero" cardinale Innocenzo Cibo, parente dei Medici ed uomo di fiducia di Carlo V, mirava all'elezione di Giulio,
figlio illegittimo treenne di Alessandro, ed alla concessione della tutela al cardinale stesso: la direzione della vita politica fiorentina
sarebbe così passata nelle mani di uomini di corte ed alti funzionari estranei al contesto cittadino, fautori di una linea di stretta
osservanza imperiale e di rigido accentramento. Dall'altro, intorno a Francesco Guicciardini, Francesco Vettori, Matteo Strozzi,
Roberto Acciaiuoli, gli ottimati fiorentini filomedicei, dopo breve sconcerto iniziale, si schierarono per Cosimo.
Ai loro occhi l'attuazione delle disposizioni imperiali appariva come l'unica alternativa possibile al disegno del Cibo, ed il governo
diretto di un Medici come realistica condizione per una maggior autonomia di Firenze. Essi confidavano inoltre che l'inesperienza
giovanile di C., la sua parziale estraneità agli ambienti di corte, i legami di parentela ed amicizia che egli aveva con alcuni dei
"grandi", il peso stesso dell'appoggio dato alla sua elezione consentissero loro di recuperare lo spazio politico perduto negli anni
precedenti e di realizzare quel principato temperato, condizionato dall'oligarchia cittadina, cui avevano vanamente aspirato dopo il
1530.
Nel clima di timore che il vuoto di potere provocato dalla morte di Alessandro suscitava in entrambi i gruppi, gli eventì si
succedettero con estrema rapidità. Dopo che l'8 gennaio una prima seduta del Senato dei Quarantotto, supremo organo del governo
cittadino, si era conclusa con un nienie di fatto, i capi ottimati, tramite Maria Salviati, mandavano a chiamare C., che si trovava al
Trebbio. Questi nel frattempo, avuta notizia dell'assassinio di Alessandro, si era spontaneamente messo in viaggio per Firenze. Giunto
in città, si recava immediatamente dal Cibo, e, pur senza porre esplicitamente la propria candidatura, gli offriva con reverenza "quegli
aiuti che i bisogni della patria richiedessero". La presenza del giovane Medici, sostenuto dagli ottimati, da "ragunate d'affezionati e
partigiani" e da spontanee manifestazioni della milizia, creava una situazione di fatto da cui era impossibile prescindere. Così il 9
genn. 1537, in una città percorsa da inquietudine, dove - scriverà il Varchi - "si vedeva preso e guardato da soldati non solo il Palazzo,
ma i canti e tutte le bocche della via Larga", il Senato lo designò alla successione. La proposta fu avanzata dallo stesso Cibo, (con il
quale C. si era impegnato a mantenersi fedele all'imperatore, a tutelare la vedova ed il figlio di Alessandro ed a perseguirne l'uccisore)
e fu sostenuta da Francesco Vettori. Pochissime furono le voci dissenzienti.
Gli agiografi ducali hanno spesso esaltato la precoce fermezza politica di C. e la rapidità con cui seppe imporre la propria autorità a
Firenze. La realtà però appare più sfumata. Agli inizi la sua posizione fu fragile, minata dall'esterno dal pericolo costituito dai
fuorusciti, dall'ostilità dei Francesi e del papa, nonché dalla diffidenza dello stesso Carlo V; condizionata internamente dall'azione dei
gruppi eterogenei che avevano concorso all'elezione: ad un osservatore avvertito come Filippo de' Nerli sembrava che C. fosse "stato
fatto signore come si fanno i signori delle compagnie di Carnovaleo e che il suo governo procedesse "in su trespoli".
Il 10 gennaio, dando forma ufficiale alle condizioni poste a C. all'atto dell'elezione, il Senato deliberava che egli non avesse il titolo di
duca, ma solo quello di "capo e primario della città"; che, diversamente da Alessandro, dovesse scegliere il proprio luogotenente tra
gli stessi membri del Senato; che il suo appannaggio non superasse i 12.000 scudi annui. Era il fragile tentativo di limitarne per via
legale i poteri, a favore dell'oligarchia cittadina. Questa inoltre gli affiancò non solo il Consiglio a rotazione, già previsto dalla
costituzione del 1532 (il Magistrato supremo), ma anche un Consiglio segreto, composto da ottimati di grande autorità, come
Francesco Guicciardini, Francesco Vettori, Roberto Acciaiuoli, Matteo Niccolini e Matteo Strozzi, che avrebbe dovuto guidarne le
operazioni.
La notte tra il 9 e il 10 Alessandro Vitelli, d'altra parte, aveva occupato con un colpo di mano la Fortezza da basso, dichiarando di
tenerla a nome di Carlo V e dello stesso C., purché questi restasse fedele all'imperatore: simbolo della tutela imperiale, la fortezza
diventò anche base del potere personale del Vitelli, nonché del Cibo, che vi si rifugiò: un potere imposto con arroganza al giovane
principe, ed ambiguamente renitente alle stesse direttive imperiali. Un'azione analoga fu condotta poco dopo anche a Livorno.
Contemporaneamente confluivano in Toscana da Lerici 1.500 soldati spagnoli, sotto il comando di Francesco Sarmiento, mentre il
marchese del Vasto, comandante delle forze imperiali nell'Italia settgntrionale, inviava a Firenze il capitano Pirro Colonna, con il
compito di dirigere eventuali operazioni militari.
D'altro lato, benché C. non esitasse a dichiarare di voler "riposare nell'ombra dell'imperatore", e già il 12 gennaio gli inviasse
un'ambasciata per chiedergli la concessione del titolo ducale nonché la mano della duchessa vedova Margherita d'Austria in segno
della sua protezione, Carlo V, come rivelano i documenti conservati a Simancas, esitò a lungo tra l'opportunità di riconoscere il nuovo
principato e quella di restaurare la repubblica, per sottrarre i fuorusciti fiorentini all'influenza francese.
Ancora nel maggio il conte di Cifuentes, inviato come ambasciatore imperiale a Firenze, aveva in realtà l'incarico segreto di valutare
la situazione e giudicare se non fosse il caso di ridimensionare il potere di C.; e quando gli riconobbe, sia pure con una formula
ambigua e con riserva dell'approvazione imperiale, la stessa autorità di cui aveva goduto Alessandro, lo fece in deroga alle istruzioni
ricevute. Al tempo stesso, sulla base di una convenzione stipulata con Alessandro nel 1536, egli costringeva C. a cedere ufficialmente
a Carlo V le fortezze di Firenze e Livorno, lasciandogli solo quella meno rilevante di Pisa.
Se al disegno dei fuorusciti di piegare la costituzione fiorentina in senso repubblicano ed alle loro propensioni filofrancesi C. oppose
sempre con fermezza il proprio attaccamento al potere che gli era stato accordato e la propria lealtà verso l'imperatore, non è però
facile individuare una sua linea politica personale nei loro confronti: con qualche ragione lo zio, il cardinale repubblicano Iacopo
Salviati, gli rinfacciava a questo proposito di "dependere in tutto da altri".
In effetti nei tentativi iniziali di conciliazione verso Filippo Strozzi e verso i cardinali Salviati, Ridolfi, Gaddi durante il loro viaggio a
Firenze, nello stesso indulto pubblicato il 30 gennaio in nome di C. traspaiono piuttosto le pressioni dell'oligarchia cittadina, legata ai
fuorusciti da affinità politiche e spesso da vincoli di amicizia e di famiglia; mentre nelle resistenze opposte con qualche successo a
questi tentativi emergono l'ostilità e la volontà di rottura, diversamente accentuate, degli esponenti imperiali a Firenze ed in Italia.
Pochi mesi più tardi la mediazione condotta (in verità con scarso impegno e scarsi risultati) dal conte di Cifuentes, e l'ernanazione di
un secondo indulto obbedivano alle disposizioni dello stesso Carlo V, incline ad una politica che precludesse ogni possibilità di
intervento ai Francesi ed incontrasse l'approvazione del papa. Quando infine, nel luglio, i fuorusciti, rotti i lunghi indugi, con
l'appoggio dei Francesi, la partecipazione militare di Piero Strozzi ed il decisivo concorso finanziario di Filippo, organizzarono una
spedizione contro Firenze e penetrarono disordinatamente entro i confini dello Stato, la rapida azione militare condotta
vittoriosamente contro di essi il 1º agosto a Montemurlo fu coordinata e diretta da Alessandro Vitelli. Da lui fu anche voluto, o
almeno consentito, il massacro delle bande della fazione dei Cancellieri, che nel Pistoiese avevano appoggiato l'impresa degli esuli:
sconfitte nello stesso giorno dalle truppe fiorentine, ed abbandonate, con i loro capi, alla ferocia della fazione avversa dei Panciatichi.
Allo scarso rilievo personale assunto da C. nella questione dei fuorusciti fa però riscontro il vigore con cui egli affrontò i problemi del
governo interno, acquistando rapidamente autorità sulle magistrature cittadine ed assurgendo a fermo punto di riferimento per la rete
dei commissari e dei rettori incaricati di reggere lo Stato e far fronte ai disordini ed alle lotte di'fazione che si intrecciarono
pericolosamente alle vicende degli esuli non solo nel Pistoiese, ma anche nella Romagna fiorentina, a Borgo San Sepolcro, Anghiari.
Così a chi, come gli oratori senesi residenti a Firenze, lo considerava entro il quadro della vita cittadina, C. ben sembrò essere e far
"tutto" e sostituirsi di fatto agli organi costituzionali. In ciò fu sostenuto dalla madre, e soprattutto da un gruppo di abili e fedeli
collaboratori, provenienti dal servizio privato di Maria Salviati, come il Ricci, o maturati già al servizio di Alessandro, se non
addirittura di Lorenzo duca di Urbino e di Clemente VII., come Francesco Campana da Colle, Ugolino Griffoni da San Miniato, il
giurista Lelio Torelli da Fano, Agnolo Marzi Medici, vescovo di Assisi. In questi uomini, talvolta di estrazione fiorentina ed
aristocratica, ma più spesso originari di centri minori dello Stato o addirittura forestieri, ed in ogni caso personalmente legati al nuovo
principe, che ne aveva promosso o mantenuto la fortuna, C., in qualche misura erede di tradizioni famigliari, trovò un contrappeso al
Consiglio segreto posto al suo fianco dagli ottimati, uno strumento personale di governo e in un primo tempo probabilmente una
guida.
Il colpo inferto a Montemurlo ai fuorusciti (i cui capi, fatti prigionieri da Alessandro Vitelli, furono consegnati a C. ad eccezione del
più ricco e prestigioso di essi, Filippo Strozzi, e nel giro di un mese furono processatì ed in buona parte giustiziati) non dileguò le
minacce e le incertezze che gravavano sul principato. Gli esuli superstiti, tra ì quali vì era Piero Strozzi, tentarono a più riprese di
ricostituire un esercito con l'appoggio francese nella vicina base della Mirandola. Paolo III d'altro lato non abbandonò le proprie
aspirazioni ad uno Stato farnesiano; né il campo imperiale offriva a C. un appoggio chiaro e concorde: ancora alla fine del 1539
circolavano voci inquietanti sulla possibilità che Carlo V trasferisse il ducato nelle mani dei Farnese per agevolare il proprio
riavvicinamento al Papato. Dopo Montemurlo tuttavia si aprì a C. uno spazio di manovra di cui seppe avvalersi con abilità, da un lato
rafforzando con tenacia, seppur gradualmente, il proprio potere interno, dall'altro impegnandosi nel difficile compito di consolidare la
propria posizione internazionale e conquistare una più concreta autonomia nell'ambito del sistema spagnolo.
Già alla fine dell'estate del 1537 C. si proponeva di regolare in modo più favorevole i propri rapporti con Carlo V e gli inviava una
legazione diretta da Averardo Serristori, con il compito di chiedere il riconoscimento della propria successione ad Alessandro ed il
titolo ducale; la consegna di Filippo Strozzi, che il Vitelli deteneva nella Fortezza da basso ed intorno alla cui sorte si esercitavano
numerose contrastanti pressioni; la restituzione delle fortezze, a garanzia dell'indipendenza reale dello Stato di Firenze; infine, ancora
una volta, la mano di Margherita d'Austria. Carlo V, sia pure con qualche ritardo, rispose positivamente alla prima richiesta,
adeguandosi del resto agli impegni provvisoriamente assunti dal Cifuentes; ed il 30 settembre emanò un privilegio imperiale che
legittimava la successione di C. e gli attribuiva il titolo di duca di Firenze; ma sugli altri punti fece solo vaghe promesse. Tuttavia
nella primavera del 1538, durante il convegno che ebbe luogo a Nizza tra l'imperatore, il pontefice e Francesco I, e che sfociò nella
stipulazione di una tregua decennale tra Francia e Spagna, i rappresentanti di C. I ottennero alcune concessioni ulteriori: Carlo V
ribadi la propria intenzione di conservare le fortezze e rifiutò delimitivamente a C. I la mano di Margherita d'Austria, di cui pochi
mesi più tardi sarebbero state celebrate le nozze con uno dei più fieri avversari del duca, Ottavio Farnese; ma si impegnò a trovarglì
un'altra soluzione matrimoniale conveniente; gli accordò il ridimensionamento delle guarnigioni spagnole, il cui costo gravava sulle
esangui finanze fiorentine, e l'allontanamento da Firenze dell'inviso Alessandro Vitelli, che sarebbe stato sostituito con un capitano
spagnolo; gli prornise infine la testa di Filippo Strozzi.
Se la lotta tenace che questi aveva intrapreso per la propria salvezza e gli appoggi di cui ancora godeva a corte e tra gli esponenti
spagnoli in Italia valsero a ritardare ancora di alcuni mesi la conclusione della vicenda, alla fine dell'anno fu effettivamente emanato
l'ordine di ronsegna a C. I, cui conseguì, il 18 dicembre, il suicidio del prigioniero.
Nel frattempo C. I, che aveva rifiutato la mano di Vittoria Farnese, insistentemente offertagli dal papa, si impegnava, tramite il
proprio ambasciatore presso Carlo V, nella ricerca di una sposa "bella nobile ricca et giovine" e di parte spagnola; ed il 29 luglio
1539, sotto gli auspici dell'imperatore, si univa in matrimonio con Eleonora, figlia di don Pietro di Toledo, viceré di Napoli e fratello
del duca d'Alba.
Il parentado così concluso, pur inferiore a quello cui egli aveva inizialmente aspirato, rafforzava senza dubblo la sua posizione,
garantendogli l'appoggio attivo di una delle più potenti consorterie spagnole. Con gli Alba-Toledo egli avrebbe però condiviso negli
anni successivi non solo amici e consiglieri (alcuni dei quali avrebbero costituito il seguito stabile ed autorevole di Eleonora a
Firenze), ma anche gli avversari che essi contavano a corte ed in Italia, quali il marchese del Vasto o l'ambasciatore imperiale a Roma,
il marchese d'Aguilar. Le trattative precedenti le nozze furono ovviamente dominate da considerazioni politiche e finanziarie: in esse
tuttavia trovò qualche spazio anche la scelta personale del giovane C. I, irremovibile nel preferire alla primogenita Isabella, brutta e
"di cervello il ludibrio di Napoli", la più giovane, aggraziata e saggia Eleonora. A lei C. I restò sempre legato da stima ed affetto
profondi; e con lei visse, come scriveva il suo protomedico e biografo Baccio Baldini, "con molto riposo et piacere, lietamente
molt'anni". Il loro matrimonio fu coronato, tra il 1540 ed il 1554, dalla nascita di cinque figli maschi e tre femmine.
Con l'acquisita maturità ed il consolidarsi della sua posizione internazionale, C. I veniva anche liberandosi gradualmente, come
scriverà un altro dei suoi biografi cinquecenteschi, il Cini, "da balii et da tutori che come fanciullo et pupillo facevano professione di
governarlo". Il potere degli ottimati, già incrinato dal fallimento dei loro disegni di conciliazione con i fuorusciti, dopo la sconfitta di
questi subì una degradazione naturale: la sopravvivenza, peraltro lunga, del Consiglio segreto fu un puro fatto di forma, ed anche
Francesco Guicciardini, forse il più autorevole fra i consiglieri, provò la tristezza dell'emarginazione.
Più difficile fu liberarsi di coloro che esercitavano un'autorità in ragione di un rapporto privilegiato con gli Imperiali: alla fine dei
1537 Alessandro Vitelli, ad esempio, non esitava a far comunicare arrogantemente dal proprio inviato personale presso Carlo V ai
legati di C. I, di essere ben disposto a non "disunirsi" da lui, purché egli "per essere giovine o mai consigliato da qualcuno." non
facesse "cose da irritarlo o provocarlo". Ma, come si è visto, C. I, nella primavera del 1538 ne ottenne da Carlo V l'allontanamento.
Tra il 1539 ed il 1540 riuscì a mettere in disparte anche il Cibo, denunciando con durezza a Carlo V l'indiscrezione di cui egli aveva
dato prova, gli intrighi che aveva intessuto a Roma con i ministri imperiali, le insinuazioni calunniose che aveva diffuso a proposito di
un piano dello stesso C. I per avvelenare il figlioletto illegittimo di Alessandro. Ridotto a non scambiar con il duca "se non buon di,
buona notte e basta", il Cibo si ritirò infine volontariamente a Massa nel maggio 1540. Un anno più tardi, C. I esautorava anche Pirro
Colonna, adducendo a pretesto il suo contegno arrogante nei confronti del nano di corte.
Erano, per il duca di Firenze, passi necessari non solo per l'affermazione di principio della propria sovranità, ma anche verso
quell'esercizio diretto, personale del potere che caratterizzò il suo stile di governo. Senza modificare la costituzione del 1532, che, a
garanzia dei diritti dell'aristocrazia fiorentina, prevedeva il funzionamento di tre Consigli (il Consiglio dei duecento, il Senato dei
quarantotto ed il Magistrato supremo) ed attribuiva alle tradizionali magistrature cittadine un ruole, specifico e sostanzialmente
autonomo, e prima ancora di creare a supporto della propria azione nuove figure istituzionalizzate di ministri, C. I mirò ad accentrare
nelle proprie mani non solo il potere legislativo, come aveva già fatto Alessandro, ma anche l'amministrazione ordinaria: richiese
relazioni minuziose sugli affari di polizia, intervenne nelle cause civili e penali, instaurò l'uso di rispondere personalmente alle
suppliche dei sudditi. La sua volontà di conoscenza diretta del dominio ed al tempo stesso una nuova pratica di governo, attenta non
solo ai problemi della città dominante, ma a quelli delle Comunità soggette, si manifestarono anche nella consuetudine precoce dei
viaggi: tra il 1539 ed il 1543 C. I fu ripetutamente a Pisa, dove diede avvio ai primi provvedimenti per il risanamento della pianura; a
Pietrasanta, per porre le basi dello sfruttamento minerario della zona; ad Arezzo, per sorvegliare la costruzione della fortezza, nel
Casentino, in Valdelsa, a Borgo San Sepolcro.
Nel dominio C. I perseguì con durezza la repressione delle lotte di fazione: a Pistoia in particolare giunse a sospendere gli uffici
pubblici cittadini (dal 1538 al 1546) ed a sottrarre all'oligarchia locale l'amministrazione delle entrate, delegando al governo della città
commissari e provveditori fiorentini. Negli stessi anni la moltiplicazione delle "bande", ossia delle milizie locali soggette a servizio in
caso di necessità e dotate di ampi privilegi fiscali, giurisdizionali, amministrativi che erano state costituite da Alessandro, veniva
offrendo a C. I non solo un serbatoio di truppe fedeli, ma anche una rete di supporto capillarmente diffusa nel territorio. Anche le
fortezze di cui tra il 1539 ed il 1540 si intraprese il restauro o la costruzione a San Miniato, Arezzo, Pistoia, Prato, Firenze, Fivizzano
furono concepite come deterrente interno oltre che strumento di difesa militare.
Del carattere innovativo della sua politica nel dominio C. I fu orgogliosamente consapevole. Nel 1540, scrivendo a Carlo V, a prova
della propria capacità di governo e ferma volontà di "perpetuare nello Stato" adduceva in primo luogo i risultati conseguiti nelle "cose
di fuora del dominio": il compimento della fortezza di Arezzo, interrotta da Alessandro a lavori appena iniziati; la restaurazione
dell'ordine a Pistoia, mentre prima di luì si era sempre ritenuto che "la divisione et discordie di quella città" fossero essenziali al
mantenimento dei governo fiorentino.
L'intento di affermare la pienezza delle proprie prerogative sovrane, e quindi la giurisdizione dello Stato, si manifestò anche nella
politica seguita da C. I in materia di rapporti tra Stato e Chiesa durante i primi anni del suo principato, con la collaborazione, se non
addirittura la guida, di personaggi come Lelio Torelli, Francesco Campana e lo stesso Ricci, ostili alla politica curiale. In primo luogo
in questa luce vanno considerati la resistenza opposta tra il 1537 ed il 1540 all'esazione delle decime ecclesiastiche nel ducato; la
lunga (ed infine vittoriosa) controversia con il papa per l'attribuzione del lauto beneficio ecclesiastico dell'ospedale di Altopascio;
l'istituzione, fin dal 1539, di forme di controllo sull'attribuzione dei benefici da parte dei rettori civili; l'imprigionamento qualche anno
più tardi (1545) di venti domenicani di S. Marco, troppo vivacemente memori della tradizione savonaroliana, e l'espulsione
dell'Ordine dal convento fiorentino.
Al papa che lo accusava di essere poco cristiano C. I opponeva allora la recisa rivendicazione della propria sovranità politica: "farete
liberamente intendere a S. S. - scriveva al suo ambasciatore a Roma - che nelle cose di Stato non solo non harò rispetto a' frati, ma se
e' cardinali ne daranno cagione, gli impiccherò per la gola senza farne la minima parlata". Nel 1546 revocava infine l'espulsione; ma
più che la minaccia della scomunica papale pesava su di lui il volere di Carlo V, al cui appoggio teneva per questioni "le quali più ci
importano".
Nei toni di aspra conflittualità raggiunta in queste dispute si rifletteva però anche la tensione perdurante tra Medici e Farnese sul piano
politico. Questa toccò il culmine nel 1540, allorché C. I, durante l'insurrezione di Perugia, consentì a Rinaldo Baglioni, fuoruscito e
comandante della cavalleria ducale, di raggiungere la sua città, ed al tempo stesso tentò di proporsi quale intermediario tra il potere
pontificio ed i ribelli.
Il tentativo, che fallì per la rapida sconfitta degli insorti e l'atteggiamento ambiguo di Carlo V, esprimeva con chiarezza l'aspirazione
di C. 1 ad una presenza più dinamica e più autorevole sullo scacchiere italiano. Fin dal 1538, del resto, tendenze analoghe si erano
delineate anche nei rapporti con Lucca, pur saldamente ancorata al campo imperiale, e forte della protezione particolare del del Vasto
oltre che della simpatia del pontefice. Mentre nella partecipazione delle milizie ducali ai tradizionali scontri di confine tra Comunità
limitrofe e nell'interessamento di C. I alle vertenze che ne nascevano si manifestava una nuova attenzione (non limitata alla
Lucchesia) per la definizione ed il rafforzamento delle frontiere incerte e frastagliate dello Stato, il favore accordato ai fuorusciti
lucchesi (sull'esempio di Alessandro) e soprattutto l'intervento nella guerricciola scoppiata nel 1538 tra Lucca ed il principato di
Massa rivelavano non soltanto l'ostilità di C. I verso la piccola repubblica confinante, ma anche la sua volontà di porsi come garante
della concordia tra gli alleati minori di Carlo V e tutore della pace nell'Italia centrale, ed in questo modo di conquistarsi spazio e
preminenza politica nell'area imperiale.
Allo stesso disegno di egemonia, se non già di espansione, oltre che alla preoccupazione di bloccare eventuali propositi francesi di
intervento, nonché le esplicite mire farnesiane, era dovuto il vivo interesse di C. I per l'area instabile e militarmente debole costituita
ai confini meridionali del ducato dalla repubblica di Siena e dal principato di Piombino, piccolo ma rilevante per la posizione
strategica delle sue coste e le ricchezze minerarie dell'Elba.
Di qui le reiterate pressioni esercitate a partire dal 1538 su Carlo V per indurlo a sottrarre Piombino agli Appiani ed a cederlo allo
stesso Cosimo I. Di qui il tentativo, nel 1540, di scalzare il potere del governatore di Siena, Alfonso Piccolomini, e di erigersi a
fautore della pacificazione interna della città; la sua sollecitudine, nel 1541, nel rivelare la congiura filofrancese di Ludovico
Dell'Armi e di Giulio de' Salvi. Se C. I non ottenne i risultati voluti, riuscì però a stipulare sotto l'egida imperiale dei patti di amicizia
con i due Stati, comportanti l'obbligo reciproco di aiuto in caso di attacco da parte di potenze nemiche di Carlo V (3 giugno 1541 e 10
marzo 1542). Gli si apriva così la strada dell'intervento politico e militare nei loro confronti.
Agli inizi degli anni '40 C. I incominciò ad assumere un ruolo di primo piano tra le forze filoimperiali in Italia: non gli fu quindi arduo
trarre profitto dalle difficoltà finanziarie, politiche e militari che Carlo V doveva allora affrontare in seguito alla sconfitta di Algeri
(1541), alla ripresa della guerra con la Francia (1542) ed all'addensarsi della minaccia turca sui domini mediterranei della Spagna per
ottenere finalmente, dietro esborso di un - spicua somma (da 100.000 a 200.000 scudi) l'ambita restituzione delle fortezze di Firenze e
Livorno (accordi di Pavia, 12 giugno 1543).
Ormai interamente padrone deli suo Stato, a partire dal 1543 C. I diede avvio ad una serie di riforme istituzionali ed amministrative,
che, pur senza realizzare un disegno organico e complessivo di trasformazione, consolidavano le tendenze all'accentramento di cui si
erano visti dopo Montemurlo gli inizi. La creazione nel 1543 delle cariche di auditore fiscale ed auditore delle Riformagioni (in un
primo tempo affidate unitamente al pratese Jacopo Polverini; quindi, alla morte di questo, nel 1555. sdoppiate tra il volterrano
Francesco Vinta ed il mirandolese Alfonso Quistelli), sancì l'istituzione di ministri dijcali destinati, senza una rigida delimitazione di
compiti, a sovrintendere ai diversi settori dell'amministrazione, ed a fungere da tramite tra il duca ed i consigli o le magistrature
cittadine. A partire dal 1546, sotto la direzione di Lelio Torelli, succeduto al Campana nella carica di primo segretario e nominato
poco dopo anche auditore della Giurisdizione, si moltiplicò anche il numero dei segretari, destinati a svolgere compiti all'interno dello
Stato o nelle rappresentanze diplomatiche, tradizionalmente affidate ad aristocratici. In seno alle stesse magistrature cittadine si
accrebbero le funzioni ed il numero dei provveditori, segretari, cancellieri. Venne così consolidandosi una nuova burocrazia,
largamente aperta ai "provinciali", anche se non costituita esclusivamente da essi.
Formalmente subordinata ai consigli ed alle magistrature riservati all'aristocrazia cittadina (gli auditori, ricorderà all'inizio del secolo
XVII un vecchio cortigiano di C., Domenico Mellini, "giammai alla presenza del Magistrato sedettero, ma stando dritti in piede da
una testa del banco, quando l'occorrenza la richiedeva trattavano con il Magistrato quanto occorreva"), questa burocrazia costituì in
realtà uno strumento di cui C. I si servì per svuotare il dualismo insito nella costituzione del 1532 senza sopprimerlo. Legati a lui da
un rapporto di stretta dipendenza, tenuti a riferirgli puntigliosamente tutti gli affari trattati, a sottoporre alle sue decisioni le pratiche
istruite e ad eseguire fedelmente i "rescritti" da lui apposti in calce (sul cui valore legale verrà emanata una normativa specifica nel
1561), i collaboratori di C. 1 godettero di una parziale autonomia solo quando egli ne stimasse particolarmente "le rare et lodevoli
virtù", come fu per Lelio Torelli, ma in altri casi furono rudemente richiamati, come avvenne al più modesto Alfonso Quistelli, ad
eseguire soltanto ciò che egli avesse t di mano in mano" ordinato, al di fuori di ogni disposizione di carattere generale.
Anche la Pratica segreta, il nuovo Consiglio privato in cui si raccoglievano i principali ministri del duca, entrata in funzione di fatto
nel 1547, senza che alcuna delibera pubblica ne stabilisse composizione e compiti, ebbe un'attività prevalentemente consultiva, ed
operò in materia giurisdizionale ed economica assai più che non politica. C. I continuò a riservarsi non solo il potere legislativo, ma la
decisione degli affari più minuti.
A tutto ciò era consacrata la sua lunga ed intensa giornata lavorativa, che l'ambasciatore veneto Vincenzo Fedeli descriverà nel 1561
iniziando all'alba e d'inverno "due o tre ore innanzi giorno", essa scorreva con regolarità dalla chiamata quotidiana a rapporto
dell'auditore fiscale e del primo segretario ed auditore delle Riformagioni, alla lettura della corrispondenza e dei dispacci, cui C. I
rispondeva spesso "di suo pugno"; dalle udienze riservate ad ambasciatori, nunzi ed "altre persone principali" a quelle concesse a "li
particolari ad uno ad uno fino all'ora del desinare". La ricerca del rapporto diretto, paternalistico, con i sudditi fu sempre uno dei tratti
caratteristici di C. I, simile in questo più ad un signore quattrocentesco che ai nuovi monarchi assoluti. "Quando egli andava alla
Messa fuori di Palagio e a spasso per la città - ricorda ancora il Mellini, forse con qualche amplificazione - cavalcava un cavallino
baio molto piccolo, acciocché tutti quelli del popolo che avessero voluto parlargli il potessero fare comodamente".
Sempre al Fedeli nell'amministrazione della giustizia C. I apparirà "principe tremendo et spaventevole". Nella durezza delle leggi
emanate al fine di reprimere la violenza pubblica, vietare l'uso privato delle armi, tutelare la persona del sovrano (la "lex polverina"
del 1548) e nel rigore della loro applicazione; nella creazione di un'ampia rete di spie e di "sindaci dei malefici", incaricati
istituzionalmente di provvedere alle denunce; nel rafforzamento dell'apparato di polizia si esprimevano le tendenze autoritarie di C. I e
la sua preoccupazione preminente per la conservazione dell'ordine pubblico. Ma "provvedere et cercare che la justitia sia egualmente
administrata fra gli sua suddita" era ai suoi occhi dovere essenziale di un "optimo principe". Al di là dello stereotipo, non nuovo ed
ampiamente circolante nella trattatistica ufficiale del ducato (come, ad es., negli scritti del Lottini), i suoi interventi in questo campo
espressero anche la sua volontà di rafforzare le strutture dello Stato ed instaurare rapporti parzialmente diversi con le forze sociali
preminenti.
Le leggi da lui emanate nel campo dell'alta penalità (sulla bestemmia e sodomia, 1542; sugli omicidi ed atti di violenza, 1543; sui
contratti usurari, 1545; sui sicari, 1546; sulla violenza carnale, 1558 ecc.) tesero ad eliminare le disparità di trattamento ancora
previste dagli statuti quattrocenteschi di Firenze in ragione del rango degli offesi e degli offensori; a limitare la discrezionalità dei
giudici, che sotto la Repubblica era stata strumento di una giustizia di parte; a favorire l'uniformazione legislativa dello Stato,
mediante l'applicazione delle nuove norme a tutto il dominio. A quest'ultimo fine mirò anche l'estensione della giurisdizione di alcuni
tribunali, in primo luogo della Ruota fiorentina, come supremo tribunale d'appello civile, ma anche dei Conservatori di legge, per le
cause riguardanti poveri ed "impotenti a litigare" (1545) e degli Otto di guardia e balia in campo penale (1550): magistrature di
origine repubblicana e di composizione cittadina, che le ripetute riforme di carattere procedurale ed amministrativo promosse da C. I a
partire dagli anni '40 subordinarono al potere dei funzionari ducali e sottoposero a norme più rigide.
Ma al disopra delle magistrature ordinarie (che egli non si peritò di licenziare quando il loro operato gli fosse sgradito, come accadde
nel 1558 agli Otto di guardia e balia), al disopra degli auditori, in conformità con il proprio modo di intendere funzioni e prerogative
sovrane, C. I anche in questo campo si riservò ampio spazio di intervento personale ed autoritario: depositario del supremo diritto di
grazia, come i monarchi assoluti coevi, e di una giurisdizione straordinaria in campo civile (al cui espletamento fu delegato il
Magistrato supremo, ridotto al ruolo di tribunale duciale), egli fu anche puntiglioso controllore dell'operato dei magistrati ordinari e
non esitò ad interferire nelle loro sentenze, "alterando leggi e statuti", come scriveva con dimesso consenso il Quistelli e "arbitrando
altrimenti le pene". I suoi propositi di uniformazione legislativa restarono d'altra parte frammentari e furono contraddetti dal suo
rispetto per le autonomie ed i privilegi locali; è significativo che nel 1546 egli ordinasse a tutte le Comunità che non vi avessero
ancora proceduto di riordinare i propri statuti e consegnarne una copia a Firenze, affermando che la loro applicazione nei vasti settori
in cui la nuova legislazione ducale non aveva tolto loro vigore era condizione essenziale per una retta giustizia.
C. I in effetti non operò una trasformazione complessiva delle strutture giurisdizionali ed amministrative del dominio ereditate dalla
Repubblica, caratterizzate da un grado di accentramento superiore a quello che tra '400 e '500 era stato generalmente raggiunto negli
altri Stati italiani, ma fondate pur sempre sul riconoscimento dei poteri locali e l'attribuzione ad essi di funzioni rilevanti in campo
amministrativo e fiscale. In un contesto di formale fedeltà alle istituzioni comunali vigenti, si propose però di controllarne il
funzionamento dal centro. L'esautoramento degli organi cittadini attuato a Pistoia nel 1538 costituì un provvedimento del tutto
eccezionale e temporaneo, ma fu non di rado avocata dal duca la nomina a cariche di particolare rilievo finanziario, come quella di
governatore dei Ceppi di Prato e di Pistoia. Egli, inoltre, rafforzò ed estese il controllo amministrativo e contabile esercitato su tutte le
Comunità dai Cinque Conservatori del contado e del distretto, alla cui riforma in senso accentuatamente burocratico provvide con
ripetuti interventi legislativi, nel 1548, 1551, 1552. In conformità con la propria ideologia del principato, C. I amava presentare gli
interventi così attuati come tutela degli interessi collettivi (e di quelli dei poveri) contro la gestione di parte dei gruppi dominanti nelle
Comunità; ma in realtà egli acquisiva in questo modo uno strumento da un lato per interferire nei conflitti locali, dall'altro per regolare
le finanze comunali, "conservare et accrescere le entrate et i denari e risecar le spese del publico".
Questa nuova capacità di controllo dei territorio acquistava un rilievo non secondario anche nel quadro della politica fiscale che C. I
veniva elaborando nello stesso arco di anni, e da questa usciva d'altra parte ulteriormente rafforzata. Sotto il peso delle crescenti
esigenze finanziarie per il consolidamento delle strutture burocratiche e la politica internazionale e militare del ducato, egli non solo
ricorse a mezzi tradizionali, come la tassazione straordinaria ed in buona parte arbitraria dei redditi commerciali "arbitri") ed i prestiti
forzosi redimibili o in perdita "accatti"); ma si preoccupò di ampliare e consolidare le basi ed i sistemi del prelievo ordinario.
Di qui le misure di più rigoroso accertamento della ricchezza, il riordinamento della decima, l'imposta fondiaria fiorentina, cui C. I
diede avvio per il contado subito dopo la sua elezione; il rifacimento da parte degli organi centrali dell'estimo fondiario di tutto il
contado di Pisa, iniziato nel 1547 e compiuto nel 1551. Di qui la distribuzione delle spese per alloggiamenti militari e mantenimento
delle milizie ducali tra tutte le Comunità, in base a parametri prestabiliti (1545). Di qui, infine, quando già incombeva la preparazione
dell'intervento militare a Siena, l'istituzione delle gabelle sulle farine (1552) e sulle carni macellate (1553), imposte gravanti sui
consumi popolari, ma profondamente rispondenti all'idea cosimiana dell'uguaglianza dei sudditi, perché percepite in modo regolare ed
uniforme in tutto lo Stato, senza tener conto di alcun privilegio od esenzione territoriale o personale. Le due gabelle, concepite
dapprima come tasse straordinarie, costituirono poi le voci di entrata più rilevanti nel bilancio statale.
Con una commistione tra interessi pubblici e privati usuale in quei tempi, che si rifletteva nel duplice ruolo della Depositeria come
cassa centrale sia dello Stato sia del patrimonio mediceo, alle spese pubbliche contribuirono in misura non indifferente anche le
rendite del vasto patrimonio fondiario di C. I ed i profitti delle attività mercantili che egli incominciò a svolgere in proprio negli anni
'40. Queste attività (finora assai scarsamente studiate) furono d'altra parte sostenute dal potere interno di C. I, che praticava l'incetta in
deroga ai divieti ed appoggiava la vendita o la distribuzione coatta dei grano raccolto nelle fattorie medicee o importato alle istituzioni
pubbliche, gestiva in proprio la "magona" del ferro e miniere di argento, di allume e di rame. La sua posizione internazionale d'altro
lato gli consentiva di tessere una vasta rete di affari nei domini spagnoli, di godere di appalti proficui (come quello dei sale per lo
Stato di Milano nel 1548), di esercitare su larga scala il commercio dei metalli connesso con le industrie militari; di accedere a prestiti
cospicui o praticarli. Il forte incremento del patrimonio fondiario mediceo fu infine dovuto in buona parte all'accaparramento di terre
paludose, prima appartenenti alle Comunità, ed alla loro bonifica (quando non fosse preferibile riservarle alla pesca o all'impianto di
risaie).
Gli stessi interventi che C. I operò nel dominio, per valorizzarne le risorse agricole e minerarie, favorirne lo sviluppo commerciale e
manifatturiero, promuovere la bonifica ed il popolamento di alcune aree, non furono certo senza rapporto con i suoi interessi privati,
fondiari e commerciali. Essi assunsero tuttavia in alcuni casi notevole organicità e rilievo economico.
Di particolare interesse furono i provvedimenti emanati tra il 1546 ed il 1551 a favore di Pisa e del guo contado: alla concessione di
privilegi a chi introducesse nella città la I., vorazione della lana, agli inviti rivolti a, ebrei e marrani perché vi stabilissero la loro
residenza, all'apertura dell'arsenale, si affiancarono la promessa di esenzioni ed immunità a tutti i nuovi immigrati urbani e rurali e
l'emanazione di misure volte a promuovere opere di bonifica, mediante una più equa distribuzione delle spese ed un miglior
funzionamento dell'organo preposto (Ufficio dei fossi). Contemporaneamente C. I dava avvio a lavori per migliorare le fortificazioni
di Livorno. Pisa, residenza invernale della corte e sede dell'università, conobbe così sotto C. I una vivace ripresa economica e
demografica, e costitui, con le sue campagne ed il vicino scalo livornese, un secondo polo economico del ducato. Benché Firenze per
molti aspetti conservasse i privilegi politici, fiscalì, giurisdizionali che erano l'eredità del passato repubblicano, la capacità di
intervento nel dominio di C. I conferiva al suo Stato dei caratteri ormai regionali.
Maturava intanto anche una nuova politica culturale, consapevolmente tesa a rafforzare le istituzioni operanti in questo campo e ad
egemonizzare gli intellettuali del ducato. Nel 1543 C. I riapriva l'università a Pisa, e le affiancava il Collegio di Sapienza, destinato
agli studenti poveri del ducato. Già nel 1541-42 egli aveva promosso la trasformazione dell'Accademia degli Umidi, sorta come
aggregazione spontanea e ristretta di dotti e letterati fiorentini, in organo ufficiale del regime, posto sotto l'alta protezione ducale. Era
così nata l'Accademia fiorentina, la cui attività veniva finalizzata a compiti di rilevanza politica: la diffusione della lingua "toscana",
la fondazione di una storiografia ducale, le discussioni politiche, la panegiristica. Nel 1546-47 l'Accademia veniva riformata in senso
oligarchico e più rigidi regolamenti fornivano lo strumento per imporre che i lavori si svolgessero "con ordine e in silenzio", sotto il
controllo dei vertici graditi al duca. Contemporaneamente questi promuoveva la fondazione di una stamperia ducale, concedendone il
monopolio al fiammingo Torrentino.
Dopo il recupero delle fortezze, non senza connessioni con il processo di consolidamento dello Stato, C. I diede avvio ad una politica
internazionale più aggressiva, contrassegnata da chiare mire egemoniche, se non addirittura espansionistiche. Se verso Lucca neppure
nei momenti di tensione provocati dalla congiura antimedicea di Francesco Burlamacchi (1546) andò al di là di un tono di contenuta
minaccia; se ai confini nordoccidentali poté soltanto acquistare alcune Comunità precedentemente infeudate ai Malaspina. cume
Rocca Sigillina (1546), Filattiera (1549), Corlaga (1550); se con lo Stato pontificio i rapporti, già migliorati negli ultimi anni di Paolo
III, conobbero una svolta assai positiva dopo la morte di quest'ultimo e l'elezione di Giovan Maria Ciocchi Del Monte (Giulio III,
1550), suddito e candidato mediceo. decisa ed aspra fu invece la pressione esercitata da C. in direzione di Piombino e, in forme
diverse, di Siena.
In quest'area però incontrò la dura opposizione non solo dei poteri locali e di chi, come la Repubblica di Genova, temeva la
preponderanza ducale nel medio Tirreno, ma degli stessi rappresentanti imperiali che sotto la guida di Ferrante Gonzaga, governatore
dello Stato di Milano, e di don Diego de Mendoza, rappresentante di Carlo V a Siena, sostenevano la necessità di un più vigoroso
impegno spagnolo in Italia e dell'assoggettamento diretto così degli Stati minori toscani come di quelli padani: di qui le ambiguità
della condotta dello stesso Carlo V. A Piombino nel 1543 C. I intervenne secondo gli accordi contro la minaccia di un attacco di Khair
ad-dīn, detto il Barbarossa, capo dei corsari ottomani, e provvide al restauro delle fortificazioni che gli Appiani avevano lasciato
deteriorarsi, addossandosi il costo dei lavori. Ma neppure dopo la morte di Iacopo V (1545) ottenne la cessione del piccolo Stato,
tenacemente difeso dalla vedova, Elena Salviati e dal giovane figlio, Iacopo VI; e le speranze concepite nel 1546, allorché
l'imperatore, impegnato in Germania nella guerra contro i principi protestanti, gliene promise solennemente l'infeudazione, con l'Elba
e Pianosa, in cambio di un prestito di 200.000 scudi, andarono per diverso tempo frustrate. Nel 1548 C. I ottenne l'Elba, ma solo a
titolo di deposito temporaneo e con il gravoso impegno di procedere alla fortificazione di Portoferraio. Quanto a Piombino, il diploma
di investitura emanato poco dopo dall'imperatore fu ritrattato nel giro di un mese.Se il profondo risentimento di C. I per l'assenza di
compensi politici alla costosa azione di appoggio che gli veniva richiesta ed ai debiti enormi accumulati da Carlo V nei suoi confronti,
per "il tropo stirachiato modo di far ogni cosa meco" non giunse al punto di provocarne l'uscita dal campo imperiale, fu tale però da
indurlo ad un riavvicinamento segreto con la Francia e da ripercuotersi gravemente sulla sua politica senese.
A Siena nel 1546, in occasione della sommossa di parte popolare contro il Monte dei Nove, proprio il deciso sostegno militare ducale
aveva consentito alla guarnigione spagnola di ritirarsi indenne dalla città. Ma negli anni successivi C. I non esitò a distinguere le
proprie posizioni da quelle del Mendoza, fino a giungere nel 1551 ad una vera e propria rottura. Dopo la rivolta antispagnola del 27
luglio 1552, riluttante a schierarsi accanto al contestato rappresentante imperiale e contro le forze repubblicane che sapeva sostenute
dai Francesi, C. I ritirò rapidamente le proprie truppe e nel giro di pochi giorni, scavalcando gli Spagnoli, firmò con la Repubblica una
capitolazione che le riconosceva l'indipendenza, mentre essa si impegnava a non partecipare ad eventuali azioni ostili contro Firenze
(4 agosto). Contemporaneamente sottoscriveva un trattato segreto con Enrico II, impegnandosi ad una stretta neutralità tra Francia ed
Impero.
Non si trattò, tuttavia, di una netta scelta di campo: i timori di C. I nei confronti dei Francesi, tradizionali alleati dei fuorusciti
fiorentini, non si dileguarono; e la sua insistenza sulla segretezza dell'accordo, la sua preoccupazione di giustificare il proprio mancato
intervento agli occhi di Carlo V (sottolineando al tempo stesso le responsabilità dei Mendoza), i preparativi militari avviati nel ducato
indicavano con chiarezza i limiti e l'ambiguità della svolta. In effetti il declino del prestigio del Mendoza e del Gonzaga ed il prevalere
alla corte imperiale della linea di maggior disponibilità nei confronti dei principi alleati sostenuta dal duca d'Alba e dai Toledo, aprì la
strada ad un lento riavvicinamento: ne furono segni, da parte di Carlo V, la concessione di Piombino a C. I, sia pure a titolo
temporaneo; da parte di C. I la richiesta di revoca del patto con la Francia nel mese di novembre; l'assunzione al proprio servizio., con
il consenso di Carlo V, di Giangiacomo de' Medici, marchese di Marignano, suddito e capitano imperiale (febbraio 1553).C. I tuttavia
era ormai deciso a porre condizioni preliminari al proprio intervento, a chiarirne con l'imperatore i termini militari, finanziari e
politici: la riconquista di Siena doveva significare ai suoi occhi non la semplice costosa restaurazione della guarnigione spagnola, ma
l'occasione di ingrandimenti territoriali per sé, o almeno di un ampliamento della propria sfera di influenza politica. Così egli
mantenne un atteggiamento assai cauto nei confronti della spedizione guidata all'inizio del 1553 da Pietro di Toledo (destinata a
concludersi nel mese di giugno con il ritiro delle truppe napoletane che assediavano Siena): dopo la morte del suocero, avvenuta nel
febbraio, rifiutò di assumerne il comando, passato quindi al figlio Garcia, ed aderì invece al tentativo di mediazione svolto da Giulio
III. Quando nell'autunno del 1553 trattò infine con Carlo V l'organizzazione di una nuova spedizione, C. 1 volle assicurarsene la
direzione personale ed esclusiva, chiedendo al grande alleato solo la concessione di un congruo aiuto militare (4.000 fanti e 300
cavalieri) e la garanzia che Siena sarebbe rimasta nelle sue mani, finché tutti i debiti imperiali non gli fossero stati saldati o non gli
fossero stati concessi adeguati compensi territoriali.
L'attacco scattò tra il 26 ed il 27 genn. 1554, cogliendo di sorpresa i Francesi, tratti in inganno dalle trattative di pace condotte con la
mediazione del pontefice, alle quali C. I aveva finto di aderire. La guerra, condotta sotto il comando supremo del Marignano e
secondo i piani che C. I aveva elaborato con lui, con Francesco di Toledo e pochi altri collaboratori 1 fu lunga e durissima: alla rapida
conquista del forte di Camollia, alle soglie della città, ed al blocco parziale di questa, seguì un assedio protratto ed un'opera capillare
di distruzione degli approvvigionamenti e dei raccolti, di devastazione delle campagne, di perseguimento dei contadini che si fossero
arrischiati a portare vettovaglie in città. Nel giugno-luglio Piero Strozzi, luogotenente del re a Siena, diresse due sortite spettacolari;
dapprima riuscì a condurre le sue truppe fin nel cuore del ducato, alle porte di Prato ed in Valdinievole, ai confini con la Repubblica
di Lucca, inseguito con cauta lentezza dal Marignano; ma infine fu rovinosamente sconfitto a Scannagallo, vicino ad Arezzo (2
agosto). Siena resistette all'assedio ancora circa otto mesi; poi, abbandonata dai Francesi, si arrese a C. I il 17 apr. 1555. Se la guerra
lasciò sull'economia cittadina e sul territorio di Siena segni non facilmente cancellabili, al ducato essa richiese uno sforzo militare e
finanziario altissimo (stando alle cifre fornite dai contemporanei furono impegnati 20.000 uomini e 1.000 cavalli, tra bande ducali e
truppe mercenarie) e fu un indubbio banco di prova per la solidità dello Stato mediceo. C. I affiancò al Marignano come proprio
commissario Bartolomeo Concini, funzionario di umili origini, che aveva dato le prime prove della sua abilità nelle trattative con
Carlo V e negli anni a venire sarebbe diventato il più ascoltato ministro e consigliere ducale. Fedele alle proprie abitudini, C. I,
informato dal Concini, seguì di persona le operazioni più minute, criticando spesso rudemente le esitazioni, le lentezze, le scelte
tattiche del vecchio comandante.
La capitolazione, sottoscritta da C. I senza consenso preventivo di Carlo V (che la ratificò soltanto nel mese di giugno, non senza
obiezioni e resistenze), stabiliva che Siena tornasse sotto la protezione dell'imperatore, alle condizioni vigenti nel 1552; dovesse
accettare una guamigione imperiale e fosse privata delle fortezze. Riconosceva a Carlo V il diritto di procedere alle riforme che avesse
ritenuto opportune, nel rispetto, tuttavia, delle istituzioni repubblicane fondamentali. C. I non mancò di porre un'ipoteca sulla città,
nominandovi un proprio governatore e occupando le fortezze: a lui, del resto, erano ancora affidate le operazioni per eliminare le
guarnigioni francesi rimaste in Maremma e soprattutto nella zona di Porto Ercole.
Le sue speranze, ora abbastanza chiaramente orientate verso l'acquisto della repubblica, sembrarono destinate ad una nuova
frustrazione, allorché Carlo V, pochi mesi più tardi, ne creò vicario imperiale il figlio Filippo. Avevano premuto in questo senso gli
stessi Senesi, ostili alla prospettiva di un'annessione. al ducato. C. I tuttavia seppe approfittare con grande abilità delle difficoltà in cui
Filippo si trovò dopo l'abdicazione del padre, di fronte al perdurare delle guerre con la Francia in Italia e nelle Fiandre, alla bellicosa
politica antispagnola del nuovo pontefice eletto nel maggio 1555, Paolo IV Carafa, ed alla grave crisi finanziaria della Spagna. Nel
1557, preoccupato anche per le voci circolanti sull'eventualità di una cessione di Siena ai Farnese o addirittura ai Carafa, C. I ne
richiedeva con grande energia la subinfeudazione, ricordando gli enormi debiti accumulati con lui dalla Spagna (più di 2 milioni di
scudi) e minacciando, qualora non gli fosse stata data soddisfazione, di "provvedere in altro modo ai propri interessi", cioè di
riavvicinarsi alla Francia ed a Paolo IV.Il 3 luglio 1557 fu concluso l'accordo: C. riceveva lo Stato senese in feudo, ad eccezione dei
castelli di Talamone, Porto Ercole, Orbetello e di tutto l'Argentario, sui quali la Spagna manteneva il dominio diretto; doveva
restituire i territori di Piombino e. dell'Elba, dove tuttavia gli veniva lasciato Portoferraio, la "Cosmopoli" che egli aveva
dispendiosamente e faticosamente costruito e popolato a partire dal 1548. In cambio C. I annullava i debiti spagnoli.
Contemporaneamente si stabiliva una lega di assistenza militare tra la Spagna ed il ducato mediceo in Italia. Due anni dopo (1559) la
pace di Cateau-Cambrésis poneva termine all'ultimo focolaio di resistenza antimedicea, la Repubblica di Montalcino.
All'alleanza con Filippo II C. I restò fondamentalmente fedele fino alla morte, senza cedere alle sollecitazioni che in diversi momenti
gli giunsero da parte francese. In quest'ambito negli anni successivi alla pace di Cateau-Cambrésis egli aspirò con tenacia alla
preminenza tra gli Stati italiani: di qui il suo impegno nella annosa controversia sulla precedenza con gli Estensi (iniziata già nel 1541
e trascinatasi fino al 1569); la sua aspirazione, esplicita fin dal 1560, ad un titolo che lo elevasse al disopra degli altri principi italiani.
Essenziale fu per lui il rapporto privilegiato che si instaurò con il Papato a partire dal 1559, quando, dopo la morte di Paolo IV, dal
conclave abilmente condotto dal Concini fu eletto il cardinale Giovanni Angelo Medici (Pio IV), candidato spagnolo e mediceo: un
rapporto che C. I tenne a conservare anche sotto il rigido successore, Pio V, eletto nel 1566. Così si spiega (oltre che per la sua
religiosità personale, profonda e crescente) la politica ecclesiastica e religiosa di C. I nei suoi anni maturi: l'azione svolta nel 1560 a
favore della riapertura del concilio, tramite i propri diplomatici e recandosi personalmente dal pontefice a Roma; il suo attivo
allineamento sulle posizioni pontificie negli anni successivi, e le mediazioni svolte quando queste contrastassero con i punti di vista
spagnoli; la rapida accettazione dei decreti tridentini; l'attenuazione delle tendenze che avevano caratterizzato i primi anni del suo
governo, ed il favore concesso alle grevi aggiunte apportate da Pio V alla bolla In coena Domini;L'irrigidimento verso gli eretici, di
cui fu episodio culminante la consegna di Pietro Carnesecchi all'Inquisizione romana (1566).
Il legame con la Spagna non impedi d'altro lato a C. I di attuare iniziative autonome; né mancarono momenti di acuta tensione. Se nel
1558 egli riuscì ad acquistare senza difficoltà dai Piccolomini di Siena, in nome della moglie Eleonora, Castiglione della Pescaia e
l'isola del Giglio, il tentativo compiuto nel 1560-62 di entrare in possesso del feudo imperiale di Pitigliano, o almeno di legarlo a sé
attraverso un patto di accomandigia, e i progetti di annessione della Corsica insorta contro Genova accarezzati tra il 1564 ed il 1567 (a
ripresa di un interesse per l'isola mediterranea che C. I aveva già dimostrato nel 1553) irritarono profondamente Filippo II. Il veto
opposto dal sovrano spagnolo indusse C. I ad abbandonare le due imprese; ma l'aspirazione a rafforzare il proprio peso militare e
politico in seno all'alleanza per renderla tendenzialmente paritaria rappresentò una direttrice costante della sua azione negli anni '60.
Consapevole del ruolo che il Mediterraneo e la pressione turca stavano assumendo nell'impero di Filippo II, C. I si preoccupò ora
prevalentemente del rafforzamento delle strutture marinare del ducato.
"Le cose del mare - egli scriveva poco dopo l'annessione di Siena, delineando una sorta di programma politico per il futuro - non sono
di manco reputazione e utile alli stati che quelle di terra". Di qui l'appassionato interesse per la costruzione delle galere, cui egli amò
presenziare personalmente fino ai suoi anni più tardi, ed il programma di potenziamento della flotta di Stato; di qui la sua cura per le
fortificazioni di Livorno e per lo sviluppo dell'arsenale di Pisa. Di qui, anche, l'istituzione nel 1562, con l'autorizzazione e l'appoggio
di Pio IV, dell'Ordine cavalleresco di S. Stefano, con sede a Pisa, del quale il duca stesso fu gran maestro. Dalla sua attività, consona,
per usare le parole di un altro biografo cinquecentesco di C., il Mannucci, a "un onorato esercizio di armi" e ai "cortesi costumi de'
gentil'uomini", oltre che allo spirito di crociata del secolo, dalla sua partecipazione alle imprese di Filippo II contro i Turchi
(spedizioni di Orano, nel 1563, di Malta nel 1565) C. I si riprometteva, forse con qualche illusione, una trasformazione in senso
paritario dei vincoli che lo legavano al sovrano spagnolo. L'apertura dei ranghi dell'Ordine, attraverso il sistema delle conimende, ai
membri non solo dell'aristocrazia fiorentina, ma dei gruppi dominanti delle città e terre del dominio, ne faceva d'altro lato uno
strumento importante di unificazione dei ceti dirigenti del ducato.
Dopo l'annessione di Siena il ducato conobbe comunque un lungo periodo di pace. La situazione delle finanze migliorò nettamente, e
C. I poté abolire l'"arbitrio", che tra i tipi di imposizione era ai suoi occhi il più iniquo ed il più impopolare (1561). Perfezionò il
sistema statale delineato precedentemente, con alcune ulteriori riforme nei campi preminenti dell'amministrazione della giustizia
(riorganizzazione del fisco, 1563) e della sovrintendenza al dominio (sostituzione dell'unico Magistrato dei Nove conservatori della
giurisdizione e del dominio fiorentino ai due uffici dei Cinque conservatori e degli Otto di pratica, le cui competenze si erano spesso
sovrapposte, 1560). Pur nel rispetto dell'autonomia da Firenze e delle istituzioni cittadine precedentemente in vigore imposto dalla
capitolazione del 1555 e dall'atto di infeudazione del 1557, C. I procedette a una ampia riforma dello Stato di Siena (1561), in cui si
riflettevano significativamente gli stessi criteri che avevano guidato il suo governo a Firenze.
Istituì un governatore, che volle strettamente dipendente da sé, conferendogli "quella e quanta autorità ci parrà alla giornata, per le
lettere della sua elettione o in altro modo"; avocò a sé le nomine ai Consigli ed alle magistrature più rilevanti; creò la nuova
magistratura dei Quattro conservatori, destinata, come i Nove a Firenze, a sovrintendere all'amministrazione delleComunità del
contado. Più tardi, nel 1571, procederà anche alla riorganizzazione giurisdizionale del contado, sostituendo, secondo il modello,
fiorentino, alla vasta congerie di perduranti autonomie locali una rete più regolare di giusdicenti cittadini, largamente sottoposti al
controllo accentrato del governatore e del capitano di Giustizia di Siena.
Furono anni di grandi interventi sul territorio, non più soltanto fiorentino ma anche senese. Ad essi il duca continuò a sovrintendere
anche di persona, con lunghi viaggi pressoché annuali: così tra il 1560 ed il 1562 visitò la Valdichiana, la Maremma senese
(progettandovi bonifiche e ripopolamento ed accaparrando al tempo stesso terre incolte ed impaludate), Grosseto, Livorno, Pisa e le
sue campagne.
La rete delle fortificazioni cui C. I aveva dato avvio fin dai primi anni del suo principato si articolò ulteriormente: ai numerosi
restauri, alla costruzione di nuove cinte bastionate intorno a terre e città, di torri e fortini lungo le coste si aggiunse la costruzione di
due città-fortezza, Terra del Sole, avamposto della Romagna ducale (1564), e Sasso di Simone, inerpicato su una montagna di 1.200
metri ai confini col ducato di Urbino (1569). Nello "Stato nuovo" veniva edificata una cittadella a Siena (1561) e si avviava la
fortificazione di Grosseto e Radicofani. Procedettero con slancio i lavori di bonifica del piano dell'Arno e di raddrizzamento del corso
del fiume; ad essi si affiancarono tentativi più frammentari e scarsamente fruttuosi nella Maremma senese. Nel 1560 fu dato avvio al
canale dei Navicelli, destinato a collegare per via d'acqua Pisa a Livorno.
In campo culturale all'Accademia fiorentina fu affiancata nel 1563 l'Accademia del disegno, alla quale fu affidato un compito analogo
di direzione ufficiale ed uniformazione dell'attività artistica nel settore che le era proprio. A C. I la propria opera sembrava in qualche
misura compiuta: ed alla sua esaltazione, nei suoi aspetti centralizzatori e regionali, egli indirizzava le più notevoli iniziative di quegli
anni in campo architettonico e figurativo. Nel 1560 prendeva avvio, sotto la direzione del Vasari, la costruzione degli Uffizi; nel 1565
sempre il Vasari, con la decorazione allegorica del salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, celebrava unitamente lo Stato e l'opera
di C. I ed esaltava in lui l'"optimus princeps" che regnava "pacata Etruria, aucto imperio, constituta civitate".
All'immagine del principe che ha raggiunto i suoi fini si intreccia agli inizi degli anni '60 quella di uda vita famigliare e privata piena,
libera e felice. Nel 1561 Vincenzo Fedeli (cui più tardi faranno eco numerosi biografi di C. I), accanto alla sua intensa giornata di
lavoro, ricorda il suo amore per le "cose ove bisogna agilità, forza, destrezza", il maneggio delle armi, i tornei, la caccia; la sua
passione spontanea per la pesca ed il nuoto, nei quali "è la totale sua ricreazione". Ed al severo rigore che caratterizza il suo
personaggio pubblico contrappone il lieto abbandono alla semplicità giocosa dei rapporti privati, "talmente che è fatto proverbio nella
città che il duca si disduca e s'induca quando vuole". Alla "grandezza" della corte, di cui pure proprio per quegli anni ci è noto
l'ampissimo "ruolo", C. I preferiva ora un modo di vita più dimesso: "come un grandissimo padre di famiglia" mangiava "con la
moglie e con i suoi figliuoli con una tavola moderatamente ornata", mantenendo la stretta unità del suo nucleo famigliare e del suo
seguito, contro le consuetudini principesche generalmente in voga. Anche "nell'andar fuori o per la città o in campagna, dove va il
duca va la moglie e figliuoli e tutta la casa", notava ancora il Fedeli, con il seguito delle guardie, dei cavalleggeri, dei capitani
pensionati e stipendiati.
Un anno più tardi, però, tra il novembre ed il dicembre 1562, proprio nel corso di un viaggio attraverso il ducato, C. I perse in rapida
successione i figli Giovanni (morto a Livorno il 20 novembre) e Garzia (morto a Pisa il 12 dicembre), colpiti da febbri malariche, e la
moglie Eleonora, da tempo ammalata di tubercolosi (morta a Pisa il 17 dicembre).
Egli reagì con la pubblica compostezza del sovrano; ma, scriverà il protomedico Baldini, era stato "carnalissimo della moglie et dei
suoi figliuoli mentre che eglino vissino", e molto sofferse della loro morte. Lo provano anche le lettere che C. I inviò al primogenito
Francesco, che allora si trovava alla corte di Filippo II a Madrid, nelle quali si professa "un vero cristiano che da Dio riconosce il
tutto", ma si dilunga poi nel racconto particolareggiato, realistico e dolente, delle tre morti, come se fosse tutto preso dal ricordo di
queste. Le voci relative a cupe tragedie famigliari rapidamente diffuse dalle cerchie dei fuorusciti fiorentini residenti a Roma, recepite
negli ambienti del concilio tridentino, e di qui propagate altrove, rivelano soltanto l'ostilità di cui era ancora circondato Cosimo I.
Il 1º maggio 1564 C. I cedette il governo e le rendite dello Stato al figlio Francesco, riservandosi il titolo ducale, il diritto di nomina
alle cariche più importanti, i beni allodiali e i capitali commerciali, nonché il diritto di beneplacito nelle questioni politiche di maggior
rilievo.
Se al papa egli adduceva il proprio desiderio di servire meglio Dio ed a Filippo II ricordava l'esempio di Carlo V, alla sua decisione
contribuirono probabilmente diverse ragioni pubbliche e private: il suo precoce logoramento fisico (egli soffriva di "pietra e renella");
la sua crescente aspirazione ad una vita ritirata; il suo desiderio di facilitare la successione di Francesco al trono. nonché forse la
concessione del titolo più elevato cui ambiva, sostituendo a se stesso, che della dinastia era il fondatore, il figlio, principe per diritto
ereditario. Proprio nel 1564, d'altra parte, stavano felicemente concludendosi le trattative per il matrimonio di Francesco con
Giovanna d'Austria sorella dell'imperatore Massimiliano II, in cui C. I, dopo il fallimento del progetto di unione con Giovanna,
infanta di Spagna e principessa vedova di Portogallo (1560), vedeva un riconoscimento essenziale della preminenza raggiunta dal suo
casato. In effetti le nozze principesche furono poi celebrate nel dicembre 1565, con festeggiamenti pubblici alla cui preparazione
sovrintese lo stesso Cosimo I.
Il precoce ritiro di C. I fu lungi pero dall'essere totale. Egli continuò a dirigere la politica estera del ducato, a sovrintendere all'attività
marinara della flotta di Stato e dell'Ordine di S. Stefano (fino alla partecipazione delle galere toscane alla battaglia di Lepanto sotto le
bandiere pontificie). Seguì personalmente le lunghe 1 trattative (affidate ancora una volta al Concini) che, dopo i veti opposti negli
anni precedenti da Spagna ed Impero alla concessione del titolo regio o arciducale da parte di Pio IV, condussero infine Pio V ad
insignire nel 1569 C. I del titolo di granduca di Toscana ed incoronarlo solennemente a Roma il 5 marzo 1570. Ancora C. I negli anni
successivi fece fronte al risentimento dell'imperatore e di Filippo II, per il pregiudizio portato agli altri principi italiani ed agli
arciduchi tedeschi; il procedimento volutamente unilaterale seguito dal pontefice; la natura del titolo attribuito, che implicava la
sostituzione alla disgiunta sovranità su Siena e Firenze di quella unitaria sulla Toscana. Il privilegio imperiale, necessario per la sua
effettiva validità, verrà emanato soltanto dopo la morte di C. I, a favore di Francesco, nel 1576.
Con il figlio C. I ebbe però rapporti non facili. Già nel 1561, dopo avergli affidato, come addestramento alla pratica del governo,
proprio la risposta alle richieste di grazia cui attribuiva tanta importanza, C. I rimproverava Francesco per il modo in cui aveva assolto
fl compito, da cui era stato costretto ad esonerarlo: "non durò molto che per Fiorenza si diceva che le gratie le facevono i tuoi servitori
et ancora si vendevono", gli scriveva con collera; e lo richiamava all'opportunità di tenere "li servitori come servitori".
Lo separava in effetti dal figlio un modo diverso di concepire la funzione del principe ed il ruolo della corte e dei ministri. Nel 1568,
in una lettera indirizzata al Magistrato supremo e diffusa agli altri organi pubblici, C. I ricordava la "buona usanza" da lui introdotta
nel passato di ricevere personalmente lettere e suppliche indirizzate "in nostra man propria" e provvedere in segreto alle richieste così
pervenute; ne constatava con rimpianto il declino, "pensando forse le genti che noi non volessimo più negotiare"; protestava la volontà
sua e del principe a "durar ogni sorta di fatica" pur di tornare all'antica consuetudine, chiedendo perciò paradossalmente l'aiuto degli
organi pubblici.
Con amarezza egli assisteva, in questo come in altri campi, al tramonto di quel rapporto paternalistico e diretto con i sudditi che gli
era stato tanto a cuore, ed alla crescita dei poteri di mediazione dei ministri e della corte. A questa, nella versione accentuatamente
spagnolesca che le fu propria sotto Francesco e Giovanna, egli, pur amante di feste, spettacoli e balli, si sentiva estraneo.
Creavano d'altra parte dissapori anche gli amori che C. I intrecciava pubblicamente, senza i riguardi che secondo i figli erano dovuti al
suo grado. La relazione con Leonora degli Albizzi (1565-67), dalla quale nacque il figlio don Giovanni, si concluse con
l'allontanamento della donna, e le sue nozze, volute da C. I, con un cittadino fiorentino, Bartolomeo Panciatichi.
Ad essa però, ed ai contrasti con Francesco, è legato l'assassinio di Sforza Almeni, compiuto da C. I il 22 maggio 1566, in un violento
accesso di collera: l'Almeni, da lungo tempo primo cameriere segreto e intimo del duca, da lui lautamente beneficiato con case, poderi
e monopoli mercantili, si era probabilmente reso colpevole di qualche indiscrezione nei confronti del suo vecchio signore, e del
tentativo, simile ad un tradimento, di ottenere il favore del nuovo principe.
Ben più durevole ed impegnativo fu il legame con Camilla Martelli, dalla quale C. I nel maggio 1568 ebbe la figlia Virginia. Nel
1570, dopo la sua incoronazione granducale, C. I confessò al papa i suoi scrupoli, e ne fu esortato a rompere il concubinato. "Padre
Santo gli rispose a quanto egli stesso scrive la mia coscienza non mi detta così". Tornato a Firenze, "per la quiete dell'anima e del
corpo", la sposò in forma riservata, senza concederle alcun titolo.
Alla collera di Francesco ed agli altezzosi rimproveri della nuora Giovanna, che gli trasmetteva l'indignazione dell'imperatore, C. I
opponeva il ricordo della propria generosa dedizione nei confronti del figlio, cui aveva dato "gli stati et quanto havevo" e la propria
disponibilità a "strascicarsi" sempre per la sua grandezza; ma rivendicava con fermezza la propria libertà privata ed il proprio diritto
"d'esser lasciato vivere".Licenziata la sua corte, trascorse i suoi ultimi anni con Camilla a Pisa e nelle ville di Castello e Poggio a
Caiano in forma ritiratissima: dedito ancora, per quanto gli era possibile, a brevi viaggi, ed alle attività all'aria aperta, attraverso le
quali, scriverà il Baldini, aveva maturato la conoscenza profonda ed appassionata di "tutte le parti et tutti i paesi degli Stati suoi, non
altrimenti che se egli fusse stato confinovamente presente in tutti"; sorretto da una religiosità sincera, ancora attenta alle "cose a
benefitio de' poveri"; ma tormentato in misura crescente dalla gotta e, a partire dal 1568, da una serie di colpi apoplettici, che negli
ultimi anni lo ridussero ad una condizione di invalidità; immalinconito dal confronto quotidiano con la moglie troppo giovane ed
amante dei divertimenti, scarsamente incline ad assisterlo.
Morì a seguito di un ultimo colpo apoplettico nella villa di Castello, presso Firenze, il 21 apr. 1574.
Fonti e Bibl.: Tra le fonti ms. relative alla storia del ducato al tempo di C. I hanno particolare interesse biogr. i carteggi, registri di
lettere e minutari di C. I, in Arch. di Stato di Firenze, Me diceo del Principato (cfr. Arch. di Stato di Firenze, Arch. Mediceo del
Principato. Invent. sommario, Roma 1951, e Id., Carteggio universale di C. I, I, 1536-1541, a cura di A. Bellinazzi-C. Lamioni,
Firenze 1982). Rilevanti sono anche i fondi Carte Strozziane (cfr. Le carte strozziane del R. Arch. di Stato di Firenze, Inventario, serie
I, I-II, Firenze 1883-1891); Miscell. medicea, Diplom. mediceo. Per le fonti di parte spagnola, cfr. R. Magdaleno, Estados Pequefios
de Italia (siglos XVI-XVIII). Catalogo XXVII del Archivo de Simancas, Valladolid 1978. Per la bibl. e le fonti a stampa, cfr. i
repertori di D. Moreni, Serie d'autori di opere riguardanti la celebre famiglia Medici, Firenze 1826, passim;e S. Camerani, Saggio di
bibliografia medicea, Firenze 1964, pp. 96-105. Per gli studi più recenti, cfr. le rassegne di storia toscana di F. Diaz, Recent studies on
Medicean Tuscany, in The Journal of Italian History, I (1978), pp. 95-110; e di G. Spini, Bilancio di un "trend" storiogr., in Potere
centrale e strutture perifer. nella Toscana del '500, Firenze 1980, pp. 7-25. In questa sede ci si limita a fornire le indicazioni più
rilevanti. Gli atti legislativi di C. I sono in buona parte pubbl. in Legislaz. toscana raccolta e illustrata da L. Cantini, I-VIII, Firenze
1800-1803. Dal suo carteggio è tratto Cosimo I de' Medici, Lettere, a cura di G. Spini, Firenze 1940. Tra le fonti diplom. cfr.
Relazioni degli ambasc. veneti al Senato, a cura di E. Alberi, s. 2, I, Firenze 1839, pp. 321-400 (relaz. di V. Fedeli, 1561) e s. 2, II,
Firenze 1841, pp. 57-93 (relaz. di L. Priuli, 1566); Legazioni di Averardo Serristori, ambasciatore di C. I a Carlo V ed in corte di
Roma, a cura di G. Canestrini, Firenze 1853; C. Paoli-E. Casanova, C. I dei M. ed i fuorusciti del 1537 (Da lettere di due oratori
senesi), in Arch. stor. ital., s. 5, XI (1893), pp. 279-338; G. Canestrini-A. Desiardins, Négociations diplom. de la France avec la
Toscane, III, Paris 1865, passim;C.Guidiccioni, Opere, a cura di C. Minutoli, Firenze 1867, III, pp. 215, 217, 273, 286, 340; M.
François, Corresp. du cardinal Francois de Tournon, Paris 1946, passim. Tra i carteggi, diari, cronache e opere contemp., cfr. P.
Bigazzi, Documenti ined. spettanti alla vita Politica e letter. di F. Strozzi, append. a G.B. Niccolini, FilippoStrozzi, Firenze 1847; G.
Ughi, Cronica di Firenze..., a cura di F. Frediani, in Arch. stor. ital., VII (1849), App., pp. 97-274 passim;A. Lapini, Diario fiorentino
.., a cura di G. O. Corazzini, Firenze 1900, passim;B. Cellini, Vita, a cura di O. Bacci, Firenze 1901, pp. 173, 415 s., 423 e passim; F.
Guicciardini, Carteggi, XVII, a cura di P. G. Ricci, Roma 1972, pp. 322-42; G. Vasari, Le vite de' più eccellenti pittori scultori e
architettori nelle redazioni del 1550e 1568, testo a cura di Bettarini, 4 voll., commento a cura di P. Barocchi, 3 voll., Firenze 1966-76,
passim. Tra le biografie ined. di C. I. sono di qualche interesse, Firenze, Bibl. nazionale, Magliab., cl. XXV, cod. 49: F. Cavriana,
Cosmi Medices Magni Ducis Hetruriae vita; Ibid., cl. VIII, cod. 1401, cc. 42-62: M. Adriani, Vita del granduca C.;tra le biogr. edite
quelle coeve di B. Baldini, Vita di C. M. primo granduca di Toscana, Firenze 1578; G. B. Cini, Vita del serenissmo signor C. de' M.,
Primo granduca di Toscana, Firenze 1611; S. Ammirato, Opuscoli, Firenze 1642, III, pp. 206-34; D. Mellini, Ricordi intorno ai
costumi, azioni e governo del serenissmo granduca C. I, Firenze 1820; A. Mannucci, Vita di C. de' M. granduca di Toscana, Pisa
1823; G. B. Adriani, Vita di C. de' M., in Scelta di curiosità letter. ined. o rare dal secolo XIII al XVII, CXXI, Bologna 1871, pp. 1114. Cfr., inoltre, tra le biografie o studi di particolare rilevanza biografica più tardi: L. Cantini, Vita di C. de' M., primo granduca di
Toscana, Firenze 1805 (con appendice docum.); L. A. Ferrai, C. I de'M. duca di Firenze, Bologna 1882 (con append. docum.); G. E.
Saltini, Tragedie medicee domestiche (1557-1587), Firenze 1898, passim;G. E. Young, The Medici, London 1909, pp. 237-303 (trad.
it., Firenze 1934); G. Pieraccini, La stirpe dei Medici di Cafaggiolo, Firenze 1947, I, pp. 501-07; II, 1, pp. 1-54; G. Spini, C. I dei M.,
in Libera cattedra di storia della civiltà fiorentina, Firenze 1958, pp. 163-78. Forniscono indicazioni biografiche le storie generali
coeve di P. Giovio, Historiae sui temporis, Basileae 1560, passim;G. B. Adriani, Istoria de' suoi tempi (1573-1574), Firenze 1583,
passim;S. Ammirato, Istorie fiorentine, con l'aggiunte di Scipione Ammirato il giovine, Firenze 1647, II, pp. 437-563; B. Varchi,
Storia fiorentina (1527-1538), Colonia 1721, pp. 587-640; B. Segni, Istorie fiorentine (1527-1555) Augusta [Firenze] 1723, passim;F.
de' Nerli, Commentari de'fatti civili dal 1215 al 1537, Augusta [Firenze] 1728, pp. 291-302; I. Nardi, Istorie della città di Firenze, a
cura di L. Arbib, II, Firenze 1842, pp. 367-410. Tra le storie o studi complessivi posteriori, cfr. G. Bianchini, Dei granduchi di
Toscana della real Casa de' Medici protettori delle lettere e delle belle arti, ragionamenti istorici, Venezia 1741, pp. 1-31; R. Galluzzi,
Istoria del granducato di Toscana sotto il governo della casa Medici, Firenze 1781, I-II, passim;F. Inghirami, Storia della Toscana,
Fiesole 1841-43, X, pp, 88-253; XII, pp. 498 s.; A. von Reumont, Gesch. Toskanas seit dem Ende des florentinischen Freistaates,
Gotha 1876-77, I, pp. 69-294; R. Caggese, Firenze dalla decadenza di Roma al Risorg. d'Italia, Firenze 1912-13, III, pp. 50-124; A.
Panella, Storia di Firenze, Firenze 1949, pp. 202-22; F. Diaz, Ilgranducato di Toscana. I Medici, Torino 1976, pp. 66-229; E.
Cochrane, Florence in the forgotten Centuries, Chicago 1973, pp. 13-92; J. R. Hale, Florence and the Medici. The Pattern of Control,
London 1977 (trad it. Firenze e i Medici. Storia di una città e di una famiglia, Milano 1980, pp. 157-99). Offrono contrib. ulteriori alla
storia dell'infanzia ed adolescenza di C. I: C. Guasti, Alcuni fatti della Prima giovinezza di C. I. de' M. granduca di Toscana, in Il
Giorn. stor. d. archivi toscani, II (1858), pp. 1364; Lettere di Giovanni de' Medici, a cura di G. Milanesi, in Arch. stor. ital., n. s., VIII
(1858), pp. 24-27; L. A. Ferrai, Lorenzino de' Medici e la soc. cortigiana del Cinquecento, Milano 1891, pp. 2639, 96-99 e passim.
Sugli inizi dei principato di C. cfr.: A. Rossi, L'elezione di C. I, in Atti del R. Istituto veneto di lett., scienze ed arti, s. 7, I (1889-90),
pp. 369-435; L. Staffetti, Ilcard. Innocenzo Cybo, Firenze 1894, pp. 153-224; A. Rossi, Francesco Guicciardini e il governo fiorentino
dal 1527 al 1540, Bologna 1896, pp. 273-329; A. Anzilotti, La crisi costituz. della Repubblica fiorentina, Firenze 1912, pp. 121-48; A.
Otetea, François Guichardin. Sa vie Publique et sa Pensée Politique, Paris 1926, pp. 302-15; R. von Albertini, Das florentin.
Staatsbewusstsein im Übergang von der Republik zum Prinzipat, Bern 1955 (trad. it., Firenze d alla repubblica al principato, Torino
1970, pp. 280-305 e passim);R. Ridolfi, La vita di Francesco Guicciardini, Roma 1960, pp. 386-95, 400, 411, 415; Id., Francesco
Guicciardini e C. I, in Arch. stor. ital., CXXII(1964), pp. 567-606; G. Spini, C. Ie l'indip. del Principato mediceo, Firenze 1980. Sulle
riforme istituz., la politica interna e gli interventi nel territorio attuati da C. I, cfr. A. Anzilotti, La costituz. interna dello Stato
fiorentino sotto C. I duca di Toscana, Firenze 1910; I. Ferretti, L'organizzaz. militare toscana durante il governo di Alessandro e C. I,
in Riv. stor. d. archivi toscani, I (1929), pp. 248-75; II (1930), pp. 58-80; D. Marrara, Studi giurid. sulla Toscana medicea, Milano
1965, ad Ind.;A. D'Addario, Lo Stato fiorent. alla metà del '500, in Arch. stor. ital., CXXI ( 1963), pp. 362-456; E. Fasano Guarini, Lo
Stato mediceo di C. I, Firenze 1973; G. Pansini, IlMagistrato supremo e l'ammin. della giustizia civile durante il Principato mediceo,
in Studi senesi, LXXV (1973), pp. 283-315; Architettura e politica da C. I a Ferdinando I, a cura di G. Spini, Firenze 1976, ad Ind.;A.
D'Addario, La formazione dello Stato moderno in Toscana da Cosimo il Vecchio a C. I de' M., Lecce 1976, pp. 193-245; E. Fasano
Guarini, Città soggette e contadi nel dominio fiorentino tra Quattrocento e Cinquecento, in Ricerche di storia moderna, I, Pisa 1976,
pp. 1-94 passim;Id., Potere centrale e comunità soggette nel granducato di C. I, in Riv. stor. ital., LXXXIX (1977), pp. 490-538; Id.,
Consideraz. su giustizia, Stato e società nel ducato di Toscana del Cinquecento, in Florence and Venice: comparisons and relations, II,
Cinquecento, Firenze 1980, pp. 135-68; La nascita della Toscana. Dal convegno di studi Per il IV centenario della morte di C. I de'
M., Firenze 1980, passim; Potere centrale e strutture Periferiche nella Toscana del '500, a cura di G. Spini, Firenze 1980, passim. Sulla
polit. religiosa ed eccles. di C. I, cfr. anche L. Bruni, C. I de' M. e il processo di eresia del Carnesecchi, Torino 1891; L. von Pastor,
Storia dei papi, V-IX,Roma 1914-1925, ad Ind.; C. Capasso, Paolo III (1534-1549),Messina 1923-24, I, pp. 322 s., 527-33, 634-38; II,
pp. 89-91, 218-22, 566-76 e passim;A.Amati, C. I e i frati di S. Marco, in Arch. stor. ital., LXXXI (1923), pp. 226-77; A. Panella,
L'introduzione a Firenze dell'Indice di Paolo IV, in Rivista storica degli archivi toscani, I (1929), pp. 11-25; H. Jedin, La polit.
conciliare di C. I, in Riv. stor. ital., LXII (1950), pp. 345-74, 477-96; A. D'Addario, Aspetti della Controriforma a Firenze, Roma
1972, passim;S. Caponetto, Aonio Paleario e la riforma protestante in Toscana, Torino 1979, pp. 42-57; A. De Maddalena, Le Piaghe
di Roma ("Pareri" di. C. de' M. primo granduca di Toscana), in Giornale degli economisti e Annali di economia, XXXVIII (1979), pp.
709-18. Sulla sua polit. estera e le sue imprese militari, oltre a G. Spini, C. I e l'indipendenza del Principato mediceo, cit., cfr. G. Livi,
La Corsica e C. I de' M., Firenze 1885; A. De Morati, La Corse, Cosme Ier de Médicis et Philippe II, Bastia 1886; L. Cappelletti,
Storia della città e Stato di Piombino, Livorno 1897, pp. 156-222; C. Manfroni, Storia della marina milit. del granducato mediceo,
Roma 1897, passim;E. Palandri, Les négociat. politiques et religieuses entre la Toscane et la France à l'époque de Cosme Ier et de
Cathérine de Médicis, Roulers 1908, pp. 1-169; L. Romier, Les origines Politiques des guerres de religion, Paris 1913-14, ad Ind.;N.
Giorgetti, Le armi toscane e le occupaz. straniere in Toscana, Città di Castello 1916, I, pp. 17-300; A. D'Addario, Il problema senese
nella storia ital. della prima metà dei Cinquecento, Firenze 1958, passim;G. Guarnieri, I cavalieri di S. Stefano, Pisa 1960, pp. 41-105;
R. Cantagalli, La guerra di Siena, Siena 1962, passim;M. Berengo, Nobili e mercanti..., Torino 1962, pp. 203-3, 223 ss., 228-34; F.
Angiolini, Diplomazia e politica dell'Italia non spagnola nell'età di Filippo II, in Rivista stor. ital., XCII (1980), pp. 432-69. Sulla
politica finanziaria internazionale di C. I, cfr. G. v. Pölnity, C. I M. und die europäische Anleihepolitik der Fugger, in Quellen und
Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, XXXII (1942), pp. 207-237. Sulla questione della precedenza e
l'acquisizione del titolo granducale, cfr. G. Mondaini, La questione di precedenza tra il duca C. I e Alfonso II d'Este, Firenze 1898; V.
Maffei, Dal titolo di duca di Firenze e di Siena a granduca di Toscana, Firenze 1905; V. Bibl, Die Erhebung Herzog C.s von M. zum
Grossherzog von Toscana und kaiserliche Anerkennung (1569-1576), Wien 1911; L. Carcereri, C. I granduca, Venezia 1926. Sulla
polit. culturale di C. cfr., oltre a R. von Albertini, cit., e Architett. e politica, cit., A. Fabroni, Historiae Academiae Pisanae, II, Pisa
1792, pp. 3-40; G. Prezziner, Storia del pubblico Studio e delle società scientif. e letter. di Firenze, II, Firenze 1810, pp. 3-39; D.
Marrara, L'università di Pisa come università statale nel granducato mediceo, Milano 1965, pp. 7-40; E. Borsook, Art and politics at
the Medici Court: The funeral of C. I de' M., in Mitteil. des kunsthistor. Institutes in Florenz, XII (1965-66), pp. 31-54; A. Minor-B.
Mitchell, A Renaissance entertainment. Festivities for the marriage of C. I duke of Florence in 1539, Columbia, Missouri, 1968; K.
W. Forster, Metaphors of Rule. Political Ideology and History in the Portraits of C. I de' M., in Mitteil. des kunsthistor. Institutes, in
Florenz, XV (1971), pp. 65-104; M. Plaisance, Une Première affirmation de la polit. culturelle deCosme Ier. La transformation de
l'Académie des "Humidi" (1540-42), in Les ecrivains et le pouvoir en Italie à l'éPoque de la Renaissance, s. 1, Paris 1973, pp. 361438; Id., Culture et polit. à Florence de 1542 à 1551, ibid., s. 2, Paris 1974, pp. 149-242; C. Di Filippo Bareggi, In nota alla politica
culturale di C. I: L'Accad. fiorentina, in Quaderni storici, VIII (1973), pp. 527-74; M. B. Hall, Renovatio and Counter - Reformation,
Vasari and Duke C. in S.ta Maria Novella and S.ta Croce (1567-1571), Oxford 1979, pp. 1-90; G. Cipriani, Il mito etrusco nel
Rinascimento fiorentino, Firenze 1980, pp. 71-112.
Gian Giacomo Medici
(1495 - 1555)
From Wikipedia, the free encyclopedia
Gian Giacomo Medici, Il Medeghino, in a 16th-century engraving Medici's bronze portrait, from his monument in the Cathedral of Milan, by Leone Leoni
Gian Giacomo Medici (c. 1495 – 8 November 1555) was an Italian condottiero, Duke of Marignano and Marquess of Musso and
Lecco in Lombardy. Gian Giacomo Medici was the brother of Giovanni Angelo Medici, who was later to be elected Pope as Pius IV.
They were scions of an impoverished though patrician family of Milan not connected with the Medici of Florence, in spite of the
Medici heraldic palle appearing in the contemporary engraving (illustration): thus Gian Giacomo's nickname Il Medeghino, the "little
medico". Gian Giacomo, the eldest of fourteen children, was banished from Milan after a daring murder of revenge in broad daylight.
He fled to Lake Como where he gathered about him a band of brigands answerable to none but him. He threw in his lot as bodyguard
to the future Duke of Milan, Francesco II Sforza, reinstated in Milan by Emperor Charles V. The Medeghino gained a reputation for
unscrupulous violence in the Sforza pay; in partial recompense, he was made Marquis of Marignano on 28 March 1528 (by Imperial
patent and confirmed by Francesco Sforza II, Duke of Milan), and also Marquis of Musso and Lecco. In this connection it is often
mentioned that he fled to Lake Como, making it his retreat. This however was not a coincidence, as he was born in Valsolda which is
a part of the community of Porlezza. Still today, evidence can be found that Marquis Giacomo di Medici was born in Valsolda and
even had a residence in the community of Porlezza. In the main church of Cima, which belongs to the community of Porlezza, an
inconspicuous relief can be found which can be seen underneath. Il Medeghino became a famous condottiere, or soldier of fortune,
who fought in the pay of Charles V at the Battle of Mühlberg and elsewhere in Italy (the "War of Siena"), in the Wars of Religion in
France and in the Low Countries. The great engineer Agostino Ramelli trained with Gian Giacomo, who instructed him in
mathematics and architecture [1]. In 1543 he purchased the ancient fortified castle of Frascarolo in the Valceresio, which he converted
into a sumptuous villa [2], and in the summer of 1545 he married Marzia Orsini, daughter of Ludovico Orsini, conte di Pitigliano. He
was made a knight of the Order of the Golden Fleece in 1555, also the year of his death. Il Medeghino is buried in the Duomo of
Milan. Since his only son, Camillo (died after 1586), was illegitimate, though made a Knight of the Order of Malta, Gian Giacomo's
honors passed to his brother Agosto (1501 – 1570).
External links Medici di Marignano: genealogical notes
The relief shows the lion of San Marco which is a symbol of the alliance between Gian Giacomo de Medici and the former republic of
Venice. It was put there in honor of his achievements, regarding the unity of Italy. Despite his revolting past he turned into a loyal
supporter of the royal family. A description of the relief can be found on a plate next to it: Interestingly, when asking the pastor of the
local main church in Cima, Gian Giacomo even had a residence in Cima, right on the same spot where now a hotel stands which
probably was not called by chance Parco San Marco.
Emanuele Filiberto, duca di Savoia
(1528 - 1580)
Dizionario Biografico degli Italiani
di EE. Stumpo
EMANUELE FILIBERTO, duca di Savoia. - Nacque a Chambéry l'8 luglio 1528, terzogenito di Carlo II, duca di Savoia, e di
Beatrice di Portogallo.
Il 19 ottobre dello stesso anno, nella cappella della S. Sindone a Chambery, Carlo II volle che si celebrasse in forma solenne il
battesimo, secondo le antiche tradizioni sabaude e borgognone. Il signore di Bonnes Nouvelles, re d'armi dell'Ordine della Ss.
Annunziata, apriva il corteo, cui partecipavano il gran maestro dell'Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, Filippo di Villiers de l'Isle
Adam, ospitato dal duca di Savoia dopo la perdita di Rodi, con trenta cavalieri. Era uno dei padrini insieme con Margherita d'Austria,
governatrice dei Paesi Bassi, zia dell'imperatore Carlo V e vedova del predecessore di Carlo II, Filiberto II, e col re Emanuele di
Portogallo, padre della duchessa Beatrice. In un momento difficile per la situazione d'isolamento internazionale in cui si era trovato il
Ducato sabaudo, Carlo II aveva voluto sottolineare il ruolo, il rango internazionale e i legami dinastici dei Savoia, anche di fronte
all'atteggiamento ostile della stessa sorella Luisa, madre di Francesco I di Francia.
Di complessione assai gracile, il piccolo E. venne destinato inizialmente alla carriera ecclesiastica, mentre sul fratello maggiore Luigi,
nato nel 1524, si appuntavano le speranze di successione al trono, essendo morto in tenera età il primogenito Adriano. E dopo averlo
presentato a soli tre anni a Bologna, nel 1530, al pontefice Clemente VII, il duca di Savoia aveva ottenuto la promessa per lui della
nomina al vescovado di Ginevra e d'un posto nel Collegio cardinalizio, tanto che per qualche anno il giovanissimo principe venne
chiamato a corte "il cardinalino" e così vestito lo ricorda ancor oggi un quadro conservato a Torino, all'età di circa quattro anni. Dopo
i primi anni passati in Savoia E. visse qualche tempo a Torino e poi si ritirò con la madre Beatrice nella più sicura Nizza, dove restò
sette anni.
Furono, quelli, anni di gravissima crisi per il Ducato sabaudo: alla profonda incapacità politica di Carlo II si accompagnava infatti una
davvero scialba personalità che nel corso degli anni aveva portato il già scarso prestigio personale del duca ai livelli più bassi sia
presso le corti sia presso l'opinione pubblica del tempo. Lo stesso Pietro Aretino, nel suo Pronostico politico, osservava causticamente
nel 1534 che temeva di "perdere reputazione a mentovar Savoia, sendo così basso subbietto…" (E., a cura di C. Rinaudo, p. 32),
prevedendo per il duca la perdita di tutte le terre e la morte per veleno. E di terre in effetti Carlo II, eufemisticamente definito il Buono
dalla fin troppo benevola storiografia di corte, ne aveva già perse parecchie, alcune in modo invero paradossale. Già nel 1508 e nel
1511 il duca era stato costretto a riconoscere due false donazioni a favore dei Cantoni di Berna e Friburgo, prodotte da un suo
cancelliere e notaio ducale Jean Dufour, rifugiato presso gli Svizzeri; donazioni e concordati che gli costarono oltre 400.000 fiorini,
una grave perdita di prestigio e una vera e propria umiliazione presso sudditi e stranieri, unanimi nel condannare la sua debolezza.
Così quando nel 1530 Ginevra rifiutò il potere militare e temporale del duca, che l'esercitava a nome del vescovo, a nulla valsero i
tentativi militari di Carlo II. Ginevra si legò con i Cantoni di Berna e Friburgo, abbracciando l'eresia luterana prima, quella calvinista
dopo. E l'intervento militare degli altri Cantoni portò all'occupazione di altre terre ducali nel Vaud e nella Alta Savoia. La stessa
sorella del duca del resto, Luisa di Savoia, madre di Francesco I, iniziò ad avanzare pretese su molte terre ducali, come eredità
paterna, incoraggiando il figlio nelle richieste francesi su Asti e Ceva. La corte francese aveva tentato di opporsi inoltre al matrimonio
del duca con Beatrice di Portogallo, anche perché la sorella Isabella, andando sposa al neo eletto Carlo V, rendeva molto più stretti i
vincoli dei Savoia con l'Impero. E in effetti proprio il forte carattere della nuova duchessa Beatrice e il suo ascendente presso il
cognato avvicinarono Carlo II all'imperatore. A Bologna, nel 1530, egli ebbe un posto d'onore nella cerimonia dell'incoronazione di
Carlo V, il quale l'anno seguente, con abile mossa, concesse la contea d'Asti e il marchesato di Ceva alla duchessa di Savoia,
suscitando lo sdegno e l'avversione di Francesco I verso il duca sabaudo. Nel 1536 quindi l'esercito francese, sotto il comando di
Filippo di Chabod, mosse all'invasione del Ducato: la Savoia e gran parte del Piemonte furono occupate, la stessa Torino venne
rapidamente fortificata, i territori annessi al Regno di Francia, mentre Carlo II si rifugiava a Vercelli. Berna e Friburgo occuparono
allora il Paese di Vaud e il litorale del lago Lemano. Pochi mesi dopo Carlo V da Genova deludeva le aspirazioni del duca rigettando
le sue pretese di successione sul marchesato di Monferrato e pronunciando una sentenza favorevole a Federico Gonzaga. Inoltre, il 25
dicembre dello stesso e davvero infelice anno, il principe ereditario Luigi, educato in Spagna a corte insieme col cugino Filippo,
moriva improvvisamente: E., a otto anni, divenne così principe di Piemonte e l'unico erede al Ducato sabaudo.
L'educazione di E. venne radicalmente modificata: a Claude Louis Allardet, abate di Filly, che ne aveva curato la prima educazione si
affiancarono Louis de Châtillon, gran scudiere di Savoia e primo governatore, Giovan Battista Provana, poi vescovo di Nizza e
Aimone di Ginevra, signore di Lullin, che esercitò notevole influenza sul giovane principe, seguendolo poi fino alla corte imperiale e
nella battaglia di Ingolstadt. Esercizi fisici, giochi militari, equitazione, caccia, scherma occupavano quasi interamente le sue giornate,
alternandosi alle lezioni di cultura umanistica del maestro Giacomo Bosio, già precettore in Spagna del fratello Luigi.
Le sue letture possono in parte essere ricostruite dai codici poi passati alla Biblioteca reale: tra questi figuravano Dante, Petrarca,
Boccaccio, Cicerone, Tito Livio, mentre più tardi appaiono scrittori di arte militare quali R. Valturio, il De militia di L. Bruni,
Vitruvio, G. Busca e F. di Clèves.
Alcuni dolori funestarono la giovinezza di E.: nel 1537 moriva a Milano la sorella Caterina, l'8 genn. 1538 a Nizza la madre Beatrice,
lasciandolo erede universale. Della madre E. ebbe, secondo alcune penetranti osservazioni degli ambasciatori veneti, molti lati del
carattere: la fermezza, il coraggio, la fierezza nonché quel senso profondo della regalità che sudditi e nobiltà sabauda scambiavano per
"altierezza" (rimproveratagli del resto anche da alcuni suoi prigionieri illustri quali lo stesso G. de Coligny); ma che in realtà era un
senso profondo ed alto della sovranità e del legittimismo dinastico, da lui talvolta quasi volutamente accentuato, "…biasimando in
questo la natura del Duca suo padre, qual era tanto trattabile che ognuno se gli reputava compagno: dal che poi nasceva il poco
rispetto e la poca obedienza che gli prestavano" (Relazioni…, p. 96). Del resto l'influenza e certi tratti dell'eredità materna furono
riconosciuti dallo stesso principe, il quale così scriveva da Worms, nel suo primo soggiorno alla corte imperiale, al re di Portogallo nel
dicembre 1547 a proposito dei suoi difficili momenti: "…che pruovo disagii molto contrarii alla qualità di casa mia con tanto
cordoglio che senza ch'io mi trovo il cuore tanto gagliardo quanto l'ho portato dalle materne viscere mi sarebbe stato
insopportabile…" (L. Cibrario, Origine e progressi…, p. 245).
Nel 1541 E. era a Genova, con il padre, a rendere omaggio all'imperatore in partenza per l'impresa di Tunisi. Sembra che gli chiedesse
di prenderlo con sé nella pericolosa impresa; ma Carlo V, pur assicurandogli la sua protezione, lo invitò ad attendere la maggiore età.
Il 27 maggio 1545, con l'assenso imperiale, E. partiva finalmente alla volta della Dieta di Worms, recando un lungo memoriale sulla
triste situazione del Ducato sabaudo. Il 29 luglio venne ricevuto con gran benevolenza da Carlo V che gli confermò i suoi impegni
nella difesa del Ducato e nella volontà di ottenere la restituzione delle terre occupate dai Francesi. Conferendogli il collare del Toson
d'oro l'anno seguente l'imperatore lo nominò, appena diciottenne, comandante della cavalleria di Fiandra e Borgogna, alla vigilia della
guerra contro i protestanti. A Ingolstadt e a Mühlberg il giovane principe si condusse con abilità e valore, al comando della cavalleria
e in azioni di retroguardia. La corte imperiale lo aveva del resto ben accolto: il re dei Romani Ferdinando e la regina Maria d'Ungheria
lo aiutarono spesso, mentre simpatia e protezione gli mostrarono il Granvelle e più tardi il principe Filippo.
E. aveva dovuto tuttavia restringere al minimo le sue spese personali e la sua già piccola corte: furono quelli anni di bisogni e
necessità economiche quasi umilianti, ai quali ben poco potevano far fronte le sacrificatissime finanze ducali. Era costretto a rinviare i
giovani gentiluomini che principi e sovrani inviavano come paggi al suo servizio, confessando sinceramente di non avere i mezzi per
mantenerli. Da qui una lunga serie di richieste a parenti o famiglie amiche, verso le quali più tardi, come duca di Savoia, fu assai
legato. Tra questi la stessa regina Maria, il re di Portogallo, Ercole II d'Este e il cardinale di Trento C. Madruzzo.
Tra il 1548 e il 1550 E. fu a Bruxelles dove familiarizzò con il quasi coetaneo cugino Filippo di Spagna: tornei, feste e balli di corte li
videro spesso insieme, tanto che nel 1551 E. accompagnò Filippo nel viaggio di ritorno in Spagna. Tornato in Piemonte, egli si fermò
presso il padre a Vercelli e trascorse la primavera e l'estate di quell'anno combattendo contro i Francesi sotto il comando di Ferrante
Gonzaga e richiamando sotto le sue insegne i pochi nobili rimasti fedeli ai Savoia: Giovanni Amedeo Valperga di Masino, Giorgio
Costa della Trinità e Giovan Francesco Costa d'Arignano, Carlo Manfredi di Luserna, René de Challant, maresciallo di Savoia e
potente governatore della Val d'Aosta. Ma nell'agosto del 1552 raggiunse la corte imperiale in Baviera in compagnia di Claudio di
Savoia-Pancalieri e Andrea Provana di Leiny, convinto che solo presso Carlo V avrebbe potuto risolvere la gravissima situazione dei
domini paterni.
Nell'ottobre dello stesso anno partecipò allo sfortunato assedio di Metz, al comando della cavalleria fiamminga; l'esito negativo
dell'impresa costò la perdita del comando al duca d'Alba e per la prima volta nelle discussioni a corte per decidere la nomina del
successore venne fatto il nome di Emanuele Filiberto. Il suo nome venne fatto a Bruxelles anche per l'eventuale nomina a viceré di
Napoli, carica vacante per la morte di don Pedro de Toledo con una motivazione invero piuttosto abituale in quei tempi: la
popolazione e la nobiltà locale avrebbero preferito un principe del sangue a un semplice cavaliere quale era stato il viceré scomparso
(A. Segre-P. Egidi, E. F., I, p. 72). Caduta questa ipotesi, anche per la nomina al comando generale, Carlo V, pur sollecitato dalla
regina Maria, preferì nominare l'anziano Adriano di Croy, conte di Roeulx, il quale il 20 giugno investì e prese la cittadella di
Thérouanne. Ma il conte, già gravemente ammalato, morì pochi giorni dopo, lasciando nuovamente vacante il comando. Così il 27
giugno 1553 Carlo V rese pubblica la nomina di E. a luogotenente generale in Fiandra e a comandante supremo dell'esercito
imperiale.
L'elezione di E. era ormai attesa: nessuno a corte poteva vantare dignità e titoli pari ai suoi, nonché gli stretti legami di parentela con
la famiglia imperiale; e la nomina venne approvata dalle varie nazioni dell'esercito: Tedeschi, Fiamminghi, Spagnoli, Italiani. Poche
settimane dopo egli prese Hesdin, ai confini della Piccardia, difesa dal duca di Bouillon Robert de La Mack. E negli anni seguenti fu
un lungo succedersi di scontri e assedi in una guerra di piccoli movimenti e di scontri minori, tra una tregua e l'altra.
Che la nomina del principe di Piemonte al comando delle truppe imperiali fosse anche il risultato di un abile calcolo politico lo
confermarono gli avvenimenti successivi alla morte del duca Carlo II. Oramai quasi abbandonato da tutti il duca era morto nella notte
del 16-17 ag. 1553 a Vercelli e non fu possibile neppure procedere al funerale ufficiale: il corpo, chiuso in una semplice cassa, venne
trasferito nella cattedrale e lì rimase fino al 1637. Commosse dichiarazioni rilasciarono al principe sia Carlo V ("…egli pigliava tutti
quegli obblighi sopra di se' che deve il padre al figlio"), sia la regina Maria, la quale gli scriveva "…che se bene li era morto il padre,
non li era perciò morta la madre" (A. Segre-P. Egidi, E. F., I, p. 84). Ma in realtà gli impegni che chiese l'imperatore furono ben altri:
con un'assai singolare coincidenza il 15 luglio 1554 E. venne ufficialmente investito da Carlo V del Ducato di Savoia; un'investitura
certo formale essendo quasi tutto il Ducato in mano ai Francesi. Ma appena tre settimane dopo, ad Arras, il nuovo duca faceva
testamento: esecutori testamentari erano la regina Maria d'Ungheria, A. Perrenot de Granvelle e Rodrigo Gomez de Silva. Le
indicazioni assai precise e vincolanti: il giovane duca indicava nel cugino Giacomo di Savoia-Nemours l'erede di tutti i suoi Stati
"purché però abbandoni il servizio del re di Francia … e si sottometta nelle buone grazie dell'imperatore, dal quale dipenderanno detti
suoi stati e presti la dovuta obbedienza et ove non adempisse a quanto sovra entro un mese sia privato e investito erede universale
Filippo d'Austria figlio di detto imperatore principe della Spagna di lui cugino et prossimo cognato … il quale istituisce erede di detto
Giacomo morendo questo senza figliuoli … Datum in Castri cesarei Atrebartez in Arthesia" (Arch. di Stato di Torino, Real Casa,
Testamenti n. 7; trad. ital. dall'originale latino). Praticamente ignorato finora dalla storiografia sabauda tale testamento rivela
chiaramente il patto politico-diplomatico sotteso alla nomina di E. a capitano generale prima e a governatore generale dei Paesi Bassi
dopo: nel caso della sua morte la Spagna si sarebbe assicurata tutti i diritti di successione sul Ducato. Così il nuovo duca legava tutto
il futuro della casa sabauda esclusivamente alle proprie capacità da un lato e ad un futuro matrimonio dall'altro, facendo le più ampie
concessioni alla corte imperiale e alla Spagna.
Nel 1554 il richiamo del governatore di Milano Ferrante Gonzaga a Bruxelles fece intravedere a E. la possibilità di essere nominato al
suo posto, in Lombardia, con il comando delle truppe impegnate contro le forze francesi dislocate in Piemonte. La sua richiesta a
Carlo V e allo stesso Filippo, divenuto re d'Inghilterra grazie al suo matrimonio con Maria Tudor, fu disattesa. Filippo tuttavia volle
ricevere il cugino a Londra e la regina Maria gli conferì l'Ordine della Giarrettiera. Si parlò anche di un eventuale matrimonio fra E. e
la sorella della regina, Elisabetta, così come del resto qualche anno prima si era parlato a corte di un suo matrimonio con Margherita
di Francia, sorella di Enrico II. In realtà già nel 1541 era stata stipulata per E. una promessa matrimoniale dal duca Carlo II con
l'arciduchessa Maddalena, figlia del re dei Romani Ferdinando, futuro successore di Carlo V, con la quale E. si riteneva vincolato. Ma
il matrimonio inglese si rivelò un'ipotesi assai vaga; e del resto una breve parentesi si rivelò il trono inglese per lo stesso Filippo.
Pochi mesi dopo il soggiorno londinese le cattive notizie relative alla tragica situazione militare del Piemonte indussero E. a lasciare
Bruxelles, da dove, nel mese di maggio, si recò in forma privata a visitare Milano e Vercelli.
La situazione militare in Piemonte era ormai molto grave. Da un lato l'occupazione francese del paese, divenuto nel 1536 una
provincia del Regno, si era rivelata assai intelligente: sia il primo governatore Guillaume Du Bellay, l'illuminato amico di Rabelais,
sia Charles de Cossé di Brissac, governatore e comandante militare negli anni Cinquanta, avevano proibito saccheggi e ruberie,
alleggerito il carico fiscale, favorito il commercio con la Francia, aiutato con elargizioni in viveri ed elemosine la popolazione più
povera. Spesse volte gli abitanti dei luoghi sottoposti al governo ducale, o meglio spagnolo, emigravano per porsi sotto la protezione
dei gigli di Francia. Lo stesso E. fu costretto a riconoscere l'abilità di tale politica, soprattutto in confronto con quella, assai più dura e
costosa, del governo spagnolo. Alla notizia della morte del padre il principe aveva nominato René de Challant luogotenente generale
del Ducato e capo del Consiglio ducale. Le armi sabaude ormai tenevano soltanto Vercelli, Asti, Ceva, Fossano, Cuneo, Nizza, Ivrea e
la Val d'Aosta. Ma erano possedimenti isolati fra loro la cui difesa dipendeva più dall'impegno e dal valore dei singoli comandanti che
dalle truppe spagnole, poco propense ad offensive militari e abituatesi ad una guerra difensiva. Per poco, nell'autunno del 1553, non
cadde la stessa Vercelli, occupata sia pure per soli due giorni da un colpo di mano del Brissac: difesa e soccorsa da Asti, la città venne
rioccupata, ma nel frattempo i Francesi presero prigioniero lo stesso René de Challant e altri condottieri sabaudi.
La sorpresa di Vercelli causò la caduta del Gonzaga, richiamato appunto a corte; ma E:, preoccupato per la possibilità che i Francesi,
grazie a Challant, potessero occupare o invadere la Val d'Aosta, inviò in Piemonte Andrea Provana di Leiny con l'incarico di
assicurare la difesa della valle e riorganizzare il potere ducale nei territori ancora sabaudi. E in effetti la visita del Leiny e soprattutto
le poche somme di denaro che riuscì a procurarsi si rivelarono provvidenziali per la sicurezza della valle, così come il viaggio che
fece nelle altre città piemontesi e soprattutto a Nizza, di cui riorganizzò accuratamente le difese. Al Gonzaga ormai in disgrazia
successe come governatore di Milano il duca d'Alba, ma la situazione militare non migliorò certamente: l'abile Brissac riuscì a
prendere Santhià e poi la stessa Alessandria. Lo stesso E. non poté far altro che visitare Vercelli e raccomandare al nuovo governatore
i suoi territori: "…per dar qualche refrigerio ai miei sudditi, che si po' dir sono in extremis, a ponto di render il solo spirito che gli è
rimasto" (A. Segre-P. Egidi, E. F., I, p. 116). Ma il duca d'Alba si rivelò pessimo comandante in campo e crudele saccheggiatore in
campagna provocando le ire e le ritorsioni dei Francesi e la disperazione degli abitanti: il suo tentativo di riprendere Santhià e
l'abbandono della fortezza di Volpiano furono talmente mal condotti che crearono fra le truppe spagnole l'ingiurioso insulto: "Tu es
mas vigliacco que la retirada de Santhià". Fortuna volle che il duca d'Alba fosse nominato l'anno seguente (1555) vicerè di Napoli: al
suo posto in Lombardia vennero inviati il cardinale Cristoforo Madruzzo, vescovo di Trento, da anni molto legato a E., per il governo
civile e il marchese di Pescara Francesco Ferdinando d'Avalos per il comando militare.
Ma la tregua di Vaticelles, firmata il 5 febbr. 1556 fra Francia, Spagna e Impero, fu un colpo assai grave per le speranze di E., il quale
aveva cercato di opporsi sia presso Filippo a Londra sia presso Carlo V. Quest'ultimo tuttavia aveva già abdicato, con una solenne
cerimonia, il 23 ottobre, il governo dei Paesi Bassi al figlio; il 16 genn. 1556, pochi giorni prima della tregua, lasciò quello della
Spagna e dei regni collegati. Carlo V e la sorella Maria, che abbandonava il governo dei Paesi Bassi, si ritiravano in Spagna. La
tregua, probabilmente accettata da Carlo V per stanchezza, sarebbe durata cinque anni e prevedeva il mantenimento della situazione
militare de facto: nessuna ipotesi di restituzione per i ducati sabaudi, sia pur addolcita dalla consueta proposta matrimoniale per il
duca di Savoia con una principessa di Francia e dal pagamento di una pensione di 20.000 scudi l'anno da parte del re di Francia. La
delusione di E. fu profonda e le sue proteste vivissime, soprattutto presso Filippo II e i suoi stretti consiglieri: rifiutò come "principe
d'animo e signore legittimo" la pensione francese. Il nuovo sovrano di Spagna, tuttavia, continuò a protestargli la sua fiducia e
l'impegno nella difesa dei suoi interessi: così nello stesso mese ratificò la precedente nomina del duca a governatore generale dei Paesi
Bassi, con poteri assai ampi sul Consiglio di Stato.
Sicuramente fu importante l'esperienza di governo del duca nei Paesi Bassi sia pur assai limitata nel tempo e nei rigidi vincoli posti
dal sovrano spagnolo. Unico risultato notevole che E. riuscì ad ottenere, d'accordo con gli Stati provinciali, fu la riduzione dei tributi
straordinari di guerra, che gravavano quasi interamente sul paese, e il concorso del Tesoro spagnolo al pagamento dei debiti di guerra.
La tregua di Vaucelles si rivelò del resto assai più fragile del previsto: essa veniva rotta in Italia già nel novembre dello stesso anno e
l'esercito del duca di Guisa, penetrato in Italia, iniziava la sua marcia verso Roma e Napoli, grazie all'appoggio del pontefice Paolo IV
Carafa. Sul fronte franco-fiammingo le ostilità cominciarono nella primavera seguente; i Francesi del Coligny iniziarono i
combattimenti dalla Piccardia, ma E. poteva contare su un esercito rafforzato dall'alleanza che Filippo II, grazie al suo matrimonio
con la regina Maria Tudor, aveva saputo imporre all'Inghilterra. L'esercito imperiale pose l'assedio a San Quintino dove riuscì a
rifugiarsi il Coligny: nel tentativo di soccorrere la piazza già circondata, il conestabile Anne de Montmorency si fece sorprendere
dall'intero esercito di E. e venne clamorosamente sconfitto. Il conestabile e i migliori comandanti francesi, 16 pezzi d'artiglieria, 200
cavalieri e 4.000 fanti rimasero nelle mani dei vincitori.
Fu vera gloria per il duca di Savoia? Difficile certo penetrare nel velo di retorica e di propaganda che la storiografia sabauda ha steso
su tale impresa. D'altro canto il talento militare era in quegli anni ben diverso dalle capacità che la guerra di manovra richiese
successivamente in Europa. Allora da un comandante in capo si richiedeva per lo più nobiltà di nascita, autorità, prestigio, capacità di
mantenere ordine e disciplina più che una vera e propria esperienza strategica o tattica; questa la possedevano e la suggerivano i
diversi consiglieri militari. Di E. lo furono Antonio Doria e G. B. Castaldo mentre il principe d'Orange, il conte d'Egmont e il conte
d'Aremberg o il Gonzaga facevano parte del Consiglio allargato, al quale del resto potevano anche accedere il Granvelle e lo stesso
Filippo II.
Erano inoltre, quelli, anni in cui alleati, corpi di truppe, intere armate potevano muoversi con tempi diversi giungendo sul campo di
battaglia con ore e a volte giorni di ritardo: alla grande battaglia campale si giungeva più per caso che per volontà precisa d'una delle
due forze in campo.
Indubbiamente E. poteva vantare sicure doti di comando; il suo primo bando alle truppe imperiali, appena assunta la carica, rimase
celebre e fu durissimo: vennero proibite le assenze ingiustificate, controllati i registri delle mostre di tutti i reggimenti, allontanati dal
campo prostitute e vagabondi, introdotta la pena di morte per stupri, violenze e rapine a danno dei civili. A differenza di altri tale
bando venne applicato alcuni giorni dopo, quando, presa la fortezza di Hesdin, la fanteria spagnola s'impadronì del castello e lo
saccheggiò, violando una breve sospensione d'armi. E. fece arrestare il capitano delle compagnie insubordinate, inviandolo con i ferri
alle mani a Bruxelles e ordinò l'impiccagione di cinque fra i soldati più violenti: proprio quei soldati spagnoli che solo qualche giorno
prima, soddisfatti della sua nomina, gli avevano offerto la rinunzia di 1.000 scudi al mese sulle loro paghe per le spese della sua
carica. Così il suo stesso nome di battaglia, "Testa di ferro", pur essendogli stato dato dai Catalani a Barcellona (per la sua azione
nella difesa della città contro un tentativo di sbarco della flotta di L. Strozzi) fu diffuso soprattutto proprio tra i tercios spagnoli. Ma
l'applicazione del bando nulla tolse alla sua popolarità fra le truppe, grazie alla sua cura a dividerne disagi e impegni, secondo la
grande tradizione e il modello del marchese di Pescara: dalle marce forzate con i fanti alle notti nelle trincee, riposando "con la
medesima camicia bagnata, senza cavarsi stivali e speroni, per 30 giorni consecutivi" (Relazioni…, p. 207). E per quanto riguarda la
sua fermezza nel mantenere l'ordine fra le truppe, anche fra quelle più indocili, fece molto scalpore l'episodio del conte di Waldeck.
Nel settembre 1555, poco dopo lo scontro di Renty con l'esercito francese, E. confermò la condanna a morte di alcuni raitri del conte
di Waldeck, colpevoli di rapina e violenze, tra i quali un domestico del conte. Protestò il conte insolentemente il giorno dopo con E.,
davanti al suo reggimento, a cavallo, agitando un piccolo archibugio verso il duca; questi, respingendo l'arma, scaricò sul conte la sua
pistola, uccidendolo all'istante. La sera stessa il conte di Schwarzenberg e gli altri condottieri tedeschi invitarono E. ad un solenne
banchetto, mentre lo stesso Carlo V elogiava la fermezza del nipote nel Consiglio di guerra.
La vittoria di San Quintino fu in ogni caso un notevole avvenimento politico-militare: sia a E. sia a Filippo II fu poi rimproverato di
non aver saputo cogliere tutti i frutti dell'improvvisa vittoria. Ma in realtà tale accusa appare oggi ingiusta: anche una marcia vittoriosa
su Parigi, pur sempre difficile e pericolosa, non avrebbe certo potuto dare più di quello che il re di Spagna ed E. raccolsero con la pace
di Cateau-Cambrésis.
Anche sul fronte piemontese gli avvenimenti militari si erano mostrati in effetti favorevoli: Cuneo, brillantemente difesa da Carlo
Manfredi di Luserna, resistette all'assedio francese guidato dal Brissac dal 3 maggio al 27 giugno. L'esercito francese dovette infine
abbandonare l'assedio per il sopraggiungere delle truppe spagnole al comando del marchese di Pescara, lasciando tutti i bagagli, molti
feriti e circa 3.000 morti.
Le trattative di pace, benché lunghe e complicate, erano favorite dallo stesso Montmorency e da Enrico II nonché dai successi del
Guisa, che, costretto ad abbandonare l'impresa italiana, aveva riconquistato alla Francia la città di Calais. Ai primi di aprile 1559
veniva firmata la pace tra Francia, Inghilterra e Spagna. I domini sabaudi erano restituiti al duca di Savoia, salvo cinque piazzeforti
che sarebbero rimaste alle truppe francesi per tre anni e due, Asti e Santhià, al re di Spagna. La giovane figlia di Enrico II, Elisabetta,
avrebbe sposato Filippo II mentre Margherita, sorella del re, era destinata ad E., il quale in realtà avrebbe preferito l'altra figlia di
Enrico, Claudia, assai più giovane della pur nota e ammirata zia. Inoltre, grazie al ricco bottino e ai riscatti dei prigionieri (il solo
Montmorency pagò 200.000 scudi) e alla dote di Margherita, la pace diede qualche ristoro alle sempre esauste finanze di Emanuele
Filiberto. Tuttavia al trattato pubblico Filippo II volle aggiungere alcuni patti segreti, concordati fra i due sovrani il 26 marzo nel
convento di Grunendal, presso Bruxelles. Quasi apponendo una postilla al suo testamento del 1554, E. si impegnava infatti a
mantenere due guarnigioni a Nizza e Villafranca, pagate dal re di Spagna con castellani fedeli al re e al duca, e a lasciare le due
località, preziose per la marina spagnola, al re di Spagna, in caso di sua morte senza eredi.
E. entrava poco dopo a Parigi il 21 giugno 1559 con un seguito di duecento gentiluomini, "tout accoutrés en velours violet cramoisi,
deublé de toile d'or e avec velours noir"; nero, rosso, oro, colori di Margherita di Francia (A. Segre-P. Egidi, E. F., II, p. 3). Tra questi
René de Challant, Claudio, Bernardino e Filippo di Savoia-Racconigi, i conti di Masino, d'Arignano, della Trinità. Enrico II lo
ricevette con grande amabilità, incontrandolo fin quasi sulla soglia del palazzo reale e lo stesso giorno il re gli presentò la sorella
Margherita. La principessa aveva da poco compiuto trentasei anni: allevata e educata dalla zia Margherita d'Angoulême, poi regina di
Navarra, era divenuta ben presto la protettrice dei poeti e degli artisti della corte di Francia, Ronsard e Du Bellay, i poeti della Pléiade,
Michel de L'Hospital, illustri giuristi quali H. Doneau e J. Cujas frequentavano la piccola capitale del suo ducato di Berry, Bourges,
celebrando nella principessa la più illustre e ammirata donna di Francia. Il 27 giugno furono firmati i capitoli matrimoniali tra i
delegati del re e quelli del duca di Savoia. Ma tre giorni dopo in una giostra cavalleresca corsa per celebrare le grandi feste
matrimoniali Enrico II veniva mortalmente ferito. L'agonia del sovrano francese durò diversi giorni: egli stesso volle che si
concludesse il matrimonio della sorella, che fu in effetti celebrato in forma privata nella notte del 9 luglio, poche ore prima della
morte del re.
La morte di Enrico II, se negli anni si rivelò un indubbio vantaggio per il duca sabaudo, favorendo indirettamente un lungo periodo di
pace e una sostanziale debolezza del potere regio in Francia, nell'immediato lo privò di un sicuro e prezioso alleato, sia nelle sue
regioni verso Ginevra e i territori occupati dagli Svizzeri, che egli si era impegnato a difendere, sia nelle trattative per la restituzione
delle piazze occupate, prolungate nel tempo dai suoi successori e da Caterina de' Medici fino al 1574.
Nel mese di agosto E. tornò nelle Fiandre per cedere il governo a Margherita Farnese; quindi si congedò da Filippo II, in partenza per
la Spagna, e, dopo aver assistito a Reims alla consacrazione del nuovo sovrano francese Francesco II, ricevendo il collare dell'Ordine
di S. Michele, s'imbarcò finalmente a Marsiglia per Nizza.
Il ritorno in Piemonte avveniva in condizioni ancora estremamente difficili. Certamente appare ancor oggi difficile un'obiettiva
valutazione dell'azione di E., al di là dell'agiografia e delle sopravalutazioni di tanta storiografia sabauda. Tuttavia occorre considerare
come il Piemonte del 1560 fosse praticamente tagliato e diviso dal marchesato del Monferrato da un lato e da quello di Saluzzo
dall'altro. L'accesso verso la preziosa contea di Nizza era controllato dalla contea di Tenda, feudo imperiale tenuto da un ramo
bastardo dei Savoia legato alla Francia. Torino, Chieri, Pinerolo, Chivasso e Villanova d'Asti erano guardate da truppe francesi, Asti e
Santhià da truppe spagnole. Verso Ginevra i Cantoni di Berna e Friburgo continuavano ad occupare i territori presi nel 1536: il Vaud,
il Gex, il Chiablese e il basso Vallese con Romont. All'interno un paese duramente stremato per i pesanti costi della guerra, con
un'economia in larga parte solo agricola, una società ancora divisa fra partigiani francesi o spagnoli, una popolazione fortemente
legata al precedente governo francese, dimostratosi assai più moderato e illuminato di quello sabaudo, mentre sempre più acuto era
diventato il problema religioso, sia per l'influenza ginevrina e francese (Delfinato e Linguadoca) sia per la questione valdese,
riaccesasi nelle valli del Pellice e del Chisone.
Sicuramente sia nella politica estera sia in quella interna l'esempio degli insuccessi paterni condizionarono con forte evidenza molte
decisioni di E., così come grande influenza si può attribuire alla sua personale esperienza di governo e di comando in Germania e nei
Paesi Bassi. La pace e i trattati con gli Svizzeri divennero l'asse portante della sua politica estera così come il mantenimento
dell'equilibrio fra Francia e Spagna il suo obiettivo di lungo periodo.
Ma la pacificazione all'interno dello Stato fu il primo compito di E.: a Nizza e poi durante il suo primo viaggio nel Piemonte fu largo
di riconoscimenti verso le città e i sudditi più fedeli. A Nizza volle lasciare le bandiere conquistate a San Quintino; verso Cuneo fu
largo di concessioni e privilegi, mentre alle cariche di corte e di governo chiamò gli esponenti di quella nobiltà feudale e degli uffici
che già avevano servito nel paese o fuori. Mancavano tuttavia gli uomini; anche dalle relazioni degli ambasciatori veneti E. appare
isolato, quasi ansioso di dare e ricevere informazioni, notizie, idee, progetti. Ben poche sono le persone che riceveva a corte o delle
quali si circondava nel Consiglio di Stato e di cui accettava eventuali suggerimenti o consigli. Precisa e l'osservazione su tale
mancanza: "Non vi è in questa corte uomo di gran maneggio e di molto spirito … son persone tutte nuove al governo … vanno
dubitando sopra ogni cosa e mai non si risolvono" (Le relazioni…, p. 326).
Cosi i personaggi sono sempre gli stessi: il segretario H. Michaud, già nel suo seguito nelle precedenti campagne, G. Tommaso
Langosco di Stroppiana, nominato nel 1560 gran cancelliere, Giovanni Fabbri segretario di Stato, Cassiano Dal Pozzo presidente del
Senato, il vecchio maresciallo di Savoia René de Challant, i pochi antichi combattenti, Amedeo Valperga, Carlo Manfredi di Luserna,
Giorgio Costa della Trinità, qualche giurista come Giovanni Matteo di Cocconato o G. Cacherano d'Osasco, persino l'antico precettore
di E., Luigi Alardet, vescovo di Mondovì. Tutti utilizzati nelle lunghe e complesse trattative delle restituzioni delle piazze, o nelle
negoziazioni con gli Svizzeri e gli Stati italiani o in altre missioni diplomatiche. E in alcuni posti chiave, dove erano richieste davvero
capacità e conoscenze specifiche, il duca chiamò qualche tecnico: il genovese Negrone Di Negro, da lui conosciuto nelle Fiandre,
nominato tesoriere generale, il giurista Pierino Belli diplomatico e consigliere di Stato, lo spagnolo Diego Hortiz de Pros, creato
contadore generale delle genti di guerra, ufficio da lui già svolto sotto Carlo V, o il piacentino G. A. Levo, veterano delle Fiandre,
nominato sergente maggiore della nuova milizia.
E ancora una volta a corte o al servizio di E. vecchi compagni d'arme o rappresentanti di famiglie amiche e legate ai Savoia. I buoni
rapporti intrattenuti con lui dal cardinale Madruzzo in Germania vennero ricompensati con la nomina del nipote Giovanni Federico a
colonnello della fanteria tedesca, ma soprattutto dando in moglie a questo l'unica erede di René de Challant, il più potente e ricco
feudatario sabaudo, arbitro dell'intera Val d'Aosta. Filippo d'Este ebbe la nomina a generale della cavalleria e la mano della figlia
naturale del duca, Maria. E Andrea Provana di Leiny il governo di Nizza e il comando delle quattro galere sabaude, con tre delle quali
si distinse poi a Lepanto. Uomini d'arme di solida e provata esperienza certo, ma utilizzati di volta in volta ora in incarichi
diplomatici, ora nelle trattative con gli Stati generali, ora nella repressione dell'eresia. Emblematico per certi versi il ricorso a Giorgio
Maria Costa di Trinità, il più noto e fedele combattente sabaudo e imperiale nelle guerre contro i Francesi. Nel 1560 fu nominato sì
"generale maestro di campo delle Milizie dette ordinamenti ducali", ma pochi giorni dopo veniva incaricato dal duca di condurre le
trattative con gli Stati generali, convocati a Racconigi, per stabilire l'aumento della gabella del sale. E tre mesi dopo promosso
"capitano generale dell'impresa contro i Valdesi". Incarico assai poco gradito dal Costa che così scriveva al duca "…et Ella vorrà ch'io
pigli la croce in spalle questo … per amor di Dio et per far servitio di V. A. lo farò…" (Diz. biogr. d. Ital., XXX, sub voce).
La scelta del Costa non fu certo casuale: uno dei primi atti di E. fu proprio lo scioglimento degli Stati generali rivelatisi già con Carlo
II inadeguati e incapaci di sostenere la volontà del principe, soprattutto per la mancata concessione dei tributi militari e straordinari
richiesti in occasione dell'invasione svizzera e di quella francese. Convocati per l'approvazione dell'aumento della gabella del sale,
aumento poi trasformato in un'imposta fondiaria diretta, il tasso, simile alla taglia francese, gli Stati non furono mai più convocati.
Giustificato in diversi modi dalla storiografia ottocentesca, in realtà tale atto fu dovuto proprio al profondo disprezzo che il nuovo
duca, sovrano autoritario e assoluto, aveva maturato verso tali forme di rappresentanza politica sia nelle Fiandre sia nelle passate
esperienze piemontesi.
Molto più attenta e avveduta si rivelò nei primi anni invece la politica di repressione dell'eresia in Savoia e in Piemonte.
L'occupazione francese aveva comportato in effetti molta tolleranza sia verso la propaganda calvinista e protestante sia verso i forti
gruppi valdesi attivi nelle valli alpine. Sollecitato dalla S. Sede e dallo stesso Filippo II, il nuovo duca favorì indubbiamente la
repressione di tali gruppi, anche perché personalmente convinto che le guerre di religione, così come era successo in Germania e stava
avvenendo nella vicina Francia, avrebbero gravemente minato l'autorità sovrana, favorendo le lotte civili.
In un primo tempo il duca pensò ad una vera e propria spedizione punitiva nelle valli valdesi, affidandone appunto il comando al
Costa. Ma la resistenza dei valdesi, i possibili coinvolgimenti degli ugonotti del Delfinato, le mediazioni dei principi protestanti
tedeschi, ma soprattutto i tentativi di mediazione operati nella stessa corte dalla duchessa Margherita e da Filippo di Savoia-Racconigi
spostarono i termini del conflitto. Il 5 giugno 1561, dopo lunghe trattative, si arrivò ad un accordo firmato nel castello di Cavour fra i
rappresentanti ducali e quelli valdesi: questi ottennero piena amnistia e libertà di culto nelle valli, estesa anche ai cattolici; fuori dalle
valli solo libertà di coscienza. Il trattato di Cavour, che il duca volle ufficialmente proclamato "ad intercessione della serenissima
Madama nostra principessa et per grazia soa speciale", "restò per oltre due secoli la carta della libertà religiosa dei valdesi. E in effetti
fu un'abile concessione del nuovo duca.
Egli, ricordano gli ambasciatori veneti, sentendosi principe profondamente religioso e intimamente cattolico, aveva vissuto come
uomo d'arme e vero cristiano. Destò sorpresa il suo trascorrere la notte della vigilia della presa del comando supremo, nel 1553, nel
monastero di S. Paolo, quasi nuova investitura di armi; ma altri giorni aveva trascorsi in ritiro e in preghiera, due anni prima, nella
celebre abbazia di Monserrato, vicino Barcellona, dove già erano stati Consalvo di Cordova, Fernando d'Avalos, lo stesso Carlo V, e
Ignazio di Loyola.
E tuttavia il suo atteggiamento nei confronti della riforma protestante fu singolarmente prudente. Prudenza assai probabilmente dovuta
alla sua esperienza presso la corte cesarea, osservatorio privilegiato per rendersi conto della gravità e dei pericoli legati all'eresia, ma
d'altro canto della vanità e dell'inutilità di una repressione armata. Affermava quindi che: "…la religione cristiana non fu mai piantata
con la forza degli eserciti né colla violenza delle armi; ma ben con la verità del Verbo…" (Ricotti, p. 413). E così del resto scrisse, nel
1565, con notevole lucidità politica alla corte di Madrid, che lo aveva rimproverato per il perdono concesso ai valdesi di Caraglio:
"…questi modi di riavere gli eretici … riusciranno assai migliori. Perciocché, facendogli morire ne nascerà tumulto e sollevazioni, e,
lasciandogli fuggire, non guadagniamo le anime e perdiamo le persone, facciamo disabitare il nostro Stato e popoliamo l'altrui…"
(Arch. di St. di Torino, Lettere ministri, Spagna, 1565). Saggio consiglio che lo stesso Filippo II avrebbe potuto seguire anni dopo. E
così ancora di fronte alle insistenze di Pio V e dell'Inquisizione di Vercelli per far eseguire la condanna al rogo di un frate relapso,
Giorgio Olivetta, così scriveva a Roma: "…Non basta né conviene di questi tempi bruciare un uomo, la cui morte non farà li buoni
essere migliori, ma si bene li mali essere peggiori e più ostinati… Ma posso io far quel che non possono i re di Francia e Spagna? …
So bene che tollerare eretici è pericolosissimo … ma non bisogna ingannarsi. Castigarli tutti a me è impossibile, abbruciarne alcuni
infiamma crudelmente gli altri alla vendetta. Sicché … il mio parere è … che si abbia da usare della mediocrità tanto necessaria in
questi tempi, castigando, non disperando … (Ricotti, p. 320).
Nel 1561 la corte ducale si stabiliva a Rivoli, in attesa della restituzione di Torino e delle altre piazze occupate dai Francesi. Le
trattative furono lunghe e difficili, poi la nascita dell'erede al Ducato, Carlo Emanuele, il 12 genn. 1562, favorì gli interessi sabaudi. Il
7 febbr. 1563 E. fece il suo ingresso ufficiale nella città di Torino, con la duchessa Margherita, proclamando la città capitale dello
Stato e sede della corte.
L'esperienza militare di E. e quella acquisita nel governo dei Paesi Bassi avevano radicato in lui la ferma convinzione che solo un
forte esercito e una solida struttura finanziaria gli avrebbero permesso la conservazione dello Stato. Da qui le sue cure, già dai primi
mesi del ritorno in Piemonte, a Nizza e poi a Vercelli, per una riforma del sistema fiscale e per la creazione di una struttura militare
permanente. L'aumento della gabella del sale, l'introduzione del tasso, le gabelle dei consumi del vino e della carne, quelle sul
commercio d'esportazione e di transito fecero in effetti crescere notevolmente il gettito delle imposte. In pochi anni la Tesoreria
generale di Piemonte, grazie anche all'oculata gestione del duca, poteva vantare un saldo attivo che andava negli anni ad incrementare
una riserva monetaria notevole. Da qui una certa impopolarità dello stesso E., ben colta da alcuni ambasciatori veneti, proprio per la
forte e accresciuta presenza del governo ducale, in stridente contrasto sia con la precedente debolezza del governo di Carlo II sia con
la moderazione osservata dai governatori francesi. L'occupazione francese inoltre era stata caratterizzata da forti spese militari nel
Piemonte, mentre l'avveduta gestione finanziaria del nuovo duca limitava molto e le spese di corte e quelle militari.
Molto è stato scritto sulla riforma militare di E. e sull'introduzione della milizia ovvero su una sorta di leva militare alla quale erano
tenuti tutti i sudditi compresi fra 1 18 e i 50 anni. Già utilizzata nella Terraferma veneta, con il nome di cernite, teorizzata da
Machiavelli per Firenze, ripresa da Cosimo I in Toscana, con le note bande provinciali, essa aveva essenzialmente due scopi: evitare o
almeno ridurre il ricorso alle truppe mercenarie, che costituivano allora il nerbo degli eserciti permanenti; abituare i sudditi
all'esercizio delle armi per l'eventuale difesa del paese. Ma E. sapeva benissimo quanto poco potessero valere semplici contadini in
una vera battaglia, come aveva lui stesso scritto, anni prima, a Filippo II: "… ya sabe V. M. cosa son villanos …" (A. Segre-P. Egidi,
E. F., II, p. 15). Ma sapeva altrettanto bene cosa potesse significare presso le altre corti italiane ed europee la semplice notizia che
oltre a contingenti svizzeri e a condottieri italiani "trattenuti" il duca di Savoia poteva contare su circa 22.000 uomini della milizia
nazionale d'ordinanza. E in effetti l'organizzazione e la struttura della milizia, affidata al piacentino G. A. Levo e al vicentino G.
Piovena includeva uomini d'arme, condottieri e capitani assoldati dal duca in tutta Italia. L'effetto propagandistico fu notevole: sia
pure scettici sul valore di tali milizie tutti gli ambasciatori veneziani, francesi e spagnoli fecero a gara per rilevarne numero e
consistenza. Il regolamento a stampa fu diffuso in Italia e all'estero, giungendo persino in Portogallo e ogni occasione ufficiale fu dal
duca sfruttata per mettere in mostra e propagandare la milizia d'ordinanza. Nel 1566 mille uomini furono inviati all'imperatore
Massimiliano in guerra contro i Turchi; l'anno seguente altri 6.000 uomini furono inviati in Francia per combattere contro gli ugonotti;
nel 1574, in occasione del passaggio in Piemonte del nuovo re di Francia Enrico III, E. lo fece scortare via via da un complesso di
10.000 fanti e 2.000 cavalieri, dei quali 5.000 servirono il re di Francia con R. de Bellegarde all'assedio di Livron.
Uguale cura e attenzione il duca mostrò verso il sistema di fortificazioni che difendeva i punti chiave del Ducato. A Nizza, Bourg-enBresse, Saint-Julien, Montmélian furono innalzate nuove fortezze; a Mondovi e Santhià nuove cittadelle, così come a Torino. Qui il
duca commissionò agli architetti F. Orologi e O. Paciotto la costruzione di una nuova cittadella, che venne innalzata in soli due anni,
fra il 1564 e il 1566.
Ma soprattutto E. pensò di utilizzare il suo stesso prestigio e la fama conquistata sul campo per tessere una fitta rete di rapporti
diplomatici che garantissero allo Stato un lungo periodo di pace. Perno della sua strategia fu l'intesa con i Cantoni svizzeri, grazie alla
quale poteva assicurarsi la loro neutralità in caso di guerra, il reclutamento di truppe professionali e addestrate, trattati commerciali
che assicuravano l'esportazione dei principali prodotti del paese, soprattutto quelli agricoli.
E. iniziò già nel 1560 a trattare con i Cantoni cattolici firmando con essi un primo trattato a Lucerna, che garantiva la libertà di
traffico fra i due contraenti, il divieto di transito a eventuali truppe nemiche e il reclutamento di un piccolo contingente per la guardia
del corpo del duca. Con Berna e Friburgo le trattative erano articolate dal contenzioso sui territori ducali occupati dai due Cantoni e
dalle richieste sabaude: tuttavia E. preferì cedere a Berna i territori a occidente, tra cui il Vaud e Losanna, recuperando invece il
Genevese, il Gex e lo Chiablese. La questione ginevrina fu lasciata da parte, mentre il duca assicurava la tolleranza religiosa ai
riformati dei territori restituiti. Quest'ultima clausola del trattato, firmato a Losanna nel 1564, provocò le proteste della S. Sede e dello
stesso Filippo II, che rifiutò a lungo di ratificare l'accordo. Solo tre anni dopo, nel 1567, in occasione della richiesta di transito fatta a
E. per le truppe spagnole inviate da Milano nelle Fiandre, Filippo Il concesse la ratifica, insieme con Pio V. Altri accordi E. continuò
a stipulare con Friburgo, Berna e gli altri Cantoni cattolici, ora cedendo qualche territorio, ora ottenendone indietro altri, rinnovando
accordi commerciali, spesso contro l'opposizione pontificia, fino alla pace firmata a Torino nel 1577, con Friburgo e la Lega cattolica,
che prevedeva in caso di guerra di poter assoldare ben 12.000 fanti svizzeri, impegnandosi il duca a sua volta a fornirne 1.500 e
sussidi in denaro ai Cantoni.
Con gli Stati italiani E. tenne una politica altrettanto accorta. Già prima del rientro in Piemonte inviò una legazione permanente a
Venezia, con la quale i Savoia avevano interrotto le relazioni alla fine del Quattrocento a causa delle loro rivendicazioni sul Regno di
Cipro. Venezia quindi stabilì in Piemonte un'ambasciata regolare e durante il governo di E. ben sette ambasciatori si alternarono a
Torino, lasciando nei loro dispacci e nelle loro relazioni una ricchissima descrizione sia del paese e del governo del duca sia della
personalità dello stesso Emanuele Filiberto.
L'attenzione di E. verso Venezia fu costante; due volte fu nella città, nel 1566 e nel 1574, ottenendone il patriziato e volle che la
Repubblica facesse da madrina al battesimo del principe Carlo Emanuele nel 1567. E in occasione della Lega santa, che portò alla
vittoria di Lepanto, volle che le tre galere del nuovo Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, al comando di A. Provana di Leiny,
partecipassero alla campagna insieme con la flotta veneziana. Buoni rapporti mantenne con gli Estensi e i Della Rovere, mentre quelli
con il duca di Mantova restarono sempre assai difficili per le aspirazioni sabaude alla successione del marchesato di Monferrato.
Nelle relazioni con la S. Sede E. giocò quasi sempre con successo la carta del pericolo protestante, avvalendosi della delicata
posizione del Ducato, confinante con i Cantoni svizzeri riformati e con le province francesi più dichiaratamente ugonotte come il
Delfinato e la Provenza.
Ciò permise, giostrando abilmente con i diversi pontefici e soprattutto con Gregorio XIII Boncompagni, di ottenere numerose
concessioni: il riconoscimento del celebre indulto concesso da Niccolò V ai Savoia, che per i benefici e le nomine del Ducato
prevedeva il placet del duca e l'amministrazione ducale dei benefici vacanti; la ratifica della pace di Cavour con i valdesi e quella del
trattato di Losanna con gli Svizzeri; la vendita dei benefici ecclesiastici dei territori recuperati agli Svizzeri a favore dell'Ordine
mauriziano; l'unione dell'Ordine di S. Maurizio con quello di S. Lazzaro, con le relative ricche commende; l'introduzione della norma
del tribunale competente, che proibiva ai sudditi di comparire di fronte a tribunali stranieri e quindi a quelli ecclesiastici, poi mitigata,
di fronte alla reazione romana, con quella della appellazione per abuso, che dichiarava il Senato di Piemonte tribunale supremo di
appello.
Certamente tali successi furono il frutto di altrettante concessioni: coerente con l'immagine del principe e sovrano cattolico, E. favorì
l'introduzione dei canoni tridentini in Piemonte (ma non in Savoia), fu largo di concessioni e privilegi verso i nuovi collegi dei gesuiti,
sostenne le ragioni della S. Sede su Avignone, minacciata dagli ugonotti, inviò più volte le galere mauriziane in crociera con quelle
pontificie nel Mediterraneo.
Ma indubbiamente l'attenzione di E. fu in questi anni assorbita più dallo scenario internazionale che da quello italiano. Il
mantenimento della pace tra la Spagna e la Francia fu il suo obiettivo immediato; e con gli anni la sua neutralità divenne forse ancor
più accentuata, probabilmente proprio a causa della grave situazione di debolezza della corte francese e delle guerre di religione. Più
volte incontrò in Francia la regina Caterina e diversi esponenti della Lega o del partito dei Montmorency, dimostrandosi abile
mediatore, ma pur sempre sostenitore dei diritti della Corona francese. Tale azione non mancò di suscitare a Madrid numerosi
sospetti, ma la ricca corrispondenza del duca con Filippo II testimonia una solidità di rapporti che solo la conoscenza diretta fra i due
principi può spiegare.
Interpellato spesso da Madrid direttamente o tramite i diversi governatori generali di Milano, E. suggeriva dove fare nuovi
arruolamenti in Italia; garantiva una via diretta per le Fiandre ai tercios della penisola; custodiva nel castello di Nizza le loro paghe
per un valore di 2.000.000 di scudi d'oro; offriva la sua stessa persona al sovrano spagnolo per il comando militare della Lega santa.
Ma in questo caso Filippo II rifiutò: voleva uno spagnolo al comando dell'impresa gloriosa e soprattutto non voleva che il Ducato, in
posizione così delicata e in un momento grave per le guerre di religione in Francia, venisse governato da Margherita di Francia, dalle
simpatie protestanti così apparentemente manifeste ai suoi occhi.
Nel 1574 E. si recò, d'intesa con la regina Caterina, a Venezia per incontrare il nuovo sovrano francese Enrico III e scortarlo poi sino a
Lione. Lo scopo del duca era sin troppo evidente: voleva persuadere il giovane re ad acconsentire alla cessione delle due ultime
piazzeforti conservate dai Francesi in Piemonte, Pinerolo e Savigliano. Ma subito dopo la breve permanenza a Torino del nipote
Enrico III, presso il quale indubbiamente la duchessa esercitò tutta la sua influenza per ottenere la promessa della restituzione delle
due piazze, Margherita si ammalò gravemente. Il duca ricevette la notizia della malattia in Francia, a Lione, dove aveva
accompagnato con un largo seguito militare il sovrano francese e dove finalmente aveva ottenuto la tanto attesa promessa di
restituzione. Ma al suo rientro a Torino la duchessa era già morta.
"Muger de gran spiritu y inteligencia… muger que no dorme", come sottolineava il pur ostile residente spagnolo a Torino G. Vargas,
Margherita di Francia aveva esercitato una grande influenza su E., profondamente amato, tanto da far ammettere lei stessa a corte due
suoi figli naturali, allevati segretamente fuori Torino. Fu lei indubbiamente a rafforzare lo spirito di tolleranza religiosa del duca, in lui
certo molto più politico che reale; mentre sicuramente minore fu la sua propensione verso la causa francese, tanto temuta a Madrid,
probabilmente anche per la grave crisi politica della monarchia in Francia. E tuttavia il suo matrimonio e il suo legame con il marito
avevano accresciuto il prestigio e l'influenza personale del duca in Francia. Lo testimoniano la frequentissima corrispondenza fra la
corte francese e Torino, le numerose richieste di mediazione fra la corte e alcuni principi e marescialli ribelli, quali il Bellegarde o il
duca di Daniville, le stesse richieste pontificie al duca a favore di Avignone.
Dopo il 1574 l'attenzione di E. verso gli affari interni francesi si fece nettamente più marcata: le province meridionali del regno erano
ormai in aperta rivolta. D'altro canto sia con il maresciallo Henri de Montmorency, duca di Damville, figlio del suo antico prigioniero
di San Quintino, governatore di Linguadoca, sia con il maresciallo di Bellegarde governatore di Carmagnola e quindi del marchesato
di Saluzzo, egli aveva sempre avuto innumerevoli contatti. Nel 1577, dopo l'ennesimo patteggiamento con la corte, mediato dal duca,
il Damville si avvicinò alla lega dei Guisa, il Bellegarde agli ugonotti. Quest'ultimo, pur di non cedere Saluzzo al nuovo governatore
reale Carlo Birago, l'occupò militarmente, con il tacito appoggio di E. e di Filippo II. Ma nello stesso anno il Bellegarde morì
improvvisamente: pochi mesi dopo E. fece occupare il marchesato dalle truppe di Ferrante Vitelli, tenendolo "a nome del re di
Francia" e suscitando le proteste francesi e dello stesso Filippo II. Probabilmente desiderata da tempo, l'occupazione di Saluzzo fu
tuttavia un'operazione assai intempestiva e mal condotta, soprattutto a livello diplomatico. L'incertezza degli avvenimenti francesi
aveva reso molto scettico verso la corte di Parigi lo stesso E.; la debolezza della monarchia lo privava di una valida alternativa
all'alleanza spagnola, sempre pesantemente vincolante. Così, incerto se intervenire direttamente negli affari francesi, magari per
strappare questa o quella provincia confinante, E. non riusciva neanche a decidere tra le varie proposte matrimoniali per il figlio,
l'appena diciottenne Carlo Emanuele. Filippo II offriva la mano della Infanta Caterina, la corte imperiale l'arciduchessa Isabella,
quella di Parigi la principessa di Lorena.
D'altro canto più volte E. aveva manifestato l'intenzione di ritirarsi a Nizza, lasciando il governo a Carlo Emanuele, forse influenzato
dal grande esempio di Carlo V. Ma lui stesso si rendeva conto che il pericolo ugonotto ai confini francesi, la delicata situazione del
marchesato di Saluzzo, l'arroganza del governo spagnolo in Lombardia richiedevano la sua attiva presenza a Torino. Già sofferente da
anni di malaria e di insufficienza renale, aveva però ostinatamente perseverato in una dieta assai inadatta, privilegiando
esclusivamente le carni e i pesanti vini spagnoli, di cui aveva sempre abusato. Nell'agosto del 1580 sopraggiunse una forte febbre, con
edema alle gambe. Assistito dalla figlia Maria e dai fedelissimi Provana e Della Torre, ricevette il 30 ag. 1580 l'unzione
dall'arcivescovo G. Della Rovere, spegnendosi poche ore dopo, a Torino.
Rottura e continuità avevano caratterizzato l'azione di E.: forse si è insistito da parte di certa storiografia nel cogliere più gli elementi
di rottura con la situazione precedente che quelli di continuità. E indubbiamente lo scioglimento degli Stati generali, le innovazioni
finanziarie e monetarie, l'introduzione di nuovi tribunali come le prefetture, la creazione di una milizia nazionale costituirono un
nuovo assetto dello Stato sabaudo. Pure E. volle conservare i grandi tribunali introdotti dai Francesi, mutandone semplicemente il
nome in Senato di Savoia e di Piemonte; le Camere dei conti di Savoia e Piemonte restarono nel campo finanziario e contabile i
supremi organi di controllo e verifica dell'attività governativa. E numerosi certo furono i tentativi volti a privilegiare lo sviluppo
economico e commerciale del paese; ma non diversi o più originali di quelli che pure venivano portati avanti negli altri Stati italiani
del tempo. Privilegi alle arti, concessioni a mercanti e banchieri, tentativi d'introdurre l'arte della lana e quella della seta, aperture per
chiamare nello Stato gli ebrei cacciati dalla Spagna, sviluppo del porto di Nizza, spesso si rivelarono piuttosto fragili speranze che
progetti concreti, del tutto simili a quelli che si tentavano nella Toscana medicea o nella stessa Roma pontificia. Né miglior fortuna
ebbe del resto la pur intelligente riforma monetaria, introdotta per rimediare ai gravi inconvenienti che le monete di basso conio e le
diverse monete di conto recavano alla debole economia del paese. Ma la lira ducale d'argento, pur effettivamente coniata, divenne
praticamente una sia pur utile moneta di conto; l'inflazione e la svalutazione monetaria restarono, aggravandosi sotto il governo dei
suoi successori e solo con la nuova riforma di Vittorio Amedeo I la lira piemontese trovò equilibrio stabile con le monete forti del
tempo. Ma indubbiamente E. lasciava al figlio uno Stato profondamente rinnovato, una struttura finanziaria solida, un paese con una
ricca economia agricola, un prestigio e una posizione internazionale di tutto rilievo nel panorama dell'Italia del tempo.
Prestigio, fama e successo riconosciutigli ampiamente già ai suoi tempi: la stessa Venezia, dopo Lepanto, fu la prima a tributargli in
Italia il titolo di Altezza, prima ancora della concessione imperiale. E nessun altro osservatore del tempo ha saputo cogliere la ricca
personalità del principe sabaudo, nella sua schiettezza e nelle varie sfumature, meglio degli ambasciatori veneti residenti a Torino, dai
segni del successo e del prestigio ("Ha questo signor duca tutti li ordini di cavalleria che siano oggi de' principali fra principi cristiani
… l'ordine dell'Annunziata… la Giarettiera d'Inghilterra; il Tosone di Borgogna, S. Michele di Francia… Anzi dico di più che non è
altri che gli abbia tutti quattro fuori che Sua Eccellenza…": Relazioni…, p. 37) alla capacità di trattare con gli uomini in guerra e in
pace, mostrando un carattere forte ma capace di adattarsi ai luoghi e alle circostanze.
Grande fu quindi sempre la familiarità di E. con gli ambasciatori veneziani, verso i quali evidentemente non sentiva particolari
obblighi di etichetta e con i quali si abbandonava a lunghe ore di conversazione. Ecco allora emergere la passione per il mare (frutto
forse della sua giovinezza a Nizza?), gli svaghi nei suoi gabinetti di alchimia o negli studioli di matematica o nelle cacce. La
descrizione di una di queste fatta da Francesco Morosini è davvero indicativa del carattere del personaggio: dopo una corsa di nove
ore dietro un cervo, il duca, con soli più ormai quattro compagni, tra cui l'ambasciatore, uccide il cervo. Rifugiatisi presso un
minuscolo castelluccio si trovano nella necessità di attendere che l'unico garzone spacchi la legna per il fuoco: ma il duca "vedendo
che questi faceva molto a suo agio … gli levò sua eccellenza la mannara di mano e si mise con una destrezza e forza mirabile a
spezzar quei legni, e in poco spazio ne preparò tanti che bastarono d'avvantaggio per il bisogno della cena … e fornita la cena subito si
levò e restò in quel luogo giocando alle predelle… se bene tutti noi altri a pena potevamo stare in piedi…" (Relazioni…, p. 207).
Sovrano e principe assoluto, altero certo e ben conscio del suo ruolo, ma anche profondo diplomatico ed esperto conoscitore d'uomini
e dei modi per conquistarli: questo spiega i suoi successi con le truppe, la simpatia riscossa nella corte imperiale, la sua capacità di
muoversi a corte o al campo, dai suoi primi anni alla maturità. Così, ormai duca di Savoia, a Torino, dopo anni di lunghe ed estenuanti
trattative con i Cantoni svizzeri e in particolare con i sei Cantoni cattolici, fra i quali Friburgo, non esitò ricevendoli a Torino a
onorarli in vari modi, ma soprattutto "all'improvviso una mattina se ne andò con loro a disinare alla hosteria, dove erano alloggiati, nel
qual luogo fece loro quelli più domestici favori che poté, cercando con quelle maniere accostumate tra quella Natione, far loro
conoscere l'intimo del suo cuore, et la stima che faceva delle persone et superiori loro" (Adriani, Sanctacrucii…, p. 954). Non sarebbe
quindi azzardato definirlo come il più celebre, illustre e fortunato principe italiano dell'età moderna.
Fonti e Bibl.: Per i numerosi incarichi ricoperti presso la corte imperiale, nelle Fiandre e al servizio della Spagna numerose sono le
fonti relative a E. conservate nei maggiori archivi europei. Qui si indicherà soltanto per i suoi rapporti con Filippo II la corrispondenza
del residente spagnolo a Torino, Giovanni de Vargas Mejia, in Archivo general de Simancas, Segreteria de Estado, Saboa, anni 15691575. Torino, Biblioteca Reale, Iconografia sabauda, c. 7: originale della stampa ufficiale di E. con i quattro Ordini cavallereschi e le
varie imprese, destinata ad esser pubblicata dal Tonso nella prima biografia ufficiale; Ibid., Manoscritti, Misc. 165, cc. 29, 36 s.; 170,
cc. 37, 33; Ibid., Misc. st. patria 560 (1-5); 1158-1159; Ibid., Fondo Saluzzo 231, 723 per alcuni carteggi e memorie relative all'attività
di E. in Piemonte per gli anni 1552-1576.
Nell'Archivio di Stato di Torino, cfr. Real Casa, Cerimoniale, Nascite e battesimi, ms. 1, con la relazione del re d'armi dell'Annunziata
sul battesimo di E.; Ibid., Matrimoni sovrani e principi, m. 19, per il matrimonio; Ibid., Testamenti, n. 7, per l'atto originale datato 8
ag. 1554. In Storia Real Casa, III, ms. 10 i diari originali e autografi delle campagne militari e il testo della Preghiera. Per la
corrispondenza si vedano la serie Lettere duchi, Carlo III, E. F.; Registri lettere corte 1541-1553 quale principe di Piemonte e 15531573 come duca di Savoia; Minute lettere ducali, nn. 8-22. L'attività diplomatica di E. e la sua personale ingerenza nei rapporti con le
grandi monarchie europee e gli Stati italiani si può facilmente riscontrare nelle serie Trattati diversi, Negoziazioni Svizzeri, Spagna,
Roma, Francia, Venezia e Lettere ministri, sub voce, mentre per l'attività politica interna sono fondamentali i Protocolli ducali, nn.
223-237, con la registrazione di tutti gli atti prodotti dai segretari e cancellieri ducali. Inoltre, sempre nella sezione I, Materie militari,
siconservano buona parte dei provvedimenti e delle memorie sull'istituzione della milizia voluta da E., da integrare con l'altrettanto
ricca documentazione conservata nella sezione IV, Guerra e marina, Veedoria e contadoria generale…, e nella sezione III, Camerale,
Tesoreria generale di milizia; qui si vedano inoltre gli artt. 259, con alcuni bilanci dello Stato e della Real Casa corretti dallo stesso E.,
392, con i viaggi e gli itinerari del duca attraverso il Piemonte e la Savoia; e 217, Tesoreria Real Casa, per il mantenimento e la
struttura della corte ducale. Nell'Archivio storico d. città di Torino, Collezione Simeon, nn. 2367-2368, la descrizione di alcune feste a
Torino al tempo di Emanuele Filiberto.
I diari di E. furono pubblicati in occasione del IV centenario della nascita: si veda Diari della campagna di Fiandra, a cura di E.
Brunelli, Introd. di P. Egidi, in Biblioteca della società storica subalpina, CXII, Torino 1928. Essi erano già stati commentati da E.
Ricotti, Degli scritti di E. F. duca di Savoia, in Atti d. Acc. d. scienze di Torino, s. 2, XXII (1876), pp. 69 ss.; e da L. Romier, I diarii
di E. F., in Mélanges… École française de Rome, XXX (1910), pp. 3-50.
Importanti giudizi sull'azione e la personalità di E. sono stati espressi da numerosi contemporanei e dai primi biografi. Tra i
contemporanei, oltre alle numerose osservazioni, a volte davvero penetranti dei diversi ambasciatori veneti, sono intetessanti sia
quelle espresse da generali e condottieri spagnoli sia dagli avversari francesi. Fra questi ultimi cfr. P. de Brantôme, Oeuvres
complétes, I, Vies des homme illustres…, E. F., Paris 1822; B. de Monluc, Commentaires, 1521-1576, Bruges 1971, sub voce;
Collection complète des mémoires relatifs à l'histoire de France depuis le régne de Philippe-Auguste…, a cura di Cl.-B. Petitot, Paris
1819-27, voll. XXVI-XXX (Memorie di Fr. de Scepeaux, sire de Vielleville, e di Fr. de Boyvin, baron du Villars), sub voce. Più
agiografici e destinati a propagandare la figura del duca i lavori di altri contemporanei quali quelli di T. Malignano, Libro de
cavalleria intitulato El Cavallero resplendor..: dirigido al Ser.mo E. Ph…., Vercelli 1562; B. Pellipari, L'Italia consolata, Vercelli
1562; I. Tonsi, De vita Emmanuelis Philiberti Allobrogum ducis… libri duo, Augustae Taurinorum 1596; G. Botero, I principi
cristiani. Vita dei capitani, Torino 1603, sub voce.
La sincera ammirazione di E. verso la Repubblica di Venezia traspare dagli ottimi rapporti da lui avuti con i ben sette ambasciatori
che risiedettero a Torino fra il 1561 e il 1580; così le loro relazioni sono ricchissime di particolari, di notizie e di penetranti
osservazioni sul carattere e la personalità del duca: cfr. Relazioni degli ambasciatori veneti, XI, Savoia, a cura di E. Alberi, nella
riedizione, curata da L. Firpo, Torino 1983, pp. 37, 52, 79, 130, 140, 162, 230, 352 s., 420 s., 424 e passim; sui rapporti con Venezia
cfr. inoltre Emanuele Filiberto duca di Savoia, Lettere alla Repubblica Veneta, a cura di N. Barozzi, Portogruaro 1863; e A. Paravia,
Sul patriziato veneto dei reali di Savoia e sulle relazioni fra Venezia e Piemonte al tempo di E. F., in Memorie piem. di letter. e storia,
Torino 1853, pp. 62-136, e A. Segre, E. F. e la Repubblica di Venezia, in Miscellanea della R. Deputaz. ven. di st. patria, VII (1896),
pp. 87 ss. Come fonti coeve sono inoltre interessanti le osservazioni di G. Cambiano di Ruffia, Historico discorso, riedito in
Monumenta historiae patriae, Scriptores, III, Augustae Taurinorum 1840, coll. 931-1422, e le Memorie di un terrazzano di Rivoli dal
1535 al 1586, a cura di D. Promis, in Miscellanea di storia italiana…, VI (1865), pp. 601 ss.; M. C. De Buttet, Les victoires … E.
Ph…., ibid., s. 3, XVII (1915), pp. 587-607.
Importanti riferimenti all'attività politica e diplomatica del duca di Savoia si trovano ancor oggi nei classici lavori di E. Ricotti, Storia
della monarchia piemontese, II, Firenze 1861, pp. 8, 12, 18, 23 e passim; D. Carutti, Storia della diplomazia della corte di Savoia, II,
Torino 1875, pp. 3, 15, 17 e passim; L. Cibrario, Origine e progressi delle istituzioni della monarchia di Savoia, Firenze 1869, passim;
ricchissimi sono del resto i lavori di B. Claretta, Notizie storiche intorno alla vita e ai tempi di Beatrice. di Portogallo duchessa di
Savoia, Torino 1863, passim; Id., Ferrante Vitelli alla corte di Savoia nel sec. XVI, Torino 1879, passim; Id., La successione di E. F.
al trono sabaudo, Torino 1894; Id., Giacomina d'Entremont ammiraglia di Coligny ed E. F. duca di Savoia, in Nuova Rivista, Torino
1882; Id., Dell'Ordine mauriziano nel primo secolo della sua ricostruzione e del suo grand'ammiraglio A. Provana di Leyni, Torino
1890; Id., Il duca di Savoia E. F. e la corte di Londra negli anni 1554-1555, Genova 1892; G. B. Adriani, Santacrucii cardinalis
Prosperi de vita atque rebus gestis…, in Miscellanea di storia italiana, V (1868), pp. 612-992, in part. pp. 933-955, con la più ricca e
documentata ricostruzione delle trattative diplomatiche di E. con gli Svizzeri; A. Perrenot De Granvela, Lettere al duca E. F., Torino
1880; D. Promis, Cento lettere riguardanti la storia del Piemonte, in Miscellanea di storia patria, IX (1880), pp. 111, 117 e passim; L.
P. Gachard, Le duc E. Ph. de S. gouverneur général des Pays Bas (1555-1559), in Id., Etudes historiques… l'histoire des Pays Bas, III,
Bruxelles 1890, pp. 13, 16 e passim; L. Vaccarrone, E. F. in Germania, Torino 1900; A. Segre, L'opera politica e militare di A.
Provana di Leyni nello Stato sabaudo dal 1553 al 1559, in Atti d. R. Accad. d. Lincei, classe di scienze morali, stor. e filol., s. 5, VI
(1898), pp. 3-123; Id., E. F. in Germania e le ultime relazioni del duca Carlo II di Savoia con Alfonso d'Avalos…, in Atti d. R. Accad.
d. scienze di Torino, XXXVIII (1902-1903), pp. 17 ss. Sulle riforme politiche di E. in Piemonte e la soppressione dei Parlamenti cfr.
E. Peverelli, Il Consiglio di Stato nella monarchia di Savoia dal conte Tommaso I fino a E., Roma 1888, pp. 128 ss.; A. Tallone,
Parlamento sabaudo, VII, Patria cismontana (1525-1560), Bologna 1933, pp. CI, CIII e passim; A. H. Koenigsberger, The Parliament
of Piemont during the Renaissance 1460-1560, in Recueil d. travaux d'hist. et philol. de l'Univ. cath. de Louvain, XIV (1952), pp. 97,
102 e passim; sulle riforme giudiziarie, oltre alle importanti raccolte quali quelle coeve Brief recueil des Edits de trés illustre prince E.
Ph. ..., Chambéry 1567; o le Nove costituzioni ducali, Torino 1582, cfr. C. Dionisotti, Storia della magistratura piemontese, I, Torino
1881, pp. 99-125; A. Manno, Degli ordinamenti giudiziari del duca di Savoia E. F., Torino 1928; e l'ampia e ragionata rassegna di G.
Astuti, Gli ordinamenti giuridici degli Stati sabaudi, in Storia del Piemonte, Torino 1960, pp. 487-562; mentre il lavoro più recente è
quello di P. Merlin, Giustizia, amministrazione e politica nel Piemonte di E. F. La riorganizzazione del Senato di Torino, in Boll. storbibl. subalpino, LXXX (1982), pp. 35-94. Il IV centenario della nascita di E. fu celebrato con una ricca produzione storiografica, della
quale si segnalano in particolare: E. F., a cura e con introduzione di C. Rinaudo, Torino 1928; Lo Stato sabaudo al tempo di E. F., a
cura di C. Patrucco, I-III, Torino 1928; A. Segre-P. Egidi, E. F., Torino 1928; P. Silva, E. F., Roma 1928; R. Quazza, E. F. di Savoia e
Guglielmo Gonzaga (1559-1580), in Atti e mem. d. Accad. Virg. di Mantova, n. s., XXI (1929), pp. 86 ss.. Molto numerosi sono stati
gli studi sui rapporti fra il duca di Savoia, i movimenti protestanti e la Riforma: cfr. L. Cramer, La Seigneurie de Genève et la maison
de Savoie de 1519 à 1603, II, Paris 1912, pp. 33, 35, 39 e passim; C. Ciccolini, E. F. e il concilio di Trento, in Studi trent. di sc.
storiche, IX (1928), pp. 8 ss.; D. Jahier, I valdesi e E. F., Torino 1928; G. Galbiati, I duchi di Savoia E. F. e Carlo Emanuele I nel loro
carteggio con s. Carlo Borromeo, Milano 1941; E. Comba, La campagna del conte della Trinità narrata da lui medesimo, in Bull. de la
Soc. d'hist. vaudoise, XXVIII (1904), pp. 3-32; ibid., XXIX (1905), pp. 7-27; A. Pascal, La lotta contro la riforma in Piemonte al
tempo di E. …, ibid., pp. 6-83; M. Grosso-M. Mellano, La controriforma nella arcidiocesi di Torino (1558-1610), I, Il card. G. Della
Rovere e il suo tempo, Città del Vaticano 1957, pp. 31, 36, 41 e passim; R. De Simone, Tre anni decisivi di storia valdese…, Roma
1958, pp. 5, 9, 13 e passim; Nunziatura di Savoia, 1560-1573, a cura di F. Fonzi, Roma 1960, in Fonti per la storia d'Italia, pp. III-VIIX e passim; A. Erba, La Chiesa sabauda fra Cinque e Seicento…, Roma 1979, pp. 41 s., 54 e passim.
Sul matrimonio di E. e il ruolo di Margherita di Francia duchessa di Savoia cfr.: Marguerite de France … ses rapports avec Genève
(1563-67), in Mem. et doc. publiés par la Soc. d'hist. et d'archéol. de Genève, XV (1865), pp. 121 ss.; I. Malaguzzi, Le nozze di E. F.
con Margherita di Francia, Modena 1893; R. Peyre, Une princesse de la Renaissance: Marguerite de France…, Paris 1902. Sui figli
naturali avuti da E. cfr. B. Amante, Di Amedeo di Savoia figlio di E. F., Macerata 1877. Sulle riforme militari oltre alle tradizionali e
classiche storie militari di C. Saluzzo, cfr. G. Briolo, Storia ragionata della milizia volontaria…, Torino 1798; G. Ottolenghi, Appunti
e documenti sulla riforma militare di E. F., Casale 1892; e il penetrante giudizio datone in P. Anderson, Lo Stato assoluto, Milano
1976, pp. 154-159, assai più lucido della confusa ricostruzione di W. Barberis. Le armi del principe…, Torino 1988, pp. 5-77.
Sull'organizzazione della corte ducale cfr. infine C. Stango, La corte di E. F.: organizzazione e gruppi sociali, in Boll. stor-bibl.
subalpino, LXXXV (1987), pp. 445-502.
Emmanuel Philibert, Duke of Savoy 1528-1580
From Wikipedia, the free encyclopedia
1553 – 1580
Reign
Predecessor Charles III
Successor Charles Emmanuel I
Spouse Margaret of France, Duchess of Berry
Issue Charles Emmanuel I of Savoy
Father Charles III of Savoy
Mother Beatrice of Portugal
8 July 1528 Chambéry
Born
30 August 1580 (aged 52) Turin, Italy
Died
Emmanuel Philibert (in Italian Emanuele Filiberto; known as "Testa di ferro" in English "Ironhead," because of his military career,
8 July 1528 – 30 August 1580) was Duke of Savoy from 1553 to 1580. Born in Chambéry, Emmanuel Philibert was the only child of
Charles III, Duke of Savoy and Beatrice of Portugal to reach adulthood. His mother was sister-in-law to Charles V, Holy Roman
Emperor, and the future duke served in Charles's army during the war against Francis I of France, distinguishing himself by capturing
Hesdin in July 1553. A month later, he became duke on the death of his father, but this was a nearly empty honour, as the vast
majority of his hereditary lands had been occupied and administered by the French since 1536. Instead, he continued to serve the
Habsburgs in hopes of recovering his lands, and served his maternal first cousin King Philip II as Governor of the Netherlands from
1555-1559. In this capacity he personally led the Spanish invasion of northern France and won a brilliant victory at Saint-Quentin in
August 1557. He was a suitor to Lady Elizabeth Tudor, the future Queen Elizabeth I. He had barely any money at that time. By the
Peace of Cateau Cambrésis between France and Spain, (1559) the duchy was restored to Emmanuel Philibert and he married his halffirst cousin once removed Margaret of France, Duchess of Berry (1523-1574), daughter of King Francis I of France and sister to King
Henry II. Their only child was Charles Emmanuel I of Savoy. Following his uncle's, Henry I of Portugal, death (31 January 1580)
Emmanuel Philibert fought to impose his rights as a claimant to the Portuguese throne. However, he soon realised that he had quite a
fragile position due to his cousin, Philip II of Spain claims who, in the end, managed to conquer the country and the Crown.
Emmanuel Philibert spent his rule regaining what had been lost in the costly wars with France. A skilled political strategist, he took
advantage of various squabbles in Europe to slowly regain territory from both the French and the Spanish, including the city of Turin.
He also purchased two territories. Internally, he moved the capital of the duchy from Chambéry to Turin and replaced Latin as the
duchy's official language with Italian.[1] He was attempting to acquire the marquisate of Saluzzo when he died in Turin. [2]
Notes
1.
^ Francesco Bruni, ‘La politica linguistica di Emanuele Filiberto’, Storia della Lingua Italiana, Rai International:
Italica.
2.
^ Cambridge modern History, Volume 1, Stanley Leathes, G. W. (George Walter) Prothero, Sir Adolphus William
Ward, CUP Archive, 1964, pg. 399-400
See also 1580 Portuguese succession crisis
Preceded by Charles III
Duke of Savoy 1553–1580
Succeeded byCharles Emmanuel I
Governor of the Netherlands 1555–
Preceded by Mary of Austria
Succeeded by Margaret of Parma
1559
Piero Strozzi (1510 - 1558)
From Wikipedia, the free encyclopedia
Piero Strozzi as Marshal of France. Buste de Pierre Strozzi, Galerie des batailles, Versailles
Piero (or Pietro) Strozzi (c. 1510 – 21 June 1558) was an Italian military leader. He was a member of the rich Florentine family of
the Strozzi.
Biography Piero Strozzi was the son of Filippo Strozzi the Younger and Clarice de' Medici. Although in 1539 he married another
Medici, Laudomia di Pierfrancesco, he was a fierce opponent of the main line of that family. He fought in the army led by his father
and other Florentine exile from France to oust the Medici from Florence, but, after their defeat at the Battle of Montemurlo, Piero fled
to France at the court of Catherine de' Medici. He was in French service during the Italian War of 1542. Having raised an army of
Italian mercenaries, he was confronted by the Spanish-Imperial forces at the Battle of Serravalle, where he was defeated. In 1548 he
was in Scotland supporting Mary of Guise of behalf of Henri II of France, during the war of the Rough Wooing. There he designed
fortifications against the English at Leith and Haddington. As he was shot in the thigh by an arquebus at Haddington, Strozzi
supervised the works at Leith from a chair carried by four workmen.[1] Strozzi also designed works at Dunbar Castle with the
assistance of Migiliorino Ubaldini.[2] He was named marshal of France in 1554. Later he fought in the defence of the Republic of
Siena against Cosimo de' Medici, leading a French army. He obtained a pyrrhic victory at Pontedera on 11 June 1554, but his army
could not receive help from the ships of his brother Leone (who had been killed by an arquebus shot near Castiglione della Pescaia)
and he was forced to retreat to Pistoia. On 2 August his defeat at the Battle of Marciano meant the end of the Senese independence. In
1556 he was appointed as superintendent of the Papal army and lord of Épernay. In 1557 the participated in the siege of Thionville,
near Calais. He died there the following year. He is generally credited as the inventor of the dragoon military speciality (arquebusiers
à cheval or horse arquibusiers).[3] His son Filippo was also a military commander, as was his brother Leone Strozzi, a Knight of Malta,
known as the Prior of Capua.
Citations and notes
1.
^ Calendar State Papers Scotland, vol. i, (1898), 158: Michaud & Poujoulat, "Nouvelle Collection des memoirs
pour
server
a
l’histoire
de
France,
vol.
6
(1839)".
http://books.google.co.uk/books?id=dtxAAAAAcAAJ&pg=PA1&dq=michaud+poujoulat+nouvelle+guise+aumale&cd=9#v
=onepage&q&f=false., 3.
2.
^ Merriman, Marcus, The Rough Wooings, Tuckwell (2000), 327-330.
3.
^ p.102, Fortescue
References Fortescue, John William, A History of the British Army, volume I, chapter 2, Macmillan, 1899
Recommended reading Oman, Charles. A History of the Art of War in the Sixteenth Century. London: Methuen & Co., 1937
Piero Strozzi
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Piero o Pietro Strozzi (1510 – Thionville, 21 giugno 1558) è stato un condottiero italiano, membro della famiglia patrizia fiorentina
degli Strozzi, figlio di Filippo Strozzi e di Clarice de' Medici.
Biografia Il primogentito di casa Strozzi venne avviato inizialmente alla carriera ecclesiastica, per poi preferire quella militare. Dal
1539 fu sposato con Laudomia di Piefrancesco de' Medici, sorella di Lorenzino de' Medici (amico del padre) dalla quale ebbe due
figli. Sebbene strettamente imparentato con i Medici, la sua famiglia fu spesso in contrasto con il ramo principale, in particolare
contro Cosimo I. Nel 1537 suo padre era sceso dalla Francia con un esercito di esuli fiorentini decisi a riprendere la città dopo la
scelta del nuovo granduca, ma fu miseramente sconfitto nella battaglia di Montemurlo, trovando la morte nel carcere della Fortezza di
San Giovanni. Piero in quell'occasione, con gli altri fratelli, era riuscito a trovare scampo in Francia, alla corte di Caterina de' Medici,
che non gradiva la nuova generazione dei Medici al potere. Passato al servizio di Francesco I di Francia, combatté contro gli spagnoli
a Serravalle Scrivia. Enrico II lo creò, più tardi, Maresciallo di Francia (1558).
L'assedio della Mirandola Nel 1551 Piero Strozzi tornò in Italia dove diede prova luminosa delle sue capacità militari durante
l'assedio della Mirandola. La guerra era nata dalla successione nel ducato di Parma e Piacenza, a Pier Luigi Farnese, figlio
riconosciuto di papa Paolo III. Assassinato Pier Luigi dal consuocero, l'imperatore Carlo V, il pontefice aveva veduto dissolversi il
sogno di fondare una casa principesca, si era impegnato a convincere il concistoro dei cardinali a consegnare le due città al figlio di
Pierluigi, Ottavio, in forma legale, ma Ottavio prevenne il nonno occupando Parma con gesto di ribaldo. Per il gesto Paolo III morì,
forse, di crepacuore. Ferrante I Gonzaga, governatore imperiale di Milano, ebbe ordine dall'imperatore Carlo V di occupare Parma. Il
giovane duca ribelle trovò l'appoggio dei francesi, desiderosi di rientrare, dopo Pavia, nel gioco italiano. La Francia assoldò lo Strozzi,
che raccolse soldati alla Mirandola, la cittadella il cui signore era stato dichiarato fellone da Carlo e si era venduto alla Francia. Si
combatté sotto le mura di Parma e di Mirandola, che sostenne lo sforzo preminente contro schiaccianti forze papali. Le mura di nuova
concezione, disegnate per un uso rivoluzionario delle artiglierie, consentirono a poche centinaia di difensori di avere ragione di 23.000 avversari, uccidendone oltre 1.000. Fu il trionfo dello Strozzi, che ne uscì con la fama di primo generale italiano, e del giovane
signore della Mirandola, Ludovico Pico.
Altre imprese Paradossalmente, Strozzi avrebbe dissolto la propria fama, dopo pochi anni, nella battaglia della Chiana, dove fu
tradito dalla errata manovra di Ludovico Pico, che, al comando della cavalleria, gli scoprì il fianco agli spagnoli. Col tramonto di
Strozzi, nemico giurato di Cosimo I, ritrovavano la sicurezza i Medici a Firenze, uscivano i francesi dal gioco italiano.[1]. Quando
Cosimo si preparò ad attaccare Siena, Piero insieme con il fratello Leone accorso per difendere l'antica repubblica, con un esercito di
truppe francesi. Assediati dai fiorentini e dagli imperiali, l'11 giugno 1554 Piero tentò una sortita dalla città con diecimila uomini,
dirigendosi verso Pontedera. Sperando di raggiungere Firenze attraverso la Val di Nievole, colse di sorpresa i nemici. Dopo un esito
inizialmente favorevole, le truppe di Piero si ritirarono a Pistoia in attesa di aiuti via mare portati da Leone Strozzi. Ma Leone era
morto colpito da un archibugio vicino a Castiglione della Pescaia e il mal tempo impedì alle navi di attraccare. Così Piero riuscì solo a
rientrare fortunosamente in Siena. Piero tentò un nuova sortita il 2 agosto, ma fu sconfitto a Marciano della Chiana. La guerra di Siena
venne persa. La causa della sconfitta fu attribuita ad un errato utilizzo della cavalleria comandata da Pico della Mirandola. Persa
Siena, la resistenza continuò a Montalcino (1556). Nel 1556 fu nominato Sovraintendente alle armate pontificie e signore di Epernay.
Nel 1557 partecipò all'assedio di Thionville, presso Calais, morendo il 21 giugno del 1558. Viene generalmente considerato come
l'inventore dei Dragoni, cioè delle truppe di archibugieri a cavallo. Suo figlio Filippo fu pure un comandante.
Note ^ I precedenti diplomatici della guerra, condotti dal cardinale Alessandro, fratello di Ottavio, la preparazione militare, gli scontri
iniziali, il lungo assedio, la sua fine repentina, per l'uccisione del nipote del papa che comandava l'esercito assediante, sono stati
ricostruiti, sulle cronache locali, nel romanzo storico di Antonio Saltini, L'assedio della Mirandola, Edizioni Diabasis, 2004.
Bibliografia Giorgio Batini, Capitani di Toscana, Firenze, Edizioni Polistampa, 2005, pp. 182 - 195 ISBN 88-8304-915-2
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene file multimediali su Piero Strozzi
Pierre Strozzi (1510 - 1558)
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Piero Strozzi, cousin de Catherine de Médicis, connu en France sous le nom de Pierre Strozzi (né v. 1510 - mort le 21 juin 1558, à
Thionville, France) était un condottiere florentin de la Renaissance, qui s'engagea au service de la France et devint maréchal de France
en 1554. Son fils Philippe Strozzi, fut amiral de la France, et fut battu et tué lors de la bataille navale des Açores en 1582.
Biographie Destiné dans sa jeunesse à l’état ecclésiastique, Pierre Strozzi quitte cette carrière pour embrasser celle des armes. Il sert
comme colonel sous le comte Guy Rangon en Italie, et contribue à faire lever le siège de Turin par les Impériaux en 1536. En 1537 il
est défait par le grand-duc de Toscane près de Montemario. Dévoué au service de la France par aversion de Médicis, qui gouvernent
sa patrie, il se met à la tête de bandes italiennes qui servent en Piémont pour le Roi de France. Rentré en France en 1543, il prit part au
siège de Luxembourg sous le duc d’Orléans. Battu par le Marquis del Vasto, il répare cet échec en levant un nouveau corps de huit
milles hommes et en s’emparant d’Albe. En 1545, il sert dans l’armée navale sous l’amiral d'Annebaut, puis est fait Général des
Galères de France. Le Roi Henri II lui donne ensuite le commandement de l’armée envoyée en Italie au secours des Siennois.
Encouragé par Catherine de Medicis, Strozzi s'acharne à défendre la ville de Sienne malgré la supériorité des armées hispanoflorentines coalisées. Afin de prolonger le siège dans l'attente d'une hypothétique armée de secours venue de France, il organise
l'expulsion des "bouches inutiles" : l'opération provoque la mort de nombreux civils essentiellement des femmes, des enfants et des
personnes âgées ou handicapées. Strozzi bat Rudolf Raglion et Ascagne de La Corne, mais est défait et gravement blessé à Marciano
le 2 août 1554. Notons qu'il a aussi participé au siège de Metz en 1552 aux côtés de François de Lorraine, duc de Guise. Il reçoit le
bâton de Maréchal de France la même année. Nommé Lieutenant général de l’armée qui doit défendre le Pape Paul IV contre les
Espagnols, il reprend la ville d’Ostie et fait lever le siège de Rome en 1557. Revenu en France, il se distingue au siège de Calais en
1558. En juin de la même année, étant au siège de Thionville sous les ordres du duc de Guise et alors qu’il va reconnaître un
emplacement de batterie, il est mortellement frappé d’un coup d’arquebuse. Pierre Strozzi est inhumé à Épernay.
Notes et références
1.
↑ Johannes Baptist Rietstap, Armorial général : contenant la description des armoiries des familles nobles et patriciennes de
l'Europe : précédé d'un dictionnaire des termes du blason, G.B. van Goor, 1861, 1171 p. [lire en ligne [archive]], et ses
Compléments sur www.euraldic.com [archive]
Courcelles, Dictionnaire Historique des Généraux Français, IX, pp. 197 - 200
Leone Strozzi
From Wikipedia, the free encyclopedia
Leone Strozzi (October 15, 1515 – June 28, 1554) was an Italian condottiero belonging to the famous Strozzi family of Florence. He
was the son of Filippo Strozzi the Younger and Clarice de' Medici, and brother to Piero, Roberto and Lorenzo Strozzi. After his
father's defeat in the Battle of Montemurlo, Strozzi fled with his brothers to France, at the court of Catherine de' Medici. Later he
fought against Cosimo I de' Medici at Siena, but was again defeated. In 1530, Strozzi became Knight of the Order of Malta, for which
he was Prior in Capua. In 1536, he was named commander of the galleys of the Order, a position he held again in 1552. In August
1547 he captured St Andrews Castle in Scotland from the Protestant Lairds of Fife who had killed David Beaton. The lairds knew an
expert was in the field when they observed cannon being winched into position with ropes rather than exposing the besiegers to their
fire.[1] Strozzi died in the siege of Scarlino, in Tuscany, during the unsuccessful defence of Republic of Siena against Florence and the
Holy Roman Empire, shot by an arquebus ball. Footnotes ^ Lindsay of Pitscottie, Chronicles of Scotland, vol. 2, Edinburgh, (1814),
489-490.
Ramón de Cardona
(1467 - 1523)
From Wikipedia, the free encyclopedia
Ramon Folch de Cardona y Anglesola (Italian: Raimondo di Cardona) (1467 – 10 March 1523) was a Catalan general and
politician, who served as the viceroy of Naples during the Italian Wars and commanded the Spanish forces in Italy during the War of
the League of Cambrai. He was count of Oliveto, title awarded on 12 December 1515. Oliveto is in Italy This Cardona, 5th Baron of
Bellpuig, 41º 37´N 1º 01' E, Baron of Linyola and Baron of Utxafavá, all the 3 places in Catalonia, was born in Bellpuig, within one
of the greatest families in Aragon. On 12 December 1502 he was awarded the title of Duke of Soma, taking part in 1505, with the role
of admiral, in the capture of Mers-el-Kébir. King Ferdinand II of Aragon, of whom he has been postulated to be a natural son[1], made
him Viceroy of Naples in 1505. He stayed a Viceroy of Naples till 1507, being a Viceroy of Sicily from 1507 to 1509 and coming
back to Naples and staying there till his death in 1522. In 1510 he received instructions on introducing the Inquisition in Naples, a
decision which caused a popular revolt; after which the Spanish king canceled the decree. In 1511 Cardona moved to northern Italy as
the commander-in-chief of the League of Cambrai army, leaving the Neapolitan government to his wife Isabel de Requesens, 2nd
countess of Palamós, 41° 51′ 0″ N, 3° 8′ 0″ E, in Catalonia, Spain, 2nd countess of Avellino,40º 55´N 14º 47'E, in Campania, Italy,
2nd countess of Trivento,41º 46´N 14º 33´E in Molise, Italy, baroness of Calonge, Baix Empordà, Catalonia, Spain, daughter of
Galceran de Requesens the first holder of these titles. In the following year he was defeated by Gaston of Foix, Duke of Nemours at
Battle of Ravenna. Cardona then moved to Tuscany to support the then Spanish-supported House of Medici. His troops besieged
Prato, massacring the population after its fall. In 1513 Cardona returned to Lombardy with a new army the following year and fought
successfully at the Battle of La Motta, defeating the Venetian army led by Bartolomeo d'Alviano. He was however unable to prevent
the Venetians from joining with the French at the Battle of Marignano. In February 1513, after the death of Pope Julius II, (1443–
1513), a.k.a. Giuliano della Rovere and the arrival in Italy of King Francis I of France, Cardona was called back to Spain. In 1515 he
had received the title of Count of Alvito, a fiefdom in what is now southern Lazio. In 1519 the new king of Spain, Charles I of Spain,
a.k.a. Charles V, Holy Roman Emperor, made him Great Admiral of the Kingdom of Naples. He died at Naples in 1522. His cenotaph
in Bellpuig, Catalonia, executed by Giovanni da Nola, is one of the most outstanding examples of Renaissance art in the region. One
of their sons was named Fernando Folch de Cardona, 2nd duke of Soma being 3r count of Oliveto, in Italy and other titles, Viceroy of
Sicily, deceased 13 September 1571, was the inheritor of the title of the title of "duca de Soma", Duke of Soma, in Italy, apparently,
on 12 December 1534, probably because the original title of 1502 seems to have been awarded by the supposed king of Naples,
bastard Frederick IV of Naples, the son of bastard king of Naples Ferrante I of Naples, (1423 - king of Naples 1458 - January 1494).
The sister of this 2nd duke of Soma, named Caterina de Cardona y Requesens, deceased in 1577, married Italian aristocracy coming
from the bastard king of Naples Ferrante I of Naples relationship with Diana Guardato , Ferrante I comin from Giraldona Carlino
relationship with the king in Spanish Aragon-Catalonia and later Conqueror of the Naples - Sicily kingdom Alfonso V of Aragon.
Thus, Caterina de Cardona y Requesens linked her Catalan "Folch de Cardona" blood with the Neapolitan-Calabrese-Sicilian royal
blood of Don Ferrante d' Aragona, 1st duke of Montalto, later continued also on the "Moncada" family Sicilian Princes of Paternò,
from the Province of Catania, Sicily, 37°34′N 14°54′E, Grandees of Spain, too.
Notes^ Ballesteros Gaibrois, Manuel (1953). Ramon de Cardona, colaborador del Rey Catolico en Italia. Madrid.
References
• Norwich, John Julius (1989). A History of Venice. New York: Vintage Books. ISBN 0-679-72197-5.
• Taylor, Frederick Lewis (1973). The Art of War in Italy, 1494-1529. Westport: Greenwood Press. ISBN 0-8371-5025-6.
http://www.grandesp.org.uk/historia/gzas/soma.htm
Portrait of Dona Isabel de Requesens, wife of Ramon de Cardona. Tomb of Ramon de Cardona, by Giovanni da Nola.
Carlo Gonzaga
(1525-1566)
From Wikipedia, the free encyclopedia
Carlo Gonzaga (1525–1566) was an Italian military leader. At the Battle of Ceresole, he commanded the Imperial heavy cavalry, and
was captured by the French when it fled from the field. Oman, Charles (1937). A History of the Art of War in the Sixteenth Century.
London: Methuen & Co..
Eriprando Madruzzo (? - 1547)
From Wikipedia, the free encyclopedia
Eriprando Madruzzo[1] (died 1547) was an Italian mercenary captain. The brother of the Bishop of Trent Cristoforo Madruzzo, he
fought in Hungary against the Turks at the service of Charles V. During the Italian Wars, he commanded the Imperial landsknechts at
the Battle of Ceresole in 1544,[2] being wounded in the fray. The following year he was entrusted the security of the Council of Trent.
In 1546 Madruzzo took part to the wars against the Protestants in Germany, and died at Ulm in 1547. Notes
1.
^ Other variants of the spelling, such as "Aldobrando Madrazzo", are occasionally used by non-Italian historians.
2.
^ Oman, Art of War, 236.
References Madruzzo geneaology (Italian) Oman, Charles (1937). A History of the Art of War in the Sixteenth Century. London:
Methuen & Co..
Ferdinando Sanseverino (1507 - 1568)
From Wikipedia, the free encyclopedia
Ferdinando (Ferrante) Sanseverino, Prince of Salerno (January 18, 1507 – 1568) was an Italian condottiero.
Biography Born in Naples, he was the son of Roberto Sanseverino and a noble girl from a Salerno family. Fernando Sanseverino was
the last of the Sanseverino Princes of Salerno. He fought for Emperor Charles V in Germany and France. He took part to Charles'
incoronation in Bologna (1530), and was also present at the conquest of Tunis in 1535. He was one of the imperial leaders in the
fourth war against Francis I of France and fought at the battle of Ceresole (1544). Returning to Naples, he went to short terms with the
Spanish viceroy Pedro de Toledo, due to his opposition to the institution of Holy Inquisition tribunals in the Kingdom of Naples. He
therefore moved to France at the court of King Henry II, embracing the Huguenot creed. His Italian fiefs were given to the Gonzaga.
Ferdinando Sanseverino died in France in 1568.
Main accomplishments He organized a naval attack of French ships against Naples and Salerno, but it failed due to the intervention
of the Turk fleet. He was an a passionate supporter of contemporary theatre, and had one built within his palace in Naples. His refusal
to accept the Inquisition inside his possession in Salerno created a break between him and the Spanish government in southern Italy.
Mainly as a consequence of this, Fernando Sanseverino was forced to exile in France. He died in Avignon in 1568. His legacy in the
Principate of Salerno was to bring to the southern italian city (and the surrounding area) the ideas of the Italian Renaissance. He
brought to Salerno Torquato Tasso for some years.
External links Sanseverino
Philip de Lannoy, 1st Prince of Sulmona
From Wikipedia, the free encyclopedia
Philip de Lannoy, Prince of Sulmona (fl. 1544) was an Italian military leader in Spanish service. At the Battle of Ceresole, he
commanded the Neapolitan light cavalry. Oman, Charles. A History of the Art of War in the Sixteenth Century. London: Methuen &
Co., 1937.
Capitan Giovacchino da Coniano
Sergente maggiore della fanteria italiana al soldo inglese e agli ordini di Surrey, nella spedizione francese del 1544.
Trattato dell'Ordinanze, o' vero Battaglie del Capitano Giovacchino, in Della fortificazione delle città, di M. Girolamo Maggi, e del
Capitan Iacomo Castriotto Ingegniero del Christianiß. Re di Francia, Libri III In Venetia, Appresso Camillo Borgominiero, al
Segno di S. Giorgio MDLXXXIII. anastatica, Roma, Viella, 1982. Venezia, 1584, in-fol. [Haym IV, p. 166, N. 4. Tiraboschi,
Storia della lett. it., VII, 2a, p. 512. Ayala, pp. 19-20: "trovasi alla fine del trattato di fortificazione di M. Girolamo Maggi: ma
non è intero, e fu dato al Maggi da Vincenzio Quistello, il quale aveva altre opere del Coniano, massime su la fortificazione. Il
Coniano fu sergente maggiore degl'italiani nell'esercito inglese contro il francese, ed ebbe compagno d'armi il Melloni ch'ei cita
di frequente". Cockle N. 532].