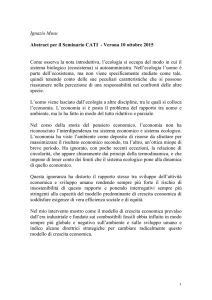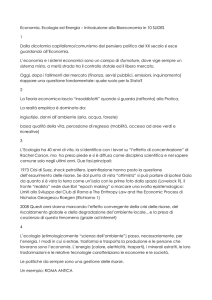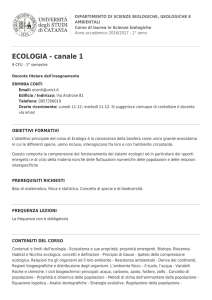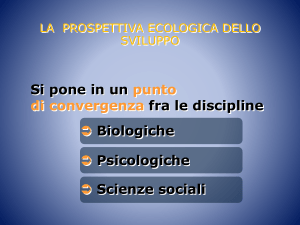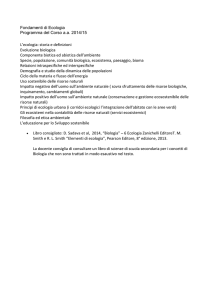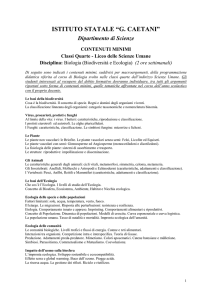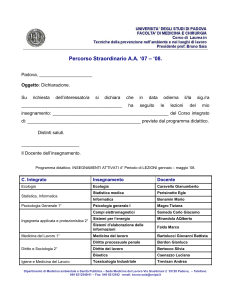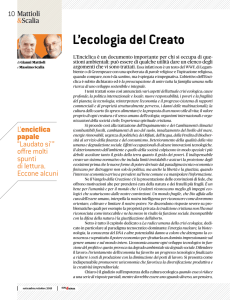La crisi ecologica viene da lontano.
Crisi ecologica e crisi della modernità.1
Anne Frémaux
“Il tempo del mondo finito è cominciato!”2
L’uomo occidentale del XXI secolo sta facendo una scoperta storica senza precedenti. Dopo quattro
secoli di sviluppo scientifico che mirava a realizzare il progetto cartesiano di una natura totalmente
“dominata” e “posseduta” in grado di soddisfare dei bisogni divenuti illimitati, si deve confrontare con
l’immagine di un “nuovo mondo” l’immagine di un mondo finito e ostile al proprio sfruttamento,
dotato di risorse limitate e di capacità di rigenerazione ridotte. Resiste in effetti all’ideale di una crescita
infinita, all’ideologia “folle” che è stata quella del secolo scorso di una società di consumo e di spreco
fondata sulla produzione, l’accumulazione e la distruzione sistematica e illimitata dei beni.
L’ecologia, in quanto, come “attenzione all’ambiente di vita”, preoccupazione particolare è apparsa solo
quando i problemi erano già preoccupanti, quando l’attività umana aveva già distrutto o perturbato
stabilmente l’ambiente. Le società tradizionali non conoscevano il concetto di ecologia, né nella sua
forma scientifica (cioè lo studio degli ambienti naturali) né nella sua forma politica (allestimento e
gestione dell’habitat umano). Non c’è ecologia presso i popoli la cui influenza sull’ambiente è minima.
E perché avrebbe dovuto esserci? Le risorse naturali sembrano in quei contesti infinite e i prelievi sono
così minimi che l’ecosistema può assorbire, senza danni, gli effetti dell’azione umana. Le prime grandi
manifestazioni politiche della preoccupazione ecologica (negli anni sessanta) corrispondono dunque alla
presa di coscienza delle alterazioni quasi irreversibili che le nostre industrie hanno prodotto
sull’ambiente. Le distruzioni poi si sono talmente accelerate che oggi si parla di “sfida ecologica” per
significare le difficoltà straordinarie con le quali dobbiamo confrontarci.
La crisi ecologica, un vero e proprio evento storico, è proprio l’occasione per una rimessa in
discussione totale individuale e collettiva, psicologica e antropologica.3 E’ in effetti proprio la questione
stessa della civiltà e, a contrario, dell’eventualità della barbarie che è in gioco nell’ecologia: quale società
vogliamo per domani? Cosa significa per noi “vivere bene”? Sappiamo, anche se ancora non lo
ammettiamo, che il nostro attuale modo di vivere è senza avvenire, che le nostre società industrializzate
vivono del saccheggio della natura, del prelievo irreversibile fatto su risorse che hanno limiti e della
distruzione delle capacità auto generative del pianeta. Detto altrimenti, il nostro mondo è morto anche
se certi tentativi, come il capitalismo verde o l’eco-crescita, cercano di farci credere che è ancora un
“mondo possibile”.
La crisi del mondo moderno
Dire che il mondo moderno è attraversato da una crisi significa che è giunto a un punto critico: quel
punto culminante che Ippocrate chiamava, a proposito della malattia, apex, sommità, il momento
fatidico e irreversibile dopo il quale il paziente può guarire o trapassare. Il verbo greco krinein ha in
effetti due significati: scegliere, distinguere ma anche decidere nel senso giuridico. Nel caso di un
conflitto o della rottura di un equilibrio, caratteristica delle situazioni critiche, bisogna allora scegliere,
decidere quale soluzione sarà favorevole o sfavorevole in modo da attivare un cambiamento decisivo.
1 “Introduzione” a La nécessité d’une écologie radicale. La pensée à l’épreuve des problèmes environnementaux, Sang de la Terre, Parigi
2015, Traduzione dal francese di Piero Coppo.
2 Paul Valéry, (Regard sur le monde actuel, 1945)
3 “Antropologico” significa qui, come nel resto del libro, non lo studio di un popolo particolare ma “caratteristiche
filosofiche dell’uomo” anche se alla fine, sono proprio quelle di un uomo particolare che studiamo qui: l’uomo occidentale
moderno.
Questo momento “critico”, questa frattura irreversibile nel continuum “normale”, indica che una
trasformazione più o meno profonda, un cambiamento di orientamento devono avvenire per generare
qualcosa di nuovo. La crisi in questo è un momento cerniera che rompe la normalità e chiama a nuove
opportunità. Non possiamo sapere in anticipo quello che nascerà dalla crisi ecologica: è una messa alla
prova il cui risultato è incerto e che, come ogni prova, è accompagnata da sofferenze. Momento di
perturbazione in un sistema fino a quel momento in apparenza stabile, la crisi porta con sé il suo carico
di incertezze e rischi. Ciò che invece è certo, è che ha bisogno di una risposta radicale e profonda.
Le crisi economiche a ripetizione alle quali da più di trenta anni siamo sottoposti, così come la
degradazione ecologica quasi irreversibile iniziata negli anni 60-70, sono solo gli effetti generati da una
crisi ben più profonda: la crisi del modello economico e antropologico che spinge all’accumulazione
illimitata dei profitti, allo sfruttamento totale delle risorse e alla privatizzazione di tutti gli spazi
collettivi, suoi soli e unici obiettivi. I limiti economici (ma non ecologici) di un tale sistema sono stati
già ammirabilmente descritti da Marx già nel XIX secolo: concentrazione del capitale (creazione di
monopoli, aggravamento delle ineguaglianze…) , crisi dei mercati (crisi da sovra-produzione),
alienazione economica e antropologica dei lavoratori obbligati a dare in affitto la loro forza lavoro o
addirittura a “vendersi”… Contrariamente a quello che pretendono i difensori dell’ideologia liberale che
quasi sempre fanno discorsi rassegnati in rapporto a fenomeni che a loro sfuggirebbero (la famosa
“mondializzazione”), i fattori che contribuiscono alla situazione attuale, come la de-regolazione degli
scambi che favorisce i più “competitivi” o anche quelli che meno pensano e parlano “socialmente” e
“ecologicamente”, non sono affatto una fatalità: provengono loro stessi da scelte ideologiche d’ordine
economico e politico o anche da una vera volontà di “lasciar fare”. Disoccupazione, miseria e crisi
ecologica non cascano dal cielo ma sono davvero generate da questa politica economica che si dà come
il solo scopo degno di essere perseguito la mercificazione e la privatizzazione totale degli esseri, dei
servizi di interesse generale (scuola, salute, trasporti…) e dei beni comuni (aria, acqua, paesaggi…). E
non è la pretesa “moralizzazione” di un sistema economico (che, per sua natura, è totalmente estraneo
alla morale4) che cambierà questo fatto. Perché le cose cambino, serve un nuovo progetto politico
simile a quello che aveva animato i promotori del Consiglio nazionale della resistenza (CNR) nel 1945 o i
fautori del socialismo originale del XIX secolo. Per questo dobbiamo rivivificare il progetto politico
ridefinendo gli scopi che deve darsi l’economia in una società che ha a cuore la giustizia sociale ed è
cosciente dei limiti ecologici ai quali deve adattarsi.
Ma ancor più di questo, l’obiettivo del nostro lavoro sarà mostrare che la crisi ecologica è il sintomo
rivelatore, e forse il più estremo, di una crisi molto più fondamentale: la crisi del modello antropologico
occidentale e della sua concezione di un “progresso” umano animato soprattutto dalla scienza o
piuttosto, oggi, dalla tecno-scienza (alleanza, in verità poco progressista, delle tecnologie innovatrici
messe al servizio del mercato). Secondo la nostra ipotesi, la “crisi ecologica” sarebbe il punto d’arrivo
della situazione estremamente critica del mondo moderno. Confermerebbe, con le conseguenze
drammatiche e forse definitive che l’accompagnano, che la nostra visione antropocentrica del mondo
(che considera l’uomo come il centro di tutto) e il nostro gusto per la dismisura sono inutili, o
addirittura funeste, per l’umanità. Così il nostro umanismo proclamato che si rifiuta di dare valore e
senso a ciò che non è umano rischia proprio di rigirarsi contro sé stesso. L’essere umano, malgrado i
suoi sogni insensati di indipendenza e di onnipotenza, appartiene in effetti a una totalità dalla quale non
può astrarsi. La natura, il “Terzo escluso” secondo l’espressione di Michel Serres, deve tornare al centro
delle nostre preoccupazioni dopo qualche secolo di occultamento. Fin da ora dobbiamo lavorare alla
costruzione di una nuova civiltà che non ceda più alla visione ristretta di una natura separata dall’uomo
e fatta cosa (la natura concepita come “semplice cosa dispiegata”, priva di valore).
La crisi, un’occasione mancata?
4
Il capitalismo, in questo senso, non è immorale ma a-morale.
“Là dove cresce il pericolo cresce anche ciò che salva” diceva Hölderlin. Tuttavia, malgrado la
successione delle crisi economiche, dei rapporti allarmanti sullo stato del pineta (desertificazione,
rarefazione delle risorse…) o delle catastrofi ecologiche anche nel mondo sviluppato come l’uragano
Katrina o la recente marea nera che ha toccato la Louisiana, non cambia niente. Come spiegare una
simile inerzia? Bisognerà aspettare che l’Ovest degli Stati Uniti divenga un immenso deserto di sabbia o
che gli uragani facciano la loro apparizione in Europa perché i paesi sviluppati si decidano finalmente
ad agire?
La crisi economica che attraversiamo – la più importante dal 1929 – potrebbe invece costituire
un’occasione inasperata per cambiare di modello. Questo, tanto vantato negli ultimi venti anni, di un
capitalismo senza briglie portatore di ricchezze è nei fatti andato in mille pezzi. Nessuno potrà più
sostenere senza suscitare dubbi e perplessità che il mercato da solo possa risolvere i problemi
dell’umanità o anche che basterebbe sregolare, lasciare gli individui affrontarsi “liberamente” perché
siano risolti i problemi che questo stesso lasciar fare contribuisce abbondantemente a creare. Oggi, la
maschera è caduta. L’ideologia che si chiama, a torto, “neoliberale” (nella misura in cui il liberalismo è
una teoria politica opposta ai conservatorismi e ai privilegi5) ha perso davvero ogni credito. La crisi
economica come la crisi ecologica richiedono un rinnovamento radicale dei meccanismi produttori di
ricchezze, delle pratiche mentali individuali e collettive e delle forme di espressione democratiche.
Tuttavia dobbiamo constatare, dopo la crisi finanziaria del 2008, che tutto è continuato come prima: gli
Stati hanno socializzato le perdite rifinanziando le banche predatrici senza domandare loro dei pegni6;
nuove bolle finanziarie si gonfiano, in particolare sul mercato dei diritti a inquinare; i governi, sotto la
pressione dell’opinione pubblica, fanno finta di prendersela con i paradisi fiscali per non rimettere in
discussione i fondamenti sacri dell’edificio: libera circolazione dei capitali e delle merci, potere degli
azionisti, speculazione sprovvista di utilità sociale… Lungi dalla trasformazione radicale del mondo
della finanzia che ci si sarebbe potuto aspettare, assistiamo al contrario a misure omeopatiche desinate a
rendere il capitalismo finanziario… ancora più duraturo.
Come rimedio alla crisi ecologica, ci propongono il capitalismo verde. Ora, questo non è tale da poterci
rassicurare. La “crescita verde” si fonda su un’ondata di innovazioni tecnologiche che si suppone
risolvano la crisi climatica ed economica creando dell’impiego. In realtà, non soltanto la volontà politica
per assicurare investimenti simili è totalmente assente, ma in più, dato che nulla può essere prodotto a
partire da niente, la produzione di beni per quanto “verdi” possano sembrare, rischia nel migliore dei
casi di spostare i problemi (la macchina elettrica pone per esempio il problema della produzione e del
riciclaggio “ecologico” delle batterie); nel peggiore, di aggravare le cose dando l’illusione di essere una
soluzione. In realtà noi non pensiamo, per via della natura stessa del capitalismo che si caratterizza per
l’accumulazione del capitale (il “sempre di più”) e per la generalizzazione dei rapporti mercantili a tutte
le sfere della società, che un simile sistema sia capace di rispondere alle sfide sociali ed ecologiche che si
pongono nel nostro XXI secolo. Fondato sulla ricerca permanente del profitto, è difficile immaginare
come un tale sistema possa imporsi dei limiti nell’uso delle risorse e nella quantità dei beni prodotti.
Certo, il capitalismo ha mostrato, nel dopo-guerra, che era in grado di fare delle concessioni sociali
(New Deal di Roosevelt e applicazione del Keynesianismo), concessioni distrutte dalla rivoluzione
ultraliberale degli anni 1980-90; ma oggi il problema che si pone non è più solo quello della redistribuzione delle ricchezze, è anche quello della loro sparizione (se qui intendiamo il termine
“ricchezza” come “ricchezze naturali): al problema sociale del livello di vita si aggiunge quello,
5 Sul piano politico il liberalismo classico che emerge nel XVI secolo si presentava come una forza progressista e
rivoluzionaria poiché rimetteva in discussione l’assolutismo politico e religioso. Il liberali, difensori delle libertà pubbliche e
posti nella parte sinistra dell’emiciclo, si opponevano ai conservatori monarchici che stavano a destra.
6 Lo Stato francese, per esempio, ha iniettato alla fine del 2008 dieci miliardi di Euro nelle principali banche francesi senza
reclamare diritto di voto nei consigli di amministrazione né del plusvalore al momento del rimborso dei fondi avanzati
(prestiti a tasso 0). In definitiva, le regole di gestione non sono state cambiate e le banche hanno potuto riprendere la loro
routine speculativa…
ecologico, delle condizioni di vita delle popolazioni esistenti e delle condizioni di sopravvivenza di
quelle a venire.
Così, se la realizzazione di un “new deal verde”7 che regolerebbe, in qualche misura, le derive del
capitalismo attuale, ci sembra di gran lunga preferibile all’ideologia ultraliberale che dirige oggi la
maggioranza dei paesi sviluppati, compresi quelli che hanno un governo di sinistra, ci sembra tuttavia
che sia insufficiente per risolvere la crisi ecologica di cui sono responsabili i paesi ricchi. Nonostante il
suo termine negativo (o forse proprio in ragione del suo termine negativo che le impedisce di essere
recuperata dal capitalismo verde), la de-crescita ci appare così come il solo orizzonte in grado di
rompere con la logica capitalista dell’accumulazione indefinita e il progetto moderno dell’illimitato
promosso dalla scienza moderna. I veri utopisti non sono in effetti quelli che sostengono la riduzione
drastica dei nostri consumi ma quelli che ci fanno credere che questi possono crescere all’infinito. Fa,
per questo, un certo effetto vedere, leggere e ascoltare nelle varie emissioni della televisione, della radio
o nelle colonne dei giornali, i promotori del “sempre di più”, della “crescita infinita” qualificare come
“dolci sognatori” o come “pericolosi estremisti” quelli che difendono un modello di società più attento
alle risorse o anche alle “realtà materiali” del pianeta sul quale viviamo.
La libertà dei moderni e l’ hubris
Benjamin Constant, nel suo celebre saggio del 1819 De la liberté des anciens comparée à celle des modernes,
trattava della diversità tra le forme moderne e antiche di democrazia. Quella degli antichi consisteva in
una partecipazione attiva dei cittadini (democrazia diretta) e in una importanza primordiale accordata
alla polis rispetto all’individuo. Questi doveva sacrificarsi all’insieme al quale apparteneva e doveva il suo
status sostanziale di “cittadino” a questa appartenenza. Riassumendo: fuori della polis, nessuna salvezza.
Ecco perché Socrate, per esempio, rifiutò di fuggire dalla sua città e di contravvenirne le leggi malgrado
la sua condanna a morte. Al contrario, la libertà dei moderni mette al centro l’individuo e i suoi “piaceri
privati” ai quali può consacrarsi grazie a rappresentanti politici incaricati di difendere i suoi interessi e di
sollevarlo dal compito politico (democrazia indiretta). La libertà moderna non è dunque più la capacità
di esercitare la propria sovranità ma piuttosto quella di soddisfare la propria individualità a detrimento,
se necessario, della collettività alla quale l’individuo appartiene. Questa nuova concezione della libertà si
esprime nell’inflazione dei “diritti di” o “diritti a” e nella celebre dichiarazione francese dei diritti umani:
la mia libertà termina là dove comincia quella degli altri; libertà puramente negativa che consiste
nell’astenersi nel nuocere a quella altrui. Immancabilmente, una simile concezione che non definisce
alcun vivere insieme e nessun interesse generale (però necessario alla realizzazione di una vera
autonomia) porta allo scontro tra arbìtri individuali o anche all’assenza di civismo che oggi deploriamo.
Ognuno reclama per se l’assolutezza di una libertà che non saprebbe vedere limitata senza opporvisi;
ognuno si aspetta dalle leggi che limitino al minimo le proprie scelte di vita e i propri desideri. Può una
simile concezione perdurare in un mondo che si scopre da ogni parte finito e che deve, per questo, per
forza di cose regolamentare il potere di consumo di ciascuno? La nozione di “bene comune” da
preservare si accorda con l’ideologia che promuove la libertà infinita di ognuno?
Il liberalismo economico, ideologia fondata sulla possibilità teoricamente data a ciascuno di
“massimizzare i suoi vantaggi” e di favorire i suoi interessi particolari è certo seducente perché fa di
ogni individuo “un impero nell’impero”. Invece, tenere in conto le necessità ecologiche esige il
ripensamento della libertà individuale e il suo posto nell’edificio dei valori a misura di queste nuove
sfide. E’ certo un’idea difficile da ammettere per noi, eredi di un individualismo che pretende essersi
liberato da ogni limite ma che alla fine si riduce, nel nuovo regime ultraliberale, alla possibilità di
consumare per quelli che ne hanno i mezzi e di investire per quelli che possiedono dei capitali. E’
questa concezione liberale che è stata l’alleata decisiva del capitalismo nel suo progetto funesto di
crescita illimitata. Progetto “funesto”, in effetti, sia dal punto di vista sociale che di civiltà ed ecologico:
7 Come lo promuove per esempio il partito dei Verdi, ma anche numerosi ambientalisti come Nicolas Hulot, Joseph Stiglitz
o Paul Krugman ecc. Per la descrizione di questo new deal verde e dei suoi limiti, si veda l’eccellente libro di Thomas Coutrot,
Jalons vers un monde possible, Le bord de l’eau, 2010.
aumento delle ineguaglianze tra paesi del nord e del sud ma anche all’interno dei paesi ricchi stessi,
riduzione dell’essere umano occidentale a una semplice “macchina desiderante”, “consumo” della
nostra nicchia ecologica… Ecco quelle che ne sono le conseguenze inevitabili.
Dopo gli anni 80-90 e la caduta del muro di Berlino, il liberalismo si è in effetti trasformato in ultraliberalismo planetario, ideologia devastatrice che si appoggia sulla “governance”, e cioè sulla gestione
comune da parte delle oligarchie politiche e finanziarie del destino dell’umanità. In altri tempi, lo Stato
poteva disporre di una relativa indipendenza nei confronti del capitale (come lo ha dimostrato il New
Deal nordamericano negli anni trenta o l’applicazione in Francia del programma del Consiglio nazionale
della resistenza nel 1945). L’ultra-liberalismo si appoggia oggi sulla forza coercitiva dei governi per
imporre a tutti i livelli della società la logica dei mercati e dell’accumulazione illimitata del capitale.
Questa è l’opera di ciò che Félix Guattari chiama Capitalismo mondiale integrato (CMI), e cioè “l’impero di
un mercato mondiale che lima i sistemi particolari di valori, che mette sullo stesso piano di equivalenza
i beni materiali, i beni culturali, i siti naturali, ecc.”, al quale si aggiunge un sistema di dominio “che
mette l’insieme delle relazioni sociali e delle relazioni internazionali sotto la mano delle macchine
poliziesche e militari8”. Questa ideologia incontestata che non incontra quasi nessuna opposizione
organizzata e che diffonde la propria propaganda grazie ai supporti mediatici acquisiti dai grandi gruppi
finanziari, orchestra una degradazione delle condizioni di vita a tutti i livelli. A livello economico, gli
Organismi Internazionali (FMI, OMC, Commissione Europea…) impongono una de-regolazione e una
privatizzazione dei servizi pubblici, destinate a favorire l’accumulazione dei profitti per pochi; a livello
politico, il sostegno attivo dei governi ai mercati comporta una regressione democratica o perfino una
scissione tra la sovranità teoricamente popolare e l’esercizio reale del potere, un gran numero degli eletti
avendo in sostanza aderito alla causa dei mercati; a livello sociale, le tensioni e le ineguaglianze
economiche generate da questa ideologia impongono un forte controllo sulle popolazioni e una
focalizzazione sempre più inquietante sulla sicurezza (tema che ha come corollario, come lo vediamo
bene oggi, la scelta di vittime espiatorie e la montata di arcaismi conservatori inquietanti).
La logica della massimizzazione degli interessi individuali impone in effetti che lo Stato divenga sempre
più costrittivo, per non dire “poliziesco”, per tenere insieme persone che hanno perso il senso della
loro esistenza collettiva (quando questa deriva politica non derivi da un semplice calcolo…). In effetti, a
livello individuale il CMI spinge le pulsioni di avidità, l’individualismo e il cinismo che ipotecano
pesantemente le condizioni del “vivere insieme”. Come lo dice J. C. Michéa: “l’unica forma di libertà
che per un liberale è realmente universalizzabile [è] quella del consumatore ‘cool’, ‘hype’ e ‘nomade’
addestrato a desiderare tutto e il suo contrario a seconda delle esigenze in continuo cambiamento del
mercato mondiale.”9
Questa “logica liberale” significa molto semplicemente la fine della politica intesa come costruzione di
un vivere-insieme collettivo e deliberato: ognuno è rinviato, in quanto consumatore o imprenditore, alla
sua libertà sovrana, alla sua capacità infinita di possedere più degli altri, di liberarsi da ogni costrizione
che sia d’ordine morale, sociale o ecologico. A livello politico segna la fine dell’indipendenza dei nostri
governi nei confronti dell’ordine economico. Nonostante sia in crisi dappertutto (a livello economico,
ecologico e sociale) questa ideologia continua a essere difesa con forza dal mondo mediatico e politico.
Ovunque, i dirigenti occidentali (socialisti compresi…) applicano la formula secondo la quale “bisogna
curare il male con il male” e colgono l’occasione della crisi di questo sistema per imporlo con maggiore
fermezza: rigore, sregolazione, smantellamento dei servizi pubblici e della protezione sociale. Il popolo
è chiamato a pagare il conto economico degli speculatori come ben presto gli verrà imposto di pagare,
attraverso tasse e restrizioni di ogni genere, il conto ecologico di una logica così profondamente
predatrice.
Tuttavia, se questo modello continua a essere difeso, non è solo per via della mancanza di
immaginazione dei nostri dirigenti o delle loro eventuali collusioni con il mondo finanziario. E’ anche
8
9
Les trois écologies, Paris, Galilée, 1989, pp. 14-17
Jean-Claude Michéa, La double pensée, Parigi, Flammarion, 2008, p. 46
perché l’immaginario capitalista e la sua forza simbolica (come crescita illimitata e cultura del consumo)
sono così profondamente ancorate in ciascuno di noi che la loro rimessa in discussione sarebbe, agli
occhi della maggioranza, una eresia pura e semplice. L’ecologia, in questo senso, è sovversiva. Come
scrive Cornelius Castoriadis, “mette in discussione l’immagine capitalista che domina il pianeta. Ne
rifiuta il motivo centrale, secondo il quale il nostro destino è l’aumento senza fine della produzione e
del consumo. Mostra l’impatto catastrofico della logica capitalista sull’ambiente naturale e sulla vita
degli umani.”10
E’ dunque questo immaginario che oggi deve essere rimesso in discussione, non solo per degli
imperativi ecologici ma anche in ragione di imperativi di civiltà: quale può essere l’avvenire di una
società che si è fissata come progetto finale il consumo per il consumo senza nessun riguardo per la sua
utilità sociale?
Un mondo senza soggetti
Ciononostante, come immaginare un’occasione migliore di quella che ci offrono la crisi ecologica e la
crisi economica per prendere coscienza degli effetti deleteri del modello che si perpetua sotto i nostri
occhi? Economisti e scienziati di buona fede moltiplicano i segnali di allarme, ci mettono in guardia
contro le conseguenze disastrose generate dalla perpetuazione di un simile sistema. Sappiamo meglio
delle generazioni precedenti ciò che ci aspetta se non facciamo niente. Il problema, tuttavia, per
riprendere una formula di Jean-Pierre Dupuy, è che “non crediamo a ciò che sappiamo”. Ci capita
d’altra parte spesso di dire, con aria infastidita “Lo so!, lo so!” a proposito di questioni di cui, appunto,
vorremmo non saperne di più. In questi casi è in nome di un preteso sapere che preferiamo rifugiarci
nell’ignoranza. Così accade per la crisi ecologica: tutti sanno “lo so, lo so, lo sappiamo” ma, in realtà,
pochi credono davvero alla gravità della situazione.
Una delle cause di questa inerzia deriva dallo “sfalsamento prometeico” (dal Dio Prometeo che aveva
voluto far concorrenza agli Dei dell’Olimpo) tra il nostro potere e la nostra immaginazione, o più
esattamente, tra la nostra facoltà di sentire e le nostre capacità di azione 11 . E’ certo una simile
constatazione che faceva Einstein quando diceva “ciò che caratterizza la nostra epoca è la profusione
dei mezzi e la confusione dei fini”. Siamo perciò incapaci di immaginare la portata delle nostre azioni,
di provare, per empatia, l’ampiezza delle sofferenze che causiamo alle popolazioni e alle categorie
sfruttate o che causeremo alle generazioni future. E’ dunque su una vera presa di coscienza delle
conseguenze dei nostri comportamenti che può inizialmente appoggiarsi la trasformazione
antropologica necessaria.
Un’altra causa di inerzia sta nel fatto che non ci sentiamo capaci di agire. La crisi sembra superare il
nostro campo di competenza: “che volete che ci faccia?”. Da qui, la tendenza comoda ad affidarci agli
esperti scientifici che finiranno per trovare “qualcosa” o ai nostri rappresentanti che, dopo tutto (come
vuole la professionalizzazione della politica) “sono pagati per questo”. Il compito sembra troppo
complesso e troppo pesante perché possiamo sentirci capaci di farcene carico personalmente. E poi,
qualsiasi cosa facciamo, le iniziative popolari sono inascoltate o archiviate da parte dei politici. “Non è
la strada a governare”, ha detto uno dei nostri ministri. Dato che non si sente “attore”, agente di questa
crisi, l’individuo non se ne sente neppure “responsabile”. Dall’irresponsabilità all’indifferenza, non c’è
poi che un passo.
La presa in carico dell’avvenire si potrà effettuare solo lottando contro tutte le forme di alienazione di
cui oggi siamo vittime, la prima delle quali deriva appunto dalla credenza profondamente radicata nella
nostra impotenza. In effetti, essa è fortemente alimentata dalla doxa politica che spesso si riferisce anche
“L’écologie contre les marchands”, in Une société à la dérive, Seuil, 2005 (postumo) p. 237
Per un’analisi di questa degradazione della facoltà di sentire, vedere il libro di Jean-Clude Besson Girard, Decresendo
cantabile, Lione, Parangon, 2005.
10
11
al carattere “inesorabile”, “ineluttabile” degli avvenimenti che viviamo o, su un altro registro, al
carattere evidentemente troppo complesso delle soluzioni che il comune mortale dovrebbe immaginare.
Ora, è attraverso il prendere in considerazione la nostra capacità di cambiamento, la messa in opera di
nuove pratiche sociali emancipatrici in tutti i campi dell’esistenza che potrà effettuarsi la trasformazione
necessaria: nel nostro lavoro, nella nostra vita quotidiana, nell’esercizio della nostra democrazia e nella
costruzione stessa della nostra soggettività. Altrettanti processi di liberazione che dobbiamo da ora
mettere in opera per conquistare la nostra autonomia. Il Soggetto in quanto tale appare solo nel porsi in
ribellione contro le disposizioni sociali e i determinismi che lo controllano. E’ sempre, come diceva
Alain Touraine, un cattivo soggetto, ribelle al potere e alle regole, alla società come apparato totale. Il
suo atto di fondazione è in effetti la ribellione contro ciò che la società gli fa fare o subire12.
E’ dunque contro l’ “esistenza strumentalizzata” che dobbiamo lottare, contro il conformismo dolce
che ci impone la società mercantile e contro la passività alla quale ci invitano coloro che decidono. Non
dobbiamo neppure “abbandonarci alle nostre attività”, ma al contrario prenderle in carico e dar loro un
senso, viverle alla luce della coscienza. Se il pensiero ecologico può condurci all’autonomia, alla
resistenza contro ogni forma di alienazione, è prima di tutto perché mette in prima linea il potere del
soggetto paradossalmente destituito dalla nostra modernità liberale, perché è da lui che verrà la risposta
alla crisi e sicuramente non dagli esperti o dai tecnocrati che hanno pazientemente costruito la tela nella
quale oggi siamo tutti presi.
Il “liberalismo” chiude in effetti gli individui doppiamente. Prima di tutto, nella sua forma politica
organizza il “dispotismo dolce” trasferendo il potere dei cittadini a delle nuove oligarchie (lobbie,
rappresentanti politici o strutture amministrative) privandoli così del loro potere di decisione. Poi, nella
sua forma economica, alimenta l’illusione di una libertà illimitata dei consumatori che si rivela, se la si
analizza, solo una libertà o addirittura un “obbligo” al consumo. Nei due casi, siamo confrontati a una
vera delega di potere che rimette in discussione l’autonomia reale (e non solo proclamata) degli
individui. Non dimentichiamo a questo proposito che l’autonomia degli individui sulla quale sono
fondate le nostre democrazie, richiama nelle sue origini etimologiche (auto-nomos) la capacità di dare a se
stessi le proprie leggi. L’ecologia filosofica ci porterà così inevitabilmente a ripensare l’idea di
democrazia: “una società democratica è una società autonoma” ( C. Castoriadis), e cioè una società
adulta, responsabile e liberata dai capricci infantili oggi alimentati dalla società dei consumi.
La crisi dell’umanesimo moderno: ecologia e filosofia
Quale rapporto può avere l’ecologia con la filosofia? In un momento in cui si parla a torto e traverso di
ecologia, in cui si usa questo concetto senza discernimento né precauzione come un argomento da
vendere o come un nuovo ornamento del pensiero “politicamente corretto” (“eco-confezione”, ecoindustria”, “macchina ecologica” e anche “ecologia dell’amore”), il lavoro del filosofo consiste appunto
nel ri-definire ciò che uno spreco intempestivo, uno gioco frivolo e interessato hanno lasciato che si
perdesse. Lì l’ecologia richiama vagamente l’idea di qualcosa di “buono per la salute” (il bio), o anche
per lo spirito (“ecologia dello spirito”), qualcosa di “umanista”, di “progressista”. In breve, l’ecologia è
“hype”, fa “tendenza”. Il bio e l’ecologia hanno il vento in poppa. E facciamo dunque dell’ecologia!
Dopo “l’impresa cittadina”, luogo elevato di partecipazione democratica e garantista, certo… del
benessere dei salariati, ora ci propinano l’impresa “eco-responsabile”: IBM, Microsoft, HP, Google,
ecc. Tutte le grandi multinazionali affiggono le loro etichette bio perché hanno perfettamente capito
che l’ecologia sarebbe divenuta un elemento essenziale della comunicazione e del marketing del III
millennio. Recuperato dall’industria o dal business del ben-essere, questo concetto “portante” ci lascia
interdetti. Non si può che essere stupiti di fronte al cinismo di un sistema che ricicla nel suo seno il
male che nutre cercando ancora, fino a che morte non venga, di trarne profitto. La filosofia, a questo
12 “E’ il gesto di rifiuto, di resistenza, che crea il soggetto. E’ la capacità più limitata di prendere distanza rispetto ai propri
ruoli sociali, la non appartenenza e il bisogno di contestare che fanno vivere ciascuno di noi come soggetto.” Critique de la
modernité, Parigi, Fayard, 1992, p. 318.
proposito, come agente di chiarificazione dei concetti, deve prendere il concetto di ecologia e
analizzare, a partire da questo tema, i legami che l’uomo intrattiene con la natura.
Se la filosofia può chiarire il concetto di ecologia, non ha tuttavia la vocazione di proporre una nuova
scienza della natura: può solo dare senso alla concezione scientifica dell’ecosistema e criticare il
riduzionismo scientifico che ha meccanizzato la natura, col rischio di dimenticare la vita e il movimento
che li abitano. La filosofia non ha neppure l’ambizione di spiegare come “gestire” meglio gli spazi
naturali e neppure quale potrebbe essere un modo diverso di produzione. Molte opere tecniche scritte
molto bene servono perfettamente allo scopo. La filosofia ci permette di pensare la nostra vita
“moderna”, di analizzarne le sorgenti e le derive e, eventualmente, di far intravvedere la possibilità di
una “nuova modernità”. La filosofia dell’ecologia, per questo, deve essere capace di rimettere in
discussione il dogma dualista (separazione natura-cultura) che fa dell’uomo un essere a parte nel
mondo, o ancora “un impero in un impero”, oltrepassando i limiti della sua propria condizione.
Ma la filosofia ecologica deve anche diffidare della tentazione naturalista che consiste nel vedere nella
natura dei valori morali o estetici oggettivi che si dovrebbero rispettare o imitare (come certi
“ecologisti” che idealizzano la natura al punto da dirci che si dovrebbe “seguirla”). A questo proposito
la natura è un vero e proprio “albergo spagnolo”: vi troviamo molto spesso solo i valori che vi abbiamo
noi stessi portato. Ci si potrebbe vedere sia della bellezza che della bruttezza, dell’armonia come della
violenza… In realtà, è solo l’uomo a prescrivere, a attribuire dei valori: è lui che sceglie quelli che vuole
rispettare; la natura, lei, non può esprimersi in proposito, contrariamente all’uso che ne fa il
naturalismo.
Pensare l’ecologia filosoficamente comporterà necessariamente l’istruzione di un processo contro una
certa filosofia occidentale, che sia antropocentrista (mettendo l’uomo al centro) o naturalista (mettendo
al centro la natura). Se la filosofia si dimostra indispensabile per fondare un pensiero ecologico,
l’ecologia, quanto a lei, si dimostra il mezzo più sicuro per fare il processo a questi due riduzionismi
filosofici.
Una nuova filosofia della natura
Abbiamo bisogno di un nuovo sistema di idee che permetta di vedere il mondo, di strutturare il reale o
anche di fornirci una “visione del mondo”. Il reale prende forma, esiste, non appena ci sono parole per
nominarlo. Dove sono questi nuovi “ecologi”, i nuovi pensatori dell’ecologia? Va anche sottolineata
l’ostilità confessata dagli intellettuali francesi nei confronti del “pericolo ecologico”: l’accusa confusa di
antimodernismo non viene soltanto da Luc Ferry e dalla sua opera emblematica (dall’ignoranza di un
certo ambiente intellettuale, razionalista e pseudo umanista), Le nouveau ordre écologique, ma anche da
personalità rispettabili come Marcel Gauchet (“Sotto l’amore della natura, l’odio degli uomini”, Débat,
60, 1990) o ancora François Dragognet (autore di Nature, 1990) firmatario con Pierre Bourdieu,
Umberto Eco, Eugène Ionesco, Henri Laborit e tanti altri dell’appello di Heidelberg alla vigilia del
Vertice di Rio del 1992, manifesto nel quale 200 personalità firmatarie (tra le quali d’altronde, molto
pochi erano i veri specialisti dell’ecologia) affermavano che “l’umanità ha sempre progredito mettendo
la natura al suo servizio, e non viceversa” e dichiaravano di essere preoccupati per “l’emergere di una
ideologia irrazionale che si oppone al progresso scientifico e industriale [e che] nuoce allo sviluppo
economico e sociale.” Ci si è accorti poi, della serie “manipolazioni svelate troppo tardi”, che grandi
gruppi industriali avevano manovrato per suscitare questo appello. Questa mobilizzazione contro il
pensiero ecologista (in quanto “anti-moderno”) è stata allora possibile senza che ci sia stato un vero
dibattito con posizioni contradditorie.
Nel dicembre 2006 Telerama ha pubblicato un numero speciale ecologico che aveva come titolo:
“Ecologia: il silenzio degli intellettuali francesi”. Se la Francia è così silenziosa riguardo all’ecologia,
contrariamente ai paesi anglosassoni o anche alla Germania, è in gran parte per via della sua tradizione
filosofica dualista e umanista che fa dell’uomo un essere a parte nel mondo. Come diceva Spinoza,
“Sembra che concepiscano l’uomo nella Natura come un impero nell’impero”. Qui è presa di mira la
rappresentazione di sé, antropocentrica e scissa, del soggetto moderno. Dobbiamo assolutamente
impegnarci in una nuova definizione del posto dell’uomo nel suo mondo, in una nuova filosofia della
natura 13 dove questa sia, se non “rispettata”, almeno presa in seria considerazione. L’uomo non è “un
impero nell’impero”. Fa parte integrante di questa natura che secoli di antropocentrismo hanno cercato
di denigrare.
La natura, contrariamente a ciò che veicola il pensiero accademico, non è in effetti un oggetto vuoto
che non offrirebbe niente su cui pensare. La crisi ecologica, legata all’antinaturalismo della nostra civiltà,
non potrà essere risolta fino a che ci rifiuteremo di pensare filosoficamente la natura e insieme la nostra
stessa naturalità.
13 Tra i rari intellettuali francesi che si sono lanciati in questa impresa, vanno citati Catherine e Raphael Larrère e in
particolare il loro testo illuminante, Du bon usage de la nature. Pour une philosophie de l’environnement, Parigi, Flammarion, 2009.