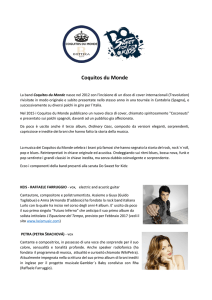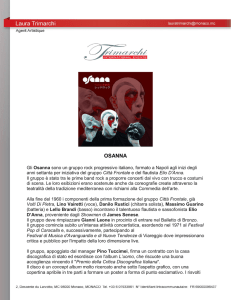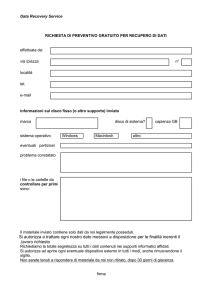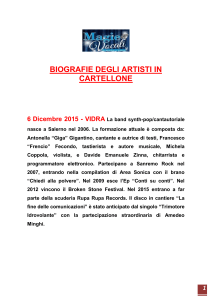digital magazine giugno 2010
Flying
Lotus
N.68
The Divine
Comedy
Pavement
Ufomammut
Sikitikis
David Maranha // Villagers // Ariel Pink // Avi Buffalo // Peckinpah
Clouds in a Pocket // was // Alessandro Fiori // Funki Porcini
68
Sentireascoltare n.
Turn On
p. 4
David Maranha
5
Villagers
6
Ariel Pink
7
Avi Buffalo
8
Peckinpah, Clouds in a Pocket, was
10
Alessandro Fiori
12
Funki Porcini
Drop Out
20
The Divine Comedy
28
Flying Lotus
Tune In
14
Ufomammut
17
Sikitikis
Recensioni
36
Born Ruffians, Emeralds, Excepter, Indian Jewelry...
Rearview Mirror
92
The Cure, Pavement, Frank Zappa, Starfuckers...
Rubriche
88
Gimme Some Inches
90
Re-boot
102
Giant Steps
103
Classic Album
104
La Sera della Prima
SentireAscoltare online music magazine
Registrazione Trib.BO N° 7590 del 28/10/05
Editore: Edoardo Bridda
Direttore responsabile: Antonello Comunale
Provider NGI S.p.A.
Copyright © 2009 Edoardo Bridda.
Tutti i diritti riservati.La riproduzione totale o parziale,
in qualsiasi forma, su qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo,
è proibita senza autorizzazione scritta di SentireAscoltare
Direttore: Edoardo Bridda
Direttore Responsabile: Antonello Comunale
Ufficio Stampa: Teresa Greco
Coordinamento: Gaspare Caliri
Progetto Grafico
e
Impaginazione: Nicolas Campagnari
Redazione: Antonello Comunale, Edoardo Bridda, Gabriele Marino, Gaspare Caliri, Nicolas Campagnari, Stefano Pifferi,
Stefano Solventi, Teresa Greco.
Staff: Leonardo Amico, Marco Boscolo, Giancarlo Turra, Diego Ballani, Fabrizio Zampighi, Luca Barachetti,
Fabrizio Zampighi, Andrea Napoli, Marco Braggion
Guida
2
In
spirituale:
copertina:
Adriano Trauber (1966-2004)
flying lotus
C
ompositore rock-minimalista dalla sopraffina ricercatezza timbrica, il portoghese David Maranha
è uno dei più interessanti talenti usciti da quella fucina
malinconica e apparentemente periferica che è la Lisbona del nuovo millennio.
Dopo aver dato il via alla seminale esperienza Osso
Exotico ed aver girovagato nel mondo dell’avanguardia
borderline tra sperimentazione minimalista, musica concreta e rock di confine con personaggi come Z’ev, Francesco Dillon e gli australiani Minit, catalizzando intorno
a sé un nucleo mobile e avventuroso di sperimentatori
sonori (Loosers, Curia, Gala Drop), David ha intrapreso
un percorso in solo in cui confluiscono le sue grosse
passioni musicali, ovvero una forma dilatata di rock acido
e reiterato e un neo-minimalismo che più ossessivo e
compresso non si può. Antarctica è la sua ultima release e per immaginario e atmosfere rappresenta l’ideale
seguito dell’epocale Marches Of The New World, a testimonianza di un percorso di ricerca sui suoni e sulle
suggestioni lontano dall’essere concluso, come lo stesso
David, contattato via mail ci conferma: Considero ogni
lavoro come parte di un processo continuo. Questo sarebbe il seguito di Curia II, anche se c’è una sorta di
approccio riconoscibile che da Circunscrita passa per
Marches e arriva a Antarctica.
4
Villagers
Turn On
Turn On
David
Maranha
—Ad libitum...—
—Per conto proprio—
Rock e minimalismo: un suono
preso dal corpo morente del rock
e reiterato all'infinito. Questo il
credo del compositore portoghese
David Maranha.
Un disco di formazione e un
percorso esistenzial- musicale per
l’esordio di Conor J. O’Brien con
il progetto Villagers.
E quell’approccio dietro gli ultimi lavori è sempre lo
stesso: i Velvet più acidi e dilatati trattati con la lente dei
campioni del minimalismo come La Monte Young, Tony
Conrad, Terry Riley. Tutti questi artisti propongono musica che amo, ma ce ne sono altrettanti che mi hanno
influenzato. A Maranha però interessa il processo, non
l’immagine di qualcosa che ha ascoltato e non ha problemi nell'affermare che non gli interessa scoprire qualcosa
di nuovo. Nella sua mente, per esempio, c'è Yves Klein
che con la sua Monotone Symphony del 1958 è molto
più seminale dei riferimenti che solitamente gli si appioppano. È un po’ come la relazione tra Hieronimus Bosch
e il surrealismo. Yves Klein è un visionario e merita di
essere riconosciuto per il lavoro che ha iniziato e che fu
poi seguito da artisti come Conrad, Riley,Young.
In pratica, nelle musiche di Maranha convivono la tensione del rock e la forza ossessiva del minimalismo e non
che questo sia un problema o generi alcun conflitto in
lui. Cerco di viverla in un modo che abbia senso per me,
prima di tutto. Come biasimarlo. Le catalogazioni hanno
senso per mettere ordine e presentare degli argomenti,
viverli è tutto un altro paio di maniche. Stefano Pifferi
C
onor J. O’Brien, mente pensante dei Villagers, si
mostra abbastanza imbarazzato dagli ingombranti
paragoni fatti dalla stampa nei suoi confronti con Conor
Oberst ed Elliott Smith, di cui peraltro è fan da sempre.
Il moniker Villagers circola da almeno un anno e mezzo
nell’ambiente per alcuni singoli ed EP, confermandosi ora
nome piuttosto interessante con il bell’esordio Becoming A Jackal su Domino, un pop chamber personale ed
espressivo che colpisce per intensità emotiva..
I Villagers nascono dopo una delusione, quella per lo
scioglimento un paio di anni fa del primo gruppo di Conor, The Immediate, a seguito di sfortunate vicissitudini
contrattuali. La band era divisa a metà con l’amico d’infanzia Dave Hedderman, con il quale il Nostro condivideva le esperienze musicali sin dall’età di 12 anni. Sciolto
il gruppo, ma non l’amicizia, O’Brien si dedica al suo songwriting, anche se già durante la permanenza negli Immediate aveva provato a comporre per conto proprio.
Il nuovo gruppo, di fatto sua esclusiva creatura, nasce
allora con questi presupposti. “Cerco di non aspettarmi
niente ora, dopo le esperienze precedenti negative, e di
non dar nulla per scontato. Negli Immediate prendevo
tutto troppo seriamente e a un certo punto si era creata
moltissima pressione. Ho imparato adesso a concentrarmi solo sulla musica e ad essere più attento”. Un contatto con la Domino nato durante un concerto a supporto
di Cass McCombs si trasforma positivamente in contratto, e da qui nascono le basi per Becoming A Jackal,
che è un disco di formazione come il più classico degli
esordi, arrangiato e suonato quasi per intero da Conor.
Di songwriting pop si tratta, talvolta sinfonico, intimistico e malinconico quanto basta, con le necessarie inquietudini e variazioni stilistiche. Un percorso di iniziazione
(la storia un ragazzo sciacallo che cerca il suo posto in
mezzo agli uomini) informa il concept attorno al quale
ruota l’album, in cui si raccontano una serie di prove che
implicheranno la crescita e la conseguente evoluzione
del protagonista.
Si schermisce con imbarazzo Conor, dopo le prime
reazioni positive, dei paragoni ingombranti fatti con alcuni suoi miti (Smith e Oberst), dribblando elegantemente
e con il corretto approccio per uno agli inizi, rivelando
che “scrivere una canzone in realtà non è un processo isolato
e non dev’essere preso troppo seriamente, ma con il giusto
spirito e humour. Il segreto è sorprendersi, se non lo sono io
per primo, non sono soddisfatto del risultato”.
Umiltà e ironia non gli mancano di certo, insieme a
una buona dose di personalità. Ne sentiremo senz’altro
parlare.
Teresa greco
5
Avi
Buffalo
—Tempo di raccolta—
—Piccoli folk singer
crescono—
Quello della bassa fedeltà non è mai
stato un dogma. Con il nuovo album
Ariel Pink cambia etichetta, si
rimette in discussione ed è pronto a
mettere a frutto anni di gavetta DIY.
Avere vent'anni e un talento
eclettico e raffinato: facciamo la
conoscenza con la nuova, splendida
realtà indie folk californiana e il suo
giovanissimo leader.
F
è
passato un anno da quando Mr. Pink lamentava di
non aver mai ricevuto vere offerte da etichette.
Oggi, l'"old fashion support" che cercava è arrivato dalla
4AD. "E' vero, ma non parlavo di pacche sulle spalle e parole
d'incoraggiamento - afferma causticamente - No, grazie! Put
your money where the mouth is!".
Raggiunto via mail, l'artista ci racconta com'è cambiata la
sua vita nel suddetto arco di tempo, a partire dai primi
contatti con la con la nuova label. "Ho conosciuto Simon
Hallyday quando era alla Warp. Ci siamo persi di vista per
un po', poi ho scoperto che dirigeva l'ufficio della 4AD. Così
gli abbiamo inviato del materiale spiegando la direzione che
volevamo prendere".
Cosa non andava con la Paw Tracks? "L'esperienza con
la Paw Tracks è stata importante, ma ci sono solo alcune cose
che una label del genere può fare. Nei miei riguardi non hanno mai avuto l'esclusiva. Potevo pubblicare materiale anche
per altre indipendenti. Con 4AD invece il rapporto è usclusivo
e mi auguro che facciano il possibile per trarre profitto dal
loro investimento".
Questo significa che non pubblicherai più CD-R? "No,
a meno che non sia costretto a farlo".
Diversa l'etichetta e diverso l'approccio in sede di registrazione. "E' stato tutto prodotto in digitale, con pro tools,
6
Turn On
Turn On
Ariel Pink
mixato e registrato a più riprese. L'abbiamo realizzato come
una vera band, lavorando e riarrangiando nuovi brani e altri
che non avevo mai pubblicato".
Si dice che sia stato registrato negli home studios di
Tito Jackson, fratello di Michael. "Ci abbiamo passato tre
giorni, principalmente per sistemare le parti di batteria. Per
il resto è stato realizzato alla House Of Blues. E' stato Sunny Levine (produttore nonché nipote di Quincy Jones, ndr) a
prenotarla e a chiamare Rikk Pekkonen come ingegnere del
suono".
Adesso partirà il tour che lo porterà in giro per il
mondo, sebbene lui stesso in più occasioni abbia ammesso di non prediligere la dimensione live. "Dal 2004
sono stato in tour circa 3-4 volte all'anno per mesi, provando
e riprovando le canzoni per adattarle ai vari cambi di line
up. In tutto questo periodo, ufficialmente, non sono mai stati
rilasciati album e non c'è stato supporto dall'etichetta. Il mio
agente è stato la mia ancora di salvezza, nel senso che per
tutto il tempo mi ha pagato l'affitto e mi ha tenuto lontano
dalla strada. Suonare dal vivo, andare in tour, avere una band:
un tempo tutto questo mi era estraneo, ma oggi è quello che
so fare meglio". Diego Ballani
accia pulita e un'età in cui, solitamente, i suoi coetanei si limitano a suonare a qualche raduno scolastico: la band di Avigdor Zahner-Isenberg (Avi per gli amici)
è la nuova promessa targata Sub Pop, e a giudicare dalla
maturità del suo songwriting, sembra che tale fiducia sia
stata ben riposta. La sua storia inizia prestissimo, nel garage di casa: "Ho iniziato a suonare la chitarra quando ero
in seconda media. In quel periodo mi esercitavo con classici
blues e rock. Poi mi ho conosciuto i Wilco e ho iniziato ad
appassionarmi a jazz e musica sperimentale".
Faccia pulita e un'età in cui, solitamente, i suoi coetanei si limitano a suonare a qualche raduno scolastico:
la band di Avigdor Zahner-Isenberg (Avi per gli amici) è
la nuova promessa targata Sub Pop, e a giudicare dalla
maturità del suo songwriting, sembra che tale fiducia sia
stata ben riposta.
La sua storia inizia prestissimo, nel garage di casa: "Ho
iniziato a suonare la chitarra quando ero in seconda media.
In quel periodo mi esercitavo con classici blues e rock. Poi mi
ho conosciuto i Wilco e ho iniziato ad appassionarmi a jazz
e musica sperimentale".
L'ispirazione folk, gentile e rarefatta, è frutto di una
serie di esperienze musicali sorprendentemente eterogenee per un diciannovenne: "Ho suonato blues con vecchi
amici, studiato jazz e suonato in una jazz band a scuola, in un
gruppo gospel a Los Angeles e salutariamente con un gruppo
R&B". Il resto dei Buffalo sono amici avvicinati a scuola nel
corso degli anni: "con Sheridan (Riley, il bassista) abbiamo iniziato a suonare insieme alle medie, con Rebecca e Arin (Co-
leman e Fazio, rispettivamente voce/tastiere e basso) al terzo
e quarto anno di liceo". Poi è arrivata la Sub Pop. "E' stato
Aaron Embry, che ha registrato il nostro disco, a metterci in
contatto. Aveva parlato di noi al manager dell'etichetta, ma
hanno aspettato che avessimo registrazioni più professionali
prima di contattarci".
Non poteva essere altrimenti. L'etichetta americana
ha un peso specifico rilevante nell'immaginario musicale della band. "Non ci sembra vero di essere parte della
famiglia. Avevo tredici anni quando ho iniziato ad ascoltare
Nirvana e Shins".
A proposito di Shins: sarà la fragile vocalità di Avi,
saranno le tiepide melodie temprate al sole dei Beach
Boys, ma i paragoni con la band di James Mercer si sono
sprecati. "Ho iniziato ad ascoltarli in un'età in cui musicalmente assorbi tutto come una spugna: ovvio che facciano
parte del mio background".
L'intellighentia indie ha imparato a conoscerli e ad apprezzarli al SXSW, prima fortunata tappa di una tournée
che li vedrà protagonisti in numerosi festival. "Adoro i festival è un modo splendido per vedere e conoscere nuove
band. Il massimo sarà partecipare all'ATP, a settembre".
E per il futuro? E' qui che traspare l'entusiasmo del
diciannovenne: "Ci sono tanti artisti con cui mi piacerebbe
collaborare, anche al di fuori della band. Non vorrei dire troppo, ma uno dei prossimi progetti sarà con il mio amico Luis
Gutee. E poi, naturalmente, spero tanti altri".
Diego Ballani
7
Turn On
Peckinpah/
Clouds In A
Pocket/
WAS
—Utopie in scatola—
Scorie di sogno americano e rimasugli
psych-pop d'Albione: tutto fa
gioco se in gioco c'è il senso stesso
dell'oggetto-disco. Da reinventare
anzi da riciclare. Come il folk
riciclato di Canebagnato.
8
C
anebagnato è un'etichetta milanese tanto piccola
quanto accanita. Come ce ne sono tante, d'accordo, ma intanto può vantare un logo dall'appeal irresistibile, come del resto la ragione sociale. Poi c'è la dignità
di chi oppone alla povertà dei mezzi la cura delle proprie idee, la cocciutaggine di chi sceglie l'autunno come
stagione di riferimento malgrado il volgere delle stagioni
(una stagione buona per tutte le stagioni?), il sogno utopico - o la toccante velleità - di restituire al disco (al cd)
un'identità e un senso al gesto di acquistarlo. Così da
"creare qualcosa d'importante (...), almeno per qualcuno".
E infatti, se il roster non è particolarmente affollato (ad oggi conta otto artisti), è vero però che nomi
come Mauve e Gabriel Sternberg ti accendono ricordi particolari, sono piccole insidiose promesse che
non hai mai smesso davvero di aspettare. Una strategia
non eclatante, che non vuole spaccare in due l'onda né
aggredirti come un siluro underground, ma fieramente
galleggiare. Perché la qualità, come la cacca, non va a fondo. Ritorna sempre, è tenace e nutritiva, sfida il tempo e
l'indifferenza del momento. In questo senso è piuttosto
significativo il caso di Paolo Tedesco da Mazara del Vallo,
che nella vita reale fa il venditore di auto e nell'altra
si è inventato questo progetto Clouds In A Pocket.
Inizialmente faceva da solo, poi ha finito per coinvolgere
un manipolo di amici tra cui - tra gli altri - Christian
Alati.
L'esordio Ten Blown Feathers (6.9/10) propone
folk declinato pop in maniera parecchio accorta per
non dire apprensiva, sembra quasi che Paolo cammini su
un pavimento di cristallo di boemia e invece sono trepide palpitazioni col santino dei Beatles nel taschino.
Non a caso la traccia numero 2 porta il titolo di John
Winston Lennon, non mancando di ammiccare a Working
Class Hero, mentre Lullaby sembra un miraggio sospeso
tra le beatlesiane Blackbird e Goodnight. C'è però che
tanta devota delicatezza cova una passione consolidata, capace di ispessirsi all'improvviso tra inquietudini e
slanci (Tunafish Can For Lunch, Oh, Elizabette!, Hannibal
Lecter), riuscendo a ritagliarsi una dimensione propria e
persino robustella.
Ancor più emblematica è l'iniziativa Box Series. Trattasi di lavori di esordienti o side project editi in custodie
di cartoncino riciclato, la grafica generosa al punto da
stupire (eh, il fascino tattile della serigrafia...) e in un
caso c'è pure una sorpresina che non sto a dirvi, se
no ve la guasto. La confezione smette di sembrarti un
pur gradevole guscio quando fai girare i dischetti nello
stereo e ti accorgi che tutto si tiene, che ci sono impronte folk-pop tatuate nell'immaginario meritevoli di
periodico riciclaggio, giacché il suddetto immaginario è
anche - soprattutto? - questione di ritorni e ripetizioni,
di ipnotica inesauribilità.
Due le uscite sinora, simili nello spirito ma eterogenee per forma e sostanza. E' frugale ma intensa la proposta del cagliaritano Andrea Cherchi, che col moniker
WAS esce dalla cameretta dei sogni cantautorali per
sfornare l'esordio After Dinner (7.0/10), sei tracce di
folk acustico (al bisogno c'è una tromba, un violino, un
synh e un pizzico d'elettricità) sbilanciato dreamy (prezioso in tal senso il contributo vocale di Sara Cappai).
I pezzi se la giocano tra ritrosia e incanto, palesando
una certa discendenza sixties tanto palpabile quanto
comprensibile, ma anche una sorprendente emulsione
emotiva che sembra ricavata da dei My Bloody Valentine disidratati. Fatto sta che almeno Somebody Thinks To
Know e Wakefulness squadernano l'intimismo con morbidezza implacabile, sono i tipici pezzi che lavorano in
sordina impreziosendo i grandi album. Non resta quindi
che aspettarlo, un album dei WAS da impreziosire.
Quindi, signore e signori, c'è nientemeno che Peckinpah, alter ego - più che moniker - di Lorenzo Bettazzi, già noto per il suo lavoro come bassista per gli
Zenerswoon. That's All Bad Folk (7.3/10) è il suo secondo titolo in solitario, di nuovo nel segno di un folk
ombroso venato blues e psych, ad alta intensità emotiva
come un fucile puntato appena dietro l'angolo, tuttavia
portatore sano d'un lirismo speranzoso come chi getta
comunque lo sguardo verso il migliore orizzonte possibile. Diciamo subito che Elle è un pezzo fantastico, ponte
gettato tra il grunge acustico, i Gun Club e le pensosità
salvifiche del post-post rock. Per il resto assistiamo ad
abili declinazioni contemporanee di congetture Fred
Neil (Drunken Lover), Nick Drake/Tim Hardin (None
Of Them) e Graham Nash (In The Meantime). Con Call
Me A Believer e The Seed si alza la temperatura, la prima
essendo una melmosa retrovisione tra Small Faces
e CSN&Y, la seconda una preveggenza beatlesiana di
Mark Lanegan, mentre Grinder chiude il programma
nella semplice intensità del piano-voce impastando particelle Mark Kozelek e Jackson Browne. Un gran disco, ma non ditelo troppo in giro.
Stefano Solventi
9
Turn On
Alessandro
Fiori
—Artigianato in rima—
Quanto sia distante il "mainstream
dell'amore spettacolare" dalla
produzione di Alessandro Fiori ce
lo dirà solo il tempo. Per ora c'è un
disco che parla di una creatività
affilata e sorprendente.
A
guardarlo bene sembra il Lucio Dalla degli esordi. Saranno forse i maglioni sdruciti che indossa
nelle foto ufficiali, la barba lunga, il fisico tarchiato o l'occhio vispo. Un animo da fricchettone che ha molto a che
vedere con l'indole del personaggio ma anche con la
sua “seconda natura” vissuta da cantante dei Mariposa.
Loro, davvero, figli adottati dei Settanta. Gente che tra
ironia sottile e ritorni al prog, messe in scena ai limiti del
demenziale e virtuosismi, i pantaloni a zampa d'elefante
e le Clarks marroni non le ha mai archiviate. E il Nostro,
in questo senso, non fa eccezione, visto che di pari responsabilità si parla quando si tratta di definire l'immaginario del gruppo bolognese: Gabrielli, Giusti, Marchi,
Orvieti, Canè, Cimino a curare la linea editoriale, Fiori a
dare forma a una poetica surreale che è un po' il tratto
distintivo della formazione bolognese.
La stessa che ritroviamo anche nel suo Attento a
me stesso, spogliata dal divertissement dei Mariposa e indirizzata verso il folk e la canzone d'autore. Anche perché quando si parla di Alessandro Fiori ci si riferisce
soprattutto a un cantautore, pur sopra le righe: “Credo
d'essere un cantautore. Sono sia cantante che autore. Canto
e autoro. Non so cosa ho mutuato dai colleghi del passato,
senz'altro qualcosa. Oltre che dai vari Tenco, De Gregori, Dalla, Gaber, anche da Venditti, da Masini, da Paoli, da Cocciante,
da Bennato, da Daniele eccetera eccetera eccetera. Ascolti e
vivi, assorbi e rielabori, senza saperlo. Da quando l'ho conosciuto, mi sento molto vicino a Ciampi. Forse anche a certe
cose del Jannacci più solo e disperato. In questo disco le
influenze più dirette sono state Ivan Graziani, Manuel Agnelli
e i cari Marco Parente e Paolo Benvegnù. Ma mi pare inutile
far presente che il mondo di Attento a me stesso non è
lo stesso di questi artisti citati.”
Credo che in fondo ci sia tra l'altro dell'encomiabile merda. Io
mi riallaccio facilmente a certi modi di vedere le cose perché
sono rimasto un po' bambino, o meglio, perché da bambino
ero già un cantautore-filosofo in miniatura.”
Al di là dei punti di vista più o meno coerenti e delle
sensazioni di chi scrive, resta comunque un disco riuscito, capace di raccogliere impressioni profonde e linguaggi musicali tra i più disparati (folk, jazz, arrangiamenti
classici, ruvidezze o magari la musica rinascimentale del
"Tu riposa un po' mentre faccio il borderò" che si ascolta in
2 cowboy per un parcheggio). Merito anche di un gruppo
di illustri collaboratori che raccoglie Alessandro Stefana (“Devo moltissimo ad Asso. Mi ha aiutato in un brutto
momento. Poi è il produttore artistico, ha registrato, ha dato
il là ai missaggi."), Danilo Gallo e Zeno De Rossi (“Si
sono prestati praticamente a scatola chiusa”), Marco Parente (“Avere Parente alla batteria è davvero una rarità!”
) e Enrico Gabrielli (“E' una specie di fratellino musicale”). Oltre ai curatori del progetto grafico Marino Neri
("il disegno di copertina l'ho trovato da subito perfetto”) e
Chiara Scarselli e al binomio Giacomo Fiorenza/
Giovanni Versari dietro al mixer.
Fabrizio Zampighi
La dimensione autobiografica diventa la chiave di lettura
per interpretare l'immaginario dell'artista toscano. Lo è
per la musica – a tratti sognante, a tratti minimale -, per
i testi delle canzoni e anche per i mini-racconti che Fiori
colleziona sul suo sito ufficiale. Questi ultimi spaccati
di vita vissuta in cui si mescolano l'amarezza per una
passato popolare che non c'è più e una certa ironia da
osteria. In questo senso, comprendere il lavoro di Fiori
significa decifrare un intreccio di malinconiche leggerezze che descrivono una quotidianità sotto spirito, aliena,
spiazzante. E in cui spesso è l'infanzia che rielabora il
peso specifico dei sentimenti: “Io non voglio piangere / per
riempir di lacrime una vasca / che reclama ancora quei miei
occhi / la testa coi pidocchi / gli sbucci sui ginocchi / non ho
più il cuore ché un bambino, col secchio, me lo ripesca ogni
or / perché sta fermo”.Anche se il musicista, a tal proposito, stronca di netto ogni ipotesi di revivalismo romantico: “L'infanzia non è un metro di giudizio, è un burrone nero.
10
11
Turn On
Funki
Porcini
—The Downtempo
King—
Dopo otto anni James Braddell torna
con due album di ritmo a bassa
velocità.
12
A
vere l’opportunità di sentire un proprio eroe non
capita tutti i giorni. James Braddell è uno dei
pochi personaggi che mi hanno segnato musicalmente.
Nel periodo in cui tutti restavano allibiti per lo spopolare del grunge, dell’indie rock alternativo o del metal,
pochi si filavano la Ninja Tune dei maghi del sampling
Coldcut (oggi guardacaso festeggia pure il suo ventesimo anniversario). Caposcuola di un sentire il ritmo più
slow della techno e dell’acid - che di lì a poco avrebbe
bruciato milioni di giovanissimi neuroni - l’etichetta col
ninja che lancia i vinili come stellette agli esordi era un
affare prettamente londinese.
Senza internet, si leggeva della crew di personaggi
che si drogavano di samples d’antan in qualche fanzine esclusiva o in qualche catalogo di distribuzioni underground d’importazione UK. Del personaggio Funki
Porcini si sapeva ancora meno. Con quel nome che non
capivi bene se lo dovevi scrivere proprio così, all’italiana.
Uno che nella musica ci ha sempre messo tonnellate
di umorismo e savoir faire stiloso. Sorprendentemente,
per qualche scherzo del destino, la sua King Ashabanapal
è stata inclusa nella riduzione cinematografica di Jack
Frusciante è uscito dal gruppo. Un film e un libro che alimentavano le fantasie dei tardoadolescenti del 1997. Io
ero uno di quelli. Parte anche da quella folgorazione il
microculto che oggi sono lieto di sentire via mail intervistando quel personaggio che se ne fotteva delle mode
e faceva del dub elettronico mescolato a influenze jungle, tagliato con bordate che oggi sentiamo nei territori
wonky.
La storia nasce per caso. In uno dei soliti check che
si fanno svogliatamente, a fine mese, quando il giornale
sta andando in stampa e si è più rilassati sotto gli occhi
capita il sito di Funki Porcini. Ci campeggiano ben due
album nuovi di zecca: uno uscito in sola distribuzione
sul sito/blog personale (Plod) e l'altro in stampa sulla
fedele Ninja Tune confermata per maggio (On). In realtà
“provengono entrambi dallo stesso corpus che ho scritto in
questi ultimi anni”, sottolinea lui “Avrei voluto pubblicarli in
un unico lavoro, ma alla Ninja hanno selezionato solo metà
delle tracce, così ho pensato di pubblicare le altre su un
canale indipendente”.
Gli album sono le due facce di una medaglia targata Novanta. On è un concentrato di relax basato sugli
strumenti live (e dunque senza campionamento). Moog
che ti sparano il blues jazz di Moon River, l’attualizzazione con i teen wonky visionari (This Aint The Way To Live)
e il bordone di un piano distante che ricorda i mitici
Ambient Works di Aphex. Plod è l’altra faccia: le atmosfere da IDM warp tagliata con lo sporco della old school di crate digging in trip sampledelico (Carbide), fumi di
assenzio, sigari ed erba. La malinconia della campagna
inglese, quelle atmosfere da end of the party lisergico
(Bed To Be).
E' la nostalgia per quei ‘90 in cui tutto poteva succedere quella che si riflette nella mente sonica del britannico (“Oggi c’è più musica a disposizione, ma influisce meno
nella cultura. Le radio e le TV sono diventate un mezzo per
fare soldi, e non promuovono la cultura”) e non senza una
punta di ottimismo e speranza (“Penso che lo stato in cui
siamo sia comunque di transizione tra ventesimo e ventunesimo secolo. Ci aspettano ancora novità eccitanti”), James
del resto è uno che si gode un meritato riposo dopo
anni passatti a viaggiare in lungo e in largo.
A 19 anni è fuggito dall’Inghilterra per atterrare a
Los Angeles. Ha trascorso poi il suo bildungsroman tra
San Francisco e New York per approdare pure in Italia.
Tornato in patria, in un luogo top secret, si limita a dirci
che è un paesino sperduto in campagna “in the middle of
England”. E la parentesi romana? “Ho vissuto dieci anni a
Roma e non ho mai dimenticato molti aspetti della cultura
italiana. Ho parlato con Morricone una volta a Testaccio.
C’erano poche persone e l’ambiente era molto intimo, ma se
n’è uscito con una quantità di merda egotistica che l’ho lasciato perdere. Piero Umiliani è molto più interessante, sia
come sperimentatore che come persona: aveva più sense of
humour ed era più modesto nell’approccio. Un vero genio”.
James ha quella consapevolezza di sé e un poco di
rassegnazione. Fa le cose in piccolo ma come più gli
piace “il più della gente coinvolta nel panorama culturale
vive a Londra. Non mi piace lavorare a distanza, preferisco
il faccia a faccia. Ultimamente ho lavorato con lo scrittore e
regista Tony Grisoni. Abbiamo lavorato su due suoi film e mi
è piaciuto molto”. Tra i nuovi progetti anche uno show
“che sarà pronto in pochi mesi, un evento multimediale”.
Alla prossima.
Marco Braggion
13
Tune-In
Ufo
mammut
—Vibrazioni dal parto primordiale—
Appena uscito Eve, un concept album sulla progenitrice dell'umanità, abbiamo
colto l'occasione per parlare con gli Ufomammut delle cose che ci stanno più a
cuore. Donne e musica.
Testo: Leonardo Amico
14
G
li Ufomammut sono sicuramente una tra
le band più pesanti del panorama italiano e,
per una volta tanto, anche fiore all'occhiello
dell'esportazione nostrana avendo suonato nei maggiori
heavy festival internazionali come il Roadburn in Olanda
o l'Hellfest francese ed avendo raccolto consensi a più
riprese dai tipi di Aquarius (che sono tra i più importanti
mailorder americani).
Dieci e più anni di impegno a testa bassa, a levigare
un sound ormai divenuto impeccabile. Tanto efficace in
enormi palchi di concerto, come nella solitudine di una
piccola stanza. La carica dirompente dei loro live, quella
densa fisicità - fatta di frequenze risuonate lungo la schiena, è stato decisivo per farli amare anche al di fuori dagli
angusti confini del nostro paese, riuscendo a sfondare
quel muro di scetticismo che troppo spesso penalizza le
band italiane all'estero. Mentre le suggestioni mentali di
un suono riccamente psichedelico, fa di loro un nutriente cibo anche per gli spiriti psych-doom più solitari.
Lo scorso aprile è uscito Eve, l'ultimo album della
band di Tortona. Un ulteriore conferma delle qualità dalla band, se ce ne fosse ancora bisogno, e soprattutto
un affascinante nuovo viaggio nel mondo della creatura
Ufommammut. Prodotto dall'etichetta di casa Supernatural Cat con la solita cura grafica firmata Malleus ed una
prestigiosa distribuzione Relapse, Eve è un ambizioso
concept album sulla progenitrice dell'umanità. Ne abbiamo colto l'occasione per una breve chiacchierata via email. Su argomenti che difficilmente si possono pensare
più comuni: donne e musica.
L'ultimo album Eve. Se non sbaglio nasce dalla
rielaborazione di alcune registrazioni di Urlo e
Poia con una vostra precedente band. Una genesi strana per un disco. Parlateci di come è nata
l'idea e di chi erano questi Judy Corda.
POIA: I Judy Corda sono stati la nostra prima band,
Urlo ed io suoniamo insieme dal 1991: ci sono due brani
in un paio di compilation italiane degli anni 90, più tre
demotapes a testimoniarlo. Credo che, al di là di alcune ingenuità, i Judy Corda fossero più innovativi degli
Ufomammut. arpeggio di chitarra iniziale e accordi finali
di Eve sono frammenti ritrovati da nostri vecchi nastri
(non buttiamo via nulla): da questi, come fossero semi
congelati, si è ramificato l'intero brano.
URLO: Facevamo cose diverse, più progressive forse
e più ingenue... Eravamo giovani...
VITA: Seguivo spesso i Judy Corda durante i loro concerti perché mi piacevano molto, erano innovativi per
l'epoca tant'è vero che abbiamo parecchie volte pescato
dal loro repertorio, per esempio in Odio. Per mia fortuna
il batterista lasciando la band ha involontariamente dato
vita a Ufomammut...
Un brano unico incentrato sulla figura della
prima donna, Eva. Come si è sviluppata l'idea di
questo concept, visto anche che il materiale su
cui avete iniziato a lavorare non nasce originariamente con l'album? E che relazione c'è con i
grandi concept album del passato? Penso ai Pink
Floyd su tutti.
POIA: I Pink Floyd fanno parte del nostro pane quotidiano e la loro musica si rinnova da sé, ad ogni ascolto: sembra provenire da un'epoca indefinita. Gli echi di
Echoes si riverberano da sempre nella nostra musica.
VITA: L'idea del lungo pezzo era nell'aria già da un po'
ispirati da Meddle dei Floyd o anche, personalmente,
da Thick As A Brick dei Jethro Tull. Un unico brano
ma con più movimenti, cambi di tempo ed atmosfere
psichedeliche che si intrecciano creando un unico flusso
musicale. Eve credo che sia un concentrato di tutto ciò
che ci piace.
URLO: ...e che avremmo sempre voluto fare. Come
dice Vita l'idea iniziale era quella di dar vita ad un album
impostato come Meddle dei Pink Floyd, quindi una traccia lunga e varie più brevi. L'errore è stato cominciare
dal brano più lungo che è andato ad espandersi come
l'universo...
Sludge, Heavy Psychedelia sono generi principalmente maschili, e in concerti di questo tipo
raramente capita di vedere ragazze. Che rapporto ha la vostra musica e il vostro modo di fare
musica con l'universo femminile, al di là delle figure mitologiche?
POIA: Credo che sia più una questione di cultura
musicale. Sicuramente in Italia il genere è decisamente
seguito più dal pubblico maschile. Abbiamo invece notato (con una certa soddisfazione... eheh) come all'estero
in realtà questo sbilanciamento sia più contenuto. E il
rapporto con l'universo femminile è sempre stato molto profondo. Al di là del fatto che fare musica unisce le
componenti del cervello maschile (gli aspetti numericirazionali) con quelle femminili (istinto ed emozioni), credo che tra le motivazioni iniziali che spingono a suonare
uno strumento, ci sia quella, neanche troppo inconscia, di
attirare a sé le femmine.
URLO: La donna è bellezza, noi cerchiamo, sia con
Ufomammut che con Malleus (di cui Poia ed io siamo 2/3),
di celebrare la figura femminile. Comunque suonare davanti a belle ragazze è sempre meglio che alzar gli occhi e
vedere energumeni barbuti che trincano birra... eheh)
VITA: Devo dire che negli ultimi anni ho notato che
le ragazze sono più presenti sia ai nostri concerti che ad
altri di diversi generi musicali. Non so per quale ragione
15
Tune-In
Sikitikis
—Fuori dalle mode—
effettivamente ma credo sia un dato di fatto. La donna
piace ma Ufomammut non crea musica per conquistarle.
URLO: Anche perché siamo talmente brutti che sarebbe dura... ahaha!
Nella musica degli Ufomammut c'è un legame
molto forte verso una certa tradizione musicale.
Come se dal verbo originario dei Black Sabbath,
magari attraverso la rielaborazione di Sleep e
Kyuss non ci sia più bisogno di introdurre nuovi
linguaggi, ma soltanto di declinare quell'intuizione. Qual è la vostra idea?
VITA: Chiunque suoni in una band, famosa o no, si
ispira o lo ha fatto in passato a qualcuno che prima di lui
ha creato musica, è il cane che si morde la coda, è una catena... L'importante è cercare di essere sempre se stessi
senza avere il bisogno di assomigliare a qualcun altro...
POIA: Si tratta di seguire una traccia e vedere dove
questa può portare. Se prendiamo la storia della musica moderna, non è poi così semplice trovare dischi che
improvvisamente si liberano di quello che è stato prima.
Stiamo ancora suonando Blues, dopotutto. E non vogliamo essere "strani" a tutti i costi (certe band mi danno
questa sensazione, di scarsa spontaneità). È solo musica,
suonata dal nostro punto di vista. Rielaborata in base a
quelli che sono stati i nostri ascolti. A volumi molto alti.
URLO: Tutto è già stato fatto, è dura inventare nuove
sonorità... pensa a Tomorrow Never Knows dei Beatles...
Anche nella vostra ricerca per strumentazioni
vintage, vecchi effetti analogici, noto come una ricerca per quella formula perfetta. Da scovare attraverso una cura meticolosa di dettagli, piuttosto
16
che mediante radicali stravolgimenti. Mi sbaglio?
POIA: Non siamo dei puristi del vintage e non viviamo
nella nostalgia. Semplicemente, alcuni vecchi amplificatori
valvolari suonano meglio di altri nuovi, alcuni distorsori
sono più caldi e potenti. Ma ci sono anche prodotti più
recenti che funzionano molto bene. C'è molta tecnologia
moderna in Ufomammut (il miscuglio passato/futuro è
una nostra caratteristica, credo). Cerchiamo il risultato, e
i mezzi per ottenerlo sono svariati.
URLO: Personalmente non ho nulla nella mia strumentazione che potrei definire vintage. Forse un paio di
pedalini, ma sono lì solo perchè mi fanno ottenere i risultati che cerco. Come dice Poia, ogni cosa va bene per
ottenere il suono che si cerca. L'importante è dosare il
tutto per avere un risultato finale soddisfacente.
VITA: Quando sperimenti cerchi sempre qualcosa di
diverso ma il processo avviene per gradi, scopri un nuovo
suono che ti può aprire più di una porta per arrivare il
più vicino possibile alla formula perfetta, che sinceramente parlando credo non esista...
Un'ultima domanda. Cosa state ascoltando di
più in questo periodo?
POIA: Cream e Circle. Sono alla lettera C.
URLO: Anche io sono alla C! Sto ascoltando molto i
Creedence e Cohen. Ma anche Assjack che non comincia
per C...
Vita: sarò banale ma ascolto spesso i Pink Floyd, i
Beatles, i Black Sabbath e le vecchie band che mi fan
sempre provare grandi emozioni...
Come passare indenni attraverso un decennio di musica mescolando generi diversi e un immaginario pop, con il valore aggiunto di uno sguardo ironico e amaro
sulla nostra realtà.
Testo: Teresa Greco
C
i sono gruppi che non appartengono a nessuna cosiddetta scena, gruppi per i quali essere fuori dai circuiti canonici è un obbligo
e un bisogno assoluto, e per i quali è in essere totalmente “fuori moda” e assolutamente non allineati.
Prendiamo il caso dei palindromi sardi Sikitikis. Con
alle spalle ormai ben due lustri di attività e tre album
pubblicati, la band di Cagliari non è di certo l’ultima
arrivata in ordine di tempo nella musica del Belpaese.
La formazione si era fatta notare nel 2005 all’esordio
sulla Casasonica di Max Casacci (Subsonica) con
Fuga dal deserto del Tiki; il disco era un eclettico
mix senza chitarre tra psych pop, ironia sferzante,
electro punk funk, Ennio Morricone, modernariato e garage, rigorosamente cantato in italiano, con
un immaginario fervido a cavallo tra Sessanta, spy,
sci-fi e poliziesco Settanta. Li avevamo poi ritrovati
tre anni dopo con B - Il mondo è una giungla per
chi non vede al di là degli alberi (2008) e con un
coraggioso e fruttuoso esperimento di distribuzione
on-line e di vendita dei cd presso i concerti. Arrivano
17
ora alla terza prova, Dischi Fuori Moda (SA # 67) che
ben compendia la loro attività, confermandone la cifra
stilistica, insieme a una vena dissacrante, ironica e amara sull’attualità, e alla onnipresente tendenza a frullare
un’ampia gamma di generi in un mix assemblato con una
bella dose di personalità. Abbiamo incontrato il cantante
Ale Diablo per una chiacchierata ad ampio raggio sulla
band, su quel che ruota loro intorno e su molto altro
ancora. La nostra intervista.
Potresti ripercorrere la vostra storia finora,
come ci siete arrivati e con quali esperienze?
Il progetto è nato nel 2000 da iniziativa mia (Ale Diablo) e di Jimi (bassista), dopo lo scioglimento del nostro
precedente gruppo: i Canidarapina. Daniele e Zico
(batteria e tastiere) hanno aderito con grande entusiasmo. Dopo diversi anni alla ricerca di un suono che
ci soddisfacesse e che sintetizzasse al meglio la nostra
passione per le colonne sonore e il nostro background
rock, abbiamo firmato un contratto con Casasonica, con
la quale fra il 2004 e il 2008 abbiamo registrato e stampato due dischi: Fuga dal Deserto del Tiki e B. Sono
stati anni straordinari nei quali abbiamo avuto modo di
suonare su ogni tipo di palco e nei contesti più diversi.
Abbiamo firmato colonne sonore e prodotto progetti
di sonorizzazione per immagini, parole, danza, teatro e
(addirittura) monumenti. Terminata l’esperienza con Casasonica abbiamo deciso di affrontare un percorso in cui
essere ancora più padroni del nostro lavoro. Oggi collaboriamo con Manuele Fusaroli, produttore straordinario
che ha creduto in Dischi Fuori Moda fin dall’ascolto dei
primi provini.
Le vostre influenze musicali sono variegate e si
sente… Quali sono i punti di contatto comuni che
poi portano fino alla vostra musica?
Effettivamente siamo fruitori onnivori di musica. Abbiamo anche ascolti differenti fra di noi, ma una cosa da
imparare quando si fa parte di una band è riconoscere la
qualità oggettiva di quello che si fa, con il giusto apporto
di autocritica e la necessaria dose di confronto. A tutti
piacciono la spinta ritmica, le armonie asciutte e dirette, i
testi ironici, l’amore per la vita.
Come siete arrivati alle sonorizzazioni per cinema, letteratura e teatro, visto che è ormai un
percorso parallelo?
La rivisitazione di colonne sonore è stato il primo collante della band. Per almeno tre anni siamo stati chiusi in
sala prove – le apparizioni live erano sporadiche – a fare
una vera e propria attività di laboratorio sulla musica da
cinema vintage, soprattutto italiana. Quando abbiamo iniziato a scrivere canzoni, a fare dischi e tour, non abbiamo
voluto perdere il contatto con quel mondo che, in qual18
che modo, ci tiene sempre sul filo della sperimentazione.
Così abbiamo fondato il Brain Dept. un “dipartimento”
libero e destrutturato per i progetti più estremi.
Gli anni 60 e 70 per voi…
Credo che per tutti gli appassionati di arte e cultura contemporanea rappresentino il ventennio più ricco,
quello da cui trarre maggior ispirazione. Molti artisti che
hanno prodotto in quel periodo sono ancora vivi, questo rende più semplice mantenere un contatto diretto
con quegli anni. Per i Sikitikis sono soprattutto musica
e cinema a fare la differenza in quel periodo. La grande
produzione di colonne sonore e l’esplosione del pop, la
rivoluzione culturale e il cinema italiano che conquistava
il mondo.
Come vedete la scena musicale italiana attuale? I gruppi con cui vi sentite in sintonia…
Mi sembra che i tempi bui stiamo passando, anche se
non ne siamo ancora fuori. Molti pensano che siano le
band a fare un “scena”, io credo che questa famosa scena
non sia altro che il pubblico che va a vedere i concerti.
In tal senso sembrano esserci timidi segnali di ripresa. I
dischi usciti negli ultimi sei mesi parlano chiaramente di
una qualità media che si sta alzando, anche nei dischi di
esordio. Inoltre sembra esserci una certa compattezza
nei contenuti, pur nella differenza di stile. In questo momento ci piace sentire delle affinità con i Tre Allegri
Ragazzi Morti, con gli Zen Circus… ma anche coi
Virginiana Miller e col Teatro Degli Orrori. Ci tengo a sottolineare che con questo non intendo dire che
assomigliamo a tutti questi progetti, ma in ognuno di loro
c’è qualche aspetto che stimiamo e in cui ci riconosciamo.
Secondo chi scrive la scelta di esprimersi in
italiano è fondamentale, cosa pensate invece di
chi ha scelto l’inglese come lingua?
Per noi il problema non si è nemmeno posto. Io scrivo
i testi e conosco solo due lingue: l’Italiano e il Sardo. La
speranza è che chi ha scelto l’inglese conosca davvero
l’inglese. Conoscere una lingua, però, non significa solo
avere la padronanza della sua grammatica e del suo vocabolario, ma significa anche saper cogliere sfumature e
sfaccettature di una intera cultura. Solo un madrelingua
credo si possa permettere di fare della poesia (perché di
questo si tratta) in inglese, o magari anche uno particolarmente talentuoso che abbia vissuto un lungo periodo
in un paese anglosassone. Quello che sento in giro in
inglese prodotto in Italia, per la stragrande maggioranza, è inascoltabile per pronuncia e contenuti. Qualcosa
si salva.
Come è stata l’esperienza della distribuzione
online e ai concerti del secondo disco B?
Un bilancio… estremamente positivo. Basti pensare
che abbiamo confermato i numeri del primo disco che
aveva distribuzione major. Ora con la distribuzione indipendente abbiamo fatto un primo passo anche in quella
digitale. Con ogni probabilità studieremo una formula per
il futuro che si sbilanci sempre di più su quest’ultima.
Come è nato l’ultimo Dischi Fuori Moda?
Semplicemente scrivendo canzoni. Abbiamo iniziato a
lavorare in grande libertà, proprio come se questo disco
non dovesse mai uscire. Se devo usare un sostantivo che
racchiuda la nostra sensazione in una sola parola ti dico
“leggerezza”. Per il resto, è stato fondamentale il periodo
di registrazione al Natural Head Quarter di Ferrara, dove
il Fusaroli è stato capace di distillare al meglio l’essenza
della band e l’umore della scrittura. Un mese di clausura
nelle campagne romagnole che ha dato una dimensione
bucolica ad un’esperienza, quella di registrare un disco,
che per noi era, fino a quel momento, fortemente legata
alla dimensione urbana del centro di Torino.
Il vostro sguardo sull’attualità è ironico ma
anche pessimista, penso per esempio all’immigrazione in Salvateci dagli italiani, o i ritratti generazionali in Uccidere compagni di scuola… Avere
trent’anni … Come vedete la situazione attuale in
tema di immigrazione, libertà… alla luce anche
del vostro sostegno all’indipendentismo sardo?
Abbiamo sicuramente uno sguardo più ironico che
pessimista. Addirittura si può dire che lo sguardo sul futuro è addirittura ottimista! Descrivere l’attualità in chiave ironica (anche amara) è una modalità assolutamente
istintiva. Avere Trent’Anni parla di una storia vera, Uccidere
Compagni di Scuola è una rassegna stampa surreale con
tanto di commenti e ritornello con spiraglio di speranza.
Per Salvateci Dagli Italiani il discorso è più complesso, ci
sono diversi piani di lettura, il testo è forte ed equivocabile. Gli extracomunitari sono una grande risorsa per tutti i paesi europei dove l’invecchiamento sta per diventare
un problema serio. In chiave indipendentista, io credo che
la nazione sarda debba conservare la sua indole inclusiva,
aperta alla contaminazione e integrativa. Essere indipendentisti oggi non significa essere contro qualcuno, ma a
favore di qualcosa. Immagino la Sardegna del futuro come
una repubblica multietnica… magari anche noi avremo
un presidente nero!
Anche in questo album sono presenti le cover, qui Malamore di Enzo Carella… Come è nata
questa scelta?
Ho amato per anni questa canzone. I testi di Pasquale
Panella sono straordinari. All’inizio, l’idea era di cercare un
brano di Lucio Battisti. Nel gruppo proviamo tutti un amore
folle per Battisti. Poi abbiamo scoperto che Enzo Carella era
uno dei sui artisti preferiti. Così abbiamo colto questo legame
ed abbiamo deciso di stravolgere Malamore per farne un pezzo
“fuori moda".
19
the divine
comedy
—Semplicemente pop
“M
Drop Out
A distanza di quattro anni dal disco
precedente, i Divine Comedy ritornano con le loro atmosfere raffinatamente retrò per un disco maturo
Testo: Marco Boscolo
20
i sento da Dio! Sento che adesso so esattamente quello che sto
facendo!” Esordisce così Mr. Neil
Hannon all'altro capo del telefono quando lo raggiungiamo per l'intervista. Una felicità e una confidenza che traspaiono in più di un episodio di Bang Goes The Knighthood, l'ultima fatica,
la decima, a firma Divine Comedy. Se provate a dirglielo, probabilmente si metterà a ridere, ma oramai
la sua creatura o, come preferisce dire lui stesso “il
contenitore del mio cervello”, ha raggiunto lo status
di icona. Certo, in ambito indie e lontano dai riflettori
dell'hype, e di questo Neil Hannon potrebbe non dispiacersi più di tanto. Sicuramente la sigla Divine Comedy è sinonimo di pop raffinato, con uno stile classicheggiante e una tendenza demodé ai testi intelligenti.
Tutte caratteristiche non propriamente in linea con il
mondo del pop contemporaneo (indie o mainstream
che sia), quasi che il Neil Hannon che esordiva nel
lontano 1989, da quell'Irlanda del Nord non propriamente centrale nella musica britannica, fosse un'altra
persona rispetto al tranquillo quarantenne di oggi.
Gli anni Novanta raccontano che i dischi buoni
Hannon li ha sempre scritti, soprattutto guardando
all'accoppiata '96 - '97 composta da Casanova e A
Short Album About Love. Con quest'ultimo, in particolare, fin dalla copertina che richiama quelle degli
Smiths, sembra che Neil Hannon sia sull'orlo di di21
ventare una vera e propria popstar.
Un altro disco (A Fanfare For The
Comic Muse, meno convincente, ma
non da buttare) e il circo si chiude,
quasi improvvisamente, lasciando
Neil Hannon in una certa difficoltà
a capire che cosa fare della propria
carriere musicale. Nuovo decennio e
nuova vita per i Divine Comedy, che
nel 2001 diventano una vera band
per incidere Regeneration, un disco accolto piuttosto bene e che fa
pensare che tutto può ancora essere recuperato. Ma come leggerete
nell'intervista, Neil Hannon non era
del tutto a proprio agio con il processo creativo che ha portato a quel
disco. Così a partire dal 2001, mentre
l'hype generato della stampa inglese
si sta progressivamente spostando
altrove (siamo ancora impelagati con
il New Acoustic Movement, ma di lì
a poco esplode il revival new wave
che stiamo ancora vivendo), i Divine
Comedy diventano sempre più l'idea
di musica di Neil Hannon e di nessun
altro.
Absent Friends (2004) e Victory
For The Comic Muse (2006) aprono
una stagione diversa, si potrebbe dire
della consapevolezza, che porta i Divine
Comedy a inseguire in tutto e per tutto l'idea di pop orchestrale che l'esperimento di Regeneration aveva in parte
messo in pausa. In tutti questi anni, Hannon ha costruito uno status tale che la
sua musica finisce al cinema (Il favoloso
mondo di Amélie, Guida intergalattica per autostoppisti) e in televisione
(Doctor Who), mentre fioccano colalborazioni con altri musicisti (Air, Thomas
Walsh) e si arriva al musical (Swallows
And Amazons, “una cosa principalmente per ragazzi e bambini”, che andrà in
scena in autunno a Bristol), che porta
a compimento un percorso che in più
punti sembrava affacciarsi già nei dischi.
Sulla soglia dei quarant'anni, al ventesimo
anno di carriera, Neil Hannon sembra
aver pienamente raggiunto una maturità
umana, prima ancora che musicale, tale
22
da poter vivere con serenità il rapporto con il pubblico, cioè con coloro “che mi permettono di continuare a fare quello che amo”, cioè raffinato pop cantautoriale fuori
dal tempo e dal gusto retrò. Dobbiamo per forza chiedergli di più?
Gli ultimi tre album dei Divine Comedy hanno l'aspetto di un
tutto, di una storia che si sviluppa da un punto di vista musicale e
danno l'impressione che tu abbia raggiunto una tua voce specifica,
abbia trovato il tuo equilibrio. È così?
Sì è proprio così! Ho sempre pensato di migliorare con gli anni, proprio come
del buon vino! Credo che dipenda dal fatto che il mio stile per i testi è piuttosto
narrativo, concentrato su alcune vere e proprie storie che voglio raccontare. Così mi
succede quello che accede agli scrittori: più passa il tempo e più accumulo esperienza
sulla vita e le persone, oltre – si spera – a un po' di saggezza. E questo aspetto credo
che non abbia fatto altro che migliorare il mio modo di scrivere canzoni. Il periodo
che coincide con questi ultimi tre dischi è stato un momento particolare. Anche negli
anni Novanta ero sempre cosciente di quello che stavo facendo, ma attorno a me
c'era una situazione diversa: avevo piazzato qualche hit e, insomma, ero una specie di
popstar. Improvvisamente tutto questo è scomparso. E sono rimasto a chiedermi: e
adesso che faccio? Ecco, gli ultimi dieci anni sono stati il mio tentativo di riposizionarmi, di cercare di trovare il modo di restare rilevante facendo musica lontano dai
riflettori del popchart system.
Questa omogeneità di intenti si è riflessa anche sul processo
creativo che ha portato a Bang Goes The Knighthood?
In quest'ultimo disco, in realtà ho avuto un approccio leggermente diverso al solito.
Stavo scrivendo un musical, intitolato Swallows And Amazons, per il quale ho composto esclusivamente al pianoforte, una cosa che non sono abituato a fare. Normalmente
uso le tastiere e il computer per costruire le mie canzoni, già con in testa delle idee
per gli arrangiamenti. Per il musical ho voluto che le canzoni suonassero perfette già
al pianoforte. Così ho iniziato a usare questo sistema anche per le canzoni che non
facevano parte del progetto.Tutti i brani del disco sono stati creati così, con me da solo
seduto davanti ai tasti del pianoforte. Tra l'altro questo mi ha fatto molto migliorare
come pianista. Da bambino l'ho studiato un po', ma ho lasciato perdere quando avevo
undici anni perché ero troppo pigro! Quindi non sono particolarmente attrezzato da
un punto di vista tecnico, ma con il tempo passato sui tasti ho sviluppato una specie di
mio stile originale. E mi piace l'idea che ora posso andare a casa di chiunque e semplicemente suonare le mie canzoni sul pianoforte del soggiorno!
Anche in questo caso si migliora con l'età...
Certo e senza fare sfoggio di falsa modestia, rispetto al passato, oltre a suonare
meglio il pianoforte, adesso so precisamente come deve suonare una canzone e
come fare perché ciò accada. Una volta mi trattenevo molto e quando un disco usciva, potevo solo sperare che piacesse. Ero meno sicuro.
Considerando anche il tuo stile narrativo, cominci scrivere prima i testi o la musica? Cioè, come funziona il processo creativo di
Neil Hannon?
Di solito scrivo i testi e le musiche indipendentemente. Ho un sacco di bloc notes
dove mi segno tutto quello che mi colpisce e che mi interessa. A volte scrivo solo un
appunto, altre volte un paio di versi, ma sempre senza prendere in considerazione la
musica. Allo stesso tempo, però, faccio un po' di casino al pianoforte e vedo quello
che succede. Quando poi trovo una melodia che mi convince, penso che ho bisogno
di un testo e allora me lo vado a cercare tra i miei bloc notes e cerco di mettere insieme le due cose. In alcuni casi funziona, in altri è semplicemente terribile e bisogna
ricominciare da capo!
Quando scrivi, come distingui quello che va bene per i Divine
Comedy e quello che invece può andare bene per altri progetti o
per altri interpreti, come per esempio è successo con Charlotte
Gainsbourg?
Certo, potrei avere scritto qualcosa con un'attitudine musicale diversa da quella
che può andare bene per i Divine Comedy e quindi essere buono per un altro interprete o per un altro scopo. Ma nel caso della Gainsbourg, il fatto è che la produzione
voleva che scrivessi qualcosa di intelligente, ma io non riesco a resistere all'idea di
mettere qualche battuta ironica nei miei testi. La verità è che non sono bravo a fare il
serio! Comunque, credo che l'operazione, in generale, sia andata piuttosto bene.
Torniamo a Bang Goes The Knighthood e guardiamolo più da vicino. Con il primo singolo, Indie disco, hai evocato molti nomi della
scena britannica di quegli anni, apparentemente con una certa nostalgia. Come ti sembra invece la scene attuale? C'è qualche artista
23
te Banker, in cui ti occupi della
situazione in cui versa oggi il
settore della finanza in tutto il
mondo. Da dove nasce questa
canzone?
È una delle poche canzoni che ho
scritto nella mia carriera con un vero
sentimento di rabbia. Sono sconvolto
dall'idea che abbiamo lasciato che il capitalismo rampante abbia prodotto questa situazione negli ultimi anni. C'è, però,
una parte delle persone che lavorano nel
mondo della finanza che non sono così
orribilmente avare o dei veri bastardi,
così ho scritto The Complete Banker. Mi
rendo conto che è solo una canzone
che non cambierà una virgola di questa
situazione, ma scrivere canzoni è quello
che posso fare ed è l'unica arma a mia
disposizione.
Ma cos'è un tentativo di raccogliere la rabbia della working
class...
Se solo lo fossi! La realtà è che sono
parte della noiosa middle class anglosassone. Sono quello che sono e non voglio appropriarmi di battaglie che non mi
appartengono. Ma la crisi del capitalismo
ha a che fare con tutti, non solo con
la classe lavoratrice. E a essere onesto,
sono stupito che nessuno prima di me
abbia scritto una canzone su questo argomento.
o una band che ti piace e ti sembra assomigli a te?
Mhmm... No! Non riesco a farmene venire in mente una... tu, hai qualche idea? È difficile. Mi piace Rufus Wainwright, ma è
canadese. C'è una nuova band di Dublino, The Villagers, che esce per la Domino Records, che mi piace molto. Conor (O'Brien,
ndr) è un amico e credo che la sua musica sia una delle migliori cose prodotte in Irlanda da molto tempo a questa parte. È un
compositore davvero bravo e intelligente. Mi piacciono molto anche gli MGMT, anche se sono solo dei ragazzacci che vengono
da un college americano! Sono completamente diversi da me e dalla mia musica, ma ieri sera ho fatto una cover della loro Time to
Pretend, perché mi piace il testo, che parla di chi vive il sogno del rock'n'roll. C'è questo aspetto del “vivi veloce e muori giovane”,
descritto in modo così profondo e sensibile, che mi diverte.
Te lo chiedevo perché tu sembri avere uno stile che guarda più al passato che alla scena indie odierna...
Non credo di poter rivendicare di essere indie pop! Non sono nemmeno sicuro di quel diavolo che sono. Ascolto tanta
musica così diversa, da Stravinskij e Scott Walker, dai cantautori francesi a Randy Newman. Adoro il synth pop e credo che
Dare! degli Human League sia il mio disco preferito di tutti i tempi. Mi piacciono cose anche molto diverse, ma questo non
significa necessariamente che poi finiscano con l'influenzare lo stile della mia musica. C'è una certa differenza tra quello che mi
piace e quello che mi ispira e mi influenza. Però, ecco, il punto fondamentale che mi fa ammirare gli Human League, nonostante
il loro synth-pop non sia compatibile con il tipo di strumentazione che mi piace usare per la mia musica, è che le loro canzoni
sono costruzioni pop perfette. È questo che mi interessa più di tutto.
Tra le storie che racconti, ce n'è una che sembra un po' particolare. Sto parlando di The Comple24
Oramai alla soglia dei quaranta, con una carriera oramai
ventennale che è appena approdata al decimo album di studio:
è tempo di qualche bilancio. Di
solito nel considerare la tua carriera nel suo insieme, i giornalisti tendono a dividerla in due
parti: prima e dopo il 2001, dalle
parti di Regeneration. Sei d'accordo che quello è stato un disco davvero di svolta, in qualche
modo, nel tuo percorso? Oppure
questa descrizione della tua carriera non ti piace?
Regeneration è sicuramente stato
una momento importante della mia strada, ma credo che sia stato una sorta di
reazione al fatto che non volevo essere visto come il cliché dandy degli anni '90.
Volevo che la gente mi prendesse sul serio. Il progetto, però, non mi ha convinto
fino in fondo e sebbene a molta gente piaccia quel disco, io non mi sento del tutto
soddisfatto. Intendiamoci, il disco mi piace e lo sento abbastanza mio, ma il problema è stato il processo che ha portato a quel disco: è quello a non essermi piaciuto.
Probabilmente è perché non è che sul Regeneration io faccia poi molto! In effetti
avevo un ruolo più piccolo del solito. La verità è che mi piace che i Divine Comedy
siano la mia cosa e in quell'occasione lo sono stati solo per una parte. Rispetto agli
altri dischi, Regeneration non è rappresentativo di tutto l'insieme di quello che è la
mia musica.
E continuando a parlare dei cliché, durante gli anni '90, specialmente nella prima metà, c'era in Gran Bretagna una visione di USA
vs. UK, di grunge vs. britpop. Come ti ricordi quel periodo? Sei stato
coinvolto in questa “lotta” nazionalistica?
Certo che me lo ricordo, ma non mi sono mai sentito davvero parte della scene
a quel tempo. Nessuno mi invitava alle feste! Non so, forse perché sono irlandese
ero un po' ai margini. Quello che facevo all'epoca era di concentrarmi sulle mie cose
e basta. In ogni caso, preferivo sicuramente la musica che veniva dalla Gran Bretagna,
rispetto a quella americana di quel periodo. Non mi è mai piaciuto davvero il grunge.
Mi ricordo di un mio amico che portò Nevermind dei Nirvana di qua dell'oceano
prima che fosse pubblicato in Inghilterra. Mentre lo ascoltavo pensavo che per essere
il futuro della musica, a me sembrava soltanto del noiosissimo heavy metal! Scherzi
a parte, ad ascoltarlo oggi mi rendo conto che è un grande disco, ma credo che la
maggior parte degli altri dischi grunge del tempo fossero orribili. D'altro canto io
amavo i Blur e il pop, e tutta una serie di dischi che sono usciti in quel periodo in
Inghilterra, sebbene non sia mai stato un grande fan degli Oasis...
Bang Goes the Knighthood è il tuo primo disco a uscire dalla tua
neonata etichetta, la Divine Comedy Records. Questo fatto ti ha
permesso di essere più libero che in passato?
Certamente. Quando ero in studio per registrare o lavorare all'album mi sono
reso conto che c'era qualcosa di davvero diverso che stava accadendo, perché non
c'era nessuno che mi teneva d'occhio, che entrava e mi diceva “Ehi Neil, il tuo cantato
non mi convince”. Nessuno mi telefonava per chiedermi “Ehi, come sta andando?”
Era tutto lasciato alle mie scelte personali, in un modo di lavorare che mi è piaciuto
molto. Sai, mi piace molto l'idea di fare le cose in autonomia. Ma c'è anche un rovescio
della medaglia, perché fare tutto da solo aumenta le tue responsabilità. Per esempio,
dovevo prenotare le sessioni in studio, dovevo ricordarmi di portare gli hard disk con
il materiale, ecc. Pensa che una volta ero all'aeroporto per andare a Londra a registrare gli archi e mi ero dimenticato gli hard disk a casa. Così ho dovuto telefonare a
un amico che me li ha portati in tempo! La verità è che non sono troppo bravo con
le responsabilità!
E con la tua etichetta hai intenzione di pubblicare anche altri
artisti?
È un'idea intrigante, mi piacerebbe molto. Ma Nathalie, che si occupa dell'intero
management, fa già il lavoro di trenta persone, che non so se posso chiederle anche
di fare questo! Credo che sarebbe davvero chiederle troppo. Per il momento continuerò a pubblicare le mie cose sull'etichetta, ma magari in futuro, se mi ritrovo a
non avere più idee per scrivere canzoni, potrei pensare di pubblicare qualche altro
artista!
25
Flying Lotus
—The (im)perfect beat
Drop Out
Sovraccarico e sovreccitato, svolta
personale e termometro di tutta una
ribollente scena, Cosmogramma è
il pretesto perfetto per ricostruire
il percorso di FlyLo alla ricerca del
beat (im)perfetto
Testo: Gabriele Marino
26
Per quel che ci riguarda, tra ritmi ed elettroniche, finora il 2010 è soprattutto l'anno di Gonjasufi.
Un culto che monta, macinando consensi, un nome
da cui aspettiamo, se non già il secondo album, sicuramente nuove e fresche produzioni. Chi si trova
un gradino più in su, chi questo cursus l'ha già
scalato tutto, è Flying Lotus: il 2010 doveva essere
anche - e soprattutto - il suo anno. Non quello della consacrazione, avvenuta due anni fa, ma quello
della grande conferma, delle certezze ribadite una
volta e per tutte, l'anno di un nuovo grande lavoro. Fa un certo effetto registrare un consenso così
compatto (pressocché unanime; bastino Wikipedia
e Metacritics) nei confronti di questo disco: Cosmogramma piace e piace assai, pare avere messo
d'accordo tutti, appassionati, musicisti, critici. Noi la
nostra l'abbiamo detta e adesso ci premeva più
che altro fare il punto della situazione: ricostruire
il percorso che ha portato alla consacrazione su
scala mondiale uno dei produttori più interessanti
e importanti dei nostri giorni. 1983
Steven Ellison continua la nobile tradizione
dei produttori dal destino segnato. Come e più
di Otis Jackson Jr., si trova a crescere in una famiglia di musicisti e di musicofili. E se a Madlib
tocca in sorte come zio il trombettista jazz Jon
Faddis, Flying Lotus ha come prozia un vero
27
pezzo di storia della musica afroamericana: Alice Coltrane, moglie di John,
musicista free e space visionaria. Lo Steven adolescente, al contrario del piccolo
Otis, non ha però ancora ben chiaro cosa farà da grande: suona, disegna, dipinge,
gira video.
Classe 1983, natali a Winnetka (California, la città di Boogie Nights), Steven
frequenta l'art school e prende dapprima la strada del cinema. Il suo film preferito è Fight Club (notare lo stacco culturale e generazionale da uno come
Mad, "fermo" a Melvin Van Peebles). La tv non lo interessa: ad eccezione di Adult
Swim, contenitore culto di cartoon supersballati e d'autore. Un giorno, tra un
Family Guy e un Cowboy Bebop, legge un annuncio che invita gli spettatori a sottoporre i propri demo musicali al network. Detto, fatto. E’ così che le sue produzioni domestiche (anche qui si sente lo stacco, niente sampler né drum machine,
100% laptop) finiscono tra gli stacchetti (bumps) messi in onda tra un cartoon
28
e l'altro, accanto a selezioni tratte dai
cataloghi delle più importanti label a
cavallo tra hip hop, ritmi ed elettronica: Ninja Tune, Warp, Def Jux e ovviamente Stones Throw (che con le musiche realizzate appositamente per
Adult Swim assembla le due antologie Chrome Children, 2006-2007). Il
legame con la Stones Throw è doppio
e segna profondamente il percorso di
Steven, che proprio presso l’etichetta
di Peanut Butter Wolf si trova a
lavorare per un breve periodo (non
sappiamo a che titolo): ha così modo
di vedere in azione gente come Madlib e soprattutto J Dilla. Sono i suoi
produttori-mito, assieme a Mr. Oizo,
Aphex Twin, Timbaland, Dj Premiere e Dr. Dre. Steven si decide:
farà il musicista. Il nome c’è – Flying
Lotus – ed è venuto fuori come in un
sogno lucido, perché «se potessi scegliere un superpotere, chiederei subito
di poter volare».
I primi frutti della scelta si vedono nel 2005, quando Steven mette
su cd-r il primo beat-tape, July Heat
(«non so perché, ma mi trovo a produrre
sempre durante l'estate»), raccolta di
beat hip hop brevi e asciutti, sulla scia
di Dilla non solo per il clap, ma anche
per una certa diffusa vena malinconica-agrodolce. E’ un Lotus ancora
molto derivativo, per quanto tecnicamente già consapevole. Lo stesso
anno Steven produce il primo pezzo
per altri, Off The Domain per John
Robinson, e si trova così nei credits
del disco accanto a Danger Mouse,
MF Doom e Madlib. E’ il 2006 però
l’anno decisivo, con un secondo cd-r,
Raw Cartoons, più colorato, sperimentale e ruvido del precedente, e
l’inserimento di Two Bottom Blues
(pezzo spacey e naif) in The Sound
of L.A., compila curata dal produttore Carlos Niño con dentro la
crema della scena losangelina: Cut
Chemist, Daedelus, Sa-Ra, Ras G,
Nobody, Georgia Anne Muldrow
e ovviamente l’onnipresente Madlib
(a nome Young Jazz Rebels). Niño si fa sponsor di Steven presso la Plug Research, neonata indie label fondata da Allen Avanessian, che lo mette subito
sotto contratto. Arriva così il primo album.
Il titolo 1983 (7.1/10) è l’omaggio di Steven alla propria generazione: la
stessa di altri produttori/amici come la Muldrow, GB, Black Milk, Gaslamp
Killer, Samiyam e Blu. Il disco, fin dalla copertina, presenta atmosfere spaceysynth e Sixties sci-fi, flirtando apertamente con chill out e downtempo. La
lezione di Dilla è sempre in evidenza e questo accostamento – inevitabile,
eppure sostanzialmente rifiutato dal nostro – sarà un biglietto da visita che
dividerà gli ascoltatori: chi lo vedrà come uno scopiazzatore, chi come l’abile
continuatore di una nuova tradizione, chi come il visionario di "terza generazione" che dovrà portare a compimento la mutazione del beat. Beat lineari e
amniotici, raffinati bozzetti ritmico-timbrici, con un paio di temini in evidenza
(la title track, Orbital Brazil): per quanto ancora acerbo, Steven è qui già pienamente Flying Lotus. Si veda la seconda metà di Pet Monster Shotglass, con
le due feature chiave dell’uomo perfettamente esposte: la ritmica scollata e
la timbrica organica, a suggerire una stabilità precaria, una pulsazione incerta – parkinsoniana – eppure viva. Feat di Laura Darlington (non ancora
stucchevole) e remix (non riuscitissimo) del marito di lei, Daedelus, amico
e mentore musicale di Steven (la sua influenza negli anni si farà sempre più
forte).
1983 è sicuramente un ottimo esordio e viene accolto da molti come la
prima prova di un nuovo grande talento. Tra questi, c’è il boss di casa Warp,
Steve Beckett, che fa di tutto per accaparrarselo. Steven fa il grande salto e
così nel 2007 esce l’EP Reset (6.2/10). Nessun taglio netto col passato, nonostante il titolo, ma un feel più patinato e catchy, per un lavoro comunque
di assestamento, con esercizi di loop di batteria, sperimentazioni con la voce,
reminiscenze bumper (Massage Situation, non a caso utilizzata da Adult Swim;
si nota un appesantimento dei suoni nel finale che indica alcuni degli sviluppi
futuri del nostro), dance primitiva (Floot Stalker) e il bel feat della singer Andreya Triana nell’iniziale Tea Leaf, pezzo migliore del lotto.
Si attende il lavoro di livello, che confermi e amplifichi quanto di buono si
è già sentito. L’hype cresce. E a stuzzicare fan e addetti ai lavori ci si mettono
anche due EP cuscinetto (prima parte di una trilogia che si concluderà nel
2009; complessivamente 7.0/10) con anticipazioni dall’album e remix realizzati da nomi importanti: Martyn, Samiyam, Ras G, Exile, Dimlite, Nosaj Thing
(altro nome hot tra le giovani leve).
L os A ngeles
Inguantato da una copertina allo stesso tempo macabra e sexy che occhieggia a Mezzanine dei Massive Attack (il dettaglio di una scultura gigeriana
realizzata appositamente dal duo di artisti Commonwealth, i coniugi Zoë
Coombes e Francisco David Boira), Los Angeles (7.8/10) è a tutti gli effetti il
precoce capolavoro di Flying Lotus e uno dei dischi chiave del 2008. Influenzato dall’atmosfera apocalittica e dal romanticismo fatto a pezzi di Blade
Runner, il disco è pensato come un ritratto notturno e fantascientifico della
metropoli americana, indeciso tra amore e odio, tra luce e buio. La poetica
lotusiana è al picco della maturità tecnica, espressiva ed emozionale: Steven
parte da Dilla e dall’hip hop strumentale di Dabrye e di Prefuse 73, si nutre di suggestioni lounge (come già su 1983) e techno e presenta al mondo
la propria personale declinazione glitch, uno dei possibili manifesti di quello
29
che è stato chiamato wonky. Non lavora sui loop, ma atomizza la materia
sonora alla ricerca del dettaglio, del singolo suono che faccia la differenza:
vuole creare una propria sintesi bassy, «unire gli apparenti estremi di ambient e
hip hop». E ci riesce. Los Angeles, sperimentale e godibile, è un lavoro che vive
degli sfaldamenti dell’ossatura ritmica e delle sporcature della grana timbrica,
esponendo tanto le crepe quanto le macchie con una piacevolezza d’ascolto
che ha fatto opportunamente tirare in ballo metafore gastronomiche e pasticciarie: cioccolato fondente, granella, zucchero filato. Los Angeles è carbone
di zucchero per un pic-nic tra le macerie: sentire Sleepy Dinosaur, un pezzo
a tutti gli effetti edibile, un misto di suggestioni tattili e papillari. Ricollegandosi alla tradizione trip-hop, Steven dà maggiore peso alla voce, con la solita
Darlington, con Dolly (la turca Ahu Kelesoglu), ma soprattutto con l’epifania
gonjasufiana, in uno dei pezzi più belli del disco, Testament (ma questa - come
si dice - è un’altra storia).
Al di là dei singoli episodi, la forza suggestiva di Los Angeles sta nell’impasto
che FlyLo è riuscito a creare, perfetta fotografia della convergenza qui e ora di
hip hop ed elettroniche allo stato dell’arte. L'album lancia Flying Lotus nell’empireo dei grandi nomi dei Duemila. Per capire come girano le cose, basta
sentire cosa dice di lui la dj e giornalista opinion leader Mary Anne Hobbs,
figura chiave dell’ondata dubstep (con lei e Shackleton Steven divide il palco
del Sonarlab 2008): «Flying Lotus è il Jimi Hendrix della sua generazione».
Il mondo è ai suoi piedi e Steven non si risparmia. Remixa i Radiohead, Shafiq Husayn e i King Midas Sound, jamma con Prefuse 73, produce José James e Dudley Perkins/Declaime (l’EP Whole Wide World;
6.7/10), sonorizza pellicole d’essai e fa da opener per un inaspettato vicino di
casa come RZA (il produttore del Wu-Tang Clan, trasferitosi da New York
a Winnetka). Con il collettivo di dj, laptop artist e producer di cui fa parte,
Brainfeeder (gente diversissima come Austin Peralta, Daedelus, Samiyam,
Dr. Strangeloop, MatthewDavid, Ras G e Gaslamp Killer), fonda l’omonima etichetta indipendente e intesse una rete di relazioni e di scambi con altre
fucine di ritmi come la LuckyMe di Hudson Mohawke (con il quale jamma)
e la Hyperdub di Kode9 (ne vengono fuori alcuni eventi live e un paio di split
EP). Il fermento è tanto e tale che ci scappa anche il fake dell’anno.
Per quanto lui si dichiari a proprio agio più con le cuffie nel chiuso della
propria stanza che non nella bolgia ovattata dei club, i live di Steven lo vedono
sempre sorridente e scatenato ad accompagnare ritmi e cantati (colpa della
"medicinal marijuana"?). Sono set eclettici ed esagerati, che frullano remix più
o meno sorprendenti come A Milli di Lil Wayne o Promiscuous di Nelly Furtado (vedere per quest’ultimo il bootleg Shhh!; 6.7/10), hip e glitch-hop («ma
quasi tutto il rap contemporaneo non mi piace»), pezzi prodotti per l’occasione
o improvvisati sul momento («produco ogni giorno, soprattutto quando so che
devo suonare dal vivo») e UK step (con Archangel, HudMo e Rustie in pole
position). Succede allora che FlyLo posta sul proprio myspace un frammento
tratto da uno di questi set, in cui mischia il Burial più ambient e un pezzo
di Dimlite, Ravemond's Young Problems, uscito su un'oscura compilation. Succede che il popolo del web riconosce il primo ma non il secondo e che è
troppo facile e troppo bello poter risolvere l'equazione come Burial + Flying
Lotus. Il fake dura poco, ma fa sensazione e, soprattutto, trasmette l’idea del
buzz che ruota attorno a Steven e alle sue mosse (e ovviamente alle mosse
di Will Bevan).
30
Cosmogramma
E’ tempo di anniversari e di festeggiamenti. Steven spegne le dieci candeline come produttore (2000-2010) e decide
di fare un regalo ai propri fan: A Decade Of Flying Lotus (7.3/10), megamix di frattaglie inedite, scelte, tagliate e
riassemblate dall’amico Gaslamp Killer. Un perfetto bignami del Lotus-modo in attesa del "secondo difficile album"
(su Warp).
Mentre raccoglie idee e mezzi per Cosmogramma (misunderstanding condensato di cosmic drama), Steven è iperstimolato e sotto pressione, come e più di prima. Alcuni dei suoi artisti preferiti, da Erykah Badu ai Portishead, si
sono dichiarati suoi fan; Thom Yorke si è letteralmente innamorato di lui (e di Gonjasufi) e ha ricambiato il favore
del remix di Reckoner offrendogli una propria collaborazione su disco e un posto come opener per i concerti del supergruppo Atoms For Peace. Steven, da par suo, suggestionato dai mille pad e dal Monome di Daedelus, è sempre
più interessato allo sviluppo di un’elettronica live e suonata e sogna una band in carne e ossa da portare in giro.Vuole
poi che il disco sia un omaggio alla prozia Alice, scomparsa nel 2007, sulla cui figura da anni sta preparando un documentario che «probabilmente non vedrà mai la luce». Queste le premesse del disco, questi i suoi ingredienti principali.
Definito una cosmic opera ed etichettato - non senza ragioni - come experimental psychedelic hip hop, Cosmogramma
soffre proprio questo eccesso di suggestioni, di input, di fonti, di strumenti e di materiali eterogenei messi in gioco, e
segna lo spostamento di FlyLo da una foto in bianco e nero (Los Angeles) ad una virata a colori vivaci-acidi, da territori
di sintesi a territori contaminati, da un glitch-hop memore di ricordi trip e attento ai fermenti dell'elettronica -step e
post-techno a un hip hop onnivoro e progressivo. Cosmogramma è un disco da ascoltare con la massima attenzione,
per poterne assaporarne tutti gli strati e coglierne i giusti scarti. Non un passo indietro, e neppure uno in avanti,
piuttosto uno di lato.
Steven, supportato da un consenso mediatico e critico senza precedenti, ne è entusiasta e già guarda all'orizzonte,
programmando le prossime mosse: una big band live che integri laptop, cantanti e strumenti analogici/elettrici; un EP
del suo duo FLYamSAM (assieme all’amico Samiyam); un remix per i Massive Attack. E fantasticando sui prossimi
sogni da realizzare: collaborare con Björk, con Prince, con Lil Wayne (...) e con i Jaga Jazzist. Tutti assieme. Lo
aspettiamo al varco.
31
Recensioni
A Guy Called Gerald - Tronic Jazz
The Berlin Sessions (Laboratory
Instinct, Maggio 2010)
G enere : T echno , deep
Vada che il precedente Proto Acid: The Berlin Sessions era
un trip techno e deep intinto di echi sci-fi, cassa in quattro e una deepness a scavare diritta nell'anima dell'uomo.
A metà Duemila averlo inciso live a Berlino significava
riazzerare le cose e ricominciare assieme a una nuova
generazione di dj e producer.
Il nuovo capitolo ne testimonia invece il ripiegamento in
una sterile fierezza techno-soul.
Ancora tutto strumentale (e perciò privo delle voci e
del sudore black che da Voodoo Ray a Essence lo contraddistinguevano), Tronic Jazz è un superfluo distillato di carne e circuiti con qualche buon momento
(Iland) ma soprattutto nostalgie canaglie che culminano, sul finale, in rimpianti dell'era Pacific State firmata
808 State. Gerald era uno di loro prima di buttarsi
a pesce nella fantastica giungla dell'indimenticato Black
Secret Technology (ristampato recentemente). Ora il suo
moniker preferito è pienamente storicizzato e l'album
per soli fan.(6/10)
Edoardo Bridda
AA. VV. - Indie Or Die (Disco Dada,
Maggio 2010)
G enere : vari
Ci sfugge lo scopo di questa compilation promossa dalla
neonata Disco Dada, visto che non si parla esclusivamente di un'opera celebrativa del lavoro della label.
Optiamo per un vero e proprio manifesto programmatico redatto anche con l'aiuto di artisti esterni (tra i tanti,
The Horrors, A Place To Bury Strangers, Umberto Palazzo, Schonwald, Who Made Who) col fine di
ben rappresentare i variegati interessi e il raggio d'azione
dell'etichetta. Nello specifico, un mix incoerente di wave,
psichedelia, canzone d'autore, folk, elettronica.
Gli artisti di casa rispondono al nome di Simona
Gretchen, Letherdive e Nevica su Quattropuntozero, per un disco che tra gli ambienti electro imponenti di Tying Tiffany, le chitarre sferraglianti degli
Audionom e gli Ottanta pop sintetici dei Fan Death
32
— cd&lp
raggiunge l'obiettivo non rinunciando a una certa dose
di coraggio.(6.7/10)
Fabrizio Zampighi
AA. VV. - Be Yourself - A tribute
to Graham Nash’s “Songs For
Beginners” (Grassroots, Giugno
2010)
G enere : folk rock
Fu (anzi: è) lo spigolo gentile di quel triangolo folk-rock
che trovò formidabile quadratura in CSN&Y. Tempra di
cantautor gentile anzi gentleman, il caro Graham Nash
merita certo questo bel tributo organizzato da sua figlia
Nile. La quale ha avuto l'idea e il buon gusto di concentrare il fuoco sull'album di debutto da solista del padre,
chiamando una pletora di presumo amici o comunque
simpatizzanti a reinterpretarne una traccia ciascuno.
Tale procedimento conferisce una certa uniformità
d'intenti pur nella inevitabile - e benvenuta - diversità
degli approcci. Vale a dire, predomina una grana vintage in punta di nostalgia, ma quel che conta è il carattere e la cura che ogni pezzo testimonia. Se la cavano
con bella disinvoltura i Vetiver, si disimpegna solenne
e generosa Alela Diane, promanano lirismo acidulo e
obliquo Port O Brien and the Papercuts, sprimaccia
una flemma istrionica Brendan Benson, mentre il caro
Bonnie Prince Billy ha ben pensato di concedersi una
parentesi da mariachi tenerone.
Forse quella meno in parte alla fine è proprio Nile, ma
sono dettagli: il paparino ha buoni motivi per essere orgoglioso sia del disco che dell'erede.(6.8/10)
Stefano Solventi
AA. VV./Jon Tye - Milky Disco III : To
The Stars (Lo Recordings, Giugno
2010)
G enere : M inimal spacey disco
Terzo volume della serie (il primo risale al 2007) che si
propone di esplorare e sdoganare il microcosmo della
cosidetta Nu Disco/Cosmic Disco. Siamo dalle parti della Minimal Wave recentemente riesumata dalla Stones
Throw. La selecta (in doppia versione unmixed + mixed,
curata dal boss di casa Lo Recordins, Jon Tye) com-
highlight
Born Ruffians - Say It (Warp Records, Giugno 2010)
G enere : I ndie rock
In Red Yellow & Blue si erano distinti per un indie collegale pimpante e vacanziero, zeppo di saliscendi
contagiosissimi come se Libertines e Wombats venissero presi a scosse dagli Animal Collective e
portati alle baleari dai Vampire Weekend. Del resto, la distanza per miscelare scene e sapori con l'atlantico nel mezzo c'erano: i ragazzi, pur sotto contratto con la londinese Warp, venivano da un piccolo
ma delizioso villaggio del Canada, Midland, sedicimila abitanti affacciati sulla Georgian Bay che d'estate ne
accolgo altri ottantamila facendo della città uno dei punti di riferimento per
il turismo nell'Ontario il cui capoluogo è quella Toronto sede dei Broken
Social Scene.
Il super gruppo dalla coralità contagiosa è però un'inflenza soltanto indiretta
per i Born Ruffians che in questo secondo lavoro maturano innanzitutto
una personale via canora intersecando l'urgenza rurale dei Violent Femmes con un'indole più consapevolemente folk-punk e una serie di tricks
neri nel fraseggio melodico. Luke LaLonde è diventato un frontman di un
brand riconoscibilissimo, la scocca avant-folk di una scrittura facile eppure
così complessa e piacevolmente afabulante, capace d'episodi confidenziali dai sapori r'n'b come What To
Say (che aspira già a diventare un piccolo classico indie-rock '00) ma anche di pose arty come Nova Leigh
(dall'accattivante tiro garage).
Il resto non sbaglia un colpo: il valzer di Blood The sun And Water, i tagli cow punk tropicalizzati di Oh Man
e le chitarrine esotiche di Retard Canard e lo strascicato crescendo di Sole Brother (il singolo d'apertura)
ne sono i migliori testimoni.
Saranno troppo raffinati per venir acclamati come devono, del resto i Born Ruffians hanno firmato fin'ora
il miglior album indie rock del 2010.(7.3/10)
Edoardo Bridda
prende dodici piccole perle undeground che declinano
in modi sempre diversi i verbi minimal e spacey. Questa
Cosmic Disco, in pratica, mette assieme suggestioni di
musica cosmica tedesca, minimalismo, la tastierosità di un
Jarre e di certo Vangelis, la primissima electro e il funky
della discomusic. Il risultato è deliziosamente demodè.
I brani partono - geneticamente - da scansioni e ritmiche electro, per travestirsi poi minimal (Leo Zero), tribal
(Ghostape), krautpop (Jonny Nash), disco e discofunky
secondo vari gradienti di concentrazione (tutti gli altri).
Agli estremi opposti si posizionano i giapponesi Cosmes, con una Iron Deck che resta electro al 100%, e gli
Oneohtrix Point Never, con una Astral Project T.I.N.A.
tanto dilatata da stingere in una intorpidita galleggiante
psichedelia post-Tangerine Dream.
Una goduria per i cultori, un'ottima introduzione per tutti gli altri.(7.2/10)
Gabriele Marino
AA.VV. - We Are Only Riders
(Glitterhouse, Gennaio 2010)
G enere : new roots tribute
Viene da porsi la domanda sul (relativo) clamore che
ha investito Jeffrey Lee Pierce tra la fine dello scor33
so anno e l’inizio del 2010.
Sul perché abbiano visto
la luce altre ristampe della
triade Miami/Death Party/
The Las Vegas Story che ratificano l’importanza dei
Gun Club e sul perché,
alcuni mesi fa, è stata infine
resa di pubblico dominio questa operazione. Forse che
certi miti non muoiono davvero mai e a maggior ragione
se a sostenerli ci sono sostanza e attualità.
Probabile che sia così, e un valido sostegno alla tesi lo
offre questo tributo dall’origine atipica. Le sedici tracce
prendono infatti le mosse da registrazioni casalinghe di
Pierce, in origine destinate all’album Ramblin’ Jeffrey Lee
& Cypress Grove With Willie Love, rinvenute dallo stesso
suo collaboratore Cypress Grove su una malmessa
cassetta per puro, fortuito caso. Cosa giusta accantonare
i sospetti di speculazione, perché nonostante il “peso” di
alcuni dei nomi coinvolti lo spirito che anima l’operazione è senza dubbio sincero. Lo prova la fedeltà del respiro
infuso sul pugno di originali - dove peraltro aleggia anche in senso “materiale” (una chitarra, una voce flebile)
l’ectoplasma dell’uomo, scomparso da quasi tre lustri - e
il fatto che i partecipanti siano stati in larga misura suoi
amici e/o collaboratori.
Superando una certa amarezza, non ci metti molto ad
afferrare la contemporaneità di questi brani, la classicità
che da potenziale (non era al meglio in quell’epoca, l’autore) diventa reale: che Lydia Lunch sorprenda in abiti
folk (struggente When I Get My Cadillac, funerea St. Marks
Place) o che Debbie Harry insegni una cosa o due a P.J.
Harvey (Lucky Jim); che Mark Lanegan riallacci un filo
andato perduto (Constant Waiting, la superba Free To Walk
con Isobel Campbell) e Nick Cave lo accompagni
(Ramblin’ Mind); che David Eugene Edwards mostri
una volta di più da dove proviene e i Crippled Black
Phoenix riconoscano un Maestro. Poco cambia, perché
hai di fronte lignaggio, attitudine e stile sempre più rari.
Come degli antichi blues e, al nocciolo, è proprio così
che stanno le cose.(7.5/10)
Giancarlo Turra
Acorn - No Ghost (Bella Union,
Giugno 2010)
G enere : modern folk - rock
Se una qualità non difetta ai canadesi Acorn, è proprio il
coraggio.Arrivare col secondo disco Glory Hope Mountain
arrischiando una sorta di “concept”, non è mossa da tutti; idem farla franca con un folk umanista e moderno,
talvolta aperto con misura alla grandeur sonora tipica di
34
svariati loro connazionali per via di arrangiamenti ricchi
nel dettaglio. Materia che torna anche qui e cammina a
schiena dritta tra malinconie di tastiere, violini e plettri; nell’escogitare brani che - in linea con le tendenze
dell’ultimo lustro - partono dalla tradizione per fuggire
via lontano.
Folk-rock nell’era del post? E sia, se del prefisso accantonate cerebralità sterili e invece abbracciate la curiosità a
tutto tondo, la voglia di osare senza eccedere nel recinto
della forma canzone. Questo è, a conti fatti, No Ghost:
un’osservazione delle radici condotta con passione e
acume tra up-tempo (Restoration) e impennate di classe (la percussiva title track, I Made The Law), tra oneste
convenzioni che riscaldano (Slippery When Wet, Crossed
Wires) ed esempi di Califone morbidi ma non torpidi.
Sono questi a regalare gli episodi che s’imprimono nella
memoria, al di là delle soluzioni produttive che su rifanno lampanti all’operato di Tim Rutili e soci. L’intensità
spiccia di On The Line, la ticchettante e dolce Almanac e
una Kindling To Cremation tra cielo e terra consegnano i
vertici di un lavoro solido, che apprezzi per un’altra virtù
degna di nota. Chiamasi discrezione.(7/10)
Giancarlo Turra
Actress - Splazsh (Werk Discs,
Maggio 2010)
G enere : E lettronica
Esce per la Honest Jon's di Damon Albarn e non per la
sua Werk il secondo lavoro a firma Darren Cunningham,
dj e label manager che per Hazyville si era guadagnato
comparazioni con Theo Parrish, Newworldaquarium e
Anthony 'Shake’ Shakir.
Continuando l'approfondimento dell’house piena di
“magie del mondo black” di quel lavoro, il ragazzo rischia svelando un lato sperimentale a tutto tondo in piena tradizione AFX. Splazsch ne è il foglio d’appunti:
materiale da remember Club dei 99 e di tutta la stagione
Exogroove 1994/1995 in un’egregia house bituminoso/
narcotica perfetta per l’after hour (Lost, Senorita) da un
lato, e un laboratorio di bassa fedeltà e degradazioni
synth (Bubble Butts And Equations), riscaqui amniotici (Get
Ohn in pratica il Moby degli esordi chiarificato della battuta e messo in lavatrice), sintetiche wave (Maze e Purple
Splazsch:Vangelis, Kraftwerk, certi Ottanta molto pop e
ritorno), lallazioni elettroniche berlinesi (Supreme Cunnilingus) e omaggi all'IDM storica (i Sabres Of Paradise
in The Kettle Men) dall'altro.
Un lavoro certamente di transizione, lontano dal dubstep (la sola Wrong Potion lavora sulla battuta dell'amico Kode 9) mediamente buono e affascinante con dei
momenti davvero ottimi (il piccolo classico garage NY
Always Human che pare rubato a un set di Ivan Jacobucci
o Ralf).
Actress si conferma moniker decisamente di culto.(7/10)
Edoardo Bridda
Alva Noto - For 2 (12k/Line, Aprile
2010)
G enere : A mbient N oise
Si diceva, recensendo Yannis Kyriakides, di come il
fattore committenza possa trasformarsi in una seria ipoteca per la musica d'arte. Il discorso vale anche in contesti extra-accademici. For 2, secondo album di Carsten
Nicolai/Alva Noto nel catalogo Line - etichetta sussidiaria della 12k di Taylor Deupree - sta qui a dimostrarlo. Ad accomunarlo al primo volume - licenziato sempre da
Line nel 2007 -, più che il vezzo di dedicare ogni singolo
brano a imponenti personalità dell'arte e della cultura,
è la strategia compilativa. Nel 2010 come nel 2007, For
significa infatti musica commissionata da musei, istituzioni culturali e, soprattutto, musica che il Nicolai artista
visivo ha utilizzato nel corso degli anni (qui dal 2003 al
2008) per installazioni, sculture sonore, performance...
Il disco, allora, si presta facilmente a una scansione che
riesca a isolare tre livelli di pregnanza estetica: a brani
che si intuiscono semplici riempitivi (per durata: Villa Aurora, Pax, Ans o ridondanza: T3), si affiancano esperimenti
mimetici piuttosto di mestiere (la niblockiana Early Winter, dedicata al grande compositore inglese) ed episodi
che invece meritavano senz'altro di essere ripescati da
quel grande limbo che dev'essere l'hard disk dell'uomo
Nicolai e della macchina Alva Noto (Argonaut, Stalker e,
soprattutto, Anthem Berlin, fanta-inno per la nazione inesistente Ergaland Vargaland).
Proprio per questo, For 2 è un lavoro che avremmo
apprezzato molto di più sotto forma di EP - se una distinzione di formati ha ancora qualche potere residuale
nell'arginare quella vertigine d'infinito che è l'iperproduttività di artisti siffatti.(6/10)
Vincenzo Santarcangelo
Anaïs Mitchell - Hadestown
(Righteous Babe, Marzo 2010)
G enere : F olk opera
Ambizione. È la prima parola che viene in mente ascoltando quest'ultima fatica di Anaïs Mitchell, folk singer
americana da qualche tempo accasata alla Righteous
Babe di Ani Difranco. Si tratta della trasposizione in
chiave folk del mito classico di Orfeo che, impazzito per
la morte della sua amata sposa Euridice, decide di andare
a riprendersela nel regno dei morti. La Mitchell, però,
non si accontenta di mettere in musica questa storia, ma
la ambienta - in modo vago come può esserlo un sogno nell'America degli anni Trenta: l'America di Little Orphan
Annie e della Grande Depressione; l'America del New
Deal e di Franklin Delano Roosvelt.
Ne esce una folk opera resa efficace, oltre che dalle canzoni e le musiche composte tutte dalla stessa Mitchell,
dalle orchestrazioni di Michael Chorney e la produzione di Todd Sickafoose (già con Ani Difranco e Andrew Bird). Oltre alla fragile e toccante voce dell'autrice, a dare valore alle composizione è la pletora di ospiti
più o meno noti al grande pubblico che ha chiamato a
raccolta. Ad Ani Difranco si sono aggiunti Justin Vernon/Bon Iver (nei panni di Orfeo), Greg Brown (la
cui voce cavernosa dà vita in modo straordinario al personaggio di Ade, basti ascoltare Hey, Little Songbird e His
Kiss,The Riot) e Ben Knox Miller (Ermes).
La sforzo compositivo è elevato e la stessa Mitchell racconta che questo progetto ha cominciato a prendere
forma nella sua testa già nel 2006, ma si è portato a
compimento solo recentemente, quanto è riuscita a far
uscire di bocca le proprie canzoni a molti dei suoi miti
del mondo indie-folk di oggi. Emerge ovunque l'amore
per il folk e per questi interpreti, con una cura non così
comune per ogni sfumatura della composizione (basti
ascoltare l'intricata struttura in rima dei brani).
Il ciclo prende il via con il matrimonio (Wedding Song,
tutta spazzole e dolcezze), ma come in tutti i drammi
che si rispettino, serve una dose di epica (Epic I) per
arrivare al primo episodio in cui i personaggi cantano
tutti insieme: Way Down Hadestown, che sa tanto di Tom
Waits, con il suo fare fintamente scanzonato, in realtà
organizzatissimo, e un'idea generale di processione pagana, tra il mardì gras di New Orleans e le marchin' bands.
Da come è concepito il disco, è difficile se non impossibile estrarre qualche brano in particolare (forse Our
Lady of the Underground con il call and response bluesy
di Persefone e il coro, o l'offertorio finale di I Raise My
Cup To Him). Rari i veri e propri riempitivi strumentali,
che pure sono necessari al disegno generale. Va invece
sottolineato il lavoro al coro della Hades Triplets, che
in Nothing Changes cantano
a cappella, in uno stile già
riportato sotto i rifelttori
dalle Unthanks, ma che
non suonerà certo nuovo
a chi segue il mondo del
folk.
Un disco intrigante, che
aumenta di valore con gli
35
ascolti e che fa venire la voglia di vederne, anche solo
in DVD, una rappresentazione teatrale (che però non è
chiaro se ci sia mai stata, almeno con questo cast). Ambizioso, ma riuscito.(7.3/10)
Marco Boscolo
Andrea Chimenti - Tempesta di fiori
(Soffici Dischi, Aprile 2010)
G enere : canzone d ' autore
Sorprende Andrea Chimenti con questa nuova uscita
a cinque anni da Vietato morire. Difatti, se anche avessimo ipotizzato una svolta dopo la pubblicazione dell'antologia ChimentidanzaSilenda, difficilmente avremmo
potuto immaginare ciò che Tempesta di fiori presenta.
Un Chimenti più solare, diretto, deciso a tornare a forme
di scrittura tradizionali, dove la tematica amorosa viene
sviscerata in una serie di ballate dalle tonalità se non proprio e sempre lucenti, quantomeno crepuscolari, o meglio
albeggianti visto il generale clima di rinascita e cambiamento di cui si nutrono queste dodici canzoni.
Laddove Vietato morire, album di per sé splendido, lo
vedeva meditativo, finanche altero, per brani che accanto
all'immancabile fascinazione per il songwriting complesso e maturo di David Sylvian continuavano una ricerca
spirituale già praticata nei lavori sul Qoelet e il Cantico
dei Cantici, Tempesta di fiori arriva come il primo raggio di sole dopo un'immersione notturna in sé stessi.
Elettriche ed archi contornano di seta e aria primaverile
canzoni dalle melodie ariose; la voce non ricorre come
d'abitudine a quei bordi ombrosi che sono il marchio
di fabbrica dell'ex leader dei Moda ma si lascia libera di
vibrare. E proprio l'avventura ottantiana che gli aprì la
strada solista traspare in certi frangenti, come uno spleen giovanile senza nostalgie ma con lo stesso vigore.
Nelle tracce iniziali le tante novità disorientano un po', e
lo stesso Chimenti pare dover prendere le misure, questo almeno fino alla loureediana Bellissima, quando cioè
il meccanismo comincia a funzionare al meglio, e da lì in
poi sempre di più.
Proprio a metà scaletta il classicismo baluginante di Feroce e inerme e Stupido così come l'intensità Paolo Benvegnù di Sangue portano l'intero lavoro al suo zenit.
Quasi in fondo invece la rilettura di Vorrei incontrarti di
Alan Sorrenti conferma uno stato di forma che non ha
reso vano un quinquennio di silenzio.(7.3/10)
Luca Barachetti
Angus & Julia Stone - Down The
Way (Pias, Aprile 2010)
G enere : folk pop
I due fratelli australiani Angus & Julia Stone dopo il
36
discreto EP And The Boys uscito l’anno scorso, arrivati
alla seconda prova mostrano tutti i loro limiti espressivi.
Un folk chitarristico piuttosto malinconico è il loro, cantato alternandosi con le voci maschili e femminili, ricco
di melodie ma prevedibilmente tendente al mainstream,
come già era in precedenza.
Questa volta troviamo qua è là anche qualche ambizione
più orchestrale a riempire le loro trame e il tutto appare molto curato e pulito. Cocorosie, Bjork ma anche
Emiliana Torrini i riferimenti più immediati, più di un
omaggio al buon Neil Young e in generale un mood che
non prende più di tanto; tutto rimane infatti in superficie,
calligraficamente. Voci esili e sussurrate, delicatezza e un
folk pop che non ha del resto molte pretese.(5.8/10)
Teresa Greco
Ariel Pink - Before Today (4AD,
Maggio 2010)
G enere : fantasy - psych
Ariel Pink ha ottenuto quello che voleva. Non solo è
approdato su 4AD, non solo si è costruito una band, ma
ha completato un’operazione culturale. Ha portato il
kitch Ottanta nel lo-fi. Lo vediamo dalla ovvia schiera di
proseliti che dietro al glo-fi trovano sempre il suo lume.
O la sua mancanza di lucidità, che il diretto interessato
chiama fantasy-psych.
Basta vedere Neon Indian dal vivo (con band) per capire
la portata del lavoro preparatorio di Ariel. Il quale oggi
arriva a sancire la sua paternità del fenomeno, offrendo
con Before Today una sequenza di ricordi pop appannati
Ottanta e fine Settanta - col senno di poi e l’accortezza di
fare l’occhiolino a destra e a manca. In realtà le differenze
ci sono eccome, rispetto ai capitoli precedenti dell’epopea pinkiana. Quella bassa definizione da macchina vintage
e mal funzionante che arrivava all’orrido sublime in dischi
come Underground, oggi, è sostituita da una sorta di
“fedeltà” suonata che perde il sapore casalingo. Niente
più patina di scortesia alla Residents. Pezzi come Round
Round o Beverly Kills non mettono uno sull’altro piste disorientanti dei pezzi degli Abba, fanno gli Abba, punto. Non
manca il distacco ironico del Nostro, che è gran visir e
gran giullare insieme - e a tratti rimane divertente (Little
Wig), specie nella seconda parte dell'album.
Eppure ci sembra che Before Today soffra dell’onda da
riflusso. Il luccichìo sotto l’acqua non scompare del tutto
(Butt-House Blondies potrebbe segnare un nuovo avvio
per la carriera di Pink, smutandando la scorza del grunge
da sotto il pop sentimentalone). È per questo che va
bacchettato, Mr. Pink, prima che scompaia dietro al personaggio.(6/10)
highlight
Divine Comedy (The) - Bang Goes The Knighthood (Divine Comedy
Records, Maggio 2010)
G enere : P op
L'ultimo disco dei Divine Comedy, la sigla dietro cui si nasconde Neil Hannon, era datato 2006 (Victory for
the Comic Muse), ma l'oramai quarantenne cantautore irlandese non è certo
stato con le mani in mano. Oltre a realizzare un concept album sul cricket
(The Duckworth Lewis Method, in coppia con Thomas Walsh), ad
aver scritto canzoni per altri (vedi alla voce Charlotte Gainsbourg) ed
essere apparso sull'ultimo album dei francesi Air, Neil Hannon ha anche
scritto un intero musical (previsto per l'autunno), un numero che conoscendo le sue passioni musicali prima o poi doveva arrivare. Bang Goes
The Knighthood, il primo disco a uscire per la neonata Divine Comedy
Records, continua la ricerca iniziata con Absent Friends, subito dopo il punto di svolta Regeneration, del pop perfetto lontano dalle classifiche e dall'hype. E il discorso rimane
lo stesso degli ultimi dieci anni: raffinato pop orchestrale, con un predilezione per il classico, spruzzato
di vaudeville e musical.
Un mini-musical sembra proprio l'iniziale Down in the Street Below, che dopo fin dall'introduzione con i
campanelli rimanda il pensiero a Shaftesbury Avenue e al Charles Dickens di Cantico di Natale (ma forse
Neil Hannon preferisce Anthony Trollope). L'aria di divertimento generale, che rimanda alle atmosfere
degli album migliori degli anni '90, si propaga per molta parte del disco: da una Neapolitan Girl shuffle
alla conclusiva I Like, passando per una The Complete Banker che nonostante il tono scanzonato da Broadway d'antan, in realtà si occupa della crisi finanziaria mondiale. L'attitudine generale, pur con i classici
rimandi musicali a Scott Walker (la titletrack, When A Man Cries) fa pensare alle narrazioni in musica
di Randy Newman, un maestro che lo stesso Hannon ammette di ascoltare e di amare, e con il quale
negli ultimi anni ha in comune la composizione per il cinema.
Altrove lo sguardo ironico si posa su quelli che per Hannon sono i mali della modernità: la tecnologie
che ci fanno perdere l'abitudine a dialogare (The Lost Art of Conversation, puro Divine Comedy), la scena
indie di oggi che sta già dimenticando il passato prossimo (il singolo At The Indie Disco, che nell'elenco
infinito di campioni del britpop anni '90 intercala “we drink and talk about stupid stuff/then hit the floor for
Tainted Love”). Lo sguardo musicale e sociale di stampo modernista raggiunge probabilmente il massimo
splendore in Assume The Perpendicular (si parla di cricket per ironizzare sulle manie della middle class) e
nella dolente When A Man Cries, dove Hannon sfoggia un'interpretazione ai massimi livelli.
Se per certi versi l'album è un completamento del discorso iniziato con Absent Friends, per altri è un
ponte gettato verso Casanova e A Short Album About Love. Neil Hannon sembra aver trovato un equilibrio tra il crooning e il pop, fusi in una visione musicale personale. Ma in Bang Goes The Knighthood non
tutto è fuoco. Alcuni brani entreranno di diritto tra i suoi migliori, altri (Can You Stand Upon One Leg, che
pare un b-side del musical riciclato alla bisogna, e il duetto in salsa Belle And Sebastian con Cathey
Davey in Island Life) sono da intendersi come inciampi in un percorso comunque sopra la media, per la
classe e l'esperienza del suo autore. Rimane un gradino sotto i suoi migliori lavori, ma gli episodi migliori
hanno le potenzialità per crescere sulla distanza. In fin dei conti, cosa vogliamo ancora: una manciata di
grandi canzoni non ci basta più?(7.4/10)
Marco Boscolo
Gaspare Caliri
37
Art Giraffefungal - Black
Porridge Kaleidoscope (Pointy Bird
Records, Marzo 2010)
G enere : E lettronica pura
Con un atteggiamento da scienziato pazzo assai simile
a quello ravvisato in Rothkamm e, per certi aspetti,
nel Kim Cascone di Anti-Musical Celestial Forces,
Art Giraffefungal s'inventa per il secondo album una
stramba forma di art-noise del tutto improvvisata.
Realizzati con "limited computer skills" e liofilizzati in sedici rapidi bozzetti sonori - solo uno supera i tre minuti
- gli strambi oggetti simulano maldestramente il formato
canzone ma assomigliano in realtà assai più vistosamente ai primi vagiti di elettronica accademica emessi negli
studi di fonologia d'Europa e d'America (o allo Xenakis
degli electronic works).
Chi già conosce il sound-artist inglese grazie a un album d'esordio (Balloon Animals, Pointy Bird Records,
2006) che viveva intero di una sola fonte sonora - i rumori emessi da un palloncino di gomma -, si stupirà di un
formalismo che si concede qui il lusso di seguire le traiettorie ordinate di sinusoidi, onde, feedback, o addirittura rarefatti pattern ritmici (The Temple Of Black Square).
A tutti gli altri sembrerà di esser capitati chissà come in
un caleidoscopio oscuro - per parafrasare il titolo dell'album - generatore di strutture simmetriche ostinatamente monocrome. Ovvero, in un incubo.(6/10)
Vincenzo Santarcangelo
Ättestupa - Begraven Mot Norr
(Release The Bats, Maggio 2010)
G enere : B l ack N oise F olk
Dopo una compilation (Utmarken) e un 12 pollici (1867), il famigerato combo, punta di diamante del
noise svedese, torna con un secondo full-lenght. Se il
precedente album si dipanava in maniera monolitica e
lineare nelle due lunghe tracce che lo componevano,
mescolando folk faunesco, kraut teutonico e suggestioni black metal, il nuovo sound acquisisce una tridimensionalità che, come suggerisce il titolo (Sepolto al Nord),
non punta al cielo ma indaga le profondità degli abissi
terrestri.
Oltre all'usuale coltre di densa sporcizia, il trio di Goteborg rielabora la formula aggiungendo parti acustiche,
intermezzi concreti ed una più opprimente componente percussiva. Nella nuova coppia di pezzi si alternano,
come di regola, momenti grevi, passaggi astratti e umori
da celebrazione funebre; la voce poi si mescola dentro la
pasta di mestizia sonora, accrescendone ulteriormente
la carica rituale e psichedelica. Begraven Mot Norr non è
dunque una replica del primo, ma la sua naturale evolu38
zione, più articolata ed ambiziosa ma sempre immancabilmente riconoscibile sotto il nero vessillo Ättestupa.(7.4/10)
Andrea Napoli
Avi Buffalo - Avi Buffalo (Sub Pop,
Maggio 2010)
G enere : indie pop
I falsetti nella Angie degli anni 00’ oggi rinominata Jessica,
una vaga attitudine surf (nell’ottimo singolo What's In It
For), il ripescaggio del migliori indie pop makers dello
scorso anno (XX, Animal Collective, Pains Of Being
Pure At Heart e Glasvegas) e un vago riferiferimento
all’estate sognata del glo-fi.
Ecco cosa ci vuole per fare un gruppetto che ha delle
serie possibilità di infrangere cuori e diventare la nuova
next big thing per la (fine della) prossima estate (Summer
Cum appunto). Sdoganati su Sub Pop, i quattro tardoadolescenti da Long Beach, California son fieri di avere il
passaporto americano.
La sottile sottile linea rossa si allunga quindi toccando
un miscuglio di folk country à la Wilco e qualche traccia Built To Spill, tutto ovviamente filtrato dalla lente
under 20: i loro testi non possono che essere quindi un
paradigma di amori insoddisfatti e di cliché chitarristici
che guardano sì a quell’imprescindibile mondo now, ma
con lo specchio retrovisore che punta ai '70 Fleetwood
Mac (One Last). Epici, spirituali e sbarazzini. Potremmo
innamorarcene.(7.3/10)
Marco Braggion
Bad Apple Sons - Bad Apple Sons (A
Buzz Supreme, Aprile 2010)
G enere : hard - wave - noise
Vincitori dell'edizione 2008 del contest di Controradio,
i Bad Apple Sons mettono in scena un hard-wave che
ha in sé il germe della trasversalità. Un bignami in cui si
riconoscono certi Birthday Party virati Jesus Lizard
(The Claim), le dissonanze incendiarie dei Korn (Take
This Mortal Tea), una new wave evocativa ai confini con
la psichedelia (Backroom Facials), claustrofobie industrial
in sbornia kraut (Whales Are Watching), i Sonic Youth
(Namby Pamby), tribalismi sfilacciati del primo Nick
Cave (I'm The Cutter).
La virtù maggiore del combo fiorentino è il saper diluire
le specificità di genere in una soluzione credibile e decisamente affascinante, sospesa tra rigore e sciabolate
di chitarre elettriche. Con le dinamiche dei Tool a fare
l'occhiolino dietro alle profondità oscure e teatrali di
questo omonimo esordio e un pugno di ospiti del giro
A Buzz Supreme - tra cui Samuel Katarro, Wassi-
highlight
Emeralds (The) - Does It Look Like I'm Here? (Editions Mego,
Maggio 2010)
G enere : kosmische new age
Il problema con gli Emeralds è sempre lo stesso: come prenderli. Come una appendice stramba e weirder
del nuovo noise americano o come un malato esempio di rielaborazione di ipotetiche trasversali kosmische/new age? Quale che sia la risposta a questo lecito dubbio di posizionamento e/o prospettiva, resta
la certezza che le definizioni potrebbero andare bene entrambe così come
nessuna delle due. Gli Emeralds sono una band coi controcoglioni e lo dimostrano ad ogni uscita, ufficiale o meno che sia.
Nello specifico, Does It Look Like I’m Here? rappresenta per forza di cose
un passo avanti per il trio. L’etichetta, innanzitutto, è la prestigiosa Editions
Mego, segno che Mark McGuire, John Elliott e Steve Hauschildt (chitarre e
chincaglieria analogica varia) sono ormai ufficialmente emersi dalla melma
post-noise dell’underground americano. La musica poi viene di conseguenza:
appare più screziata, meno incline agli stordimenti noise dei primi passi, sempre dilatabile verso lande kosmische sinthetiche e tappetini di suoni new age, seppur corposi e sfatti, con
una certa predilezione per quest’ultima deriva. A stupire però è il procedere eccentrico dei tre di Cleveland. Eccentrico nella macrostruttura dell’album tanto quanto nelle microstrutture di ogni singolo pezzo,
capaci, cioè, di partire da un centro e svilupparsi centrifugamente verso ogni reale direzione possibile.
Se ne parlerà a lungo e a lungo si discuterà sull’effettivo valore di questo album, così come della svolta
“educata” degli Emeralds. I giudizi saranno discordi ma non ci si potrà esimere da una grossa verità: nel revival dell'analogico, questo è uno dei gruppi più importanti di questo scorcio di terzo millennio.(7.2/10)
Stefano Pifferi
lij Kropotkin - a dare il proprio contributo nelle dieci
tracce della tracklist.(7/10)
Fabrizio Zampighi
Band Of Horses - Infinite Arms
(Columbia Records, Giugno 2010)
G enere : C ountry R ock
Con il sophomore post-Matt Brooke (nel frattempo
Grand Archives), la band di Ben Bridwell, rilocatasi
nella sua South Carolina, aveva ricalibrato e preso confidenza con la formula dell’esordio, riconsiderando ancora
una volta il southern sound agrodolce dei My Morning
Jacket, iniettandolo qua e là di spezie post-Neil Young
di gente come Built To Spill, Wilco e Iron & Wine.
Cease To Begin era però un lavoro ben lungi dal gettare il cuore oltre l’ostacolo; inferiore rispetto all’esordio
giocava, non senza malizia, dentro stereotipi consolidati
e liriche fin troppo consapevoli del proprio pubblico di
nicchia.
Per Infinite Arms la band ha voluto qualcosa di diverso,
ottenendolo con maggiore successo. Firmando major si
è dichiarata quintetto vergine e accogliendo due amici
(quali Tyler Ramsey alla chitarra e Bill Reynolds al basso)
ha voltato pagina a partire dall’iniziale Factory, il segno
più tangibile di una maggiore sicurezza nell'espressione
ma anche di un rinnovato arrangiamento: un suono pieno e spaziale nel quale cinematiche Black Heart Procession incontrano un chamber folk di tutto rispetto.
Altre testimonianze si riscontrano nel tiro folk rock à la
Crosby Stills & Nash della successiva Compliments e nei
tagli indie rock di Laredo e Northwest Apartment, nonché
negli episodi confidenziali (Blue Beard) quando non - senza troppo sorprenderci - pop (Dilly) o folk-pop (Evening
Kitchen) fino al country circa Harvest dell'emblematica
Older, degna di una classicità che ancora non saprà del
tutto d’autentico, ma è quanto basta per averceli intorno
senza star troppo a criticare. (7/10)
Edoardo Bridda
Benga - Phaze: One (Tempa, Giugno
2010)
G enere : dubstep techno
L’avevamo lasciato voglioso di ragga, ma il capellone
guerriero insiste con delle bombe di acido squadrato da
39
spararsi in vena che ricordano la techno maraglia europea. Il nuovo EP di lusso (doppio vinile e due bonustrack
per la digital version) è una cosa che ribolle hard dubstep calcato sull’analogico radioattivo.
Un preambolo infarcito di cartooning Marvel subito prima dell’uscita del progetto uberhyped Magnetc Man
con gli amici Skream e Artwork, una manciata di badilate sui denti fin dall’iniziale minimalissima e technoide
Baltimore Clap, infiltrazioni 8 bit (eyeTunes e Your Band)
senza farsi mancare dissing a distanza con Toddla T
(808), uptempo sintetici Planet Mu, parentesi Ninja Tune
(Rock Music) e il mesh firmato Crookers (No Bra, No
Panties).
Uscita per aficionados, Phaze One è la riconferma per un
grandissimo produttore.(7.11/10)
Marco Braggion
Bettye LaVette - Interpretations:
The British Rock Songbook (ANTI-,
Giugno 2010)
G enere : soul diva
Difficilmente Madame LaVette potrà ripetere il magnifico I’ve Got My Own Hell To Raise che un lustro fa la rilanciò. Non per colpa sua, intendiamoci: anche qui l’ugola si appropria con invidiabili maestria e varietà di ogni
composizione. Il fatto è che certe magie non le recuperi
che occasionalmente perché vivono di un momento e si
vestono di significati a esso legati. Piaceva infatti The Scene Of The Crime nel 2007, benché dobbiamo confessare
che il riascolto lo abbia un poco sminuito, ma tant’è. Insomma, ci piace ascoltare ciò che poteva diventare Tina
Turner se si fosse circondata di gente all’altezza e gli
anni non fossero stati i vacui Ottanta, tuttavia vorremmo
ogni volta un disco col cuore e le sofferenze gettate al di
là dell’ostacolo. Non si può, e a pretendere l’impossibile
si fa peccato.
La Signora ci perdona con dodici brani (più bonus dal vivo
in una squarciante Love Reign O’er Me di Peter Townshend) volti a omaggiare celebri songwriter britannici.
Ci sono un’ennesima Don’t Let Me Be Misunderstood di
classe e la mesta No Time To Live (dei bianchi per caso
Jim Capaldi e Steve Winwood), una trascinante The
Word sottratta a Rubber
Soul e la struggente Isn’t
It A Pity di George Harrison, eseguita come fosse
l’ultimo saluto agli avventori prima del mattino. Ci
sono sonorità tonde e nessuna traccia di manovalanza, persino in mosse meno
40
riuscite come la All My Love che comunque strapazza il
melenso originale zeppelininano e alcuni momenti “solo”
apprezzabili.
Quando però dalla stonesiana Salt Of The Earth sorgono
un afflato e una potenza che ingoiano ogni parola, capisci che non si deve chiedere sangue a chi ha già dato; a
chi compie miracoli riabilitando nefandezze del calibro
di Wish You Were Here e Nights In White Satin. Con buona
pace del recensore di turno, fastidiosamente seduto a
soppesare con vuoti numeri l’operato di un essere umano.(7.3/10)
Giancarlo Turra
Bitters (The) - East General
(Mexican Summer, Aprile 2010)
G enere : N oise P op
A volte capita che qualche band del roster Captured
Tracks sia in grado di riservare piacevoli sorprese e non
solo cocenti delusioni. I fautori del piccolo miracolo si
chiamano Bitters e sono un duo di Toronto formato
dalla cantante Aerin Fogel e dal chitarrista Ben Cook, già
negli arci-noti Fucked Up, nonché attivo in solo a nome
Young Governor. La proposta dei due, fortemente caratterizzata dalla versatile impronta vocale della Fogel, è
un noise pop che chiama a raccolta le paladine storiche
del post punk al femminile come Slits, Siouxsie And
The Banshees e Delta 5. Quindi chitarre ultra acide,
primitivismo percussivo distorto a dismisura, sgraziati
coretti da bambine ritardate e filastrocche al miele scaduto.
Se questo era già chiaro dalle due precedenti uscite di
breve durata, ora la coppia rilancia la posta e imbastisce un album di debutto denso e pastoso. Travelin’ Girl è
un fuzz pop ramonesiano e No Anchor un garage sixties
cristallino, mentre Wild Beast e il suo stomp faunesco,
insieme con Nails In The Coffins, che traballa su di un ritornello memorabile, sono lo spirito più inquieto che
infesta East General. In giro per il web, nelle pagine di
blasonate testate d’oltre oceano, potete leggere di come
I'm Feeling Good si trascini per sette minuti senza motivo,
ma non dategli retta: è solo la giusta chiosa di un lavoro
di lenta digestione, che mescola melodia e rumore, dolcezza e asperità. D’altra parte non si chiamano Amari per
niente, con buona pace degli omonimi nostrani.(7.1/10)
Andrea Napoli
Blue Van (The) - Man Up! (Iceberg
Records, Maggio 2010)
G enere : I ndie rock
Stavolta la periferia che prende dal centro, rielabora e
rispedisce è la Danimarca dei Blue Van (che dalle loro
parti è il furgone che trasporta i disabili mentali: in pratica l'Ottavo Padiglione).
Innamorato di certi anni '60 (i nomi che ricorrono sono
Kinks, Small Faces e Cream), il quartetto fonde le
influenze in una miscela non priva di verve e disinvoltura,
che innerva l'apparente semplicità dei brani articolando la struttura compositiva (l'iniziale Be Home Soon) o
attraverso stratificazioni (la title track) o arguzie (The
Socialite) di arrangiamento.
Al terzo disco (uscito nel 2008 e distribuito nello stivale
solo ora), però, l'amalgama non riesce ancora a fondersi
in uno stile che abbia una personalità riconoscibile: per
cui alla fine, nonostante l'efficacia del carrarmato Silly Boy
(primo singolo) o il piglio della marcia I'm A Man con azzeccato duetto di sax e un coretto da Stones in America, ad un ascolto distratto il gruppo rischia di passare per
uno dei tanti in zona Kapranos, a danno dell'intelligenza
con cui lavorano di dettaglio e di una buona freschezza
generale.(6.4/10)
Giulio Pasquali
Brendan Perry - Ark (Cooking Vinyl
UK, Maggio 2010)
G enere : elettronica trip hop
La metà maschile dei Dead Can Dance mancava all’appuntamento solista dal 1999, anno di pubblicazione del
magistrale Eye Of the Hunter. Lo si è visto poi, celebrare i fasti della reunion, insieme a Lisa Gerrard, con il
tour del 2005 e recentemente come ospite per la traccia d’apertura dell’ultimo Piano Magic. Uno che fa le
cose con calma quindi, del resto sulla maestria compositiva dell’australiano non ci sono più dubbi da decenni,
da quando tutto il catalogo DCD ha riscritto le regole
dell’arrangiamento rock pop per come lo conoscevamo,
andando a sperimentare le più erudite contaminazioni di
ogni epoca e latitudine.
Ark è quindi il disco che segna il ritorno del Perry compositore da più di dieci anni, e con un piglio che per stessa ammissione del suo autore va a scavare nelle stesse
coordinate della sua vecchia band. Niente cantautorato
e chitarre acustiche, come nel precedente disco solista,
piuttosto elettronica, samples, campionamenti, andando
praticamente a posizionarsi li dove avevamo lasciato
i DCD, con l’elettronica
mid-tempo di Into The
Labyrinth e soprattutto
Spiritchaser. La base è
quella, poi Brendan Perry si
diverte come un pittore ad
utilizzare scale, strumenti
e percussioni di ogni zona del mondo per arricchire il
quadro.
Ripescati due brani scritti per la reunion, Babylon e Crescent, il disco si concentra però su un banale e noioso
trip hop, senza troppe innovazioni o trovate di genio.
Materiale di normale amministrazione per uno come lui.
Un ascolto sicuramente piacevole per i fan dei DCD, ma
visto il personaggio e l’assenza dalle scene era ampiamente lecito aspettarsi di più.(5.7/10)
Antonello Comunale
Bungaro - Arte (Egea, Marzo 2010)
G enere : canzone d \' autore
Mestiere ingrato quello degli autori per conto terzi. Si
scrive su ispirazione ma anche su commissione, per interpreti d'eccellenza e per meteore bisognose di riempire un disco; talvolta poi ci si prende tutta la scena e
si pubblicano dischi da sé. Così per Bungaro, giunto al
sesto titolo di una carriera che lo ha visto fornire brani
a nomi importanti della musica patria (Mannoia, Vanoni,
Ruggiero, Patrizia Laquidara) ma anche a starlette da reality.
Con Arte rieccolo alla dimensione originaria di cantautore in bilico tra Italia e Brasile, innamorato tanto di Caetanto Veloso quanto di Sergio Endrigo, e devoto ad
una classicità raffinata che nell'aurea di João Gilberto
e Jobim lo vede accostarsi ad un altro autore-outsider
nostrano quale Joe Barbieri. E lungo una scaletta fin
troppo estesa di quattordici tracce, con un'evidente fase
di stanca giusto a metà, il brindisino ripassa le influenze
descritte ed altre conseguenti: etno-world poppeggianti
con veli sontuosi d'archi (Il motore immobile) o fragranze
di bandoneon (Trafficante); bossanove purissime che accarezzano il palato (la title-track con Paola Morelenbaum); calligrafie fossatiane (Il deserto insieme ad un'ovvia ma fondamentale Fiorella Mannoia); vaporosità di
synth e piano jazzato alla Sergio Cammariere (Vestimi
di te); piano-voce-archi in crescendo cinematici tipo Niccolò Fabi (Non è tempo che passa); deviazioni popolari
con liriche in dialetto e ospiti a fare da marchio di qualità
(Madonna di lu finimundi con Ambrogio Sparagna e
Lucilla Galeazzi; Piccenna Mia con Guinga).

C'è spazio anche per Dal destino fortunato, testo
inedito proprio di Endrigo musicato e arrangiato insieme
al pianista cubano Omar Sosa e all'ex Avion Travel Ferruccio Spinetti che, tirate le somme, risulta l'episodio
migliore fra liriche sempre dignitose ma con rari spunti
memorabili. Del tutto da dimenticare invece il duetto con
Neri Marcorè di Piacere di vederti, soffocante impasto
di retorica sull'amicizia e i dubbi della mezza età. Osi di
più la prossima volta Bungaro, e si prenda la classicità im41
bastardita (e non imperlucida come qui) di un Vinicius
Cantuaria o il cosmopolitismo di un Arto Lindsay.
Potremmo sentirne davvero di interessanti.(6.3/10)
Luca Barachetti
Canadians - The Fall Of 1960 (Ghost
Records, Aprile 2010)
G enere : guitar - pop
Mettete insieme gli Hüsker Dü, i Dinosaur Jr., il college pop degli Weezer, le armonie dei Beach Boys e
otterrete i veronesi Canadians. Un intreccio di chitarre
elettriche corpose spalmato su un'attitudine punk/postqualcosa che vive di fraseggi uncinanti e melodie appiccicose. Ai tempi del precedente A Sky With No Stars
qualcuno urlò al miracolo per un'opera che si limitava a
riproporre nella giusta chiave un immaginario legato agli
ultimi Ottanta/primi Novanta indie americani; di questo
The Fall Of 1960 si dirà forse, commettendo un errore,
che altro non fa se non ripetere quanto di buono si era
già ascoltato in quell'esordio.
Si tratta invece di un lavoro dalla scrittura certosina e
l'organizzazione quadrata. Quel misurare muri di chitarre e melodia che porta la band di Duccio Simbeni,
Michele Nicoli, Massimo Fiorio, Vittorio Pozzato,
Christian Corso, a dar vita a un piccolo capolavoro
di equilibri, produzione, sintesi e arrangiamento. Un po'
come era successo agli Yuppie Flu del 2003, quando con
Days Before The Day fecero intendere dove poteva arrivare la grazia di una piccola band italiana impegnata a trafficare con una musica lontana anni luce dalla tradizione
del Bel Paese. Per i Canadians di The Fall Of 1960, pur
con le dovute differenze stilistiche, vale lo stesso discorso: classe e fede incrollabile in un background di ascolti
capace di dar vita a un pop ricercato ma con punti di riferimento riconoscibili. Fulgido esempio di un indie forse
fuori moda ma tutt'altro che sepolto.(7/10)
Fabrizio Zampighi
Chrome Hoof - Crush Depth
(Southern Records, Giugno 2010)
G enere : psycho prog
Il classico gruppo da amare o odiare. Una confusione di
tante (belle) idee, (Sun Ra, ESG, Goblin, Parliament-Funkadelic e Black Sabbath), buttate giù un po' alla rinfusa sotto
l'ombrello del psych prog. Nel nuovo capitolo Crush Depth
l'amalgama mostra, rinnovamenti e non miglioramenti tanto che i Chrome Hoof di adesso sembrano una versione
contratta dei Faith No More epoca King For A Day.
Cristalline e One Day e Labyrinth sono le solite sfuriate
progressive forti di metalliche dosi di funk e teatralità,
eppure episodi come Sea Hornet (possente suite prog
42
con tanto di indovinato piano elettrico), Mental Peptides (che ai Faith No More aggiunge un filo di Primus)
e Vapourise (electro presa di peso dai primi ’80), tutte
strumentali, spiccano sul mucchio forse proprio perché
tali.(6/10)
Gianni Avella
Crystal Method (The) - Divided By
Night - Special Edition (Black Hole
Recordings, Marzo 2010)
G enere : E lectrock
Quarto disco in studio per il duo americano, uscito esattamente un anno fa, ripubblicato adesso in edizione doppia (coi remix).
Fan sfegatati dei Depeche Mode, i Crystal partono da lì
per tirare su la loro electro rocciosa, rockettara e contaminata, sorta di aggiornamento dei modi e dei suoni big beat.
Le loro produzioni non ci fanno impazzire, bene quando
azzeccano il pezzo "pop" (Come Back Clean, Slipstream, Falling Hard) o il riff potente (è qui che si sente la filiazione
Depeche; Dirthy Thirty, Kling To The Wreckage), male malissimo quando si abbandonano a intrecci di schitarroni e di
tastierine. Messa in conto una certa dose di generalismo e
di tamarragine (vedere alcuni feat vocali), i Crystal hanno
bei momenti. Che, affinando un po' la formula, potrebbero
fare un bel un passo avanti è una certezza. Ospiti il rapper
Matisyahu e Peter Hook, al basso in due pezzi.
Sui remix: come spesso accade, sono abbastanza superflui,
se non dannosi. Cose pessime (Sine Language ad opera di
Dunugoz e Tha Roofas Breakz; già l'originale è brutta, col
rappato di LMFAO), tanta mediocrità e qualche isolato
highlight (la title track deephousizzata da Andy Duguid,
niente comunque per cui strapparsi i capelli).(5.7/10)
Gabriele Marino
Cypress Hill - Rise Up (Priority,
Aprile 2010)
G enere : C ros sover hip hop
Considerando i sei anni di silenzio e la deriva qualitativa dei Soul Assassins di Dj Muggs, il ritorno dei
Cypress Hill è molto meno brutto di come ce lo si
poteva aspettare. Rise Up è un disco celebrativo (come
già Intermission) il cui scopo principale è ribadire il
ruolo del gruppo all'interno della tradizione hip hop e
alle origini del fenomeno crossover.
Ecco allora spiegato, da una parte, il classicismo funksoul
di alcuni buoni pezzi (su tutti la Light Up prodotta dal
maestro Pete Rock). Ecco allora spiegati, dall'altra, i riffoni hard di Tom Morello su Rise Up e Shut 'Em Down,
le progressioni emozionali di Mike Shinoda dei Linkin
Park in Carry Me Away e le declamazioni di Daron Ma-
highlight
Excepter - Presidence (Paw tracks, Febbraio 2010)
G enere : psichedelia nera
Rischiavamo di farcelo sfuggire tra le uscite dei primi mesi del 2010, questo colosso di 130 minuti diviso
in due CD, quadratura del cerchio della dilatazione di mondi (e di pupille).
Si parte con la saga Teleportation, un lungo viaggio - e come poteva non esserlo? - fortemente influenzato
dai brandelli della “industrial music for industrial people” (Teleportation: Bre).
Da Teleportation: Lil accade invece qualcosa di più interessante: nasce una sorta di Saucerful Of Secrets dei giorni nostri, con spunti minimalisti che si fanno
tappeto, soffi di tastiere e un mood misto tra metropoli e le rovine di Pompei. Il ciclo dei brani del primo CD è il modo di Excepter di aprirsi le porte
dell’aldilà, con culmine in Teleportation: Kop, un ibrido tra industriale e dub.
E così, nel nuovo inizio, dopo la planata del teletrasporto, si confida passo
passo qual è la chiusura del quadro, con prima tappa, pur con i filtri (personalizzanti) dei Nostri, su lande Steve Roach. Tutto è ancora giocato sulla
prevalenza del nero rispetto al colore, con fortissime valenze psichedeliche, ma anche con quella ricerca
colta che siamo sicuri gli Excepter abbiano sviluppato. Quando siamo sul punto di pensare che Presidence possa essere troppo intelligente a tutti i costi, arriva Leng, dove il dub si anima di una cosmica
di eccezionale efficacia, pur nel rimando continuo a quelle musiche che gli anni in corso, specie nel sottobosco del rumore, procedono a sdoganare senza tregua, così come l’idea di suite, di lunga durata, di
concentrazione.
Nessuno direbbe più “non mi piace”, specie se si trova scritto “è come se i Wolf Eyes rifacessero i PIL che
rifanno i Tangerine Dream”. Oppure “Eno/Fripp dei giorni nostri”, riferimento che si potrebbe spendere
per l’impressionante tenuta compositiva della quasi mezz’ora di Og - per non parlare dei 33 minuti della
title-track, geniale prestito Terry Riley (in un fanta feat. Experimental Audio Research) giocato sulle
varianti di un unico arpeggio senza posa.
Presidence è un monumento a una cultura musicale, un tout se tient. Può essere rifiutato come compilativo oppure strabiliare. Ma, all’interno di rimandi piuttosto chiari, il gioco è di tirare fuori un percorso
(secondo un’etica Spacemen 3) poliedrico, che inizia dai borborigmi industriali e risale fino al kraut. Un
album maturato nei tanti anni di attività del combo, interessato forse a orientare in modo abbastanza definitivo lo sguardo del passaggio ’00 / ’10 del nuovo millennio. Gli Excepter sono ora un gruppo eclettico di
psichedelia totale, diversa però da quella dei No Neck Blues Band, da cui gli Excepter (con intercessione di John Fell Ryan) derivano, almeno biograficamente. Hanno deciso di essere portavoce - d’eccellenza
- di un’epoca. Duro confrontarsi, d’ora in poi.(7.7/10)
Gaspare Caliri
lakian dei System Of A Down in Trouble Seeker, feat e
pezzi efficaci, anche e soprattutto al di là del rappato di
casa Cypress, che non sempre va a segno. L'iniziale It Ain't
Nothin', primo singolo, spacca senza appello. La conclusiva Armada Latina, pezzaccio per il barrio con il ritornello
di Marc Anthony (che nel video ufficiale si è fatto sostituire da un sosia), ribadisce le radici del gruppo.
Una manciata di brani brutti o pasticciati (citiamo solo
l'impacciato uptempo discomusic di I Unlimited) non riescono a far dimenticare le cose buone. Ma ad abbassare
il voto sì.(5.8/10)
Gabriele Marino
Damien Jurado - Saint Bartlett
(Secretly Canadian, Maggio 2010)
G enere : folk rock
Il coinvolgimento di Richard Swift - uno dei talenti più
versatili e imprevedibili di casa Secretly Canadian - quale
produttore artistico del nuovo di Damien Jurado può
essere letto in modi diversi. Ad esser buoni, si è trattata
di un'intesa sbocciata naturalmente fra i due, malgrado
la sostanziale diversità delle rispettive proposte. Volendo fare invece un po' di dietrologia a gratis, potremmo
supporre che l'intervento di Richard il Bizzarro sia stato
foraggiato dalla stessa etichetta per dare una scossa alla
43
discografia di Jurado, le cui potenzialità finora non sono
sbocciate come e quanto è lecito supporre. Il risultato
è l'ennesimo buon disco del buon Damien, con gli stessi immancabili rimandi (le apprensioni Jason Molina, i
malanimi stropicciati Will Oldham, l'incedere grave e
struggente Black Heart Procession...) e la sensazione di trovarsi ad un passo dall'eccellenza in ambito folk
rock. Giusto un passo indietro, ma è quello che fa la differenza.
La mano di Swift va forse indovinata nella fibra onirica ed
evocativa degli sfondi sonici
(le cianfrusaglie mnemoniche di Pear, le perturbazioni sintetiche à la Sparklehorse di Kansas City...) e
per qualche azzeccata intuizione in sede d'arrangiamento (l'ipnotico intreccio
di arpeggi nel finale di Rachel & Cali, i coretti gospel
di Beacon Hill...). Per il resto, a bilancio possiamo mettere
un paio di pezzi notevoli come Wallingford (elettricità tra
front porch e metropoli come il Neil Young di Freedom) e Cloudy Shoes (palpitazioni a volo d'uccello tra
Nick Drake e Radar Bros.), mentre il singolo Arkansas
giochicchia tra movenze fifties e inquietudine strisciante
come uno Springsteen giovane posseduto dallo spettro
di Scott Walker.
Insomma, è un buon lavoro, ma a Jurado manca ancora
qualcosa.(6.4/10)
Stefano Solventi
Dan Sartain - Lives (One Little
Indian, Maggio 2010)
G enere : garage & roll
Passano gli anni e Dan Sartain da Birmingham, Alabama, assomiglia sempre più a un figlioccio sartorialmente
più stiloso del buon Tav Falco. Pesca nello stesso immaginario sonoro - aggiungendo talvolta un po’ di primi
sixties - ma la pianta è quella e guai a lamentarsi. Anche se non c’è stato e non potrà mai più esserci Alex
Chilton a produrlo (troppo sperare in Billy Childish?),
prosegue imperterrito nell’approccio basilare e minimale verso le radici del rock.
Roba che dopo il successo planetario degli White Stripes ancora ti chiedi come faccia a rimanere di culto eppure è così: nonostante una stampa inglese finalmente in
grado di capire il suo operato - omaggiare il passato e un
intero mondo ivi racchiuso senza scadere nella cartolina:
mica facile - non siamo andati oltre un apprezzabile successo indipendente. Però qualche copia in più della me44
dia deve smerciarla, se alla One Little Indian ancora non
gli hanno fatto le scarpe di cemento. Significa che Sartain
è tosto, è uno che con dedizione e pazienza prima o
poi diventa “capo famiglia”. E’ sulla buona strada e amen
se questo nuovo disco è un poco sotto al precedente
Join Dan Sartain, per varietà di accenti e brillantezza della
scrittura.
Conta che Dan si confermi fedele al suo credo, ora che
siamo pure orfani di Mink De Ville; conta che sia ancora
qui tra vent’anni a rifilarci orologi d’oro rubati (Watcha
Gonna Do? un folk-beat che non tradisce; quella The Passenger riportata alla Sun Records chiamata Prayin’ For A
Miracle), auto usate col contachilometri ritoccato (i perfetti garage Yes Men e Bohemian Grove; l’affilata Bad Things
Will Happen) e sigarette di contrabbando (una Ruby Carol sardonicamente noir; il romanticismo stradaiolo che
muove Touch Me; l’innodia ubriaca di Atheist Funeral).
Prendiamo, paghiamo e ringraziamo, perché il brivido del
proibito ci piace. Hm, hm, magico Dan
(7.3/10)
Giancarlo Turra
Daniel Johnston/Beam Orchestra
- Beam Me Up! (Hazelwood, Marzo
2010)
G enere : indie - pop
Il percorso è coerente. Prima un disco come Is And Always Was in cui aggiornare le cassettine giovanili con un
pop-rock adulto e rotondo, poi la big band di turno, a
sondare un inedito classicismo orchestrale che vorrebbe
forse richiamare - nei sogni, più che nelle intenzioni - il
Let It Be degli amati Beatles. Il Phil Spector della situazione diventa Bart van Dongen - leader del collettivo olandese BEAM -, abile manipolatore di un tessuto
orchestrale fatto di contrabbassi, percussioni, sax, violini,
violoncelli e tromboni. Quest'ultimo ideale spartiacque
con il passato sotterraneo sempre più lontano dell'artista americano.
Tutto nella norma, a vederci chiaro. Il problema è che
l'arrangiamento classico che spopola in Beam Me Up!
brutalizza Johnston e lo obbliga a una disciplina che non
gli appartiene. O meglio, che non appartiene a una voce
come la sua, sgrammaticata e pasolinianamente neorealista, sgraziata e incapace di irregimentarsi, oltre che completamente inadatta all'intensità emotiva da crooner in
smoking che le si richiede. Un elefante in un negozio di
cristallo tediato dal Sondre Lerche primaverile di Try
To Love, sballottato dalla Shirley Bassey di Must, schernito dagli elefanti effervescenti di Wicked World. Strumenti
e cantato viaggiano paralleli senza incontrarsi quasi mai,
se non nell'iniziale Syrup Of Tears, nella splendida True
Love Will Find You In The End, in Walking The Cow e nella
bandistica Devil Town. Guarda a caso gli unici episodi in
cui l'orchestra si fa parzialmente da parte o opta saggiamente per il sincopato proprio del rock.
Alla fine non ci si scandalizza più di tanto per il risultato
finale - e pazienza se qualcuno si sperticherà in elogi
fuori luogo - ma certo è che con Beam Me Up! ci si
trova di fronte al primo disco in cui l'estrema sincerità
artistica del personaggio Johnston non riesce a colmare
del tutto il divario con il linguaggio musicale scelto per
veicolarla.(6.6/10)
Fabrizio Zampighi
David Maranha - Antarctica
(Roaratorio, Maggio 2010)
G enere : drone - rock
David Maranha torna al suo solo-project in cui unisce
la fascinazione per il minimalismo e l’indubbio retroterra rock. Un po’ come succedeva per Marches Of
The New World, di cui questo Antarctica è ideale
prosecuzione, le lande toccate dal compositore portoghese sono quelle di confine tra i “generi” citati sopra:
da un lato il minimalismo più rock-oriented che prende
le mosse dal Dream Syndicate di LaMonte Young, passa per Terry Riley e arriva all’Outside The Dream
Syndicate della premiata ditta Conrad/Faust; dall’altro l’insanabile amore per i Velvet più dilatati e trancey,
tutti pelle, depravazioni e reiterazione.
Ad accompagnare Maranha (a organo e violino) troviamo Riccardo Dillon Wanke alla chitarra elettrica,
Joao Milagre e Stefano Pilia al basso, Patricia Machàs al
tambourine e Afonso Simoes alla batteria. Dunque una
grande band d’appoggio dalla notevole coesione e forza evocativa, per un suono reiterato che non si limita a
disegnare nuovi paesaggi sonori nella coscienza alterata
dell’ascoltatore, ma si offre corposo e ipnotico come
non mai.
Meritoria, in questo senso, la scelta del vinile: nelle facciate del disco le due suite untitled da 20 minuti l’una
spalmano la catalessi sonora su un tempo in apparenza
immoto, ma in cui le minime variazioni cromatiche sprigionano una agonizzante e monolitica versione dronerock dell’ottimo e screziato predecessore.
Lande distanti, malinconicamente solitarie e gelide vengono evocate attraverso un ossessivo lavorio di cesello
sui timbri di violino, organo e chitarre che pone Maranha
ai vertici del genere per ricercatezza e risultati.(7.2/10)
Stefano Pifferi
dDamage - Aeroplanes (Ascetic,
Aprile 2010)
G enere : electrocros sover
Al decimo disco, tra LP ed EP, i fratelli francesi Frederic e
Jean-Baptiste Hanak appiccicano i soliti nomi di richiamo
(Jon Spencer, Bomb The Bass, Mochipet; altrove
erano MF Doom e Dose One) sulla loro poltiglia a
base di electro rocciosa, hip hop commerciale, b-breaks
e momenti più rilassati tra ambient e softechno, gettando anche uno sguardo tamarro su certa effettistica daftpunkiana. Brutto come la copertina.(4/10)
Gabriele Marino
Dead Meadow - Three Kings
(Matador, Maggio 2010)
G enere : H eavy psych
Tempo di celebrazioni per
il trio di Washington, dopo
quel Old Growth che,
spostando il loro heavy
blues verso terreni psycho
folk, ne ricalibrava le aspirazioni.
Oggi si propongono come
i figli prediletti della lunga
genealogia stoner, tanto che potrebbero perfino aspirare
ad essere l'act di maggior successo, se non fosse che a
questi tre freak poco interessano le vaste platee.
La loro è musica degli infiniti spazi e delle profonde introspezioni: i loro deliqui psichedelici partono da premesse
terrene (la matrice sabbathiana è sempre presente), ma
si aprono verso soluzioni free form o in lunghe jam che
non perdono mai di vista la loro matrice umana, non
tralasciano la melodia e la componente emotiva.
Three Kings, lungi dall'essere un semplice live album, è un
progetto che appartiene ad un'epoca in cui musica e immagine procedevano avvinghiate in una sorta di simbiosi.
Il cd, infatti, è la colonna sonora di un vero e proprio film,
che alterna suggestivo materiale video dal sapore mistico, a frammenti dal vivo: il risultato è quello di tracciare
una volta per tutte le coordinate del dreaming landscape
della band.
Una sorta di manifesto, dunque, le cui aspirazioni non
escludono la godibilità di un album estremamente pulito
e potente nelle sue tracce live.
I cinque nuovi brani testimoniano la crescita esponenziale del combo. Dal gruppo si stacca il singolo That Old
Temple: sorta di War Pigs del terzo millennio, che fra stacchi jazzy e vagheggiamenti acid rock, concorre fin da ora
al mio personale titolo di fuzz song dell'anno.(6.9/10)
Diego Ballani
45
highlight
Frank Bretschneider - EXP (Raster Noton DE, Maggio 2010)
G enere : P ost -T echno
Frank Bretschneider spartisce con snd, altro act di matrice techno di casa rastern-noton, la capacità di
procedere in direzione dell'essenza del suono elettronico per sottrazione, o meglio sarebbe dire per
via di progressive scarnificazioni - il termine non è casuale: è un processo caratterizzato da una violenza
espressiva di fondo che lo rende davvero peculiare.
Ma il co-fondatore dell'etichetta di Carsten Nicolai è dotato di maggiore
inventiva rispetto al duo britannico Mark Fell/Mat Steel, maggior senso
del ritmo, del movimento, più consapevolezza della struttura - diremmo, del
dna - di quel suono e del suo farsi. E' anche più ambizioso, come mostra il nuovo lavoro EXP, poderoso esempio di gesamtkunwerk elettronica che si articola in un un album audio e un
dvd contenente 18 minuti di visualizzazioni algoritmiche in formato .mov.
La suddivisione in 35 brevi tracce è puramente convenzionale: ciò che qui
si ascolta è l'incessante peregrinare di un unico segnale audio e delle sue
esondazioni ritmiche, volumetriche, dinamiche (nel cd audio) e grafiche (nel dvd), realizzate secondo un
procedimento che ricorderebbe molto da vicino le griglie autogenerantesi del Nicolai di Grid Index
(libro-opera grafica di recente pubblicata da Gestalten) non fosse così fieramente improntato su principi
stocastici.
Le strade infinite di ritmo, volume, movimento, intensità e struttura sono scandagliate da Bretschneider
con il piglio sistematico e l'acribia dello scienziato puro - ma con quella dose di spregiudicatezza che è
dello scienziato sperimentale a là Albert Hofmann -, in ossequio al principio secondo cui "fine art should
attain the abstract purity of music". Ciò che rende EXP un appuntamento al quale nessun ascoltatore
curioso può sognare di sottrarsi. (7.4/10)
Vincenzo Santarcangelo
Dead Weather (The) - Sea Of
Cowards (Warner Music Group,
Maggio 2010)
G enere : R ock
Rispetto all'esordio Horehound, la differenza sta nel
gioco di squadra. I Dead Weather, scemato l'effetto sorpresa della formazione (Jack White formalmente alla batteria) e nella formula (un hard-blues aperto al crossover,
un taglio goth e post-modernista), si comportano come
chi non ha bisogno di strafare per confermarsi.
Sea Of Cowards pare registrato in poco tempo e con
il menefreghismo necessario, gerarchizzando così - una
volta per tutte - il progetto al numero tre nel cantiere ex
White Stripes, ma anche conferendogli la scioltezza e
l’inventiva necessarie.
La maggiore presenza al canto di Jack (in due canzoni
canta da solo, nelle altre duetta utilizzando call and response) è puramente casuale: Allison Mosshart guadagna
sensualità e personalità in episodi come Gasoline e Jawbreaker, mentre l'uomo che fa veramente la differenza
è Dean Ferita. Accanto a canonici riffoni primi 70 im46
partiti dal batterista, lo Stone Age infila effetti su effetti
impiegando la chitarra a mo’ di synth e viceversa.
L'apporto retro-modernista è, di fatto, l'incastro sottile
che ne costruisce la cifra stilistica o se preferite il miglior
sabotaggio al marchio di fabbrica White Stripes, presente
e in alcuni casi pure ingombrante (No Horse). In questo
contesto di regole autoimposte o accettate (alla fine dei
conti è pur sempre un side project), scherzetti elettronici (Looking At The Invisibile Man) e cazzatine (I'm Mad)
finiscono per acquisire una posizione “altra” rispetto al
giochetto da rockstar compiaciute; piuttosto, tracciano
un’alternativa ai consueti episodi dal taglio blues (Jawbreaker) e conferiscono al sophomore dinamica, varietà
e un paio di momenti degni del miglior Jackie (Blue Blood
Blues: formidabile gioco tra Sabbath e Zeppelin, effettistica e controcanti soul; The Difference Between Us: tensione sottotraccia e circolarità sintetiche che conducono a
una coda d'esplosioni psych-blues).
Rimane, è vero, un sapore di prodotto da supermercato
dell'autenticità (o proprio di essa ci si prende affettuosamente gioco, il dibattito è aperto), eppure la contro-
mossa è funzionale e l’album si gusta proprio in ragione
dell’intesa tra i musicisti.
A corrente alternata o congiuntamente blues-sintetica,
Sea Of Cowards fa il suo dovere: arrivare dritto in
pancia, e anche più giù.(7/10)
Edoardo Bridda
Digi G'Alessio - L'attentato ai
mondiali (Signora Franca Records,
Aprile 2010)
G enere : uonchi banghra
Una colonna sonora immaginaria per il nuovo disco di
Cristiano Crisci. Il fiorentino importa le sonorità banghra nel suolo italico e inaugura una nuova stagione di
elettronica contaminata per il Bel Paese. Se già con Uxo
avevamo subodorato la possibilità di uno uonchi (scritto
così perché de noantri’), con questo disco si capisce
come gli impasti che vengono da M.I.A., Missill e tutte
le ristampe pop della Sublime Frequencies non siano passati inosservati ai radar delle camerette di infiniti nerd.
Di geekness si può decisamente parlare: il mood insiste
su un tunnel strippato di tastierine cicciose (A pranzo dal
nemico) e ricordi per maniaci di consolle a 8 bit (Wave Ya
Mitrahs In Da Air). Ma il ragazzo fa di più, innesta un meticciato che spilucca sia dal Vicino Oriente (La Partenza)
che dal Sud America e dalle colonne sonore di Morricone (L’attentato fallisce). In più c’è la mescolanza con le
basi stictly hip-hop (L’ultimo giorno allo stadio) e darkstep
infatuato di Supercar (L’invasione delle spie russe).
Un modo di reinventare l’hip-hop - passando per tutto
quello che sta succedendo ora - in uno streaming truzzo
senza confini che sa il fatto suo e segna il nuovo corso
(dopo il botto mainstream scoppiato con i Crookers)
dell’indie italo-hop. La punta di un iceberg che (come ci
ha confessato Cristiano via e-mail) segnala un’interessante e frastagliata realtà musicale italica. Licenziato su Creative Commons, L'attentato ai mondiali è il punto di
partenza per l’esplorazione di un underground mutante
in odore di next big thing. Stay tuned, folks!(7.3/10)
Marco Braggion
Dillinger Escape Plan (The) Option Paralysis (Season Of Mist,
Marzo 2010)
G enere : M ath C ore
What did you expect? That we would never leave home? ...
we can never get back what we choose to throw away. La
maggior parte di ciò che è stato detto o scritto sui TDEP
dall'epoca del secondo album, si è limitato ad un unica
questione: la scelta di inserire elementi melodici in quel
peculiare marasma sonico di ipertecnicismi prog/metal e
rabbia punk che li ha resi, sin dall'esordio Calculating
Infinity, nome imprescindibile per i nuovi HC kids, assieme ai vari Converge, Coalesce, Botch e Cave In.
Da allora la critica si è polarizzata tra sostenitori e detrattori lasciando ben poco margine a giudizi di merito
sugli album. Il sophomore Miss Machine, a parte l'effetto
sorpresa di zuccherosi refrain, è in realtà poco più di
un tentativo di ridefinire la formula dopo un massiccio
cambio di line-up che vede la sostituzione del bassista
Adam Doll con Liam Wilson e del cantante Dimitri Minakakis con Greg Pulciato. Formula che trova un migliore compimento nel successivo Ire Works dove le sfuriate math-core si sono bilanciate all'interno dei pezzi,
ora propriamente canzoni con Pulciato ad alternare urla
indemoniate e anatemi Power-Pop.
Lungo il medesimo solco si colloca Option Paralysis, ancora in bilico tra tentazioni da classifica pop-rock e una
sempre indomita furia hardcore, eppure con qualcosa
fuori fuoco. Il tragico piano di Windower è decisamente
sopra le righe, ed in altri episodi (I Wouldn't If You Didn't,
Parasitic Twins) i ragazzi non riescono a ripetere la scrittura compatta che li caratterizzava in precedenza, anrzi
forzando ancor più la convivenza tra le due anime.
(6.4/10)
Leonardo Amico
Dirac - Phon (Valeot, Maggio 2010)
G enere : drone post - rock
I Dirac sono un trio viennese, qui al terzo disco, che a
quanto afferma fa “musica da camera del 21esimo secolo”.
Usano laptop e strumentazioni acustiche e a questo giro,
ottengono un’unica suite di 42 minuti che come si legge nelle note di copertina è stata registrata in un’unica
soluzione, sebbene ci sia anche l’indicazione “performer
& arranged by Dirac 2007-2010”. I tre sembrerebbero
quindi avere una percezione del tempo quanto meno
singolare.
Musicalmente, stiamo parlando di drone music dal risvolto post rock. Sembra di ascoltare le vecchie cavalcate, in lento e sistematico crescendo dei Godspeed You
Black Emperor, ma non c’è la stessa emozione o la
stesso piglio avventuroso.Tutto è previsto in precedenza.
A partire dal diagramma della copertina che riporta le
quattro parti in cui è idealmente suddiviso il brano, con
relativo crescendo sonoro. Tutto troppo calcolato per
emozionare.(5.5/10)
Antonello Comunale
47
highlight
Indian Jewelry - Totaled (We Are Free, Giugno 2010)
G enere : psych - industrial
Gli Indian Jewelry sono magistrali nel proporre un pot-pourri di questi anni. All’indomani dell’uscita di
Free Gold, li avevamo già presi a esempio di una ondata psichedelica, poi altre band avevano dato vita
al cosiddetto digital shoegaze (un'etichetta nostrana), e ci eravamo voltati a guardare di nuovo a loro da
quella prospettiva.
Oggi, Thrasher e Kerschen sono più digitali che mai, impredibili e auto-evidenti nelle citazioni più o meno volute e Totaled, il loro trip gotico, programmato e aderente certo vintage avant-synth inizio Ottanta (Cabaret
Voltaire, primissimi Human League, D.F.A.), all'insegna di una psichedelia
nera sempre più industriale.
Vision, infatti, è versione ultra-downtempo di Heroes di David Bowie. Un
potentissimo incedere Ottanta annegato nell’ultra-nero alla Royal Trux ancora alle prese con le droghe leggere.
Trovano intersezioni uniche, gli Indian Jewelry e se il titolo dell'album sta tutto lì, i palesi riferimenti sonici sfumano dietro alla capacità di sfocare la profondità del campo acustico e nello sbilanciare il figurativo
musicale dentro un bad trip tutto di cervello. E' da qui che nasce un'attitudine trasparente da un punto
di vista armonico, di mestiere se vogliamo (come è evidente nelle tante drum machine e in particolare in
Tono Bungay), furba e persino di moda nei circuiti lo-fi che oggi contano più che mai.Va però riconosciuto
ai Jewelry il compimento di un percorso personale originato dall’esperienza NTX Electric e beatificato
nel citato sophomore che oggi, su coordinate condivise, è comune a decine di altre band. Poche di loro
riescono a condensare quanto interiorizzato (Ottanta/Duemila) e restituito con fragranza da brani quali
Diamond Things, Never Been Better, Touching The Roof Of The Sun (sorta di All Tomorrows Parties per tastiere
e fantasmi).(7.4/10)
Gaspare Caliri
Dirty Sweet - American Spiritual
(Acetate, Giugno 2010)
G enere : R ock
Il nome bolaniano di questa band di San Diego potrebbe
far pensare al glam, ma non è così: si tratta sì di nostalgici
anni '70, ma di quelli dell'hard rock e dei live incendiari (a
quanto dicono), benché non manchino sporcature della
seconda parte del decennio che li portano su una rotta
Zep/Black Crowes da nostalgici doc, con puntate dalle
parti dei Fuzztones nell'opener Rest Sniper Rest ma anche dei Coral in You've Been Warned.
In realtà il glam in qualche modo torna, ed è un po' il
problema di questo secondo album: il quale conferma sì
grinta, scioltezza e coesione, ma qua e là inclina pericolosamente verso vocalizzi propri del modo degenerato
in cui quel genere è stato inteso nel metal-pop degli anni
'80 (Crimson Cavalry).
La scrittura poi non riscatta particolarmente il deja vu
della formula e il pur innegabile piglio non può farlo più
di tanto: per cui alla fine, a parte qualche eco Alice In
Chains (vedi Kill Or Be Killed), la più interessante è pro48
prio la title track, uno spiritual notturno che riesce ad
essere suggestivo pur sembrando semplicemente un
Bon Jovi in buona forma.
Gli amanti del genere ci troveranno tutto il "rock" che
vogliono.(6.1/10)
Giulio Pasquali
Disappears - Lux (Kranky, Maggio
2010)
G enere : hard - psych
Inspessisce il proprio suono la Kranky, pubblicando
l'esordio dei Disappears. Il combo chicagoano, con
dentro ex membri di Ponys e 90 Day Men, si muove infatti su coordinate piuttosto distanti da quelle care
all'estetica della label della windy town. Il perché di questa insolita scelta è presto detto: Lux era infatti destinato
alla Touch'n'Go, etichetta più incline a strutture sonore
corpose e grasse, ma purtroppo il recente ridimensionamento della storica label noise-rock ha comportato
prima lo stallo dell'album, poi il recupero da parte della
Kranky.
Il suono del quartetto, si sarà capito, è bello possente e
distorto, krauto e cosmico nelle accezioni più rovinose e
generiche dei termini, incline a veleggiare su spazi aperti
tramite ripetizioni strumentali ossessive, ritmiche quadrate e reiterate allo sfinimento, voci catacombali e una
sensibilità oscura che spesso se non sempre ammanta i
brevi pezzi di una coltre dark piuttosto evidente. Sullo
sfondo i Can del primo periodo, ma disidratati; a distanza ma non troppo Spacemen 3 e Loop, tanto per fare
nomi di pietre miliari del genere; in primo piano, tanto
per rimanere alla contemporaneità, Warlocks ridotti
all'osso e Wooden Shjips, in particolare nella versione
ultra-minimal Moon Duo: questi i possibili referenti del
suono Disappears. Ideali per orientare chi legge e per
collocare una proposta che seppur di genere mostra accattivanti soluzioni e un briciolo di originalità che non fa
mai male.(7/10)
Stefano Pifferi
DM Stith - Heavy Ghost Appendices
(Asthmatic Kitty Records, Maggio
2010)
G enere : pop lunare
Heavy Ghost Appendices è un doppio CD retto sul
tentativo evidente di massimizzare il profitto del meritevolissimo Heavy Ghost. DM Stith chiama compagni
a raccolta e si impegna in svariate cover generalmente
piuttosto riuscite, ma la domanda rimane sempre una:
dietro a un tanto massivo dispiego di forze cosa resta?
Rimane senz’altro la firma di David, nonostante meticciamenti (in levare nel caso di Pigs con la Jefferson Street
Band), fino all’osso (di cui ringraziamo) messo in bella
mostra nella versione demo di Thanksgiving Moon per
voce di David, chitarra, piano, statura di cantautore indiscutibile. In Suzanne, poi, cover di Randy Newman,
l’ennesimo riproporre di cori lontani quali ululati poi
messi in loop delicati non va a noia ma anima un’essenzialità personale e convincente. Avanza forse qualcosa,
una volta ascoltato tutto il disco A (presente anche la
demo di BMB, nuovo singolo di DM), quando si snocciolano le tracce del disco B, quasi tutti remix. Rischio
ipertrofia. Peccato perdonabile.(6/10)
Gaspare Caliri
Dr. Dog - Shame, Shame (ANTI-,
Aprile 2010)
G enere : pop rock
Arrivati al sesto album (e qualche EP), i Dr Dog di Phidadelphia hanno un sound codificato e riconoscibile, che
fa del rimescolamento della tradizione americana (e non
solo) il punto di forza.
Riferimenti (The Band, Byrds, Bob Dylan, ma anche
Beatles lato Macca), armonie vocali e melodie restano
anche in quest'ultimo lavoro gli elementi fondandi, questa volta espressi magari con maggiore irruenza e spontaneità ("Volevamo creare un clima prettamente live", hanno
dichiarato), eppure una certa fiacchezza complessiva è
il dato che emerge fin da subito ascoltando Shame Shame. Rispetto al precedente sforzo, è proprio la grana del
suono a mostrare la corda: cose già sentite e cristallizzate, cliché certamente piacevoli ma tutto sommato non
utili, gabbie del mestiere in cui i Dr Dog, come tanti altri,
sono finiti.(5.5/10)
Teresa Greco
Dreadzone - Eye On The Horizon
(Dubwiser, Aprile 2010)
G enere : poprock / reggae
Insalvabile.(3/10)
Gabriele Marino
Drums (The) - The Drums (Island,
Giugno 2010)
G enere : E ighties pop
Con quella formula eighties a base degli intramontabili
da cameretta quali Cure, New Order ma soprattutto
Smiths e i loro adorati The Wake, gli innesti surf (ma
anche girl group) e una gaiezza dichirata senza residui di
antagonismo, i The Drums alle soglie del debutto sono,
non solo l'indie act più chiacchierato dalla blogosfera da
almeno un anno, ma a giudicare dal numero di date sold
out infilate dal quartetto da febbraio a questa parte, i
salvatori del pop britannico tout court.
Chissà che faccia avranno fatto lo stesso Moz, Mike Joyce
e Andy Rourke sentendo il singolo killer Let's Go Surfing
(l'insuperata gemma pop),
o la freschezza imbattibile
di Best Friend (la più smithsiana del lotto) in una
delle tre date londinesi alle
quali hanno assistito. Date
letteralmente sbancate dai
ragazzi americani che si
sono portati a casa uno dei
premi di NME (il Philip Hall Radar Award) impennando
ancor più l'hpye già satollo di aspettative per l'esordio.
Risultato? Alcune tracce edite in The Drums (autoprodotto) e Summertime (secondo eppì uscito per Moshi
Moshi) anticipavano un botto che la manciata d'inediti
veri e propri non innescherà del tutto. Brani come Me
And The Moon (sapori Factory al synth e l'oramai riconoscibile branding surf) e It Will All End In Tears (più accorata
49
e sintetica) funzionano a dovere ma a partire da un'ordinaria Book Of Stories il refrain surf si fa un po' ripetitivo e
i testi non all'altezza degli episodi migliori.
Mancando un equivalente di Marr, quando tutto si basa
sull'hook melodico, scadere nel riempitivo è facilissimo (Skippin' Town e I Need Fun In My Life che finiscono irrimediabilmente per suonare come dei remix delle celebri
Let's Go Surfing e Best Friend) e se la qualità altalenante
potrebbe essere un paragone sensato con gli zii Smiths,
sbagliare un singolo è un errore difficilmente perdonabile. Forever and Ever Amen, il nuovo 45'' del duo/quartetto
infatti, non sembra godere dei numeri degli hit maggiori,
o di alcuni episodi più interessanti del disco che rimangono comunque quelli più pacati.(6.7/10)
Edoardo Bridda
Drunken Butterfly - L'ultima risata
(Irma Group, Aprile 2010)
G enere : post rock
Sarà forse il format che influenza il prodotto finale. Fatto
sta che la tendenza a scrivere colonne sonore per film
muti che sembra aver preso piede ultimamente in certi
ambienti indipendenti, produce risultati a dir poco sorprendenti. Pensiamo al commento de Il Fuoco (1915) di
Giovanni Pastrone ad opera dei Giardini di Miro', alla
sonorizzazione de La caduta della Casa Usher (1928) di
Jean Epstein proposta dal vivo dai Massimo Volume o
a questi Drunken Butterfly, impegnati a musicare L'ultima
risata (1929) di W. F. Murnau. Si tratta di ispirazione, è
evidente. Far collidere immagini e musica in uno specchiarsi reciproco che vive di spazi vuoti e rimandi, in un
percorso radicato nei temi proposti dai fotogrammi ma
al tempo stesso libero di spaziare tra i livelli interpretativi che l'assenza di sonoro originale lascia in sospeso.
Terreno fertile e concreto binario per quel post-rock
immaginifico che ritroviamo nel DNA di tutte e tre le
formazioni citate.
Il gruppo marchigiano se
la cava egregiamente, affidandosi a una girandola di
riferimenti che cita i Sigur Rós (Ritorno a casa),
si adagia su un'elettronica
minimale (Il furto), riprende
certe ruvidezze elettriche
à la Mogwai (La vergogna)
tra pianoforti e chitarre elettriche, laptop e parti vocali
abbozzate. Il tutto in brani da tre minuti e mezzo di durata media che lasciano intendere una volontà comunicativa lontana dalle perifrasi autocelebrative, sostenuta
da arrangiamenti ben calibrati, valorizzata da sprazzi di
50
creatività originali. Come in quella Etere in cui si colgono
rimandi pinkfloydiani confusi tra le spire di un sintetizzatore à la Walter Carlos o in una title track che riprende i Radiohead di Ok Computer parafrasandoli.
Da leggersi in maniera autonoma, questo quarto disco
dei Drunken Butterfly. Parto riuscito di una formazione
che riesce a unire semplicità, intensità e accuratezza in
una sola soluzione evitando di impantanarsi nelle sabbie
mobili della routine.(7.2/10)
Fabrizio Zampighi
Ed Harcourt - Lustre (Piano Wolf,
Giugno 2010)
G enere : P ower F olk
“Lustre from the ruby red blood on my hands when you pull
out all the thorns", oppure “Lustre when the dream is dead”.
Lustre è costellato di sogni che non fanno neanche in
tempo a trasformarsi in incubi, di contrasti. Quello del
testo della title-track e il suo incedere angelico ad esempio, un “gioco” che si ripete un po’ per tutta la scaletta.
Ed fa ormai parte dello squadrone di cantautori/loser
che han indovinato il primo disco e poi, vuoi per carenze
artistiche, vuoi per pura sfiga, non han visto la loro stella
sorgere davvero. Peccato, perché di classe Ed ne aveva e
con Lustre dimostra ancora di averne.
La cifra stilistica ruota ancora attorno ad un cantautorato folk ricolmo di inflessioni soulful e pop sinfonico; al
crocicchio tra Phil Ochs, Rufus Wainwright e Joseph Arthur insomma. Punte di diamante, la demoniaca
(e pare quasi sia di Tom Waits di cui Ed è fan esagitato)
Heart Of A Wolf, il soave dolore al calor bianco di Lachrymosity, il pestare catchy della scoppiettante A Secret Society. E non badate troppo alla copertina, un filo troppo
kitch.(7/10)
Giampaolo Cristofaro
Eri Yamamoto Trio - In Each Day,
Something Good (Aum Fidelity,
Aprile 2010)
G enere : modern jazz
La pianista giapponese - ormai newyorkese d'adozione
- Eri Yamamoto è giustamente famosa e apprezzata, per
le sue collaborazioni (con William Parker ed Hamid
Drake, ad esempio) e per gli album confezionati in una
decade col suo trio. Siamo già al sesto album con questo
In Each Day, Something Good, raccolta di pezzi originali
alcuni dei quali composti per la sonorizazione di un film
del 1932 di Yasujiro Ozu (Io sono nato ma...).
Il tocco di Eri è elegante, indaga con inesorabile intelligenza nell'ordito armonico e ritmico (David Ambrosio al
contrabbasso e Ikuo Takeuchi alla batteria sono più che
semplici comprimari), lasciando intuire arguzie oblique
Monk (l'opening track Attraction Of the Moon, Every Day)
che presto stemperano in un intimismo atmosferico non
privo d'inquietudini E.S.T. (Let's Eat, Then Everything Will
Be Ok) o smanie blues più o meno riconducibili ai guizzi
d'un giovane Keith Jarrett (Sheep Song, A Little Suspicious).
Disco più godibile che coraggioso, attento a definirsi una
contemporaneità compatibile coi dettami della tradizione.(6.8/10)
Stefano Solventi
Ethan Rose/Laura Gibson - Bridge
carols (Baskaru, Aprile 2010)
G enere : B oreal -G litch
Casomai si sentisse bisogno di primavera, Ethan Rose
e Laura Gibson, nel loro strano connubio stagionale,
risponderanno all'appello dell'equinozio con foscotinte
a cavallo di una pioggia infinita e di un montante sole
dell'avvenire.
Alla maniera del puntillismo, dipingono macchie boreali di
post-glitch e colori australi di folk cameristico con la disinvoltura di materiali dal carattere passeggero ma incisivo,
posti tra due bordi liminari e similmente flessi alla ricerca
di una terza via d'incontro. Questa via la si potrebbe identificare in un folk scheletrico dal raro ingegno narrativo, e
da un'elettronica attratta, tanto dal texture-glitch quanto
dall'uso straniante di vecchi mezzi analogici. Lo dice Boris Borealis, reduce delle spiaggie fennesziane
dei granulosi ossimori metafisici, così come il monologo
costante della voce della Gibson, ogni tanto attraversata
da qualche accordo timido come le basi di synth che
attraversano la breve durata di un disco utopico quanto
reale e sincero. Lo dice a più alta voce, la distesa armonia
vocale di Introduction, fatta di angeliche percorrenze e
moduli sonori ambient-paradisiaci. Tuttavia Bridge Carols soffre di un certo ordinariato strutturale: le figure
sonore che si succedono quasi mai convivono di quella
complessità tipica di un disco i cui pattern sono spesso
isolati e parchi, senza sfondare mai il quadro complessivo. Tele pittate appena, la cui semplicità talvolta si nutre
di un minimo segno bozzettistico, che non diventa mai
contorno né calco. A comprometterne la portata una
qualche uniformità d'arrangiamenti.
Buono ma non imprescindibile.(6.8/10)
Salvatore Borrelli
Faithless - The Dance (Nate's Tunes,
Maggio 2010)
G enere : disco UK
Assieme al ritorno in gran spolvero dei Chemical
Brothers, annunciati più tech che mai, riecco un altro
combo che è montato sul cavallone dance UK anni '90
sapendo abilmente miscelare tutti i contorni e dintorni
del caso (trip hop, ragga, soul, funk ecc.).
Maxi Jaxx - MC d’annata - alle vocals , Sister Bliss - DJ e
ritmo - e Rollo - ombra e producer - ancora una volta rivangano le primigenie istanze del club, richiamando,
come da prassi dei grandi
ritorni, una mezza dozzina
di ospiti illustri oltre a amici tra i quali sorella Dido
(di Rollo, sì), Dougy Mandagi dei Temper Trap, Jonny
'Itch' Fox dei King Blues.
La proposta si colloca su un tapis roulant che nelle vene
ha la tamarraggine di Guetta e Tiesto mescolata a un
gusto per il rave da stadio ereditato dai coetanei chimici
Underworld (Sun To Me) e Orbital (pure loro in giro
quest'estate). Il ricordo trippy nella sola voce di Maxi, al
solito memore di Diagable Planets e Massive Attack (Not
Going Home, Scandalous) fa un po' zio; del resto dopo
quindici anni di carriera, i Faithless sono una SPA con
cachet da paura e quello che fanno è capitalizzare un
mondo sonico che già al tempo del loro esordio era
prepotentemente cristallizzato. Di differente, c'è che
quel zompare dentro e fuori dai club si è fatto calcolo,
mentre prima sprigionava libertà d'azione (Reverence
funziona meglio ora che allora).
Not Going Home, singolo già da un paio di mesi in giro
per i piatti d'Inghilterra, riporta i ragazzi di Trainspotting spalla a spalla con i neroni slack. Un ascolto facile
facile come i ricordi bleep di Feel Me o la manciata di
trance (Coming Around) e old skool assortita (Tweak Your
Nipple) a seguire. Meglio sentirli in veste reggae (Crazy
Bal'Heads) o raggamuffin (Fling Hi), ma poi nel circo ti
devi sorbire tutta la new age della seconda parte (Love Is
My Condition e Feeling Good con una pallosa Dido), altri
riempitivi buonisti da quarantenne in remember "pasta"
(North Star con ancora Dido...) e assenzi veramente duri
da ingoiare (Sun To Me).
Misuratevi l'appetito con il menù completo prima d'acquistare, oppure andatevi a sballare ai loro show, senz'altro più meritevoli.(5.5/10)
Marco Braggion, Edoardo Bridda
Films - Messenger (Noble, Maggio
2010)
G enere : ethereal cl as sic
Non è il più semplice dei territori quello che hanno scelto i Films per muovere i loro primi passi. L’enigmatico
51
duo giapponese, dal nome cinematografico e dal piglio
fantasy, è in apparenza, ad un ascolto distratto e frettoloso, l’ennesimo riflusso di certa scuola post-rock mieloso
islandese che ha preso tutto il peggio dai Mùm e dai
Sigur Rós e l’ha riproposto enne volte da un decennio
a questa parte. In realtà i Films, pur muovendo dall’esempio degli illustri predecessori d’Islanda, trovano una propria via personale all’etereo, in un modo che ricorda un
po’ tutti e un po’ nessuno.
C’è sicuramente molto della scuola dream pop anni ’80,
Bel Canto su tutti, così come l’uso contemporaneo di
elettronica minimal glitch e gli inserti neo classici vanno
evidentemente a fare i conti proprio con i Sigur Ros e
con un neppure tanto vago sentore di classica contemporanea. Sono diversi i momenti in cui fanno pensare a
certi passaggi delle colonne sonore di Joe Hisaishi per
esempio. Sono i momenti più classici, dove uniscono al
meglio arrangiamenti ricchi e dettagliati a base di piano, viola, violino e cello. Messenger dovrebbe ruotare
intorno ad una fiaba immaginaria, e altro non è dato sapere, vista la difficoltà di decifrare un canto quanto mai
perso nei riverberi e negli echi de missaggio.
Detto questo, la magia assoluta di momenti semplici eppure emozionanti come le frasi di piano di Water Horse,
la nenia smaccatamente infantile di Liz & Lilly, il cullare
agrodolce di Little Forest o i cori celestiali di I'm Sleeping
Under The Dead Tree (che reggono facilmente il paragone
con quelli del primo disco dei Silver Mt. Zion), riescono a riconciliare con un genere, di questi tempi, afflitto
come non mai, dalla serie B.(7/10)
Antonello Comunale
solidato per proposte del
genere, una nicchia consistente pasturata dai canali
televisivi e radiofonici dedicati proprio all'indie major
(la Brand New di MTV, le
occhiute radio libere britanniche...).
A differenza di quanto accadeva un decennio fa, la ricerca del successo non significa necessariamente prendere
spunto dal rock alternativo per sviluppare un linguaggio mainstream (come fecero, ad esempio, i Muse ed i
Coldplay). Oggi una band arguta e adeguatamente preparata tipo i Friendly Fires o - appunto - i Foals, può
permettersi di fare la propria cosa restando sostanzialmente fedele ai propri riferimenti musicali (e - perché
no? - culturali), perché sa di poter comunque contare su
una fetta della torta.
Il problema è che non sempre questi preziosismi semantici sono l'abito di un quid forte, espressivamente ben
caratterizzato e potentemente contestualizzato. Intendiamoci, i Foals sono abili: pezzi come After Glow, la titile
track, 2 Trees ed il singolo Spanish Sahara sono ambrosia
per i timpani del tipico rockettaro sognatore. Ma non
riescono a coinvolgere fino in fondo, la magia non scatta
e i pur volenterosi marchingegni sonori non riescono a
celare la loro natura di manufatto. Con le potenzialità
emotive di un libretto delle istruzioni per l'assemblaggio.(5.9/10)
Stefano Solventi
Foals - Total Life Forever
(Transgressive, Maggio 2010)
G enere : rock pop wave
Fol Chen - Part II: The New
December (Asthmatic Kitty
Records, Giugno 2010)
G enere : elettropop
I Foals sono un'altra band da Oxford. Esordirono due
anni orsono con Antidote, album che guadagnò loro un
più che discreto hype, in ragione del quale il qui presente
sophomore Total Life Forever acquista i tipici connotati del banco di prova. Che superano in forza di una calligrafia tanto complessa quanto gradevole, all'insegna di
un'enfasi ad ampio spettro ma allo stesso tempo fragrante. Tuttavia, non riescono a convincermi. Ad avvincermi.
Il loro è un iper-pop che impasta benissimo riferimenti e reminiscenze "nobili" - i Talking Heads già etnofunk, olografie Brian Eno e Japan, persino particelle di
traiettorie matematiche June Of '44 - con i tòpoi da
mainstream alternativo definiti negli ultimi anni grazie a
band tipo Manic Street Preachers, Elbow e sia pure
Radiohead. Tutto ciò sembra accadere in forza di una
consapevolezza tenace, che esista cioè un pubblico con-
I Fol Chen operano dentro a un universo abbastanza
limitato, quello dell’elettropop che più occhieggia all’indie e alla vecchia folktronica. È questo il limite e punto di
forza insieme. I losangelini ricercano in quel mondo - e
in maniera ostentata - uno spazio proprio, basato sulla
capacità produttiva di incastri, sullo studio approfondito
di quello che è successo negli ultimi anni, sul versante
pop e anche nell’impero della percussione.
I risultati interessanti ci sono, vedi Men, Beasts Or Houses, sorta di folktronica per Akron/Family agli esordi,
e facendo zoom out il ritmo spezzettato di gran parte
dei brani (C/U), che in qualche modo fanno tesoro di alcune scelte con mirino Ottanta e fucile ’00. Non sempre
l'aritmia percussiva dà giovamento alla band - testimone
Adeline (You Always Look So Bored), con composizione che
rimanda un po’ a Brian Eno ma struttura melodica e
52
armonica che lascia a desiderare, con un refrain che rovina tutto. The New December è una profluvio di steel
per una quasi cover dei Pink Floyd, che richiama anche
Camofleur dei Gastr Del Sol. Anche qui apprezziamo
dei Fol Chen l’inserto certosino di piccole elettroniche
ritmiche, specie nell’atmosfera floydiana della traccia finale, che scorre senza fretta verso il termine.
In effetti i pezzi lenti riescono meglio ai Chen, eppure, se
dovessimo esprimere il sapore che resta in bocca, tutto
torna all’operazione chirurgica: riprendere la folktronica e darle un sapore elettropop, continuando a oscillare
tra queste due mode. Del resto, e tornando all’inizio,
nell’elettropop difficilmente escono dischi memorabili,
che dall’inizio alla fine possono essere considerati dei
capolavori. Ci sono però opere che poi si tende a citare
- come è successo per Blow, che di certo con Paper
Television non avevano licenziato un disco sconvolgente, e ciononostante tutti lo citammo e lo ri-citiamo. Sarà
forse lo stesso per Part II: The New December di Fol
Chen.(6.5/10)
Gaspare Caliri
Food - Quiet Inlet (ECM, Aprile
2010)
G enere : G litch J azz
Il sassofonista inglese Iain Ballamy e il percussionista norvegese Thomas Strønen ripensano il loro gruppo Food
e chiamano (dopo la dipartita del trombettista Arve
Henriksen e del bassista Mats Eilertsen nel 2004) due
nomi culto nei rispettivi ambiti: Nils Petter Molvær
per il tech-disco-jazz e Christian Fennesz per i drone
in distorsione chitarristica.
Dopo aver pubblicato - tra gli altri - due album su Rune
Grammofon, la nuova fatica del combo sale sul podio
della puntigliosa etichetta/culto tedesca, rivelando connessioni con il Miles Davis più elettronico, con la mistica di Jan Garbarek e con le derive ambient di un
certo dubstep contemporaneo di qualità (vedi alla voce
Scuba). Il risultato sovrappone mondi che confluiscono
in una feconda idea di nu-jazz per gli anni zero, con gli
stupendi echi chitarristici in sordina di Fennesz (Tobiko,
Mictyris e Fathom) e con la sempreverde classe trombettistica di Molvær. Un supergruppo da tener d'occhio,
soprattutto per i non addetti ai lavori.(7.1/10)
Marco Braggion
Fuh - Dancing Judas (Escape From
Today, Aprile 2010)
G enere : grunge - noise - rock
Extinct ce li aveva introdotti, Dancing Judas ce li mostra nella prima, piena realizzazione matura. Ennesima
punta di diamante del cuneese rumoroso, esattamente a
metà strada tra Washington e San Diego, i Fuh giungono
all’esordio ufficiale per cui sembrano aver tenuto da parte le frecce migliori del loro arco. Se di base il sostrato
è grunge, vedi l’innata capacità di mischiare melodia e
rumore, i quattro svicolano sinceri e spavaldi tra generi
e sottogeneri, sperimentando nuove vie di fuga tramite
l’innesto dell’eredità più sperimentale dell’indie-rock dei
secondi ’90, di un background fatto di ascolti d’ambito
post-hc e di una certa passione per strutture mobili e
intricate d’ascendenza math-.
I quattro però, tra spigoli, curve a gomito, variazioni di
tempi e luoghi, compongono canzoni. Non necessariamente lineari e legate agli stilemi della forma-canzone,
ma pur sempre canzoni: melodiche, accattivanti, intelligibili nonostante le dinamiche interne non siano mai
scontate e gli sviluppi dei
pezzi possano portare in
direzioni inusitate. Notevole l’estenuante lavorio sul
particolare che rende ogni
pezzo perfettamente equilibrato e affascinante per i
mille rivoli sonici che scaturiscono dal corpo principale. Disco dalle sonorità retrò senza però mai risultare
datato o tanto meno stantio, Dancing Judas è in definitiva un ottimo disco che farà la gioia di chi è cresciuto
nel marasma indie dei nineties. Per chi invece di quei
tempi ha solo una conoscenza indiretta, non c'è miglior
biglietto da visita.(7.1/10)
Stefano Pifferi
General Elektriks - Good City For
Dreamers (Audio Kitchen, Maggio
2010)
G enere : funkpop
Per parlare dei General Elektriks del francese Hervé
Salters è necessario parlare del mondo di appartenenza,
che è il mainstream. Lì sono ambientate le vicende di
Good City For Dreamers, nei luoghi dei vari Cake,
Jamiroquai, e altri personaggi così distanti l’uno dall’altro. Abbiamo scelto questi due nomi perché ai primi si
accostano per fruibilità, al secondo per almeno due motivi: da un lato per un’aura di presunta creatività, dall’altro per riferimenti nella musica funk e in quella nera
sbiancata.
Nelle radio commerciali si parlerebbe (si parlerà?), a
proposito di Salters, di creatività, eccentricità, se non altro per il potenziale di dare un po’ di vitalità a un mondo completamente morto. D’altra parte Good City
fa in
53
highlight
Greie Gut Fraktion - Baustelle
(Monika Enterprise DE, Maggio
2010)
G enere : elettro industrial
James Holden - Dj Kicks (!K7, Giugno 2010)
G enere : kraut , trance
Lo scorso inverno James Holden al Kindergarden di Bologna si è presentato per quel grande DJ e producer che tutti dovrebbero conoscere e andarsi a cercare. Lui è un ragazzo che crede ancora che nei Club
si possa esprimere della creatività e che far girare i dischi non sia solo un sincronizzare BPM. Holden è
inoltre la mente creativa dietro alla svolta dance dell’amico e compagno di set Four Tet, oltre che il boss
di quella Border Community, una piccola label che tre anni fa aveva fatto gridare a un nuovo rinascimento
dance londinese senza più confini tra Londra e Berlino (Apparat, Ellen Allien), il passato e il presente
di un’elettronica onirica da ballare.
Non è un caso se quelli della !K7 l’abbiano voluto nella doppia uscita estiva
della serie assieme ad un altro grande innovatore della scena brit 00 che è
Kode 9 (a fine giugno), altro label manager (per Hyperdub) rispetto al quale
James rappresenta un possibile contraltare bianco e spirituale, specializzato
in crescendo calibrati che guardano al kraut rock e alla trance.
Come una zona di decompressione dopo Club, il Kicks diventa un unico
trip di stranianti groove coltivati con rigore e una conduzione quasi liturgica,
un risultato affascinante soprattutto per questo frangiflutti di suoni arenati
nell'alba dell'after party. Pure quando si tratta di mettere i pezzi di Caribou, Kieran Hebden (con Steve
Reid), Piano Magic e persino Mogwai (in un remix dello stesso James), James fa comunque risaltare la
polpa del soundo, un fiorire di beat che si avvicinano e allontanano trovando il perfetto bliss. L’estasi del
ballo e della mente.(7.2/10)
Edoardo Bridda
modo che l’ascoltatore mantenga una sufficiente attenzione per cogliere la minuzia di particolari, nonché qualche buona idea di arrangiamento.
È pressoché assente l’elemento perturbante, che, lo si
ammetta o meno, ci fa sempre piacere. Ne è immune
Helicopter, l’episodio “rumoroso” dell’album, popolato di
folletti cyborg da film disney - traccia che rappresenta
un po’ lo specchio dei limiti del disco. Più interessante,
piuttosto, lo scazzo mieloso e un po’ melò di Cottons Of
Inertia, che sviluppa sospiri in scale blu con finale di piatti
assordanti a sorpresa. Per il resto, dettagli sciorinati con
gran serenità.(6/10)
Gaspare Caliri
Granturismo - Il tempo di una
danza (Live Global, Marzo 2010)
G enere : funk - beat - pop
Forse così suonerebbero oggi dei Baustelle più solari e
non in fregola spectoriana. Veracemente beat e litoranei.
Funky in cromatismi lucenti e un filino ormonali. Con lo
stesso gusto per le storie d'amore e morte, ma con più
leggerezza e ironia. Questi i Granturismo, alias Claudio
Cavallaro e Vincenzo Vernocchi. Il primo, autore di tutti
i brani eccetto uno, voce calda e adriatica. Il secondo
54
chitarre che scelgono a campione fra quattro decenni di
elettricità da balera, ossia rockabilly, funk, beat, surf. Tutti
mescolati in soluzioni pop spesso manualistiche tuttavia
efficaci.
Gospel in giugno apre su respiri soul non del tutto liberati; Rivedere lei e Addio tristi lunedì raccontano di eros
e thanatos su paradigmi latin-rock che abborderebbero
Tarantino e con le stesse liriche di un Bianconi primo
tipo anche se meno patologico. E poi le loungerie leggere di una ballad soffusa come Prendo fiato, i Carnifull
Trio smaltati della title-track, le giocosità Beatles dei
fiati di La tua casa è dove sei felice e ancora il beat puro e
corposo di E il tempo va.
Ci sanno fare i Granturismo e qualche decennio fa
avrebbero potuto scrivere per gente tipo Celentano o
Johnny Hallyday. Peccato che a lungo andare si abbia
l'impressione che su queste traiettorie ci sia ben poco
da far evolvere. Comunque sia, per chi vuole prepararsi
all'estate, ecco un efficace rimedio ai tormentoni a parte
spegnere la radio e affogarla nel gin tonic.(6.7/10)
Luca Barachetti
Le foto che accompagnano la pubblicazione di questo disco dicono già tutto. Si vedono Antye Greie ovvero AGF
e Gudrun Gut, che indossano entrambe un elmetto da
muratori, in un paesaggio desertico e pietroso. La collaborazione tra le due signore dell’elettronica tedesca nasce sotto il segno della costruzione di nuove prospettive,
ovvero “un posto di progresso,” nella nuova Germania del
compromesso Merkel.
Che i presupposti siano programmatici e per niente lasciati al caso lo indicano tanti elementi. In primis la provenienza delle due:AGF rappresenta la Germania dell’Est,
Gudrun Gut quella dell’ovest; il titolo Baustelle, che sta
per “sito in costruzione” e le due che hanno già portato il
disco dal vivo, con tanto di scenografia corredata di nastri da operai edili. Che il pensiero, partendo da queste
premesse, arrivi subito agli Einsturzende Neubauten,
è quasi ovvio e la presenza di Gudrun Gut non fa che
alimentare la speculazione a riguardo, ma la musica di
Baustelle, pur con tutte le sue evidenti inflessioni industriali, non è direttamente paragonabile a quella della
band di Blixa Bargeld. Di fatto, la somma delle parti è
una sintesi sufficiente per brani così calati in una gradazione dub, da somigliare a tratti molto agli Scorn.
Il resto ce lo mettono i campionamenti di trapani, legni,
seghe, viti e bulloni che sono stati al centro delle registrazioni sul campo (ovvero veri cantieri in costruzione) dove
AGF e Gudrun Gut si sono aggirati per un certo periodo di tempo, nel tentativo di assorbirne l’umore di fondo
(oltre che le fonti sonore). L’iniziale Cutting Trees vale per
tutto il lavoro, nel suo magistrale uso di campionamenti
e voci filtrate, ma il pendolo può facilmente pendere per
una (AGF) o per l’altra (Gudrun Gut), a seconda che si
propenda per frangenti più in odore di minimal techno,
come Wir Bauen Eine Neue Stadt o We Matter, o per le
geometrie più arty e diagonali di sculture sonore dalle
forme inedite come Baustein o China Memories.
Il risultato è seducente e severo al tempo stesso. Le due
dominatrix elettroniche non lesinano nemmeno in fatto
di erotismo (“Un uomo in piena fioritura / le sue gambe
spalancate”). Un disco definibile con una parola sola: tedesco.(7.3/10)
Antonello Comunale
Guido Maria Grillo - Guido Maria
Grillo (AM Productions, Maggio 2010)
G enere : chamber - pop
Per Guido Maria Grillo il rischio principale è quello
di disperdere capacità enormi in una rete di riferimenti
entro i quali è difficile ritagliarsi uno spazio autonomo.
Il chamber-pop asciugato negli arrangiamenti di questo
esordio guarda infatti alla magniloquenza dolorante di
un Rufus Wainwright, dove le lacrime però si trasformano in pulviscoli di luce più che in stinti lustrini. Così
il pianoforte si circonda di reverse mesmerici come dei
Radiohead da camera o di voci sinistre e dalla grana
ectoplasmatica - in pratica uno Scott Walker guardato
a rispettosa distanza. Il resto lo fanno i toni spesso teatralizzati e una voce che in zona Jeff Buckley risulta
potente e impalpabile.
Servirebbe insomma uno scatto di reni, qualche trovata
da cappellaio magico alla Alessandro Grazian, o la forza sublime e onnicomprensiva di un Antony in italiano.
Perché, a parte le evidenti derivazioni, un lavoro cantato, arrangiato e suonato (praticamente in solitario) così
bene non capita di ascoltarlo spesso. Ancor di più se le
canzoni non sono pose di virtuosismo ma concentrati di
vibrazioni che dei nomi sopracitati condividono lo stesso fuoco.(6.5/10)
Luca Barachetti
Hacienda (The) - Big Red &
Barbacoa (Alive Naturalsound
Records, Maggio 2010)
G enere : sixties sound
Piccoli “chicanos” innamorati dei Sessanta crescono.
Avevamo lasciato gli Hacienda a un’esordio esemplare,
nel senso che delle opere prime possedeva la voglia di
dire mentre mostrava il lavoro da fare e sulla scrittura
in primis. Fa dunque piacere ritrovarli un anno e mezzo
dopo maturati nell’approccio e tuttora convinti che non
sia uscito nulla di davvero rilevante dopo il 1966. Piace,
la loro rivisitazione garagista della solarità melodica dei
Beach Boys (Younger Days, Hound Dog), e lo stesso dicasi per i gradevoli quadretti di taglio “roots” e fifties e
gli omaggi plateali al Sir Douglas Quintet.
E’ soprattutto in questi ultimi, e nella produzione studiata al millimetro per proporsi - controsenso oggi forse
inevitabile - ruvida e spontanea, che risalta il ruolo del
Dan Auerbach confermato alla regia. Mossa assennata per una competenza in
materia che è fuori discussione e della sagacia nel pilotare i ragazzi verso il traguardo, per quanto il fiato
corto non sia scomparso
del tutto (ecco un riempitivo strumentale qui e un
brano col pilota automati55
co là, alcune tortuosità compositive e la penna discontinua). Sono nondimeno episodi belli e sinceramente
artigianali come il Phil Spector livido di You’re My Girl,
la giostrina malinconica in abiti da valzer Got To Get Back
Home, una bizzarra ma timida Prisoner a indicare potenzialità di vaglia. Sapranno spiccare il balzo, al prossimo
giro?(6.9/10)
Giancarlo Turra
Half Seas Over - Half Seas Over
(Brownswood, Maggio 2010)
G enere : jazz folk
Non è detto che un'occasione perduta lo sia del tutto.
Prendi questo omonimo esordio degli Half Seas Over:
uno è il cantautore alt-country Adam McBride-Smith, l'altro è Elan Mehler, apprezzato pianista e compositore jazz.
Si sono incontrati in quel di Brooklyn, è scattata l'intesa
e la pazza idea di partorire un combo col chiaro intento
di trovare minimi comun denominatori tra due calligrafie
apparentemente così lontane. Idea stuzzicante.
Il risultato però è un mezzo fallimento, perché il timbro
buonista - come un nipotino di James Taylor - di McBride non sviluppa una vera sinergia con la complessa
eleganza delle trame di Mehler, mentre quando il pianista aggiusta le coordinate
verso la folk ballad finisce
per sembrare una guarnizione di lusso (ai limiti del
pretenzioso) o poco più. I
due insomma si annusano,
si tollerano, si sfiorano senza sviluppare l'empatia necessaria. Però, come dicevamo,
non tutto è da buttare. Anzi.
Se non azzeccano una reale profondità, pezzi come Evensong, The New Breed e Into The Night sviluppano una leggerezza ammaliante, sono veri e propri bassorilievi in bilico
tra swing, blues e folk. Con l'additivo di caligini europee,
umori black e pensoso lirismo modern-jazz, gli Half Seas
Over ipotizzano una formula pop ibrida, instabile ma in
qualche modo armoniosa. Diversamente normale. E sorprendentemente godibile.(6.5/10)
Stefano Solventi
Harlem - Hippies (Matador, Maggio
2010)
G enere : sixties - pop
Il trend del momento è quello del sixties-pop tutto
spensieratezza, coretti accattivanti e zuccherosi, lo-fi
d’obbligo e dimensione gioiosa. Su questo credo non ci
sia più dubbio ormai, e se ce ne fosse ancora qualcuno,
56
gli Harlem, terzetto garage-pop di Austin con la testa
molti km più a Nord (e il cuore altrettanti a Ovest), sono
qui per chiarirlo.
The only band we like is nirvana; the only album we like
is nevermind, the only song we like is smells like teen spirit, dichiarano sul loro myspace e se gli schitarramenti e
l'attitudine sono da grunge-addicted, è la melodia vocale
ad essere al centro di Hippies: clamorosamente appiccicosa, chubby e rassicurante come la quotidianità della
middle-class americana di Happy Days.
Neanche in termini temporali si supera mai quella invisibile linea di demarcazione, anzi se ci si allontana si va
di retromarcia, spingendosi fino alla summer of love e
allo psyh-pop meno lisergico e più canzonettaro dei 60s.
Perfetta musica da festa dall’originalità vicina allo zero
assoluto.(6.4/10)
Stefano Pifferi
Internal Tulips (The) - Mislead Into
a Field by a Deformed Deer (Planet
Mu Records, Aprile 2010)
G enere : I ndie pop
Lungo nella gestazione tanto quanto l’album d’esordio
dei Tape Tum (con il quale condivide alcuni intenti artistici), la prima prova lunga del duo The Internal Tulips,
cerca ancora una volta il sacro graal del pop wilsoninano
dentro e fuori i Beach Boys facendone un case study
per minuterie glitch e sporadici broken beat.
Rispetto ai citati belga, il cui spettro d’azione era ben più
ampio, il debutto di Alex Brandon Graham e Brad Laner si
esprime restringendo il campo a un’elettrocustica indiepop ben nota a casa Morr ma totalmente inedita per Planet
Mu, che pubblica il lavoro unicamente per trascorsi d’amicizia e passate produzioni elettroniche dei due americani
dal cuore inglese. Laner infatti pubblicava come Electric
Company a inizio duemila su Tigerbeat6 ed era considerato parte dell'assalto stellestriesce all'IDM assieme al
più famoso Kid606, mentre Graham aveva effettivamente
pubblicato per l'etichetta di Paradinas sotto il nome di
Lexaunculpt, nel 2003, con l'album The Blurring Of
Trees. Il succo di Mislead Into a Field by a Deformed
Deer riorienta quelle esperienze attorno a una spremitura a caldo di dieci canzoni dei Grandaddy o trenta
dei Grizzly Bear, ovvero gioca sul sublime sublimando
folk e pop, trattandoli cioé come se fossero essenze di un
profumo più che parti di un discorso poetico.
Attentissimo l’intarsio tra suonato in presa diretta (piano, banjo, chitarra, batteria) e sintetico (synth, glitch, effetti) ma inevitabile anche un certa autoreferenzialità.
Tanto perfezionismo si dimentica in fretta.(6/10)
Edoardo Bridda
highlight
Konono N°1 - Assume Crash Position (Crammed Discs, Maggio
2010)
G enere : congotronica
Un fatto tristemente noto che nel terzo mondo abbondino materie prime e
nondimeno scarseggi il minimo per vivere dignitosamente. Ringraziate i colonialisti occidentali - che poi sarebbero i nostri bisnonni - per tutto questo,
e nel frattempo prendente nota di quanto colà si sappia, conseguentemente,
fare di necessità virtù con invidiabile maestria. Lo dimostra il dub e i suoi
rivoluzionari sonori che si avvalevano di una tecnologia oggi risibile ma avevano dalla loro inventiva e sagacia sconosciute.
E una mano non indifferente a rafforzare la suesposta teoria la dà Konono
N° 1, collettivo proveniente dalla Repubblica Democratica del Congo in
circolazione dai primi anni Ottanta, avvezzo ad esibirsi per strada accompagnando balli e canto con un
arsenale di percussioni metalliche e il likembe, strumento locale costruito fissando per un’estremità delle
sottili lamine che, abbassate, producono una tagliente però piacevole vibrazione. Realizzavano a un certo
punto costoro di aver bisogno di un’amplificazione: se la saranno mica comprata, come fa chiunque nel
Nord del mondo? Manco per sogno. La costruivano da soli riciclando materiale dalle discariche e trovatemi voi altri che siano più DIY e “indie” di così. E lo stesso per chi riesca, nello stesso momento, a essere
primordiale e futuribile, ipnotico con sensualità e sperimentale senza intellettualismi.
Assume Crash Position respira di possanza comunicativa che si scioglie nella nostra mente attraverso brani
lunghissimi, maree frenetiche in un perenne gioco di tensione e rilascio. Che avvincono e vanno mandate giù d’un fiato senza soffermarsi sui singoli episodi. Un mantra stordente, una danza contagiosa, una
trance mesmerica di un nulla inferiore alla pietra miliare Congotronics. Necessario, ventiquattro volte al
giorno.(7.7/10)
Giancarlo Turra
Isan - Glow In The Dark Safari Set
(Morr Music, Giugno 2010)
G enere : I ndietronica
Dopo tre lustri passati a sperimentare nuove vie attraverso poemi tonali, ambient e origami sonori, gli ISAN si
sono presi il loro tempo. Senza rivoluzioni li ritroviamo, a
quattro anni dal delizioso Plans Drawn In Pencil, alle
prese con una formula indietronica oramai classica che
vive di piccoli ritocchi e tenta un rinnovamento dall'interno attraverso la cosidetta library music.
Ed è così che il duo inglese più amato dal regista Paolo Sorrentino (tracce di quell’album presenti sia in
Le Conseguenze dell’Amore che ne L’Amico di
Famiglia) ci consegna un altro prezioso album di genere: un crocevia tra note scuole berlinesi (la Morr e la
sua indietronica pienamente assimilata; Tarwater e To
Rococo Rot) e ben incamerati tocchi britannici (la narrativa vintage/spooky di Ghost Box / Focus Group appunto), sempre in dialogo con le tradizioni elettroniche
(Raymond Scott, il BBB Radiophonic Workshop ecc.).
Tra qualche proverbiale momento morto, i due lati del
sogno romantico di un futuro visto con gli occhi preinternet rivivono dignitosamente.(6.8/10)
Edoardo Bridda
Jack Rose/Charles Speer & The
Helix - Ragged and Right (Thrill
Jockey, Luglio 2010)
G enere : C ountry & R agtime
Necrofilia e ripescaggi per quest'eppì dalla brevissima
durata per il defunto Jack Rose accompagnato da D.
Charles Speer & The Helix. Anzi, ad onor del vero,
trattasi più di un disco per voce e chitarra del secondo
(Enos Slaughter, No-Neck Blues Band), diviso tra il
traditional In the pines, ed altri due brani ispirati a Mordecai Jones/Link Wray, di cui solo uno co-firmato da
Rose e Jones.
Brani che risalgono alla primavera di un tour del 2008,
ma che data la loro tradizionalissima affezione al Ragtime
Country potrebbero pure appartenere a decine di anni
prima, com'era attitudine del resto nella musica di Rose
recuperare canzoni e registrarle coi sistemi più sgraziati,
57
highlight
Marco Iacampo - Marco Iacampo (Adesiva discografica, Aprile
2010)
G enere : songwriting
L’ex GoodMorningBoy e Elle Marco Iacampo si è spogliato già da un po’ di nick ingombranti, l’abbiamo infatti trovato l’anno scorso nella compilation Il paese è reale, curata dagli Afterhours, proprio con
un pezzo, Che bella carovana, che apre questo album a suo nome.
Una messa a nudo e un ritorno all’italiano, per una musica d’autore autoctona; sono stati messi da parte i modelli di sempre (Sparklehorse, Eels,
Alex Chilton, Neil Young) per una presa di coscienza autonoma. Ne ha
guadagnato in espressività Iacampo e lo si avverte, in un album molto personale, come ha dichiarato da subito. C’è meno indie e più songwriting, con
la ripresa di una tradizione italiana (lui cita Edoardo Bennato e Paolo
Conte) e l’ispirazione anche dal vecchio amore, il blues.
Intenso e lirico, il disco ha momenti più pop, come il singolo Miracolo eccezionale, e in generale un andamento rilassato e easy, che nasconde una lunga rielaborazione, realizzata con il
produttore artistico Paolo Iafelice (Vinicio Capossela, Fabrizio De Andrè, PFM, Daniele Silvestri)
incontrato dopo il distacco dalla Urtovox nel 2006.
Echi country e reggae, qualche filastrocca, Bob Dylan che torna a riaffiorare qua e là, Lucio Battisti, il
blues e la negritudine (Il mio lavoro con i fiati di Enrico Gabrielli dei Calibro 35), e in generale un mood
malinconico e umorale, che lo ha sempre contraddistinto e che lo segue anche in questo self titled, dove
tutto è calibrato e in sintonia.
Il cantato in italiano lo aiuta parecchio in questa transizione adulta brillantemente superata, ma in fondo
Marco Iacampo non ci sembra avesse niente da dimostrare ancora: l’album è semplicemente un altro
tassello in un percorso di talento.(7.3/10)
Teresa Greco
proprio per eludere il presente dichiarando un amore
infinito per il pre-war blues (come in Dr. Ragtime).
Jack Rose è alla lap-steel elettrica, e la formazione si divide tra basso, batteria, chitarra ed una voce, quella di
Speer che rimanda a quella del Johnny Cash dei primi
quattro o cinque dischi. Una musica tutta roots-oriented,
che non aggiunge molto al discorso di Charles Speer,
così come non sembra vi siano grandi tracce del talento
di Jack Rose, che più che comprimario, o musicista aggiunto, si sente nel disco come un fantasma tirato fuori
da una seduta spiritica a tavolino.
Un disco senza troppa gloria e senza alcuna lode a cui
seguirà Honest Strings: A Tribute To The Life And Work Of
Jack Rose, altra operazione di quelle che faranno Jack
Rose leggenda in questi tempi in cui trovar qualcosa di
leggendario è davvero difficile.(6/10)
Salvatore Borrelli
58
Jackson Browne - Love Is Strange:
En Vivo Con Tino (Inside Records,
Giugno 2010)
G enere : '70 s songwriter
Non è nuovo a celebrazioni, il buon Jackson. In ciò coerente, essendo la dorata California dei 70 dalla quale proviene - alveo nel quale si sono consumati i suoi
giorni migliori - un’epoca/oasi dove lui stesso, gli Eagles,
Warren Zevon e diversi altri si passavano idee e spunti, confrontavano sogni e amarezze. Come se fossero una
famiglia allargata, insomma, secondo l’ultimo lascito del
sogno hippie che ancora oggi inscenano, anche se le cose
sono inevitabilmente cambiate. Lo stesso che respiri
a pieni polmoni in questo corposo doppio dal vivo (di
nuovo: come si usava una volta) cronaca di un felice tour
spagnolo del 2006, tenutosi in chiave acustica avvalendosi dell’apporto di musicisti locali.
Un bel problema, però, parlarne con serenità: male non
puoi dirne, giacché scorre gradevole e limita il reducismo a un tollerabile minimo sindacale; formalmente è
ineccepibile - il sodale di sempre David Lindley alla chitarra è tuttora un asso
- e molte canzoni si confermano
autentici classici, qualcuna magari più datata e altre semplicemente databili. Tuttavia, di dischi pubblicati oggi con
le idee e il portamento di ieri ve ne sono in circolazione
sin troppi, a prescindere da che questo si elevi sopra la
media di parecchi coetanei e colleghi dell’autore. I fan,
comunque, gradiranno.(6.8/10)
Giancarlo Turra
James Yuill - Movement in a Storm
(Moshi Moshi, Giugno 2010)
G enere : I ndie pop
Dopo il debutto del 2008, James Yuill non ha visto l'ora
di pubblicare questo sophomore, scritto e prodotto in
poco tempo e soprattutto fresco di composizione. Turning Down Water For Air era stato pubblicato un
anno dopo la sua stesura mentre il nuovo lavoro, a detta
del suo autore, è uscito con natualezza e velocità proprio durante la fase finale di una lunga tournée durata
ben due anni (e 105 concerti).
Ad ogni modo, di tanta frechezza (e soprattutto rinnovamento) non vi è traccia nelle dieci tracce dell'album.Yuill
non è cambiato per nulla: la base di abusato songwriting
folk-pop agrodolece rimane la radice folktronica di un
aggiornamento che si riassume unicamente nell'acquisizione della cassa in quattro e qualche retaggio indie
dance a contorno. Ancora una volta, come una sorta di
cugino di Album Leaf, il ventottenne prepara le canzoni un po' con il pilota automatico, prima al piano (o alla
chitarra) per riarrangiarle con macchine (synth, drum
machine, glitch) o in un misto di acustico e elettronico.
In pratica, è come rimettere gli Hot Chip dalla discoteca alla cameretta, senza alcuna ironia e disinvoltura, ma
con le solite citazioncine Ottanta (First In Line) e arpeggi
Tunng (Foreign Shore), tanto per gradire e non dar troppo fastidio.
Più che disquisire sul valore della scrittura o soppesarne le canzoni, è l'invecchiamento rapidissimo di questa
modalità del sentire e suonare (Ray Gun), l'aspetto più
dolente del lavoro. Un prodotto figlio del suo tempo andato, come l'adult synth eighties che Yiull continuamente
rimette in pista (Taller Song).(6/10)
Edoardo Bridda
Jana Winderen - Energy Field
(Touch Music UK, Maggio 2010)
G enere : field recordings
Un disco a base di field recordings su Touch. Occorre
andare a prendere quel paio di cuffie molto buone, acquistate solo per poter carpire tutti i dettagli di ascol-
ti così complessi. L’etichetta inglese ritrova la maestra
norvegese, già vista all'opera con il precedente Heated.
Originaria di Oslo, con un curriculum che parla chiaro
e dice di una personalità con specializzazioni in matematica, chimica ed ecologia marina. Energy Field è un
lavoro che si pone nel suo genere con la sapienza e la
maestria che occorrono.
Il disco è composto integralmente ed esclusivamente di
field recordings (quindi niente sovraincisioni digitali successive) presi nella regione del Barents Sea, ovvero la
parte dell’Oceano Artico che si trova nelle regioni intorno a Norvegia, Russia e Groenlandia, dove i suoni sono
stati carpiti con una strumentazione all’avanguardia che
ha visto l’utilizzo di specifici device come quattro “8011
DPA hydrophones, DPA 4060 omni mics, a Telinga parabolic
reflector mic and and a Sound Devices 744T digital hard disk
recorder”. L’intento di Jana era quello di sviscerare il mistero delle profondità marine, restituendone una cartina
sonora, che fosse al tempo stessa fedele e avventurosa,
rispettosa e indagatrice.
Il risultato finale, si articola in tre tracce dense e mesmeriche, che fanno interagire suoni attinti al regno animale
(uccelli, pesci), con quelli presi da regno naturale e minerale (venti, flutti, ghiacciai, gorghi). Il paragone con Chris
Watson viene quasi naturale, ma qui si regge il confronto.
La Winderen tocca punte di assoluta visionarietà quando
riesce a mimare l’immersione negli abissi neri delle profondità. Quella che lei chiama “sensory perception” e che
viene tradotta in un suono ipnotico, magnetico, affascinante, capace di restituire un’idea dei mari del nord, che
appare quanto mai fedele.
Lo statement d’artista del resto parla chiaro. Jana è
un’esploratrice delle regioni più nascoste del suono.
“Nelle profondità degli oceani ci sono paesaggi sonori invisibili ma ascoltabili, a proposito dei quali siamo per la maggior
parte ignoranti, anche se gli oceani coprono il 70% del nostro
pianeta”.(7.2/10)
Antonello Comunale
John Parish - She, A Chinese OST
(Dreamboat, Maggio 2010)
G enere : wave soundtrack
Un tipo versatile, John Parish. Lo sapevamo. Stavolta si cimenta con una soundtrack tutta intera. Compone, suona,
organizza le proprie visioni su quelle di She, a chinese,
film di Xiaolu Guo già premiato ai festival di Amburgo e
di Locarno, nel quale si narra la storia di Li Mei, emigrante cinese in quel di Londra. Le diciotto tracce obbediscono spesso alla tipica fisiologia dei commenti sonori,
presentandosi come schegge e bozzetti strumentali, più
o meno ambientali, nel caso specifico tendenti ad una
59
inquietudine dal taglio ombroso, obliquo e talora aspro,
che ai fans di Parish risulterà abbastanza familiare.
Tra di esse, particolarmente suggestive sono l'astrazione
blues di Unseen/Mr. Hunt, l'insidiosa frenesia di Snake At The
Docks e lo spiegazzato abbandono di November, mentre Li
Mei Makes A Break spennella quiete orientale su frenesia
rock suggerendo stati di dissociazione esistenzial-culturali
che solo la visione della pellicola saprà confermare. Quindi
ci sono le canzoni vere e proprie, per interpretare le quali
Parish si affida a band cinesi come le "riot grrrl" Hang
On The Box (per quel vero e proprio anthem power
pop che è There Is A City), i Muma (per una Fei Fei Run
che impasta Bunnymen e Tears For Fears) e la cantante
Tian Xhen (per l'angelica Wildflowers).
Ultima, nel senso che chiude la scaletta, quella Lonely Lonely per la voce di Feist, tutto un malanimo madreperla,
folk sospeso tra acustica frugale e vaghe nuances electro.
Un lavoro notevole.(7.1/10)
Stefano Solventi
K'naan - Troubadour (Universal,
Aprile 2010)
G enere : pop rap world
Keinan Abdi Warsame, nato a Mogadiscio nel 1978, nonno poeta e zia cantante, è cresciuto nel pieno della famigerata guerra civile: ascoltando i dischi hip hop che gli
mandava il padre dall'America. Scappato a 13 anni con
la madre e i fratelli, si è rifugiato in Canada. Questo è il
suo terzo album (il secondo ad avere una distribuzione
adeguata), dopo il successo di critica e pubblico di The
Dusty Foot Philosopher
(2005).
K'naan alleggerisce il carico (meno folk-world, molto
più pop-rock), si fa tentare
dai featuring prestigiosi (I
Come Prepared, con Damien Marley, niente di eccezionale) e sposa un eclettismo di bocca buona che lo porta a brutture indifendibili
come Bang Bang (siamo a due passi da Ricky Martin, feat
del cantante dei Maroon 5), Does It Really Matter (i peggiori stilemi dell'hip hop costruito con basi elettroniche)
e If Rap Get Jealous (già sul disco precedente, ospite nientemeno che Kirk Hammet dei Metallica).
Si salvano America, con Mos Def e Chali 2na, Fire In
Freetown, leggera leggera ma che funziona, e la Wavin' Flag
scelta da Coca-Cola (...) e Fifa per celebrare l'inizio dei
Mondiali di calcio in Sudafrica, se non altro per l'innegabile appeal corale.(5/10)
Gabriele Marino
60
k-os - Yes! (Universal, Maggio
2010)
G enere : C ros sover hip hop
Kevin Brereton aka k-os (leggi chaos) è un rapper e produttore canadese di colore. Yes! è il suo quarto album,
in giro come promo da fine 2009, pubblicato ufficialmente lo scorso febbraio negli USA, arrivato adesso dalle nostre parti. Il suo ci sembra l'ennesimo lavoro che cavalca
- male - il vento crossover hip hop.
Ne ritroviamo tutti gli stilemi, con l'effetto finale della
marmellata furba, non priva di un certo appeal e di un
certo impatto, ma sostanzialmente senza sapore. Campioni di brani celebri, nella tradizione di Puff Daddy e
come fanno adesso i Black Eyed Peas (il riff di Love
Buzz dei Nirvana; una I Wish I Knew Natalie Portman, ospite nientemeno che Nelly Furtado, che in pratica è una
cover di California dei Phantom Planet, l'ossessionante
sigla del serial OC); cantati impiastricciati dall'autotune;
flirt col reggae; cattivi modelli di rapping come Lil Wayne (Mr.Telephone Man).
Alcuni pezzi non sono malaccio, soprattutto a livello di
mixage tra suonato e campionato, ma sono troppo pochi - e sono troppo poco - per far passare in cavalleria le
tamarrate e le brutture.(5/10)
Gabriele Marino
Keane - Night Train (Interscope
Records, Maggio 2010)
G enere : P op
La notizia è che il 16 maggio, esattamente sei giorni dopo
l'uscita ufficiale, il nuovo lavoro dei Keane ha raggiunto
il numero uno della classifica degli album in UK. Considerando che i brani migliori dell'EP (dura considerarlo
un vero e proprio album: 8 soli brani, tra cui uno strumentale di meno di un minuto e mezzo) sono un pezzo
basato sul campionamento dello score del film Rocky su
cui si adagia il rapping del canadese K'Naan (Looking
Back) e una cover di un brano del 1983 dei giapponesi
Yellow Magic Orchestra (Ishin Denshin, con ospite la
cantante funk MC Tigarah), la notizia non è di quelle
positive.
Dopo un parziale tentativo di virare verso il synth-pop
con il precedente Perfect Symmetry (2008), che nonostante il primo posto nella classifica inglese e il settimo in quella americana, aveva un po' spiazzato i fan, i Keane ritornano ad atmosfere più propriamente brit-pop,
più congeniali alla voce delicata del cantante e allo stile
pianistico di Tim Rice-Oxley, con la consueta assenza di
chitarre di Hopes And Fears (nove volte disco di platino)
e l'appena più movimentato Under The Iron Sea (2006).
La ruffianeria è quella che nel 2004 aveva mandato in
orbita l'esordio, con cori stucchevoli al limite dell'imbarazzo (Stop For A Minute, dove ritorna K'Naan), ballad
plasticose buone per il suicidio di qualche teenager (Your
Love) e il campionamento del rumore del modem che si
connette in Ishin Denshin che sembra un gomitino messo
lì per i meno ragazzi, del tipo:“Ehi, noi eravamo qui prima
di questa era digitale. Tu dov'eri? Non siamo forse noi la
tua colonna sonora di questo new millennium?”
Nel 2004 i Keane cantavano praticamente ovunque “Everybody's changing and I don't feel the same”: ecco da allora
hanno cercato di cambiarsi d'abito un paio di volte, ma
sotto la giacchetta scura e il calzino rosso non è successo niente. Venderanno ancora una volta milioni di copie,
dopo aver strizzato l'occhiolino al mercato giapponese e
al mondo delle collaborazioni tra rap e pop (Alicia, dove
sei?), i tre dell'East Sussex sono rimasti ragazzi e dopo
quattro dischi è lecito pensare che le promesse non verranno mantenute nemmeno in futuro.(4.9/10)
Marco Boscolo
Kele Okereke - The Boxer (Polydor,
Giugno 2010)
G enere : T ech - pop
Prima il call and response da jogging militaresco a ritmo di flamenco, poi le celeberrime colate laviche al sintetizzatore, infine qualche brandello di strofa del Kele
che conosciamo. Si apre così l’album solista della voce
dei Bloc Party, membro di una band che non ha mai
negato la passione per la dance UK e qui in un personale approfondimento sintetico tra IDM e spezie dance.
Ingredienti curiosamente e intelligentemente suggeriti
dall’astro nascente dell’elettronica now on di casa Warp,
quell'Hudson Mohawke che in una traccia come On
The Lam svolta una classica house track britannica in un
calibrato gioco di sponda
drum’n’bass, basso spugnoso Mr. Oizo e citazionismo
’ardkore (c'è anche il sample di James Brown).
Dunque nessuna angolarità
fender per il Kele solista indaffarato al desk anche con
un altro producer, XXXChange degli Spank Rock - combo hip hop americano
con voglie raw electro e simpatie britanniche (remix per
Santogold, Lady Sovreign) - che di riffa o di raffa avrà
contribuito con i sintetismi più crudi, compresi quelli
sotto ai cori Nine Inch Nails del singolo Tenderoni, un
brano coca cola che è anche un po' il simbolo della rapida ossidazione di molte tracce dell'album.
Nel full lenght però c’è dell'altro. La parte più profonda e
amata di Kele viene fuori in Everything You Wanted: melodia in un misto di fervore (viene da famiglia e studi cattolici) e sessualità (recentemente si è dichiarato bisessuale
sulle pagine di Butt magazine), mentre New Rules è un
bel duetto lui/lei che mescola il formato confidenziale e
una composizione per balletto (à la Laurie Anderson per
intenderci).
Niente che possa scomodare i numeri più incisivi della
band, piuttosto è un cuore synth pop in combutta soul/
gospel - tratto maestro del nigeriano - lo scarto decisivo.
Sulla scorta dei riferimenti cardine di sempre (i Depeche Mode), i picchi Rise e All The Things I Could Ever Say
sono preghiere di ritmo e effetti sintetici che ricollocano
il progetto nella veste migliore: un side project elettro
(sulla falsa riga di quello di Thom Yorke) per indagarsi
l'anima. Ed è un'anima pronta per le grandi masse quella
di Kele. Che sia il nuovo Bono?(6.5/10)
Edoardo Bridda
Kelis - Flesh Tone (Interscope
Records, Maggio 2010)
G enere : disco pop
Meno soul e più dancefloor: questa la nuova via di Kelis.
Una vaga somiglianza con Donna Summer, il fidget ereditato dai Crookers (22nd Century) e l’attacco a Lady
Gaga con le bombe pop. Nove pezzi che bruciano velocemente il sogno disco della prossima estate oscurando
la spocchia dei Goldfrapp (4th of July).
Kelis è l’essenza dancefloor ubercommerciale di un postsoul firmato major in combutta con zarri del calibro di
Benny Benassi, Boys Noize e Diplo; blackness sciccosa
per teen innamorate e col sudore del baraccone tamarro, i catenoni e le canottiere.
Mossa Ottanta d'obbligo, cassa dritta e distorsioni analogiche oramai pienamente sdoganate per un paio di bombe da classifica (Home e Acapella prodotta con David
Guetta stanno da tempo girando per le radio di mezzo
mondo) e qualche intervallo interlocutorio.
Non ancora la Madonna nera della disco, Kelis è sul crinale discendente della Ciccone di Hard Candy.(6.5/10)
Marco Braggion
King Bleso - King Bleso and the
Voodoo Soul Unlimited - Oku (La
Sapore prod., Giugno 2010)
G enere : F unk
Dario Troso aka Gopher, salentino classe '71, è uno
che ha vissuto in prima linea gli anni pionieristici dell'hip
hop italiano: membro dell'Isola Posse All Stars, featurer
dei mitologici Sangue Misto di Neffa, Deda e Gruff,
batterista nei Sud Sound System. Il meticciato come
61
orizzonte di vita. In questo secondo disco a nome King
Bleso, dopo il dub, va a riscoprire le proprie radici funk,
aiutato - tra gli altri - da Luca Tarantino aka Sotu Tetsune
e dai due electro-rapper Smania Uagliuns. L'assemblaggio ha un sapore artigianale (alcuni cantati risultano
particoloramente ruvidi), ma la miscela, tra funk bello
grasso, latin funk (Mokele-Mbembe), hip hop jazzy Novanta (Testifyin'), soul (Damn, I'm So Sure) e richiami rock
(Sittin' On My Sofa dei Kinks) e blues (Four O'Clock di Skip
James), funziona.(6.4/10)
Gabriele Marino
King Britt - The Intricate Beauty
(Nervous, Aprile 2010)
G enere : H ouse
King James Britt è il produttore degli storici Digable
Planets, band che negli anni Novanta ha fissato uno standard hip hop fusion importante, che ancora oggi fa scuola.
Una discografia frastagliata la sua, tra collaborazioni, remix per nomi prestigiosi, musica per il grande e piccolo
schermo (per ultimo, il serial True Blood) e una manciata
di album solisti. Nel 2009 una sola compilation mixata
e adesso questo The Intricate Beauty, disco con cui
intende salutare per sempre - così pare - il mondo dei
ritmi e della dance, disco che pure è la sua prima prova
esplicitamente house. Complici una svolta spirituale e
l'avvio del progetto mixed
media Saturn Never Sleeps (nato come omaggio
a Sun Ra), che gli hanno
aperto nuovi orizzonti, il
nostro intende adesso dedicarsi alla sperimentazione e all'improvvisazione.
Il nuovo modus, in realtà,
pare avere preso avvio già con questo lavoro: Britt ha
registrato e campionato centinaia di microsounds - niente
loop - e li ha poi "mantecati" via Ableton Live (NB: la
library da cui è partito verrà effettivamente pubblicata
come tool per il celebre programma; operazione analoga
a quella Dilla/Serato). Di questo lavorìo a livello micro
(l'intricata bellezza del titolo?), l'orecchio dell'ascoltatore
può beneficiare sotto forma di suoni morbidi e avvolgenti, come lievitati, una house classicissima e altrettanto
fresca, magicamente congelata ai primi anni Novanta, con
voci cariche di soul (Nightlife, Get Up), picchi minimal/
tribal (Keep It Movin', Los) e ricordi come di certo Jarre
trancey (Inner Life). Ottimo.(7.1/10)
Gabriele Marino
62
Laurent Robin And The Sky Riders
Project - Ode To The Doodooda
(Laborie, Maggio 2010)
G enere : jazz electro
Batterista francese piuttosto apprezzato sia in ambiti jazz che pop-rock, Laurent Robin mette assieme la
squadriglia Sky Riders Project, ovvero i tastieristi Benjamin Moussay e Vincent Laffont, per solcare la nostalgia
electro soul interstellare di Ode To The Doodooda.
La rotta è di quelle piuttosto battute, ci senti le argute
nostalgie e - ovviamente - i languori french degli Air (un
vero festival di Hammond, clavier e Fender Rhodes), le
calligrafie suadenti à la Zero 7 (in coincidenza dei setosi
interventi vocali di Xiao Li), più un'estro post-fusion che
chiama in causa l'Herbie Hancock dei settanta quando
non certe inquietudini contemporaneee EST (Monica in
London).
C'è anche spazio per bambage melodiche jazzy dalle
parti del Bacharach più soffice (The Sweetest Smile) e
per una solenne "cover" di God Save The Queen (l'inno
nazionale inglese, non lo sfregio formidabile che ne fecero i Pistols). Un disco suonato con molta competenza,
intrigante ma senza intuizioni rivoluzionarie, melodicamente più azzimato che ispirato, in definitiva gradevole.(6.4/10)
Stefano Solventi
Little Annie/Paul Wallfisch Genderful (Southern Records,
Maggio 2010)
G enere : chansonnier pop
Le basi su cui si fonda il sodalizio tra la regina dell’underground musicale newyorkese Annie Bandex e l’ex tastierista di Firewater e Botanica, Paul Wallfisch, sono
più solide di quanto si sarebbe pensato inizialmente. Veterani di lungo corso, la sanno fin troppo lunga, consapevoli che dopo il precedente When Good Things
Happen To Bad Pianos, il rischio maggiore era quello
dell’archiviazione automatica al genere di riferimento: la
ballad jazzata da chansonier francese, tra Jacques Brel
e Serge Gainsbourg, e con più di qualche strizzata in
direzione Antony.
Eppure il nuovo Genderful, smuove sufficientemente la
scaletta per poter dire che non si sono ripetuti. L’apertura sofisticata di Tomorrow Will Be dice già che l’uso dello
studio è stato meticoloso: base elettronica, florilegio di
frasi di tastiera, sussurato sexy. C’è persino una puntura
di blues da cocktail nelle vellutate volute di Suitcase Full
Of Secrets che odorano deliziosamente di Tindersticks,
e fa ancora meglio, la malizia acustica di Billy Martin Requiem, che davvero cambia le carte in tavola. Poi, ovvia-
highlight
Michael Leonhart & The Avramina 7 - Seahorse And The
Storyteller (Truth & Soul, Aprile 2010)
G enere : psych - soul
Sulle prime non ti capaciti proprio. Nel senso che fatichi a capire come Michael Leonhart sia arrivato
solo adesso a fare un disco simile. Hai voglia pensare alla gavetta da trombettista, arrangiatore, produttore
e via dicendo, al Grammy intascato da adolescente e la presenza alla corte
dei redivivi Steely Dan. Puoi fare tutte le valutazioni che ti pare, fatto è che
a una cosa del genere non eravamo preparati anche sapendo delle collaborazioni con - tanto per fare qualche nome - Yoko Ono e Arto Lindsay,
Brian Eno e David Byrne.
E questo non perché Seahorse And The Storyteller tiri fuori dall’armadio il temuto spettro del "concept” muovendosi in ambito black. Già lo
hanno fatto e prima di lui dei tizi di nome George Clinton e Sly Stone.
Che sono, guarda caso, due paletti da piantare saldamente nel terreno per
delimitare le fughe per la tangente del nostro ragazzo, essendo un altro paio
la psichedelia morbida venata di pop e oriente di fine ’60 e certe squadrature kraute che non sai bene
come siano capitate lì. Musica di fusione, insomma, che puoi giustificare solo con lo sguardo attento di
chi conosce e maneggia l’argomento sin da piccolo ed è così che sono andate le cose: solo che senza la
visione resti un tecnico come tanti, non spicchi il volo. Serve prendere tempo e maturare, ed ecco un’altra
possibile spiegazione.
Progetto peraltro ambizioso, questo disco, allestito con un parterre prestigioso ma discreto (membri
sparsi di TV On The Radio, Dap-Kings, Antibalas; svariati “cervelli” della New York intellettualmente
deviata) che dell’eterogeneità e del multiculturalismo fa bandiera. Che oltrepassa le restrizioni di genere
come, a ben pensarci, tutti gli artisti sin qui tirati in ballo: perché se The Story Of Echo Lake è pop chitarristico di tesa melanconia attraversato dal sax, Jaipur e Madhouse Mumbai mescolano Alice Coltrane e
Bollywood come a Gonjasufi non riuscirà mai; se Dreams Of An Aquarian è Sly & Famiglia persi nei solchi
di Tago Mago, Have You Met Martina? si porge da scioglilingua in apnea di somma orecchiabilità.
Persino i due brevi strumentali che precedono la conclusiva Here Comes The Dragonfish possiedono vivace
senso narrativo e preparano a un capolavoro dove Prince si inoltra nella giungla a cercare proprio Eno &
Byrne. Ecco: ci piacerebbe affermare di aver trovato un plausibile erede “spirituale” di Roger Nelson, ma
vorremmo aspettare la fine dell’anno. Scaramanzia pura e semplice, sappiatelo.(7.8/10)
Giancarlo Turra
mente, il resto dello spettacolo è sempre più o meno
lo stesso: Annie ancheggia e sussurra per un pubblico di
astanti dal vezzo intelletual chic e la mazzetta di banconote fermate con la pinzetta d’oro. E’ pur sempre tutta
una messa in scena e il copione va rispettato.(6.5/10)
Antonello Comunale
Lombroso - Una vita non mi basta
(Niegazowana, Aprile 2010)
G enere : rock
Per i Lombroso il citazionismo è il carburante di una
macchina che soprattutto dal vivo riesce a dimostrare
tutto il proprio vigore. Il beat nostrano e Lucio Battisti - e i suoi rapporti con Otis Redding - nei primi
due dischi, la Motown rivisitata con indole mescolatoria
(funk, new wave, pop nobilitato) in questo terzo lavoro
che fin dal titolo denuncia un'urgenza canonicamente
rock'n'roll, senza però dimenticare un'italianità che nella scrittura, rotonda ma mai troppo, sottolinea l'origine
novantiana di uno dei due componenti del gruppo (l'ex
Afterhours Dario Ciffo).
E se già il precedente Credi di conoscermi allargava
con convinzione lo spettro strumentale oltre la diade
batteria-chitarra, è con Una vita non mi basta che i
due milanesi rivestono i brani di fiati (Enrico Gabrielli), percussioni e basso ormai onnipresente (talvolta imbracciato da Enrico Molteni dei Tre Allegri Ragazzi
Morti). A giovarne è la prestanza delle singole tracce in
63
particolare quando gli ascolti si ripetono, a fronte di liriche sempre in equilibrio sul filo sottile che separa chiarezza e banalità. Poi, in chiusura, il bozzetto beatlesiano
di Immenso e fragile lascia spontanea una domanda: e se si
cimentassero un po' più spesso con le ballate?(6.5/10)
Luca Barachetti
Luca Faggella - Ghisola
(Goodfellas, Maggio 2010)
G enere : canzone d ' autore
Il riferimento a Ghisola, personaggio femminile di “Con
gli occhi chiusi” di Federigo Tozzi, è solo uno dei tanti
segnali dell'inquietudine intellettuale di Luca Faggella. Attore di teatro (ha recitato Beckett, Jarry, Borges),
interprete fra i migliori di Piero Ciampi e ciampiano
nell'animo, ma anche vincitore nel 2002 di una Targa Tenco come miglior esordio con il klezmer di Tredici canti
- cui fece seguito il rock scuro e sessuale di Fetish - il
livornese pare muoversi fra vite solo apparentemente
parallele fra loro, in vero brucianti della stessa fiamma
che non lascia scampo a concessioni di sorta e neppure,
almeno fino ad oggi, ad un'identità precisa.
Questo disco, prodotto da Giorgio Baldi (già all'opera
coi dischi meglio riusciti di Max Gazzé), lo vede confrontarsi con certa new wave livida alla Diaframma
(Come), comunque virata
in senso cantautorale dalle
parti di Faust'O (La prova)
e con qualche interessante
deviazione su architetture
maestose di synth, chitarre
in rifrazione e voce luciferina alla Scott Walker
(Maremma sangue). Nomi
importanti e di culto insomma, il cui spettro attraversa canzoni che non disdegnano nemmeno semplicità poppeggianti (la title-track),
improvvisi trip-hop (una Ti bacio e torno volutamente
antiquata nei suoni) e cover raffinate condotte in porto
con maestria (St. Elmo's Fire di Brian Eno). Tuttavia a
Faggella mancano ancora quegli spunti personali che lo
rendano non tanto un emulo - non è questo il caso - ma
certamente qualcosa di più che un (buon) proseguitore.(6.3/10)
Luca Barachetti
Magic Lantern - Platoon (Not Not
Fun, Maggio 2010)
G enere : heavy - psych
Disco di snodo (e di fine corsa, a quanto pare) per i Magic Lantern dopo un silenzio biennale che di questi tempi
64
assume i contorni dell’era geologica.
Chi segue le evoluzioni più nascoste dell’underground
psichedelico americano avrà notato la bizzarria che accompagna la sigla: essere, cioè, un supergruppo a priori.
Nel senso che, visti le sviluppi degli ultimi due anni - i
Sun Araw di Cameron Stallones, i Super Minerals di
William Giacchi e Phil French, la Stunned Records gestita da quest’ultimo - fa strano che l’allstar game sia stato
giocato prima della regular season. E così Platoon sembra quasi un ritorno al futuro, una porta spazio-temporale che permette di sbirciare cosa e come si procedeva
prima del big bang.
Nessuna novità all’orizzonte, sia chiaro: si va come al solito di jam visionaria e reiterata, deformata in deliqui psichedelici, ma a differenza dei precedenti lavori si spinge
molto sull’acceleratore funk e acid-rock. La componente
più evidentemente psych - dilatata, rallentata e liquida - è
evidente nel corpo centrale dell’album (Moon Lagoon Platoon, su tutte), ma per forza di cose sono i monoliti posti
in principio (Dark Cicadas, 8 minuti di acid-rock dei 70s
e groove alla Grand Funk Railroad) e coda (Friendship,
melma desertica al servizio di una jam fuori dal tempo) a
segnare la cifra dell’album. I due “classici” delle esibizioni
live di Magic Lantern spostano la psichedelia “fattona”
del quintetto verso lande funkadeliche, con continui solo
di chitarre, echi di wah-wah, svisate d’organo e tromba
che sfuggono ovunque, in ogni luogo e ogni tempo.
La versione in cd, sempre targata NNF, aggiunge in coda
anche le due tracce del 7” Showshopper (funkissima cover di Iron Knowledge a segnare ancor di più le posizioni
del disco, più l’originale Cypress) in uscita ora sempre
per la label di Brit, perciò se gradite un personal blend of
psych-rock, sapete a chi rivolgervi.(7.2/10)
Stefano Pifferi
Mar delle blatte - Aspide
(Avanthopperz, Gennaio 2010)
G enere : D ark ambient
Nel mare di produzioni underground italiane a circolazione esclusivamente digitale, peschiamo l'esordio del
palermitano Mar delle blatte, del giro Avanthopperz.
Lui dice di fare dark ambient e, in effetti, il ritratto che
ne viene fuori è quello di una Palermo post-atomica, al
contatore Geiger. Il disco, sette pezzi e venti minuti circa,
ha un suo strano fascino, nonostante e forse proprio
perché fatto di nulla, con pochi elementi musicali che si
impongono all'ascolto come cattedrali nel deserto.
Spazzole tribal-jazzy (IX), quattro note di contrabbasso
(Heron #1), un arpeggio sinistro di chitarra (You'll Be Seing
Red), una batteria caracollante fatta di lamiere ((Poison
From) Standing Waters), un arpeggio di basso (This Is Not
An Exit) emergono da un pulviscolo di rumori di fondo,
di voci e di disturbi che filtrano come da un walkie-talkie.
Nel pezzo finale, coerentemente con la citazione landolfiana, in una schiuma di droni di chitarra elettrica, si apre
(forse) uno spiraglio di luce.(7/10)
Gabriele Marino
Martha Tilston - Lucy & The Wolves
(Squiggly, Giugno 2010)
G enere : F olk
Non è artista di primo pelo Martha Tilston. Ha aperto
concerti per Damien Rice, ha la sua etichetta personale (e di questi tempi è quasi qualcosa “di serie”) ed è
stata nominata come best new act dei BBC Folk Awards
per Of Milkmaids And Architects del 2007.
Guardacaso folk è la parola chiave, ché di canzoni di folk
pastorale è costituito anche Lucy & The Wolves. Pianoforte, chitarre acustiche e la voce di Martha sono i
protagonisti di affreschi di intimità sonora, luminosa anche quando si fa crepuscolare, giusto mix di delicatezza
e leggiadria, intessute in arazzi che rimandano a certo
Bert Jansch senza Pentangle, a un Van Morrison
in versione light e ad una Polly Paulusma di qualità. Al
basso Jon Thorne dei Lamb, membri dei Woods ospiti
qui e là, ma tra lupi, foreste e ruscelli emerge chiara l’ispirazione della Tilston. Riuscito.(7/10)
Giampaolo Cristofaro
Max Gazzé - Quindi? (Universal,
Maggio 2010)
G enere : canzone d ' autore
In calo almeno dal precedente Tra l’aratro e la radio,
il percorso di Max Gazzé non sembra riprendersi nemmeno con Quindi?, settimo lavoro in studio con appendice cinematografica al seguito. Il primo singolo Mentre
dormi fa parte della colonna sonora del film di Rocco
Papaleo “Basilicata Coast To Coast” (che vede lo stesso
cantautore romano nei panni di un contrabbassista muto
dopo una delusione d’amore) ed è anche la traccia più
convincente di tutto il lavoro - tipica ballad d’amore alla
Gazzé dove dolcezza e atmosfera onirica si mescolano
sul volteggiare di un ritornello compiacente ma senza
ruffianerie.
Il resto presenta le solite raffinatezze del nostro, fra
electro-pop in area Battiato (Storie crudeli), accelerazioni funky come dei Police in combutta coi Jamiroquai (Nuovi allineamenti di Stonehenge) e liquefazioni
pinkfloydiane di synth (Io dov'ero) e chitarre. Una certa
verbosità delle liriche e la mancanza quasi totale di brani
incisivi lasciano però affiorare larghi momenti di noia.
In altre parole: Gazzé è ancora quello de La favola di
Adamo ed Eva - anche se in questo caso è Contro
un’onda del mare il riferimento più preciso - ma senza
la forza di quelle canzoni. E un singolo davvero buono
- come lo fu Il solito sesso per Tra l’aratro e la radio insieme a pochi altri palpiti (La cosa più importante) non
bastano.
Così il titolo, sintesi dell’atmosfera di sospensione e
dubbio che attraversa l’intera track-list, diventa un interrogativo altrettanto incerto sul futuro, a fronte di un
presente piuttosto ristagnato.(5.8/10)
Luca Barachetti
Melvins - The Bride Screamed
Murder (Ipecac Recordings,
Maggio 2010)
G enere : hard - rock
Parte benissimo, l’ennesimo comeback dei Melvins.
L’attacco di pura psicopatia rock dell’iniziale The Water
Glass, schitarrate heavy che si aprono in un sing-a-long
free-form fatto di urla nonsense, ne mostra il lato deforme e schizzato. A ruota segue Evil New War God e scatta
l’evergreen melvinsiano: un
carrarmato hard-rock cafone che si nutre di quel suono pachidermico, grasso e
distorto che rimanda alle
pesantezze di Stoner Witch
e che è marchio di fabbrica
di King Buzzo & friends da
un quarto di secolo buono.
Se Chicken Switch giocava sul versante più sperimentale e strambo al quale i nostri ci hanno abituato sin
dai tempi della trilogia-omaggio (sberleffo?) ai Kiss, The
Bride Screamed Murder è il classico album di studio
dell’ormai consolidato quartetto (i due Big Business
Coady Willis e Jared Warren sono ancora della partita).
Un pizzico di slancio epico-coatto in più in alcuni passaggi chitarristici o in alcune vocals (Pig House), qualche
ambientazione dark-funerea (I’ll Finish You Off), abbozzi di
rumorismo doom semi-concreto che si fa totale follia (PG
x 3). Per il resto si va sul sicuro con un mix di doom, hardrock, post-grunge, hc sperimentale alla NoMeansNo, su
cui aleggia grigiore post-apocalittico e paranoia suburbana. I soliti vecchi Melvins, con soddisfazione.(6.9/10)
Stefano Pifferi
Mick Barr/Nondor Nevai Labyrintha (ugExplode, Marzo
2010)
G enere : C haos -R ock
Dopo una pubblicazione in MP3 su Brutal-Prog e un
65
highlight
Natalie Merchant - Leave Your Sleep (Nonesuch, Aprile 2010)
G enere : alt - rock
Ventotto anni di carriera per l’ex cantante dei 10,000 Maniacs e non sentirli. Il cambio di etichetta (da
Elektra a Nonesuch), l'accolita di mostri del calibro di Wynton Marsalis, Medeski Martin & Wood,
i solisti della New York Philharmonic, i Klezmatics, i Memphis Boys e altri (superando il ragguardevole
numero di 100 musicisti e collaboratori sonici, tra cui anche il produttore
di David Byrne), più di un anno di lavoro e un cervello che non si ferma
sono gli ingredienti per una nuova primavera compositiva ricca di gemme in
fiore.
Natalie è assente dal mercato dal 2003: l’anno in cui ha dedicato il buon
Motherland alla neonata figlia Lúcia. Da quei giorni non ha smesso di leggere
poesie e per far addormentare la baby era inevitabile cantargliele a mò di
ninna nanna. Anche se il titolo potrebbe richiamare ad atmosfere in slowmotion, le 26 tracce non mancano di varietà e moto. La linea narrativa della
cantante nordamericana si esplica in un progetto monstre’, lungo, pieno di citazioni: dal cajun (Adventures
Of Isabel) al jazz, dallo swing (The Janitor’s Boy) ai tradizionali irlandesi (The Walloping Window Blind) e cinesi
(The King Of China’s Daughter), dal blues al reggae (stupenda Topsyturvey-World), dal country (Calico Pie) alla
balcanica.
La giustapposizione di generi è coesa grazie alle citazioni da classici della letteratura inglese e americana: e
e cummings, Mamma Oca (!), qualche poeta vittoriano e altre sorprese. In più è proprio la stessa voce della Merchant che tesse una trama solida e senza sbavature, confermandosi come una delle più convincenti
chanteuses d’oltreoceano, capace di farci rabbrividire (ascoltate ad esempio il blues Griselda o la ballad
Vain And Careless) con una naturalezza e una classe d’altri tempi.
Per chi cerca un’alternativa alla presunta classe di Johanna Newsom e altre poshy amichette finto intellettualoidi, vale la pena di ritornare alla tradizione tout court con questo piccolo grande classico. Uno
dei migliori dischi del 2010.(7.8/10)
Marco Braggion
Cd-R in tiratura irrisoria, la UgExplode di Weasel Walter stampa il primo vero album a nome Barr-Nevai.
Verrebbe da chiedersi perché aspettare tanto, visto che
le potenzialità del duo chitarra-batteria non hanno nulla
da invidiare ai simili act ultracelebrati di Lightning Bolt
o Hella. Potenti quanto i primi ma senza riffoni tamarri,
caotici quanto i secondi eppure senza il piglio arty, sotto
alcuni aspetti funzionano ancora meglio. Un free noise da
urlo, sguaiato e vicino all'isteria. Assolutamente distanti
poi, dalla fastidiosa mancanza di pathos che si criticava in
occasione di Shred Earthship, colosso di tecnica selvaggia
che vedeva Mick Barr collaborare con il batterista degli
Hella, Zach Hill.
Qui, quegli stessi frenetici funambolismi chitarristici di
Barr, sciolti dalle costrizioni minimaliste auto-imposte
con gli Orthrelm, suonano invece decisamente azzeccati. Vibrati ossessivi sulle sei corde costruiscono tensioni
aliene, salvo poi esplodere in mille pezzi sotto le cariche
distruttive di Nevai. Il batterista colpisce selvaggio tra
66
improvvisi cambi di tempo e assalti blast-beat urlando
sguaiato al peggio della tradizione noise rock americana
(Colossamite, Harry Pussy) finché, di tanto in tanto, i suoni si distendono in luridi duetti feedback/voce a
salmodiare improbabili om per un infido sentore misticheggiante da dopobomba.
Registrato dallo stesso Nevai nel suo Fuck You studio
in un disastro di compressioni, Labyrintha si merita
quello spazio vuoto che c'è tra i dischi di Ruins e di
Napalm Death.(7.4/10)
Leonardo Amico
Mirco Menna/Banda di Avola - ...e
l'italiano ride (Felmay, Marzo
2010)
G enere : etno - world
Tra i tanti microfenomeni degli anni zero italiani, quello del recupero della musica da banda è stato uno dei
più curiosi e proficui. Merito di un manipolo di musicisti
appassionatisi ad un mondo la cui tradizione va ben
oltre il folklorismo da strapaese, su tutti Roy Paci e
Fabio Barovero, e merito
di un'etichetta come la Felmay che di alcune di queste
riscoperte è stata convinta
sostenitrice. Ci riferiamo al bel progetto ChantSong
Orchestra (canzoni dell'indie anni novanta rifatte in
chiave bandistico-orchestrale e ricantate da alcuni dei
protagonisti di quella stagione) e ovviamente alla siracusana Banda di Avola. Ma rimanendo a sud, anche ai due
splendidi dischi della Banda Ionica, il secondo dei quali
(Matri Mia, assolutamente da avere) coniugava musica
da banda e songwriting di qualità (coinvolgendo fra gli
altri Vinicio Capossela e La Crus).
Sugli stessi binari si muove questo lavoro della Banda di
Avola insieme al cantautore Mirco Menna, titolare fino
ad oggi di due discreti dischi del più tipico cantautorato
italiano, che per l'occasione riprende alcune canzoni già
pubblicate e le affida alle mani del maestro arrangiatore
Sebastiano Bell'Arte, ovvero il direttore dei cinquanta
elementi - età media sotto i vent'anni - della banda.
L'esito dell'operazione è buono; la scrittura agile e densa sotto il profilo lessicale di Menna trova un'ulteriore
pronuncia nelle vestiture bandistiche, le quali accrescono
i toni più drammatici e danno al tutto maggior vigore e
presa. Certo è che a lungo andare si percepisce come
questi brani non siano stati scritti appositamente per
l'occasione e nel confrontarsi con ance e ottoni pagano a tratti uno scarto coloristico. Ma è questione da
poco. In ...e l'italiano ride ad emergere è soprattutto
la carica vitale della Banda, sostegno perfetto a liriche
spesso intrise di critica al malcostume del palazzo come
del popolo. Tipico compito della musica realmente popolare.(6.8/10)
Luca Barachetti
Nada Surf - If I Had a Hi-Fi (Mardev
Records, Giugno 2010)
G enere : P ower pop
Strani oggetti gli album di cover. Nella classifica dell'inutilità stilata da ogni appassionato di musica che si rispetti,
si piazzano al terzo posto, dopo i live album e le raccolte
senza inediti. Solitamente sono il modo con cui una band
prende tempo, roda una nuova line up, tira su qualche
soldo (il che non fa mai male), cerca di non perdere il
contatto con i fan quando problemi di varia natura (crisi
creativa? beghe con l'etichetta? la malasorte?) gli impediscono di mettere mano a materiale inedito.
Il che, in alcuni fortunati casi, non impedisce di realizzare
prodotti interessanti: una volta evitato l'effetto karaoke,
la strada è tutta in discesa.
Un esempio lo abbiamo avuto proprio all'inizio di
quest'anno con l'album degli Hot Rats: rock'n'roll urgente, stringato e divertente come si conviene in questi casi. Ora arrivano i Nada Surf, che dal canto loro
realizzano un album di maturo power pop, dalla vena
vagamente malinconica ed intimista, in linea con lo stile
inaugurato anni fa con il classico Let Go.
Applicano la loro cifra a brani presi in prestito dai quattro cantoni del pop mondiale, passano in rassegna artisti
delle più disparate epoche, background e collocazione
geografiche (si va dagli Spoon a Kate Bush, dai newcomers Soft Pack a Coralie Clement) e se ne escono
con quaranta minuti che li riconciliano con il proprio
pubblico e con chi, come il sottoscritto, ha sempre seguito distrattamente la loro carriera.
Il metro della loro capacità di reinterpretare sta tutto
nella cover di Enjoy The Silence, ennesima versione del
classico dei Depeche Mode, covertito in scintillante
jangle pop, che mantiene pochi punti di contatto con
l'originale.
Il top si ha con i pezzi che, per loro stessa natura, meglio si sposano con i guitar pop del terzetto, quelli in
cui i Nada Surf riescono a dar sfoggio dei loro sofisticati impasti vocali. La versione di Love Goes On dei Go
Betweens, oltre a farci riscoprire un classico minore di
incontaminata bellezza, ce li mostra totalmente a proprio agio.
Si finisce persino per perdonar loro qualche piccola caduta di tono nel finale, quando qualche arrangiamento
barocco di troppo finisce per incrinare una prestazione
fin qui esemplare. Ma a quel punto il risultato è già stato
portato a casa.(6.5/10)
Diego Ballani
Nedry - Condors (Monotreme,
Maggio 2010)
G enere : electro - rock
La Monotreme non è nuova alle commistioni elettroniche in ambiti rock, prevalentemente di matrice indiee post-. Della serie, vedi alla voce 65daysofstatic per
conferme. Non sfuggono al marchio della casa-madre
anche questi Nedry, terzetto misto di stanza in quel di
Londra in cui centrale è la figura della cantante nippo
Ayu Okakita (anche loop station e percussioni), corpo
minuto al servizio di voce bjorkiana e sex-appeal alla
Kazu Makino.
Quello del trio è un suono misto electro-rock dalla lampante sensibilità pop, che fa vibrare reminiscenze glitch
67
su slanci fuzzy creando paesaggi oscuri, a volte quasi ambient, ma sempre delicati e soffusi. Merito sicuramente
della sapiente alternanza strumentale tra i restanti due
membri del trio, Matt Parker e Chris Amblin, intenti a
scambiarsi chitarre effettate e keyboard per creare ambientazioni eteree che sono l’ideale tappeto sonoro su
cui si muovono le corde vocali della Okakita. A volte la
ragazza è troppo dipendente dal modello bjorkiano, ma
riesce sempre a soddisfare l’ascoltatore per sensualità e
sensibilità, oltre che a donare quel tocco di esotismo che
in tempi di interculturalità non guasta affatto.(6.5/10)
Stefano Pifferi
O'Spada - Pay Off (Despotz, Maggio
2010)
G enere : P op - dance '80
Esordio di un quintetto con base a Stoccolma guidato
dalla voce pulita di Julia, look ultrakitsch e capisci subito
che musica fanno. Anni Ottanta a manetta, tastiere con
progressioni rubate agli Steely Dan ma traghettate da
synth e synthoni, chitarrine funky, stacchi a loro modo
mozzafiato, eccessi produttivi alla Todd Rundgren.
I primi tre pezzi sono ottimi, colori lucidissimi che quasi
abbagliano, un revivalismo così sopra le righe che saresti
tentato di dirlo consapevole e autoironico. Peccato che
il livello sia molto disomogeneo e si finisca col battere spesso la fiacca, perché quei tre-quattro pezzi buoni
sono davvero deliziosamente camp.(6/10)
Gabriele Marino
Oval - Oh (Thrill Jockey, Giugno
2010)
G enere : acoustic glitch
Ci aveva lasciato dieci anni fa con Ovalcommers, approdo pop di un personale percorso d'innovazione iniziato con Systemish, uno degli album che inaugurarono
(anticipandola) l'epopea dell'errore teconologico come
ragione estetica, procedurale e, perché no, filosofica e
anti accademica. Oggi lo ritroviamo con lo stesso sguardo sdrucito e probabilmente la medesima indisponenza
e asocialità d'allora, invecchiato, perplesso, ma con un
distacco dal presente importante tanto quanto quello dell'autoesiliato Jim
O'Rourke.
Di fatto, quest'idea di chitarra come simulacro, del
suo utilizzo come medium
tra tanti presenti e un univoco passato condiviso, è
senz'altro il tratto fondante di quest'eppì e il fuo68
co comune agli sguardi dei due musicisti, i più influenti
peraltro nei rispettivi ambiti avant negli anni Novanta.
Differentemente da O'Rourke, Oval ha tuttavia dovuto
lavorare sodo per trasformarsi in un musicista impro canonico. E' ripartito suonando ogni strumento, imparando
nel frattempo a farlo prendendosi così maggiori libertà
d'osservazione. In Oh il glitch di cui fu pioniere suona
acustico, ma acustico non è, ritroviamo il laptop (uno
di quelli economici confessa nella press) ma forse è un
effetto a pedale per elettrica, e quel che si ascolta sono
una serie di brevi pièces per chitarra trattata, batteria,
theremin e synth che rimandano a memoria certe schegge soniche dei Gastr Del Sol per rifiorire sottoforma
di bozzetti melodici e astratti, dagli arpeggi folk o dall'intaglio astratto, spesso scossi dallo sconquasso free ma
anche lasciati soli.
Un risultato affascinante, familiarmente alieno, colorato
à la Mirò, suonato con semplicità e attenzione al dettaglio. Qui la manomissione è tutto un aggiungere densità
piuttosto che trasfigurare l'America di un Fahey, il nitore
nipponico o il vento di certe contaminazioni post di Chicago.(7.3/10)
Edoardo Bridda
Paul White - Paul White & The
Purple Brain (One-Handed Music,
Giugno 2010)
G enere : psych - hip - hop
Essere dj e produttore madlibiano, oggi, significa spesso
fare una cosa: trovare un concept e lasciare che innervi in maniera più o meno decisa il proprio stile. Disco
su disco, concept su concept, e un flusso continuo della
propria firma.
Paul White per il sophomore ha scelto la produzione
del guru psichedelico svedese S.T. Mikael, attento alle
suggestioni orientali e al classico trip del rock Sessanta, come sfondo della propria stanza dei bottoni. Paul
White & The Purple Brain è un’infilata di brani che
ancora una volta fa parlare una cultura, un’ibridazione
tra il sound di partenza e la personalità di Paul. Una sequenza che si fa entusiasmante da Ancient Treasures fino
almeno a Fly With Me, cioè tra traccia 5 e traccia 11, e
poi si distende, riprende, impenna, ci conduce con molti
alti e pochi bassi fino alla venticinquesima e ultima siglatura di brano, Professional Criminals. Un disco che parte
piano, dunque, senza troppo convincere, e poi gioca le
sue carte a caldo. Gli stilemi evidenti sono la California targata UK di White. C’è meno melange con i suoni
rock e con la tradizione chitarra-basso-batteria, rispetto
all’esordio, sostituiti da un po’ di India fake (ancora echi
Madlib, evidentemente, per l’orecchio allenato che va a
un concept di qualche anno fa del producer della Stones
Throw), strati di suoni ora soffusi ora determinati.
Ci accorgiamo di una cosa, con Paul White & The Purple
Brain, una volta di più, e cioè che siamo noi i nuovi dj che
metteremmo questa musica a una festa.(7/10)
Gaspare Caliri
Perturbazione - Del nostro tempo
rubato (Santeria, Maggio 2010)
G enere : rock cantautorale
Tornano a tre anni di distanza da Pianissimo Fortissimo ed è come se nel frattempo fosse successo di tutto. Ci sono state tournée teatrali piuttosto riuscite e
apprezzate. C'è stata la rottura con la Emi ed il ritorno
presso Santeria. Ci sono
state esperienze professionali extra-band, defezioni
e sostituzioni. Sono nati
figli. Sono scoppiate bolle.
C'è insomma che le cose
accadono e devi prenderne atto, bene o male. Ecco
quindi i Perturbazione uscire dagli anni zero con un album doppio (24 canzoni) nel
quale danno voce e forma all'amarezza, al disincanto, alla
disillusione, a quel po' di residua magia pasturata a speranza e passione. Il loro consueto genio tiepido è ancora
alla base di questo Del nostro tempo rubato, ma l'approccio si è come squadernato in un ventaglio stilistico
mai tanto vario ed estremo, entusiasta e feroce.
Altro ritorno: Fabio Magistrali alla produzione e al missaggio, come già ai tempi di In Circolo (correva l'anno
2002) che li consacrò: una presenza che si sente nell'utilizzo incisivo ma sobrio degli elementi, sempre funzionali
alla situazione, che siano gli archi o i cori o una salva
di chitarre inviperite. Capita quindi che i folk indolenziti
si alternino a pop-rock briosi quando non veementi (lo
spasmo punk-folk di Vomito!, il malanimo espettorato ne
L'Italia ritagliata) o segnatamente sintetici (Partire davvero), giocando con la densità delle atmosfere (che oscillano dalle volute eteree di Musica leggera all'estro ingrugnito di Niente eroi) per poi d'amblé rinfrescarsi errebì
(La fuga dei cervelli) o con un sorso di para-tropicalismo
piacione (Promozionale).
E' un disco ambizioso, ovviamente, ma ha il grande merito di non suonare pretenzioso. Sembra proprio raccogliere - con mestiere pari alla genuinità - quel che di buono e urgente è uscito negli ultimi tempi dalla penna della
premiata ditta. Una penna ancora in grado di sfornare
piccoli gioielli di pop "senziente" come Mondo tempesta,
Mao Zeitung e Buongiorno buonafortuna (in quest'ultima
ospite quel buontempone malinconico di Dente), oppure stringenti quadretti cantautorali come la title track (a
proposito di come l'impegno possa dribblare la retorica)
e L'elastico. Nota di merito speciale per Primo, capace
di descrivere il suicidio (di Primo Levi) con un delicato
quanto efficace incastro di allusioni soniche e testuali.
Avrebbero potuto restare i vecchi Perturbazione ad libitum, staccare comodamente il cedolino, vivacchiare in
quel gradevole limbo di quasi grandezza. Invece hanno
scelto di essere qualcosa di più. O comunque di provarci.
Bravi.(7.1/10)
Stefano Solventi
Pjusk - Sval (12k, Marzo 2010)
G enere : A mbient T echno
Custode di una delle più credibili declinazioni di ambient
techno a oggi disponibili, il duo composto dai norvegesi
Rune Sagevik e Jostein Dahl Gjelsvik arriva al secondo album su 12k e conferma - va detto subito - quanto di buono dimostrato in Sart (12k, 2007), esordio già
maturo di produttori dei quali tutto si poteva intuire
tranne che fossero alle prime armi.
Grazie a una cura del suono che definiremmo quasi maniacale, i due riescono infatti a rendere ancora attraente
quella che è ormai lingua morta di un genere che ha
attualmente nel ritornello deleuziano (differenza e ripetizione) di Biosphere - un altro norvegese - o nelle
evoluzioni di Pantha du Prince o Monolake gli ultimi
avamposti di creatività percepibili all'orizzonte.
Sono le maestose aperture di brani come Validal e Sus non il canonico e costante frullare di beat sottopelle - il
marchio di fabbrica di Pjusk, ciò che meglio sanno fare
e li rende riconoscibili - come rende riconoscibile Biosphere e un certo modo di intendere l'elettronica tipico
dei paesi scandinavi.
Il disco funziona, specie se ascoltato a volume sostenuto
sì da poter apprezzare le dinamiche texturali - davvero
sopraffine - che sono qui più importanti di quelle armoniche o melodiche - rare e, quando presenti, piuttosto
prevedibili. Con qualche colpo a vuoto in meno - il disco dura più di un'ora: troppo per queste sonorità - saremmo qui a parlare di un classico minore dell'ambient
techno - o del primo vagito di una new school del genere.(7.2/10)
Vincenzo Santarcangelo
Pontiak - Living (Thrill Jockey,
Maggio 2010)
G enere : post hard rock
Gente che viene dalla campagna i fratelli Van, Lain e
Jennings Carney. Da noi si dice “scarpe grosse e cervello
69
fino”, nella loro Virginia non sapremmo, ma conta averli
tra noi questi stacanovisti delle note - siamo all’album
numero cinque - che non ne sbagliano una. Arrivano a
una prima maturità, com’è giusto, spendendo più tempo
nel granaio che hanno adibito a studio di registrazione
(un poker di mesi in luogo dell’usuale settimana
) e apparecchiare quelle che sulle prime sono le “solite” chitarre pesanti, i “soliti” bassi rugosi, le “solite” melodie
sabbathiane.
Calma, che non ci troviamo al cospetto di uno tra i tanti
gruppi di copisti che sia aggirano nel panorama di riferimento: qui nulla dura più del dovuto e l’urgenza espressiva prevale. Vero è che Young e This Is Living sono paradigmi di quanto appena elencato, nondimeno c’è un
tono sardonico e oppiaceo nell’esecuzione e nella voce
che tradisce l’approccio iconoclasta del trio. Demoliscono regole che, un tempo lontano, erano quando di più
sonicamente eversivo potevi chiedere. I Pontiak lo hanno capito e sanno che non
puoi più cadere nella prosopopea se ti misuri con
queste sonorità.
Ecco perché Original Vestal
sfocia in colpi sparsi e feedback modulato in equilibrio
paritario tra gli strumenti,
e Algiers By Day e Thousand
Citrus sottraggono zolfo a Tony Iommi per farne acidume da California ’68. Questo il motivo dietro And By
Night e Second Sun, sperimentali parossismi col sorriso
sulle labbra come li pensavano magari i Thin White
Rope; questa la motivazione che libera le Virgin Guest e
Beach vicine ai Pink Floyd estatici e intorpiditi nell’alveo dei primi 70. Dal quale proviene - ancorandosi tra
la Londra degli Hawkwind e la Detroit degli Stooges
- la tenebrosa e spezzettata Lemon Lady, laddove i sei
minuti di psichedelico ondeggiare di Pacific riassumono
il senso della band americana come meglio non si potrebbe. Stato dell’arte per un certo rock chitarristico,
un disco siffatto, perché prende a esempio il passato per
non farsi impaludare. Hai detto niente.(7.5/10)
Sei brani e altrettanti remix degli stessi, nati tramite contatti umani veicolati dalla rete, tra un social network e
l’altro. Accompagnati magari da video come quello di Ad
Occhi Chiusi, realizzato come collage di filmati personali e
d’epoca esenti da copyright, transitato addirittura per il
sito di NME. Premesse interessanti per pezzi che coniugano immediatezza ad arrangiamenti che ammiccano ai
generi citati poco su, peccando in quanto a qualità compositiva e pagando pegno per un’affinità troppo marcata
con i Subsonica pre Microchip Emozionale. E paradossalmente poi son proprio i remix (Crime su tutti) a
spiccare, tiro dance e strizzatine d’occhio al dubstep ben
congeniate comprese. Da calibrare.(5/10)
Giancarlo Turra
Stefano Pifferi
Giampaolo Cristofaro
Pttrns - Science Piñata (Altin
Village, Maggio 2010)
G enere : p - funk
Cominciare il proprio disco d'esordio con un titolo come
Apocalypso è come indicare una via in maniera piuttosto
eloquente. La musica dei tre Pttrns - tedeschi di Colonia
- è appunto una apocalisse, uno svelamento incessante di
fonti e rimandi evidenti e voluti, in cui si staglia tutto quel
sottobosco di matrice p-funk che da !!! e Rapture in poi
ha segnato l’indie-music del decennio scorso.
Se i gruppi citati sono il punto di partenza per Benjamin
Riedl, Daniel Mertens e Patrick Hohlweck (indifferentemente chitarre, basso, batteria e percussioni) c’è da
dire che le destinazioni intraprese sono piuttosto stimolanti: tropical-indie alla Vampire Weekend più corposi,
meticciato culturale alla Mi Ami con minore asprezza
e tensione, funkettoni hard tagliati con l’accetta, terzomondismo alla Radio 4 o Panico che mischia coretti
e dub, voci bianche e slanci dancey, poliritmi alla Black
Eyes e funk bianco che più fine ’70 non si potrebbe.
Insomma, inserito il cd ecco che in un attimo la fredda Colonia d’origine si trasforma in un caleidoscopio di
sensazioni coloratissime e multiformi. Nulla di innovativo e molto di derivativo, ma classe sonora, gran tiro
dancefloor-oriented e spessore non da runners ce li fanno apprezzare.(6.5/10)
Popuccià Band - Pop 2.0
(Autoprodotto, Maggio 2010)
G enere : F orma canzone dub
Rowland S. Howard - Pop Crimes
(Infectious, Maggio 2010)
G enere : pop mitteleuropeo
Nato come progetto del tutto hip hop, i calabresi Popucià (“proprio ciao” in vernacolo) diventano band vera e
propria e con Pop 2.0 coniugano l’amore per dub, drum
n bass e jungle ad una visione concettuale "moderna"
della composizione e della struttura del disco.
Annus horribilis questo 2010, almeno a giudicare dai
troppi trapassi che ne hanno funestato questa prima,
scarsa metà. Tra i tantissimi, anzi tra i primi visto che
risale al 30 dicembre 2009, c’è da segnalare anche quello
di Rowland S. Howard, comprimario di lusso di quel
70
highlight
Oneohtrix Point Never - Returnal (Editions Mego, Maggio 2010)
G enere : synth trance
Nil Admirari. Non stupirsi di niente. Vecchio adagio degli stoici, che lo consideravano come la base della felicità. Non stupitevi quindi di inserire l’ultimo
disco di Oneohtrix Point Never nel lettore cd (mai come nel suo caso il
supporto cd diventa fondamentale. No vinile, no cassetta. Compact Disc!)
e di trovarvi di fronte all’annichilente bellezza del rumore. L’apertura noise
del nuovo disco di Daniel Lopatin, salda ponti importanti con gente come
Aphex Twin e Venetian Snares: caotico, abrasivo, brutale eppure esteticamente bello, con l’uso di una voce umana che nella parte finale del brano
sembra soccombere all’atroce rantolo delle macchine.
Lopatin passa ora, ufficialmente, dal rango di culto a quello di portabandiera di una serie di cose che si
muovono nella caotica scena musicale di questi anni. Lui è il punto di contatto tra i nuovi corrieri cosmici,
gli esteti di una nuova ambient new-age, gli intellettuali pop della scuola hipnagocica. Daniel Lopatin sta da
qualche parte li in mezzo, forte di una personalità che oltrepassa l’accerchiamento e si permette di citare
i classici di sopra come si compete ad uno che guarda ben oltre l’orizzonte quotidiano. Poi, in generale, i
sintomi che Returnal sarà il best seller del settore quest’anno sono un po’ ovunque. I precedenti di Zones
Without People e Rifts hanno sedimentato. Ora Lopatin viene citato in egual misura da Pitchfork e dal
più carbonaro dei blogs, l’etichetta di distribuzione è diventata la lungimirante ed esposta Editions Mego
e dulcis in fundo ci sono gli artwork “designed by” Stephen O’Malley e il mastering di James Plotkin,
le griffe più alla moda per l’underground che perde la verginità. Returnal si presenta quindi subito con le
vesti del classico.
Describing Bodies e Stress Waves migliorano ulteriormente gli standard del suo paesaggismo androide,
prima di inaugurare un nuovo esempio di ballad robotica, cantata da una voce pesantemente effettata
e compromessa nell’umore. Un sentore di mestizia cosmica, che va oltre la semplice dicotomia uomo/
macchina. Non è un caso che tutto finisca con l’assumere un profilo vagamente esotico. Qui siamo oltre il
quarto mondo di Jon Hassel. E’ il quinto mondo di Daniel Lopatin, un mondo fatto di microchip, synth e
circuiti valvolari, un mondo che viene raggiunto nelle tracce finali: Ouroboros e Preyouandi. Ormai da Tron,
siamo passati a Tron Legacy.(7.8/10)
Antonello Comunale
rock australiano maledetto e rinnegato che ha segnato
l’ultimo trentennio. Ecco così che il compianto chitarrista consegna involontariamente a questo Pop Crimes il
proprio epitaffio.
Un disco che, seppur carico di ovvi significati emotivi, non
può prescindere dalla temperie musicale in cui il Nostro
è cresciuto: dai seminali Boys Next Door/Birthday
Party ai Bad Seeds del sodale Nick Cave (pur non
facendone mai parte materialmente) passando per Crime & The City Solution e These Immortal Souls,
senza contare le mille collaborazioni con Lydia Lunch,
Einsturzende, Barry Adamson e tanti altri ancora. Come
a dire tutti gli stadi intermedi che dal post-punk più isterico e bluesy arrivano a una moderna forma di pop-song
dall’eleganza mitteleuropea.
Nonostante questo evidente e ingombrante background,
Pop Crimes si mostra perfettamente compiuto nelle
trame ricercate e nella raffinatezza di fondo. A risaltare sono la fine eleganza strumentale messa al servizio
di un mood gothic, appassionatamente oscuro e dal taglio mitteleuropeo e un songwriting maturo, composto,
da crooner esistenzialista: che siano ballads in coppia
(l’opener (I Know) A Girl Called Jonny con Jonnine Standish
degli HTRK), incessanti torch songs (Nothin’) o cavalcate badseedsiane (Life’s What You Take It e Pop Crimes),
Rowland S. Howard si dimostra artista di spessore, dalla sensibilità profonda e di cui sicuramente si sentirà la
mancanza. Buon viaggio.(7.2/10)
Stefano Pifferi
71
highlight
Sursumcorda - La porta dietro la cascata (Egea, Maggio 2010)
G enere : cantautorato avant
Se la sono presa comoda i Sursumcorda per dare un seguito all'eccellente
L'albero dei bradipi, un lustro intero. Non che il quintetto milanese sia
rimasto con le mani in mano, anzi. Rubricati i fisiologici cambiamenti di organico (della formazione originale sono rimasti Giampiero “Nero” Sanzari,
Piero Bruni e Francesco Saverio Gliozzi), in questo lasso di tempo hanno
composto ben sette soundtrack per documentari di varia natura, cioè hanno
seguito l'estro, quella sontuosa attitudine che li porta a realizzare stanze
sonore per situazioni particolari, coincidenze poetiche, traiettorie narrative,
frame visuali...
E' quindi nel segno della suggestione musicale applicata al cantautorato che nasce La Porta dietro la cascata, album di canzoni dalle grandi aperture melodiche, sorrette da una apprensiva solennità chiosata da
generose però mai eccessive partiture orchestrali. Un folk pervaso di aromi mediterranei come orizzonte
mentale, il languore accorto e pensoso degli chansonnier - e vagamente Tenco - a spigolare intuizioni
liriche, un esotismo sperso e a tratti balcanico a condire i guizzi: queste le principali coordinate di una
calligrafia stratificata ma estremamente fruibile, interpretata con sobrietà disarmante dal Sanzari, voce
non certo virtuosa ma ben dentro al quid poetico della cosa, anche quando si cimenta della "cover della
cover" con So che mi vuoi (la versione che Mina fece della beatlesiana It's For You). Pezzi indubbiamente
riusciti come Infinito, Il palazzo, Bambina che schiaccia i pinoli e Nascita nuova sembrano la sintesi ideale tra
pop di qualità e musica d'autore.
Poi ci sono i "frattali", variazioni strumentali più o meno brevi di spunti melodici raccolti nel secondo CD,
un'appendice che torna a mettere l'accento sulla capacità di imbastire situazioni soniche tra poetico e
cinematico, ribadendo la statura di una band da tenere in grande considerazione.(7.8/10)
Stefano Solventi
Sage Francis - Li(f)e (ANTI-, Maggio
2010)
G enere : post hip - hop
Sin dai giorni in cui gravitava attorno alla galassia Anticon, Sage Francis ha avuto poco a che spartire col ruolo
dell’MC tradizionale. La dimensione che gli appartiene
è un podio spartano da poeta beat con una piccola folla attorno che lo ascolta rapita. Siccome si è trovato a
scrivere rime tra secondo e terzo millennio, non poteva
che caricarsi sulle spalle la timbrica agra e snocciolarle,
quelle rime, con fare da rapper. Benissimo così finora ed
era logico che, prima o poi, entrasse nell’asilo per menti
libere e sovversive della Anti-.
Li(f)e arriva dopo Human The Death Dance, lavoro oscuro
che a tratti finiva per raggomitolarsi e tirare sin troppi
calci a chi gli si avvicinava. Avercene, però di intimazioni
così coraggiose. Come avercene della maturità esibita
qui, chiamando a sé facce inattese ma non se si pensa a
quando detto in apertura: tra i tanti, sono della partita
Brian Deck, Jim Becker e Tim Rutili dei Califone;
l’energica Three Sheets To The Wind è a quattro mani con
72
Chris Walla; la splendida, amara apertura Little Houdini ospita un decisivo Jason Lytle. Come dire che tutti
questi fan di Sage non possono sbagliarsi e così il Nostro,
che ha deliberatamente scelto collaboratori non appartenenti all’area hip-hop: bene ha fatto quando gli esiti
sono - per spremere il succo più saporito - l’amarcord
tra narcosi e vetriolo I Was Zero e la minacciosa però
malinconica Diamonds And Pearls, la The Baby Stays che
meglio di altre si integra con l’anima Califone e una
favolosa 16 Years cigolante di cupezza.
Abbuonato il paio di episodi che fatica a prendere corpo,
ripensi all’integrità del personaggio, alla conclusiva narrazione The Best Of Times e a ciò che l’ha preceduta. Ci
scopri canzoni, la vita e le bugie che questa ci spaccia.
Ma quello lo spiega già il titolo del disco, con un calembour geniale tanto quanto lo è una sua consistente
parte.(7.1/10)
Giancarlo Turra
Sleepy Sun - Fever (ATP Recordings,
Giugno 2010)
G enere : psych rock
e Smiths mentre l'organo gracchia tepori sixties (come
nel bel singolo I Saw You Blink).
Tutto ciò senza mai staccare la spina - pardon - le radici
Non sposta una virgola il sophomore di Sleepy Sun. dal grembo di un front porch immaginario (immaginato?),
Nessuno, del resto, poteva aspettarsi che potesse cam- laddove accanto alle ballate country sono benvenute le
biare qualcosa, e l’ascoltatore mezzo salvato non reste- marcette errebì come non sarebbero spiaciute al giovarà sostanzialmente deluso, da Fever. Si potrà godere la ne Van Morrison (The End Of The Movie). Chiesastici e
produzione di buon effetto alzando il volume e restando sbrigliati, frugali e stradaioli, sbarazzini e intensi, capaci di
immobile, nell’afa estiva, a lasciar scorrere la psichedelia servirsi alla bisogna e con disinvoltura di trombe, violino
e campane, gli Stornoway sono l'ennesima dimostrazione
torrida del combo di San Francisco.
Il maggiore rilievo attorno al disco sta qui: l’efficacia ma di come il pop sappia declinarsi in infinite, sempre gradeanche la mancanza di appigli per la memoria del lento flu- voli, sfumature.(7.2/10)
ire delle tracce. Normale forse, per un rock pachidermiStefano Solventi
co basato sulla ri-proposizione, ma che si regge su buona
qualità costruttiva di psych song fortemente tradizionali Sur - Il limite (Sidecar, Aprile
eppure dirette, nonché, in fin dei conti, ben scritte. Come 2010)
dai Black Sabbath in avanti, la formula vincente è quella G enere : jazz folk
della melma ferma che fa da intro a moderate accelera- Già assieme nei Caputolindi, band che sul finire dei
zioni lisergiche (il tutto contenuto in Sandstorm Woman) novanta si cimentava nel sempre florido incontro tra
- anche se a noi piacerebbe sapere dove sarebbero in jazz e bossanova, la cantante e musicista Eloisa Atti ed
grado di arrivare se seguissero le piccole novità polirit- il versatile strumentista Francesco Giampaoli hanno poi
miche quasi in coda a Marina.
dato vita ai Sur, che nel corso del tempo è diventato
Per ora - anche alla luce dei loro live - non ci si chiede un quintetto sfornando un esordio omonimo nel 2006
quanto potrà durare, ma la domanda sta lì, dietro l’ango- e dando vita oggi ad un sophomore che merita d'essere
lo.(6.5/10)
raccontato. Undici canzoni
Gaspare Caliri che galleggiano su un tessuto languido e soave per
quanto composito.
Stornoway - Beachcombers
Un intreccio di modi e
Windowsill (4AD, Maggio 2010)
suggestioni colti dal jazz al
G enere : pop folk
E' una storia sentita mille volte, quella degli Stornoway. canzoniere italiano, dal reQuattro studenti di Oxford che fanno la loro cosa so- pertorio popolare latinonora nella cameretta del college per poi rosicchiare en- americano al fado, questi
tusiasmo e favori con esibizioni pubbliche sempre più af- ultimi omaggiati con le versioni del tradizionale messicafollate, finché non cadono sotto i riflettori dell'etichetta no La sandunga (pezzo ottocentesco scritto da Máximo
occhiuta (nientemeno che la 4AD) e ti sfornano un de- Ramón Ortiz) e del classicone portoghese Lagrima (di
butto saturo di entusiasmo giovane e prospettive a lungo Carlos Gonçalves e Amàlia Rodrigues). Interpretazioni
termine. Si chiamano Stornoway, come il nome di un e arrangiamenti si fanno apprezzare per la sobrietà apvillaggio portuale scozzese dalle note origini vichinghe. passionata, per l'inventiva sempre organica alla situazione
espressiva, per l'ingegno e la misura con cui certe vibraCosa c'entra? Non ci è dato sapere.
Certo è che le undici canzoni di Beachcombers Win- zioni contemporanee (grazie soprattutto al micromoog)
dowsill conservano una natura ondivaga o se volete iti- si mimetizzano nell'impasto.
nerante, impastando le suggestioni alternative e doo-wop Tutto ciò nel caso dei pezzi originali significa disimpedegli Housemartins con l'alone traditional-folk degli gnarsi tra oniriche suggestioni (la splendidamente indefiOkkervil River, cogliendo dalla corolla Belle And Se- nibile Cavallino di vetro), argute ballatine (Colibrì) e ferventi
bastian petali di tenerezza indolenzita (la toccante Fuel ibridi jazz-folk (Pelle), passando dalla marcetta traslucida
Up) ed estro stradaiolo (quella Watching Birds dall'estro di Gloria del mattino e dalla flemmatica inquietudine dixie
quasi Modern Lovers), concedendosi il sussiego bu- della title track. E' disco da meditazione come certi vini
colico di certi Hidden Cameras (We Are The Battery che ti chiedono la giusta disposizione d'animo.(7.2/10)
Human) o un pizzico di depistaggio postmodernista LoStefano Solventi
cal Natives (On The Rocks), spacciando retaggi R.E.M.
73
Sweet Apple - Love & Desperation
(Tee Pee, Maggio 2010)
G enere : grunge - rock
Gone incantevoli e ricolmi di amore nero. No Snare
conquista il suo posticino nell’interstizio spazio/temporale in cui regnano Postal Service, Beach House e
Gli Sweet Apple sono J. Mascis (batteria/chitarra/voce), Frozen, mentre Melanie una tenuta sulla distanza che
gli ex Cobra Verde Tim Parnin (chitarra) e John Petkovic non era poi così scontata all’esordio.(7/10)
(voce/chitarra) e Dave Sweetapple degli Witch (basso/
Giampaolo Cristofaro
voce) e Love & Desperation una macchina spazio-temporale che ci fa uscire centrifugati a dovere nel Nord-Ovest Terror Pigeon Dance Revolt (The)
americano agli inizi dei ’90. Sì, esattamente in quella città - I Love You. I Love You. I Love You
che nessuno osa più nominare da un buon quindicennio And I'm In Love With You. Have An
si può collocare l’esordio di questo che non si sa bene Awesome Day! Have The Best Day Of
se sia un side-project ben definito o un gruppo estem- Your life! (Luaka Bop, Maggio 2010)
poraneo.
G enere : I ndie mes s
Di sicuro lì va a parare la musica, un power-pop dalle Sull'etichetta di David Byrne, accanto a Tom Zé, Os
tinte hard e grunge troppo riconoscibili e lineari: più Foo Mutantes e Zap Mama, l'esordio di questa band/colletFighters che Nirvana, qualche reminder dei Meat tivo numerosa come un condominio (18 persone: quelPuppets del medio periodo (altezza Too High To Die), le che affollano la copertina?), capitanata da tale Neil
ovviamente Dinosaur Jr, uno sbiascicamento sofferente Fridd. Per capirci subito, il tutto suona come se diciotto
alla Eddie Vedder (Never Came), una spruzzatina di main- tizi sbronzi di birra si fossero infilati in studio mettendosi
stream-rock sporchetto alla White Stripes/Dead We- a cazzeggiare con gli strumenti. Un po' come - pare - facather, per capirsi (Flying Up A Mountain), una bottarella ciano effettivamente dal vivo i Terror Pigeon.
di aor-rock di quello zuccheroso al limite della ballatona Il modus operandi, figlio degenere di un'epoca già postda accendino (Dead Moon) Animal Collective, è semplicissimo: prendere un moe il gioco è fatto. Insomma, tivetto pop e incasinarlo, strepitarlo, stonacchiarlo, scimscivolano via senza sussulti i miottarlo. Il disco è tutto così, un flusso di (in)coscienza
40 minuti di quest’album e a base di (s)cazzeggio alt/indie, un pasticcio che mischia
l’unico piacevole passatem- piano acustico ed elettronica analogica, soul e dancefloor
po è quello di mettersi lì a demente, con titoli assolutamente autoesplicativi come
trovare e riconoscere i rife- iotdwykirhtbr.
rimenti. O al massimo dare Non ci sono, ma ci fanno, e quindi ci stanno meno simuno sguardo alle due belle patici di quanto potrebbero. Sprazzi di divertimento, ma,
in copertina, anch’essa a ben vedere un deja-vu, visto che sinceramente, troppo facile.(6/10)
è un palese omaggio a Country Life dei Roxy Music.
Gabriele Marino
Decisamente prescindibile, seppur ben suonato. E ci mancherebbe.(6/10)
Têtes de Bois - Goodbike (Ala
Stefano Pifferi
Tender Forever - No Snare (K
Records, Giugno 2010)
G enere : E lectro - pop
Bianca, Aprile 2010)
G enere : canzone d ' autore
I Têtes de Bois amano i percorsi trasversali, fatti non
solo di canzoni - scritte, riscritte (vedi l'omaggio a Leo
Ferré del 2002), recuperate - ma capaci di coinvolgere
La capacità di inanellare melodie a presa rapida è uno dei teatro, letteratura, ricerca sul campo e negli archivi. E' il
talenti che un musicista che si vuol misurare con qualsiasi caso di questo Goodbike, secondo concept del grupforma di pop deve riuscire prima o poi ad acquisire. Ca- po romano dopo quell'Avanti Pop del 2007 dedicato
pacità che Melanie Valera/Tender Forever ha dimostra- al lavoro, nonché verace atto d'amore nei confronti della
to avere innata, indipendentemente dai vestiti che con- bicicletta e del suo immaginario. I Têtes, come tanti altri
fezionava per il suo electro-pop sensuale e drammatico. cantautori nostrani prima di loro (Conte, De Gregori,
Magari Wider continua ad essere il suo lavoro meglio Ruggeri), ne indagano il lato romantico, talvolta epico ma
riuscito, ma No Snare gli è di poco dietro, pervaso da sempre in senso esistenziale, e pure quello politico, poatmosfere cangianti, tra effusioni di “indie gospel”, tappeti nendo le due ruote come mezzo di locomozione libertaritmici tribali e quel tocco lugubre che rende pezzi come rio - se non addirittura rivoluzionario - o come principio
When I’m The Dark You Take The Light o Like Snare That’s costitutivo di uno stile di vita possibile e sostenibile.
74
highlight
Teenage Fanclub - Shadows (PeMa, Maggio 2010)
G enere : P ower P op
In un mondo più giusto l'hype riservato, magari dopo appena un singolo o
un EP, a certe mezze calzette della scena britannica dovrebbe invece essere
riservato alle uscite discografiche di Norman Blake, Gerald Love e Raymond
McGinley, le tre firme delle gemme power pop che da un ventennio vengono
dispensate sotto la sigla Teenage Fanclub. Dopo un singolo (Baby Lee)
messo in circolazione già qualche tempo fa attraverso il loro sito ufficiale, i
tre tornano con un disco che conferma la loro solidità compositiva, le loro
capacità melodiche fuori dal mondo e la freschezza dei loro arrangiamenti
per farci tornare tutti sedicenni.
I detrattori obietteranno che non c'è nulla di diverso dal solito disco Teenage Fanclub (eccezion fatta, forse, per una concessione pianistica in Dark Clouds, in un contesto altrimenti dominato come sempre dalle
chitarre), che la formula è sempre la stessa e che i grandi dischi sono stati Bandwagonesque, Grand Prix
e Songs From Northern Britain. Certo, qui siamo un gradino sotto, ma quante altre band riescono a suscitare
lo stesso sentimento bittersweet dell'iniziale Sometime I Don't Need To Believe In Anything, come viaggiare
sulla metropolitana del destino, cuffie calate nelle orecchie mentre il sole tramonta e gli archi che sorreggono il ritornello spargono tutt'intorno l'odore dell'oceano? E quell'organo che suona in lontananza in
Shock and Awe non è il tocco di classe a una canzone pop perfetta (anche qui sorretta da violini delicati e
bellissimi)? E non vi viene voglia di tornare brufolosi solo per poter dedicare a qualcuno When I Still Have
Thee, con i suoi raggi di sole che si insinuano tra le tende della cameretta (“It's a minor song/ in a major key/
but the stars still shine/ and you see'em spin/ no I don't need much/ when I still have thee”)?
Poche volte come in Shadows è sembrato evidente che il pop dei Beatles e di Ray Davies e la gioie
musicali della costa californiana dei Beach Boys e di Van Dike Parks si possono fondere in un unico
atto estetico definitivo rappresentato dallo spleen adolescenziale. E che lo amettiamo o meno, a sedici
come a sessant'anni, è quel tipo di emozione che ci fa mancare un battito al cuore.
(7.1/10)
Marco Boscolo
Da qui dunque la traduzione di un classico di Yves Montand come La bicicletta e la rilettura del Paoli minore di
Coppi (entrambi assai riuscite e molto molto francesi), e
da qui allo stesso modo il funk-ska urbano di Corrosivo
acido e il pop festante di Noi siamo il traffico. Cosa manca?
Forse una canzone all'altezza di una tradizione che alla
bicicletta, e al ciclismo in particolare, ha dedicato più di
un capolavoro. Anche se La canzone del ciclista, autografo
però risalente allo splendido Pace e male (2004), sta
proprio a un passo da Diavolo rosso e Il bandito e il campione.
Tuttavia di Goodbike si apprezza soprattutto l'organicità del progetto. Reading letteraria prima (il cantante Andrea Satta ha dedicato alla bici un romanzo), spettacolo
teatrale poi, ora disco multistrato. Che per comprendere
e sognare (sul)la bicicletta raduna vignette (di Sergio Staino), featuring oblique (Militant A degli Assalti Frontali in Alfonsina e la bici dedicata ad Alfonsina Strada, unica
donna a partecipare al Giro nel 1924), voci e penne ciclistiche più o meno storiche (Gianni Mura che firma il testo montanaro di Le bal des cols, Claudio Ferretti, Maurizio Crosetti, Alessandra de Stefano e Marco Pastonesi) e
pareri eminenti (Alfredo Martini, Marc Augé, Margherita
Hack, Chris Carlsson).Traguardo raggiunto tra i primi ma
senza distacchi pesanti dal gruppo.(6.8/10)
Luca Barachetti
Thee Jones Bones - Electric
Babyland (Il verso del cinghiale,
Maggio 2010)
G enere : rock ' n ' roll
Fanno il verso ad un mostro sacro del rock come Jimi
Hendrix, questi due bresciani: nel titolo come nella cover, splendida riproposizione della foto di Electric Ladyland. Luca Ducoli (voce, chitarra) e Michele Federici (batteria) hanno però piedi e testa ben piantati nel
75
rock’n’roll più scalmanato e senza freni possibile: slanci
country, bellezze blues-punk, richiami garage come se
piovesse, energia e sudore d’obbligo si alternano senza
soste in Electric Babyland tanto che se in prima battuta a venire in mente sono le scarne trame della Blues
Explosion e discendenti vari, nel corso della scarsa mezzora dell’album ci si rende conto che il duo bresciano
è molto più inzaccherato nei crismi del rock’n’roll più
selvaggio e sboccato.
Per capirsi, quello che da Jerry Lee Lewis arriva fino
agli oscuri garage-heroes delle varie Back From The
Grave, passando per il sixties-pop più rumoroso, il rockblues storico, gli Stooges e gli Stones. Quella è la tradizione cui attingono e di cui non fanno mistero alcuno,
anzi la mantengono in vita alla grande sullo slancio di freschezza strumentale e energica passione. I vari ganci e
indizi disseminati qua e là ne fanno più che un disco, una
sorta di caccia al tesoro negli ultimi 50 anni di r’n’r. Di più
non oseremmo chiedere. Bravi.(7/10)
Those Furious Flames - Trip To
Deafness (Bagana Records, Maggio
2010)
G enere : hard - rock
Il progetto dei ticinesi Those Furious Flames è stracolmo
di stereotipi riconducibili all'hard-rock. Dal nome scelto
per la ragione sociale, alle note biografiche riportate sul
sito della band - “It was born at the end of 2003, when 5
motherfuckers with a big passion for rock'n'roll met and decided to form a new band. As soon as they began to play some
music, what they all had in their minds became clear: they
wanted their real rockers attitude - turned on by sex, drugs
and rock’n’roll - to grow wilder” -, alle foto ufficiali in pose
da “supertosti”, a una grafica del disco - peraltro apprezzabile - in bilico tra 13th Floor Elevators e Grateful Dead
(Malleus docet).
In realtà si tratta di molta “fuffa” e di un po' di sostanza,
visto che tolta la sovrastruttura fatta di immaginari riciclati a oltranza, rimane una base abbastanza solida in cui
Stefano Pifferi far convivere Unida, porzioni di Radio Birdman, spauracchi Guns & Roses - più citazioni nel suono che altro
- e un pizzico di rock-pop fine Settanta / inizio Ottanta
Thee Oh Sees - Warm Slime (In The
da capelloni ormai stemRed Records, Maggio 2010)
piati (la I Love Rock'n'roll via
G enere : garage - rock
Non si può dire che si risparmino i Thee Oh Sees di Arrows / Joan Jett And
John Dwyer vista la pletora di uscite brevi e lunghe che The Blackhearts suggeridonano ad ogni giro di calendario. Nello stesso modo ta da When The City Is Slenon si può dire che non sorprendano ogni volta, pur gio- eping). Nulla di stravagante
cando sempre sul terreno garage-psichedelico infiltrato o particolarmente originain egual misura di scorrettezze soniche e sommessi slanci le, insomma, ma nemmeno
l'opera di qualche residuato
soul.
Warm Slime si apre con un pezzo, l’omonima title track, criogenico in pantaloni in pelle del decennio reaganiano.
che da sola occupa esattamente una buona metà dell’in- Un viaggio verso la sordità che nasconde meno pericoli di
tero disco e che in un quarto d’ora scarso di stomp- quel che potrebbe sembrare.(6/10)
garage psichedelico non fa un prigioniero che sia uno.
Fabrizio Zampighi
C’è l’intero universo targato Thee Oh Sees in quel pezzo:
coretti twangy e sensibilità Nuggets, umore sfascione e Titiyo - Hidden (Despotz, Maggio
elettricità a manetta, brandelli di wave, punk e sixties-pop 2010)
maciullati insieme in un saliscendi da ottovolante dera- G enere : R\' n \'B
gliante. È lì, forse, che risiede il grande segreto dell’ascesa La lunga carriera della regina dell'R'n'B svedese, nonché
del quartetto nell’odierno panorama (ex)garage, testi- sorellastra di Neneh Cherry che alla musica la avviò,
moniato anche dalla centralità che la sigla ha assunto in non aveva regalato pagine particolarmente memorabili,
questi ultimi 2 o 3 anni tra i mille progetti del suo leader: come si evince dal Best Of del 2004: un disco ogni tanriuscire a condensare in dosi uguali asperità e melodie, to, piazzato anche dove gli competeva - ossia nelle chart
lo-fi e garage, psych e sixties pop, evocando solari e aci- americane, ma il tutto all'insegna di un pop che seguiva
di panorami retrò così come sguaiate performance da senza grossi sussulti i trend del periodo.
rock’n’roll marcio. Insomma, miscelare tutti gli ingredienti Dopo esser passata però dallo stardom di Come Along
(noti) ma tirandone fuori ogni volta pietanze ricche, gu- allo stallo creativo dell'album non terminato nel 2004,
stosissime e appetitose.(7.2/10)
Titiyo ha avviato un percorso di ridiscussione che l'ha
Stefano Pifferi portata, tra le altre cose, a scrivere da sé il repertorio.
Ne è risultato Hidden (del 2008 ma distribuito in Ita76
lia solo adesso), il quale fin dal titolo - da intendere più
come "intimo" che come "nascosto" - si muove su linee
nuove rispetto al passato, mollando il dancefloor per una
malinconia che non viene meno nemmeno quando si
recupera un po' di tiro ritmico, vedi l'opener Awakening
(con melodia di celtico pathos su bassi house) o una Clear Crystal Mud con furtino-Eurythmics. Il pop lo cerca
semmai nei Portishead di Stumble To Fall, nel bordone
vagamente Harvey di N.Y. o nel duetto con Moto Boy
della If Only Your Bed Could Cry: per il resto la nostra preferisce insistere sul celtico nelle movenze sinuose di piano,
archi ed elettrica di Standby Beauty o cercare delicatezze
mitchelliane in Longing For Lullabies, misteriose in Drunken
Gnome.
Pop lo è ancora, dell'R'n'B ne rimane, eppure Titiyo ha
trovato una mano già ferma per farne qualcosa di segno
opposto rispetto al poco carattere del passato.(6.8/10)
Twin Stumps - Seedbed (Fan Death,
Maggio 2010)
G enere : N oise R ock D owntempo
Dei Twin Stumps cennavamo il mese scorso parlando dei colleghi Drunkdriver, oggi una nuova uscita ci
sorprende di per sé dato un EP omonimo di pochi mesi
fa e considerata la violenta
aggressione di cui è stato
vittima il bassista Mike Yaniro. Se il 12 pollici stava
precariamente in bilico tra
acre punk hardcore downtempo e rumore puro, con
il primo full-lenght, grazie al
prezioso lavoro di Ben Greenberg dei Pygmy Shrews, il suono s'ingrossa perdendo in atmosfera e guadagnandoci in impatto e irruenza.
Giulio Pasquali Ascoltando le sinuose linee di basso (Child Republic), i
clangori delle chitarre (Missing Person) o la marzialità metronomica (Landlord), il paragone con i Pissed Jeans può
Tracey Thorn - Love And Its
nascere spontaneo, eppure Seedbed non è un lavoro di
Opposite (Strange Feeling, Maggio
purificazione o una svolta, piuttosto rappresenta una ver2010)
sione più mirata e cinica dell’hardcore sudicio della band,
G enere : songwriting
Ci sono voluti quasi tre anni all’ex Everything But The in cui i rarissimi momenti di quiete (i droni subliminali di
Girl per dare alla luce un nuovo disco. Registrato tra Pigs At The Trough) e quelli turbati (Body Plan), ne fanno apLondra e Berlino, prodotto da Ewan Pearson e infar- prezzare ancor più l’incedere greve. I Twin Stumps sono
cito con collaborazioni d’eccellenza (tra cui la voce di autori di un hard blues-noise da ultimo giorno sulla TerJens Lekman, la chitarra e la batteria degli Hot Chip, ra.(6.9/10)
al secolo Al Doyle e Leo Taylor) l’album è una meditazioAndrea Napoli
ne diretta e senza peli sulla lingua sull’immaginario sentimentale della mezza età.
Tying Tiffany - Peoples Temple
La Thorn confessa sul suo blog che questo è uno dei di- (Trisol, Maggio 2010)
schi più acustici su cui ha lavorato. Come a dire che col G enere : dark electro cl ash
passare del tempo le macchine servono solo in fase di Tiffany prende di pancia le eredità Depeche Mode e le
post-produzione e ci si concentra più sui testi che su- buone intuizioni dei primi Crystal Castles nel suo velogli FX. Piano, chitarra e live drums per dei piccoli grandi cissimo terzo disco. Addestrata nella palestra Gomma e
quadri di un’esposizione su come la “middle age non sia sui palchi del post-electroclash, la ragazza se ne esce con
un periodo di rilassamento, anzi è più una zona di guerra”. dieci tracce di buon dark pop tagliato per la Kitten geneE quindi vai di divorzi, scazzi, depressioni e altre amenità ration. L’azzardo fuori tempo massimo rischia l’emulazione
over 50. Ma se la riflessione si fa dura, la voce riesce a plagiarista, ma dopo qualche ripetuto e piacevole ascolto,
cullare e a far passare tutte le tensioni.
si capisce come il genere sia ancora ad uso e consumo
Tracey ha ancora voglia di esprimere il soul che in una di una nicchia selezionata che può contare su personaggi
carriera più che decennale le ha fatto meritare il rispetto di fiducia. Tying furbescamente piazza il dark sulle distorda chanteuse sinuosa (stupenda la piano ballad in free sioni vocali (3 Circle), non sfigura con le cavalcate che
downloading Oh, The Divorces!), folk rocker indispettita ricordano il rock dei Garbage tagliato Bowie (One Bre(Hormones), bohemien wave epifanica (Kentish Town) e ath) e riporta tutto ai nostri giorni sulla linea delle Yeah
blueswoman west-morriconiana (Come On Home To Me). Yeah Yeahs e delle post-rrriot più commerciali (Still In My
Adult, sì, ma che voce, Tracey.(7.2/10)
Head). Un discone per i teen emo dark (Cecille) e per i
Marco Braggion darkettoni con l'immancabile cerone bianco (Border Line).
Solo per aficionados, ma comunque ben fatto.(6.5/10)
Marco Braggion
77
highlight
Walls - Walls (Kompakt, Aprile
2010)
G enere : A mbient , noise chill
Villagers - Becoming A Jackal (Domino, Maggio 2010)
G enere : songwriting , chamber
La personalità non difetta di certo al dublinese Conor J. O’Brien, titolare
del progetto Villagers arrivato ora all’esordio su Domino con Becoming
A Jackal. Deus ex machina del progetto e nome che circola da un anno e
mezzo almeno con alcuni singoli ed EP all’attivo, il Nostro è titolare di un
songwriting di matrice classica, che si abbevera alle fonti consuete dei Bob
Dylan, Neil Young e Simon e Garfunkel per molte soluzioni armoniche;
ne rinnova poi la tradizione, innestandosi su una scena, che ha visto negli ultimi anni la stella di Conor Oberst - Bright Eyes, e parallelamente quella
di Micah P. Hinson e Eugene Mc Guinness, non dimenticando l’intensità
di un Eliott Smith di cui Conor peraltro è fan.
Becoming A Jackal ha il suo valore aggiunto nella matrice chamber che non è secondaria, anzi, contribuendo alla costruzione di un pop talora sinfonico, intimistico e malinconico il giusto. Che non si esaurisce
in questo, presentando variazioni e inquietudini tipiche di un disco di formazione qual è quest’esordio,
incentrato non a caso sul crescere ed evolversi. Sensibilità e mood che avvicinano Conor ai soliti Robert
Wyatt e Scott Walker, ma anche ai più recenti Divine Comedy e Owen Pallett.
Il nostro plauso va allora al progetto Villagers per essere riuscito ad unire intensità emotiva ed espressività, personalità e sintesi in un album riuscito.(7.4/10)
Teresa Greco
Ulaan Khol - III (Soft Abuse, Aprile
2010)
G enere : giutar solo
Unbunny - Moon Food (Affairs Of
the Heart, Maggio 2010)
G enere : folk rock
Terzo e conclusivo episodio per Steven R. Smith sotto
le mentite spoglie del moniker Ulaan Khol. L’episodio
numero III della trilogia Ceremony accentua ancor di più
il solipsistico procedere heavy-psych a base di riverberi,
echi, feedback e distorsioni che caratterizza il progetto,
presentandosi come l’anello più duro e a tratti incompromissorio dell’intera trilogia.
Convivono anime diverse e apparentemente inconciliabili nelle 8 tracce untitled che, come da costume, sono da
intendersi come movimenti più che come veri e propri
pezzi a sé stanti: dilatazioni doom e introspezioni eteree di matrice folk, aperture heavy-rock reminiscenti la
kosmische più materica e deadmaniani solo di chitarra
riverberata. A caratterizzare Ulaan Khol è però il mantenere sempre vivo un taglio rurale, primitivista, di ovvia
ascendenza Jewelled Antler Collective, insieme mistico-spirituale e rumoroso ma depurato da ogni manifestazione urbana o industriale. L’intera trilogia è disponibile anche in edizione limitata in box di betulla, perciò
affrettarsi è d’obbligo.(7/10)
Già un pugno di album per etichette ruspanti e sparse, e
adesso questo Moon Food che celebra il quindicesimo
anno di attività per Unbunny, band dietro cui opera
l'attività di songwriter di Jarid del Deo. Tutto un estro
folk-rock sbilanciato sixties (l'enfasi acida, il trasporto fideistico) mantecato in un disincanto magico di quelli che
Linkous buonanima ci distillava capolavori, coi germi del
power pop ad illanguidire i contorni.
In queste dieci tracce per poco più di mezz'ora assistiamo perciò ad un gradevolissimo teatrino di situazioni
melodiche che se non sembrano avere la forza per affondare il colpo riescono però a blandirti con garbo e
arguzia. Un placido caleidoscopio dove scorgi i Birds
tra fregole country e fervore religioso (Young Men Are
Easy Prey), vivide cartoline Neil Young e raccomandate elettriche CSN&Y (Whispers), palesi tracce - appunto - Sparklehorse (Winning Streak, Landslide) e un
impasto indefinibile di umori Lennon e Grandaddy (la
splendida February Secret). Un piccolo disco da tenere
caro.(7.1/10)
Stefano Pifferi
Stefano Solventi
78
I Fuck Buttons, in quel mix di cosmica '70 e noise, nu
rave e new age, felpe con il cappuccio e sneakers sono
stati i capostipiti di quel che abbiamo chiamato digital
shoegaze segnando l'immaginario di una piccola generazione allo stesso modo di quanto ha fatto (e sta facendo)
il movimento glo fi e la stonata voglia d'evasione che lo
alimenta.
Sulla falsariga di tutto questo germogliano piante e fiori dai profumi particolarissimi, il mese scorso abbiamo
scoperto i Gayngs e la loro internazionale downtempo, ed ora tocca ai Walls, altro combo dai sintetismi (e
dall'elettroacustica) svagati, dalle coordinate non necessariamente coerenti, eppure con il fuoco giusto dove doveva stare in una formula tra le più fresche e now on che
ci potevano essere.
Il duo composto da Sam Willis (ALLEZ-ALLEZ) e Alessio Natalizia (Banjo Or Freakout ma soprattutto Disco Drive), dopo essersi fatto conoscere per i remix di
Pantha du Prince e The Field, partendo proprio dalle
escrescenze del suono di quest'ultimi, girano la chiave
giusta, quella che tutti avevano davanti agli occhi ma che
nessuno ancora aveva avuto l'intuizione d'utilizzare: svoltare chill out i Fuck Buttons e farne una versione balearic. Era la mossa perfetta, soprattutto se ad alimentare
l'idea dietro il progetto c'è stata una mano ferma nel
dosare misticanza psych, disinvoltura post-tutto e un pizzico d'antico spirito punk.
Disco di culto Walls, umile ed efficacissimo pure nel
gestire l'immaginario, spingendo magari i venti artici di
Pantha sopra i campfire pastorali di certi Animal Collective, oppure facendogli calare gli ufo dei Boards Of
Canada (Austerlitz Wide Open); il tutto servito a caldo e
senza farsi mancare la voglia d'estate e di sabotaggio (la
techno poverissima di A Virus Waits).
Se lo volete è come nei primi Novanta: di sera le chimiche dance di James Holden, Pantha Du Prince,
Four Tet e The Field e quando il sole sale tutti in spiaggia con The Walls.(7.1/10)
Edoardo Bridda
Weasel Walter Septet - Invasion
(ugExplode, Marzo 2010)
G enere : F ree -J azz /P unk
Weasel Walter non è di certo uno a cui piaccia starsene con le mani in mano. Finiti i fasti Now! Wave di una
Chicago ormai in declino, si è spostato ad Oakland. Lì
ha continuato a pubblicare dischi a nome Flying Luttenbachers fino a dismettere la ragione sociale nel
2007, sempre senza mai smettere di intraprendere nuovi
progetti e collaborazioni (Burmese, Lake Of Dracula, Lair Of The Minotaur, To Live And To Shave In
LA...) e di occuparsi della sua etichetta UgExplode. Per
ultimo, avendo esaurito tutto quello che la California
potesse dargli, dallo scorso 2009, si è trasferito a New
York dove suona come nuovo batterista nella band progdeath Behold...The Arctopus.
Come se non bastasse, parallelamente alla sua carriera
rumorosa ed iconoclastica, da qualche anno a nome Weasel Walter sono stati pubblicati anche diversi album che
lo vedono a fianco di figure
di spicco dell'avanguardia
jazz. Gianni Gebbia, Paul
Flaherty sono solo alcuni dei nomi che troviamo
nelle miscele esplosive di
jazz-punk di Apocalyptik
Paranoia, Particles, Lichens
o altri dischi.
Uscito per la solita UgExplode a nome Weasel Walter
Septet, l'ultimo Invasion si avvale della collaborazione tra
gli altri, del chitarrista Herry Kaiser e del contrabbassista John Lindberg, entrambi attivi come improvvisatori
free sin dagli anni '70. Ma pensare che la presenza di personaggi del genere intimorisca Weasel, significa non aver
ben colto il personaggio. “Il mio credo oggi è di spingere i
musicisti con cui suono sempre un po' oltre a quello di cui sono
abituati” dichiara in un intervista per AllAboutJazz. E nei
70 minuti di Invasion infatti, raramente capita di tirare
il fiato. Le percussioni di Weasel, in coppia con William
Winant, spingono fino in fondo l'acceleratore, costringendo gli altri musicisti a fronteggiare velocità insolite
per il jazz. Ed in questa situazione si susseguono le frenetiche scale della tromba di Liz Allbee o del sax di Vinny Golia, gli spunti atonali sharrockiani della chitarra di
Kaiser, come le sfuriate del contrabbasso di Lindberg e
di Damon Smith. Trame fittissime, abbaglianti, con tante diverse personalità in gioco da generare una creatura pluri-schizofrenica. Non si finirebbe mai di sviscerare
ogni aspetto nel dettaglio, ognuno dei sette componenti
apporta le sue particolarissimi caratteristiche.
Ma è il risultato complessivo a fare la differenza, come
una reazione esotermica, la musica sprigiona calore,
energia. E se si dovesse trovare un tratto comune, è proprio l'energia l'elemento ricorrente in tutte le produzioni di Weasel Walter. Più che un musicista, un Re Mida
della velocità.(7.1/10)
Leonardo Amico
79
Woodpigeon - Die Stadt Muzikanten
(End Of The Road Records , Giugno
2010)
G enere : indie country
Da Calgary, Canada, al crocevia tra memoria e moderna
composizione indie. Il collettivo Woodpigeon capitanato
da Mark Andrew taglia il traguardo del terzo disco mostrandosi ancora una volta combo tradizionalista dai tratti peculiari. Oltre che nei fraseggi strumentali e nell’uso
delle vocals (in comproprietà tra lo stesso Andrew e le
donzelle del progetto), nella musica dei canadesi batte un
cuore folky, un'alchimia agreste che, alla pari dell’influenza dichiarata Fairport Convention, rimanda al lavoro
di Gram Parsons in combutta con Emmylou Harris
(Morningside, Enchantee Janvier e Redbeard ).
Suonano come degli hippy svagati in gita fuori porta i
Woodpigeon, armoniosi (otto elementi, più una mini orchestra che il classico gruppo rock) e coraggiosi nel viziare la storia con elementi "altri" senza offenderne l’originaria lettera (Spirehouse tra ottoni, archi e vibrafoni,
somiglia tanto a degli Efterklang in licenza folk; oppure
nella delicatissima e onirica Our Love Is As Tall As The Calgary Tower affidata a celesti violini e chitarre pizzicate).
Esistono due versioni di Die Stadt Muzikanten, la presente marchiata End Of The Road Records e una per
Boompa che al disco accorpa un ep registrato con Steve
Albini.(7/10)
Gianni Avella
Woods - At Echo Lake (Woodsist,
Maggio 2010)
G enere : lo - fi pop
E così mentre i Woods sportivi non sembrano imbroccarne una che sia una, i Woods musicisti trovano la
proverbiale quadratura del cerchio. Quella quadratura,
senza troppi giri di parole, ha un nome e un luogo ben
definiti: Jerry Garcìa e la west coast. È infatti dall’altra
parte degli States che Jeremy Earl, band-leader oltre che
fondatore e unico responsabile di Woodsist, ha definitivamente spostato il cuore dei suoi Woods, alla ricerca
della melodia lo-fi perfetta.
Quelle di At Echo Lake sono infatti piccole gemme,
tratteggiate in bucolici quadretti sonori abbozzati in forma-canzone, che rimandano ad un immaginario ultranoto
come quello della summer of love, delle coste assolate e
un po’ malinconiche della California, delle droghe leggere smazzate al tramonto. Pulite le asperità e le dissonanze dei precedenti album, At Echo Lake si offre nitido
e sobrio in uno scintillio lo-fi di sixties-pop adattato al
mondo indie dei ’90, risultando a tratti accecante nella
sua perfetta semplicità. Cristallino è uno degli aggettivi
80
che vengono in mente ciondolando la testa all’ascolto di
Blood Dries Darker o Suffering Season, semplici e deliziose
pop-songs cantate in punta d’ugola da Earl. La sua voce,
infatti, è uno degli elementi portanti dell’album: un “ibrido tra Jad Fair, Jonathan Richman e Neil Young” secondo
la definizione dell’etichetta che ci sentiamo pienamente
di appoggiare.
Cattura di brutto, mr. Woodsist, senza strafare e senza mai andare sopra le righe, ma risultando irresistibile
mentre infila, una dietro l'altra, trame melodiche da urlo.
E se lo conoscevamo come leader di una band weirdlo-fi pop e come scopritore di talenti underground, ora
possiamo dire di conoscerlo e apprezzarlo pienamente
anche come cantante.(7/10)
Stefano Pifferi
Wounded Lion - Wounded Lion (In
The Red Records, Aprile 2010)
G enere : G arage R ock
L.A. da sempre ha la reputazione di città violenta, dove
gli eccessi delle star e la brutalità della polizia e delle
gang riempiono le strade, le pagine della cronaca e spesso anche i dischi. Risulta così piuttosto strano che da
lì venga un gruppo come
i Wounded Lion, quintetto al primo album su In
the Red dopo l’aggiunta di
Monty Buckles dei Lamps
dietro le pelli.
Ritroviamo un pizzico della
furia ritardata del gruppo
di Monty in questi solchi
(Carol Cloud), anche se a caratterizzare maggiormente
l’omonimo debutto sono filastrocche demenziali e ballate strampalate assai più ironiche che aggressive (I Think
It’s Hungry, che saccheggia a man bassa Velvet e Gories,
e i coretti ilari alla Television Personalities di Belt Of
Orion). Il gruppo di Dan Treacy viene alla memoria anche
per i testi naif e surrelai in cui i WL cantano di strane
creature amichevoli ed improbabili casi umani.
Wounded Lion è per il resto un divertente garagepunk dai toni ora circensi (Black Sox, Degobah System)
ora beffardi (Silver People), che, se non aggiunge nulla di
nuovo alla tavolozza del genere, di certo è una salubre
ventata d’aria fresca, utile per l'arrivo imminente della
calura.
(7/10)
Andrea Napoli
Year Of No Light - Ausserwelt
(Conspiracy Records, Aprile 2010)
G enere : P ost -R ock /S ludge
Un lieve feedback tenuto per un paio di secondi e subito
l'aria si riempie del suono delle chitarre elettriche. Denso, compatto, come solo una nutrita line-up, con 4 elementi a percuotere corde, riesce a creare. Un suono che
non è destinato a caratterizzare tutto il corso dell'album,
ma che di sicuro imprime la sua carica a più riprese. Una
materica zavorra per riportare il peso della realtà quando la foschia onirica dei riverberi prende il sopravvento,
in un dualismo sonico che è tratto peculiare dei Year
Of No Light.
Ausserwelt è il secondo disco della band francese, dopo
Nord, uscito per Crucial Blast, e una manciata di split
e partecipazioni a compilation. E nonostante scrivano
"shoegaze" tra i generi praticati, la loro musica sembra
semmai un post-rock in drop-tuning. Più un incrocio tra i
tribalismi di casa Neurosis e le andature progressive dei
Godspeed You! Black Emperor che le effusioni di rumore di My Bloody Valentine, neppure nella versione
rivisitata metal di Jesu.
I saliscendi, pregni di un emotività malinconica, vengono
sospinti da ritmi incalzanti, con due batterie a raddoppiarne l'intensità, mentre le chitarre tingono lo spettro
di un caleidoscopio di suoni, ognuna a sovrapporre uno
strato diverso all'intensa tela musicale. Non sarà lo stato dell'arte del genere, ma probabilmente a Year Of No
Light non interessa nemmeno.(6.8/10)
Leonardo Amico
Zero Centigrade - I'm not like you
(Twilight Luggage, Marzo 2010)
G enere : A vant -F olk
Il limite di certe sonorità avant sta nel superarsi ostentatamente ed ostinatamente, senza bastarsi mai. Proiettarsi
in avanti, raggiungere il rush senza più un corpo, un'idea,
per il fatto di non avere abbastanza fiato nè fiuto per
guardarsi indietro. L'avant-folk dei Zero Centigrade
fortunatamente non ne risente affatto: mantiene nelle
proiezioni un saldo appoggio all'origine più oscura che ci
sia, il blues dei primi tempi - passato per l'azzeramento
totale, il riduzionismo, il limite, il microsuono, l'atonalità.
Vincenzo De Luce e Tonino Taiuti (l'uno architetto, l'altro
artista, attore teatrale, pittore), adescando qua e là linee
percorribili, tornando alla musica cotoniera e con solo
due strumenti (chitarra acustica e tromba), suonano
come se fossero nella giungla amazzonica, oppure all'inizio (o alla fine) del mondo. Chitarra e tromba sembrano
due reperti fossili, due strumenti il cui difficile unisono
si collega al primitivismo informale con cui i due non-
musicisti tingono a piene mani. Griglie elettriche marcescenti fanno spola con diramazioni tessil-acustiche,
tutte briglie ordinate su distese di fiati, che fanno dei
beat (Dirty Times), claustrofobica presenza inquieta, tutta
centrata sull'assurdo minidrone ventilato e i coltelli di
chitarre. Sembra di stare in mezzo alle piantagioni, non
quelle del Mississipi, che sarebbero piaciute a Sleepy
John Estes, quanto piuttosto quelle del Delta velenoso,
fatto di liquami e piante carnivore, nero come la pelle di
un bluesman rapito dagli alieni.
A gettare catrame sulla costellazione infinita di macerie
più o meno liquide di chitarra e tromba è l'assenza totale
di effetti, macchine, mastering, missaggi vari - cosa che
spinge ancor più nella ricerca di una forma verace, inossidabile, taumaturgica.
Il disco, secondo di una serie che si spera essenziale
quanto i due primi episodi, è licenziato da Twilight Luggage, in formato cd-r oppure scaricabile e stampabile con
copertina. Più di così non si poteva proprio.(7.5/10)
Salvatore Borrelli
Zero In On - Silly Lilly
(Autoprodotto, Maggio 2010)
G enere : I ndie rock
Che ci fa un disco come questo tra le autoproduzioni?
Per trovare l'America non serve andarci davvero: basta
farci arrivare i dischi, a restituire gli stimoli che da lì e
dall'Inghilterra hanno colonizzato il mondo, Locarno
compresa, da dove vengono gli Zero In On.
Il trio italo-svizzero nelle terre del rock c'era però stato
davvero; dunque non si capisce come mai Silly Lilly non
sia pubblicato da chi di gruppi come loro ne ha sfornati a
decine, spesso peggiori. Il disco non sfigurerebbe nell'indie-rock odierno, quello
che rallenta i Green Day,
canta come Casablancas
e somiglia a mille altri, dai
Franz Ferdinand e dintorni: niente di eclatante
ma complessivamente una
buona disinvoltura, energia
e una produzione che ogni
tanto spara qualche finezza (il piano e i fiati miniati in
duetto su Los Angeles Is Burning, una Seargent Dylan Sand
che dopo la Intro psichedelica passa a fare ska come lo
farebbero i Beirut). Lo stomp della title track, poi, è una
freccia - MTV-proof - che non hanno proprio tutti in
faretra.(6.4/10)
Giulio Pasquali
81
— libri
Franco Battiato. Soprattutto il silenzio
A nnino L a P osta (G iunti , 2010)
Frank Zappa - Il Don Chisciotte elettrico
N eil S l aven (O doya , 2010)
Odoya si fa coraggio in un mercato allo stesso tempo desertico e inflazionatissimo e rimette in circolazione la traduzione di Electric Don Quixote di Neil Slaven, ponderosa biografia di Frank Zappa che aveva avuto una prima
edizione italiana nel 1997 per la misconosciuta Tarab. Operazione meritoria "a prescindere", data la scarsità di testi
in generale e di biografie in particolare dedicati a FZ: l'unica altra disponibile è infatti quella firmata da Barry Miles
uscita per Kowalski nel 2006. Per quanto simili nella struttura e nelle intenzioni (percorso rigidamente cronologico,
grande ricchezza di dettagli, volontà di proporsi come "libro definitivo") e per quanto pure quello di Miles citi tra
le sue fonti quello di Slaven (scritto quasi dieci anni prima), i due volumi hanno un taglio profondamente diverso,
risultando di fatto complemetari.
Sposiamo la lettura che del libro di Slaven fa il guru zappiano Ben Watson (guru controverso, si veda il suo The
Negative Dialectics of Poodle Play) in una affilatissima recensione su The Wire (n. 154, dicembre 1996): gli zappiani
conosceranno quasi tutto (ma, aggiungiamo noi, è proprio su quel
quasi che si coagula il maniacale interesse zappofilo) e i non iniziati
non riusciranno a leggervi una storia organica, con la sensazione
di trovarsi di fronte ad un collage, arido e frammentario. Se Miles
infatti esplicita spesso la propria lettura del fenomeno Zappa, da
studioso dell'underground USA quale è (e si può essere più o meno
d'accordo con quel che dice), Slaven (esperto di blues, produttore
discografico) si limita a riportare - con colore, sia chiaro - gli eventi, senza interpretarli (per quanto si possa leggere in filigrana una
insistita sottolineatura del ruolo del caso nelle vicende zappiane),
lasciando a giustificazione del titolo scelto - Zappa Don Chisciotte
rock in lotta contro i mulini a vento della cultura americana, ipocrita
e bigotta - giusto un paio di considerazioni incipitarie e conclusive.
Questo il grosso limite di fondo del testo. Andiamo adesso ai grossi
pregi di superficie.
Il libro scorre veloce nonostante le 400 pagine, ed è accuratissimo,
pieno di informazioni contestuali (fino alla pedanteria del gusto per
le trattazioni ab ovo, si veda l'iniziale descrizione della città di Baltimora), di dichiarazioni, interviste e recensioni (anche e soprattutto
negative, cosa questa assai interessante per una possibile "storia
della ricezione zappiana") tratte da pubblicazioni d'epoca (e addirittura da quotidiani locali), di analisi e commenti molto arguti su alcuni brani del repertorio zappiano (con annessa
la storia compositiva e le traversie discografiche). Si nota con un certo stupore il poco spazio riservato ad alcuni
musicisti/comprimari di prim'ordine: giusto due parole, per esempio, sul fondamentale Vinnie Colaiuta, il batterista
preferito di FZ. Venendo all'edizione Odoya, un dubbio sulla parte iconografica (assente nell'originale), spesso utile
perché esemplificativa, altre volte un po' spiazzante: va bene la copertina di Infidels di Bob Dylan, perché scopriamo che Zappa avrebbe dovuto produrlo; un po' meno la foto di Giorgio Moroder, al quale Zappa avrebbe voluto
affidare gli arrangiamenti di sintetizzatori del disco.
In sintesi, resta l'appetibilità contraddittoria del volume di Slaven, così come sintetizzata qui sopra, con la certezza
che a livello di informazioni, dati, date, cronologie, nomi, eccetera, si tratti in pratica di un reference book. Resta pure
la conferma che il libro definitivo su Zappa (checché ne dica Colin Larkin, il fondatore della Encyclopedia of Popular
Music, nella presentazione) non è ancora stato scritto. Per quello aspettiamo Gianfranco Salvatore.
Gabriele Marino
82
Compito non facile quello di delineare nel dettaglio la carriera di Franco Battiato. Nel corso di oltre quarant'anni
- esordio nel 1965 con il singolo L'amore è partito, inserito in un numero della Nuova Enigmistica Tascabile - il cantautore siciliano ha alternato, a volte mischiandoli tra loro, canzonette d'intrattenimento, musica sperimentale, classica
contemporanea, pop più o meno da classifica, musica sacra, collaborazioni eccellenti (Caterina Caselli, Alice, Milva, Giuni Russo), deviazioni world ed elettroniche, ultimamente anche cinema.
E' bravo dunque Annino La Posta in Soprattutto il silenzio a ripercorrerne la traiettoria con piglio entomologico, ricostruendola attraverso le parole dello stesso Battiato e una serie di esaurienti schede dedicate ad ogni
singolo disco pubblicato. La Posta non tralascia alcun dettaglio, dagli spostamenti geografici agli incontri, passando
per le collaborazioni e le produzioni per altri artisti anche sotto pseudonimo, e quel
che ne risulta alla fine è una cronologia in forma di narrazione ottima per muoversi nel
mare magnum - si pensi all'iperproduttività della prima metà degli anni ottanta - del
repertorio di Battiato.
Aneddoti e riferimenti culturali sono dosati e ben mischiati tra loro, quel che manca
invece è un apparato critico sufficiente ad accompagnare la narrazione. Ma forse l'intento dell'autore era quello di illustrare più che di criticare, e sarebbe interessante a
questo punto leggere un seguito di questo volume che proponga in modo più diffuso
- qui, seppur a sprazzi, qualche cosa si coglie - l'idea che La Posta, sicuramente competente in materia, ha di Battiato. Altro capitolo, quello di un'esegesi di un percorso
certamente variegato ma anche molto contraddittorio, che merita la stessa dose di
attenzione e approfondimento che in questo volume viene riservato soprattutto agli
aspetti biografici.
Luca Barachetti
Swordfishtrombones
D avid S may (N o R eply , 2010)
In uscita per i tipi di No Reply nella collana Tracks la bella traduzione di questo volumetto pubblicato in origine nel 2004 su Continuum.
Per analizzare Swordfishtrombones (1983), il disco che ha rappresentato l'inizio
di una svolta compositiva nella carriera di Tom Waits, il giornalista americano David Smay sceglie un trattamento spiazzante, rimescolando le carte di vita, carriera
e influenze del musicista californiano.
L'autore preferisce quindi non trattare la materia Waits in modo lineare e canonico,
ponendosi, con alcuni artifici letterari, perfettamente in linea con l'universo sbilenco
del musicista. Il disco in questione ha segnato a inizi Ottanta l'avvio di un periodo
assolutamente fervido per Waits, il quale nel 1982 si veniva a trovare contemporaneamente al verde, senza il controllo di quello che pubblicava e senza il manager Herb
Cohen, ma con dalla sua il fondamentale appoggio della moglie e collaboratrice artistica Kathleen Brennan; da qui partirà il periodo che sarebbe stato un importante
referente musicale da allora in poi fino alla nostra contemporaneità.
Giocando con il naturale istrionismo e la tendenza a celarsi mediaticamente del
Nostro, Smay imbandisce un mondo fervido di tracce e sottotesti da disco nel disco, ben condotto, orchestrato e
approfondito. Rivelando che preferisce in realtà il seguente Rain Dogs, il giornalista riesce a tracciare uno degli itinerari possibili alla guida del disco, collegando abilmente personaggi, canzoni e ambienti sparsi.
Swordfishtrombones è allora un volume che si legge agilmente, corredato da un' azzeccata postfazione di Dente.
Teresa Greco
83
— live report
John Zorn
A rena del S ole , B ologna (17 M aggio )
Ad Angelica 2010 John Zorn ha presentato Essential
Cinema: sonorizzazioni live on stage, in formazione con
la rodatissima Electric Masada (Ribot, Saft, Dunn, Baron,
Wollesen, Baptista, Mori, lui alla direzione e al sax), di
alcuni dei suoi cortometraggi avant preferiti.
Rose Hobart, di Joseph Cornell (1936), rimontaggio
condensato del film esotico East Of Borneo, enigmatico
monumento alla diva del titolo: immerso nel buio e sovrastato dallo schermo, l'ensemble ha sciorinato venti
minuti della più classica romantic Zorn exotica. Oz: The
Tin Woodman's Dream, di Harry Smith (1967; il musicologo della Anthology Of American Folk Music), corto di
animazione giocattoloso e psichedelico, ispirato al Mago
di Oz: l'accompagnamento musicale è stato qui opportunamente più elettronico e spigoloso; nel finale, con
suggestive immagini caleidoscopiche, tappeto tribale
dominato dagli intrecci Baron/Wollesen/Baptista. Aleph,
di Wallace Berman (1966), ipercinetico collage realizzato manipolando direttamente la pellicola, frammenti
di vita metropolitana spezzati da apparizioni improvvise
di simboli ebraici: grande botta freejazz in trio (batteria,
contrabbasso e sax), fluviale tostissima improvvisazione
colemaniana. Ritual In Transfigured Time, di Maya Deren
(1946; una delle grandi passioni di Zorn), onirico rituale
danzante che racconta la maturazione di una donna e la
sua fuga dai propri desideri: intro di contrabbasso, motivetto minimal in 5/4, romantic Zorn. Collage #36 (1953),
ancora di Cornell, corto di ambientazione naturalistica,
"protagonista" un procione: sotto la solita palla romantic, Ikue Mori fa cinguettare il suo laptop mentre sullo
schermo si vedono degli uccellini.
Pubblico entusiasta e letteralmente scalpitante, per
cui seguono tre lunghi bis a luci accese, che durano quasi quanto le proiezioni, per un totale di due ore: Little
Bittern da O'o (2009), uno dei pezzi più morbidamente
rock del catalogo zorniano; una versione superveloce di
Hath-Arob dal primissimo repertorio Masada, giostrata
con la classica conduction impro/rumorosa; un pezzo di
morbida fusion con Zorn al sax, finale con lunghi assolo (Joey Baron e un Marc Ribot davvero sempre
84
troppo uguale a se stesso). Una buona sonorizzazione,
soprattutto quando lo spartito ha rinunciato alla sincronizzazione punto per punto e si è tenuto lontano dalle
sottolineature effettistiche (la Mori con gli uccellini), ma
performance che troppo spesso ha visto JZ & Co. mettere il pilota automatico e perdersi senza troppi sforzi in
quel trip post-The Gift che va avanti da tutto il 2009.Tre
bei momenti: l'elettronica su Harry Smith, la sfuriata free
e la conduction del bis. Zorn non butta via niente, forte
della qualità intrinseca della proposta e dei musicisti con
cui lavora, forte soprattutto di un culto che lo avvolge e
che non lo farà mai stancare del pubblico che "applaude
per il motivo sbagliato".
Il programma prevedeva anche - e soprattutto, visto
che il concerto rientrava nell'ambito del progetto JeanLuc Godard: compositore di cinema? - la prima mondiale
dello spot realizzato dal regista francese per la Nike
(1989) e mai utilizzato. La proiezione non c'è stata e nessuno è parso accorgersene e lamentarsene. Il parallelo
Zorn-Godard è illuminante, non solo perché il regista
rappresenta una grande fonte di ispirazione per il nostro (vedere Godard, 1986), con la sua concezione antiromantica del lavoro dell'artista (opera sovraindivuale e
"centro aggregatore di citazioni"), ma anche perché entrambi hanno fatto del proprio iniziale radicalismo avanguardista una forma manierata e altamente stereotipata.
Gabriele Marino
The Residents
E stragon , B ologna (14 M aggio )
Non era così scontato che il nuovo show di uno dei
gruppi più amati della wave mondiale di sempre fosse
così deludente. Gli album certamente lo sono stati, almeno a partire da quelli post-Wormwood, eppure i loro
show, così pieni di tutto e perciò totali, hanno sempre
catturato l’immaginario e l’attenzione, rappresentando
di fatto la vera novità che il combo di volta in volta proponeva al mondo.
L’ultimo che mi è capitato di vedere riguardava la performance live della loro filmografia storica (Icky Flix) e
per l’occasione, al Teatro delle Celebrazioni di Bologna
nel 2002, i quattro occhiuti avevano imbastito un sceno-
grafia di tutto rispetto: colori al fosforo, gabbie Mad Max
e un bel maxischermo azionabile con telecomando che
Mr Skull, accompagnato dal fedele membro aggiunto Molly Harvey, azionava a piacere testimoniando di una band
tutt’altro che stanca. Anzi, i Residents, se hanno avuto
un problema, discograficamente parlando, era proprio
quello di non sapersi più fermare. Irrefrenabili, nell’era
di Internet, hanno sfornato un quantitativo di materiale paragonabile ai loro periodi più fervidi, abbassando la
qualità media delle produzioni "adulte" Ottanta/Novanta
e accentuando, da un lato, una senescenza basata sul ripetere all’infinito se stessi in versione collagista à la Duck
Stab (Animal Lover, Tweedles, Bunny Boy) e dall’altro
cercando nella narrazione una via di salvezza.
Proprio su quest’ultimo punto s’inserisce la traiettoria che dal drammatico Demons Dance Alone (che
rantolava nel buio dopo il nine eleven) ci porta a Talking
Light, anch’essa opera teatrale esclusivamente basata sui
testi (e i gesti) del cantante - non più col teschio - vestito
come un mix tra Elephant Man e lo scienziato pazzo in
pigiama (come è accaduto in quest’ultima performance).
Emblematico che lo spettacolo al quale abbiamo assistito non sia stato preceduto da una pubblicazione in cd.
C’è una versione ultra limitata e soltanto strumentale,
ma non l’album con ragioni presto chiare nell’ora scarsa
di durata.
Lo show, musicalmente, è stato un ronzare wave (soli
synth e chitarra) di puro accompagnamento alle storie
di fantasmi raccontate dal performer e da alcune ospiti
(non presenti) azionate a schermo. Ma il dato più doloroso è l’assenza del quarto Rez che, a detta di un ironico
Skull, se n'era uscito dal rock’n’roll way of life per occuparsi
della madre in Messico (!?). Di Karl i superstiti ci rivelano
soltanto il nome, non menzionandone l’importante ruolo. Lui era il percussionista. Ringo Starfish, come si legge
nelle note di Meet The Residents, e mancando lui, una
Semolina proveniente dal citato Duck Stab non è proprio la stessa, così come una seconda parte dello show,
incentrata sul loro recente passato, non ha sollevato le
sorti di una serata piuttosto noiosa, con storie di fantasmi un po’ senili di cui soltanto qualcuna degna del loro
tocco sarcastico-surreale.
Unico momento intenso, la ripresa della vena catastrofica di fine Ottanta, quando si erano cimentati nel
revisionare la storia della musica contemporanea (e c'era
da sbellicarsi dalle risate). Anche in quel periodo avevano intrapreso concept a tema piuttosto focalizzati (Cube
E) ma mai come ora la stanchezza del combo è evidente.
Edoardo Bridda
?Alos, Void Ov Voices
S pazio S pettacoli S an P ietro
T orino (14 M aggio )
in
V incoli ,
Inserito tra gli eventi Salone Off del ventitreesimo Salone del Libro di Torino e organizzato dalla compagnia Il
Mutamento Zona Castalia, il mini-festival Il Tempo del
Tempo che si può fermare offre cinque giorni di teatro
sperimentale e musica all'interno del suggestivo scenario
dell'ex cimitero di San Pietro in Vincoli – luogo assolutamente sconosciuto prima per chi, come il sottoscritto,
non è torinese. ?Alos e Void Ov Voices si dividono il
palco durante la seconda serata, per una doppia performance che potrebbe essere presa a modello di ciò che è
meglio fare o non fare quando l'obiettivo è la sperimentazione.
Al di là infatti di ogni estesa e necessaria riflessione
sul significato del termine oggi, è la credibilità il concettocardine attorno a cui girano esperienze come quelle in
programma. Discrimine in positivo per Stefania Pedretti che nella sua performance lunga il giusto (non più di
mezz'ora) si alterna fra elettrica e corpo, talvolta con
l'aiuto di alcuni scampoli preregistrati, e ripercorre quelli
che sembrano i nodi fondamentali di una ricerca fino ad
oggi proficua nei risultati e mai fine a se stessa. La prima parte la vede alla prese con la chitarra, da cui ricava
bordoni tellurici tutt'altro che casuali, sui quali s'innalza il
solito cantato preverbale ricco di sussurri e grida uterine
come di momenti di autentico noise vocale. Nella seconda parte invece è lei stessa a far vibrare, grazie ad una
serie di movimenti corporali assai prossimi alla danza, dei
campanellini e altri ammennicoli sonori appesi sui lunghi dreadlocks e sulle mani. L'effetto è quello prenatale e
onirico di una primigenia apertura al mondo, ma continua
una ritualità che dall'iniziale condivisione di una scodella
di vino con i presenti termina in un'accennata figura a
uovo, possibile confine – azzardiamo – da cui ripartire
verso altre esperienze già in atto. E soprattutto chiude
l'immersione in una performance nella quale femminilità,
subconscio, ancestralità e catarsi sono un tutt'uno, segnale distintivo di un percorso ostico ma estremamente
comunicativo qualora si sia disposti ad accettarne i presupposti.
Di tutt'altra misura invece l'esibizione di Attila Csihar
dei redivivi Mayhem, qui alla prese con un progetto che
vorrebbe mettere al centro dell'attenzione la voce se al
contrario non scadesse in un siparietto a dir poco stucchevole. Riempita la sala di un fumo sepolcrale alla vista
ma dolciastro all'olfatto – è lo stesso che usavano i Pooh
ai bei tempi – l'ungherese si presenta bardato di cappuccio e mantello tipo Darth Vader con tanto di teschietto
e cerini d'ordinanza. Non ci sarebbe nulla di male se poi
85
Brian Jonestown Massacre
?Alos
non avviasse un brano dalla durata interminabile dove
la sovrapposizione di loop vocali è solamente accessoria
alla mera prova di forza della voce del titolare stesso, il
quale pare lanciare chissà quali strali mortiferi, ma tanto
parlando in ungherese nessuno lo capisce. Il sottoscritto
resiste una ventina di minuti e poi se ne va. A dire il vero
con l'amaro in bocca, perché come parodia del prode
Anakin passato al Lato Oscuro della Forza Csihar non fa
neanche tanto ridere. Qualcuno glielo dica.
Luca Barachetti
Liars
I nit , R oma (13 M aggio )
C’è il pubblico delle grandi occasioni per il ritorno
dei Liars all’Init ma l’inusuale calca all’ingresso dimostra
anche che ormai il terzetto americano ha definitivamente
acquisito lo status di band di prim’ordine.
Ad aprire la serata sono i Fol Chen, quartetto californiano sulla bocca di molti ma che in realtà sembra
mostrare la corda sin da subito. Con una miscela piuttosto banale di indie schizzato, wave bislacca, post-punk che
vira spesso verso il p-funk con solito scambio vorticoso
86
di strumenti e ruoli e una voce in falsetto che è a dir
poco fastidiosa, i quattro non riescono minimamente a
evitare la noia già dopo qualche canzone. Ce ne ricorderemo soprattutto per l’affascinante tastierista.
I Liars si affacciano sul palco poco più tardi e in formazione allargata, con due membri del gruppo spalla a
suonare seconda chitarra e basso. Fatto quest’ultimo
non trascurabile, dato che libera Angus Andrew da incombenze strumentali permettendogli di agire da vero
e proprio frontman. È lì, infatti, il centro nevralgico dello
show, nella figura allampanata e incendiaria del cantante
completamente vestito di nero, al centro del palco, pronto a catalizzare su di sé l’attenzione del pubblico mentre
mette in scena una pantomima continua, tra il buffonesco
e il demenziale, si dimena, prova passi di ballo piuttosto
improbabili, s’improvvisa sensuale e ammiccante tra pose
spastiche e retrò.
Tutto intorno, composti e apparentemente distaccati,
i degni compari storici Julian Gross e Aaron Hemphill e i
due occasionali, ci danno giù saccheggiando il nuovo Sisterworld, così come i classici dei primi dischi, A Visit From
Drum e We Fenced Other Gardens... su tutte. La perizia
strumentale è ormai stranota, così come l’affiatamento
e l’interplay che permette di piegare i pezzi in versioni
più ampie, diversificate e free quasi preferibili alle registrazioni affidate al disco. Quando poi i tre, e solo loro,
si ripresentano sul palco per il bis, esce tutta la malattia
che da sempre ne contraddistingue la produzione musicale: Be Quiet Mr. Heart Attack! e Broken Witch ci lasciano
sempre più esterrefatti di fronte ad una band più che
mai sorprendente, pienamente padrona del palco, matura
verrebbe da dire se non ci fosse sempre lui, Angus Andrew con quella sua aria gigionesca a dissacrare quello
che i suoi compari architettano. Lunga vita ai bugiardi.
rare con quale efficacia questa musica - interpretazione
sincretica di 45 anni di psichedelia dalla California al Texas, passando per astrattezze shoegaze, minimalismi alla
Velvet Underground, policromie folk-rock e parafrasi
Spacemen 3 - sia stata baciata da successo nelle mani
sapienti degli Warlocks e in quelle più ruffiane di Black
Rebel Motorcycle Club, i cui membri hanno parzialmente militato nelle fila dei Brian Jonestown Massacre.
Ennesima prova della preziosa funzione di Newcombe, esperto della materia e anticipatore, in tempi in cui
tutti bollavano la cosa come nostalgia da retrogradi, di
uno stile efficace e robusto, ben più cangiante di quanto
Stefano Pifferi frettolosi o inesperti possano sostenere. Non da tutti, infatti, stipare il palco con otto elementi (la metà chitarristi:
roba da ricordare i Plan 9…) smorzando la seriosità con
Brian Jonestown Massacre
lo stralunato percussionista ballerino Joel Gion (apparso
C ovo , B ologna (1° M aggio )
E’ in un Covo stracolmo che - da italiani decentrati ri- in un episodio della serie televisiva Gilmore Girls!); cedespetto al mondo anglofono - capiamo finalmente quanto re spesso il microfono al sodale di lunga data - col quale
Anton Newcombe sia uno degli ultimi “artisti di culto”. parrebbe essersi riappacificato - Matt Hollywood e caDel tipo come lo intendevamo prima di internet e della tapultare sin dal primo minuto gli astanti in un esaltante
sovrapproduzione discografica, però, capace di chiamare trip. E, soprattutto, permetterselo rinunciando all’elettrogente da ogni dove in un giorno festivo e, lungo due ore nica degli ultimi lavori in studio, viceversa affidandosi alla
e passa di concerto, far più volte letteralmente esultare componente “classica” del proprio stile, attingendo spesso e volentieri da album come Strung Out In Heaven.
la platea agli attacchi dei brani più amati.
Quelli eretti su incroci di corde e distorsioni calibrate,
Alla base di ciò trovi la robustezza di un ideale “indipendente” nel senso pieno dell’aggettivo: la testardaggine su ritmica ipnotica e ponteggi d’organo. Come si faceva
di chi poteva avere il clamore planetario (breve: chi se una volta, non fosse che dalla mistura sale un inebriante
li fila più, i suoi ex amici Dandy Warhols?) e vi ha ri- profumo di attualità.Tale da persuadere che, ribaltando la
nunciato, preferendo un’integrità rara pur con le tipiche filosofia di Tricky, “retro is brand new”.
idiosincrasie da genio maledetto che guarda ai fab Sixties
Giancarlo Turra
e al loro spirito senza sterile revivalismo. Basta conside87
Gimme Some
Inches #6
Il Record Store Day è la mecca per appassionati e collezionisti di vinili. Questo
mese facciamo un piccolo resoconto
delle molte uscite limited di Moon Duo,
Wooden Shjips, Male Bonding, Dum
Dum Girls.
Il mese scorso è stato il mese
del Record Store Day, iniziativa encomiabile che vede coordinarsi bands, etichette, distributori, insomma,
tutta la filiera musicale alternativa
per celebrare i negozi di dischi. Non
quelli virtuali, asettici e smaterializzati, ma quelli fisici: piccoli, bui, sporchi
e puzzolenti spazi di ricreazione per
chi ama ancora toccare con mano
l’oggetto fisico prima di goderne le
prelibatezze incise, e che a loro volta allungano gli orari di apertura, si
trasformano in venues improvvisate,
propongono sconti e offerte.
Ad ogni Record Store Day molti artisti, famosi e non, partecipano
con live show nei negozi o rilasciando piccole edizioni limited in onore
della ricorrenza. Usanze che da noi,
nonostante una buona partecipazione di negozi all’iniziativa, stentano
ancora a prendere piede; la speranza è che a breve diventi consuetu88
dine com’è nei paesi anglofoni. Nel
frattempo possiamo crogiolarci con
le piccole e grandi gemme targate
RSD: da mostri sacri come Beatles
(un 7” esclusivo con Paperback Writer e Rain) e Rolling Stones (Plundered My Soul, outtake da Exile On
Main Street) ai campioni del britpop Blur, anch’essi con l’inedita Fool’s Day, e via via giù fino a Built To
Spill, Yeah Yeah Yeahs, Editors,
Weezer, Goldfrapp e molti altri.
Titoli appetitosi che sono finiti da
subito su Ebay a prezzi da capogiro.
Molto probabilmente non farà la
stessa fine il 12” in vinile blu targato Devo. Introduttivi all’upcoming
Something For Everybody, prima
manifestazione dopo uno iato ventennale, i due pezzi sinceramente
non passeranno alla storia: Fresh
sul lato A e What We Do su quello
opposto vivono di un synth-pop
tronfio, pompato e parodico che
nulla o quasi eredita della passata storia del Mothersbaugh affaire.
Detto dei redivivi ma fiacchi Devo,
inabissiamoci nel sottobosco segnalando solo alcune tra le release più
underground, perché altrimenti non
basterebbe una monografia. Cominciamo dall’ottimo 7” split tra due
band emergenti che cortocircuitano
perfida Albione e States in nome del
sacro fuoco del lo-fi in modalità diy:
Dum Dum Girls e gli inglesi Male
Bonding. Quest’ultimi spappolano
una melodia che più lo-fi anni ’90
non si potrebbe sotto una coltre di
piatti ronzanti e giri di chitarra/basso
tanto elementari quanto irresistibili.
Appiccicume totale, tanto che ci si
ritrova a cantare anthem, dimentichi
della corazza di mille e mille ascolti.
Miss Dee Dee invece è una catapulta
a zero fronzoli che ci sbatte anch’essa al tappeto con lancio diretto nel
pieno universo Blondie: cassa dritta, circolarità strumentale, melodia
eterna per 2 minuti e mezzo di pura
estasi lo-fi pop.
Si va invece giù di turbinio psych
col 7” pubblicato da Permanent con
protagonisti due side-projects di altrettante interessanti band del sottobosco hard-psichedelico americano: i prolifici Moon Duo, costola
dei Wooden Shjips, e gli esordienti Bitchin’ Bajas, offshot dei Cave.
Ossessività brumosa, synthetica e
ritmicamente meccanica per i primi (Bopper’s Hat con splendida voce
4ADiana di Sanae Yamada), circolarità ascensionale infinita e priva di
ritmica per i secondi (Fresh Air), che
evidenziano come il minimalismo
di stampo rock abbia fatto breccia
nei cuori di molti giovani musicisti
americani. Non paghi, gli inarrestabili
Moon Duo hanno appena aggiunto
l’ennesimo piccolo tassello vinilico
alla propria discografia. Catch As
Catch Can esce per la neonata Agitated Records e ripropone il sound
apprezzato su Escape, spingendo
se possibile ancor di più sul versante ritmico alla Suicide (la title track)
e pagando pegno ai padrini The
Scientists (la cover stranita di Set
It On Fire): kraut-garage, se servisse
una definizione. E per non essere da
meno, anche il gruppo madre si fa
vivo: What It Is è il 7” tour edition
che celebra la conquista dell’estremo down under del mondo, Australia e Nuova Zelanda, da parte dei
losangelini Wooden Shjips senza
aggiungere né togliere nulla al mondo sonoro del quartetto.
Passando oltre, ecco alcune no-
vità prossime venture. Nuovo sideproject per un paio di membri dei
Teenage Panzerkorps a nome Horrid Red, al debutto su cassetta per
la giovanissima Campaign For Infinity (gestita da Brett dei Pink Noise,
tanto per rimarcare, qualora ce ne
fosse bisogno, la dimensione DIY di
queste operazioni). Se vi siete mai
chiesti come suonerebbe una versione ancora più minimale del gruppo tedesco-americano, eccovi la
risposta. Gli accordi vengono abbandonati in favore di riff ultra basilari,
la batteria sostituita da una drum
machine di soli cassa e rullante, l’atmosfera è creata dagli immancabili
synth liquidi che tanto ci piacciono.
Una decina di pezzi cantanti in tedesco che presto verranno riversati
su vinile dall’ormai iperattiva Holidays, e non a torto dato che, nel
momento in cui leggerete, i cinquanta esemplari della tape saranno già
sold out da tempo. Nuovo miniLP
anche per Kurt Vile, ormai stabilmente accasato presso Matador.
Nei sette brani che compongono
Square Shells, il ragazzo prodigio di
Philadelphia attenua i riverberi che
avevano areato le precedenti release per consegnarci una versione più
diretta e domestica di sé. Come già
accadeva per God Is Saying This To
You, è la lezione imperitura del folk
di Leonard Cohen ad aleggiare per i
solchi del vinile, alternata da un paio
di episodi più robusti ma sempre
intimi e sentiti, con la chitarra ora
pizzicata ora energica in pieno stile Vile. Tornando all’orticello di casa
nostra, i local heroes Movie Star
Junkies continuano la loro sfilza di
singoli nell’attesa del nuovo album in
uscita a Giugno. Per ora i torinesi ci
rimpinzano il gozzo con due nuovi 7
pollici: il primo esce per la francese
Kizmiaz e propone, manco a dirlo,
due pezzi in lingua d’oltralpe, tra cui
la cover di Requiem Pour Un Con di
Serge Gainsbourg. Il secondo invece è ora nelle mani dell’americana
Rococo e dovrebbe vedere presto
la luce; conterrà un inedito ed una
versione alternativa di un brano già
presente su Melville.
Stefano Pifferi, Andrea Napoli
89
Re-Boot
M isticanza
#5
di mezza
primavera
Folk, blues, funk, electro, cantautorato, pop, stoner, math, post,
psych... Il setaccio che mensilmente
immergiamo nel calderone del rock
emergente nostrano ci restituisce
pietruzze più o meno grezze, più o
meno preziose, soprattutto diversissime per natura e intenzioni. Una
vera e propria misticanza a base
di gustosi germogli in diretta dallo
schizofrenico orticello sotto casa.
Andiamo a incominciare.
Se c'è qualcosa oggi che unisce
i Perturbazione e i Thee Silver
Mt. Zion sta nei veneziani manzOni. Gli ex Maladives, stella dei primi
anni zero mai del tutto illuminatasi,
tornano con un demo (Autoprodotto, 7.8/10) dove la voce del cinquantasettenne Gigi Tenca – cadente e
incantata come quella di Tommaso
Cerasuolo – declama-canta l'intimismo di un Piero Ciampi attraversato dal nulla metafisico della
più densa provincia italiana, mentre
i compagni d'avventura spargono
mantra elettrici GY!BE che s'accumulano scarni prima di esplodere in
90
Un mese di ascolti
emergenti italiani
campi bianchi senza rumore. L'esordio ufficiale dovrebbe giungere entro la fine dell'anno, lo attendiamo
trepidanti: “e scrivo / …di campi di
colza che non hanno bisogno di dio per
essere così gialli!”.
Non di esordio ma di secondo
disco si tratta nel caso di Jolanda,
songwriter venticinquenne anglofona e anglofila che alle ultime novità
femminili in materia sembra guardare soprattutto. Joan As Police
Woman e Regina Specktor infatti nel suo Aubade (Autoprodotto,
7.2), venato di frangiflutti scuri, meccaniche da crepuscolo burtoniano e
smaniosità come un PJ Harvey alle
prese con il cabaret berlinese. Nella
parte è assolutamente credibile, e
la scrittura supplice a qualche ammanco di personalità. Tuttavia, pur
comprendendo la scelta idiomatica
conseguenze alle influenze, vorremmo tanta espressività – in primis
fonetica – alle prese con la nostra
lingua. Ci provi.
Poche semplici note e un nome,
Giuseppe, a corredare il progetto Good Lucifer Inferno per il
demo omonimo (Autoprodotto,
6.8/10) che comprende cinque pezzi. Di musica elettronica strumentale si tratta, piuttosto evocativa, per
un songwriting crepuscolare con un
codice genetico prettamente dark
wave e onirico, che in alcuni episodi
si movimenta abbastanza. C’è sintesi sufficiente nella produzione e nel
progetto, e convincente variazione
da fare pensare a margini buoni di
evoluzione futura. Per ora non si può
che definire molto promettente.
Da Genova provengono invece i
Belzer, gruppo di una certa esperienza - già di supporto a Giorgio
Canali -, con l’album L’ultimo
giorno d’inverno (Pirames International, 7.0/10); trattasi di band pop
rock che possiede un suono di matrice prettamente anglofona (Cure,
Radiohead, Coldplay, Beatles) e
spiccata sensibilità italiana (gli Scisma i referenti principali ma anche
Lucio Battisti o Paolo Benvegnù volendo fare qualche nome),
per testi e melodie. Oscillando tra
indie rock e songwriting, mostrano
un gusto per l’armonia e una buona
facilità espressiva; un sentire pop li
caratterizza infatti al meglio e non
in senso deteriore, anzi. Non c’è infatti ricerca di particolare facilità ma
piuttosto l’equilibrio tra gli elementi.
Già sufficientemente bravi.
Andiamo adesso dalle parti di
Bologna, con la neonata Monster
Records. Curioso l'approccio della
label: “La forma è quella di una cooperativa con lo scopo di giungere
direttamente ai media e agli ascoltatori saltando i canali di distribuzione
e di promozione classici. L'etichetta svolge semplicemente attività di
comunicazione e servizio di vendita
per corrispondenza dei dischi ma
non finanzia né produce i dischi, che
rimangono a spese e di proprietà
degli artisti.” 200 copie per ogni CD
e gli esordi di Brain In Vain e Morse Code a fare da apripista.
I primi sono un duo chitarra e
batteria impegnati con Inner Crowd
(Monster, 6.9/10) a trovare una personalissima via di fuga tra funk, blues,
cadenze quasi math-hendrixiane
racchiusa in una girandola di controtempi e rivisitazioni delle classiche dodici battute (Superimposition).
I secondi arrivano direttamente dal
catino iper-virtuoso e ormai ufficial-
mente defunto dei Caboto - si parla
di tre dei sei musicisti che costituivano l'ossatura della band bolognese – e rinvigoriscono a suon di
funk, post-rock, jazz, free, psichedelia, tempi dispari, una concezione di
musica totale e decisamente sperimentale. The Night An Artificial
Light (Monster, 6.7/10) impressiona,
ai limiti dell'ubriacatura.
Ci spostiamo un po' più a nord
con l'alt-country dei Dead Man
Watching, che già ci convinse ai
tempi del precedente lavoro autoprodotto, in virtù di un "farsene
carico" intenso e disinvolto, come
se il veronese fosse disseminato di
highway che rosicchiano le frontiere e di front porch che raccolgono
stanchezze e disillusioni. E forse,
chissà, è davvero così. Fatto sta che
questo Dead Man Is Coming To
Town (Autoprodotto, 6.8/10) è un
ep che ripropone la formula senza
mostrare cedimenti, una triangolazione Red House Painters-Mojave 3-Wilco che è garanzia di ballate e palpiti (splendida Les Moods), ma
anche di qualche guizzo che ravvivi il
falò (Love In The Afternoon). Canonici,
ma adorabili.
Quanto ai Wheelman On Bushpig, sono Francesco Provengano
e Marcello Fauci, due romani dotati
di una prolificità spaventosa, visto
che dichiarano d'aver messo giù una
cinquantina di brani in neanche un
anno di collaborazione. Hanno deciso di raccoglierne 6 per questo Nice
Story EP (Autoprodotto, 7.1/10), un
piccolo prodigio nel quale l'industrial
compie strane mutazioni indie, stoner e math. Una formula che ti incalza (Shape) e circuisce (la title track),
ti strattona con garbo Motorhead
(Climb & Collapse) e ti spalma di delirio e frenesia (Smooky Scream). Una
realtà che attende solo la breccia
giusta per imperversare.
Anche per questo mese è tutto.
Ci rimettiamo in ascolto.
Luca Barachetti, Teresa Greco,
Stefano Solventi, Fabrizio Zampighi
91
Rearview Mirror
—ristampe
highlight
Cure (The) - Disintegration (Deluxe Edition) (Rhino, Giugno 1989)
G enere : dark pop
AA.VV. - Next Stop
Soweto Vol. 3
Giants, Ministers And Makers: Jazz
In South Africa 1963-1984 (Strut
Records, Giugno 2010)
G enere : afro - jazz
Si conclude - di già? di già - con il terzo volume la serie
dedicata a frugare tra gli archivi sonori del Sud Africa,
ed è chiudendo un cerchio con intelligenza che avviene
il congedo. Ovvero pescando in un fiorente panorama
jazz e, al suo interno, in un arco temporale esteso su
due decenni. Non facile per gli artisti qui antologizzati
poter proporre musica in modo libero, essendo la mano
del governo pesante e oppressiva: l’alternativa una fuga
all’estero per una carriera a testa altissima, come ad
esempio Hugh Masekela e Miriam Makeba.
Prendeva dunque corpo negli anni ’50 una “scena” sulla
scia di Charlie Parker e Duke Ellington, poi trasfigurati innestando le tradizioni autoctone marabi e kwela
sul be-bop. Non facendo altro che riportare a casa lo
spirito rubato agli schiavi,
riappropriandosi di qualcosa che era loro da sempre.
Che fosse in fondo questo
a spaventare il governo
che concepì la vergogna
dell’apartheid? Probabile, e
allora che l’ennesimo brindisi in onore di chi ha versato sangue per cambiare le cose sia accompagnato da
questo dischetto, impreziosito (com’è ormai consuetudine chez Strut) da un apparato iconografico esemplare
e note altrettanto.
A contare è comunque il contenuto sonoro, qui “classico” con bello stile che mai avresti detto e là propenso a
92
spingere sul pedale del groove, quando non indaffarato
a contaminarsi e omaggiare i fratelli Coltrane e Shorter.
Miglior fine non poteva esserci, davvero.(7.5/10)
Giancarlo Turra
Black Tambourine - Black
Tambourine (Slumberland, Maggio
2010)
G enere : noise - pop
È incredibile come ultimamente a venire “riscoperti” siano gruppi che in vita hanno prodotto veramente poco,
se non addirittura nulla. L’ultimo esempio in ordine di
tempo sono gli ottimi Method Actors, ma in scia
possiamo aggiungerci anche i Black Tambourine.
Il quartetto di Silver Spring
(Mike Schulman, Archie
Moore, Brian Nelson e la
cantante Pam Berry) è un
culto ormai pienamente
consolidato nonostante un’esistenza brevissima e una
discografia che definire parca è eufemistico: non più di
un paio di singoli per Slumberland e qualche pezzo sparso qua e là su compilation ormai dimenticate.
Eppure, una così scarsa produzione ha segnato trasversalmente l’indie più noise-pop e/o shoegaze di oggi - da
The Pains Of Being Pure At Heart fino a Vivian
Girls e Crystal Stilts, giusto per citare i più noti - decretando un postumo successo di culto che ha come piacevole conseguenza il ritorno in pista dei quattro. Black
Tambourine infatti non si limita a replicare quello che
l’ottima retrospettiva Complete Recordings aveva posto
in essere ormai un decennio fa, ma aggiunge un paio di
Nel 1989 la diffusione delle cassette era ancora larghissima. Le mie preferite erano le TDK e le Maxwell, ma non
per qualche specifico merito audio-tecnico, quanto per l’assai più futile motivo che la label rigata che faceva da
copertina, quella suddivisa in lato A e lato B, era molto larga e ti permetteva di scrivere tutti i titoli delle canzoni
senza dover (orrore!) abbreviarli. Fu su una di queste cassette che all’epoca registrai - o meglio - “duplicai” Disintegration, l’ottavo disco dei Cure che era rapidamente diventato il best-seller del “dark”, termine stupido
ma efficace, che contribuì a diffondere un minimo di cultura goth, nella provincia italiana. Ovviamente era solo la
punta dell’iceberg, ovviamente in Italia arrivavamo dopo, ovviamente quella dei Cure era una versione edulcorata
e facilmente commerciabile di un mondo che loro stessi avevano contribuito a costruire tempo addietro con
l’ormai mitico trittico Seventeen Seconds / Faith / Pornography, prima di darsi alle gioie pop delle charts
di Billboard con le varie In Between Days e Close To Me.
All’epoca, quindi, Disintegration fu una specie di ritorno al passato, tanto quanto l’attuale Deluxe Edition è
un po’ una sorta di ritorno al futuro. Che la riedizione, rimasterizzata, ampliata e
filologicamente studiata in tutti i dettagli, arrivi ora in pieno riflusso eighties e di
dibattito hypnagogico è sintomatico di come stiano andando le cose da qualche
anno a questa parte. Non sorprende allora che i demo, gli outtakes e le rarities
che sono incluse nel secondo dei tre dischi della Deluxe Edition, nella loro primitiva rozzezza da sala prove, siano del tutto assimilabili alle sortite attuali dei
vari Ducktails, Washed Out, Neon Indian, ecc. Non sorprende nemmeno la
cura maniacale con cui Robert Smith ha preparato questo 21esimo anniversario
del suo capolavoro, approfittando di questa occasione, per mettere su un vero e
proprio studio filologico delle canzoni contenute nel disco.
Il primo dei tre cd, riproduce per intero l’album originale, con la differenza che tutto è stato rimasterizzato
digitalmente dallo stesso Smith, presso gli studi Soundmasters di Londra. Il risultato è che vengono regalate
nuove profondità ad una produzione, che per l’epoca era già “piena” e “ricca”. Quindi, a maggior ragione vale
oggi, quello che Smith scrisse ieri nelle note di copertina del disco: “THIS MUSIC HAS BEEN MIXED TO BE
PLAYED LOUD SO TURN IT UP”.
Il piatto forte di questa edizione però sta nel secondo disco, Rarities 1988-1989. Già la versione RS Home Demo
(ovvero registrazione casalinga di Robert Smith) di Prayers For Rain fa capire che il ripescaggio di questi provini,
vale come una fotografia d’insieme della nascita delle canzoni di Disintegration. Pictures Of You in queste vesti
spartane non ha tutta la sua dinamica epica e sembra un brano depresso dei tempi di Faith, mentre Fascination
Street è oltremodo affascinante per i suoi proto arrangiamenti esotico / hawaiani che davvero fanno pensare a
Ducktails. Dai provini con la band (Band Reharsal e Band Demo) saltano fuori altrettanti fantasmi, in forma di
strumentali inediti e b side dimenticate: Fear Of Ghots, Noheart, 2 Late, Babble, Out Of Mind, Delirious Night.Alla fine
l’effetto è come quello di aver dissepolto un cassetto pieno di vecchie foto ingiallite e consumate.
Il terzo dei tre dischi, rispolvera Entreat, un vecchio live del 1991 nella Wembley Arena. Lo rispolvera ampliandolo per ottenere l’esatta scaletta di Disintegration dal vivo e per questo viene ribattezzato Entreat-plus.
Live album tecnicamente già pregevole nella sua versione originale, ma che Smith rimasterizza ugualmente,
forse per ottenere un livello omogeneo dei volumi o forse perché è un perfezionista come sempre. La Deluxe Edition di Disintegration farà certamente la gioia dei fan della prima e della seconda ora. Per tutti gli
altri rimane interessante come documento storico e come ricostruzione filologica del processo creativo di
Robert Smith. Di fatto, ormai abbiamo una fotografia completa di tutte le fasi creative di queste canzoni. Dai
provini casalinghi di Smith, alle prove in studio con la band, al prodotto finale su cd, fino alla resa live. Nascita,
ascesa e fine di un capolavoro.(8/10)
Antonello Comunale
93
demo versions (For-Ex Lovers Only e la significativa Throw
Aggi Off The Bridge, necessaria per individuare l’influenza
fondamentale della band) e addirittura quattro canzoni
nuove, appositamente registrate per questa compilation
e equamente suddivise tra originali (Heartbeat e Lazy Heart) e cover (Tears Of Joy targata Buddy Holly e l’incredibile resa di Dream Baby Dream dei Suicide).
Ben ritrovati o bentornati, poco ci cambia. Resta sempre il piacere di perdersi dentro zuccherose melodie in
overdrive. Ieri, oggi, per sempre.(7.5/10)
Stefano Pifferi
Kenny Graham - Moondog And
Suncat Suites (Trunk Records,
Aprile 2010)
G enere : jazz
Basta dire chi c’è e quasi tutto il resto va di conseguenza. È anzitutto la figura di Moondog a rendere questa
ristampa - che mette a disposizione un materiale indisponibile da più di mezzo secolo - consigliata. Un invito
all’ascolto a tanti tipi di utenze, non solo al fidato ascoltatore di jazz, che saprà a memoria la vicenda del figlio
della luna stradaiolo, ma anche all’orecchio di chi ne è
digiuno e non discerne nella massa indistinta e a volte
sterilizzata della musica nera per eccellenza.
Moondog fu quel compositore e polistrumentista non
vedente che per vent’anni si è aggirato per le strade di
New York facendone non solo il proprio palcoscenico
ma anche il luogo di paradossale intimità. Il Vichingo della
Sixth Avenue (così veniva chiamato) creava una continua
colonna sonora urbana tramite trasognate composizioni;
non un artista di strada punto, un compositore riconosciuto e storicizzato. Era la metà degli anni Cinquanta
quando, dall’altra parte
dell’Oceano, il jazzista e
compositore inglese Kenny
Graham (classe 1924, morto nel ’97) decise di fare
un disco di cover - a nome
Kenny Graham And His
Satellites - dell’amato
Viking. Nel luglio del ’56,
complice l’ingegnerizazione del suono di Joe Meek, fu
registrato Moondog And Suncat Suites, dove alla
“Moondog Suite” - le prime dieci tracce, dalla meravigliosa One Four a Fog On The Hudson -, composizioni
moondoghiane appunto, faceva seguito la “Suncat Suite”,
composta da Graham ma fortemente suggestionata da
atmosfere e tecniche compositive di Moon.
La parola chiave, nel sound diffuso dalla dozzina e più
di strumenti coinvolti (Moondog ea anche creatore di
94
nuovi strumenti, come di vestiti), è “incanto”. Per quanto
il Nostro pare traesse ispirazione dai suoni della Grande
Mela, auto, metro, sbuffi e animosità urbana, non si sente
la New York delle strade, in Moondog And Suncat Suites,
quanto una magia sospesa nell’aria (Chant). L’astrazione
di chi non poteva separarsi fisicamente dal corpo della
metropoli è tutta nella testa, quindi nella musica. Arrendiamoci alla gran quantità di fascinazioni che tutto questo comporta.(7.5/10)
nico di brani come Commotion scorrazzano proprio in
quei territori.
E' musica che ascoltata oggi risplende in tutta la sua impressionante attualità.(7/10)
Gaspare Caliri
A cosa si deve questa goduriosa rispolverata di uno dei
più grandi album della Storia del rock? E' ancora un po'
presto per celebrarne il quarantennale (sarà fra due
anni esatti), quindi: niente anniversario. E allora? Forse
perché sono stati miracolosamente rinvenuti pezzi inediti? No, sembra piuttosto che Jagger e Richards siano
stati interprellati per esaminare antichi nastri allo scopo
di estrarne materiale interessante per fornire un alibi
all’operazione. Ovvero: il progetto precede la scoperta
degli inediti.
E allora? Allora, non ci resta che elucubrare. E non c'è
bisogno di andare troppo lontano: oggi che l'idea stessa
di album si sta estinguendo dall'immaginario delle giovani
(e non solo) generazioni, non stupisce che una major
come la Universal - sotto la cui cappella gli Stones si
sono appena trasferiti - tenti di rinvigorire il mercato
riproponendo uno degli album mitologici per eccellenza. Exile On Main St. fu per gli Stones e per il rock
una tappa estremamente significativa. Musicalmente
eccelso quanto bizzarro, emblema di bastardaggine stilistica (country folk, blues, gospel, errebì...) e sanguigna
ispirazione, frutto di dissennatezze varie e fughe dalla
rettitudine, di contrasti e illuminazioni, testimonia forse
l'ultimo rigurgito di un'utopia già sepolta.
Un album estremamente coeso malgrado l'eterogeneità
formale, sostanzialmente privo di singoli: i due prescelti
si comportarono benissimo (Tumbling Dice e Happy), ma
fu l’aura straordinaria del long playing a trainare loro e
non viceversa. In un certo senso, Exile - uscito nel '72 - fu
l'ultimo grande disco rock degli anni sessanta, o la straordinaria lapide che sigillava definitivamente quell'epoca
gloriosa. Tutto ciò lo rende un feticcio perfetto, inossidabile, capace di aprirsi una breccia nell'attuale cappa
d'indifferenza verso il disco
come "raccolta di canzoni".
Chiaro il concetto?
Ecco quindi il nuovo fiammante missaggio, ed è
un bel lavoro in effetti: ti
sembra di mettere maggiormente a fuoco i volti,
le espressioni, le folate di
Method Actors (The) - This Is Still
It (Acute Records, Maggio 2010)
G enere : P ost punk
Ho sempre avuto un'inspiegabile passione per i gregari.
Adoro pensare che all'ombra di band blasonate sia stata
una scena brulicante di validissime formazioni, che solo il
capriccio del fato ha relegato alle seconde (o terze) file.
Nel caso dei Method Actors oltre al fato ci si è messa
una buona dose di schizofrenia e la follia artistoide dei
protagonisti Vic Varney e David Gamble. Troppo spigolosa e poco incline ai facili antusisami la loro musica per
compiere la medesima scalata al gusto popolare di altri
act come R.E.M. e B-52's, che pure dalla stessa scena
(Athens, Georgia, a cavallo fra 70 e 80) provenivano.
Inutile fingere conoscenze pregresse: quello che sappiamo di loro lo apprendiamo dal libretto di questo splendido This Is Still It, antologia di una carriera durata
appena tre anni, giusto il tempo di incidere un singolo
e due album attualmente introvabili. Il secondo, Little
Figures, venne definito dalla rivista Sound il migliore
dell'anno di grazia 1981.
Peculiari fin dalla formazione: un duo chitarra/voce e
batteria che in epoca pre White Stripes costituiva una
bizzarria non da poco. La musica poi raccoglieva il meglio
dell'art rock del periodo e lo declinava in agilissime canzoni che mescolavano le nevrosi chitarristiche dei Devo
e il post punk geometrico dei Wire.
Urgentissimi e spigolosi come solo chi fa musica lontano
dalle logiche del music business può suonare, eppure capaci di infilare una manciata di anthem (vedi il surf robotico di Hi-Hi-Whoopee) che
avrebbero meritato ben
altro destino. Difficile dire
quanto abbiano influenzato
o quanto a loro volta siano
in debito nei confronti di
act come Pylon e Talking
Heads, di certo il funk
punk asciutto e nevraste-
Diego Ballani
Rolling Stones (The) - Exile On
Main St. (Universal, Maggio 2010)
G enere : rock
genio selvaggio su quei lineamenti giovani che la musica ha fotografato per sempre. Quanto alle dieci tracce
"previously unreleased", rispondono in pieno alle aspettative, sono pur sempre propaggini ma si amalgamano al
contesto (al Contesto) con bella naturalezza. Degne di
nota Plundered My Soul che gioca a fare la Tumbling Dice
un po' più sanguigna, di cui Good Time Women sembra essere una vera e propria versione scollacciata. C'è poi I'm
Not Signifying che recupera il passo ebbro del banchetto
degli straccioni, c'è l'allucinata fuga garage strumentale di
Title 5, mentre destano curiosità le versioni alternative di
Loving Cup (più lenta e melmosa) e Soul Survivor (cantata
da Richards e perciò più scapigliata e alcolica).
C'è quindi il "caso" Following The River, in origine uno strumentale su cui Jagger ha cantato un testo nuovo di zecca:
operazione filologicamente discutibile, ma a pastrocchi
del genere ormai siamo vaccinati. Va detto in ogni caso
che il pezzo è piuttosto bello, situabile in un solco immaginario tra Wild Horses e You Can't Always Get What You
Want. Le super-deluxe edition prevedono versioni in vinile con sontuosi libretti fotografici e DVD (contenente
estratti dai peraltro già noti Cocksucker Blues e Ladies and
Gentlemen: The Rolling Stones): prezzi ovviamente alti ma
in fondo equi, proprio perché commercialmente in giro
c'è poco di altrettanto appagante da un punto di vista
rock. Del resto, non è la prima operazione del genere.
Vedrete che non sarà l'ultima. Anzi.
P.S. Il voto che segue ovviamente si riferisce all'operazione. Il disco sarebbe da 9 pieno.(7/10)
Stefano Solventi
Starfuckers - Ordine '91-'96
(Sometimes, Maggio 2010)
G enere : rock destrutturato
Era sinceramente tempo che qualcuno facesse ordine
nel percorso discografico degli Starfuckers. È merito
dell’etichetta romana Sometimes se oggi ci rigiriamo tra
le mani questa retrospettiva con rarità e inediti che riaccende le luci dei riflettori su una tra le poche band italiane in grado di sviluppare un percorso personale, non
derivativo e soprattutto impossibile da imitare. Non è
infatti azzardato affermare, a un quinquennio buono dalla
trasformazione in Sinistri e a un passo dalla rinascita,
che gli Starfuckers siano un unicum nel panorama musicale italiano e non, per capacità sperimentali, portato
eversivo e lucidità di intenti.
Partiamo dal principio. Nati come rockers rumorosi sulle orme di Stooges e Stones (l’esordio Metallic Disease, qui non presente ma prossimo anch’esso
alla ristampa), al varco della seconda uscita (Brodo Di
Cagne Strategico, 1991) l’allora sestetto fece tabu95
la rasa del passato rock, e
i rimasugli ancora intelligibili venivano deturpati in
una strategica dichiarazione
d’intenti sonori che, parole
di Eterogenio nel corposo
booklet, “scagliava una manciata di caos nelle orecchie
degli ascoltatori”. Free-jazz, rumorismo, no-wave, freenoise incompromissorio, come lo chiameremmo oggi,
convivono e si scontrano nei pochi minuti del minialbum,
lasciando un segno profondo nel percorso personale. Sinistri (Underground, 1994) è oltre. Il rock non esiste
più, neanche nelle forme sconquassate del mini. Ordine,
testo anarchicamente epocale e incedere pachidermico,
è l’ultimo lascito vagamente rock dell’album. Il resto è
ricerca timbrica, sperimentazione strumentale, testualità
da cut-up, ideologia eversiva, decomposizione materica,
indagine sul vuoto e poetica della frantumazione. Anello
di congiunzione ideale col futuro prossimo della band,
ormai raggrumatasi intorno al trio Manuele Giannini,
Alessandro Bocci e Roberto Bertacchini, Sinistri mostra
in nuce ciò che nei successivi di Infrantumi e (Infinitive Sessions) diverrà effettiva disgregazione sonora.
A corredo di questo esaustivo approfondimento sul primo piano quinquennale targato Starfuckers, alcune rarità
sparse su compilation (la malata Mechanical Man, cover
mansoniana acidamente riletta e affidata al tribute album
Comin’ Down Fast), magazine (Dear P. rivisitazione di
un pezzo dei Beatles, affidata ad una compilation del
magazine Bananafish) e inediti (Quattro Studi (Su Un’intervista) I), tutti rigorosamente rimasterizzati da Giuseppe Ielasi. Retrospettiva dell’anno? Molto probabilmente
sì.(8/10)
Stefano Pifferi
Frank Zappa - Greasy Love Songs
(Zappa Records, Aprile 2010)
G enere : M oustache doo - wop
Il doo-wop e le stupid songs sono una delle componenti di
base della musica di Zappa (altre due potrebbero essere
il blues e Stravinskij), un amore e una pratica che risalgono alla gavetta, fine anni Cinquanta, quando FZ sbarcava
il lunario scrivendo e suonando per misconosciuti gruppetti r'n'b e lounge dai nomi esotici come Joe Perrino &
The Mellotones. Amore e pratica che lo accompagneranno fino alle propaggini estreme della sua vita live on stage.
Il doo-wop baffo&mosca di Zappa è sì una parodia, ma da
intendere in senso - ancora - stravinskijano, un remake
umoristico che è anche un sentito omaggio.
E' nel ribollente 1968 che il baffuto dichiara ancora una
96
volta al mondo la propria alterità pubblicando un disco
zuccheroso e grottesco, interamente dedicato a questo
genere, Cruising With Ruben & The Jets (registrato
durante le session del capolavoro Uncle Meat). Sono
tredici deliziosi underground lollipop (quattro ripresi da
Freak Out!) da piluccare con distacco e partecipazione,
strizzando l'occhio, oscillanti come sono tra retorica pomatosa anni Cinquanta e doppi sensi spinti, tra armonie
rubate ai cugini pachuco dei Platters e criptocitazioni
colte (spesso gonfiate dalla critica). Greasy Love Songs,
nella serie Audio Documentary, permette finalmente di
riascoltare la versione originale di Cruising, quando
finora era disponibile su cd
soltanto il terribile remix
1984 (con le parti di batteria e di basso risuonate da
Chad Wackerman e Arthur
Barrow). Pochi gli extra, giusto qualche versione alternativa e una Valerie dell'epoca Cucamonga/Studio Z (pezzo
che ritroveremo come "fetta di chiusura" di Burnt Weeny Sandwich).
Il doo-wop zappiano è una delle più compiute dimostrazioni della americanità di FZ e della stranezza (molto più
che della difficoltà) della sua musica: Zappa non è per tutti
e questo Zappa qui (come pure quello superkitsch degli
anni Ottanta) lo è ancora meno.(7/10)
Gabriele Marino
Rearview Mirror
—speciale
Forever Young Pavement
Quando eravamo indie
Uno spettro si aggira per l’Europa e il suo nome è
Pavement. Dopo un inizio da autentico ectoplasma,
ora sta provando a rivelarsi...
98
Testo: Giancarlo Turra
Non vogliamo recitare la parte odiosa di coloro che
se l’aspettavano, ché a noi la dietrologia ha sempre disgustato. Però, nel momento in cui mettevi i dischi da
solo di Stephen Malkmus, dei Preston School Of
Industry, di Spiral Stairs e ogni altra robetta che - da
fan: ma l’amore è cieco e non sordo - ci eravamo procurati speranzosi (o forse disperati), ecco, quando prendevi
tutti questi dischi e li poggiavi su un piatto della bilancia,
li osservavi volare in aria. Dall’altra parte c’era Slanted
And Enchanted, c’erano la possibilità di essere serenamente arguti, sardonici e partecipati. C’era il momento
definitivo di un percorso del college rock che si guadagnava lo scranno meritato, i riflettori a lungo scansati
con quell’atteggiamento timidamente scazzato e l’understatement a scorrere nelle vene. Come i Nirvana, ma
diversi.
Adesso, dopo aver raccolto testimonianze di un compitino svolto sui palchi britannici senza brio, ci troviamo
davanti ad alcune date - nostrane e non - in cui lo sgradevole odore di “marchetta” tipico delle reunion pare
scomparso. E' vero: ognuno fa quel che ci si aspetta da
lui, inclusa la musica, e il dibattito sulla necessità di queste
operazioni è di quelli che conducono lontano. Nondimeno, i Pavement sono di nuovo in circolazione a recitare
se stessi, e pur nella bontà della musica proposta e delle
esibizioni (serviva forse scrollarsi di dosso un pò d'acciacchi), resta un dubbio, un tarlo: se un atteggiamento
fieramente indipendente avrebbe tollerato tutto questo,
nell'Anno in cui il Punk fece il Botto 1992.
Aspettate a darci dei talebani. I Clash, finché Joe
Strummer era ancora vivo, se n’erano ben guardati nonostante i milioni di sterline offerti loro. Ed erano
dei punk da sempre sul libro paga di una major. Ognuno
tragga le sue conclusioni in merito, ché il mondo è bello perché vario. Chi scrive preferisce pensare a quando
Malkmus e soci riuscivano - mentre noi guardavamo “oltre” la nozione di rock - a coniugare un approccio svagato e in apparenza fragile alla materia (sul versante pop
chitarristico, smembrato nelle sue componenti e ricostruito daccapo) con la robusta conoscenza del passato.
Collocando un'altra pietra miliare sulla via della canzone
"sperimentale ma anche appassionata" che va dai Velvet
Underground ai primi R.E.M. attraverso Fall, Sonic
Youth, Pixies.
Conoscevano il segreto per proporsi in modo viscerale e autoironico, costoro, oscillando come un pendolo
tra l’amore e il distacco: romantici e sarcastici al contempo e quanto talento puro serve per vivere su ambo i lati
della strada con agilità. Ecco perché ci siamo abbandonati a lungo - e tuttora replichiamo la magia - a quelle robe
sghembe, tortuose ma fischiettabili, suonate con una casualità studiata benché mai posticcia o forzata. Domandandoci quali sottotesti misteriosi si nascondessero dietro liriche confuse, quale realtà di annebbiamento sociale
potesse partorire un’indolenza vocale che dicevi restia a
comunicare; che quando lo faceva, manteneva il sorriso
di chi la sa lunga e te la sta facendo sotto il naso.
Personaggi da una pagina di Douglas Coupland, magari. Più verosimilmente gente come noi, disinteressata alla
carriera e a certe responsabilità; che lavora nel castello,
ma più per sé che nell’ombra dei monarchi. In brani fratturati, gioiosamente caotici e ricchi di svolte pericolose,
la bassa fedeltà di questi universitari americani troppo
smart per non giungere lontano si è rivelata uno degli
esempi più imitati. E per un fantastico, ragionevolmente
lungo momento, ha funzionato a meraviglia.
S lanted ? E nchanted !
Abbiamo nondimeno corso e urge riavvolgere la scalcinata C90 - del tipo che tanto piace a Thurston Moore - tornando nella California placida e sonnacchiosa di
metà ’70. Ovviamente è a scuola che cementano la propria amicizia due ragazzi come tanti: dopo alcune false
partenze, per un po’ Pavement non saranno che il progetto di studio guidato dai cantanti e chitarristi Stephen
Malkmus e Scott Kannberg. Siamo nel declinare degli
anni Ottanta, una stagione felicissima del suono indipendente a stelle e strisce che sta per chiudersi, essendo i
suoi pilastri disciolti o entrati nel grande mondo senza
vendersi. E che effetto, per chi se ne accorge, i primi 7”
ed e.p. di quella che gradatamente diventerà una band
a tutti gli effetti raccattando per strada Mark Ibold al
basso, Bob Nastanovich a percussioni e tastiere e il
batterista - un hippie quarantenne! - Gary Young.
Grafica caotica, giustapposizioni estetiche finto casuali che fanno bel paio con la musica, coacervo da mandare in visibilio i critici affamati di citazionismo e i fratelli
maggiori degli spocchiosi indie-kids odierni: dinoccolata
orecchiabilità tra storture Pixies, noise di scuola Sonic
Youth e ruvidezze new-wave d’oltremanica (titoli dei
brani e - lo ribadiamo - grafiche che sono smaccati saluti
ai Fall; talune atmosfere che ricordano gli Swell Maps)
e non solo. Manna che regge benissimo il riascolto d’un
fiato - raccolta dalla Big Cat su Westing (By Musket
And Sextant) nel ’93 (7,3/10) - a partire da You’re Killing
Me da Wire intubati, dalla Box Elder favoloso bubblegum masticato allo sfinimento per Wedding Present
e John Peel, dalla cingolata She Believes e dalla malinconia
stridente di Perfect Depth. Citazioni dei Faust di Tapes,
incrostazioni Electric Eels e ruggine Rocket From
The Tomb si mescolano ai disturbi sparsi dentro il tes99
suto sonoro come indizi da decifrare. Seguendo una logica perversa, da primi della classe che vogliono portarti al
limite per saggiare la tua reazione. Sono passi registrati in
necessaria economia e autoprodotti in un 1989 che pare
lontanissimo e che creano un alone arcano rinunciando
alle informazioni sulla line-up e accreditando le composizioni a "S.M." e "Spiral Stairs".
Dall’autoproduzione passano, in forza del clamore,
all’attenta Drag City per i 45 e 12” che precedono, in
parallelo allo stabilizzarsi della formazione e alle prime
esibizioni dal vivo, il primo LP. A tutt’oggi, di Slanted &
Enchanted (Big Cat, 1992; 9,0/10) colpisce l’abilità di
padroneggiare affermati vocabolari altrui al punto di cavarne tonalità nuove, volando altissimi su una scrittura
inattaccabile. Trentanove minuti e sette secondi da cui
non sottrai nulla: non la Summer Babe che è anthem alla
Husker Du per tempi nuovi; non gli episodi che incrociano Black Francis, Mark E. Smith e Lee Ranaldo
(in ordine casuale: Trigger Cut/Wounded Kite At :17, In The
Mouth A Desert, No Life Signed Her, Loretta Scars), non i
Velvet del terzo LP ricordati con Zurich Is Stained e la
sospensione finale Our Singer. Soprattutto non una Here
che, ballata di paralizzante bellezza, omaggia cosciente gli
Smiths ed è riluttante inno per chi desidera ancora rincuorarsi.
Non lo capivi all’epoca, tuttavia era già un suono di
“sintesi” che rintracciava nell’attitudine critica e in nella solidità intellettuale i propri pilastri: la stampa ai loro
piedi e non poteva essere altrimenti. Duro, però, gestire qualcosa spinto oltre il passatempo e ne fa le spese
Young, il quale non regge neanche un minimo di professionalità bastante ad affrontare il palco con sicurezza.
Un mini-lp eccellente come Watery, Domestic ne saluta
la dipartita, s’è fatto autunno e subentra il solido Steve
West in una band che resterà da qui immutata. Lo stile si
ripulisce e per qualcuno smarrisce verve: un errore, perché semmai incontra alla propria classicità felice di essere
considerato pietra di paragone. Avresti quindi predetto,
con buone probabilità di centrare il pronostico, che la
replica Crooked Rain, Crooked Rain (Big Cat, 1994;
7,4/10) avrebbe segnato l’accesso nell’alta società. Sì e
no: va bene l’approdo nelle charts statunitensi, MTV che
s’inchina alle satire Cut Your Hair e - acquerello remiano di
sottovalutata bellezza - Range Life (ma non abbiamo mai
veramente capito quale fosse il bersaglio…) e altrettanto
“Rolling Stone”.
Ma vuoi mettere la congiuntura favorevole di un ’94
drammatico epperò fecondo, a giustificare la nuova sensazione? Se stelle erano, rimanevano nel sottobosco:
parlavano chiaro le ruberie jazz (5-4=Unity è Take Five di
Dave Brubeck), la pigrizia sexy di Newark Wilder e Gold
100
Soundz, un Buddy Holly decontestualizzato per Silence
Kit. Su tutto spicca la magistrale psichedelia aggiornata
tramite liquidità, estasi e moviole del calibro di Stop Breathing, di Heaven Is A Truck, di Fillmore Jive. Il quintetto, dopo,
si mette in disparte a contemplare la “gloria” e inganna
il tempo. Malkmus e Nastanovich collaborano al debutto
lungo dei Silver Jews dell’amico David Berman nel
mentre progettano di allontanarsi da ciò che sta per degenerare in clichè.
Coraggio che premia, perché se Wowee Zowee (Matador, 1995; 7,6/10) è eclettico e policromo da adombrare talvolta la penna e l’equilibrio, contiene comunque
idee da regalare agli angoli delle strade. Un suono più
brillante, la cura per il dettaglio - prima erano disturbi,
ricordate? - e la ricchezza degli arrangiamenti giovano
alla classe di Brinx Job, Best Friends Arm, At & T più che
altrove. La band si concede sfizi come insegnare un paio
di mosse ai dEUS (Kennel District) dopo aver omaggiato
Alex Chilton (We Dance), alternando linearità e intimismo pastello (Father To A Sister Of Thought) e svagatezze
(Grounded) tramite le pregiate mini-suite Fight This Generation e Half A Canyon. Paradosso confacente è che i Nostri proseguano sulla cresta dell’onda ricavando soldini
ma anche frustrazione: al quinto Lollapalooza sono fuori
posto e a pochi frega di quel che suonano. II gioco iniziava
a non valere più la candela.
Terror At Twilight
Nella storia è accaduto continuamente: a un certo
punto, un gruppo si trova a un bivio. Deve scegliere se
continuare a salire oppure altrimenti fermarsi, implodere per stanchezza, prostrazione, esaurimento delle idee.
Film che va in replica anche qui. Il 1996 si consuma in uno
stallo interrotto soltanto dal mini Pacific Trim, non male e
che in Europa segna il passaggio alla Domino, preludio alla
lavorazione del quarto album con la presenza di Mitch
Easter alla consolle. Si limita a farli suonare e accendere i
microfoni, in sostanza, ma non è questo che fa storcere il
naso di Brighten The Corners (Domino, 1997; 6,8/10). E
neppure un’ulteriore accessibilità che regala vendite apprezzabili: è il riportare le lancette indietro di due dischi,
l’assenza di una evoluzione che non convince. L’onestà
mai messa in dubbio, disorientano il fiatone, una A Date
With Ikea gag FM che non fa ridere, le troppe carinerie di
un lavoro normale da parte di individui mai stati tali, che
anzi avevano dettato nuove regole per definire il concetto stesso di normalità.
Stanchezza è la ragione, e non aiuta un nuovo giro
concertistico di cui si narrano mirabilie che li sfibra in via
definitiva. Aria di fronda, o per lo meno di “pausa di riflessione”. E, diciamola tutta, quante ne conoscete di coppie
felici dopo di essa? Ecco: se c’è un momento in cui Pavement avrebbero potuto (dovuto…) chiudere bottega, questo era l’estate 1998. Quando è ora di decidere,
chiamano il già affermato Nigel Godrich a spargere fumo
sopra la monotonia di Terror Twilight (Domino, 1999;
6,0/10). Affidatisi al mestiere, scampano l’autoparodia
per un pelo. Non c’è però alcuna canzone di Spiral Stairs
e ne puoi allora quasi parlare come del primo “solo” di
Malkmus. Nulla ci toglierà comune dalla testa che i migliori Pavement dovessero esere cercati nel disco omonimo dei Blur, meraviglioso favore restituito come fu
nel 1994 Expermental Jet Set Trash And No Star della
Gioventù Sonica. I titoli di coda scorrono l’ultimo 20
novembre del decennio, allorché nella londinese Brixton
Academy, Stephen teatralizza i saluti ammanettandosi
all’asta del microfono: simbologia e finezza da piazzata
condominiale che da lui non ti saresti aspettato, e benché la casa americana Matador annunciasse una messa in
naftalina, chi aveva orecchie, intese.
Ognuno restituito a sé, i ragazzi si separano e affrontano il trauma come possono e, da soli, si smarriscono
nei meandri di cui in apertura. Più vicino a noi, ristampe
“espanse” certificano la grandezza del trittico iniziale e
il DVD Slow Century funge da lussuoso placebo. Il resto
è storia di ieri l’altro: dischi sempre più inconcludenti,
l’annuncio di spettacoli nuovamente insieme, un “best
of” scarsamente significativo. La mezza età e le sue crisi
sono del resto ardue da affrontare. Nondimeno, quel che
fa sul serio riflettere della reunion sono la maturità e il
classicismo di un (non) stile partito dal basso e giunto
lontano.
Che a un certo punto si è raggomitolato e di superarsi non ha voluto saperne. Bastava dirlo, avremmo preferito la nuda verità a un gioco di paraventi poco robusti
andati rapidamente in frantumi. Scomposto nelle parti
che sommate lo rendevano immenso, il suono dei Pavement è Genio scaduto in modestia impiegatizia. Oggi,
alla luce della loro presenza su un palco, li guardiamo
transumare da “il futuro? bah…” a “il futuro? beh…” con
flemmatica dignità. Rimane un passato da Maestri cui
tornare ogni volta che lo desideriamo, quello sì resistente a ogni riunione tra amici.
101
(GI)Ant Steps #39
classic album rev
Eric Dolphy
Type O Negative
Far Cry (Prestige, Dicembre 1960)
Slow, Deep And Hard (Roadrunner Records,
Giugno 1991)
Aveva 32 anni Eric Dolphy in quel 1960 che lo vide letteralmente esplodere. Un'esplosione di quelle che lasciano
il segno, come un asteoride piombato nel punto nevralgico del pianeta jazz. Uscito dai fifties e dal quintetto
di Chico Hamilton, eccolo incrociare il cammino del
travolgente Charles Mingus, assieme al quale - tra le
altre cose - inciderà l'incredibile Mingus At Antibes,
semplicemente uno dei più fenomenali live album che
si ricordino. Nello stesso anno, oltre ad altre performance come side man e ben sei album a proprio nome,
gli accade d'incontrare Ornette Coleman intento a
progettare uno snodo fondamentale che avrà per titolo Free Jazz, il che è tutto dire. Dolphy vi partecipa
e saprà distinguersi nella bolgia formidabile. Le sessioni
avvengono il 21 dicembre. Incredibile a dirsi ma in quello
stesso giorno, solo poche ore più tardi, un'altra seduta
d'incisione attende, nello studio di Rudy Van Gelder ad
Englewood Cliffs, New Jersey. E' la sera che vede nascere
Far Cry, album che suggella al meglio l'anno della consacrazione dolphiana.
Il quintetto allestito, a leggerne i nomi oggi, è da paura: il
nome meno celebre è quello Jaki Byard, pianista destinato a lasciare il segno nei successivi capolavori di Mingus,
quanto alla sezione ritmica, è curata da due calibri come
Ron Carter e Roy Haynes. Ma il vero pezzo da novanta,
impossibile da relegare al ruolo di comprimario, è il fenomenale trombettista Booker Little, i cui imprendibili
virtuosisimi valgono da soli il prezzo del biglietto, rappresentando allo stesso tempo una straordinaria pietra
di paragone per lo stile del leader. I cui assolo (di sax alto,
di clarinetto basso, di flauto) frullano angolosi e lirici, lievi
e risoluti, sono guizzi d'uccello e traiettorie algebriche,
sono uno stupefacente conflitto controllato tra razio-
102
nalità e istinto. Non a caso la scaletta si apre con due
brani - composti da Byard - dedicati al grande Charlie
Parker, l'uomo chiamato Bird forse perché insaziabile
amante di pollo arrosto, più probabilmente per lo stile "ornitologico" della sua mostruosa calligrafia. Little si
esalta, sembra voler incendiare la tromba in memoria di
Parker, ma Dolphy ribatte con una padronanza sbalorditiva, soprattutto nel condire d'imprevedibilità free la
fibra dell'improvvisazione.
Questo mix di puntualità, potenza, frenesia, ebbrezza e
ingegnosità percorre la rilettura di standard come It's
Magic e di originali come la title track, nuova elettrizzante versione della già nota Out There. Il programma originale si chiude con Dolphy al sax solitario nella Tenderly
firmata Gross & Lawrence, melodicamente stravolta per
ricavarne una morbidezza assieme soave e scostante, autentico capolavoro di "ri-composizione istantanea" che
non lascia indifferenti oggi come allora.
Cosa dire quindi di Far Cry se non che somiglia al respiro più profondo prima del tuffo, un farsi carico di tutto
ciò che sei stato con la consapevolezza già incontenibile
di ciò che dovrai essere. Verranno album indimenticabili
sia come leader che come side man extra lusso, tra cui
due autentiche pietre miliari come Africa/Brass e Olé
di John Coltrane. Quindi, nel 1964, sfornerà l'epocale
Out To Lunch, autentico vangelo di avanguardia jazz,
proprio come i testi bibilici infinitamente dibattuto e
adorato. La traiettoria per un'avventura imprevedibile a
quel punto era saldamente impostata. Quattro mesi più
tardi Eric s'involerà tragicamente verso il punto di non
ritorno. Silenzio.
Stefano Solventi
Ha il suono sottile della beffa, eppure Peter Steele è morto per un semplice attacco cardiaco. Lui ci aveva sempre
girato intorno, spesso aveva messo in giro false voci sul
suo decesso ed era solito celebrare il culto del suicidio
come unica forma virtuosa di farla finita. Ora siamo qui
a sentenziarne la grandezza post-mortem come si compete a tutti i grandi protagonisti del metal anni ’80 e ’90
che se ne sono andati in questi anni, da Dimebag Darrell
dei Pantera, a Chuck Shuldiner dei Death, passando per
"Piggy" dei Voivod. Peter Steele, al secolo Peter Ratajczyk,
sta li in mezzo, in un pantheon di assoluto rispetto, ma in
una nicchia tutta sua, non fosse altro che a dispetto di un
ego smisurato, di celebrazioni non ha mai voluto farne.
Ex poliziotto, ex militante in formazioni trash-hardcore
mai troppo elogiate come i Carnivore, grandissimo maniaco depressivo, morboso patologico con evidenti problemi di ordine sessuale, dal fisico scultoreo e imponente
e dalla smodata propensione all’esibizionismo (celebri le
sue foto a cazzo duro per il paginone di Playgirl, che gli valsero gli sfottò invidiosi di mezzo mondo metal). Il fascino
storto e diagonale dei Type O Negative sta tutto nel suo
modo di guardare al mondo, tanto che l’identificazione tra
lui e la band è totale e imprescindibile. L’unico modo degno allora per celebrarne la buonanima è quella di andarsi
a ripescare il primo, indimenticato, capolavoro dei Type O
Negative, datato 1991, ristampato e rimasterizzato appena l’anno passato. L’ormai leggendario Slow, Deep And
Hard, da più parti (per lo più esterne alle file della metal
intellighenzia) considerato il miglior disco di metal estremo. Una ben strana medaglia di cui fregiarsi, quando si
sono attraversate stagioni e decadi di brutali espressioni
oltranziste originatesi dal trash metal della bay area, passate nel tritacarne gore del death e del grind e arrivate al
funerale definitivo con il black. Ma i Type O Negative si
mettono a stimolare le zone buie dell’anima, senza fare
bieca didascalia splatter, ed è per questo che hanno sempre avuto un risvolto, per certi versi, più “intellettuale”.
Dopo l’ascolto di Slow, Deep And Hard si capisce che
tutte le definizioni stanno strette, in primis quella di metal, in vero contaminata fino al midollo, al punto che per
lunghi tratti è più simile ad una forma di hardcore evoluto
e progressivo, con lugubri passaggi di organo monastico a
centrare un melodismo gotico
e tenebroso, con
tanto di cori che riprendono il ritornello in terza persona,
alla maniera dei Beatles, notoriamente la band preferita
di qualunque maniaco che si rispetti, e quindi anche di
Peter Steele. Slow, Deep And Hard si presenta quindi come un parto doloroso e complicato e a conti fatti
come un vero e proprio concept album. Il concept è Peter Steele stesso. Il disco quindi non potrebbe essere più
complesso di così, tanto che stimola l’analisi dettagliata
delle sue parti più minute nel tentativo di decifrarne il
disegno generale, quasi come se si componesse un puzzle
sistemando i pezzi l’uno con l’altro. I brani viaggiano sulla
media degli 8 minuti di durata, si articolano in vere e proprie suite a più movimenti. E’ il dramma teatrale secondo
i Type O Negative. Dal dolore dell’infedeltà della sua ex
che sta al centro di Unsuccessfully Coping With The Natural
Beauty Of Infidelity (con micidiale umorismo maschilista di
Peter: “Tu c’hai il cazzo nella testa e lo sperma sul fiato /
Ti sei messa il diaframma prima di farti praticare un po’ di
ginecologia freelance”), alle disgrazie della società afflitta dai
debosciati dell’assistenza sociale in Der Untermensch, fino
alla seduzione dell’omicidio (si suppone della ex) a colpi di
piccone in faccia in Xero Tolerance, alla degradazione dello
stupro (con martello pneumatico) in Prelude to Agony, alle
trovate cinematografiche di Glass Wall Of Limbo (Dance
Mix) e The Misinterpretation Of Silence And It's Disastrous
Consequences, tra cori di monaci medioevali, schiavi che
tirano catene, male interpretati silenzi, e fino alla chiusura
della propria autorealizzazione tramite il suicidio, nell’atto
d’amore finale di Gravitational Constant: G = 6.67x10-8 cm3gm-1sec-2, in cui Peter, sedotto dalla forza di gravità, si
unisce in matrimonio con il suolo terrestre, non prima di
aver fatto atto di dolore, riconoscendo che come minimo
qualche problema c’è ("Ho un problema / Un problema con
l’odio / Non posso continuare a trascinarmi questo peso").
Per essere capito fino in fondo, Slow, Deep And Hard
va letto e sentito esclusivamente attraverso la mente del
suo autore ed è li che si nasconde tutto il suo estremismo.
Antonello Comunale
103
la sera della prima
Gli amori folli
A l ain R esnais (F rancia , I talia , 2010)
Parigi e l’Isle de France, Oggi. Marguerite Muir, Sabine Azéma, viene scippata a Parigi, fuori da un negozio.
Poco dopo Georges Palet, André Dussollier, ritrova
un portafogli in un parcheggio di un centro commerciale della periferia. Non lo riconsegna subito, indugia e
s’invaghisce della proprietaria. I due iniziano un balletto
atipico del rituale di corteggiamento e sembra che siano
destinati al perdersi sino all’esito finale.
Alain Resnais fa ciò che vuole. L’ha sempre fatto e
ora, con l’età e i tributi riconosciutigli, amplifica i modi
e i tempi con i quali dire. Non inventa nulla ma stravolge tutto. Prende quella che apparentemente sembra una
commedia amorosa assodata e piana e la riveste della
sua arte.
Nel suo ultimo film (in originale Les Herbes Folles,
2008) l’erba matta - il titolo italiano elide la logica! cresce dove vuole, senza chiedere spiegazione oppure
offrire motivazione alcuna. L’erbaccia è la metafora della
presenza umana sulla Terra, delle relazioni interpersonali
che tale presenza contraddistinguono e rendono unica e,
104
—recensioni
allo stesso tempo, sempre simile a un’altra sentita chissà
quando e dove. Quando si esce dal cinema tutto è possibile e nulla stupisce più, dice la voce narrante.
Un imprevisto, un incidente - L’incident è il romanzo di
Christian Gailly da cui parte Resnais - e tutto cambia, un
incrocio di destini altera un equilibrio apparente al quale
pareva essere abituati. Si dirà che questo è il macguffin
di tutto il cinema corale da Robert Altman a Paul
Haggis fino a Alejandro González Iñarritu.Va detto,
però, che in questo caso si presentano all’incrocio solo
due individui, due cespugli arbustivi, come li racconta la
delicatissima locandina originale del film.
Qui entra in gioco il touch of evil. Tutto quanto è narrato giace su una base d’interrogativi, di questioni irrisolte che allo spettatore sono consegnati come aspetti
frivoli e senza valore, come caratteri dei protagonisti ma
che, in realtà, fanno lentamente sgretolare ogni certezza
o deducibile propensione per una parte o per l’altra, per
una visione chiara della vicenda. Tutte queste domande
sono poste in secondo piano dal regista, dal ritmo brillante della commedia e dalla straordinaria prova degli
attori ma tale scollamento erode lentamente e trova, nel
finale, un giusto tripudio e dimostrazione nell’inspiegabile sequenza conclusiva.
Resnais gioca con il montaggio, lo fa sin dal suo esordio del 1956, Toute La Memoire Du Monde, altera
gli spazi e la successione logica degli eventi. Attraverso il
richiamo all’amatissimo fumetto, le nuvolette introspettive di Dussollier e Azéma, l’incursione nella citazione
cinefila, la macchina da presa mossa con piglio imprevedibile tra il dentro e il fuori, il regista bretone fa se stesso,
gigioneggia e chiede che gli amori folli del titolo siano
i nostri per lui. Mette in scena egocentricamente tutta
l’idea di cinema che chiude saldamente nell’obiettivo e
la serve nella forma semplice e condivisa della commedia amorosa. Lascia subodorare al melodramma ma per
confondere ancora una volta. Fa sorridere ma dissemina
d’insicurezza ogni risata che concede. Tutto è riflesso, visto attraverso, filtrato.
Diceva Resnais, ormai tanto tempo fa, che “ognuno
vive nei propri fantasmi e che è questo a rendere impossibile
la comunicazione tra le persone”. Si prendano i dialoghi
nei quali è presente il protagonista maschile, dal volto
segnato da una malattia o da una tragedia, diranno nel
film, così come dice il poliziotto che farà incontrare i
due: - Faceva certi ragionamenti che non ho capito niente.
Che parli con la moglie, con un poliziotto e con l’oggetto
del proprio desiderio, Palet parla a se stesso guardando
dinanzi a sé, senza sollievo da un peso che porta con sé.
Ecco, oltre tutti i divertissement e le gigionerie, la cifra di
Alain Resnais che spunta magnificamente, ancora una
volta, a ottantasette anni.
Aldo Romanelli
La nostra vita
D aniele L uchetti (I talia , 2010)
“Perché col tempo cambia tutto, lo sai, e cambiamo anche noi...”
Vasco Rossi, Anima Fragile
Nelle parole e nella voce traballante di uno dei migliori Vasco Rossi di sempre sta tutto il nuovo meraviglioso
film di Daniele Luchetti, La nostra vita. Unico film
italiano in competizione a Cannes dove Elio Germano,
il protagonista Claudio, ha meritato la Palma d'Oro come
migliore attore in ex aequo con il divo spagnolo Javier
Bardem, è stato applaudito accoratamente ed è nelle
sale italiane dal 21 maggio.
Roma, periferia. Oggi. Claudio ed Elena vivono insieme ai loro due figli piccoli Samuel e Christian - forse
senza H in onore del primogenito di Francesco Totti e un terzo è in arrivo. Si chiamerà Vasco. Il parto, però,
non va bene ed Elena, Isabella Ragonese, muore in sala
operatoria. L'uomo deve sopravvivere al lutto ed essere
un buon padre per i tre bambini nella realtà quotidiana
delle ingiustizie, degli abusi e dell'ignoranza con la quale
lui sceglie di accompagnarsi per rendere la vita dei suoi
piccoli migliore. Decide lucidamente di dare loro quanto
non hanno mai avuto fino a quel momento e di non far
sentire loro la mancanza della madre.
Luchetti affresca l'Italia di oggi. Lo fa con vernici tutt'altro che tenui o naturali - come si potrebbe, poi?! - sceglie
materiali caldi e olezzosi, spesso acidi ma veri e concreti,
mai sfumati o vacui. La vicenda di Claudio è raccontata
senza pietà, con la macchina da presa che accoglie quanto
accade quasi ponendosi come lo sguardo di un quinto figlio, il quarto sarà il romeno Andrei, Marius Ignat, legato a
Claudio inevitabilmente.Testimone della ferrea volontà di
un uomo di andare oltre comunque, questo sguardo non
è mai giustificante o rassicurante, mai è una carezza per
il protagonista al quale le cose vanno di male in peggio.
Infatti, d'un tratto, ci si accorge che lo sguardo della macchina da presa è quello di Elena, partita ma mai andata
via, giudice silenziosa di quanto accade. Era suo, infatti, il
ruolo ferreo tra i due genitori della coppia, era lei quella
che diceva sempre no a Samuel e Christian.
Solo alla fine, quando tutto ha trovato il suo esito,
quando il male è stato chiuso fuori dalla porta, non vinto
ma arginato, Claudio riapre la camera da letto della coppia chiusa dal giorno della morte di Elena. Si immerge nel
talamo nuziale e nell'abbraccio dei suoi bambini, di quanto resta, di quanto vale ogni collusione, ogni tolleranza
verso il male. Per aspera ad astra, si dirà. Quel letto pare
il mare tanto mostrato nel film e raccontato dai titoli di
coda. Pare il destino naturale delle cose, lo sciabordio
inevitabile e sordo delle onde che tutto muta e se ne
frega.
Lo spacciatore Ari, Luca Zingaretti, dice che su
di loro uno tsunami e non un'onda si abbatterà se non
pagheranno i creditori zingari; lo dice Vasco Rossi in
Anima fragile, lo canta Claudio per due volte nel film,
lo vivono tutti i protagonisti sulla loro pelle. Il mare, quel
qualcuno che avrebbe deciso di portare via la mamma ai
piccoli, come dice Claudio - lo si può accettare solo con
una “barchetta di affetti”, con una “scialuppa di sentire
comune”. Ed è lo stesso modo in cui la vita in questo
paese può essere ancora affrontata. Lucchetti racconta
la stagione di un riflusso mai finito, cosa realmente è accaduto dopo il ’68 e il ’77, alla fine dell’impegno civile.
Di Pier Paolo Pasolini è il fantasma che aleggia qui
prepotentemente.
Tutti gli attori del cast sono bravi: Raul Bova e Luca
Zingaretti, Isabella Ragonese e Stefania Montorsi si
prestano come perfette spalle a Elio Germano. Bravo più
che in ogni suo altrove, il ventinovenne romano diventa
105
Claudio, regalando una lezione di recitazione al Cinema
Italiano. Ampi spazi d'improvvisazione in cui la macchina
da presa figlio/moglie lo guarda e non può che tacere
intimidita. Su tutti la sequenza del funerale durante la
quale l'uomo canta l’inno alla vita dell’unico vero rocker
italiano. Non ve n'è traccia in sceneggiatura ma è nata,
dice l'attore, venuta dal nulla e non potuta trattenere.
Premiato a sorpresa a Cannes, Luchetti e lui erano rientrati in Italia il giorno prima e sono stati richiamati all'ultimo in Francia, l'attore ha dedicato la vittoria all'Italia
e agli italiani che fanno di tutto per rendere questo un
paese migliore malgrado la sua classe dominante. Oltre
la denuncia politica, importante e necessaria, Germano
dà così le chiavi interpretative di questo film semplicemente bello e, soprattutto, sincero, come la vita di certi
quartieri sempre meno realtà geografica limitata e sempre più stato mentale diffuso. Come pronosticava amaramente Pasolini ormai trent’anni fa, in un esempio di film
neorealista oggi.
Aldo Romanelli
Iron Man 2
J on F avreau (USA, 2010)
Il secondo episodio cinematografico di questo ennesimo prelievo dai tipi della Marvel comincia dove si era
interrotto il precedente capitolo, Iron Man (Jon Favreau, 2008). Il protagonista Tony Stark, Robert Downey
Jr., si toglie la maschera e urla al mondo la propria identità. Come spesso capita con gli adattamenti delle storie di supereroi, nel secondo episodio, all’affermazione
e manifestazione pubblica del protagonista, succede la
difficoltà di collocarsi nei ranghi sociali e di dialogare
con le autorità, qui l’esercito degli Stati Uniti d’America.
In più, altro topos narrativo condiviso, le condizioni di
salute di chi incarna il ruolo del supereroe si aggravano
tanto da mettere a repentaglio la sua vita e la sua lotta
contro il male. Il reattore che lo tiene in vita, alimentato
a Palladio, lo sta dannosamente contaminando di scorie
difficili da smaltire.
C’è un cattivo, si tratta di un fisico russo, Ivan Vanko, Mickey Rourke, che dopo anni di prigionia riesce a
mettere in pratica la sua vendetta nei confronti del nome
Stark. All’antagonista sarà dato aiuto dal peggior rivale
commerciale dell’ex costruttore di armi, Justin Hammer,
Sam Rockwell. C’è anche un nuovo compagno di battaglie, Don Cheadle nei panni del Tenente Colonnello Jim
"Rhodey" Rhodes. In Iron Man il ruolo del militare era
interpretato da Terrence Howard.
Il film non stravolge la logica semplice della successione narrativa tipica dei comic movies e all’interno di un
genere ben specifico e dai confini ben nitidi dà il via a
106
un buon sequel e funge da teaser per un terzo episodio attualmente in lavorazione. Come alla fine del primo
film era mostrato il ritorno a casa del protagonista dopo
l’ammissione d’identità e l’incontro con un misterioso
personaggio interpretato da Samuel L. Jackson; allo
stesso modo qui, dopo tutti i titoli di coda, ha luogo una
brevissima sequenza dalla quale si evince che, in Messico,
è stato rinvenuto qualcosa, o qualcuno. Un istantaneo
zoom su un martello nella sabbia e tutto è rimandato
di un anno o due. Si tratta, a quanto pare di Thor, altro
reclutato, dopo Iron Man, nello S.h.i.e.l.d. di Nick Fury,
Jackson.
Lo stare nei canoni del genere non ferma l’iniziativa
di Jon Favreau, anche attore qui, e del suo sceneggiatore, il poliedrico Justin Theroux, brillante attore altrove.
La coppia rende il personaggio di Stark sempre più calzante e consolidato sulle corde di quanto mostrato nel
film del 2008. Il pubblico si affeziona a una figura come
la sua, perfettamente adesa al volto e ai modi di Robert
Downey Jr. Ironico e scanzonato, distrattamente miliardario, avezzo all’alcool e alla compagnia femminile, scurrile e mai banale, si avvicina qui, dopo lunga attesa, alla
sua segretaria Pepper Pots, Gwyneth Paltrow, dopo
aver flirtato con la nuova arrivata, la polifunzionale Natalie Rushman/Natasha Romanoff, Scarlett Johansson.
Il film fa sorridere spesso e ridere a tratti. Avvince
e convince nell’eccesso luccicante del product placement
endemico agli high concept movie come questo. Si arricchisce, poi, del tratto tipico dei sequel di successo per
il quale la riconoscibilità di figure e mezzi è un richiamo all’attenzione dello spettatore che corre a vedere le
nuove avventure dell’eroe. Mancante completamente è,
purtorppo, l’approfondimento dei tratti dell’antagonista
Vanko, del quale è troppo poco detto e solo lasciato
intendere. I connotati per la creazione di una nemesi
mitica, si prenda il Joker di Heath Ledger in Il cavaliere oscuro (The Dark Knight, 2008), ci sono tutti ma
vengono tralasciati in favore del montaggio e del ritmo
sebbene Rourke colmi di se ogni inquadratura.
Montando velocemente insieme battute vincenti,
gadget tecnologici all’avanguardia, un invidiabile lifestyle
e le migliori canzoni degli AC/DC, il film arriva in Italia
inondando il mercato di 604 copie e la programmazione
nelle multisala è oberata per far fronte alla richiesta sia
di biglietti, sia di introiti da parte della distribuzione, incassando 3.536.021 euro nel primo weekend.
Aldo Romanelli
Saw VI
K evin G reuter (USA, 2010)
Anche la saga come il suo diabolico anfitrione Jig Saw
ha una malattia che la divora dall’interno, ed è lo stesso
principio che porta le cellule tumorali o infette a riprodurre altre cellule infette. Ma la proliferazione continua,
e nella sua assoluta mostruosità che porta in scena brandelli impietosi di carne, scene assuefatte di sevizie e negligente refrattarie di ogni morale dimenticata, l’antica
sbudellerai del corso riesce ancora, se non a colpire, a
saziare il retrogusto macabro di ogni insospettabile Dr.
Jekyll.
Ormai completamente disinteressati alla trama, ai colpi
di scena rattoppati, ad una recitazione da cani, a ritorni
dall’oltretomba, gli spettatori chiedono da subito il sangue. E sangue hanno. Ancora prima del titolo il teaser è
eloquente: riprende in matrice l’ormai luogo comune cui
ci hanno abituato i primi episodi, quello del “E dove cazzo
sono moh?” in cui due malcapitati si ritrovano nella Gardaland della sevizia e ci restano secchi o quasi. Qui un
ciccione che si affetta modi mortadella e una figa isterica
che poi si mozza un braccio. Roba da urlo, più credibile
della trippa e dei nervetti che dovrebbero essere i resti
di Strahm (Scott Patterson) o della mano morta con
107
cui Hoffman (Costa Mandylor) va in giro a firmar autografi. Dalla mano chirurgica da bisturi di John (Tobin
Bell) si è passata a quella marcata di Hoffman che impugnato un coltello seghettato, nasconde dietro il velo di
una giustizia sommaria il desiderio unico del sangue.
Saw si cristallizza e si contorce su se stesso come le
spirali rosse ormai brand dell’architettura del terrore o
come gli itinerari frustranti tra porte scorrevoli e congegni infernali cui sono obbligati i malcapitati ospiti. C’è
chi ne vede la forza di una log line ancora in grado di sfuggire alla morsa del tempo e in grado di replicarsi in una
indefinita quantità di monadi infette e chi ne vede solo
l’ultimo guizzo di un corpo agonizzate e condannato a
destino certo. Per sopravvivere alla morte si è riprodotto in fretta (il secondo film fu completato in poco più
di 20 giorni), si è camuffato nel citazionismo di genere,
rifugiato nel flashback poco convincente e molto esplicativo, è divenuto culto, si è autocitato, arrivando nel sesto
capitolo ad istallare come protesi veri e propri spezzoni.
Putrescenze più che fili conduttori...
Gioca. Gioca con la pazienza dello spettatore, con la sua
sadica e ferina voglia di mattatoio, gioca con se stesso
e il genere. È qui che si cela l’aspetto sociologico più
interessante e si consuma una differenza fondamentale
con parte del torture porn di cui ormai è araldo. Da un
lato la rinuncia assoluta da tempo a questa parte ad ogni
accezione metafisica, gotica o soprannaturale. Il male è
qui, oggi, si chiama Guantanamo o Abu Ghraib. Ma se
un certo filone ha portato all’estremo l’assoluta casualità del male, ricalcando la noia borghese di Hostel( Eli
Roth, 2005), è anche vero che il nuovo Gran Guignol
(e il nuovo imbonitore del circo di Jig Saw viene dalla
polizia come per lo storico teatro parigino) ha bisogno
di una giustificazione del male.
Il male insomma può essere una forma artistica peculiare, che mostra la debolezza del corpo umano, non a
caso la tendenza al gore ritorna alla ribalta nell’epoca
dell’edonismo patinato di silicone e riviste; se la pornografia ha avuto origine anche dalle spinte della body art e
del culturismo/edonismo, il gore ricorda vagamente quella sezione estrema cui faceva parte l’azionismo viennese
di Nitsch e del suo Orgien-Mysterien Theater, il teatro delle orge e dei misteri. Proprio come per l’azionismo infatti ci si concentra lentamente sul gesto in modo
che il dolore causato o patito, quello che i media riducono a informazioni asettiche o sensazionali (telegiornali) e spettacolarizzazioni fini a se stesse (horror movie),
ritornino a shoccare come tali. Si pensi alla giostra cui
sono legati gli squali dello studio delle assicurazioni, la
lenta agonia cui sono sottoposti, la consapevolezza della
condanna che spetta all’ultimo di loro.
108
I seguaci del filone continuano a moltiplicarsi dentro, e
fuori il film con lo Splat Pack - Eli Roth, Rob Zombie, Alexandre Aja, James Wan, Darren Lynn
Bousman, Greg McLean, Neil Marshall - e quando
scelgono di veicolare un messaggio possono farlo anche senza mezzi termini e finzioni, dando libero spazio
all’aberrazione come nel caso dell’asiatico Tokyo Gore
Police (Nishimura, 2008) o in Baise Moi - Scopami (Coralie Trinh Thi e Virginie Despentes, 2000).
Diventano un j’accuse generazionale, ma non si va più a
ripescare nelle paure inconsce, nel retaggio gotico. Sulla scomparsa della trascendenza gotica possiamo tessere un confronto con Nightmare, proprio in attesa
dell’uscita del prossimo capitolo della saga.
Anche la nostra generazione è cresciuta quotidianamente con i reportage di guerra, con una pornografia oculata
a grado zero tra l’altro tutto molto più accessibile grazie
al web: per questo il Gore gode di maggiore vigore di
quello che ai tempi fu il New Graphic Horror, che
non disponeva di elementi gore e blood di partenza così
ricchi, da cui si discosta radicalmente. Potrebbe sembrare tipicamente gotica l’ascendenza di una violenza
difensiva che serve a riassestare situazioni di squilibrio:
in una visione di male cosmico, anche i personaggi pre-
sumibilmente buoni giunti alla resa dei conti con il male
sono costretti a ricorrere a questo tipo di violenza fino
a vestire i panni del cattivo. Ma Amanda e Hoffman, così
come la moglie Jill (Betsy Russel) non sono la Nancy
di Wes Craven, una ragazzina che deve espiare le colpe
dei genitori. Il loro è il loro proprio male, non partono da
un’innocenza iniziale, ma dal marcio. L’uomo viene presentato così com’è: il risultato chimico della civiltà della
violenza, senza più orpelli, senza infinite simulazione con
cui nasconde il suo atto primordiale, quello sacrificale,
quello del versamento gratuito del sangue, inizialmente
quello altrui e, grazie alla terapia (d’urto) dell’enigmista,
anche il proprio.
Altro tratto comune evidente è quello della Mad House,
tematica che trova supporto nel capostipite della produzione craveniana, L’ultima casa a sinistra (Wes
Craven, 1972), e ne La casa nera (Craven, 1992), ennesimo capitolo dedicato all’argomento a distanza di un
ventennio. Ma il male made in Jig Saw si muove in senso
contrario rispetto a quello di Nightmare, ad esempio:
se la transizione metaforica di Craven è induttiva e va
dall’universo del micro a quello del macro, perciò ci si
muove dall’universo familiare agli altiforni dell’impianto
industriale, quello di Saw è deduttivo, parte dall’universo industriale per percorrere i micro-drammi familiari.
L’America riscopre l’acqua calda e si rende conto che
ha un servizio sanitario imbarazzante, proprio mentre si
discute del nuovo progetto sanitario obamiano. Come
già successo con Drag Me To Hell e la bolla delle speculazioni edilizie, o Green Zone e la guerra in Iraq servivano i popcorn perché loro i libri, i giornali o anche i
documentari di quel comunista di Michael Moore non
se li filano. È la finta morale. La stessa che porta Tiger
Woods a doversi giustificare pubblicamente per le proprie tresche extramatrimoniali, ma che rende assolutamente normale il sadico spettacolo di Saw se protetto
da una campagna di beneficienza per la donazione del
sangue. God Bless America.
Il male ha qualcosa di biblico. L’Enigmista è schiattato,
ma si ha la paura che resusciti da un momento all’altro,
mo’di primo capitolo, e Dio ce ne scampi per il settimo
capitolo in 3D. È un Cristo pazzo che insegna la via, che fa
sfruttare talenti e mette alla prova per il dono della vita
eterna. O per lo meno fino alla busta successiva. I suoi
discepoli continuano a predicare il verbo. E si scopre che
anche loro si moltiplicano o diventano stacanovisti perché da soli riescono a rapire persone con nonchalance.
Ma del resto non li si può biasimare di certo se i poliziotti a loro volta resuscitano e vorrebbero condurre il
gioco. Tutti vogliono condurre il gioco.
Il nuovo regista Kevin Greuter, storico montatore del-
la serie, dimostra di saper padroneggiare tutti i tasselli, a
volte la fa fuori dal vaso, ma pulisce subito con una bella
spruzzata di sangue. Ma i personaggi nuovi e l’apertura
di una nuova trama non fa altro che ritardare un destino
che comunque prima o poi toccherà anche al burattinaio
per eccellenza. E probabilmente sarà quello che toccò
anche a Freddy, una morte (in)gloriosa in 3D. Speriamo
solo di non doverlo vedere parodia di se stesso o troppo
giuda ballerino, perché Tobin Bell un posto nella storia se
l’è già meritato.
Saw è comunque culto. Nonostante le lacune, nonostante il facile compiacimento e l’adozione di scelte a
volte scontate, a volte troppo tirate, ha riscritto il genere, riportando alla ribalta il torture porn e generando
film cloni, con tutti i limiti che un clone di un clone può
avere. Per ingannare l’attesa che separa dall’uscita nazionale prevista per giugno, una maratona delle mattanze
precedenti non sarebbe male. Oppure lancio un sasso e
nascondo la mano: A Serbian Movie, che tanto in Italia
non sarà mai distribuito.
Luca Colnaghi
Robin Hood
R idley S cott (USA - GB, 2010)
In Come vi piace di William Shakespeare il duca, esiliato nella foresta di Arden, si chiede se quella sua vita
esposta al gelo e ai pericoli non fosse diventata assai più
dolce di quell’altra, affatturata e pomposa della corte: qui,
almeno non c’è adulazione: questi miei consiglieri (il vento
e il gelo) mi fanno sentire al vivo quello che io sono. Con
l’allegra brigata dei suoi buontemponi, il duca si trova a
vivere come il vecchio Robin Hood d’Inghilterra e, come lui,
scambia volentieri le false adulazioni della corte e i suoi
intrighi di potere con i dolci vantaggi dell’avversità.
È questo, forse, il nucleo principale che ci rende simpatica e affascinante la figura di Robin Hood - un simbolo
che piace a tutti, ha detto Ridley Scott - la sua mitica
e idealistica figura di uomo della Natura che combatte
i potenti e dà libertà al popolo. Non per altro lo troviamo nella letteratura inglese per almeno quattro secoli
e nella cultura popolare da un tempo indefinibile. Nel
cinema americano il primo Robin Hood è del 1922 con
Douglas Fairbanks e Mary Pickford.
Lascerò agli appassionati l’andare a ripescare gli eroi in
calzamaglia del passato e mi concentrerò su quest’ultima versione che - in realtà - non convince totalmente.
Ridley Scott, come saprete, è stato anche un grande
pubblicitario così colgo l’occasione per pensare il film
in termini di marketing seriale. Quando il personaggio e
il suo universo narrativo sono appesantiti da miriadi di
testi precedenti, una delle strategie migliori, al cinema, è
109
la di presentarsi sotto mentite spoglie. In realtà, sempre
parlando in termini 'seriali’ (ma non troppo seri, questa
volta) Robin Hood sembra più che altro un remake. Di
quale film? del Gladiatore; tesi che, peraltro, avvalora
l’idea che, più che altro, Scott sia il migliore imitatore
del suo stile al fulmicotone (gli skip frame erano già in
quel film del 2000): a Cannes lo hanno ribattezzato 'Gladiator a Sherwood’. Persino la scelta della location ha
privilegiato la regione del Surrey, la stessa dell’incipit del
Gladiatore.
Potrebbe non piacere la figura che Scott fa fare ai francesi (tra l’altro portando il film a Cannes), potrebbero
non piacere le lungaggini storiografiche, potrebbe persino non piacere troppo il gigionismo di Russel Crowe
- che magari fa rimpiangere il nostalgico e invecchiato
Robin di Sean Connery - ma, di certo, il punto forte del film è Cate Blanchett: il modo in cui cammina, dopo aver appreso della morte del marito, verso la
mdp, inciampando sul terreno sconnesso e sulle proprie
emozioni
Se andate sul sito ufficiale del film e cliccate
sul bottone 'lionhearts program’ avrete, invece, un bellissimo esempio di come si possono trovare, oggi, nuove
forme di marketing incrociato, in questo caso davvero
determinanti e autentiche.
Costanza Salvi
quella del reboot. Si tratta di trovare un ri-avvio, ovvero
una rifondazione del trito contesto narrativo per cercare qualcosa di nuovo. In genere, si fa ripartire tutto
dalle origini. Questa è l’operazione che sta dietro al Robin Hood di Scott: raccontare la nascita del mito sotto
una luce più realistica, sul fondo storico estremamente
accurato che lo sceneggiatore Brian Helgeland (collaboratore di Mel Gibson e autore dello script di Mystic
River) ha rielaborato nel suo tipico modo aggressivo.
Così assistiamo alla nascita dell’eroe in una maniera,
per certi versi, non dissimile dal racconto delle origini
in Batman Begins, entrato nella saga pipistrellesca in
maniera così prorompente e tipico esempio di reboot.
Inoltre il film sembra avere un finale aperto (una sorta
di cliffhanger senza l’elemento di suspance) tanto da far
pensare ad un possibile seguito e ad avvalorare l’operazione (di marketing) del reboot. Curioso è il fatto che
nel tentativo di restaurazione avessero pensato ad una
confusione simulacrale fumettistica: lo sceriffo di Nottingham doveva essere l’identità segreta di Robin Hood.
Invece si è aggiustato il tiro verso l’idea - in fondo non
troppo innovativa - del mascalzone e insincero brutto
ceffo che, però, salva l’intero popolo inglese: la prima
scena lo ritrae come l’uomo 'leale, coraggioso e sincero’
che Riccardo sta cercando ma l’azione successiva è quel110
Draquila l’Italia che trema
S abina G uzzanti (I talia , 2010)
Draquila è un documentario in digitale di un’ora e mezza che dà un’interpretazione a quanto accaduto nei giorni successivi al terremoto de L’Aquila del 6 aprile 2009.
Adoperando diverse forme narrative, il documentario,
l’animazione, il fumetto e la parodia, Sabina Guzzanti
racconta la sua visione dei fatti e, seduta su un cumulo
di macerie, salomonicamente divide i buoni dai cattivi. Le
scelte multiple non sono solo di tipo formale ma anche
interpretative e così la protagonista veste i panni di una
giornalista simile a quelli della redazione di Michele Santoro, di Michael Moore e del Presidente del Consiglio.
Purtroppo per il film l’imitazione del giornalista d’inchiesta non è sufficiente: le luci sempre a favore durante le
interviste più importanti la rendono ancor più furba di
com’è, fa trasparire un protagonismo di fondo ingente e
manca il tratto neorealista tipico delle inchieste di Riccardo Iacona, Alberto Nerazzini, Stefano Maria Bianchi o
Sandro Ruotolo. Purtroppo per il cinema italiano lei non
è Michael Moore e non ce la fa, neppure ci prova in
realtà, a trattenere il suo risentimento per Silvio Berlusconi. Il regista americano riesce sempre, invece, a non
perdere mai la posizione a causa del sentimentalismo o
del personale pregresso, si veda Roger&Me (id., 1989),
e convoglia attraverso l’ironia il proprio messaggio, mandandolo a segno. Purtroppo per lei, per noi e per quegli
aquilani che non lo credono dio, l’imitazione del Presidente del Consiglio non fa più sorridere, non solleva
il morale, non fa confidare che presto la Storia italiana
prenderà un’altra direzione.
In una topografia romana del terremoto de L’Aquila, tutto
per Guzzanti si snoda tra Palazzo Grazioli e Cinecittà. Tra il potere politico e quello televisivo incarnati nel
Presidente del Consiglio, il bastone e la carota utilizzati
con gli italiani in generale e gli aquilani in particolare. In
quei dieci chilometri sta “la dittatura della merda” (cit.),
il suo think tank preciso e spietato. Le lacrime sono 117
chilometri più a Sud e sono tante e per sempre. A tratti
Draquila è un pugno allo stomaco che lega a “quella
gente derubata” per dirla con Pasquale Cicchetti e non
si sente più il livore al quale Guzzanti aveva abituato, non
si sente più niente dopo il forte fischio dell’arrivo del
sisma. Dinanzi allo spettacolo delle rovine lei capisce e
tace. Quanto è mostrato dice tutto.
I fragorosi applausi di chi la ritiene un’eroina, di chi arriva
a paragonarla a Ipazia, sfruttando la concorrente distribuzione cinematografica di Agora (id., Alejandro Amenabar, 2009), di chi le chiede di parlare della Calabria
e del nucleare favoriscono la suggestione con La dolce
vita (id., Federico Fellini, 1960) quando al Caracalla’s
qualcuno domanda ad Adriano Celentano: “Adriano, suonaci
un po’di rock&roll!” e lui scimmiescamente esaudisce in
uno stentato playback.
Dall’incontro con la regista al cinema Astra, Padova, lunedì 10 maggio scorso, questo è parso: la sala piena, la gente
che va a vedere lei e il suo film e crede basti per essere
migliori di chi sta dall’altra parte; la necessità di una presa
di coscienza generale, di una nuova politica e della partecipazione di tutti nel piccolo per condizionare il grande; i
social forum e la censura. In playback, però. Ormai questo
rock&roll del cambiamento e della rivoluzione tanto imminente da non arrivare più suona stantio. E a quelli che
stanno ancora nei campi tenda a L’Aquila non gliene frega
niente né del Popolo Viola né di Nichi Vendola.
Aldo Romanelli
111