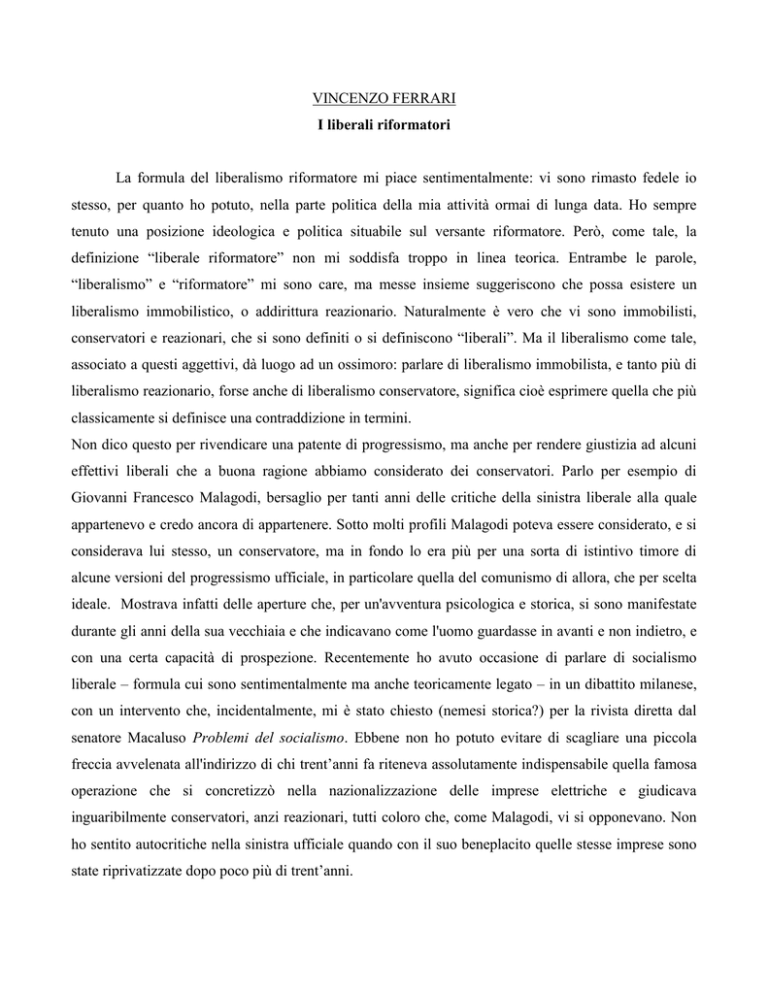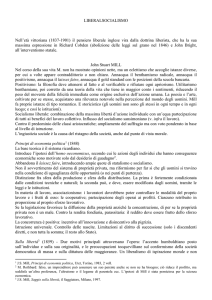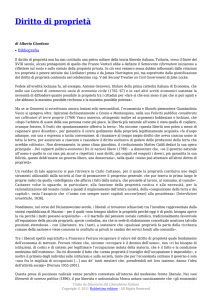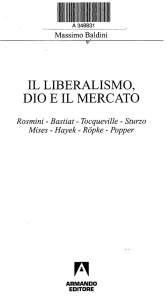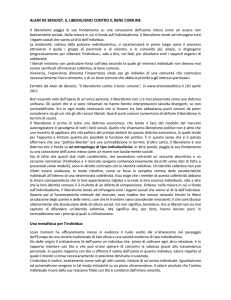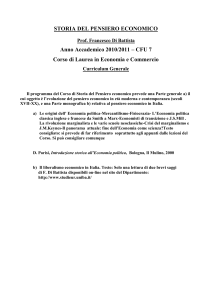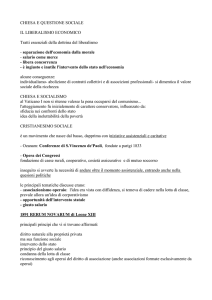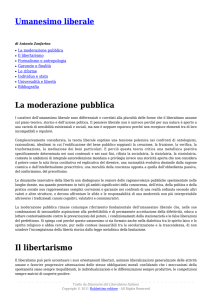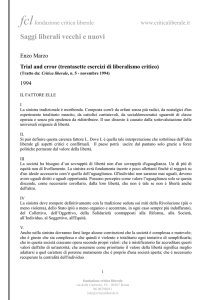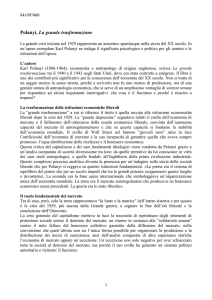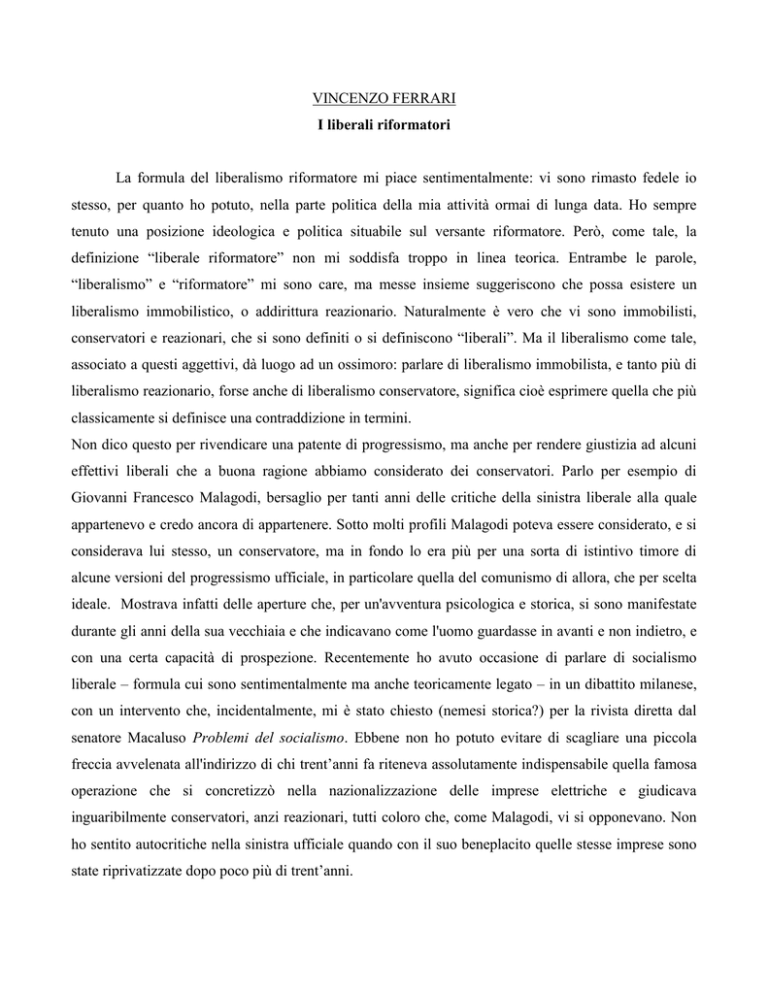
VINCENZO FERRARI
I liberali riformatori
La formula del liberalismo riformatore mi piace sentimentalmente: vi sono rimasto fedele io
stesso, per quanto ho potuto, nella parte politica della mia attività ormai di lunga data. Ho sempre
tenuto una posizione ideologica e politica situabile sul versante riformatore. Però, come tale, la
definizione “liberale riformatore” non mi soddisfa troppo in linea teorica. Entrambe le parole,
“liberalismo” e “riformatore” mi sono care, ma messe insieme suggeriscono che possa esistere un
liberalismo immobilistico, o addirittura reazionario. Naturalmente è vero che vi sono immobilisti,
conservatori e reazionari, che si sono definiti o si definiscono “liberali”. Ma il liberalismo come tale,
associato a questi aggettivi, dà luogo ad un ossimoro: parlare di liberalismo immobilista, e tanto più di
liberalismo reazionario, forse anche di liberalismo conservatore, significa cioè esprimere quella che più
classicamente si definisce una contraddizione in termini.
Non dico questo per rivendicare una patente di progressismo, ma anche per rendere giustizia ad alcuni
effettivi liberali che a buona ragione abbiamo considerato dei conservatori. Parlo per esempio di
Giovanni Francesco Malagodi, bersaglio per tanti anni delle critiche della sinistra liberale alla quale
appartenevo e credo ancora di appartenere. Sotto molti profili Malagodi poteva essere considerato, e si
considerava lui stesso, un conservatore, ma in fondo lo era più per una sorta di istintivo timore di
alcune versioni del progressismo ufficiale, in particolare quella del comunismo di allora, che per scelta
ideale. Mostrava infatti delle aperture che, per un'avventura psicologica e storica, si sono manifestate
durante gli anni della sua vecchiaia e che indicavano come l'uomo guardasse in avanti e non indietro, e
con una certa capacità di prospezione. Recentemente ho avuto occasione di parlare di socialismo
liberale – formula cui sono sentimentalmente ma anche teoricamente legato – in un dibattito milanese,
con un intervento che, incidentalmente, mi è stato chiesto (nemesi storica?) per la rivista diretta dal
senatore Macaluso Problemi del socialismo. Ebbene non ho potuto evitare di scagliare una piccola
freccia avvelenata all'indirizzo di chi trent’anni fa riteneva assolutamente indispensabile quella famosa
operazione che si concretizzò nella nazionalizzazione delle imprese elettriche e giudicava
inguaribilmente conservatori, anzi reazionari, tutti coloro che, come Malagodi, vi si opponevano. Non
ho sentito autocritiche nella sinistra ufficiale quando con il suo beneplacito quelle stesse imprese sono
state riprivatizzate dopo poco più di trent’anni.
Se “liberalismo conservatore” è un ossimoro, la formula di cui discutiamo stasera, “liberalismo
riformatore”, è un pleonasmo, poiché a parer mio il liberalismo è riformatore per definizione, nel senso
che è una teoria che, quanto meno, si pone il compito di interpretare una realtà che avanza e non
retrocede. Il liberalismo comunque la interpreta, e molto spesso la anticipa. Potrei parlare, anziché di
liberalismo riformatore, di liberalismo sociale: formula anch’essa dubbia, che uso qui soltanto a scopo
discorsivo, per denunciare quegli equivoci che scaturiscono da una fonte principale, l’equivoco degli
equivoci, e cioè che il liberalismo sia la teoria dell'individualismo asociale.
Il liberalismo è una teoria politica, al contempo descrittiva e normativa, che prende come punto
di riferimento l'individuo perché nasce dalla rivoluzione umanistica, quella rivoluzione che pone l'uomo
al centro dell'universo. In filosofia politica il liberalismo fu dunque, come si usa dire, l’espressione di
una rivoluzione copernicana, ma non è la teoria dell'individualismo asociale, dell'individualismo
anomico, dell'individualismo egoistico. E’ la teoria politica che pone l'individuo, le sua libertà, la sua
capacità di discernimento, di scelta e di autorealizzazione, al centro dell’indagine e, sul piano filosofico
e sociologico, descrive la società come composta di individui interagenti liberamente, non di atomi
isolati e racchiusi in se stessi, ciascuno nel proprio microcosmo. È una teoria politica che riconosce e
valuta positivamente il conflitto sociale – Einaudi non parlava forse di “bellezza della lotta”? – e
peraltro propone di risolverlo attraverso mezzi che tutti i liberali, salvo nei casi estremi della lotta
contro il tiranno, ritengano debbano essere non-violenti e rispettosi di leggi liberamente e
democraticamente scelte.
Questa dunque non è la teoria dell'individualismo asociale, ma semplicemente una teoria che
individua e descrive la società in un certo modo. Rievocando due classici della sociologia, tra loro
molto diversi, da un lato Émile Durkheim, per cui la società era “un tutto organico”, e dall’altro Herbert
Spencer, per cui la società era “un tutto discreto”, possiamo dire che i liberali vedono la società,
appunto, come un tutto discreto e non come un tutto organico. In fondo, potremmo aggiungere, non la
vedono neppure come un tutt’uno, in quanto la vedono nelle sue molteplici fattezze e sfaccettature,
come un insieme di individui diversi che lottano, competono, cercano anche di prevalere gli uni sugli
altri. Ma nel momento in cui questo desiderio di prevalenza, comunissimo fra gli uomini, sfocia
nell'esaltazione della forza, nella proclamazione del diritto del più forte, cioè del diritto di prevalere in
virtù della forza stessa, siamo fuori dalla teoria liberale, perché il liberalismo è sin dalle sue origini
teoria della liberazione dell’uomo dai vincoli ingiustificati, quei vincoli che taluno, esercitando la forza
(o l’inganno) imponga a tutti gli altri.
2
Il primo individuo che il liberalismo storicamente limita, non a caso, è il più forte di tutti: il re.
È stata precisamente la teoria liberale, nei suoi prodromi e poi, soprattutto, attraverso i secoli che si
sono succeduti dal Seicento in avanti, a mettere in discussione questa visione verticistica della società –
pensiamo alla teoria del diritto divino dei re – e a mettere in discussione l'autorità suprema. Da allora
ogni autorità è divenuta più fragile, esposta alle demistificazioni della dottrina liberale.
Non ho bisogno di ricordare che il capostipite della teoria liberale contemporanea, benché prima
di lui vi siano importanti predecessori, è John Locke. Locke, vorrei sottolinearlo, non è l'unico teorico
del contratto sociale. Lo è anche Thomas Hobbes, che teorizza un doppio contratto sociale, prima un
pactum unionis e poi un pactum subiectionis, come modo per uscire da una condizione primitiva che
egli configurava come di guerra generale, omnium contra omnes. Per dar vita a una società bisognava,
secondo Hobbes, consegnare il potere ad un sovrano “assoluto” perché ab-solutus, padrone di fare la
legge e di disfarla, non obbligato quindi a rispettarla. Il sovrano hobbesiano è il garante di una pace
sociale non altrimenti ottenibile che attraverso una forte compressione delle libertà individuali. Anche
questa è una dottrina politica rivoluzionaria rispetto a quella che giustifica il potere regio come
emanazione e riflesso dell’autorità divina, perché pur sempre afferma che l’autorità politica riceve
un’investitura popolare, dal basso. Tuttavia è una teoria contrattualista illiberale.
La teoria contrattualista liberale è quella di Locke, un autore che perviene a individuare, prima
di tutto, una serie di libertà individuali corrispondenti ad una condizione originaria che l'autore descrive
non come stato di guerra, ma come stato di pace. Uno stato di godimento effettivo, sia pure imperfetto e
soggetto a rischi, di libertà e di correlativi “diritti” che sono “innati” perché connaturali all’essere
umano. Tra queste libertà ve ne sono alcune che a molti fanno paura anche oggi: la libertà di opporsi a
chi detiene il potere, entro certi limiti il diritto di resistervi, quello di emigrare. Si tratta di
riconoscimenti importanti perché contengono in sé il nocciolo del pensiero liberale, ossia la
constatazione che qualunque potere, nel momento in cui si istituzionalizza, tende a raggrumarsi attorno
a chi lo esercita, a trasformarsi in arbitrio, a perpetuarsi anche al di fuori delle regole a cui deve la sua
origine, per cui è indispensabile che vi sia la libertà di opporvisi.
Il liberalismo è dunque la teoria della divisione, anzi della frantumazione del potere, non della
concentrazione del potere, e Locke è il punto di partenza di tutto questo. Che cos'è il contratto sociale
nella versione liberale? L'interazione politica è vista dalla dottrina liberale come frutto di una
contrattazione permanente fra esseri liberi, capaci di obbligarsi vicendevolmente, ma non autorizzati da
una qualche autorità superiore a prevalere sia nel momento della formazione sia nel momento
3
dell'esecuzione del contratto, per parlare da giuristi. Il contratto politico dei liberali non è un contratto
per adesione. I giuristi presenti sanno bene che cosa voglio dire: non è un contratto come quello che ci
fanno sottoscrivere la Telecom, o le compagnie di assicurazioni, o le banche, per cui dobbiamo
necessariamente sottoscrivere e accettare esplicitamente in un modulo prestampato una moltitudine di
clausole che annullano di fatto il potere negoziale del contraente più debole. Quelle clausole che nelle
polizze assicurative sono scritte in corpo invisibile, grigio su grigio o giallo su giallo, e che, alla fine, vi
rendono noto che il danno che avete effettivamente subito non è coperto dal contratto che avete
sottoscritto e quindi non verrà risarcito.
Il contratto liberale non è questo tipo di contratto, cioè non è imposto da un monopolista, o da
un cartello di oligopolisti, che detiene il 100% del potere contrattuale, ad una controparte che non ne
detiene alcuno. Il contratto liberale è un contratto fra uomini liberi. Insisto sul contratto perché è la
sintesi della società liberale: nella visione ideale le clausole di questo contratto dovrebbero tutte essere
frutto di un’interazione fra persone capaci di contrapporsi reciprocamente su un piano di uguaglianza,
cioè occupando uguali spazi di libertà contrattuale. Il contratto infatti è anche un conflitto, nel quale i
contraenti cercano di massimizzare il proprio profitto, la propria quota di libertà, a detrimento dell'altro.
Entro certi limiti si deve ammettere che questo accada. Ma vi devono essere appunto dei limiti
prefissati, e prefissati giuridicamente, sia alle disuguaglianze iniziali, sia a quelle finali.
Il liberalismo è dunque una visione della vita sociale e politica che reclama, desidera, propone il
massimo di libertà di tutti i contraenti. Proprio pochi giorni fa ho terminato di rivedere la traduzione di
un classico che raccomando alla lettura, Ancient Law di Henry Sumner Maine, che uscirà a mia cura
nella bella collana "Civiltà del diritto" dell’editore Giuffrè, diretta da Francesco Mercadante. E’ un
classico bellissimo, di un liberale moderato – un liberale inglese più vicino a Edmund Burke che a John
Stuart Mill – che osserva come le società “progressive”, a differenza di quelle “stazionarie”, si
evolvano da una condizione sociale basata sullo status ad una condizione sociale basata appunto sul
contratto, da una struttura in cui le posizioni sociali sono ascritte alla nascita di ciascun individuo,
ereditate come possono essere la società di caste indù o la società medievale, ad una struttura in cui le
posizioni sociali sono scelte, contrattate e conquistate in un libero confronto.
Contratto quindi, e conflitto. La dottrina liberale è una dottrina conflittuale come lo è quella
marxista, con la sola fondamentale differenza che i marxisti individuano una fine, uno sbocco verso una
perfetta società integrata, cosa questa alla quale i liberali non hanno mai creduto, nel loro fondamentale
scetticismo sulla natura umana. I liberali hanno sempre pensato che il conflitto sia permanente, una
4
specie di motore immobile destinato a perpetuarsi per sempre, in ogni epoca. Una società perfettamente
integrata, una “Città del sole”, non rientra nelle visioni liberali. Ma il liberalismo, come riconosce il
conflitto e proclama la necessità di non spegnerlo, così anche teorizza, e propone la necessità, che il
conflitto stesso sia controllato e “trattato” secondo una metodologia non violenta.
Dunque, per poter contrattare liberamente, gli individui devono essere liberi dai vincoli
preventivi, cioè non subire imposizioni, né da parte delle loro controparti, né da parte di un terzo, com'è
il governo, che favorisca le controparti stesse. Secondo il liberalismo il terzo, cioè il governo inteso in
senso lato come autorità politica, deve essere neutrale: sottolineo, neutrale, non assente.
Quando si proclama il principio della non interferenza dei pubblici poteri, si compie
un'operazione che può anche avere le sue giustificazioni. Ma quando si proclama per esempio l’ideale
dello stato minimo, di cui Robert Nozick è stato il massimo rappresentante, fino a quasi a sconfinare
nell'"anarchismo" liberale (da cui si distanzia con alcune sottigliezze) si compie un'operazione di
grande pericolosità. Lo Stato deve essere neutro, non minimo, per una ragione fondamentale che è ben
visibile nell’analisi di quel settore in cui i liberali sono maestri e che costituisce uno dei nuclei
fondamentali della loro dottrina sociale. Cioè l’economia del mercato.
In economia il liberalismo è la teoria della concorrenza. Questo bisogna ricordarlo: secondo il
liberalismo il mercato deve essere libero e, se non è libero, come diceva proprio Malagodi, deve essere
reso libero e poi mantenuto tale. Ma per rendere e mantenere libero un mercato occorrono delle regole;
infatti un mercato anomico, ossia senza regole, degenera. L'idea di una politica liberale monopolista in
nome della libertà di mercato è l’ossimoro, la contraddizione in termini più vistosa che si possa
immaginare.
La concorrenza è l'esatto opposto del monopolio. Se per rendere e mantenere libero il mercato
occorrono delle regole, occorre anche un'autorità che le riconosca, le proclami e le faccia rispettare,
certo senza soffocare, senza esagerare. Abbiamo un esempio vistoso sotto gli occhi. La Comunità
Europea proclama la libertà del mercato, il mercato concorrenziale come sua filosofia fondamentale. Il
principio su cui essa si basa è quello delle quattro libertà di movimento: “merci, servizi, capitali e
persone”. La sua politica di conservazione dei principi di libertà del mercato è comprensibile, ma
raggiunge dei punti ossessivi. Si è arrivati a regolamentare tutto, ogni più piccolo segmento dell’attività
economica, in un modo così minuzioso che alla fine diventa soffocante. Ma quel tanto di regole
fondamentali che impediscono la formazione di gruppi monopolistici, siano essi palesi oppure non
palesi, occultati dietro i trusts e i patti di sindacato, è coessenziale con il liberalismo.
5
Un sistema economico cessa di essere liberale quando degenera verso la struttura monopolistica.
Se gli individui devono poter contrattare liberamente, essendone garantiti dal governo che essi stessi
contrattualmente scelgono, lo sottolineo ancora, devono entrare nella relazione contrattuale in
condizioni di eguaglianza reciproca. Qui va detto che si è sempre distinto tra eguaglianza formale ed
eguaglianza sostanziale. Non so quanto abbia senso questa opposizione: un'uguaglianza che esista solo
formalmente sulla carta rischia di essere la giustificazione retorica dell'oppressione. Non c'è bisogno di
scomodare Carlo Marx; basta ricordare che lo stesso nostro progenitore, Luigi Einaudi, ha condotto
sotto questo profilo una serie di osservazioni importanti, per esempio nel campo del lavoro.
Questo problema dell'uguaglianza mi impone di compiere alcune precisazioni, ancora una volta,
sul rapporto tra libertà e uguaglianza. Sono precisazioni alle quali io sono legato anche perché mi è
capitato di insistervi molte volte e in occasioni diverse, anche nel contesto di un’ormai antica
discussione che ebbi la ventura di condurre con Ralf Dahrendorf quasi vent’anni fa, quando lo
intervistai a lungo per la Casa Editrice Laterza sul liberalismo e la politica europea.
È’ assolutamente vero che libertà e uguaglianza sono due termini diversi. Come disse
Dahrendorf in quella vecchia intervista, e come ha ripetuto tante volte Bobbio, il liberalismo è stato
sempre inteso come la bandiera della libertà, mentre il socialismo è stato per molto tempo assunto come
la bandiera dell'uguaglianza. Non dimentichiamo però che il liberalismo ha sempre detto, con molto
fondamento, che il metodo della libertà è anche quello che consente di conseguire il massimo
dell'uguaglianza possibile. Il marxismo ha detto, o cercato di dire, la cosa inversa: solo una condizione
di uguaglianza permette di conseguire, alla fine di una più o meno lunga serie storica, la totale libertà
individuale. Ho fatto questo esempio per dimostrare come, in fondo, entrambi i grandi corpi di teorie
politiche umanistiche degli ultimi secoli, cioè il liberalismo e il socialismo (la democrazia è bensì una
terza e distinta teoria, che però riguarda non la totalità dei rapporti umani ma soltanto i metodi di
gestione della cosa pubblica) hanno preso a cuore tanto la libertà quanto l'uguaglianza, magari
sbagliando, incorrendo in aporie, abbandonandosi ad illusioni, cozzando contro le dure repliche della
storia come si suol dire.
Invero, libertà e uguaglianza sono bensì due concetti diversi, ma sono uno il riflesso dell'altro
per una ragione evidente: che, come riconosceva Immanuel Kant, e dopo di lui Stuart Mill e molti altri
autori dietro i quali mi posso tranquillamente nascondere, quando non si parla di libertà di coscienza, di
pensiero, di espressione, ma si parla di libertà sociale, della libertà che regola i rapporti interattivi tra gli
individui, fatalmente la mia libertà collide con la libertà del mio vicino. Nel momento in cui devo
6
contrattare con il mio vicino l'unico modo ragionevole, e ragionevolmente morale, di gestire la
relazione consiste nel tracciare un’ideale linea mediana tra noi due, e questa è la linea dell'uguaglianza.
Quando parliamo di libertà economiche e sociali, l'uguaglianza è dunque nient’altro che il
riflesso sociale della libertà. Dicevo che liberalismo e socialismo si sono presi a cuore i due concetti da
posizione opposte; i liberali ritengono che la massima eguaglianza possibile sia ottenibile attraverso la
libertà, il socialismo, in particolare il marxismo, ha predicato al contrario l'utopia di una libertà assoluta
attraverso l'assoluta uguaglianza: un’uguaglianza che non è mai stata raggiunta perché quello che,
purtroppo, le dottrine socialiste hanno ignorato per tanto tempo è stato uno dei più grandi principi
liberali, che il potere tende a perpetuare se stesso e se lo si concentra, come dicevo poco fa, si
cristallizza nelle mani di un'élite che poi diventa difficilmente scalzabile. Anche quella liberale, la
massima eguaglianza possibile attraverso la libertà, è una utopia, ma lo è in senso debole, un ideale
meritevole di essere perseguito anche se non è realizzabile nella sua integrità. Quella marxista invece è
stata una utopia in senso forte, l’ideale di una società perfetta, un modello estremamente pericoloso
secondo il pensiero liberale perché suscettibile di offrire forti argomenti a favore di un oppressore. Non
ho bisogno di ricordare le dure critiche di Karl Popper ai teorici delle utopie forti e della società
“chiuse”.
Cambiano la società, la tecnologia, la cultura, l'economia, e soprattutto cambiano le persone, i
loro progetti, i loro ideali, le loro utopie. Il liberalismo è la teoria non solo del contratto sociale in sé,
ma è anche la teoria del contratto sociale permanente: cioè non si contratta una volta sola, ma si
continua a contrattare. Questo lo ha detto assai bene anni or sono, in Italia, un autore che pure proviene
da un’educazione prossima al marxismo, Salvatore Veca, il quale, mentre veniva diffuso nel nostro
paese il pensiero di John Rawls con la traduzione di A Theory of Justice, se ne è fatto un po' l'interprete
e ha messo in rilievo come vi sia una fondamentale inerenza fra il concetto di conflitto e il concetto di
contratto, come ho detto poco fa. Ora, se è permanente il conflitto è permanente anche il contratto.
Bisogna essere sempre disposti e pronti a contrattare e ricontrattare; non per nulla i liberali sono gli
assertori della società aperta, di una società che permette di cambiare, riprendersi, automodificarsi,
riscattarsi, rimettersi in gioco. Mi viene in mente un noto libro di Lawrence Friedman (che non va
confuso con Milton), giurista e professore a Stanford: The Republic of Choice, apparso nel 1990. Il
liberalismo vede la società come un campo di scelte permanenti. Friedman osserva che la società
liberale ottocentesca era, sotto molti profili, meno aperta e pronta alle scelte di quanto non sia la società
di oggi; la famiglia era patriarcale e pervadeva, assorbendole, tutte le decisioni individuali, il divorzio
7
era pressoché universalmente vietato, l'attività economica era più rigidamente regolamentata di quanto
non sia oggi, esisteva il carcere per debiti (talvolta viene da rimpiangerlo di fronte a certe insolvenze
programmate a scopo truffaldino). Oggi più che mai il contratto liberale è un contratto permanente, e
questo precisamente è un punto dolente delle forze conservatrici che si proclamano “liberali”, le quali si
arrestano a quel campo di scelte che è stato teorizzato e vissuto precedentemente, quando la società era
diversa. Un liberalismo che non voglia cambiare cessa di essere liberale.
C'è da chiederselo, naturalmente: cambiamenti progressivi o "progressisti"? E c’è anche da
chiedersi, più in generale, esiste davvero il “progresso”? Non lo so. Dahrendorf ricordava anni or sono
che gli ultimi a parlare seriamente di progresso, nell'ambito delle scienze sociali, sono stati Morris
Ginsberg, l'allievo di Leonard Trelawney Hobhouse, e Richard Henry Tawney. In realtà da 40-50 anni
nessuno ne parla più. Si diffida di un concetto che è apparso scientificamente fuorviante e politicamente
pericoloso. Ma ancora una volta, come per l’utopia, bisogna distinguere fra progresso in senso debole e
progresso in senso forte. Ciò che i liberali rifiutano è l’idea di un progresso inevitabile, unilineare,
determinato e deterministico, l’idea della fine della storia. Hegel, che aveva questa idea, non è un
pensatore liberale; in Marx ci sono forti fermenti liberali, come riconosceva Benedetto Croce, ma non è
certo liberale, non tanto perché teorizzi la lotta di classe, quanto piuttosto perché individua un esito
inevitabile e invariabile, per cui tutto ciò che fuoriesce da quel binario – che per i liberali è un binario
verso l'infinito ed è invece per lui un binario verso il finito – è come tale da condannare. In questo senso
forte non ci si può proclamare progressisti, né si può parlare di progresso. In realtà la società ci mette di
fronte continuamente anche le debolezze dei nostri tradizionali concetti di progresso: chi 25 o 30 anni
fa, nell'ambito della sinistra liberale alla quale appartengo, avrebbe messo seriamente in discussione il
principio dello Stato del benessere? Credo che fino alla guerra del Kippur del settembre 1973 – in
quegli anni facevo politica liberale a livello europeo – non ci fosse un solo liberale di destra o di
sinistra in tutta Europa, tranne alcune patetiche frange ultraliberiste, che mettesse in discussione l'idea
del Welfare State. E poi, come spesso accade nella storia umana, nell’arco di pochissimi giorni, mentre
il prezzo del petrolio aumentava a dismisura e ci siamo trovati in mano dopo pochi mesi i microassegni da 50 e 100 lire che ricordavano le “Am-lire” dell’occupazione militare post-bellica, in una
situazione in cui i pochi risparmi degli italiani si sono volatilizzati, ci siamo accorti che lo Stato del
benessere – forse – costava troppo rispetto alle possibilità delle nostre economie. La capacità di
autocriticarsi – che come dice bene Valerio Zanone nel suo L’età liberale, cioè di ripensare
criticamente alle proprie posizioni, è il tratto distintivo principale del liberalismo – ha portato per
8
esempio Ralf Dahrendorf, che era stato uno dei protagonisti della svolta a sinistra del Partito liberale
tedesco in tempi di welfare, a denunciare con forte anticipo sui tempi i limiti di questa formula politica,
in quanto moltiplicatrice di aspettative destinate ad essere soddisfatte con un vertiginoso aumento della
spesa pubblica e dell’inflazione, o ad essere deluse. Questo, Dahrendorf lo diceva parecchi anni prima
di Niklas Luhmann, il pensatore conservatore che negli anni ottanta è stato eletto a maître à penser
anche dalla sinistra italiana.
Come affrontare oggi un problema del genere adottando un concetto debole e liberale di
progresso? Possiamo pensare di tornare a una società non protettiva o saremo richiesti perentoriamente
di estendere la protezione sociale su una scala che trascenda i confini dei paesi sviluppati? Poco fa ho
parlato delle varie libertà di movimento che sono all'origine della Comunità Europea, che ne
costituiscono, come dire, la costituzione materiale, cioè merci, servizi, capitali e persone. Il mondo, non
solo la Comunità Europea, ha ormai sperimentato il più ampio grado mai raggiunto nella storia della
libertà di movimento di merci, servizi e capitali. Il movimento delle persone invece non è stato tanto
protetto come i suoi tre confratelli. Se nei paesi dell'Occidente rischiamo di soffrire una crisi economica
che si traduce in disoccupazione endemica, ciò accade anche perché la concorrenza nell'ambito del
mercato del lavoro da parte dei paesi in via d sviluppo è fortissima e può essere tale da non lasciarci vie
di scampo, proprio perché il movimento delle persone in larga misura è fortemente controllato. La
suddivisione del mondo secondo quel modello che abbiamo ereditato fin dalla fine del ‘600, il modello
del mondo suddiviso in una serie di stati sovrani, e che è stata superata e trascesa da una serie di
movimenti liberi che passano ben sopra gli stati, in realtà è quella che ancora regge il mercato del
lavoro mondiale. Le imprese vanno a cercare la manodopera là dove costa meno, dove non è
sindacalizzata, ciò che pone problemi di concorrenza fortissima ai paesi, come i nostri, in cui invece la
manodopera costa ed è sindacalizzata. È questa oggi la sintesi del problema, che 20 anni fa fu visto
come problema della crisi del Welfare State. Come lo devono affrontare i liberali? Questo è un quesito
che mi pongo, e vi pongo. Perché non ho la risposta: forse ce l'hanno i più giovani perché hanno più
fantasia costruttiva, mentre noi forse possiamo dare un contributo analitico, più che un contributo
propositivo. Oggi si parla molto del concetto di cittadinanza, uno dei problemi fondamentali su cui la
scienza dibatte da alcuni anni: ci si chiede se il concetto di cittadinanza debba essere riformulato come
concetto transnazionale, uscendo dalla logica nazionalistica alla quale lo si è sempre riportato. Il
problema del diritto al lavoro e della protezione del lavoro, quindi delle garanzie di welfare a livello
9
mondiale, è al centro dell’agenda della società mutevole di oggi. Non possiamo mancare di rispondere
ai quesiti che ne derivano.
Ora, io ho fatto questo esempio dello stato del benessere soltanto per dire che non bisogna avere
paura di misurarsi con il cambiamento, anche se il cambiamento pone dei problemi ai quali non siamo
pronti, ai quali non possiamo rispondere con formule tradizionali.
Termino facendo una carrellata storica. Sto leggendo il libro succitato di Valerio Zanone, caro
amico con il quale ho condotto delle battaglie politiche di cui ho qualche nostalgia. Il suo libro
conquista perché denota una profondità di pensiero e una capacità di analisi, e inoltre una competenza
storica, che immediatamente spiegano il motivo per cui Zanone non ha oggi il successo politico che ci
si poteva aspettare da lui. Il livello della discussione politica in questo paese è sceso in maniera così
vertiginosa negli ultimi anni da far sì che chiunque parli in maniera più evoluta rispetto alla media, che
si esprime per slogan urlati e spesso per insulti, per ciò stesso non abbia successo. Ho anche notato però
che c'è una sottile paratia che pur sempre mi divide da Zanone. Diceva il presidente di questa riunione
che tutti i liberali si considerano più liberali del proprio vicino. Io non mi considero più liberale del mio
vicino e anzi non credo che esista il prototipo, l'archetipo del liberalismo. Ognuno di noi è liberale a
suo modo. Io sono molto vicino a Zanone, ma c’è una sottile differenza che ci divide e che è rivelata
dall'indice dei nomi del suo libro, nel quale ho ritrovato molti autori su cui non ho la familiarità che ha
lui, ma non altri che mi sono cari. Per me il liberalismo è Locke, e certamente Kant, e anche
Tocqueville: pensate oggi al problema della transnazionalità alla luce dello scritto di Kant per un
progetto di pace perpetua. Però il liberalismo sono anche Beccaria e i fratelli Verri, e il garantismo
processuale speso per gli imputati deboli, oltre che per quelli forti, come si tende a fare oggi in Italia. E
in Inghilterra Bentham e tutta la corrente utilitarista e soprattutto Stuart Mill (autori che compaiono
marginalmente nel libro) e, voglio sottolinearlo, Henrietta Mill, all’origine del femminismo. Ho notato
con qualche amarezza che Mill compare nel libro quasi casualmente, anche se la simpatia che il libro
stesso mi ispira non potrebbe per questo indurmi a indirizzare all’autore le critiche che ho dedicato al
volumetto di Giorgio Rebuffa, La costituzione impossibile del 1995. Dissi allora in una recensione che
il liberalismo di Rebuffa, il quale proviene anche lui da un'educazione marxista, sembra si sia fermato
alle libertà civili di Locke: ma dopo le libertà civili ci sono state le libertà politiche, le libertà sociali, le
altre tappe del movimento dei diritti umani. Siamo giunti alla “quinta generazione” di questi diritti e
Mill è, nell’Ottocento, la figura centrale di un movimento liberale che ha capito e teorizzato, accanto ai
diritti civili e politici, anche i diritti sociali di cui Thomas Marshall avrebbe parlato un secolo dopo.
10
Rileggevo proprio oggi quelle pagine mirabili che sono contenute nel saggio sulla libertà. Questo è il
Mill liberale puro, che reclama il principio della libertà e della non interferenza nella sfera di ciascuno e
afferma che non si può imporre a nessuno una concezione della felicità. Ma accanto al Mill del saggio
sulla libertà vi è il Mill che riconosce la libertà del prossimo, c'è il Mill che critica le successioni mortis
causa in maniera più aspra di quanto non abbia fatto lo stesso marxismo, dando vita ad una corrente
che ha trovato in Italia due grandi interpreti con Eugenio Rignano e lo stesso Luigi Einaudi. Certo, ci
sono mille modi per evadere le imposte di successione, ma il principio fondamentale, per cui non è
ammissibile che la libertà di una generazione diventi privilegio della seconda generazione e più ancora
della terza in virtù dell'accumulo di potere e di ricchezza, questo è il principio di John Stuart Mill.
Per me il liberalismo è anche quella speciale corrente di socialismo che in Inghilterra è andato
sotto il nome di socialismo fabiano e, accanto ad esso, tutta quella grande corrente di sinistra liberale e
di social liberalism che è rimasta praticamente sotterranea e raramente viene riscoperta. Liberale è
certamente Hobhouse, anche se un po’ troppo passionale in alcune sue analisi. E Carlo Cattaneo e
certamente Benedetto Croce, come sappiamo tutti, ma anche Max Weber, di cui Zanone parla
soprattutto per l' “ascetismo capitalistico” de L’etica protestante e lo spirito del capitalismo. Ma Weber
è anche altro, è la distinzione dei compiti dello scienziato da quelli del politico e soprattutto l’autore di
Economia e società, colui che ha riformulato e rifondato la sociologia assumendo per base l’azione
volontaria degli individui, da interpretare nel suo “senso” e da spiegare nella sua complessa eziologia, e
precedendo di 30 o 40 anni la sociologia ermeneutica. Weber è un autore che ha saputo mirabilmente
collocarsi su una posizione intermedia equilibrata fra la tradizione tedesca di liberalismo nazionalista e
quella altrettanto tedesca, ma non meno viva, di liberalismo libertario. Certamente è liberale Einaudi, il
maestro di tutti noi, e lo è anche Gobetti, ma lo sono anche Carlo Rosselli, e Guido Calogero, e
certamente Hans Kelsen che con grande piacere ho trovato nel libro di Zanone, e con lui naturalmente
Bobbio e la Arendt e Dahrendorf, ma anche Jo Grimond, quel grande personaggio che fu il leader del
liberalismo radicale inglese negli anni Cinquanta e Sessanta, il teorico del “riallineamento della
sinistra” su basi liberali; e certo John Rawls, ma anche e soprattutto Bertrand Russell e, in Francia,
quel grande epistemologo che è Raymond Boudon. Alcuni di questi, ripeto, li ho trovati
occasionalmente o meno occasionalmente nel libro di Zanone, ma non ho trovato con la nettezza che
avrei voluto il filone che confluisce in quella che io chiamo la critica liberale, e questa è la sottile
paratia che mi distingue da lui.
11
Ma se dovessi scegliere ancor oggi un compagno di battaglie politiche, tra i miei compagni
sceglierei certamente Valerio Zanone. Non so se lui possa essere considerato di sinistra e se
accetterebbe di stare dalla mia parte; io mi considero a sinistra, per quel che vale l’espressione: ma
arrivati a questo punto, non so neppure se questa sia una discriminante assoluta.
12