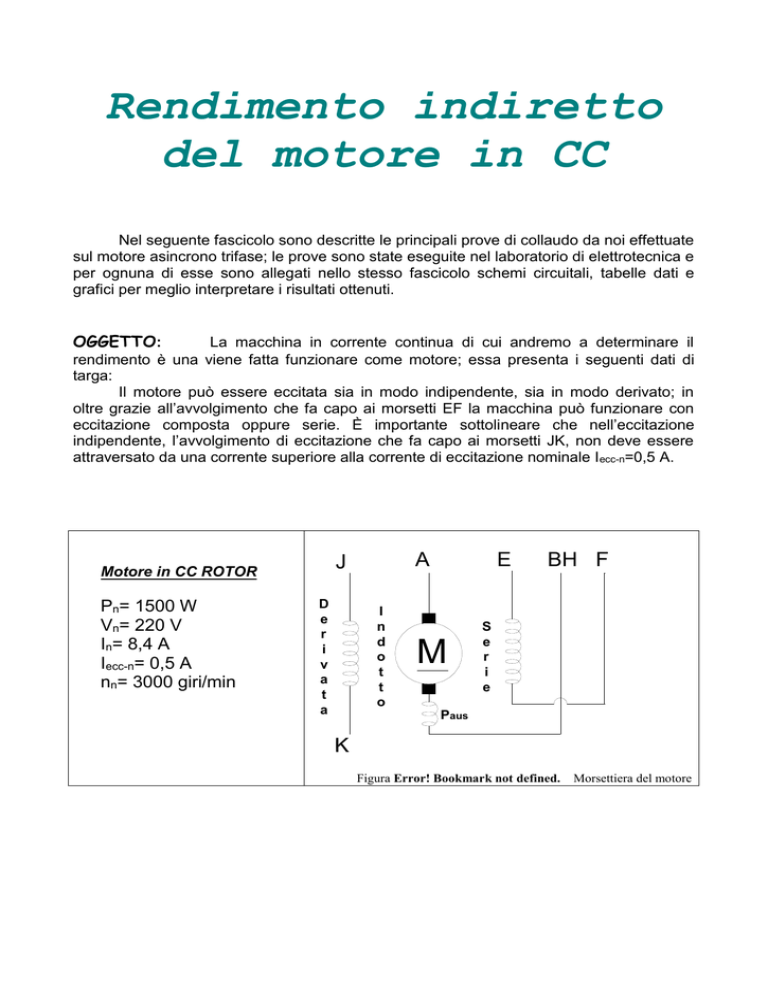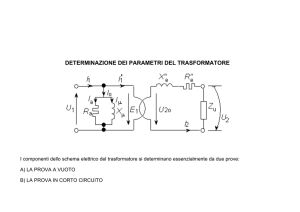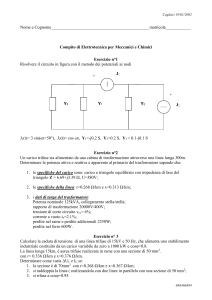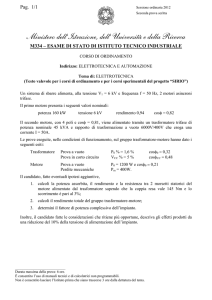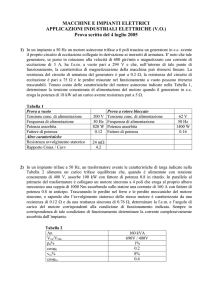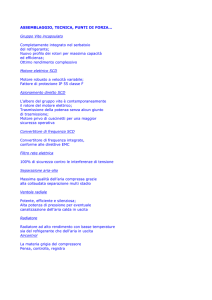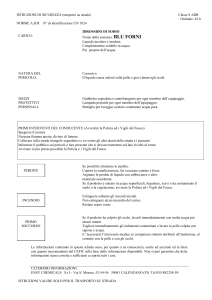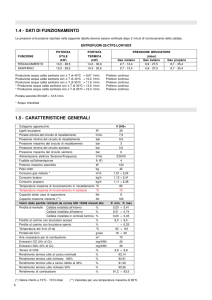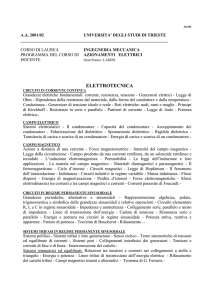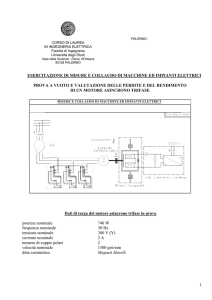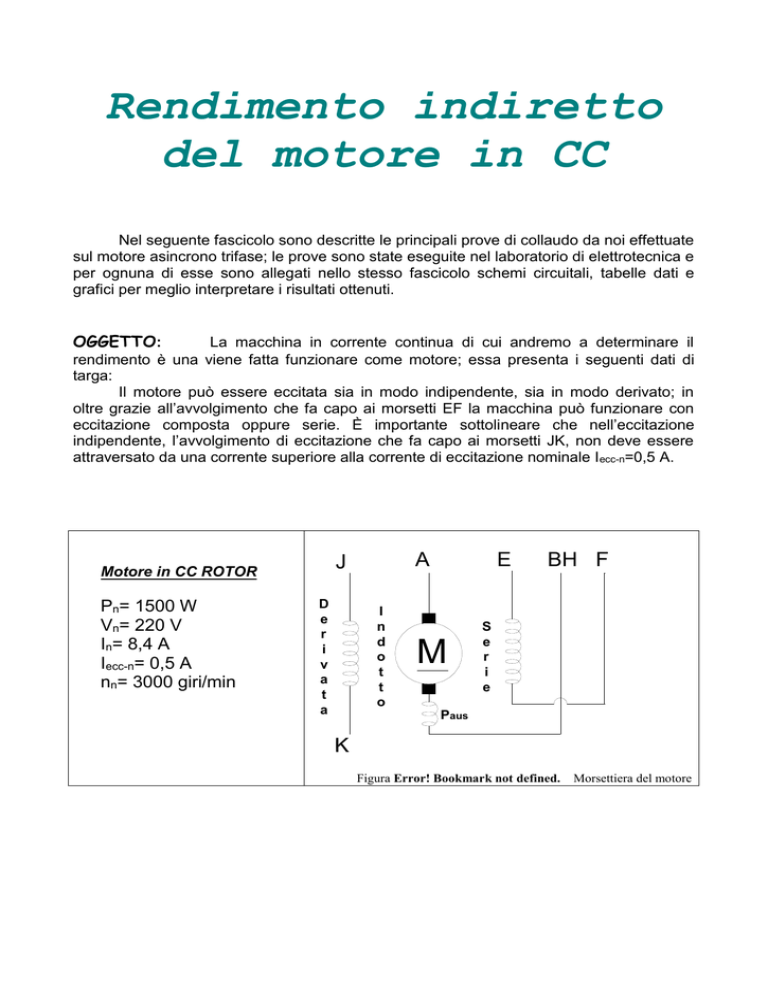
Rendimento indiretto
del motore in CC
Nel seguente fascicolo sono descritte le principali prove di collaudo da noi effettuate
sul motore asincrono trifase; le prove sono state eseguite nel laboratorio di elettrotecnica e
per ognuna di esse sono allegati nello stesso fascicolo schemi circuitali, tabelle dati e
grafici per meglio interpretare i risultati ottenuti.
OGGETTO:
La macchina in corrente continua di cui andremo a determinare il
rendimento è una viene fatta funzionare come motore; essa presenta i seguenti dati di
targa:
Il motore può essere eccitata sia in modo indipendente, sia in modo derivato; in
oltre grazie all’avvolgimento che fa capo ai morsetti EF la macchina può funzionare con
eccitazione composta oppure serie. È importante sottolineare che nell’eccitazione
indipendente, l’avvolgimento di eccitazione che fa capo ai morsetti JK, non deve essere
attraversato da una corrente superiore alla corrente di eccitazione nominale I ecc-n=0,5 A.
Pn= 1500 W
Vn= 220 V
In= 8,4 A
Iecc-n= 0,5 A
nn= 3000 giri/min
A
J
Motore in CC ROTOR
D
e
r
i
v
a
t
a
I
n
d
o
t
t
o
E
M
BH F
S
e
r
i
e
Paus
Figura Error! Bookmark not defined.
Morsettiera del motore
SCOPO:
Tracciare la curva che descrive l’andamento del rendimento al variare del
carico.
PREMESSA:Per la determinazione del rendimento della macchina si ricorre alla formula
generale del rendimento valida per qualunque dispositivo, elettrico o meccanico che sia,
che si basa sulla determinazione delle potenze erogate ed assorbite.
Per
Pas
Pas
Per
M
Ut
Pp
Figura 2 Schema delle potenze
Nella specificità del nostro caso la potenza assorbita è di tipo elettrico e viene
fornita da un alimentatore in corrente continua, mentre la potenza erogata è di tipo
meccanico; il rendimento della macchina è dato dal rapporto di queste due grandezze, e
presenta un andamento a campana se riportato su piano cartesiano in funzione della
corrente erogata.
Il rendimento del motore in corrente continua può essere determinato in due modi
differenti a seconda dei dati in possesso, si può usare il metodo diretto oppure il metodo
indiretto.
a)
Metodo diretto
Il metodo diretto si può applicare se abbiamo sia il valore della potenza elettrica di
ingresso e sia il valore della potenza meccanica in uscita. Questi valori li possiamo
ricavare se conosciamo la coppia e la velocità per la potenza erogata, e se conosciamo i
valori di tensione e corrente per la potenza assorbita.
In questo caso il rendimento sarà dato dalla potenza erogata diviso la potenza
assorbita.
b)
Per
Pas
Per T
Metodo indiretto o convenzionale
2 n
T
60
Pas Val I as
Il metodo indiretto invece lo possiamo applicare se conosciamo il valore della
potenza elettrica assorbita dalla macchina e le singole perdite interne del motore; in
questo caso il rendimento sarà dato dalla potenza assorbita meno la somma delle
potenze perse internamente, diviso la potenza assorbita.
Le singole perdite interne si possono ricavare in diversi modi; le perdite Joule
di indotto e le perdite Joule del circuito di eccitazione si possono ricavare dalla
misura delle resistenze degli avvolgimenti; le perdite meccaniche e le perdite nel
ferro si possono ricavare dalla prova a vuoto del motore; le perdite per contatto
spazzole e le perdite addizionali, invece, si calcolano convenzionalmete.
l’equazione esplicativa è la seguente
Per Pas Pp Pas Pmp Pfe PJi _ tot PJecc Pcs PAdd
Pas
Pas
Pas
è facile constatare che il rendimento sarà ovviamente sempre minore di 1 in quanto
il denominatore risulterà sempre maggiore del numeratore; la sommatoria delle potenze
perse e composta dai seguenti termini:
Pmp
è la potenza meccanica che viene dissipata dalla macchina durante la rotazione
dell’albero; essa è costituita dalla potenza trasformata in calore in prossimità dei
cuscinetti a sfera che sostengono l’albero, e la potenza utilizzata da un ventola
fissata all’albero stesso per il raffreddamento della macchina.
Pfe
sono le classiche perdite nel ferro dovute a correnti parassite e al ciclo d’isteresi; è
importante osservare però le perdite nel ferro sono localizzate soltanto nei punti
costituiti da materiale ferromagnetico immersi in un campo magnetico variabile,
quindi a causa della sua rotazione rispetto al flusso dei eccitazione la parte ferrosa
del rotore della macchina è sede di tali perdite; non vale lo stesso discorso per la
scarpa polare e tutto il circuito ferromagnetico di eccitazione, in quanto interessato
da un flusso generato da una corrente continua e quindi non variabile. La potenza
dissipata nel ferro provoca il riscaldamento delle pari ferrose stesse.
PJi _ tot
le perdite joule totali interessano tutti gli avvolgimenti percorsi dalla corrente
d’indotto,
quindi saranno interessati: avvolgimento d’indotto, avvolgimento dei
poli ausiliari e avvolgimento serie se previsto; la potenza si dissipa sempre sotto
forma di energia termica
PJecc
della stessa natura delle perdite nell’indotto, le perdite joule per eccitazione
interessano il circuito di eccitazione e la corrente che lo percorre
Pcs
sono dovute alla caduta di tensione che si ha ai capi delle spazzole nel
funzionamento a carico della macchina; il valore di tale caduta di tensione è
determinato convenzionalmente ed è pari a 0,6 V per coppie di spazzole dure
metalgrafitiche o 2 V per coppie di spazzole morbide di carbone o grafite.
PAdd
sono perdite convenzionali che tengono conto di tutte le potenze dissipate non
misurabili direttamente
Le potenze si determinano nei seguenti modi
Pas
PJi _ tot
e PJecc
Pmp Pfe
Pcs e PAdd
V I as MISURA DI V - I
MISURA DI Rind e Recc
PROVA A VUOTO CON FUNZIONAMENTO DA MOTORE
NORME CEI
MISURA DELLE RESISTENZE
a)
Resistenza d’indotto
Per la determinazione della resistenza d’indotto si fa riferimento al seguente circuito
A
A
V
BH
Figura 3 Schema elettrico per la misurazione della resistenza d'indotto
L’indotto è costituito da più avvolgimenti idealmente di uguale resistenza; dato però
che nella pratica ci saranno delle piccole differenze fra avvolgimento e avvolgimento, si
procede misurando la resistenza di quattro avvolgimenti, rispettivamente a 0°,90° ,180° e
270°, con il metodo voltamperometrico; l’operazione nell’atto pratico viene svolta,
estraendo le spazzole in carbone ed inserendo al loro posto, a contatto delle lamelle del
collettore, delle apposite sonde. I valori misurati sono i seguenti:
Posizione
V
I
°
mV
mA
R
0°
0°
0°
90°
90°
60
166
398
131
265
90
250
576
191
386
0,667
0,664
0,691
0,686
0,687
90°
180°
180°
180°
270°
270°
270°
371
79
252
400
96
213
360
538
115
366
580
145
320
535
0,69
0,687
0,689
0,69
0,662
0,666
0,673
Rind _ media 6,679
si può notare che il valore di resistenza misurato è giustamente piuttosto limitato, in
quanto l’indotto viene percorso da correnti abbastanza elevate.
b)
Resistenza serie e poli ausiliari
Per praticità di esecuzione si è deciso di rilevare i valori delle due resistenze
mediante una sola prova che fa riferimento al circuito seguente:
BH E
V
F
A
V
M
A
Figura 4 Schema elettrico per la misurazione della resistenza serie e poli ausiliari
Anche in questo caso si usa il metodo voltamperometrico, inserendo due voltmetri
in parallelo alle due resistenze da misurare per semplificare le operazioni. I risultati ottenuti
sono i seguenti:
Avv. Serie
Avv. ausiliario
V
I
R
V
I
R
mV
MA
mV
mA
46,5
228
0,204
212,7
419
0,508
81
400
0,203
277,9
545
0,51
112,5
556
0,202
332,1
652
0,509
Rser _ media 0,202
Raus _ media 0,509
c)
Resistenza eccitazione derivata
il modo di procedere è sempre lo stesso questa volta la tensione applicata è
dell’ordine dei volt in quanto la resistenza derivata ha valori piuttosto alti
J
A
BH
M
V
A
K
Figura 5 Schema elettrico per la misurazione della resistenza eccitazione derivata
V
I
V
mA
R
9,9
13,72
16,66
28
40
49
353,6
343
340
Rder _ media 345
PROVA A VUOTO CON FUNZIONAMENTO DA MOTORE
La prova a vuoto con funzionamento come motore serve a determinare la somma
delle perdite nel ferro e delle perdite meccaniche; essendo esclusivamente provocate dalla
rotazione dell’albero esse vengono estrapolate dalla potenza assorbita dal motore
funzionante a vuoto con eccitazione indipendente secondo la seguente relazione:
Pmp Pfe P0 PJ 0 Pcs
dove si sono indicate con P0 la potenza elettrica assorbita a vuoto, PJ0 le perdite
joule a vuoto, e con Pcs le perdite per contatto spazzole. Si nota che essendo questi ultimi
due termini dipendenti dalla corrente d’indotto, che a vuoto è molto limitata, la potenza
assorbita a vuoto va a compensare quasi esclusivamente le perdite nel ferro e le perdite
meccaniche.
Il circuito utilizzato nella prova è il seguente:
A
A
E
BH F
J
D
M
K
A
V
Paus
Figura 6 Schema elettrico per la misurazione delle perdite meccaniche e nel ferro
È importantissimo sottolineare che durante il funzionamento come motore non deve
mai essere aperto il circuito di eccitazione per evitare un aumento incontrollato della
velocità. Ci si deve assicurare quindi che sia prima dell’avviamento, che sia dopo l’arresto,
il circuito di eccitazione rimanga sempre alimentato. Nella prova vengono rilevate le
correnti assorbite e di eccitazione e la tensione di alimentazione:
V0
V
I1
A
P0
W
PJ0
W
PCS
W
Pm+Pfe
W
Iecc
A
V02
V
200
180
150
0,75
150 0,668
0,635 114,3 0,479
0,62
93
0,457
1,5
1,27
1,24
147,8 0,5 40000
112,6 0,352 32400
91,3 0,235 22500
120
0,71
85,2
0,599
1,42
83,18 0,126 14400
90
60
0,87
1,22
78,3
73,2
0,899
1,768
1,74
2,44
75,66 0,111 8100
68,99 0,065 3600
Sono stati successivamente calcolati i valori mancanti tramite le seguenti equazioni:
P0 V0 I 0
PJ 0 Rind _ tot I 02
e
Pcs 2 I 0
V02 V02
Pmp Pfe P0 PJ 0 Pcs
nelle perdite per contatto spazzole si è usato il valore 2 V in quanto il motore in
questione presenta spazzole in carbone. Appare evidente che le perdite meccaniche e nel
ferro si presentano mischiate; per estrapolarle si utilizza il seguente metodo.
Separazione delle perdite nel ferro dalle perdite meccaniche
Avendo fissato che le nostre prove sono state effettuate a velocità costante si
deduce che anche le perdite meccaniche sono state sempre costanti; sappiamo anche
dall’elettrotecnica che le perdite nel ferro variano con il quadrato della tensione e
descrivono un andamento parabolico. Queste considerazioni ci permettono di modellizzare
matematicamente la somma delle due perite nel seguente modo:
Pmp Pfe cos t KV02
se visto in funzione di V02 il diagramma appare nel seguente modo:
Figura 7 Grafico delle perdite meccaniche e nel ferro
Anche se l’imprecisione del grafico non lo evidenzia pienamente l’andamento della
curva sarà di tipo lineare; tramite la funzione previsione di excel si trova il punto di
intersezione con l’asse delle ordinate, che equivarrà al valore costante delle perdite
meccaniche: Pmp=56,6W. Sempre tramite excel si calcola il valore delle perdite nel ferro al
valore nominale di tensione di alimentazione che risulta essere Pfe (Vn)= 73,39 W
Figura 8 Grafico delle perdite meccaniche e nel ferro
DETERMINAZIONE DELLA CURVA DEL RENDIMENTO
Avendo calcolato tutti i parametri necessari per il calcolo delle perdite è possibile
compilare ora la tabella riassuntiva del rendimento calcolata con il metodo indiretto
secondo le seguenti formule:
P
er
Pas
Vn I as Pmp ( RJi _ 75 R p aus _ 75 ) I as2
Vn2
Recc _ 75
Vn I as
Rserie_ 75 I as2 2 I as 0,5%V I as
In %
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Vn
Ias
Pm
Pfe
PJI_tot
PJecc
PJserie
Pcs
PAdd
Iecc-n
V
A
W
W
W
W
W
W
W
A
/
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
0,84
1,68
2,52
3,36
4,2
5,04
5,88
6,72
7,56
8,4
9,24
10,08
56,6
56,6
56,6
56,6
56,6
56,6
56,6
56,6
56,6
56,6
56,6
56,6
73,39
73,39
73,39
73,39
73,39
73,39
73,39
73,39
73,39
73,39
73,39
73,39
1,017
4,069
9,155
16,28
25,43
36,62
49,85
65,11
82,4
101,7
123,1
146,5
104,8
104,8
104,8
104,8
104,8
104,8
104,8
104,8
104,8
104,8
104,8
104,8
0,174
0,695
1,564
2,78
4,344
6,255
8,514
11,12
14,07
17,38
21,02
25,02
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
-0,46
0,227
0,453
0,562
0,625
0,665
0,691
0,709
0,721
0,729
0,735
0,738
RJitot_75° =
RJecc_75° =
RJserie_75° =
In =
1,442
419,3
0,246
8,4
1,68
8,4
3,36 16,8
5,04 25,2
6,72 33,6
8,4
42
10,08 50,4
11,76 58,8
13,44 67,2
15,12 75,6
16,8
84
18,48 92,4
20,16 100,8
A
Se ne ricava il seguente grafico
Rendimento in funzione della corrente erogata
0,8
Rendimento
0,6
0,4
0,2
0
-0,2 0
2
4
6
8
10
12
-0,4
-0,6
Ier [A]
Si può notare come il rendimento non mostri la tipica forma a campana; il punto di
rendimento massimo, si ottiene quando la macchina assorbe la corrente nominale di circa
8,5 A, in questo punto di funzionamento le perdite costanti eguagliano le perdite variabili.
Nel nostro caso specifico il rendimento è stato calcolato per la macchina che funziona con
eccitazione composta, tuttavia il valore massimo si aggira intorno al 74 %, ciò significa che
nella migliore delle ipotesi circa un quarto della potenza meccanica fornita alla macchina
viene dispersa internamente alla macchina stessa. Per calcolare il rendimento utilizzando
la macchina in configurazioni differenti (ecc indipendente, parallela, serie) basterà
eliminare i termini non necessari al denominatore dell’equazione del rendimento.
Osservando la parte iniziale della curva del rendimento, apparirebbe evidente che
la macchina possa funzionare da freno, ossia assorbire potenza meccanica e potenza
elettrica per dissiparle al suo interno; in realtà tutto ciò non è ai fini pratici possibile, l’errore
apparente è dovuto al fatto che il rendimento minimo, pari a 0, viene rilevato quando il
motore funziona a vuoto, ovvero, assorbe una certa corrente I 0 e una certa potenza P0 per
la compensazione delle perdite nel ferro e delle perdite meccaniche, quindi la potenza
erogata, quella utile, viene considerata nulla; per valori di corrente assorbita superiori a I 0,
il rendimento cresce fino al calore massimo, per valori inferiori il rendimento risulta
negativo in quanto risulta negativa la potenza erogata. Tuttavia la parte di caratteristica da
prendere in considerazione rimane quella con rendimento positivo, dal valore della
corrente a vuoto in poi.