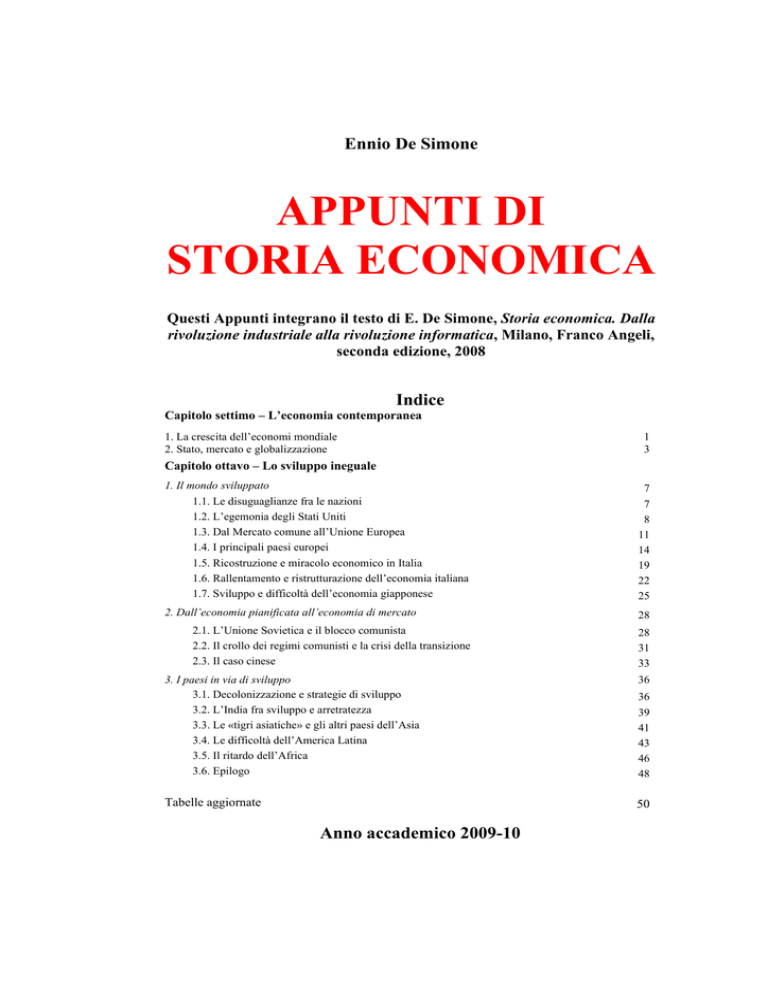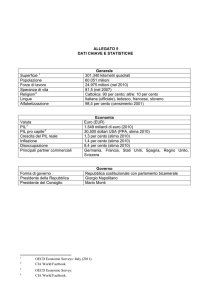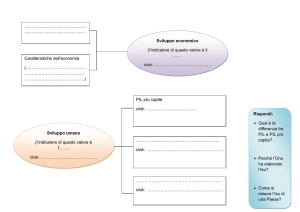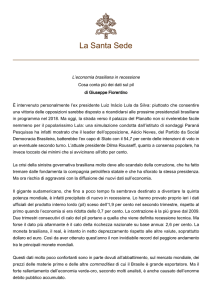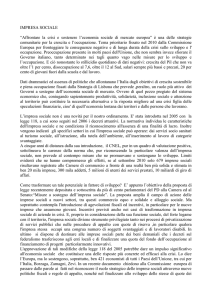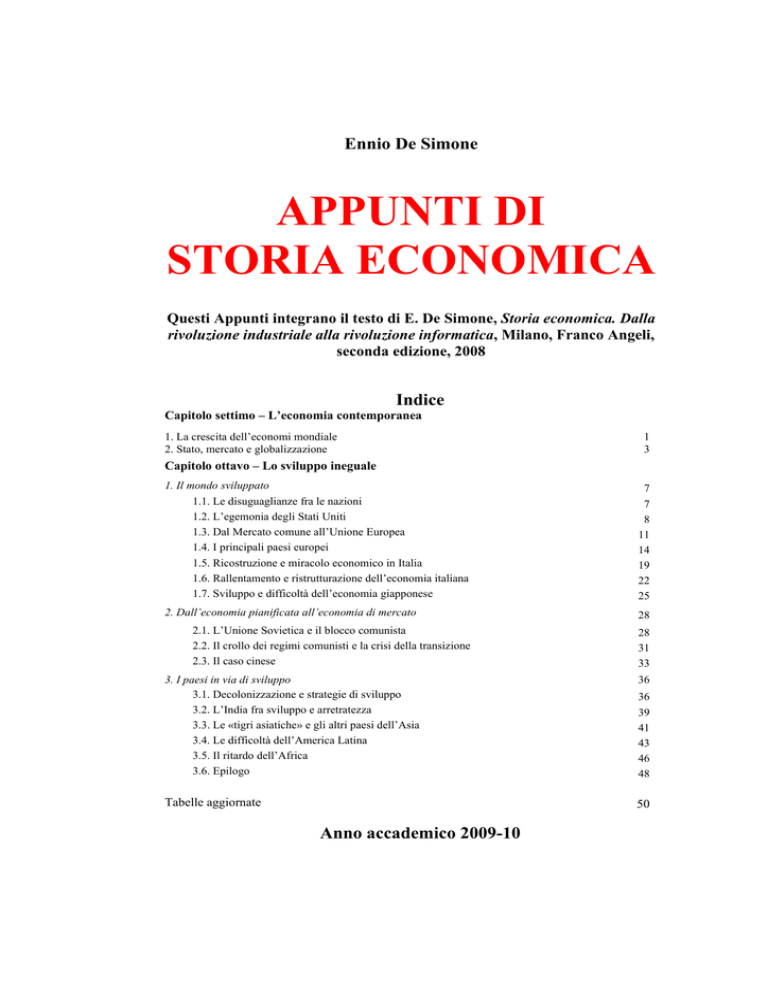
Ennio De Simone
APPUNTI DI
STORIA ECONOMICA
Questi Appunti integrano il testo di E. De Simone, Storia economica. Dalla
rivoluzione industriale alla rivoluzione informatica, Milano, Franco Angeli,
seconda edizione, 2008
Indice
Capitolo settimo – L’economia contemporanea
1. La crescita dell’economi mondiale
2. Stato, mercato e globalizzazione
1
3
Capitolo ottavo – Lo sviluppo ineguale
1. Il mondo sviluppato
1.1. Le disuguaglianze fra le nazioni
1.2. L’egemonia degli Stati Uniti
1.3. Dal Mercato comune all’Unione Europea
1.4. I principali paesi europei
1.5. Ricostruzione e miracolo economico in Italia
1.6. Rallentamento e ristrutturazione dell’economia italiana
1.7. Sviluppo e difficoltà dell’economia giapponese
7
7
8
11
14
19
22
25
2. Dall’economia pianificata all’economia di mercato
28
2.1. L’Unione Sovietica e il blocco comunista
2.2. Il crollo dei regimi comunisti e la crisi della transizione
2.3. Il caso cinese
28
31
33
3. I paesi in via di sviluppo
3.1. Decolonizzazione e strategie di sviluppo
3.2. L’India fra sviluppo e arretratezza
3.3. Le «tigri asiatiche» e gli altri paesi dell’Asia
3.4. Le difficoltà dell’America Latina
3.5. Il ritardo dell’Africa
3.6. Epilogo
36
Tabelle aggiornate
50
Anno accademico 2009-10
36
39
41
43
46
48
Capitolo settimo
L’ECONOMIA CONTEMPORANEA
Questi paragrafi integrano quelli del Capitolo settimo del libro
1. La crescita dell’economia mondiale (nuovo paragrafo iniziale del Capitolo
settimo, p. 251)
Dopo la seconda guerra mondiale iniziò un lungo periodo di nuove trasformazioni, che va
sotto il nome di terza rivoluzione industriale. Forse, in questo caso, il termine riesce ancora
meno a esprimere pienamente la profondità delle trasformazioni della struttura economica e
sociale che hanno inciso direttamente o indirettamente sulla vita di tutti i popoli della Terra,
anche perché l’elemento più caratteristico del periodo è la terziarizzazione dell’economia.
Sono trasformazioni molto più profonde di quelle delle altre due rivoluzioni, acceleratesi con
l’avvento dell’informatica, che si è estesa alle comunicazioni, facendo del mondo un «villaggio globale», ormai collegato in rete mediante Internet.
Gli anni che vanno dalla fine della guerra ai nostri giorni hanno visto una crescita senza
precedenti dell’economia mondiale, come dimostrano gli indicatori riportati nella tabella 7.0,
in cui si mettono a raffronto i dati del 1955 con quelli del 2006. Di fronte a un incremento
della popolazione mondiale, che in questo periodo è cresciuta di 2,3 volte, passando da 2,8 a
6,5 miliardi, si registra un incremento molto più consistente delle principali produzioni alimentari, come frumento, riso, granturco e pesce, che sono aumentate da 3,2 a 5,8 volte. Anche la produzione di altre materie prime, come cotone, caucciù, carbone, minerali di ferro,
rame e petrolio, è cresciuta più della popolazione, mentre la produzione di energia elettrica è
aumentata di quasi tredici volte e quella di fertilizzanti azotati di ben quindici volte. È evidente che le risorse a disposizione dell’umanità sono notevolmente cresciute, al contrario di
quanto aveva ipotizzato Malthus a proposito del rapporto fra mezzi di sussistenza e popolazione. Purtroppo, esse non sono adeguatamente distribuite fra i popoli della Terra, sicché vi
sono molte nazioni che soffrono la fame e altre che sprecano derrate e beni di cui possono
disporre.
La crescita, nel periodo in esame, si può sostanzialmente dividere in due fasi: una di vigorosa espansione e una successiva di rallentamento, anche se non generalizzato. Dopo la guerra fu innanzitutto necessario procedere alla ricostruzione economica dei paesi coinvolti nel
conflitto, molti dei quali avevano subito parecchie distruzioni sul loro territorio, e riconvertire la produzione bellica in produzione per il tempo di pace. Questa volta non furono richieste
riparazioni, ma i paesi usciti vincitori dalla guerra, in particolare gli Stati Uniti, aiutarono alleati ed ex nemici nello sforzo della ricostruzione, realizzata in poco tempo. Intanto, venivano gettate le basi per una più solida convivenza fra le nazioni, basata anche sull’incremento
degli scambi internazionali.
Effettuata rapidamente la ricostruzione, l’economia di quasi tutti i paesi del mondo, specialmente di quelli industrializzati, conobbe una lunga fase di sviluppo come non si era mai
registrata prima di allora, alla quale è stato dato il nome di golden age, che durò almeno un
2
Ennio De Simone
quarto di secolo. Si trattò di un periodo di elevata crescita economica e di grandi conquiste
tecnologiche, che hanno consentito di mantenere una popolazione in continua e forte crescita, sfruttando una serie di condizioni favorevoli, come il basso prezzo delle materie prime,
specialmente del petrolio, la consistente ripresa degli scambi internazionali e un sistema di
cambi fissi, ripristinato dopo la guerra. Nel corso degli anni Settanta, venute a mancare alcune di queste condizioni, la crescita dell’economia mondiale rallentò, senza però esaurirsi.
Anzi, parecchi paesi, specialmente asiatici, fra i quali la Cina e l’India, hanno fatto registrare
una crescita accelerata, che ha prodotto un miglioramento delle condizioni materiali di vita
delle loro popolazioni.
Tab. 7.0. – Alcuni principali indicatori dell’economia mondiale nel 1955 e nel 2006
Indicatori
Popolazione mondiale (miliardi)
Frumento (milioni di quintali)
Riso (milioni di quintali)
Granturco (milioni di quintali)
Orzo (milioni di quintali)
Patate (milioni di quintali)
Pesca (milioni di quintali)
Cotone (milioni di quintali)
Caucciù (milioni di quintali)
Bovini (milioni di capi)
Ovini (milioni di capi)
Carbon fossile (milioni di tonnellate)
Ferro, minerale (milioni di tonnellate)
Rame, minerale (migliaia di tonnellate)
Petrolio (milioni di tonnellate)
Energia elettrica (miliardi di chilowattora)
Fertilizzanti azotati (milioni di quintali)
1955
2006
2,8
1.575
1.991
1.578
691
1.537
277
75
19
856
887
1.385
133
2.700
708
1.369
68
6,5
6.059
6.346
6.952
1.386
3.151
1.599
248
99
1.560
1.102
6.165
1.690
15.300
3.660
17.351
1024
Crescita di n volte
2,3
3,8
3,2
4,4
2,0
2,0
5,8
3,3
5,2
1,8
1,2
4,5
12,7
5,7
5,2
12,7
15,1
Fonte: Calendario Atlante De Agostini, Novara, anni 1958, 2008 e 2009.
Nota: La produzione di fibre di cotone del 1955 non comprende quella dell’Unione Sovietica; il secondo dato
della produzione di energia elettrica è relativo al 2005 e quello della produzione di fertilizzanti azotati è del 2003.
Un’altra caratteristica di questo lungo periodo, almeno fino a tutti gli anni Ottanta, fu la
contrapposizione fra due modelli economici: quello rappresentato dall’economia di mercato e
quello dell’economia pianificata. I paesi che si rifacevano all’economia libera di mercato, sia
pure con diverse varianti, erano gli Stati Uniti d’America, l’Europa occidentale e il Giappone,
nonché altri paesi ad essi collegati, come quelli del Commonwealth, quasi tutta l’America Latina e molte ex colonie europee. L’economia pianificata, già attuata dall’Unione Sovietica, si
diffuse nell’Europa orientale, in Cina e in qualche altro paese asiatico e latinoamericano. Si
trattò di una vera sfida fra sistemi economici e politici diversi, condotta sotto la guida delle
due «superpotenze» dell’epoca, gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica, che difendevano e cercavano di imporre il loro modello. Questo scontro, com’è noto, è terminato con il crollo
dell’economia pianificata e con l’affermazione di quella di mercato, la quale, però, mostra limiti e contraddizioni, che sono oggetto di analisi da parte di studiosi di diverse discipline.
Appunti di Storia economica
3
Il successivo paragrafo 2 va aggiunto alla fine del Capitolo settimo del libro
2. Stato, mercato e globalizzazione
Con la crisi degli anni Settanta, lo stesso modello di produzione e di consumo fordista, o
taylor-fordista, cominciò ad evolvere verso un nuovo modello, chiamato, per convenzione,
postfordista. Il fordismo, come si è visto, era caratterizzato dalla produzione di massa in serie, mediante la catena di montaggio, assicurata dalla grande impresa, che produceva per un
mercato sempre in crescita, grazie all’aumento del reddito delle famiglie. Il nuovo modello
postfordista, viceversa, sperimentato da tempo dalla giapponese Toyota, si proponeva di abbandonare la produzione basata sulla catena di montaggio (mass production) per passare alla
cosiddetta produzione snella (lean production), più adatta alle mutate esigenze del mercato e
in grado di sfruttare le nuove tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni. Il nuovo
modello si fonda, in particolare, su una maggiore flessibilità operativa (per esempio, riducendo le scorte, che possono essere facilmente fatte giungere «just in time», poco prima della
loro utilizzazione), e su differenti modalità lavorative, che hanno portato alla graduale riduzione del ripetitivo lavoro alla catena di montaggio, sostituito con nuove forme, basate sul
lavoro di gruppo e su una pluralità di mansioni affidate al dipendente. È diminuita, però, la
sicurezza del posto di lavoro e i lavoratori sono costretti a cambiare spesso occupazione, sicché oggi è difficile che una persona possa restare per tutta la vita presso la stessa azienda e
svolgere lo stesso tipo di lavoro. In questo modello l’impresa è più leggera, agile e snella,
capace di adattarsi alle variabili esigenze della produzione e della domanda. Perciò, molte
grandi imprese hanno attuato un graduale decentramento produttivo, affidando ad altre aziende determinate operazioni o lavorazioni (esternalizzazione) oppure hanno trasferito alcune fasi del processo produttivo o l’intero processo in paesi dove vi sono condizioni più favorevoli, in particolare bassi costi della manodopera e tassazione limitata (delocalizzazione).
Con la svolta degli anni Settanta si modificò anche il ruolo dello Stato nell’economia. I
liberisti avevano sempre sostenuto che il mercato fosse capace di risolvere autonomamente
le crisi, e perciò ritenevano che lo Stato dovesse essere «minimale», ossia dovesse limitarsi
alle sue funzioni essenziali, predisponendo un insieme di regole generali per tutelare la proprietà privata, assicurare il rispetto degli obblighi contrattuali, garantire la stabilità della moneta e favorire lo sviluppo di mercati liberi e aperti. A partire dalla depressione degli anni
Trenta, le teorie liberiste non erano state giudicate idonee ad affrontare e risolvere i problemi
delle complesse economie moderne e avevano perso vigore. John M. Keynes aveva fornito la
giustificazione teorica all’intervento dello Stato e le sue teorie si affermarono dappertutto nel
secondo dopoguerra. Secondo il suo pensiero, l’intervento statale era considerato l’unico
modo per rimediare alle carenze del capitalismo e del mercato e assicurare il pieno impiego
dei fattori produttivi. Perciò, i governi attuarono gradualmente politiche ispirate alle teorie
dell’economista inglese.
Esauritasi la fase espansiva del dopoguerra, i neoliberisti ripresero il sopravvento sui keynesiani e riproposero, sia pure sotto forme più sofisticate, le teorie sulla capacità
dell’economia e del mercato di autoregolarsi. Negli anni Ottanta, le politiche economiche ispirate a queste teorie trovarono i loro più convinti sostenitori nel presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan (1981-89), e nel primo ministro britannico, Margaret Thatcher (1979-90),
4
Ennio De Simone
tanto che si parlò di reaganismo (o reaganomics) o tatcherismo. In quegli anni, i governi erano preoccupati principalmente dell’inflazione e non della disoccupazione e, perciò, si affidarono alle idee dei monetaristi, che insistevano sulla necessità di una moneta solida, anche
se ciò comportava il ricorso a politiche monetarie restrittive. I neoliberisti, inoltre, al contrario dei keynesiani che puntavano sul sostegno della domanda, proponevano una politica dal
lato dell’offerta (supply-side), atta a garantire il funzionamento dei mercati. Secondo questa
teoria, era necessario attuare una decisa deregolamentazione dei mercati (deregulation), rimuovendo norme e regolamenti che ne impedivano il libero funzionamento, come la fissazione di salari minimi o i controlli sulle operazioni finanziarie. Tale politica prevedeva anche
forti sgravi fiscali (e quindi una riduzione della spesa pubblica), nella convinzione che, riducendo le imposte da pagare, specialmente ai più ricchi, si sarebbe consentito loro di spendere
di più e sostenere i consumi privati. Ma ciò avrebbe comportato (come infatti ha comportato)
un aumento delle disparità sociali, che i sostenitori della supply-side ritenevano temporanea,
perché alla fine il benessere si sarebbe progressivamente propagato dai ricchi alle altre categorie. E, infine, se Keynes aveva visto l’intervento dello Stato come una conseguenza del
fallimento del mercato, i neoliberisti sottolineavano il fallimento dello Stato, che con il suo
intervento avrebbe impedito il libero funzionamento del mercato. Chiesero, perciò, il drastico ridimensionamento della sua ingerenza nell’attività economica e con essa anche la revisione dell’impalcatura del Welfare. Ronald Reagan sosteneva che lo Stato non era la soluzione dei problemi, ma era esso stesso il problema.
Ma quando, negli anni 2008-09, è esplosa una nuova grave crisi, favorita dall’eccessiva
libertà del mercato, in particolare di quello finanziario, il prestigio dei neoliberisti sembra essersi incrinato, e molti di coloro che fino a poco tempo prima avevano avversato l’ingerenza
dello Stato nell’economia, hanno reclamato a gran voce il suo intervento, per chiedere massicce iniezioni di denaro a sostegno delle imprese e delle banche in difficoltà e a favore dei
redditi delle famiglie per sostenere i consumi, nonché nuove e più efficaci regole per garantire un più corretto funzionamento dei mercati.
D’altronde, nonostante le politiche ispirate dai neoliberisti, era stato possibile ridurre solo in parte la presenza dello Stato nell’economia. Se risultò abbastanza agevole liberalizzare
i mercati e privatizzare parecchie banche e imprese, finite nelle mani dello Stato per i salvataggi degli anni Trenta o in seguito alle nazionalizzazioni del dopoguerra, risultò molto più
difficile contenere i costi del Welfare. Ormai i cittadini ritenevano una conquista irrinunciabile le prestazioni fornite dallo Stato (assistenza sanitaria, sicurezza sociale, istruzione e così
via) e non ne avrebbero accettato la riduzione, specialmente in un periodo di crisi. I governi,
perciò, per conservare tali servizi, dovettero indebitarsi ulteriormente e il debito pubblico di
molti Stati non fece che crescere.
La ristrutturazione economica e le politiche neoliberiste adottate per combattere la crisi
degli anni Settanta favorirono la globalizzazione dell’economia (dall’inglese global, che sta
per mondiale). Con questo termine, che si è cominciato ad usare negli anni Ottanta, s’intende
il fenomeno che ha portato alla formazione di un mercato mondiale dei fattori della produzione, dei prodotti, dei servizi e dei capitali. Ciò è stato reso possibile dal progresso tecnologico, in particolare nel campo dell’informazione e della comunicazione, che permette di effettuare transazioni con immediatezza, e in quello dei trasporti, che consente di trasferire
merci a grandi distanze, a costi molto contenuti. La globalizzazione non è un fenomeno del
tutto nuovo. Già durante la Belle époque, per esempio, si era formato un mercato mondiale
di molti beni e servizi, oltre che dei capitali e della manodopera, ma sicuramente, ai nostri
Appunti di Storia economica
5
giorni, essa ha assunto dimensioni eccezionali e, per giunta, non riguarda solo la sfera economica, ma pure altri ambiti, come la politica, la cultura e le istituzioni. La globalizzazione è
stata senza dubbio agevolata dall’attività delle imprese multinazionali, trasformatisi in imprese transnazionali, nelle quali le unità che operano all’estero godono di una maggiore autonomia operativa. La conseguenza è stata un’enorme intensificazione degli scambi e degli
investimenti internazionali, che hanno prodotto una maggiore interdipendenza delle economie dei vari paesi. Negli ultimi quindici o venti anni, circa due miliardi di persone sono entrati pienamente o parzialmente nei circuiti di mercato e, in futuro, le reti informatiche e le
telecomunicazioni digitali sono destinate ad ampliare ulteriormente l’economia globale. La
globalizzazione ha ricevuto consensi entusiastici e critiche feroci. I suoi fautori ritengono che
essa sia un fenomeno ormai irreversibile, che può contribuire a ridurre la distanza fra paesi
sviluppati e paesi in via di sviluppo. I suoi avversari, invece, sostengono che essa, se non adeguatamente controllata, porterà a una nuova forma di sfruttamento dei paesi sottosviluppati, senza realizzare una riduzione della povertà mondiale.
Non è facile trattare eventi così recenti, perché vi è il rischio di non riuscire a distinguere
con chiarezza gli aspetti congiunturali da quelli strutturali. Sembra, tuttavia, che, verso la
metà degli anni Novanta, una serie di elementi abbia concorso a imprimere un diverso andamento al ciclo economico. Le politiche neoliberiste avevano portato a una maggiore libertà
di azione delle imprese e della finanza, a una ristrutturazione produttiva e a una riduzione
dell’ingerenza dello Stato in economia, nonché alla globalizzazione dei mercati. Intanto, erano crollati i sistemi ad economia pianificata, l’Asia nel suo complesso iniziava a crescere a
ritmo accelerato e le economie americana e britannica davano segni di particolare vitalità e
dinamismo.
Durante gli anni Novanta, la crescita economica degli Stati Uniti aveva attirato capitali da
altri paesi, per la fiducia degli investitori nella stabilità del dollaro e nell’efficienza del sistema economico americano. Agli inizi del nuovo secolo, la Borsa americana conobbe una
forte espansione (fra il 2002 e il 2004, i titoli delle principali società fecero registrare ben
undici trimestri consecutivi di crescita superiore al 10 per cento), grazie al credito facile accordato dalle banche, che erano state autorizzate a svolgere ogni tipo di operazione. Un particolare rilievo avevano assunto gli investimenti in titoli speculativi (di solito trattati su mercati senza alcun controllo, paralleli a quello ufficiale), come i «derivati», ossia titoli il cui valore è legato a quello di altri titoli, o gli «hedge funds», fondi di investimento ad elevato rischio 1 . Anche le famiglie erano state sostenute nei loro consumi da prestiti facili, accordati
mediante carte di credito di ogni tipo, o mediante i cosiddetti mutui subprime, concessi, in
genere, per l’acquisto della casa, a soggetti non in grado di addossarsi impegni finanziari così onerosi. Siccome i mutui erano garantiti da un’ipoteca sulla proprietà acquistata, erano ritenuti sicuri dalle banche, anche perché il prezzo delle abitazioni (e quindi la garanzia) era in
aumento per la forte domanda, sostenuta proprio dai mutui. D’altra parte, le banche provve-
1
I fondi comuni d’investimento sono organismi di investimento collettivo, che raccolgono quote di partecipazione da parte dei risparmiatori e le impiegano in titoli, provvedendo a dividere il guadagno fra i partecipanti, dedotte le spese di gestione. In tal modo, si consente anche a piccoli risparmiatori di investire fondi che altrimenti
non sarebbero in grado di impiegare convenientemente. In genere, i fondi si distinguono tra fondi aperti, che prevedono il rimborso delle quote sottoscritte in qualsiasi momento, e fondi chiusi, dai quali si può recedere solo a
determinate condizioni. Il grado di sicurezza degli investimenti dipende dal tipo di titoli acquistati. I profitti attesi
sono elevati sui titoli ad alto rischio e bassi su quelli più sicuri.
6
Ennio De Simone
devano quasi subito a rimettere sul mercato questi loro crediti, emettendo su di essi titoli derivati, venduti ai risparmiatori di tutto il mondo.
Nella primavera del 2007, la domanda di case cominciò a diminuire, mentre molte famiglie non riuscirono più a pagare le rate del mutuo e persero la loro abitazione. Oltre che negli
Stati Uniti, anche in altri paesi (Gran Bretagna, Irlanda, Spagna, ecc.) molte banche si erano
immobilizzate con i mutui ipotecari e alcune di esse si trovarono in difficoltà per le insolvenze dei clienti. Nell’autunno del 2008, vi fu il crollo delle quotazioni di Borsa di tutto il mondo e il panico si diffuse fra i risparmiatori, specialmente fra coloro che si erano convinti a investire in titoli ad alto rischio. Inoltre, come era avvenuto nel ’29, la crisi si estese all’attività
produttiva. Le banche in difficoltà ridussero i loro finanziamenti a imprenditori e consumatori e molti risparmiatori, per le perdite subite o attese, limitarono gli acquisti di beni. Le industrie, in particolare quelle automobilistiche, fecero fatica ad andare avanti e dovettero essere
sostenute con incentivi statali alla «rottamazione» dei vecchi modelli di autovetture. Il commercio internazionale rallentò e il prezzo del petrolio, giunto a quasi 150 dollari al barile nei
primi mesi del 2008 (anche per spinte speculative), precipitò intorno ai 40 dollari alla fine
dell’anno, a testimonianza del calo della produzione industriale mondiale. Successivamente,
il prezzo è risalito fino a oltre 70 dollari nell’estate del 2009.
La crisi ha colpito, sia pure in misura diversa, tutte le economie del mondo. Lo Stato, richiamato in causa dovunque, è dovuto intervenire per salvare molte banche e imprese
sull’orlo del fallimento, mentre altre sono state lasciate al loro destino. Questa volta, al contrario di quanto era avvenuto durante la depressione degli anni Trenta, i governi dei principali paesi del mondo hanno cercato di operare congiuntamente per individuare e adottare rimedi atti a combattere la crisi, anche perché, a causa della globalizzazione dei mercati, le economie dei diversi paesi sono molto più interdipendenti che in passato. Gli effetti più gravi
riguardano, oltre che l’«economia di carta», ossia quella finanziaria, l’«economia reale», che
ha fatto registrare il calo della produzione e del Pil in quasi tutti i paesi sviluppati e un rallentamento della crescita in quelli in via di sviluppo, con la conseguente perdita del lavoro,
spesso già precario, per decine di milioni di persone.
Capitolo ottavo
LO SVILUPPO INEGUALE
Questo nuovo capitolo sostituisce i seguenti paragrafi del Capitolo settimo del
libro:
paragrafi 2.4, 2.5 e 2.6, pp. 273-282
paragrafi 3.2, 3.3 e 3.4, pp. 287-295
1. IL MONDO SVILUPPATO
1.1. Le disuguaglianze fra le nazioni
L’eccezionale sviluppo dell’economia mondiale degli ultimi sessanta anni ha prodotto un
ulteriore forte divario fra paesi ricchi e paesi poveri, facendo aumentare le disuguaglianze
già emerse nel corso degli ultimi due secoli. Secondo le stime di Maddison, il Pil pro capite
degli Stati Uniti era, nel 1820, tre volte superiore a quello dell’Africa. Nel 1913, esso era otto volte maggiore e nel 2006 quasi diciannove volte. Se si prendono in considerazione le
grandi aree geografiche del mondo (vedi tab. 8.1), si nota come oggi solo l’Europa occidentale raggiunga un Pil pro capite pari a poco più dei due terzi di quello degli Stati Uniti. L’ex
Unione Sovietica, l’Europa orientale, l’Asia e l’America Latina producono un Pil che si colloca fra il 17 e il 25 per cento di quello americano, mentre l’Africa arriva appena a poco più
del 5 per cento e la sua situazione, sempre in termini comparativi, è andata progressivamente
peggiorando. Il paese africano più povero, la Repubblica democratica del Congo (ex Zaire),
che conta circa 70 milioni di abitanti, fa registrare un Pil pro capite pari a un centoquarantaduesimo di quello degli Stati Uniti. Nell’ultimo mezzo secolo, il numero di persone che vive
nei paesi poco sviluppati è, purtroppo, notevolmente aumentato.
Tab. 8.1. – Livello del Pil pro capite delle diverse regioni del mondo raffrontato con quello degli
Stati Uniti, per alcuni anni dal 1950 al 2006
Regioni
Stati Uniti
Europa occidentale
Unione Sovietica
Europa orientale
Asia
America Latina
Africa
1950
1960
1970
1980
1990
2000
100
48
30
22
7
26
9
100
61
35
27
9
28
9
100
68
37
29
10
27
9
100
71
35
31
11
30
8
100
69
30
23
12
22
6
100
67
16
21
13
21
5
2006
100
68
22
25
17
21
5
Fonte: Dati tratti dal sito web di A. Maddison, all’indirizzo “www.ggdc.net/Maddison” (nostri calcoli).
Nota: I dati del 2000 e del 2006 dell’Unione Sovietica sono riferiti ai paesi che ne facevano parte.
8
Ennio De Simone
L’espressione «Terzo Mondo», che pure continua ad essere utilizzata, non descrive più in
modo appropriato la situazione attuale. Negli ultimi tempi, in particolare dopo la fine della
Guerra fredda, il mondo sembra potersi dividere più adeguatamente in tre diverse parti. In
cima vi sono i paesi sviluppati, in mezzo la gran massa dei paesi in via di sviluppo, che stanno crescendo in maniera consistente, e in fondo i paesi arretrati, che fanno fatica a uscire dal
sottosviluppo e non riescono a recuperare il ritardo 2 . Il primo e il terzo gruppo ospitano ciascuno intorno a un miliardo di persone, mentre il resto della popolazione mondiale, ossia circa il 70 per cento, vive nei paesi del secondo gruppo. Di recente, un economista inglese, Paul
Collier, ha chiamato the bottom billion («l’ultimo miliardo»), coloro che vivono nei paesi più
poveri, quasi soltanto africani, intrappolati nel sottosviluppo.
Da qualche tempo, di fronte all’inadeguatezza del Pil di valutare e rappresentare il divario
fra i diversi Stati del mondo, viene costruito un nuovo indice, detto Indice di sviluppo umano
(Human development index, Hdi), messo a punto da un economista pakistano e pubblicato
annualmente dalle Nazioni Unite a partire dai primi anni Novanta. Esso, che pure ha ricevuto
parecchie critiche, tende a «misurare» non soltanto la ricchezza ma anche il benessere sociale e si basa su alcuni parametri che riguardano tre dimensioni fondamentali dello sviluppo
umano: la durata della vita (speranza di vita alla nascita), il livello culturale (tasso di alfabetizzazione e accesso ai vari livelli di istruzione) e la quantità di ricchezza disponibile (Pil pro
capite a parità di potere d’acquisto). In tal modo, si assegna a ciascun paese un valore variabile fra 0 e 1 e si costruisce una graduatoria. I primi cinque Stati di tale graduatoria (su 179)
sono attualmente l’Islanda (0,972), la Norvegia (0,970), il Canada (0,967), l’Australia
(0,965) e l’Irlanda (0,960), che complessivamente contano appena una sessantina di milioni
di abitanti. Gli ultimi cinque Stati sono tutti africani: Mozambico (0,366), Liberia (0,364),
Repubblica democratica del Congo (0,361), Repubblica centrafricana (0,352) e Sierra Leone
(0,329), dove vivono oltre 90 milioni di persone. L’Italia (0,945) occupa il diciannovesimo
posto e gli Stati Uniti (0,950) il quindicesimo. La Cina (0,762) e l’India (0,609) si trovano
rispettivamente al novantaquattresimo e al centotrentaduesimo posto.
1.2. L’egemonia degli Stati Uniti
Gli Stati Uniti uscirono rafforzati economicamente dalla seconda guerra mondiale. Durante il conflitto sfruttarono in pieno la loro capacità produttiva e incrementarono la produzione agricola e quella industriale per soddisfare la forte domanda bellica. Dopo la guerra, il
«gap» tecnologico dell’Europa nei confronti degli Stati Uniti risultò evidente. Come si è visto, la tecnologia americana, soprattutto i processi produttivi basati sulla catena di montaggio
e sui prodotti standardizzati, fu esportata dovunque vi fossero le condizioni per poterla applicare. Si assistette allora, in Europa e altrove, a una sorta di «americanizzazione» a tutti i livelli e l’American way of life divenne l’esempio da imitare in tutti i campi (economia, arte,
musica, stile di vita, ecc.), specialmente per le nuove generazioni.
2
Gli economisti distinguono soltanto fra paesi sviluppati (Psv) e paesi in via di sviluppo (Pvs), fissando la linea di demarcazione fra i due gruppi intorno a 10 mila dollari di reddito medio pro capite annuo. È ovvio che al
loro interno vi sono situazioni profondamente diverse, in particolare fra i Pvs, di cui fa parte il gruppo di paesi
arretrati ai quali si è fatto sopra riferimento. Perciò, la Banca mondiale ha individuato delle sottoclassi fra i Pvs
(paesi a basso reddito, paesi a reddito medio-basso e paesi a reddito medio-alto).
Appunti di Storia economica
9
Gli Stati Uniti erano definitivamente diventati la maggiore potenza politica, militare ed
economica del pianeta e avevano preso coscienza del loro ruolo di leader del mondo capitalistico. Gli Americani si sentirono collettivamente responsabili di una grande missione, consistente nel combattere il comunismo mondiale e nell’affermare e diffondere i loro principi,
basati sulla certezza della superiorità della democrazia, delle libertà individuali e del libero
mercato, anche se la lotta al comunismo li portò, in più occasioni, ad appoggiare regimi autoritari e corrotti, che non rispettavano i diritti umani. Il dollaro assunse la funzione di moneta
dei pagamenti internazionali e gli Stati Uniti goderono del particolare privilegio di adoperarlo nei pagamenti all’estero e di vedere una massa sempre più grande di dollari trattenuti fuori
dei propri confini dagli altri paesi, che li tenevano come riserva per le loro emissioni monetarie o li utilizzavano per i pagamenti internazionali, in particolare per acquistare il petrolio. Il
Pil pro capite americano, che nel 1950 aveva superato quello di tutti i maggiori paesi industrializzati, crebbe al tasso del 2,5 per cento all’anno fino al 1973 (vedi nuova tab. 5.1).
La crescita degli Stati Uniti riguardò tutti i settori, dall’agricoltura all’industria, dal
commercio estero a quello interno, dalle banche al turismo. In agricoltura, però, nonostante
l’incremento della produttività e della produzione, il reddito delle famiglie contadine rimase
mediamente pari ai due terzi di quello delle altre famiglie americane e, in alcuni anni, scese fino alla metà. I farmers, oltre a godere di un grande prestigio in una società che serbava
ancora viva la memoria del loro ruolo nella colonizzazione dell’Ovest, avevano anche un notevole peso elettorale, specialmente nell’elezione del Senato, in cui gli Stati agricoli
dell’Ovest dispongono di due senatori come qualsiasi altro Stato dell’Unione. Perciò, il governo federale intervenne per sostenere i loro redditi, ma non riuscì a evitare un’eccessiva
produzione di grano, per via della crescita dei rendimenti, che si cercò di vendere all’estero
quando il mercato internazionale era in grado di assorbirlo. La conseguenza fu l’espulsione
dal mercato di molte piccole aziende e la formazione di aziende più grandi e produttive.
Le imprese continuarono a ingrandirsi in tutti i settori. Le corporations divennero più
numerose e assunsero caratteristiche diverse da quelle dei periodi precedenti, quando erano
gestite in modo centralizzato, spesso dallo stesso fondatore. Si affermò l’impresa multidivisionale, organizzata in divisioni o settori, ognuno con una sua autonomia funzionale e gestionale. Inoltre, si realizzò la separazione fra la proprietà, sovente dispersa fra un gran numero di azionisti e perciò incapace di esercitare una reale funzione di controllo, e il
management aziendale, che acquistava sempre maggiore potere. Le grandi imprese attirarono
l’attenzione degli investitori istituzionali, come compagnie di assicurazione, fondi comuni di
investimento e fondi pensione 3 , che negli anni Ottanta arrivarono a possedere più della metà
delle azioni quotate in Borsa, dove il volume delle transazioni aumentò di oltre cinquanta
volte in trent’anni. Nacque addirittura un mercato delle aziende, sul quale aziende o parti di
aziende erano acquistate, vendute, frazionate o accorpate. Dagli Stati Uniti, l’impresa multifunzionale si diffuse in Europa, dove contribuì a modificare l’organizzazione delle imprese
familiari e dell’impresa pubblica. Le corporations americane, oltre che nei tradizionali rami
di attività si svilupparono in particolare nell’elettronica e nell’informatica (Ibm), nella chi3
Gli investitori istituzionali sono società o enti, obbligati, per legge o per il loro statuto, a impiegare i fondi
disponibili in titoli o in immobili. I fondi pensione sono una forma di previdenza volontaria a favore dei lavoratori
di un’impresa o di una categoria professionale, che in genere si aggiunge al sistema pensionistico pubblico. Gli
iscritti al fondo versano contributi in denaro per ottenere, all’epoca prestabilita, una pensione o un capitale. I contributi raccolti sono investiti in vario modo per accrescere il fondo con il quale erogare le prestazioni a favore degli iscritti.
10
Ennio De Simone
mica e nei prodotti petroliferi. Molte di esse diedero vita, a partire dagli anni Sessanta, a un
gran numero di conglomerate, verso le quali si era sempre rivolto l’interesse del capitalismo
americano, pronto a cogliere le opportunità offerte dalla diversificazione produttiva.
Gli Stati Uniti riuscirono a realizzare buoni risultati anche dopo il 1973. Non vi fu, quindi, il forte rallentamento registrato in Europa e in Giappone (vedi nuove tabb. 5.1 e 7.2). Gli
anni Settanta, tuttavia, conobbero una fase di stagnazione e di aumento dell’inflazione (la cosiddetta stagflazione), che portò alla vittoria di Ronald Reagan alle elezioni del 1980 e
all’adozione della politica economica che da quel presidente prese il nome (reaganomics).
La lotta all’inflazione fu attuata con provvedimenti monetari e creditizi (alti tassi d’interesse,
restrizione del credito, ecc.) volti a tenere sotto controllo la massa di moneta in circolazione.
Il rilancio della crescita si fondò sulla riduzione dell’imposizione fiscale, sul taglio della spesa assistenziale (peraltro gli Stati Uniti non hanno un sistema sanitario pubblico che assiste
tutti i cittadini come in Europa), su un forte aumento della spesa militare e su una decisa liberalizzazione dei mercati finanziari, industriali e del lavoro. Si cercò di incentivare la domanda con i tagli fiscali, specialmente sui redditi medio-alti, e si sostenne l’offerta mediante
significative misure di deregolamentazione per dare maggiore libertà alle imprese. Ciò fu
possibile anche perché gli Stati Uniti, a differenza dell’Europa, dove i lavoratori erano maggiormente tutelati, avevano un mercato del lavoro più flessibile e meno regolamentato. Inoltre,
la loro economia è molto più integrata di quella europea, non essendovi le divergenze di interessi fra i singoli Stati, che invece caratterizzano i rapporti fra i paesi europei.
Le disuguaglianze sociali aumentarono, per via dei tagli dei fondi per l’assistenza ai disoccupati e agli indigenti, ritenuta una spesa improduttiva e un fattore di inflazione. Le elevate spese per la difesa, però, non consentirono una riduzione del deficit del bilancio federale, il quale, anzi, aumentò, così come crebbe notevolmente il debito pubblico. Le spese militari erano ritenute necessarie per contrastare l’Unione Sovietica, definita da Reagan «impero
del male», e servirono a costruire costosi e sofisticati sistemi di difesa e di offesa. Tuttavia,
la crescita economica fu vigorosa, sostenuta da un forte calo dei prezzi delle materie prime e
dalle spese militari, mentre la disoccupazione diminuì gradualmente. Intanto, la terziarizzazione dell’economia provocava una riduzione degli occupati nel settore industriale a vantaggio di quelli che trovavano lavoro (anche precario) nel settore dei servizi.
Nonostante qualche difficoltà, come la crisi borsistica dell’ottobre 1987, quando Wall
Street segnò, in pochi giorni, un calo delle quotazioni del 25 per cento, l’economia americana continuò a crescere, allargando il divario con le economie delle altre aree del mondo (vedi
tab. 8.1). Nella seconda metà degli anni Novanta, conobbe un lungo ciclo espansivo, con tassi di crescita annui superiori al 4 per cento, che fecero scomparire il disavanzo del bilancio
statale e ridurre il debito pubblico. Si procedette anche a una ristrutturazione delle imprese,
che segnò il declino del fordismo nel paese stesso che lo aveva inventato. Le imprese divennero più piccole e snelle e spesso delocalizzarono alcuni processi produttivi nei paesi che offrivano condizioni migliori, in particolare in materia di costo della manodopera. Gli Stati Uniti riuscirono a profittare meglio di altri paesi della globalizzazione del mercato dei capitali
internazionali. Dal 1989, dopo essere stati a lungo creditori netti verso il resto del mondo,
divennero debitori, perché importavano capitali, indebitandosi verso l’estero. Ciò significava
che, come era avvenuto prima della Grande guerra, gli altri paesi sostennero il lungo periodo
di espansione americana e finanziarono il deficit della loro bilancia dei pagamenti (si ricordi
che i finanziamenti provenienti dall’estero costituiscono una voce dell’attivo della bilancia
dei pagamenti). D’altra parte gli Stati Uniti contribuirono a sostenere la domanda mondiale,
Appunti di Storia economica
11
con un forte incremento delle loro importazioni, stimolate dal grande mercato interno e favorite dalle riduzioni tariffarie promosse da Gatt e Wto, oltre che dalla Nafta. La cosiddetta
new economy (tecnologie dell’informazione e attività connesse) ebbe una funzione propulsiva dell’economia, anche se diede luogo a qualche bolla speculativa.
La fase espansiva dell’economia continuò anche nei primi anni del nuovo secolo, nonostante una breve crisi seguita all’attacco terroristico alle Torri Gemelle di New York, nel settembre del 2001. La crescita fu sostenuta, ancor più di prima, da una forte espansione del
credito, concesso con eccessiva facilità. La finanza si sviluppò, grazie all’introduzione di
molti tipi di titoli, anche di quelli più rischiosi e privi di consistenza reale, e le quotazioni di
Borsa aumentarono notevolmente, attirando nuovi capitali da ogni parte del mondo. Nel corso del 2007, come si visto, i nodi vennero al pettine e molti mutui (cosiddetti «subprime»)
non furono rimborsati. Quell’anno furono messe in vendita all’asta per insolvenza 1,3 milioni di proprietà immobiliari, quasi l’80 per cento in più dell’anno precedente. La crisi è esplosa nel biennio 2008-09 e si è estesa dal settore finanziario a quello dell’economia reale, con
un crollo della domanda e della produzione. I consumatori, che sostenevano la domanda grazie all’indebitamento, si sono trovati privi di mezzi, anche per la riduzione dell’occupazione
nel comparto delle costruzioni e dei servizi finanziari. Ancora una volta, come nel ’29, gli
Stati Uniti e il mondo hanno dovuto affrontare una crisi di sovrapproduzione, manifestatasi
con la caduta dei consumi e con l’impossibilità di assorbire la gran quantità di manufatti che
l’apparato industriale è in grado di produrre. L’industria automobilistica, in particolare, ha
visto crollare le vendite di un terzo nel corso del 2008 e la produzione di molti beni è rallentata, con il triste corollario del forte aumento della disoccupazione. Il governo federale è dovuto intervenire per salvare banche e imprese in difficoltà, con un piano di aiuti di quasi 800
miliardi di dollari e con altri provvedimenti, che sembrano aver sortito i primi effetti nella
seconda metà del 2009.
1.3. Dal Mercato comune all’Unione Europea
Nel secondo dopoguerra, la generazione che aveva vissuto due conflitti mondiali, rappresentata da uomini come i francesi Robert Schuman e Jean Monnet, gli italiani Alcide De Gasperi e Altiero Spinelli, il tedesco Conrad Adenauer e il belga Paul-Henri Spaak, avviò un
processo di integrazione economica che successivamente ha portato alla nascita dell’Unione
Europea. I paesi che aderirono ai vari organismi via via istituiti furono costretti a cedere una
parte della loro sovranità, in uno o più ambiti, a organismi sopranazionali, ma spesso lo fecero con riluttanza. Finora ogni tentativo di costruire un’unione politica è risultata vana e ciò
ha contribuito a far diminuire il peso dell’Europa, che sulla scena internazionale non è in
grado di presentarsi come un’unica entità politica ed economica.
All’inizio, gli sforzi principali furono concentrati sull’ampliamento dei mercati, ritenuti
troppo piccoli e non in grado di garantire una conveniente collocazione dei prodotti di massa.
Si reputava che solo mercati più ampi e imprese di maggiori dimensioni potessero assicurare
economie di scala e un aumento della produttività. L’Oece, sorta per accogliere e convogliare verso gli Stati Uniti le richieste di intervento del Piano Marshall, fu una palestra di cooperazione economica, perché consentì di compilare statistiche a livello europeo, di prevedere
una progressiva liberalizzazione degli scambi e persino di abbozzare un piano quadriennale
europeo. Ma le rivalità fra i paesi aderenti non consentirono all’organizzazione di ottenere
12
Ennio De Simone
buoni risultati. Perciò, il primo passo effettivo verso l’integrazione europea fu compiuto, a
cominciare dal 1948, da tre piccoli paesi, il Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo, i quali
diedero vita a un’unione doganale, il Benelux, che decise la libera circolazione delle merci al
suo interno e introdusse un’unica barriera doganale esterna. Qualche anno più tardi, nel
1951, su iniziativa del ministro degli Esteri francese Robert Schuman, fu fondata, con il trattato di Parigi, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (Ceca), durata fino al 2002,
alla quale parteciparono la Francia, la Germania occidentale, l’Italia e i tre paesi del Benelux.
La Ceca era un’unione doganale per il minerale ferroso, il carbone, il coke e l’acciaio ed esercitava il controllo sulla produzione e sulle vendite di quei beni. Per la sua gestione furono
istituiti diversi organismi: un’Alta autorità con poteri esecutivi, un Consiglio dei ministri
composto, di volta in volta, dai ministri dei paesi aderenti competenti nella materia trattata,
un’Assemblea generale con poteri consultivi e una Corte di giustizia per dirimere le controversie. La Comunità ebbe successo e la produzione di acciaio aumentò da 34 a 56 milioni di
tonnellate fra il 1950 e il 1958, quando gli Stati Uniti ne producevano 77 milioni e la Gran
Bretagna 20 milioni.
Ma il passo più importante fu compiuto con i trattati di Roma del 1957, sempre fra i sei
paesi che avevano dato vita alla Ceca, i quali istituirono la Comunità economica europea
(Cee) – o Mercato comune europeo (Mec) – e la Comunità europea per l’energia atomica
(Ceea o Euratom), entrate in vigore all’inizio del 1958, con scopi molto più ambiziosi.
L’Euratom si proponeva di promuovere lo sviluppo delle ricerche e la diffusione delle conoscenze in materia nucleare, nonché di provvedere all’approvvigionamento della materia prima necessaria. Ben più importante fu il Mercato comune, che si prefiggeva la libera circolazione delle merci, dei lavoratori, dei capitali e dei servizi, da realizzare entro dodici anni. Si
dovevano abolire i dazi doganali e le restrizioni quantitative agli scambi, bisognava fissare
una tariffa doganale comune, garantire la libera concorrenza e praticare politiche comuni nel
campo commerciale (verso i paesi terzi) e in quelli agricolo, dei trasporti e sociale. Gli organismi delle due Comunità istituite a Roma erano simili a quelli della Ceca e perciò vennero
successivamente fusi, sicché le tre Comunità ebbero gli stessi organi di governo. I risultati
furono superiori alle attese ed entro il 1968, con anticipo sui tempi previsti, i dazi tra gli Stati
membri furono completamente eliminati. In seguito, l’Assemblea generale fu trasformata in
Parlamento europeo, i cui membri, in un primo tempo, furono eletti dai Parlamenti nazionali
e dal 1979 dai cittadini degli Stati aderenti a suffragio universale.
La Gran Bretagna, pure invitata a entrare nel nuovo organismo, non vi aderì, perché non
voleva rinunziare a parte della propria sovranità e ai suoi legami particolari con i paesi del
Commonwealth. Tuttavia non era contraria a semplici aree di libero scambio e, perciò, promosse, assieme ai paesi scandinavi, alla Svizzera, all’Austria e al Portogallo, l’Associazione
europea di libero scambio (Efta, European Free Trade Association), che entrò in funzione
nel 1960. Ma già qualche anno dopo, la Gran Bretagna chiese di essere ammessa al Mercato
comune. L’opposizione della Francia ne ritardò l’ingresso, che avvenne solo nel 1973, assieme all’Irlanda e alla Danimarca. Negli anni Ottanta aderirono alla Comunità europea anche la Grecia, la Spagna e il Portogallo.
La crescita economica dei sei paesi della Comunità durante l’età dell’oro fu veramente
imponente. Tutti gli indicatori economici mostrano un andamento che ha del «miracoloso» e
il Pil non fece che aumentare a tassi mai raggiunti né prima né successivamente. Per fare un
solo esempio, basti considerare come, fatta uguale a 100 la produzione industriale del 1938,
essa fosse giunta, già nel 1958, a 195 nella Germania occidentale, a 188 in Francia e a ben
Appunti di Storia economica
13
232 in Italia. Anche l’agricoltura conobbe una forte espansione ed entro il 1960 rese la Comunità autosufficiente in molti prodotti (latte e suoi derivati, carne suina e ortaggi) e quasi
autosufficiente in altri (grano, zucchero e pollame). Il commercio estero dei paesi della Cee,
per conseguenza, aumentò di ben 2,4 volte fra il 1953 e il 1962, quando essi controllavano il
24 per cento del commercio mondiale.
La Comunità europea si dotò di una propria politica agricola comunitaria (Pac), la cui attuazione non fu facile per le divergenze di interessi fra i paesi dell’Europa settentrionale,
produttori di cereali, di latte e dei suoi derivati, e quelli dell’Europa meridionale, che producevano ortaggi, vino e olio. La Pac si proponeva di sostenere i redditi degli agricoltori e di
proteggere la produzione dalla concorrenza estera. Perciò, i prezzi furono tenuti alti, a scapito dei consumatori, e si realizzarono delle eccedenze di prodotti, che dovettero essere ritirate
e distrutte. Con i paesi del Terzo Mondo, in particolare con gli ex possedimenti coloniali, la
Comunità europea stipulò diverse convenzioni, a partire da quella di Yaoundé, nel Camerun
(1963), che prevedeva forme di cooperazione commerciale, tecnica e finanziaria con 18 paesi africani, in gran parte ex colonie francesi e belghe. In seguito, il numero dei paesi che goderono di rapporti preferenziali con la Comunità europea, aumentarono fino a 65 (1984), anche per l’estensione di tali vantaggi alle ex colonie britanniche del Commonwealth.
Le crisi petrolifere degli anni Settanta e il crollo del sistema dei cambi fissi colpirono in
modo particolare i paesi dell’Europa occidentale. Il Pil pro capite aumentò, fra il 1973 e il
2003, dell’1,9 per cento all’anno, vale a dire meno della metà della crescita registrata nel periodo precedente (vedi nuova tab. 7.2) e la produttività del lavoro cominciò a diminuire. Nel
frattempo rallentava la crescita demografica e il vecchio continente fu interessato da un imponente flusso di immigrazione. I principali problemi dell’economia europea, però, erano la
disoccupazione e l’inflazione. La disoccupazione raggiunse livelli altissimi che, fra il 1994 e
il 1998, oscillarono mediamente intorno all’11 per cento, mentre durante l’età dell’oro erano
stati inferiori al 3 per cento. Una disoccupazione così elevata riuscì ad essere sopportata solo
grazie al sistema di sicurezza sociale (pensioni, indennità di disoccupazione, assegni familiari, assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattia, assistenza medica per tutti e così
via). La necessità di combattere l’inflazione, che in qualche paese (Italia e Spagna) superò il
16 per cento medio annuo (1974-83), indusse i governi e le forze economiche a tralasciare
un’efficace politica di lotta alla disoccupazione per puntare sulla stabilità dei prezzi. Essendo
saltato anche il sistema dei cambi fissi, si temeva che l’inflazione si potesse trasformare in
iperinflazione e si adottarono politiche restrittive del credito, che non favorivano gli investimenti e quindi la creazione di nuovi posti di lavoro. Le politiche deflazionistiche, comunque,
ebbero successo e l’inflazione, a partire dalla metà degli anni Ottanta cominciò a decrescere,
per portarsi poco sopra il due per cento nel periodo 1994-98 e rimanere a quei livelli anche
successivamente.
La necessità di combattere l’inflazione era dovuta anche a un obiettivo che i paesi europei
volevano perseguire: realizzare l’unione monetaria. Una proposta in tal senso era già stata
avanzata nel 1970, ma era stata accantonata in seguito alla fine del sistema di Bretton Woods. Se ne ricominciò a parlare molto tempo dopo, nel 1989. Nel frattempo, i paesi
dell’Europa occidentale tentarono di limitare l’oscillazione dei cambi delle loro monete mediante appositi accordi. Quello più importante riguardò la costituzione del Sistema monetario
europeo (Sme), entrato in vigore nel 1979, che prevedeva la fissazione di una parità fra le
monete aderenti e la possibilità di oscillazioni del 2,25 per cento in più o in meno (la lira italiana, più debole, fu autorizzata a fluttuare del 6 per cento, concessione che durò fino al
14
Ennio De Simone
1990). Le parità furono calcolate in una nuova unità di conto, l’Ecu (European Currency Unit), composta di un «paniere» di monete europee. Negli anni successivi, però, alcune monete, come il franco francese e la lira italiana, furono svalutate, mentre il marco fu rivalutato.
Lo Sme conseguì modesti successi fino al 1992, quando entrò in crisi. L’Italia e il Regno Unito ne uscirono, lasciando fluttuare liberamente le loro monete e l’anno successivo la banda
di oscillazione fu portata al 15 per cento, decisione che significava il sostanziale fallimento
del sistema europeo dei cambi fissi.
Nel 1992, intanto, veniva stipulato il Trattato di Maastricht (Olanda), con il quale la Comunità Economica Europea si sarebbe trasformata in Unione Europea, con lo scopo di perseguire l’unione politica, economica e monetaria. Fu decisa l’introduzione di una moneta unica, l’euro, in sostituzione di quelle dei singoli Stati e vennero fissati rigidi criteri di convergenza ai quali i paesi che volevano adottare la nuova moneta si dovevano attenere. Questi
criteri imponevano, in sostanza, di frenare l’inflazione e di mettere ordine nei conti dello Stato, riducendo il deficit e l’indebitamento pubblico. I paesi che non erano in regola, come
l’Italia, dovettero fare grossi sacrifici per raggiungere tali obiettivi. L’euro fu introdotto nel
1999 come moneta di conto e nel gennaio del 2002 come moneta effettiva, usata da 300 milioni di Europei, con la speranza di poter fare concorrenza al dollaro come moneta internazionale. Esso fu adottato da dodici paesi, con l’importante e significativa eccezione della
Gran Bretagna, che continuò a utilizzare la sterlina, non avendo aderito alla moneta unica. La
sua emissione è stata affidata alla Banca Centrale Europea (Bce), che ha anche il compito di
definire e attuare la politica monetaria nell’area dell’euro e di detenere e di gestire le riserve
degli Stati membri. Il Consiglio direttivo della Bce è composto dai governatori delle banche
centrali degli Stati che hanno aderito all’euro, le quali hanno perso la sovranità che avevano
sulle loro monete. In seguito, l’Unione si è ulteriormente allargata fino a comprendere 27
Stati, che contano circa 500 milioni di abitanti, inclusi alcuni paesi dell’Europa orientale (Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Bulgaria e Romania) o appartenenti all’ex Unione Sovietica (Estonia, Lettonia e Lituania). Finora (2009) solo sedici
paesi hanno adottato l’euro (Francia, Germania, Italia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Spagna, Portogallo, Irlanda, Austria, Grecia, Finlandia, Slovacchia, Slovenia, Malta e Cipro).
1.4. I principali paesi europei
Nel secondo dopoguerra, i paesi più grandi dell’Europa occidentale – Gran Bretagna,
Francia, Germania e Italia – ebbero destini comuni, segnati dalla costruzione dell’Unione
Europea, ma ognuno di essi seguì un proprio percorso per realizzare il grande sviluppo della
seconda metà del ventesimo secolo. La Gran Bretagna, nonostante fosse uscita vincitrice
dal secondo conflitto mondiale, si trovò in gravi difficoltà e dovette prendere atto che ormai
la leadership economica (e politica) mondiale era definitivamente passata agli Stati Uniti.
Durante la guerra aveva accumulato un pesante debito estero e fu costretta a chiedere un prestito di ben cinque miliardi di dollari agli Stati Uniti e al Canada per poter pagare le importazioni
di derrate e di materie prime. Inoltre, fu particolarmente provata dal rigido inverno del 194647, che coprì le isole britanniche di una coltre di ghiaccio e paralizzò l’economia per diverse
settimane, durante le quali, oltre al pane, dovette essere razionata anche la corrente elettrica.
Il nuovo governo laburista mise mano, nell’immediato dopoguerra, a una serie di nazionalizzazioni (Banca d’Inghilterra, telecomunicazioni, aviazione civile, carbone, elettricità, tra-
Appunti di Storia economica
15
sporti, gas, siderurgia), che, però, non mutarono i caratteri dell’economia di mercato, in quanto
l’80 per cento dell’industria rimase nelle mani dei privati e le imprese nazionalizzate, più che
diventare il settore trainante dell’economa, si trovarono a rimorchio di quelle private. Di grande importanza furono i provvedimenti tesi a realizzare il Welfare State, così come proposto da
Lord Beveridge. Fu istituito il Servizio sanitario nazionale, che doveva garantire la completa
assistenza medica a tutti i residenti nel Regno Unito, si varò un vasto programma di edilizia
pubblica per ricostruire gli immobili distrutti dai bombardamenti, si introdussero diverse forme
di assistenza ai lavoratori e ai cittadini e venne migliorato il sistema dell’istruzione.
Superati i difficili momenti dell’immediato dopoguerra, l’economia riprese a crescere e i
cittadini britannici poterono entrare nell’era dei consumi di massa qualche anno prima del
resto dell’Europa. Ma si trattò di una crescita lenta. Dalla fine del conflitto all’inizio del
Duemila, difatti, il Pil pro capite del Regno Unito aumentò a un ritmo medio di circa il 2 per
cento all’anno. Sembra – come ha scritto uno storico – che questa percentuale «fosse stata
elargita all’economia britannica per grazia divina», quasi che, effettuato lo sforzo di trainare
la prima rivoluzione industriale, la Gran Bretagna avesse acquisito il diritto a un tasso di crescita modesto, ma costante, del quale si deve accontentare (vedi nuova tab. 5.1). Gli Inglesi
non prestarono la dovuta attenzione alla modernizzazione dell’economia e trascurarono
campi come la «ricerca e sviluppo» 4 , l’incremento della produttività e l’innovazione tecnologica, mentre la bilancia commerciale continuava a essere passiva, perché si importava più
di quanto si esportasse.
La crisi petrolifera fu particolarmente dura e coincise con un lungo sciopero dei minatori
che, nel 1974, bloccò l’economia, chiaro sintomo di un malessere sociale abbastanza diffuso.
Alcune crisi cicliche colpirono in modo particolare la Gran Bretagna e, in certi anni (197475, 1980-81, 1991), il Pil invece di aumentare fece registrare una diminuzione, anche se non
molto grave. Negli anni Ottanta, la politica neoliberista di Margaret Thatcher portò alla privatizzazione di molte industrie statali (telecomunicazioni, gas, ecc.), alla riduzione della spesa pubblica, che fece peggiorare la qualità dei servizi (sanità, istruzione, ecc.) e a un processo
di ristrutturazione industriale, che comportò la chiusura delle fabbriche inefficienti e un aumento della disoccupazione. Negli anni Ottanta e Novanta si svilupparono nuovi settori di
avanguardia (in particolare l’elettronico) a scapito soprattutto dell’industria pesante e del tessile. Inoltre, la Gran Bretagna iniziò a sfruttare, dal 1975, assieme alla Norvegia, i ricchi giacimenti petroliferi scoperti nel Mare del Nord, che hanno portato l’attuale produzione complessiva dei due paesi al 5 per cento di quella mondiale e hanno consentito al Regno Unito di
coprire la maggior parte del suo fabbisogno energetico. Negli ultimi anni, l’economia ha conosciuto una fase di crescita accelerata. Il Pil pro capite, a partire dal 1993, è aumentato in
media del 2,6 per cento all’anno (superando la soglia del fatidico 2 per cento), anche grazie a
una ritrovata competitività dei prodotti inglesi. La Gran Bretagna ha potuto recuperare, così,
il ritardo precedentemente accumulato nei confronti degli altri paesi dell’Unione Europea
(vedi nuova tab. 7.1).
La Francia uscì dalla guerra con gravi distruzioni materiali sull’intero territorio nazionale. Essa presentava alcune debolezze sostanziali: la popolazione era rimasta praticamente invariata nei cinquanta anni precedenti (e perciò era invecchiata), l’economia era chiusa verso
4
L’espressione ricerca e sviluppo (in sigla R&S) indica le attività mediante le quali un’impresa studia e sperimenta la fattibilità tecnica di nuovi prodotti (ricerca) e traduce queste conoscenze in una forma standardizzata,
che ne consenta la realizzazione industriale (sviluppo).
16
Ennio De Simone
l’esterno e riusciva a sostenersi solo con misure protezionistiche e grazie ai rapporti commerciali con le sue colonie e, infine, lo Stato, dopo la lunga occupazione nazista, non aveva
né gli strumenti né la volontà di impegnarsi in una vera politica economica. Il paese, inoltre,
era ancora troppo legato all’agricoltura, con un numero di addetti particolarmente elevato.
All’indomani della liberazione, però, la Francia fu capace di uno slancio nazionale, al quale parteciparono tutte le parti politiche e l’intera popolazione, che le consentì di riprendersi
rapidamente (in cinque anni il Pil pro capite raddoppiò) e di entrare con determinazione
nei «trenta gloriosi», come i Francesi chiamano gli anni della golden age, che per loro iniziò con anticipo sugli altri paesi europei. La popolazione, nel rinnovato clima di fiducia,
riuscì a invertire la tendenza negativa che durava da troppo tempo e riprese a crescere a
ritmi sostenuti. Dalla fine della guerra a oggi, essa è aumentata di oltre il 60 per cento,
mentre quelle del Regno Unito, della Germania e dell’Italia sono cresciute di circa il 25
per cento. La ricostruzione fu realizzata a tempo di record, anche perché la Francia aveva
accusato una caduta delle attività produttive negli anni dell’occupazione nazista (1940-44),
sicché dopo la Liberazione poté subito iniziare la fase di rilancio in tutti i settori. Nel 1949,
il paese era tornato ai livelli del 1939, che era stato l’anno migliore del periodo compreso
fra le due guerre mondiali.
L’obiettivo principale fu la modernizzazione sotto la guida dello Stato. Pur rimanendo legata all’economia di mercato, la Francia s’indirizzò, come altri paesi dell’Europa continentale, verso una forma di economia mista, con la creazione di un ampio settore pubblico accanto
a quello privato. Il primo passo fu la nazionalizzazione di diverse imprese, eseguita immediatamente fra il 1944 e il 1946, che riguardò alcuni settori strategici: l’energia (carbone, elettricità e gas), i trasporti (aerei e marittimi) e il credito (le grandi banche). Grazie all’impegno di
Jean Monnet, fu introdotta, già sul finire del 1946, la pianificazione economica, mediante
l’approvazione di piani quadriennali, volti dapprima alla ricostruzione e poi alla crescita economica. I risultati furono notevoli, sia nella produzione industriale sia in quella agricola.
L’agricoltura si modernizzò, fece largo uso di macchine e aumentò la sua produttività, mentre un consistente esodo rurale riforniva di manodopera le fabbriche. Lo Stato promosse anche l’apertura dell’economia verso l’esterno. Furono abbandonate le pratiche protezionistiche e le strategie autarchiche e la Francia, con Robert Schuman, fu tra i più convinti sostenitori della costruzione del Mercato comune europeo.
La crisi petrolifera indusse la Francia, più di qualsiasi altro paese europeo, a puntare sulle
centrali nucleari per la produzione di energia elettrica e oggi, in questo campo, è seconda solo agli Stati Uniti. Dopo la crisi, la politica economica francese fu caratterizzata da un alternarsi di privatizzazioni e nazionalizzazioni. Dapprima venne seguita una politica economica
liberista, tesa al rilancio della competitività delle imprese, attraverso l’innovazione e la privatizzazione di alcune industrie di Stato. Negli anni Ottanta, il governo socialista, in controtendenza con quanto avveniva in altri paesi europei, effettuò ulteriori nazionalizzazioni
(grandi banche e gruppi industriali chimici, siderurgici, dell’informatica e degli armamenti) e
aumentò i salari e la spesa pubblica per rilanciare i consumi interni. Ma poi dovette rivedere
il suo programma e fu costretto a tagliare le spese, congelare i salari e svalutare il franco.
Negli anni Novanta furono di nuovo riprivatizzate alcune imprese precedentemente nazionalizzate. Oggi la Francia ha un’economia prospera, fondata principalmente sui servizi, possiede la più poderosa agricoltura dell’Unione Europea (con poco più del 3 per cento di addetti),
un’industria di altissimo livello ed è il primo paese al mondo per arrivo di turisti stranieri. Lo
Stato conserva una forte presenza e controlla circa un terzo delle attività industriali e la mag-
Appunti di Storia economica
17
gior parte di quelle finanziarie. Può contare, inoltre, su una classe di pubblici funzionari preparati, appositamente formati in prestigiose scuole della funzione pubblica.
La Germania, prostrata materialmente e moralmente dalla guerra, rimase priva di un proprio governo fino al 1949. Gli occupanti (specialmente i Sovietici) cominciarono subito a
smantellare l’industria degli armamenti e altre industrie pesanti, parte delle quali acquisirono
in conto delle riparazioni che pensavano di imporre al nemico sconfitto. Lo scopo degli Alleati era di impedire alla Germania di ricostruire un apparato produttivo e una concentrazione
del potere economico che le avevano consentito di sostenere il peso di due guerre mondiali a
distanza di poco tempo. Perciò, smembrarono le grandi imprese e le grandi banche e fecero
sorgere al loro posto diverse società di più modeste dimensioni. Nel 1948, senza consultare i
Sovietici, gli Americani introdussero una nuova moneta, il Deutsche Mark, in sostituzione
del vecchio Reichsmark, ormai completamente privo di valore. Questo provvedimento acuì i
contrasti fra le potenze occupanti e portò alla definitiva divisione della Germania in due Stati
separati.
La Germania occidentale (Repubblica Federale Tedesca), divisa in Länder (Stati federali)
con ampia autonomia, dove vivevano 50 milioni di persone, era la parte più industrializzata e
meglio dotata di risorse naturali. Il clima della Guerra fredda e la divisone in due del paese
indussero gli Americani a rivedere la loro politica verso la nazione sconfitta, che vollero trasformare in un alleato in funzione anticomunista. Perciò ne favorirono la ricostruzione e lo
sviluppo, inserendola nel programma di aiuti del Piano Marshall, e qualche tempo dopo, fu
possibile anche la ricostituzione dei grandi gruppi bancari e imprenditoriali smembrati. Da
allora ebbe inizio un lungo periodo di crescita, che va sotto il nome di miracolo economico
tedesco, con un incremento medio annuo del Pil pro capite del 5 per cento fino al 1973 (vedi
nuova tab. 5.1). Nel 1954, i Tedeschi avevano recuperato il livello del Pil pro capite dell’anteguerra (calcolato a valori costanti) e impiegarono appena quindici anni per raddoppiarlo.
Diverse sono le ragioni di questo rapido sviluppo. Furono innanzitutto eliminate le bardature protezionistiche e autarchiche del periodo nazista e fu liberalizzata l’economia. La Germania s’ispirò all’economia sociale di mercato, una forma di economia mista che, in qualche
misura, ha influenzato anche altri paesi dell’Europa continentale. Essa si basa sul libero mercato, ma prevede un’incisiva azione pubblica per perseguire la giustizia sociale e la solidarietà fra le diverse componenti della collettività, con particolare attenzione alle categorie più
deboli. Questo modello fu completato con la cogestione, vale a dire con la partecipazione dei
lavoratori alla conduzione delle aziende, introdotta già alla fine della guerra, ma generalizzata negli anni Settanta. La crescita dell’economia tedesca si basò principalmente sulle esportazioni, che aumentarono notevolmente a mano a mano che il paese si inseriva nel commercio internazionale e conquistava nuovi mercati con un’agguerrita politica di penetrazione
commerciale. La Germania esportava, prevalentemente, beni a elevato contenuto tecnologico
(macchinari, automobili, prodotti chimici, televisori, frigoriferi, ecc.), che arrivarono a un
quarto della produzione complessiva del paese, facendo conoscere e apprezzare i prodotti tedeschi in tutto il mondo. La Germania occidentale si poté giovare anche di un continuo flusso di lavoratori immigrati, costituito, nei primi anni, da profughi provenienti dai territori caduti sotto il controllo sovietico (almeno 12 milioni), successivamente da lavoratori, spesso
altamente specializzati, che fuggivano dalla Germania orientale e quindi facilmente integrabili (oltre 2,2 milioni), e, infine, da lavoratori generici affluiti dall’area mediterranea (almeno
altri 4 milioni), in particolare italiani e, soprattutto, turchi, che ebbero non pochi problemi di
inserimento. L’economia della Germania occidentale diventò la più solida dell’Europa e as-
18
Ennio De Simone
sunse la funzione di «locomotiva» dello sviluppo dell’intera Comunità europea, con un marco «forte», che fu più volte rivalutato.
La Germania orientale (Repubblica Democratica Tedesca), viceversa, con appena 18 milioni di abitanti, nacque come uno Stato accentrato e attuò, sull’esempio sovietico, l’economia pianificata. Essa era la parte meno sviluppata della Germania e il suo Pil pro capite, nel
1950, era la metà di quello della parte occidentale. Fino al 1973, però, la sua crescita fu solo
di poco più lenta di quella della Germania occidentale (+ 4,5 per cento all’anno) ed essa fu
fra le nazioni più ricche e avanzate del blocco sovietico. Partita da una situazione meno favorevole, subì, fino all’erezione del muro di Berlino nel 1961 (elevato proprio per questo motivo), un’emorragia di manodopera, che spesso mise in crisi la continuità del lavoro nelle fabbriche. La pianificazione puntò sull’industria pesante, a scapito dei beni di consumo, e
l’agricoltura, che fu socializzata, diede scarsi risultati. Il confronto continuo fra le realizzazioni delle due Germanie, che condizionò, in qualche modo, l’operato dei rispettivi governi,
era nettamente favorevole alla parte occidentale e i Tedeschi dell’Est soffrirono di
un’insufficiente disponibilità di beni di consumo.
La riunificazione tedesca, di cui si era parlato negli anni Cinquanta e che era poi stata accantonata, perché diventata impossibile nel clima della Guerra fredda, fu realizzata nel 1990,
l’anno successivo alla caduta del muro di Berlino. Avvenne pacificamente per annessione,
nel senso che i territori orientali chiesero di entrare a far parte della Repubblica Federale Tedesca come nuovi Länder. Il costo dell’operazione fu molto elevato. La necessità di agire con
rapidità e decisione e la volontà di favorire, per motivi politici, i Tedeschi dell’Est indussero
il governo a fissare la conversione del marco orientale con quello occidentale alla pari (uno
contro uno), mentre valeva molto di meno, con beneficio di chi, nell’ex Germania comunista,
percepiva un salario o uno stipendio. Il governo, inoltre, dovette affrontare spese ingenti, coperte con nuove imposte, per la modernizzazione delle infrastrutture e il risanamento
dell’apparato industriale della parte orientale. Le imprese furono privatizzate e quelle poco
produttive smantellate, con l’inevitabile incremento della disoccupazione, che creò malcontento in una popolazione – quella dell’ex Germania comunista – abituata a vivere modestamente, ma con i bisogni essenziali garantiti dallo Stato. Anche nella Germania occidentale
non mancarono proteste per i sacrifici imposti per realizzare l’unificazione. Negli anni Novanta, perciò, l’economia rallentò la sua crescita e furono necessari dolorosi interventi di
ristrutturazione produttiva (delocalizzazione) e di riduzione delle spese pubbliche. Fra il
1989 e il 2006, il Pil pro capite tedesco è cresciuto in media di appena l’1,1 per cento
all’anno, mentre nei quindici anni precedenti aveva messo a segno una crescita del 2 per cento. L’economia tedesca è comunque molto solida e rimane fortemente legata alle esportazioni, il cui valore (2005) è pari al 51 per cento del Pil, seguita a distanza da Italia e Francia, rispettivamente con esportazioni pari al 29 e al 28 per cento del loro Pil.
Un breve cenno merita pure la Spagna, per i successi che ha ottenuto negli ultimi decenni.
La sanguinosa guerra civile (1936-39) fra il governo repubblicano e le truppe ribelli capeggiate dal generale Francisco Franco (sostenuto da Germania e Italia), si concluse con la vittoria dei franchisti e con l’instaurazione di un regime fascista. La Spagna non partecipò al secondo conflitto mondiale, ma rimase isolata, politicamente ed economicamente, dall’Europa
democratica almeno per tutti gli anni Quaranta e Cinquanta. Nel decennio successivo, cominciò a ravvicinarsi all’Europa e conobbe uno sviluppo economico eccezionale. Se negli
anni Cinquanta il suo Pil pro capite era cresciuto del 3,5 per cento all’anno, fra il 1960 e il
1973 aumentò del 7,3 per cento ogni anno. L’economia spagnola si stava modernizzando in
Appunti di Storia economica
19
tutti i settori, con un massiccio esodo dalle campagne e una consistente industrializzazione,
anche grazie a investimenti provenienti dall’estero, mentre il turismo stava trasformando intere zone del paese e costituiva una preziosa fonte di entrate di valuta estera. Alcuni milioni
di Spagnoli, però, dovettero prendere la via dell’emigrazione, in particolare verso la Francia
e la Germania. Alla morte di Franco, nel 1975, vi fu una pacifica transizione verso la democrazia e fu restaurata la monarchia, con l’incoronazione del giovane re Juan Carlos di Borbone. Entrata nella Comunità Economica Europea nel 1986, la Spagna è continuata a crescere a
ritmi sostenuti. Il suo Pil pro capite, che nel 1960 era pari ad appena il 36 per cento di quello
britannico, giunse, in appena venti anni, al 71 per cento e, fra il 1975 e il 2002, riuscì a raddoppiarsi (in valori costanti) (vedi nuova tab. 7.1). La Spagna, oggi una delle principali nazioni sviluppate, ha riacquistato in Europa la posizione che aveva perso da molto tempo.
1.5. Ricostruzione e miracolo economico in Italia
Le condizioni dell’Italia, alla fine del secondo conflitto mondiale, erano disastrose. La
guerra, combattuta per oltre due anni sul territorio nazionale, aveva provocato ingenti danni
al patrimonio abitativo e al sistema dei trasporti, sia per i bombardamenti aerei degli angloamericani sia per le sistematiche distruzioni dei Tedeschi in ritirata. Erano stati distrutti 1,9
milioni di vani e quasi altri 5 milioni risultarono danneggiati (su circa 34 milioni di vani esistenti); si era perso più dell’80 per cento della marina mercantile; le linee ferroviarie erano
interrotte per i danni arrecati a ponti, linee aeree e binari; le strade erano impraticabili e gli
autocarri si erano ridotti a meno della metà. Relativamente pochi (meno del 10 per cento) erano, invece, i danni all’apparato industriale. Il biennio 1945-46 fu particolarmente duro per
la popolazione, che fu soccorsa dagli aiuti dell’Unrra (United Nations Relief and Rehabilitation Administration), un fondo di aiuti ai paesi colpiti dalla guerra, sostenuto principalmente
dagli Stati Uniti, che inviò soprattutto viveri, medicinali e vestiario, ma anche sementi, concimi, macchinari, materie prime e combustibili.
Il Pil pro capite era crollato, nel 1945, al 55 per cento di quello del 1939 ed era addirittura inferiore (in valori costanti) a quello del 1905. Nessuno avrebbe immaginato che sarebbero bastati appena cinque anni per ritornare al livello di prima della guerra, né che lo sviluppo
successivo sarebbe stato eccezionale, tanto da far parlare di miracolo economico, e avrebbe
trasformato profondamente l’economia e la società italiane. In appena ventitré anni, fra il
1950 e il 1973, il Pil pro capite riuscì a triplicarsi (sempre in valori costanti), e aumentò, in
media, del 5 per cento all’anno, consentendo un miglioramento senza precedenti del tenore
di vita degli Italiani (vedi nuova tab. 5.1). Per comprendere le trasformazioni realizzate, basti
pensare che, secondo l’inchiesta parlamentare sulla miseria del 1951-52, quasi un quarto delle famiglie italiane era considerato misero o indigente, la metà degli appartamenti non possedeva il gabinetto interno e più della metà non disponeva di acqua corrente. E questi valori
erano sensibilmente più elevati nel Mezzogiorno.
Negli anni della ricostruzione, la nuova classe politica, in genere priva di esperienza di
governo, non solo si trovò ad affrontare alcuni problemi immediati, come la ripresa della
produzione e la lotta all’inflazione, ma dovette effettuare scelte fondamentali per il futuro del
paese. La ricostruzione dell’apparato produttivo e dei trasporti fu rapida e si giovò degli aiuti
americani, giunti dapprima attraverso l’Unrra e poi con il Piano Marshall, il quale, come si
ricorderà, prevedeva sia aiuti gratuiti che prestiti. Il governo americano, in virtù di questo
20
Ennio De Simone
piano, cedeva gratuitamente merci al governo italiano, che le metteva in vendita sul mercato
nazionale e con il ricavato, confluito in un apposito «fondo lire» presso la Banca d’Italia,
provvedeva alle spese per la ricostruzione, in accordo con gli Americani. Fra il 1948 e il
1952, giunsero combustibili, cotone, cereali, macchinari e attrezzature industriali, che servirono sia a fare fronte alle più pressanti necessità alimentari, sia alle esigenze produttive. Le
imprese italiane, da parte loro, ottennero dagli Stati Uniti prestiti per l’acquisto di attrezzature, di cui beneficiarono principalmente le industrie meccaniche, metallurgiche ed elettriche
(Fiat, Edison, Sip e numerose società dell’Iri). All’incirca i due terzi dei fondi andarono alle
tre regioni del triangolo industriale e solo poco più del 9 per cento al Mezzogiorno continentale (quasi esclusivamente alla Campania).
L’inflazione, che era stata abbastanza contenuta fino al 1943, esplose dopo l’armistizio
dell’8 settembre, quando il fronte divise in due l’Italia. Nel 1947 il costo della vita era aumentato di oltre quaranta volte rispetto al 1939 per diversi motivi: la penuria di beni, che aveva fatto lievitare i prezzi; la massiccia emissione di biglietti di banca e di Stato, necessari
per le spese della guerra e della ricostruzione; l’introduzione, da parte delle autorità militari
alleate, delle «Amlire» (Allied military currency o Allied military lires), una moneta di occupazione che circolò dal 1943 al 1950. Alle Amlire fu attribuito un valore elevato rispetto
alla lira, sicché gli acquisti delle truppe alleate, pagati con quella moneta, contribuirono a far
aumentare i prezzi. L’inflazione fu combattuta con la cosiddetta linea Einaudi, una serie di
misure prese dal ministro del Bilancio, Luigi Einaudi, che miravano alla riduzione della circolazione monetaria, mediante un forte rialzo del tasso ufficiale di sconto e un aumento delle
riserve obbligatorie delle banche (in tal modo, le banche non potevano investire una parte dei
depositi raccolti, che quindi non erano rimessi in circolazione). Questi provvedimenti, che
comportarono una temporanea riduzione degli investimenti e un aumento della disoccupazione, riuscirono a fermare l’inflazione e diedero fiducia agli investitori stranieri. La lira fu
stabilizzata, nel 1948, a 625 lire per dollaro, che costituì la parità con la quale la moneta italiana entrò nel sistema monetario internazionale, e tale rimase fino al suo crollo nel 1971.
La scelta fondamentale del governo, costituito dal partito della Democrazia cristiana e da
alcuni partiti minori, dopo l’estromissione (1947) di socialisti e comunisti, fu quella a favore
di un’economia aperta fondata sul libero mercato, che doveva inserire l’Italia negli scambi
internazionali, in particolare con i paesi europei. La scelta era, in qualche modo, obbligata
perché, secondo gli accordi di Yalta, l’Italia rientrava nella sfera d’influenza americana.
D’altra parte, il passaggio a un’economia aperta era inevitabile per un paese costretto ad acquistare all’estero le materie prime e le fonti di energia necessarie (carbone e petrolio), quasi
del tutto assenti sul territorio nazionale, che poteva pagare solo con le sue esportazioni. Furono revocate le precedenti misure autarchiche, che ostacolavano il commercio con l’estero
(contingentamenti, restrizioni valutarie, alti dazi doganali, ecc.) e l’Italia aderì al Fondo monetario internazionale e alla Banca mondiale, nonché all’Unione europea dei pagamenti.
Durante la ricostruzione non vi furono nazionalizzazioni, come in Francia e in Inghilterra,
perché in Italia già esisteva un consistente settore pubblico. L’Iri, sorto in seguito ai salvataggi degli anni Trenta, controllava, attraverso le sue società finanziarie o mediante partecipazioni azionarie, diverse imprese che operavano nel settore industriale (meccanica, siderurgia, chimica, elettricità, costruzioni stradali), in quello dei trasporti (linee di navigazione marittime e aeree) e nel sistema bancario (grandi banche di interesse nazionale). In mano pubblica era pure l’Agip (Azienda generale italiana petroli), sorta nel 1926, che fu rilanciata da
Enrico Mattei, ex partigiano e potente manager pubblico, il quale promosse, nel 1953, la co-
Appunti di Storia economica
21
stituzione di un’altra grande azienda pubblica, l’Eni (Ente nazionale idrocarburi), che doveva assicurare all’Italia il rifornimento delle fonti di energia. Le imprese pubbliche operavano
sul mercato in regime di concorrenza con quelle private ed erano costituite sotto forma di società per azioni, possedute, in tutto o in parte, dallo Stato. Perciò fu istituito il Ministero delle
partecipazioni statali (1956-93), con il compito gestire le società che appartenevano allo Stato, che ricevette non poche critiche per i metodi politico-clientelari seguiti nello svolgimento
della sua attività.
Nel 1950 furono varati due importanti provvedimenti: la riforma agraria e la costituzione
della Cassa per il Mezzogiorno. La cosiddetta riforma agraria (in realtà provvedimenti parziali, ma tuttavia importanti) consistette nell’espropriazione di 800 mila ettari di terre ai
grandi proprietari (di cui 650 mila nel Mezzogiorno) e nella loro assegnazione a famiglie di
braccianti agricoli. I proprietari furono indennizzati con titoli di Stato e gli assegnatari, che
ebbero quote di modesta estensione, diventavano pieni proprietari dopo il pagamento di trenta annualità. In quegli stessi anni, molti contadini acquistarono terre da proprietari non coltivatori, potendo beneficiare di particolari facilitazioni e di ampie sovvenzioni creditizie. Entrambe queste redistribuzioni di terre (la riforma e i trasferimenti volontari) fecero aumentare
la piccola proprietà coltivatrice che, se da un lato soddisfaceva l’atavica fame di terre dei
contadini, dall’altro era di ostacolo all’ammodernamento dell’agricoltura, per via delle ridotte dimensioni delle aziende agricole. Si sviluppò, perciò, un vasto movimento cooperativo,
che consentì, in molte zone, di superare i limiti posti dal frazionamento della proprietà. La
Cassa per il Mezzogiorno, vissuta fino al 1984 (poi sostituita con un’Agenzia per il Mezzogiorno, soppressa nel 1993), doveva finanziare opere straordinarie di pubblico interesse nelle
regioni meridionali, in Sicilia e in Sardegna. Nei primi anni s’impegnò nella creazione di infrastrutture (strade, opere idrauliche, scuole, ospedali, ecc.) e soprattutto nel sostegno dell’agricoltura, dal momento che si era deciso di accantonare l’ipotesi dell’industrializzazione del
Mezzogiorno, per affidare solo alla più efficiente industria settentrionale il compito di essere
presente sui mercati internazionali. Da 1960, rivista questa posizione e deciso di sostenere la
creazione di imprese industriali nel Mezzogiorno, i fondi a ciò destinati furono notevolmente
potenziati.
A partire dal 1950, la crescita economica, come si è detto, fu eccezionale, almeno fino al
1963. Furono quelli gli anni del miracolo economico, durante i quali il Pil pro capite aumentò del 5,8 per cento all’anno, mentre successivamente, fino al 1973, i risultati furono più modesti, ma comunque ragguardevoli (+ 4 per cento). La crescita fu accompagnata da profondi
mutamenti strutturali. Fra i censimenti del 1951 e del 1971, gli addetti all’agricoltura crollarono dal 42 al 17 per cento del totale (perdendo oltre 5 milioni di contadini), mentre aumentarono gli addetti all’industria (dal 32 al 45 per cento) e quelli del settore terziario (dal 26 al
38 per cento). Gli analfabeti si ridussero dal 10,5 al 4 per cento della popolazione e aumentarono i diplomati (+ 44 per cento) e i laureati (+ 109 per cento). L’agricoltura si modernizzò,
anche grazie all’aiuto dello Stato, mediante una rapida meccanizzazione e una più diffusa utilizzazione di concimi chimici, e si rivolse maggiormente all’allevamento e alle produzioni
specializzate (ortofrutta, vite, olivo, ecc.). Essa, inoltre, liberando la manodopera in eccesso
delle campagne, fornì forza di lavoro a basso costo all’industria, dove si stavano sviluppando
nuovi rami accanto a quelli tradizionali. L’automobile, la meccanica di precisione, gli elettrodomestici, la petrolchimica e la produzione di fibre sintetiche furono i comparti che caratterizzarono lo sviluppo del periodo in esame. La bilancia dei pagamenti si portò in attivo a
partire dal 1957, non solo per le accresciute esportazioni, ma anche per le rimesse degli emi-
22
Ennio De Simone
grati e per lo sviluppo del turismo, che ormai cominciava ad attirare un gran numero di stranieri, desiderosi di scoprire le bellezze dell’Italia.
Le ragioni del miracolo economico italiano sono numerose e la loro individuazione è stata oggetto di parecchi studi da parte di storici e di economisti. Ne riassumiamo le principali:
a) gli aiuti americani, che consentirono la ripresa dell’economia nel dopoguerra;
b) la scelta di un’economia aperta orientata alle esportazioni, che costituirono, secondo
molti, il motore della crescita;
c) la disponibilità di manodopera a basso costo, durata fino alle rivendicazioni salariali
del 1962-63 e del 1969 (il cosiddetto «autunno caldo») e all’introduzione dello Statuto dei
lavoratori (1970), che tutelò maggiormente i lavoratori dipendenti;
d) un lungo periodo di bassi prezzi internazionali delle materie prime e delle fonti energetiche, che l’Italia doveva importare;
e) il ruolo dello Stato, che finanziò lo sviluppo di determinati settori, in particolare
l’agricoltura, l’edilizia e i trasporti (fra il 1956 e il 1964 fu costruita l’Autostrada del sole da
Milano a Napoli), e fu presente in numerosi rami economici con le imprese pubbliche, alle
quali, nel 1963, si aggiunse l’Enel (Ente nazionale per l’energia elettrica), in seguito alla nazionalizzazione, l’anno prima, delle imprese elettriche;
f) un solido sistema bancario, ristrutturato con la legge del 1936, capace di fornire i finanziamenti necessari, anche mediante i nuovi istituti di credito (in genere di origine pubblica) destinati ai finanziamenti industriali a medio-lungo temine (Mediobanca, Mediocrediti
regionali, ecc.).
Il miracolo economico presenta anche aspetti negativi, fra i quali sono da ricordare la ripresa dell’emigrazione e l’irrisolta questione meridionale. L’emigrazione dal Mezzogiorno
(ma anche da alcune zone del nord-est, come il Veneto), dove la modernizzazione
dell’agricoltura fece emergere la sovrappopolazione relativa delle campagne, fu di nuovo un
fenomeno che coinvolse milioni di persone. Gli emigranti partirono non solo per le Americhe (Argentina, Stati Uniti, Canada e Brasile), ma anche e sempre più frequentemente per
l’Europa (Francia, Svizzera e Germania) e l’Australia. Vi fu pure – e questa era una novità
per l’Italia – una massiccia migrazione interna verso le zone del triangolo industriale. Negli
anni Cinquanta e Sessanta si trasferirono dal Sud al Centro-Nord del paese circa due milioni
di persone, con non pochi problemi di sistemazione e di adattamento nelle città di arrivo. Altre abbandonarono le zone interne per spostarsi in quelle costiere della stessa regione. Il ritardo del Mezzogiorno non riuscì a essere annullato, anche se le distanze fra le due parti del
paese si ridussero (per divaricarsi di nuovo successivamente), grazie agli investimenti per
l’industrializzazione. Nacquero, in alcune zone costiere, grandi industrie, pubbliche e private, tecnologicamente avanzate, le quali, però, assorbirono poca manodopera, sicché la disoccupazione rimase molto elevata e la soluzione continuò a essere l’emigrazione verso altre regioni italiane. Con il tempo, l’emigrazione ha cominciato a riguardare sempre meno la manodopera generica priva di istruzione e sempre più giovani diplomati e laureati.
1.6. Rallentamento e ristrutturazione dell’economia italiana
L’economia italiana risentì della crisi petrolifera del 1973 e rallentò la sua crescita, realizzando, nel trentennio successivo, un incremento medio annuo del 2 per cento. Nel frattempo continuava il cammino verso la terziarizzazione dell’economia. Fra i censimenti del
Appunti di Storia economica
23
1971 e del 2001, gli addetti ai servizi passarono dal 38 al 61 per cento, mentre si ridussero
quelli dell’industria (dal 45 al 33,5 per cento) e caddero a livelli minimi gli addetti
all’agricoltura (dal 17 al 5,5 per cento). L’inflazione fu molto elevata e si tenne mediamente
intorno al 13,5 per cento all’anno sino agli inizi degli anni Ottanta. Nei mesi successivi
all’aumento dei prezzi del petrolio, furono varate delle misure per il risparmio energetico
che, sebbene durassero per poco tempo, resero evidente a tutti la gravità della crisi: fu vietato
alle autovetture di circolare la domenica; le vetrine dei negozi dovevano essere spente dopo
le 19; le sale cinematografiche, i bar e i ristoranti dovevano chiudere alle 23 e alla stessa ora
dovevano terminare le trasmissioni televisive, allora mandate in onda solo dalla Rai. L’Italia
cominciò a utilizzare sempre più il gas naturale, riducendo fortemente la dipendenza dal petrolio, che prima del 1973 costituiva quasi l’80 per cento del fabbisogno energetico italiano e
ai nostri giorni è sceso sotto il 50 per cento, mentre la quota del gas (fornito soprattutto
dall’Algeria e dalla Russia) è passata dal 10 a quasi il 40 per cento.
La crisi fu affrontata grazie all’intervento dello Stato, mediante il sostegno alle imprese in
difficoltà e ai redditi delle famiglie. Il sostegno alle imprese avvenne in diversi modi. Fu decisa la fiscalizzazione degli oneri sociali (rimasta in vigore fino al 1999), con la quale furono
ridotti i contributi che i datori di lavoro dovevano versare agli enti previdenziali e assistenziali per i loro dipendenti (pensioni, assicurazioni contro gli infortuni e le malattie, ecc.). I
salvataggi delle industrie in difficoltà avvennero tramite la Gepi (Società per le gestioni e
partecipazioni industriali), un’agenzia pubblica, istituita nel 1971, incaricata di concedere finanziamenti agevolati alle aziende industriali in difficoltà transitorie, anche mediante
l’assunzione di partecipazioni azionarie. Di fatto, però, la Gepi venne utilizzata per evitare il
licenziamento delle maestranze e mantenne in vita aziende improduttive. Fu anche finanziata
ulteriormente la Cassa integrazione guadagni (istituita alla fine degli anni Sessanta), che paga, per un certo periodo, una parte dello stipendio ai lavoratori licenziati. I redditi delle famiglie, oltre che con la Cassa integrazione guadagni, furono sostenuti mediante un allargamento del welfare. Furono introdotte le pensioni sociali a favore persone di oltre 65 anni di
età prive di reddito e fu riformato il sistema pensionistico, che prevedeva, fra l’altro, per il
pubblico impiego, la concessione di pensioni dopo soli quindici anni di servizio effettivo.
Nel 1978 fu istituito il Servizio sanitario nazionale e furono assicurati a tutti le prestazioni
mediche e ospedaliere, prima dispensate a pagamento o riservate ai lavoratori che versavano
i contributi ai loro enti mutualistici (le cosiddette «casse mutue»).
La conseguenza di tutte queste forme di intervento fu un forte aumento della spesa pubblica, alla cui lievitazione contribuirono anche la realizzazione di numerose opere pubbliche,
l’istituzione delle regioni a statuto ordinario (1970) e le massicce assunzioni di nuovo personale nel pubblico impiego. Fu, perciò, necessario aumentare il prelievo fiscale, mediante la
riforma del sistema tributario (1973), che prevedeva l’introduzione dell’Iva (imposta sul valore aggiunto) e dell’Irpef (Imposta progressiva sul reddito delle persone fisiche). Ma
l’aumento delle imposizioni fiscali non bastò e fu necessario ricorrere all’indebitamento
pubblico e all’emissione di banconote. Il debito pubblico cominciò a crescere fino a superare
il 100 per cento del Pil annuo e da allora costituisce un peso notevole che continua a gravare
sull’economia italiana. L’aumento della circolazione monetaria e la forte crescita dei prezzi
internazionali del petrolio e delle materie prime contribuirono a far esplodere l’inflazione,
che arrivò a toccare punte del 18 e del 21per cento (1978 e 1980). Per ridare competitività
alle imprese sui mercati internazionali si fece ricorso a continue svalutazioni della lira, metodo frequentemente utilizzato fino all’adozione dell’euro.
24
Ennio De Simone
Le grandi imprese, che si erano dovute notevolmente indebitare, procedettero ad una ristrutturazione produttiva. Per risparmiare sul costo della manodopera, diventato più rigido
con le conquiste salariali e normative successive all’«autunno caldo», ricorsero sempre di più
all’automazione dei processi produttivi, sostituendo i lavoratori con le macchine e, successivamente, con i computer, e decentrarono parte della loro attività a imprese più piccole o cominciarono a trasferirla all’estero. La disoccupazione aumentò, ma le grandi imprese, con un
minor numero di occupati, furono in grado di recuperare produttività e competitività e di lanciarsi di nuovo, dalla metà degli anni Ottanta, alla conquista dei mercati esteri. Alcuni comparti, come quello chimico ed elettronico non riuscirono a ristrutturarsi e rimasero indietro,
mentre la siderurgia, sia pure con difficoltà, superò la crisi. I settori più competitivi rimasero
quello meccanico (macchinari, elettrodomestici, automobili) e il cosiddetto made in Italy,
che proprio allora cominciava ad affermarsi. Costituito da un insieme di imprese che operano
nei comparti del tessile-abbigliamento-calzature (Benetton, Armani, Versace, Tod’s, Luxottica, ecc.), dell’arredamento e, in generale, dei prodotti destinati alle fasce alte del mercato, il
«made in Italy» è riuscito a incrementare notevolmente le proprie esportazioni e a far conoscere i prodotti italiani di qualità in tutto il mondo.
Mentre il peso della grande impresa nel sistema industriale italiano diminuiva, aumentava
quello delle piccole e medie imprese (Pmi). Esse, molto più flessibili, avevano sempre avuto
un ruolo importante, ma ora assunsero caratteristiche particolari ed ebbero il compito di trainare l’economia del paese. La loro presenza, diffusa sul territorio nazionale, pose fine allo
storico predominio del triangolo industriale e all’emergere della cosiddetta «Terza Italia»
(Centro e Nordest). Si formarono anche numerosi distretti industriali, aree coincidenti, in
genere, con pochi comuni, in cui si erano storicamente concentrate molte Pmi a carattere familiare, specializzate in una o più fasi di un processo produttivo. Queste imprese potevano
contare sulla presenza di maestranze specializzate, anche per l’esistenza di apposite scuole
professionali locali, e su una rete di relazioni commerciali con l’esterno per l’acquisto di materie prime e di macchinari e, soprattutto, per la collocazione sul mercato delle produzioni
«tipiche» del distretto. Le famiglie imprenditoriali dei distretti avevano maturato un forte
senso di appartenenza e di identificazione con il territorio, oltre che una specifica «cultura»
(valore del lavoro, della famiglia e del risparmio, volontà di rischiare, ecc.) e una serie di relazioni fra di loro, che si dimostrarono importanti fattori di sviluppo dell’intera zona. Nel
2005 si contavano 156 distretti industriali, riconosciuti e tutelati dalla legge, dove vivono
quasi tredici milioni di abitanti. Si possono ricordare, per fare solo qualche esempio, i distretti di Prato (tessile), di Carpi (tessile), di Sassuolo (ceramica), della Brianza (mobili), di Fermo (calzature), di Vicenza (oreficeria) e di Solofra (concerie).
La lotta all’inflazione fu condotta in vario modo. Fu adottata una politica restrittiva del
credito e il governo fece un minore ricorso alle anticipazioni della Banca d’Italia, che comportavano la stampa di nuova moneta, liberando (1981) l’istituto di emissione dall’obbligo
che fino ad allora aveva avuto di acquistare i titoli di Stato che non si riuscivano a collocare
fra i risparmiatori (si parlò, all’epoca, di «divorzio» fra Banca d’Italia e Tesoro). Inoltre, fu
ridotta la cosiddetta «scala mobile», un sistema di adeguamento automatico di salari e stipendi al costo della vita, in vigore dal 1975 al 1992, creata per difendere le retribuzioni
dall’aumento dei prezzi, ma che poi si ritenne contribuisse a far crescere i prezzi. Il tasso di
inflazione si portò, alla fine degli anni Ottanta, al 6 per cento e continuò a diminuire successivamente fino al 2 per cento del 1997. La riduzione dell’inflazione, assieme al risanamento
dei conti pubblici (contenimento del debito pubblico e diminuzione del disavanzo del bilan-
Appunti di Storia economica
25
cio statale), erano fra le condizioni previste dal trattato di Maastricht per poter entrare
nell’euro. Per raggiungere questi obiettivi furono necessarie alcune misure, come
l’abolizione di certi privilegi pensionistici, l’innalzamento dell’età pensionabile e l’aumento
della pressione fiscale, senza però riuscire a far diminuire significativamente il debito pubblico, rimasto a livelli molto elevati.
Siccome era difficile ridurre le spese sociali (pensioni, sanità e istruzione), una strada
percorribile (peraltro già seguita da altri paesi europei) fu quella della privatizzazione del rilevante patrimonio pubblico. Negli anni Ottanta erano state portate a termine le privatizzazioni dell’Alfa Romeo (ceduta alla Fiat) e di Mediobanca. Negli anni Novanta, dopo aver
trasformato le banche e gli enti pubblici in società per azioni (per poter collocare le azioni
sul mercato), si procedette a una serie di privatizzazioni che, fra il 1992 e il 2005, hanno portato nelle casse dello Stato quasi 140 miliardi di euro (circa 270 mila miliardi di lire). Esse
riguardarono le banche, le imprese dell’Iri (soppresso nel 2002), l’Eni, l’Enel, il sistema dei
trasporti (ferrovie, aerei, autostrade) e quello delle telecomunicazioni. Gli acquirenti furono
imprenditori nazionali e stranieri, alcuni dei quali con scopi speculativi, vale a dire con
l’intenzione di rivendere successivamente le imprese acquistate e non di potenziarle con un
progetto strategico per il loro futuro. Non si riuscirono a collocare molte azioni fra i piccoli
risparmiatori, anche se la Borsa italiana, che era sempre stata asfittica, conobbe una crescita
significativa, dovuta proprio all’immissione sul mercato delle imprese pubbliche. Lo Stato ha
tuttavia conservato importanti quote di partecipazione ed è ancora l’azionista di riferimento
(detentore del pacchetto di controllo), di molte aziende, comprese cinque delle maggiori dieci imprese italiane.
Il sistema bancario, oltre che privatizzato, fu riformato con alcune leggi, poi confluite nel
Testo Unico Bancario del 1993, che sostituì la legge bancaria del 1936. Oltre a una semplificazione (oggi esistono solo banche sotto forma di società per azioni e banche cooperative), è
stata superata la distinzione tra banche commerciali (credito a breve termine) e banche di investimento (credito a medio-lungo termine), per adottare il sistema delle banche universali,
che si occupano indistintamente di tutti i tipi di operazioni, compresa la partecipazione azionaria nelle società. Vi sono state anche numerosissime fusioni fra banche che hanno portato a
una riduzione del loro numero e alla formazione di grandi gruppi (Unicredit, Intesa San Paolo, Monte dei Paschi di Siena, ecc.), in grado di competere sul mercato internazionale dei capitali. Lo Stato, che, nel 1994, controllava il 70 per cento del sistema bancario, dieci anni
dopo ne controllava solo il 10 per cento.
La trasformazione dell’economia italiana, con la sostanziale scomparsa dello Stato imprenditore, ha riguardato anche il mercato del lavoro. Si è realizzato il passaggio da un mercato rigido a uno flessibile, con l’introduzione di una serie di contratti a termine, che interessano principalmente le nuove generazioni. Si è creata, in tal modo, una netta divaricazione
fra chi ha un lavoro a tempo indeterminato e tutelato e chi ne ha uno precario e poco tutelato.
Il mercato del lavoro si è arricchito, di recente, della presenza di alcuni milioni di immigrati
provenienti dai paesi poveri del mondo, che vengono impiegati in lavori che gli Italiani, in
genere, non desiderano più fare o perché troppo faticosi o perché mal retribuiti.
Nonostante le trasformazioni attuate (che, però, non sono riuscite a ridurre in modo significativo il forte debito pubblico), l’economia italiana, dopo essere cresciuta a ritmi abbastanza elevati, si è dimostrata, negli ultimi quindici anni, piuttosto debole e ha fatto registrare un
incremento annuo del Pil pro capite inferiore a quello degli altri grandi paesi europei, ai quali
resta comunque strettamente legata (vedi nuova tab. 5.1).
26
Ennio De Simone
1.7. Sviluppo e difficoltà dell’economia giapponese
Il Giappone aveva subito enormi distruzioni nella parte finale del conflitto, quando fu sottoposto a continui bombardamenti aerei e subì il tragico sgancio di due bombe atomiche su
Hiroshima e Nagasaki. Nel 1949, le sue condizioni erano ancora molto gravi e, specialmente
nelle città, la maggior parte della popolazione soffriva la fame o quantomeno era malnutrita.
La produzione agricola era crollata del 40 per cento rispetto a quella dell’anteguerra, mentre
nel paese erano affluiti circa sei milioni di individui, fra militari smobilitati e coloni ridotti in
miseria, che rientravano dai territori occupati dal Giappone. La produzione industriale era
crollata a livelli molto bassi e la disoccupazione era elevatissima. In un solo anno, il 1945, il
Pil pro capite si era dimezzato e risultava pari a meno del 12 per cento di quello americano.
Le speranze nel futuro di una nazione umiliata e sconfitta erano molto basse.
Invece, a partire dal 1950 e fino al 1973, anche il Giappone conobbe il suo miracolo economico. Il Pil pro capite aumentò in media dell’8,1 per cento all’anno, il doppio della crescita dell’Europa occidentale (vedi nuova tab. 7.2). La rimonta fu straordinaria: nel 1950 il Pil
pro capite era ancora pari al 28 per cento di quello britannico e al 20 per cento di quello americano, ma nel 1973 aveva quasi raggiunto il Pil britannico (lo supererà poco dopo, nel 1980)
e si era avvicinato a quello degli Stati Uniti. Gli investimenti e la produttività crebbero, la
disoccupazione scese a livelli bassissimi e le esportazioni aumentarono di ben ventitré volte.
I Giapponesi seppero adeguarsi alla domanda internazionale e le imprese, più che alla massimizzazione del profitto, si mostrarono interessate all’espansione produttiva e alla conquista
di nuovi mercati con prodotti di ottima qualità, come automobili e articoli elettronici.
L’eccezionale sviluppo economico giapponese si basò su diversi fattori, alcuni dei quali
erano esterni al paese. Fra questi vi fu la guerra di Corea (1950-53), maturata nel clima della
Guerra fredda, che contrappose gli Stati Uniti, alla guida di un esercito delle Nazioni Unite,
alla Corea del Nord comunista, sostenuta dalla Cina. Durante quel conflitto, che peraltro si
concluse senza vincitori né vinti con il riconoscimento di due Stati coreani, il Giappone, situato proprio di fronte alla Corea, fu in grado di rifornire le truppe americane di materiale
bellico, in cambio di dollari, che si rivelarono preziosi per pagare le importazioni di materie
prime e di petrolio, di cui aveva bisogno per la ripresa industriale. In tal modo, la sua economia poté ripartire. Il paese fu anche favorito dall’espansione del commercio internazionale, dovuta alla crescita costante delle economie degli Stati Uniti e di altri paesi occidentali e
all’azione del Gatt e del Fondo monetario internazionale. Le sue esportazioni verso il mercato statunitense aumentarono costantemente, anche perché gli Stati Uniti, come avevano fatto
in Germania, rividero la posizione inizialmente assunta verso il Giappone sconfitto e decisero di farne il fedele alleato asiatico contro il comunismo. Anche qui, difatti, gli Americani,
che occuparono militarmente il paese fino al 1952, avevano deciso lo smantellamento del
suo apparato industriale e avevano smembrato i potenti zaibatsu.
Il Giappone poté fare affidamento, ancora una volta, su una tecnologia avanzata, disponibile sul mercato internazionale a basso prezzo, in modo da recuperare il «gap» tecnologico
accumulato fra la fine degli anni Trenta e la fine degli anni Quaranta, quando la sua economia era rimasta sostanzialmente isolata dal resto del mondo. I Giapponesi seppero profittarne
meglio di altri per due ragioni: disponevano di un capitale umano di alto livello, che consentì
di utilizzare la tecnologia più moderna, e avevano un elevato volume di risparmio, dovuto
alla vita sobria che conducevano, sicché il processo di accumulazione di capitali poté ripartire in modo consistente. Il Giappone riuscì non solo ad appropriarsi della tecnologia occiden-
Appunti di Storia economica
27
tale, come aveva già fatto nell’epoca Meiji, ma anche a svilupparne una propria, soprattutto
nel campo dell’elettronica, in cui raggiunse una posizione di primo piano, contrastando con
successo il predominio statunitense.
Fra i fattori interni che favorirono lo straordinario sviluppo economico, si deve certamente ricordare l’azione dello Stato, che, com’era nella tradizione nipponica, continuò a esercitare un’importante stimolo sull’attività economica. Il governo, attraverso la Banca del Giappone, tenne bassi i tassi d’interesse e indusse le banche a garantire i finanziamenti necessari alle imprese che introducevano nuove tecnologie. Ridusse le imposte sugli alti redditi e sugli
investimenti di capitali e concesse sgravi fiscali alle imprese, in particolare sugli investimenti
in ricerca e sviluppo. Fu favorita la creazione di cartelli (vietati dagli Americani durante
l’occupazione), con l’obiettivo di fissare i prezzi e limitare la concorrenza. Il loro numero
crebbe da una cinquantina nel 1953 a oltre mille nel 1966, ma poi cominciò lentamente a diminuire. Infine, vennero varate misure protezionistiche per ostacolare l’importazione di merci straniere, sia attraverso barriere tariffarie (alti dazi o dazi differenziati per tipologia di prodotti) sia attraverso barriere non tariffarie (fissazione di elevati standard di qualità, dei prodotti da importare, ispezioni e controlli complicati e costosi, ecc.). Il governo realizzò anche
un’imponente riforma agraria (1950): acquistò a basso prezzo circa cinque milioni di ettari
da proprietari assenteisti e li ridistribuì a quasi cinque milioni di contadini.
Un altro importante fattore di sviluppo fu il clima di collaborazione fra gli attori economici e istituzionali. La collaborazione fra governo e imprese, che rientrava nella tradizione
nipponica, consentì di predisporre specifiche politiche di intervento e persino una pianificazione indicativa per i singoli comparti industriali. I ministeri, fra i quali spiccava per autorevolezza e impegno il celebre Miti (Ministero dell’industria e del commercio internazionale),
predisponevano direttive concordate, che, in genere, gli imprenditori e le loro associazioni
applicavano diligentemente. Si sviluppò anche la collaborazione fra le singole imprese, in
particolare fra quelle che facevano parte dei keiretsu, i nuovi gruppi imprenditoriali eredi degli zaibatsu. I keiretsu, una nuova forma di gruppo senza struttura gerarchica, sono formati
da numerose imprese con partecipazioni azionarie incrociate e con incarichi direttivi intrecciati 5 . Le imprese che ne fanno parte, tenute assieme più da vincoli di carattere etico che di
tipo giuridico, sono entità indipendenti che elaborano autonomamente le proprie strategie, in
collaborazione con le altre società affiliate, fra le quali vi è sempre una banca, che provvede
al loro finanziamento. Infine, si sviluppò la collaborazione fra il management delle imprese
e i dipendenti, già attiva da tempo, che rientra nella tradizione confuciana di rispetto delle
gerarchie all’interno del gruppo al quale si appartiene, e quindi anche all’interno
dell’azienda. I manager garantivano la sicurezza del posto di lavoro e prevedevano una serie
di benefici (formazione professionale, aumenti salariali per anzianità, gratifiche periodiche,
ecc.), in cambio della fedeltà dei dipendenti all’azienda. In tal modo, le vertenze sindacali
furono per lungo tempo meno numerose di quelle di qualsiasi altro paese industrializzato. La
diffusione di «public companies», inoltre, consentendo a un gran numero di persone di diventare azionisti di grandi società, contribuì a legare i Giapponesi alle imprese nelle quali investivano i loro capitali e delle quali erano spesso dipendenti.
5
Si hanno partecipazioni azionarie incrociate, quando una società (A) possiede azioni di un’altra società (B),
che a sua volta possiede azioni della prima (A). In tal modo, uomini della prima società (A) possono far parte del
Consiglio di amministrazione della seconda (B), e viceversa.
28
Ennio De Simone
L’economia giapponese, per i successi raggiunti, risentì meno delle crisi petrolifere degli
anni Settanta. La crescita del Pil rallentò, anche in modo consistente, ma in misura inferiore
a quella dell’Europa e degli Stati Uniti (vedi nuova tab. 5.1). Si procedette a una ristrutturazione
produttiva, attraverso l’introduzione di nuovi metodi (la «produzione snella», inventata proprio
dai Giapponesi) e l’utilizzazione diffusa dei robot, che sostituirono il lavoro umano, specialmente quando il loro funzionamento fu computerizzato, garantendo la competitività internazionale
di molte industrie. Negli anni Ottanta, il Giappone era diventata la seconda potenza economica
mondiale (per ammontare del Pil) e nel corso di quel decennio la crescita s’intensificò, facendo
registrare un incremento medio annuo del Pil pro capite di circa il 3,5 per cento.
Negli anni Novanta, invece, l’incremento del Pil pro capite fu di appena lo 0,7 per cento
all’anno. Il Giappone era stato colpito da una grave crisi, che presenta non poche analogie
con quella americana e mondiale del 2008-09. Le cause dell’inversione di tendenza sono da
ricercarsi proprio nella crescita precedente, durante la quale le esportazioni verso gli Stati
Uniti erano aumentate e il governo aveva adottato una politica di espansione del credito, mediante la riduzione dei tassi di interesse. Perciò, la disponibilità di moneta risultò elevata, anche per l’alto livello del risparmio interno, e i Giapponesi (imprese, istituzioni finanziarie e
famiglie) investirono le loro disponibilità in titoli azionari e in immobili. Nella seconda metà
degli anni Ottanta, il corso dei titoli azionari giunse a triplicarsi e i prezzi dei beni immobili
quasi raddoppiarono, mentre i consumi aumentavano, per l’elevata occupazione, e i prezzi
rimanevano stabili. L’economia sembrava solida e i Giapponesi si attendevano ancora un
lungo periodo di crescita, senza rendersi conto che stavano entrando in una bolla speculativa.
La bolla scoppiò all’inizio del 1990, quando alcuni investitori cominciarono a vendere le loro azioni, proprio mentre la Banca del Giappone, per ridurre la massa monetaria in circolazione, si era convinta a elevare il tasso ufficiale di sconto dal 3,75 al 6 per cento. In due anni
e mezzo l’indice della Borsa crollò del 63 per cento e i prezzi delle proprietà immobiliari,
acquistate con i prestiti facili delle banche, precipitarono. Le conseguenze furono quelle solite in tali casi: gli istituti finanziari e le banche non riuscirono a recuperare i loro crediti e
molti fallirono o dovettero essere salvati, il credito bancario si ridusse notevolmente, i consumi ristagnarono e parecchie industrie dovettero ridurre la produzione, la disoccupazione
aumentò e tutta l’economia entrò in crisi.
Per combattere la crisi, fu preparato un piano di grandi lavori pubblici, il costo del denaro
fu portato a livelli bassissimi (0,25 per cento) e si avviò un processo di deregolamentazione.
Gli investimenti cominciarono di nuovo a crescere, anche se limitatamene ad alcuni settori,
mentre il debito pubblico rimaneva a livelli elevatissimi. La fase di ristagno dell’economia
nipponica è durata a lungo e il paese ha introdotto forme sostanziali di protezione (ricorrendo
a barriere non tariffarie) per quelle industrie che, di volta in volta, sono state ritenute in espansione e perciò da potenziare, e ha fatto persino ricorso a procedure di dumping, pur di
conservare i mercati di sbocco ai propri prodotti. Solo nei primi anni del nuovo secolo
l’economia giapponese ha mostrato segni di ripresa, con un Pil pro capite che, fino alla crisi
del 2008-09, è cresciuto a un tasso medio annuo dell’1,8 per cento. Il Giappone, comunque,
con i suoi 130 milioni di abitanti e con un elevato Pil pro capite, continua a essere una delle
prime potenze economiche mondiali.
Appunti di Storia economica
29
2. DALL’ECONOMIA PIANIFICATA ALL’ECONOMIA DI MERCATO
2.1. L’Unione Sovietica e il blocco comunista
Fra i paesi che avevano partecipato alla seconda guerra mondiale, l’Unione Sovietica fu
quello che subì i danni maggiori, sia per le perdite di vite umane sia per le devastazioni materiali arrecate al suo territorio. Dopo la guerra fu ripresa la pianificazione e si varò il quarto
piano quinquennale, che puntava ancora, come i precedenti, sull’industria pesante e sugli
armamenti, con particolare riguardo a quelli nucleari. La Russia continuava a temere
l’accerchiamento, anche se ormai aveva messo fra sé e l’Europa occidentale un largo cuscinetto costituito dagli «Stati satelliti», come si dissero i paesi dell’Europa orientale passati
sotto il suo controllo. Anche dopo la morte di Stalin (1953), l’organizzazione dell’economia
pianificata non mutò. Si continuarono a predisporre piani che sacrificavano la produzione di
beni di consumo a vantaggio dei beni strumentali e degli armamenti, oltre che dell’esplorazione dello spazio, che fu l’unico campo in cui i Sovietici riuscirono a ottenere maggiori
successi degli Americani, almeno nei primi anni. Tuttavia, anche l’Unione Sovietica partecipò alla generale fase di sviluppo dell’economia mondiale e il suo Pil pro capite crebbe al tasso del 3,4 per cento annuo, vale a dire a una velocità maggiore di quelli di Gran Bretagna e
Stati Uniti. Esso, però, era, nel 1973, solo il 50 per cento di quello britannico e appena il 36
per cento di quello americano (vedi nuove tabb. 5.1 e 5.2).
I regimi comunisti dei paesi dell’Europa orientale adottarono il sistema politico ed economico dell’Unione Sovietica ed entrarono a far parte del Comecon (Consiglio per la mutua
assistenza economica), un’organizzazione con sede a Mosca, voluta dai Sovietici (1949) in
contrapposizione al Piano Marshall. I paesi aderenti al Comecon erano l’Albania (uscita nel
1961), la Bulgaria, la Cecoslovacchia, la Germania orientale, la Polonia, la Romania,
l’Ungheria e, dal 1972, anche Cuba, portata nell’orbita sovietica dal suo leader Fidel Castro.
Il Comecon si proponeva di coordinare lo sviluppo economico dei paesi membri, di realizzare tra di loro una più efficiente divisione del lavoro e di favorire gli scambi. Fu, invece, lo
strumento attraverso il quale i Sovietici imposero il loro dominio sui paesi satelliti. Il malcontento verso l’Unione Sovietica fu sempre molto forte e diede luogo a diverse rivolte, represse nel sangue, come quelle della Germania orientale (1953), dell’Ungheria (1956) e della
Cecoslovacchia (1968). La crescita dei paesi dell’Europa orientale fu comunque più consistente di quella dell’Unione Sovietica e quasi identica alla crescita dell’Europa occidentale.
Il Pil pro capite dei paesi socialisti europei 6 (compresa la Jugoslavia), difatti, aumentò, fra il
1950 e il 1973, al tasso annuo del 3,8 per cento, vicinissimo al tasso dei principali dodici paesi dell’Europa occidentale (3,9 per cento). I migliori risultati furono ottenuti dagli Stati che
partivano da condizioni più arretrate, come la Bulgaria (5,2 per cento), la Romania (4,8) e la
Jugoslavia (4,5), mentre la crescita più contenuta fu quella della Cecoslovacchia (3,1).
La crisi degli anni Settanta non coinvolse direttamene l’Unione Sovietica e gli Stati satelliti dell’Europa orientale, poco colpiti dagli shock petroliferi e dalla fine di un sistema monetario internazionale di cui non facevano parte. Tuttavia, dal 1973 al 1990, il Pil pro capite
aumentò al tasso dello 0,7 per cento in Unione Sovietica e dello 0,5 per cento nei paesi
6
I termini socialista e comunista (o socialismo e comunismo) vengono qui usati come sinonimi,
nell’accezione comune di sistema sociale basato sulla eliminazione totale o parziale della proprietà privata dei
mezzi di produzione e sul controllo collettivo della loro utilizzazione.
30
Ennio De Simone
dell’Europa orientale. I limiti della pianificazione centralizzata sovietica, processo molto
complesso e difficile da gestire in modo efficace, cominciavano a diventare più evidenti. Il
coordinamento fra l’attività delle diverse fabbriche, indispensabile per il buon funzionamento del sistema, non riusciva ad essere assicurato in modo adeguato. L’approvvigionamento di
materie prime e semilavorati di una fabbrica, difatti, dipendeva dal funzionamento di altre
fabbriche e dalla loro capacità di rispettare i tempi di consegna, per cui se un anello della catena non funzionava si arrestava l’intero sistema. I piani quinquennali (peraltro riaggiustati
ogni anno, sicché, di fatto, finivano con l’essere annuali), stabilivano la quantità fisica di beni che ogni fabbrica doveva produrre. Lo scopo dei manager era, perciò, di raggiungere gli
obiettivi prefissati, senza badare alla qualità dei prodotti, che perciò risultava molto scadente, anche perché non vi era concorrenza fra i diversi beni. Un altro inconveniente della pianificazione era costituito dal fatto che risultava molto difficile prevedere la quantità di beni da
produrre, sicché vi poteva essere un eccesso o, più frequentemente, una scarsità di beni, che
costringeva i cittadini a lunghe file (oppure a ricorrere al mercato nero) per procurarseli. Inoltre, i prezzi al consumo erano fissati senza tenere nella dovuta considerazione i costi di
produzione e, in particolare quelli dei generi di prima necessità (pane, burro, ecc.) e degli alloggi erano tenuti artificialmente bassi. La scarsità di beni e i loro bassi prezzi fecero aumentare la capacità di risparmio della popolazione, ma, in seguito, i loro risparmi furono polverizzati dall’inflazione, iniziata con la crisi del regime comunista ed esplosa con il suo crollo.
Infine, la pianificazione non induceva a perseguire innovazioni tecnologiche, nonostante si
spendessero somme cospicue per la ricerca, dal momento che non vi era uno stimolo alle invenzioni e alle innovazioni da parte dei manager delle imprese statali e la ricerca delle università non era strettamente collegata con l’attività produttiva.
Per completare il quadro dell’economia sovietica, bisogna ricordare che in quel paese,
come nelle altre economie pianificate, non vi era disoccupazione, perché un posto di lavoro
era garantito a tutti, essendo ritenuto lo svolgimento di un’attività lavorativa un obbligo dei
cittadini, ma la produttività del lavoro era bassissima e, quindi, il costo di produzione dei
beni risultava elevato. Per garantire l’occupazione, le fabbriche sovietiche avevano un numero di dipendenti eccessivo, sicuramente molto superiore a quello delle fabbriche dello stesso
tipo dei paesi capitalistici occidentali. Anche in agricoltura, che qualcuno ha definito il «tallone di Achille» dell’economia sovietica, la produttività era molto bassa, tanto più che il controllo del lavoro dei contadini risultava sicuramente più difficoltoso di quello degli operai. I
contadini che disponevano di piccoli appezzamenti privati (non più di mezzo ettaro) preferivano dedicare i loro sforzi e le loro cure a questi fazzoletti di terra, i quali, pur costituendo
appena il 3 per cento della terra coltivata, erano in grado di fornire il 20 per cento della produzione agricola complessiva. Più volte Nikita Chruščëv, capo dell’Unione Sovietica (195364), dichiarò di voler raggiungere gli Stati Uniti nella produzione di latte, burro e carne, senza però riuscirvi. Durante gli anni Settanta, grazie agli investimenti destinati all’agricoltura,
la produzione di derrate alimentari aumentò notevolmente, ma non riuscì a rendere autosufficiente l’Unione Sovietica, che dovette continuare a importarne una parte. L’agricoltura, inoltre, sacrificata alle necessità della pianificazione industriale, continuava ad avere un numero
eccessivo di addetti (da paese non industrializzato), inconcepibile per quella che comunque
era la seconda potenza militare, politica ed economica (per valore del Pil) del mondo.
Le disfunzioni del sistema erano note ai dirigenti sovietici, che tentarono più volte di riformarlo, fin dagli anni Cinquanta e Sessanta, senza risultati apprezzabili. Solo Michail Gorbačëv (1985-91) pose mano a riforme più incisive, che compendiò nei termini «glasnost» e
Appunti di Storia economica
31
«perestrojka». La glasnost (trasparenza) doveva realizzare forme più democratiche di gestione del potere politico, partendo dalle libertà di espressione e di informazione. La perestrojka
(ristrutturazione) riguardava la trasformazione del precedente sistema politico ed economico,
ritenuto troppo autoritario e burocratico. Lo scopo di Gorbačëv era, comunque, di conservare
il sistema socialista, mediante una sua radicale trasformazione. Furono approvate diverse riforme, sia nel campo economico, per esempio introducendo (1988) una certa libertà d’iniziativa delle imprese, sia in quello politico, con la graduale riduzione delle prerogative del Partito comunista a vantaggio delle cariche statali. Secondo alcuni, l’errore di Gorbačëv sarebbe
stato quello di puntare più sulle riforme politiche che su quelle economiche, al contrario di
ciò che stavano facendo i dirigenti cinesi. Le conseguenze furono il crollo del dominio del
Partito comunista, il cui apparato burocratico comunque assicurava la gestione dell’economia
e della pianificazione, e la disintegrazione dell’Unione Sovietica. Le riforme di Gorbačëv furono indubbiamente attuate in modo disordinato, ma non bisogna dimenticare che egli si dovette costantemente difendere dagli attacchi di due opposte correnti del partito: i conservatori, che non volevano le riforme, e i riformisti, che le consideravano troppo timide.
Intanto, il deficit del bilancio statale dell’Unione Sovietica era straordinariamente cresciuto, per via delle enormi spese che lo appesantivano. Oltre ai normali elevati costi per
conservare imprese inefficienti e tenere basso il livello dei prezzi al consumo, bisognò affrontare alcuni eventi eccezionali (l’incidente della centrale nucleare di Chernobyl in Ucraina, nel 1986, e il terremoto in Armenia, nel 1988) e soprattutto mantenere un costoso apparato difensivo, che era giunto ad assorbire (assieme alle spese per le imprese spaziali) il 15 per
cento del Pil, percentuale tripla di quella impiegata allo stesso scopo dagli Stati Uniti. La liberalizzazione di alcuni prezzi, conseguenti alle riforme introdotte, assieme alle necessità finanziarie dello Stato, che dovette ricorrere all’emissione di cartamoneta, provocarono due
fenomeni nuovi nella società sovietica: l’inflazione e la disoccupazione, che fecero crescere
il malcontento della popolazione.
2.2. Il crollo dei regimi comunisti e la crisi della transizione
Nei paesi dell’Europa orientale, i regimi comunisti non erano mai stati completamente
accettati, come dimostrano le ricordate rivolte degli anni Cinquanta e Sessanta. Anche la statizzazione dell’economia era stata meno spinta che in Unione Sovietica. In Polonia, per esempio, dopo un breve esperimento di collettivizzazione dell’agricoltura, i contadini avevano
potuto tornare a coltivare privatamente i loro piccoli poderi. In Ungheria, in Polonia e nella
Germani orientale era consentita la gestione privata di alcuni tipi di botteghe e di altre piccole attività commerciali. Negli anni Sessanta, inoltre, la Polonia e l’Ungheria avevano attuato
alcune riforme, compresa una maggiore apertura al commercio internazionale, che le portarono a indebitarsi all’estero e a trovarsi poi in difficoltà per rimborsare i prestiti ottenuti.
L’incapacità dell’economia pianificata di migliorare le condizioni di vita delle masse fece
crescere il loro scontento, tanto più che ormai era possibile osservare alla televisione
l’abbondanza dei vicini paesi occidentali. Le riforme avviate da Gorbačëv in Unione Sovietica diedero maggiore forza ai gruppi che si opponevano ai regimi comunisti. Le condizioni
per la loro caduta stavano maturando. Il 1989 fu l’anno della svolta. Dapprima in Polonia,
dove era stata fatta l’esperienza del sindacato autonomo Solidarność, e poi in Ungheria, si
realizzò una transizione pacifica verso governi non comunisti. Successivamente, anche in
32
Ennio De Simone
Cecoslovacchia, dopo proteste e dimostrazioni di massa, si giunse a un accordo per la formazione di un nuovo governo e fu attuata una pacifica divisione del paese fra Repubblica ceca e
Repubblica slovacca (1993).
Ma l’evento, che ha ormai assunto una funzione simbolica, come la presa della Bastiglia
durante la Rivoluzione francese, fu il crollo del muro di Berlino, nella notte fra il 9 il 10 novembre 1989. Una moltitudine di Tedeschi di Berlino Est e Ovest, sotto gli occhi stupiti di
tutto il mondo, che seguiva l’avvenimento attraverso la televisione, cominciò ad abbattere il
muro costruito nel 1961, senza che le autorità tedesco-orientali osassero intervenire, e i Tedeschi di Berlino Est si riversarono nella parte occidentale della città. L’anno successivo fu
decisa la riunificazione della Germania. In rapida successione caddero tutti gli altri regimi
comunisti, in modo pacifico in Bulgaria o in seguito a violente agitazioni di piazza in Romania, dove il dittatore Nicolae Ceauşescu e sua moglie furono giustiziati. La Jugoslavia tentò
di tenere assieme le repubbliche che la componevano, ma la secessione della Slovenia e della
Croazia (1991) portò alla sua dissoluzione e a una serie di atroci guerre intestine, con la persecuzione delle minoranze etniche. Il Comecon, che non era mai stato molto efficace, fu
sciolto ufficialmente nel 1991.
L’Unione Sovietica non intervenne per reprimere le manifestazioni che avevano portato al
crollo dei regimi comunisti. Essa, come si è visto, stava attraversando un periodo difficile. Il
tentativo di riforme di Gorbačëv non riuscì e, dopo un fallito colpo di Stato dei sostenitori
del regime, le tre repubbliche slave (Russia, Ucraina e Bielorussia), nel dicembre del 1991,
dichiaravano lo scioglimento dell’Unione Sovietica. Anche il Partito comunista fu sciolto e i
suoi beni confiscati. Dall’ex Urss nacquero quindici repubbliche indipendenti, la più grande
e importante delle quali è la Federazione Russa.
La transizione al capitalismo fu lunga e difficile. Il passaggio da un’economia pianificata,
in cui lo Stato era l’unico proprietario dei mezzi di produzione, a un’economia di mercato
costituiva un’esperienza nuova e piena di incognite. I risultati furono disastrosi. Fra il 1990 e
il 1998, il Pil pro capite diminuì in media di quasi il 7 per cento all’anno nella disciolta Unione Sovietica, mentre nell’Europa orientale si ridusse in misura minore.
Nella Federazione Russa furono liberalizzati il commercio interno e quello estero e fu avviato un processo di privatizzazione delle imprese statali, vendute a poco prezzo a imprenditori
improvvisati, spesso provenienti dalle file del precedente gruppo dirigente comunista. Vi furono, per conseguenza, grandi cambiamenti nella distribuzione del reddito. I beni che precedentemente venivano forniti gratuitamente o a prezzi molto bassi divennero più cari, mentre il potere d’acquisto dei salari fu falcidiato dall’inflazione. La sperequazione fra i nuovi ricchi, che
seppero profittare in tutti i modi (anche illegali) della situazione, e la massa della popolazione
si fece grave e preoccupante. La povertà aumentò in modo impressionante in tutte le ex repubbliche sovietiche: le persone considerate indigenti, per esempio, passarono in pochi anni dal 2
al 50 per cento nella Federazione Russa e dal 2 al 63 per cento in Ucraina. L’inflazione esplose
violenta, tanto da diventare iperinflazione, sia per la liberalizzazione dei prezzi, sia soprattutto
per le necessità finanziarie dello Stato, che fece continuo ricorso all’emissione di biglietti. In
regime di economia pianificata, difatti, lo Stato traeva le sue entrate dalle imprese che gli appartenevano. Vendute queste per pochi soldi, dovette elaborare e attuare un nuovo sistema tributario, che fu di difficile applicazione, con un’evasione fiscale molto elevata. L’agricoltura fu
ancora una volta sacrificata, nel senso che si fece poco per creare dinamismo in un settore arretrato, in cui i figli dei contadini collettivizzati non erano ancora pronti a lavorare in regime di
mercato. E infatti, molti di loro preferirono restare nelle aziende di Stato o nelle cooperative
Appunti di Storia economica
33
(ne rimasero in attività diverse migliaia), nonostante la riforma che consentiva la compravendita dei terreni. In Russia e in Ucraina la produzione agricola risultò, a fine secolo, inferiore del
40 per cento a quella del 1990. A partire dall’ultimo decennio del Novecento, si registrò anche
un calo demografico (– 5 per cento fra il 1995 e il 2008), pare a causa della diffusione
dell’alcolismo (antica piaga russa), della droga e di malattie sessualmente trasmissibili, nonché
dell’emigrazione, sintomo di un evidente disagio economico e sociale. Anche altre repubbliche
dell’ex Unione Sovietica hanno subito una diminuzione della popolazione, addirittura più marcata di quella russa, come la Bielorussia (– 6 per cento), le repubbliche baltiche (– 10 per cento), l’Ucraina (– 11 per cento) e la Georgia (– 15 per cento).
La crisi della transizione fu superata verso la fine degli anni Novanta ed è stata seguita da
una forte ripresa economica. Il Pil pro capite della Federazione russa, dopo essere crollato
del 42 per cento fra il 1990 e il 1998, è successivamente cresciuto a ritmi elevati (+ 7,4 per
cento), riportandosi, nel 2006, al livello del 1990. Tale risultato è dovuto, innanzitutto, alle
consistenti esportazioni di petrolio e gas naturale, oltre che di metalli e legname, i cui prezzi
sul mercato mondiale erano in crescita. Le grandi industrie russe, ancora arretrate e altamente inquinanti, sono in mano a pochi gruppi privati, ma lo Stato ha conservato grosse aziende,
specialmente nel settore energetico (Gazprom) e, di recente, sta acquistando o espropriando
alcune imprese cedute con le affrettate privatizzazioni degli anni Novanta. Lo sviluppo degli
ultimi tempi ha interessato principalmente la regione di Mosca (e qualche altra grande città),
dove i livelli di reddito si avvicinano a quelli europei, mentre gran parte del paese è rimasta
indietro, soprattutto nelle zone rurali e nei territori asiatici. Il governo sta anche portando avanti piani di rientro del debito estero e del debito pubblico. Il Pil pro capite della Russia,
tuttavia, è ancora pari al 29 per cento di quello americano, che è una percentuale addirittura
più bassa di quella del 1970. Anche l’Ucraina, dopo aver assistito alla perdita completa del
valore della propria moneta e a un crollo verticale dei redditi della popolazione, ha attuato
drastiche riforme economiche e sta vivendo, negli ultimi anni, una fase di crescita (senza però essere ritornata ancora ai valori del 1990), dovuta allo sviluppo di alcune industrie, alla
riforma agraria e al forte incremento delle esportazioni.
Nell’Europa orientale il processo di transizione è risultato meno traumatico, perché il
collettivismo era durato per un periodo più breve, era stato realizzato in modo meno incisivo
e la fase di passaggio all’economia di mercato fu meglio gestita. Vennero assicurate maggiori garanzie giuridiche a chi, cittadino o straniero, avesse voluto investire i propri capitali e il
processo di privatizzazione non portò alla nascita di una nuova oligarchia di capitalisti profittatori. Fu comunque necessario rinnovare gli obsoleti impianti industriali, riqualificare i lavoratori, trasformare il sistema tributario e quello della sicurezza sociale e ricostruire dal nulla il sistema bancario. I paesi dell’Europa orientale sono entrati, nel 2004 e nel 2007,
nell’Unione Europea, tranne quelli sorti dalla dissoluzione della Jugoslavia (con l’eccezione
della Slovenia, che invece è entrata nell’Unione). Le guerre che hanno coinvolto gli altri Stati dell’ex Jugoslavia hanno provocato gravi danni e il peggioramento dell’economia (specialmente in Bosnia e in Serbia), nonché l’intervento di forze armate di pace europee. Dopo
essere diminuito, fra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta, il Pil pro capite degli
ex paesi comunisti europei ha ripreso a salire prima della fine del secolo. La crescita degli
ultimi anni è stata persino superiore a quella dei paesi più industrializzati dell’Europa occidentale, e ha prodotto un aumento dei consumi e la riduzione della disoccupazione.
34
Ennio De Simone
2.3. Il caso cinese
Diverso è il caso della Cina, dove nel 1949 fu instaurato il regime comunista e costituita
la Repubblica Popolare Cinese. La Cina aveva vissuto un lungo periodo di decadenza, fra i
secoli XVI e XIX, durante il quale si era chiusa ai rapporti internazionali. Fu costretta ad aprirsi ai traffici con l’Occidente verso la metà dell’Ottocento e dovette stipulare dei trattati
che la obbligarono a tenere bassi i dazi doganali e ad ospitare sul suo territorio alcune delegazioni occidentali. L’economia cinese, anche per ragioni interne, collassò e il Pil pro capite
del 1950 (in valori costanti) risultò addirittura inferiore a quello del 1820, proprio mentre
l’economia dei paesi industrializzati stava crescendo. Dopo il crollo dell’ultima dinastia imperiale (1911), fu instaurata la repubblica e iniziò un periodo di torbidi interni, sfociato in un
conflitto armato fra il Partito nazionalista e il Partito comunista. Durante la seconda guerra
mondiale, le due fazioni sospesero le ostilità per combattere gli invasori giapponesi, ma a
guerra finita ripresero la lotta, che fu molto dura e terminò con la sconfitta dei nazionalisti, rifugiatisi nell’isola di Taiwan (Formosa), e con il trionfo del Partito comunista di Mao Zedong.
La storia economica della Cina comunista si può dividere in due periodi nettamente distinti: quello della realizzazione dell’economia pianificata (1949-1978) e quello delle riforme
successive, che hanno portato all’«economia socialista di mercato», come una modifica della
costituzione cinese (1993) ha definito il nuovo sistema economico.
L’attuazione del comunismo passò attraverso diverse fasi, che in qualche modo ripeterono
l’esperienza sovietica, anche se si tentò di evitare gli errori del potente vicino, al quale i Cinesi rimasero legati fino al 1960, ma dal quale si distaccarono successivamente. Dopo aver
domato l’iperinflazione che, anche in questo caso, aveva accompagnato la rivoluzione, e dopo aver stabilizzato la moneta, il nuovo governo dovette affrontare la trasformazione socialista dell’economia. L’industria era già stata largamente statalizzata dal precedente governo
nazionalista, che aveva confiscato la maggior parte delle aziende gestite dai Giapponesi durante la loro occupazione. Nei primi anni Cinquanta furono nazionalizzate, senza indennizzo,
le grandi imprese e le banche, mentre le piccole imprese a conduzione familiare furono spinte a trasformarsi in cooperative. Il commercio all’ingrosso passò nelle mani dello Stato e
quello al minuto fu trasferito a imprese miste, con la partecipazione pubblica. Anche in Cina,
sull’esempio dell’esperienza sovietica, furono adottati piani quinquennali, che puntarono
sull’industria pesante, a scapito della produzione dei beni di consumo.
L’agricoltura costituiva il settore più importante dell’economia. In questo campo fu attuata la più grande riforma agraria che la storia ricordi, mediante la confisca (1950-52) di 80
milioni di ettari di terra e la loro distribuzione ai contadini. Le terre furono assegnate ai singoli individui e non alle famiglie, in modo da favorire l’emancipazione delle donne e dei
giovani dal dominio patriarcale, al quale erano sottoposti da secoli. I proprietari terrieri
scomparvero e il numero di contadini poveri si ridusse notevolmente a vantaggio di quelli
medi. La proprietà individuale fu conservata, anche perché i nuovi dirigenti non volevano
alienarsi l’appoggio dei ceti agricoli, che erano la stragrande maggioranza della popolazione
e costituivano la base di sostegno del Partito comunista e del regime. Gli appezzamenti assegnati, però, risultarono troppo piccoli, per cui il governo promosse la costituzione di cooperative agricole, alle quali i contadini dovevano conferire i loro poderi e in cui la terra, gli
strumenti di lavoro e il bestiame erano di proprietà comune. In media, una cooperativa era
composta di 160 famiglie e aveva un’estensione di 150 ettari. I contadini potevano ottenere
piccoli pezzi di terra, che coltivavano personalmente per i bisogni familiari. Le loro condi-
Appunti di Storia economica
35
zioni, però, non migliorarono molto rispetto alle altre categorie e il salario agricolo rimase
molto più basso di quello industriale.
I risultati del primo decennio del nuovo regime, nonostante fossero complessivamente
positivi, non vennero ritenuti soddisfacenti dai dirigenti del Partito comunista. Fu perciò
lanciato il grande balzo in avanti (1958-60), un piano economico e sociale che richiese una
generale mobilitazione della popolazione per riformare rapidamente il paese e trasformarlo
in una moderna società industriale, con l’intento dichiarato di raggiungere i paesi sviluppati, soprattutto la Gran Bretagna. Nel campo industriale vennero attuate misure di decentramento, si potenziò la media e piccola industria locale e i lavoratori delle fabbriche furono coinvolti nella gestione. Nelle campagne si formarono le comuni agricole, a loro volta
organizzate in brigate (le ex cooperative) e squadre (unità operative), ognuna con proprie
competenze. Dopo qualche difficoltà iniziale, le comuni, diventate anche le nuove unità
amministrative dello Stato, furono riorganizzate e fu loro consentito di possedere e gestire
piccole fabbriche, laboratori, trattori, camion e magazzini. Nonostante i sacrifici imposti
alla popolazione e gli errori commessi (il paese soffrì di una gravissima carestia, che provocò 14 milioni di morti, secondo le prudenti stime ufficiali), il grande balzo in avanti trasformò il volto della Cina rurale, con la realizzazione di grandi progetti locali, grazie al lavoro collettivo. Furono dissodate nuove terre, costruiti sistemi di irrigazione per milioni di
ettari, assicurati servizi comunali (scuole, ospedali, ecc.) e fu insegnato un nuovo mestiere
a milioni di persone.
La crescita economica subì un rallentamento all’epoca della cosiddetta rivoluzione culturale (1966-69), voluta da Mao, già sostanzialmente estromesso dal potere effettivo, come rimedio straordinario al pericolo, da lui intravisto, di involuzione autoritaria e burocratica della rivoluzione comunista. Si trattò di una lotta interna al Partito, che si basò principalmente
sulla mobilitazione dei giovani (universitari e non) riuniti in gruppi, denominati «guardie
rosse», che imperversarono in tutto il paese per imporre il pensiero di Mao, sventolando il
«libretto rosso» contenente le massime del loro leader, nel tentativo di modificare le strutture
della società e finanche il modo di pensare dei Cinesi.
I risultati conseguiti nei primi decenni di comunismo, pur tra molte difficoltà, erano comunque evidenti. Il Pil pro capite cinese raddoppiò fra il 1950 e la metà degli anni Settanta,
anche se nel 1973 era ancora pari al 7 per cento di quello britannico, all’incirca quanto era
nel 1950. Ma il solo fatto che l’economia cinese fosse riuscita a tenere il passo con quelle
occidentali, senza arretrare, fu un successo, in un paese che doveva mantenere la popolazione più numerosa del mondo. Nel 1950 i Cinesi erano intorno a 550 milioni, ma trent’anni più
tardi erano diventati quasi un miliardo, con un incremento dell’80 per cento.
Dopo la morte di Mao (1976), il suo successore Deng Xiaoping avviò gradualmente un
processo di liberalizzazione dell’economia. Il precedente sistema politico con un partito unico, il Partito comunista cinese, fu conservato e si avviò l’economia di mercato sotto il controllo dello Stato. A partire dal 1978 furono attuate riforme in tutti i settori, tendenti ad accelerare lo sviluppo e a modernizzare l’economia, mediante l’introduzione di elementi di capitalismo nel sistema. Ancora oggi i dirigenti cinesi sostengono che il controllo politico accentrato dell’economia, anche di mercato, rappresenti il modo più efficiente per creare sviluppo
e sono convinti che il processo di modernizzazione richieda, specialmente nelle fasi iniziali,
una struttura politica forte e centralizzata, per impedire che le tensioni sociali ne ostacolino
lo svolgimento, e perciò hanno reagito con durezza alle manifestazioni volte a chiedere una
maggiore democrazia.
36
Ennio De Simone
Le riforme riguardarono tutta l’economia, dall’agricoltura all’industria, dal commercio
interno e internazionale al sistema finanziario. Furono introdotti degli incentivi salariali,
visti come un efficace strumento per stimolare il maggiore impegno dei lavoratori, mentre
il concetto di egualitarismo, precedentemente perseguito, venne considerato un ostacolo
alla crescita economica. Il sistema delle comuni agricole fu abbandonato e si tornò a una
produzione fondata su aziende familiari, sostenute dallo Stato, che produsse un incremento
del reddito degli agricoltori. La popolazione attiva in agricoltura è crollata da oltre il 70
per cento, livello al quale si trovava ancora nel 1995, sotto il 50 per cento attuale, valore
ancora eccessivamente elevato se confrontato con quello dei paesi sviluppati. Sono state
favorite le imprese private, comprese quelle con la partecipazione di capitali stranieri, ma è
rimasto un forte settore di imprese di proprietà pubblica, che comprende grandi gruppi capaci di competere sui mercati internazionali. La moneta, lo yuan, è stata tenuta a bassi livelli rispetto al dollaro per dare competitività alle merci cinesi e sono state fornite tutte le
garanzie necessarie agli stranieri per attirare i loro investimenti. La partecipazione della
Cina comunista al commercio internazionale è aumentata in misura considerevole, alla ricerca di mercati dove esportare i propri prodotti e da dove importare tecnologia e beni di
consumo di qualità superiore. Quel popoloso paese è diventato, così, uno dei principali attori del commercio mondiale, specialmente dopo il suo ingresso nella Wto (2001). Il valore
in dollari delle sue esportazioni è aumentato di otto volte fra il 1980 e il 1996 e di altre sei
volte entro il 2007. La Cina ha conosciuto uno dei tassi di crescita del Pil più elevati al
mondo, in genere superiore al 10 per cento all’anno, mentre il Pil pro capite è giunto a triplicarsi fra il 1980 e il 1999 e a raddoppiarsi ancora entro il 2007, restando tuttavia a livelli
molto bassi: circa il 20 per cento di quello americano (ma nel 1990 era solo l’8 per cento).
Per la Cina è fondamentale mantenere un alto tasso di crescita, dal momento che ogni anno
entrano a fare parte della forza di lavoro ben 12 milioni di persone. Per Pil complessivo
prodotto, essa è diventata, dall’inizio degli anni Novanta, seconda solo agli Stati Uniti. Il
suo evidente successo è in netto contrasto con il collasso economico dell’ex Unione Sovietica nell’ultimo decennio del Novecento.
Le trasformazioni economiche attuate hanno comportato anche una maggiore mobilità
sociale e geografica. Milioni e milioni di persone hanno avuto la possibilità di migliorare
la loro condizione economica e sociale e si sono spostati dalle zone rurali dell’interno verso le città delle aree costiere, dove si addensa gran parte della popolazione cinese. Moltissimi Cinesi (circa 18 milioni), inoltre, hanno preso la via dell’emigrazione. Una serie di
campagne di pianificazione familiare, intraprese fin dal 1970, assieme a disposizioni che
avvantaggiano le famiglie con un solo figlio, hanno fatto diminuire il tasso di natalità ma,
nonostante ciò, la popolazione è cresciuta a ritmi elevatissimi, portandosi, ai nostri giorni,
a oltre 1,3 miliardi, pari al 20 per cento di quella mondiale. Si è ormai venuta affermando
un’economia mista, con un peso sempre maggiore del settore privato, denominata, come si
è detto, «economia socialista di mercato». La riforma costituzionale del 1993 ha anche
previsto il superamento della pianificazione socialista e ha dichiarato «inviolabile» il diritto alla proprietà privata.
Appunti di Storia economica
37
3. I PAESI IN VIA DI SVILUPPO
3.1. Decolonizzazione e strategie di sviluppo
Quasi tutti gli attuali paesi in via di sviluppo hanno avuto un passato coloniale, remoto o
recente, e hanno dovuto affrontare un difficile periodo di instabilità politica ed economica
dopo l’indipendenza. Così avvenne per le colonie spagnole e portoghesi dell’America Latina
agli inizi del secolo XIX e così è avvenuto per le colonie dell’Africa e dell’Asia intorno alla
metà del secolo XX. Dopo la seconda guerra mondiale, il processo di decolonizzazione ricevette un forte impulso, dal momento che numerose truppe coloniali avevano preso parte al
conflitto ed erano state inviate a combattere per gli ideali degli Alleati, come la libertà, la
democrazia e l’autodeterminazione dei popoli. Questi principi furono inclusi nella Carta Atlantica, firmata dal presidente degli Stati Uniti Roosevelt e dal primo ministro inglese Churchill (1941), e nella Carta delle Nazioni Unite (1945). Gli indipendentisti si rifecero proprio
a queste dichiarazioni solenni per organizzare i movimenti politici che rivendicavano
l’indipendenza dei loro popoli. Dopo una resistenza più o meno convinta, le potenze occidentali dovettero abbandonare le colonie, a volte anche in seguito a violente guerre di liberazione, come in Algeria e in Indocina. Gli stessi ambienti economici dei paesi colonialisti
cominciarono a rendersi conto che il mantenimento delle colonie era diventato molto costoso
per i governi, mentre i profitti delle imprese che vi investivano i loro capitali erano in forte
calo, sicché non risultava più conveniente conservare vasti imperi coloniali. Il primo paese a
ottenere l’indipendenza fu l’India. Seguirono alcuni paesi asiatici, come la Birmania, la
Cambogia, l’Indonesia, il Laos e il Vietnam, e quelli dell’Africa settentrionale (Libia, Tunisia, Marocco e Algeria). Intorno al 1960, infine, fu la volta dell’Africa nera. A metà degli
anni Sessanta, quasi tutte le nazioni europee avevano concesso l’indipendenza alle loro colonie. Solo il Portogallo lasciò l’Angola e il Mozambico nel 1975, in seguito a una lunga lotta
armata.
I nuovi Stati indipendenti conservarono, in genere, legami economici e culturali con le ex
potenze coloniali. Quelli sotto dominio britannico, per esempio, scelsero quasi tutti di rimanere nel Commonwealth, che, di fatto, finì con il sostituire il vecchio impero. In tal modo,
poterono mantenere i rapporti economici con la Gran Bretagna e usufruire dei ridotti dazi fra
i paesi che facevano parte dell’associazione. La rilevanza economica del Commonwealth
cominciò a declinare dopo il 1973, quando il Regno Unito entrò nella Comunità Economica
Europea e dovette rinunziare ai rapporti privilegiati con le ex colonie, molte delle quali ottennero condizioni di favore per il commercio con l’Europa comunitaria. Il Commonwealth
continuò a sopravvivere come una libera associazione di Stati.
I paesi in via di sviluppo (Pvs) rappresentano realtà anche profondamente diverse fra di
loro. Ma il loro cammino verso lo sviluppo presenta alcune caratteristiche comuni che è opportuno richiamare, prima di trattare separatamente le vicende delle grandi regioni in cui essi
possono essere raggruppati. Quasi tutti i Pvs individuarono, dopo la fine della seconda guerra
mondiale o dal momento in cui ottennero l’indipendenza, strategie di sviluppo molto simili.
L’intervento diretto dello Stato nell’economia fu previsto quasi ovunque, perché ritenuto necessario per recuperare il forte ritardo nei confronti dei paesi sviluppati. I Pvs guardavano
all’esempio della pianificazione di tipo sovietico, che sembrava aver dato buoni risultati, visto che l’Unione Sovietica era riuscita a sconfiggere la Germania nazista, oppure alle varie
forme di economia mista introdotte nell’Europa occidentale. L’intervento statale, quando
38
Ennio De Simone
non portò a una completa pianificazione, come nel caso cinese o di altri paesi asiatici, si manifestò in diversi modi: furono nazionalizzati importanti settori produttivi (servizi di pubblica
utilità, banche, industrie e distribuzione all’ingrosso dei prodotti agricoli), vennero conservate o introdotte misure protezionistiche a beneficio di alcuni comparti industriali, furono imposti bassi prezzi per i beni di consumo essenziali e si fissarono livelli minimi dei salari.
Un secondo elemento comune fu l’adozione di politiche di sviluppo basate sulla sostituzione delle importazioni (import substitution). Si favorì, cioè, la creazione di industrie che
consentissero di produrre nel proprio paese i beni che si dovevano importare (manufatti e
macchinari), via seguita, in particolare, dai principali Stati dell’America Latina (Argentina,
Brasile e Messico). Alcuni paesi dell’Asia sud-orientale (Hong Kong, Singapore, Corea del
Sud e Taiwan), invece, fecero una scelta diversa e puntarono su una politica di promozione
delle esportazioni (export promotion), sviluppando industrie tecnologicamente avanzate, capaci di competere sui mercati internazionali. Questi paesi emergenti, ai quali se ne aggiunsero in seguito altri (Malaysia, Indonesia, Thailandia, Brasile, Messico, nonché Cina e India),
sono diventati noti, di recente, con il nome di paesi di nuova industrializzazione (Newly industrializing countries o Nic).
Un terzo elemento fu il ricorso ai prestiti esteri, ottenuti sia sotto forma di aiuti (prestiti
dei governi stranieri a condizione di favore, espressamente rivolti ad agevolare lo sviluppo)
sia sotto forma di prestiti commerciali da parte delle banche. Questi trasferimenti di capitali,
però, non sempre servirono per gli scopi ai quali erano destinati, ma talvolta furono utilizzati
per sostenere i consumi e la loro gestione alimentò la corruzione degli amministratori pubblici.
Infine, i Pvs si poterono giovare della diffusione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, anche grazie agli organismi internazionali, nei campi della medicina e dell’agricoltura.
Le conseguenze furono la riduzione della mortalità e un forte incremento demografico, nonché l’aumento delle rese per ettaro delle terre coltivate. Per l’agricoltura si parlò, negli anni
Settanta, di «rivoluzione verde», per indicare la diffusione di varietà di riso, grano e altri cereali più resistenti alle avversità climatiche o capaci di una crescita più rapida, che, però, non
interessò alcuni paesi, come quelli dell’Africa subsahariana.
Le strategie di sviluppo seguite, anche se non riuscirono a ridurre le disuguaglianze sociali e
la povertà, funzionarono abbastanza bene fino alla crisi degli anni Settanta. Da allora, come
stava avvenendo quasi ovunque, il ruolo dello Stato fu in genere ridimensionato e si procedette
alla liberalizzazione dell’economia e alla privatizzazione di diverse imprese. La presenza dello
Stato in economia, però, anche se ridotta, continuò ad avere un peso rilevante. L’effetto più
grave della crisi fu l’aumento del prezzo del petrolio, che costituì, per i paesi sottosviluppati
che non ne possedevano, un forte aggravio del costo delle importazioni. Inoltre, la riduzione
della domanda di beni da parte dei paesi avanzati, molti dei quali ricorsero a forme di protezione per le loro industrie in crisi, colpì le esportazioni dei Pvs. La conseguenza fu che molti di
questi paesi esportavano meno e pagavano molto di più il petrolio importato. I loro governi,
perciò, dovettero ricorrere ai prestiti esteri, tanto più che l’abbondanza di petrodollari sul mercato internazionale consentiva di ottenerli facilmente. Si venne a formare un enorme debito estero dei paesi in via di sviluppo, passato dai 70 miliardi di dollari del 1970 agli 850 del 1982 e
ai quasi 1.500 del 1990. I prestiti furono contrattati in dollari e a tassi variabili, vale a dire a un
tasso che, periodicamente, sarebbe aumentato se i tassi di interessi (quelli del mercato di Londra, assunti come riferimento) fossero aumentati e sarebbe diminuito se i tassi di interesse fossero diminuiti. Siccome i tassi di interesse aumentarono (per via dell’inflazione che colpì i paesi avanzati), e il dollaro si apprezzò sulle altre monete, cioè divenne più caro, il peso del debito
Appunti di Storia economica
39
estero dei Pvs (per capitali da rimborsare e interessi da corrispondere) si fece insopportabile.
Fra quelli fortemente indebitati vi erano grandi paesi come l’Argentina, il Brasile, il Messico,
la Nigeria, la Costa d’Avorio e le Filippine. Nel 1982, il problema del debito estero esplose e il
Messico fu costretto a chiedere una moratoria. I prestiti furono rinegoziati a condizioni più favorevoli e il Fondo monetario internazionale (il principale finanziatore) impose politiche di
stabilizzazione ai paesi debitori, che in sostanza consistevano nel costringerli a prendere misure
per favorire le esportazioni, in modo da procurarsi i dollari necessari al pagamento dei debiti,
sottraendo quindi risorse ai consumi e agli investimenti. La crisi fu superata, anche perché i
tassi di interesse cominciarono a diminuire a mano a mano che l’inflazione dei paesi avanzati
veniva domata. I prestiti ottenuti, ancora una volta, non furono utilizzati per progetti di investimento a favore dello sviluppo economico, ma per pagare le importazioni, sostenere i consumi, compresi quelli di lusso delle élites, e finanziare progetti poco utili.
La globalizzazione coinvolse anche i Pvs, molti dei quali ne trassero beneficio. Negli anni
Novanta aumentò la loro partecipazione al commercio mondiale di beni e servizi e molti di
essi accolsero le imprese dei paesi avanzati che stavano dislocando all’estero parte della loro
attività. L’allargamento dei mercati finanziari internazionali, favoriti dalla liberalizzazione,
attirò un nuovo flusso di investimenti esteri (nel 1999 il debito estero era di oltre 2.500 miliardi di dollari). Infine, le rimesse degli emigrati sono diventate sempre più consistenti e
hanno costituito un’importante fonte di entrata per i paesi più poveri, che alimentano un ingente flusso migratorio.
3.2. L’India fra sviluppo e arretratezza
Il subcontinente indiano conquistò l’indipendenza nel 1947, al termine di un lungo movimento politico, in prevalenza non violento, largamente dominato dal Partito del Congresso,
sotto la guida del mahātmā Gandhi e del pandit Nehru. Nel momento in cui ottenne
l’indipendenza, fu diviso in due Stati: l’India e il Pakistan. L’India, a maggioranza induista,
costituì uno Stato laico, sotto forma di repubblica federale, composto di ventotto Stati, con
propri governi e assemblee legislative. Il Pakistan, a maggioranza musulmana, risultò composto delle province nord-occidentali (l’attuale Pakistan) e del Bengala orientale (separatosi
nel 1971, con il nome di Bangladesh). I rapporti fra i due paesi si rivelarono subito difficili
per via del controllo sul Kashmir, una regione di confine, che da allora ha dato luogo a diversi scontri fra i due contendenti, senza che il problema sia stato risolto. La dominazione coloniale aveva comunque lasciato all’India alcune risorse che si rivelarono utili allo sviluppo
successivo, come la conoscenza diffusa della lingua inglese, una moderna burocrazia statale
e una buona dotazione di infrastrutture, in particolare un imponente sistema ferroviario.
L’India, rimasta nel Commonwealth per i forti legami economici con l’Inghilterra e con
l’area della sterlina, adottò una strategia di industrializzazione fondata su tre elementi fra loro strettamente collegati: la sostituzione delle importazioni, il protezionismo e l’intervento
statale nell’economia. La scelta della sostituzione delle importazioni comportò l’abbandono
del sistema coloniale, che aveva assegnato alle colonie (e voleva continuare ad assegnare ai
paesi sottosviluppati) la funzione di esportare materie prime e importare manufatti. Il protezionismo, già in vigore durante la guerra, fu conservato e le importazioni furono sottoposte al
sistema delle quote e delle licenze d’importazione, nonché a forti dazi, in modo da favorire le
imprese che assicuravano la sostituzione delle importazioni.
40
Ennio De Simone
Per garantire lo sviluppo e recuperare il grave ritardo del loro paese, anche gli Indiani ritennero necessario l’intervento dello Stato nell’economia e perciò progettarono il controllo
pubblico delle attività economiche e la creazione di un solido sistema di imprese pubbliche.
L’idea dell’intervento statale si era diffusa nel Partito del Congresso e finanche fra gli industriali, i quali, nel cosiddetto «piano di Bombay» (1944), delinearono un insieme di principi
generali su cui fondare la conduzione pubblica dell’economia e impostare il protezionismo.
Perciò, le idee erano chiare fin dal momento dell’indipendenza e il nuovo governo adottò subito una serie di misure per giungere all’elaborazione di piani quinquennali. I piani, se si esclude il primo (1951-56), che faceva affidamento principalmente sull’iniziativa privata,
puntarono sulla presenza dell’impresa pubblica. Le imprese e l’attività industriale furono sostanzialmente divise in tre gruppi: a) le imprese pubbliche, che si sarebbero dovute occupare
dell’industria pesante e della trasformazione delle risorse naturali; b) le imprese a partecipazione pubblica, in cui la presenza privata si sarebbe dovuta gradualmente ridurre, impegnate
in diversi rami produttivi; c) le imprese private, prevalenti nell’industria leggera e destinate
alla produzione di beni di consumo. Il numero delle imprese pubbliche di proprietà del governo federale aumentò da cinque, quante erano all’inizio del primo piano quinquennale, a
quasi centottanta all’epoca del sesto piano nel 1980.
Sul finire degli anni Sessanta, una nuova accelerazione dell’intervento statale portò alla
nazionalizzazione delle banche, con lo scopo di far giungere i servizi bancari anche nelle zone rurali e favorire la formazione del risparmio. Qualche anno dopo furono nazionalizzati gli
impianti di estrazione del carbone, le raffinerie e le compagnie di assicurazione. Le piccole
imprese ricevettero particolare attenzione da parte dello Stato, specie a partire dagli anni Settanta, anche perché erano maggiormente in grado di assorbire manodopera. Fu aumentato il
numero di prodotti loro riservati nei piani quinquennali (salito, fra il 1973 e il 1980, da 51 a
834) e ottennero facilitazioni fiscali, finanziarie e in materia di lavoro. Per continuare a godere di questi vantaggi, le piccole imprese preferirono non crescere ma rimanere di modeste
dimensioni, così come molte grandi imprese decisero di articolarsi in aziende più piccole.
L’agricoltura, invece, rimase affidata al settore privato, ma fu ampiamente sostenuta dallo
Stato, che, fra l’altro, garantiva l’acquisto di cereali da destinare alla distribuzione a prezzi controllati. Il governo federale e quelli dei singoli Stati promossero la diffusione di nuove tecniche
di coltivazione, l’utilizzazione di cereali ad alto rendimento, l’irrigazione, l’uso di fertilizzanti
chimici e la meccanizzazione e facilitarono l’accesso al credito bancario. Ciò non riuscì a evitare due gravi carestie alla metà degli anni Sessanta, ma nei primi anni Settanta, l’India raggiunse l’autosufficienza alimentare, grazie all’aumento della produzione in alcune regioni del
paese, in particolare negli Stati nord-occidentali, che producevano grandi quantità di grano.
I risultati, però, furono modesti. Fra il 1950 e il 1980, il tasso di crescita medio annuo del
Pil fu di appena il 3 per cento e grandi masse di popolazione rimasero escluse da qualsiasi
beneficio, continuando a soffrire la fame e le malattie. Negli anni Settanta, dopo la crisi petrolifera e in considerazione del fatto che il settore industriale indiano si mostrava stagnante
già da tempo, si cominciò a pensare a profonde riforme economiche. Furono introdotte le prime forme di liberalizzazione e fu realizzata la riforma del settore pubblico, per aumentare
l’efficienza e la competitività del sistema. Ma solo a partire dal 1991 fu attuata una vera e
propria liberalizzazione dell’economia e si procedette al graduale smantellamento del sistema dei controlli, con lo scopo di dare vita a un’economia competitiva sul piano internazionale, con imprese orientate all’esportazione. Nel contempo fu ridimensionato e ridefinito il
ruolo dello Stato, mediante una decisa deregolamentazione, specialmente nel settore indu-
Appunti di Storia economica
41
striale, una liberalizzazione del commercio estero, una riforma del settore finanziario, soprattutto del mercato azionario, e una maggiore apertura ai capitali stranieri.
La privatizzazione delle imprese pubbliche è stata consistente e il loro numero si è fortemente ridotto, ma lo Stato ha conservato la proprietà di cospicue quote del loro capitale sociale. Anche il settore finanziario è stato liberalizzato: le banche private e quelle straniere
hanno ottenuto maggiore libertà di azione e le banche nazionalizzate hanno conseguito una
più ampia autonomia operativa. Le riforme si prefiggevano anche la riduzione del disavanzo
pubblico, mediante il taglio delle spese statali. Furono aboliti i sussidi alle esportazioni e si
ridussero gli investimenti in infrastrutture (energia, trasporti, comunicazione), ma, poco dopo, alcune spese ripresero a crescere, in particolare quelle a carattere sociale (salute, istruzione, sviluppo rurale e sussidi per i prodotti alimentari e per i fertilizzanti). Un’importante
conseguenza del processo di riforma economica è stata l’affermazione di una competitiva e
dinamica industria del software, che si è potuta giovare di giovani ingegneri preparati e che
alimenta una crescente corrente di esportazione.
A partire dagli anni Ottanta, l’India conobbe una crescita eccezionale, con un incremento
medio annuo del Pil che si tenne intorno al 6 per cento sino a fine secolo e ha superato il 9
per cento negli anni successivi. Sono aumentati gli investimenti esteri ed è fortemente cresciuta la partecipazione al commercio internazionale, la quale, anche se ancora modesta, si è
quasi quadruplicata in valore fra il 2001 e il 2007. Ma l’economia indiana è ancora poco internazionalizzata e rimane orientata verso il mercato interno.
I problemi dell’India sono numerosi e lo sviluppo è stato pieno di contraddizioni. La popolazione, che al censimento del 1981 era di 685 milioni, è passata a 1.150 milioni nel 2008,
con un incremento del 65 per cento in un quarto di secolo. Negli ultimi decenni, però, il tasso
d’incremento annuo della popolazione sta diminuendo (dal 2,2 per cento nel 1980-85, all’1,5
per cento nel 2001-06). Il forte incremento demografico ha comportato che il Pil pro capite,
pure aumentato, si sia tenuto troppo basso, pari, com’è, ad appena il 13 per cento di quello
britannico e al 10 per cento di quello americano (vedi nuova tab. 7.1). Le persone che devono vivere con meno di un dollaro al giorno costituiscono il 34 per cento della popolazione e
quelle che dispongono di due dollari al giorno raggiungono l’80 per cento. Gli analfabeti sono ancora il 39 per cento, ma erano l’80 per cento al momento dell’indipendenza. Ciò nonostante, l’India è considerata uno dei paesi emergenti più importanti (il suo Pil complessivo è
terzo dopo quelli di Stati Uniti e Cina) e, se la sua crescita continuerà ai ritmi attuali, è destinata a diventare uno dei protagonisti dell’economia mondiale.
3.3. Le «tigri asiatiche» e gli altri paesi dell’Asia
L’Asia nel suo complesso (esclusi i territori appartenuti all’Impero russo e poi all’Unione
Sovietica) produceva, nel 1820, secondo i calcoli di Angus Maddison, quasi il 60 per cento
del Pil mondiale. Nel 1950 la sua quota si era ridotta a meno del 20 per cento, per riportarsi a
più del 40 per cento nel 2006. Questi soli dati bastano a fornire un’idea di come il continente
asiatico avesse perso terreno di fronte all’avanzata della rivoluzione industriale in Occidente
e come, negli ultimi decenni, abbia saputo realizzare una crescita per certi versi inaspettata.
In quel continente, se si escludono rari casi di paesi con redditi molto bassi, anche per contingenze particolari (Afghanistan, Iraq e Territori palestinesi), sono concentrati i Pvs che
stanno cercando (e alcuni vi sono già riusciti) di portarsi al livello dei paesi sviluppati.
42
Ennio De Simone
Finora abbiamo trattato tre paesi asiatici, il Giappone, la Cina e l’India, che oggi contano
2,6 miliardi di abitanti, pari al 65 per cento della popolazione asiatica e a più della popolazione mondiale del 1950. È necessario accennare brevemente agli altri, che divideremo in
quattro gruppi più o meno omogenei. Il primo gruppo è costituito da appena quattro paesi, le
cosiddette tigri asiatiche (Hong Kong, Taiwan, Singapore e Corea del Sud), dove vivono circa 80 milioni di persone. Questi paesi, che hanno realizzato i risultati migliori (vedi nuova
tab. 7.1), hanno orientato le loro economie in prevalenza alla produzione e all’esportazione
di prodotti ad elevato contenuto tecnologico, ma per questo sono fortemente dipendenti
dall’andamento dei mercati mondiali. Il loro Pil pro capite è al livello di quello dei paesi più
sviluppati. Hong Kong è stata una colonia britannica fino al 1997, quando, in seguito a un
trattato, è passata alla Cina, che ne ha fatto una regione speciale autonoma e si è impegnata a
conservare per cinquanta anni il sistema economico e sociale vigente sotto l’amministrazione
britannica, basato sulla libera iniziativa e sull’economia di mercato. La sua posizione di
«porta verso la Cina» le ha consentito di svolgere il ruolo di intermediaria negli scambi fra la
Cina e il resto del mondo. È riuscita ad attrarre ingenti investimenti esteri, è diventata una
piazza finanziaria di prim’ordine e ha potuto contare su un inesauribile serbatoio di manodopera per le sue industrie, proveniente dalla Cina comunista. Anche Singapore, colonia britannica
fino al 1959, ha saputo sfruttare la sua posizione strategica ed è diventata uno dei maggiori porti mondiali. La sua economia è simile a quella di Hong Kong, con la differenza che qui lo Stato
ha avuto un ruolo maggiore nel favorire la crescita. Fra il 1950 e oggi, il Pil pro capite (in valori costanti) di queste due città-stato è aumentato, rispettivamente, di 13 e di 12 volte.
Nello stesso periodo, Taiwan e Corea del Sud hanno fatto registrare un aumento del loro
Pil pro capite di quasi 22 volte, il più alto realizzato da qualsiasi altro paese al mondo. Lo
sviluppo della Corea del Sud è stato promosso da un governo autoritario, spesso retto da militari, che ha puntato su settori tradizionali ad alta intensità di capitale (industrie siderurgiche,
automobilistiche, cantieristiche, del cemento, ecc.), ha sostenuto le esportazioni e ha costretto le imprese a misurarsi sul mercato globale. Un ruolo molto importante lo hanno avuto i
chaebol, gruppi imprenditoriali familiari, simili ai keiretsu giapponesi, ma dei quali non fa
parte una banca, che controllano grandi conglomerate e sono sostenuti dallo Stato. L’isola di
Taiwan (Cina nazionalista), dove si era rifugiato il governo nazionalista sconfitto dai comunisti, portando con sé le riserve auree cinesi, è stata anch’essa retta da un regime autoritario a
partito unico fino agli anni Ottanta. Ha puntato su piccole imprese altamente competitive orientate all’esportazione (materiale elettrico ed elettronico, circuiti elettronici integrati e microprocessori, macchinari, strumenti ottici e di precisione, ecc.) e, negli ultimi tempi, ha anche effettuato cospicui investimenti all’estero, specialmente in Cina.
Il secondo gruppo, situato nell’Asia sudorientale, conta circa 850 milioni di abitanti ed è
composto di nove paesi (Malaysia, Thailandia, Birmania o Myanmar, Indonesia, Bangladesh,
Nepal, Pakistan, Filippine e Sri Lanka). Specialmente a partire dagli anni Settanta, questi paesi hanno conosciuto una crescita che per alcuni è stata consistente, mentre per altri più modesta. Quelli più ricchi sono la Malaysia e la Thailandia, che hanno visto il loro Pil pro capite
crescere rispettivamente di 6 e 10 volte dal 1950 al 2006. Indonesia e Sri Lanka si collocano
in una posizione intermedia e hanno messo a segno buoni risultati, specialmente partire dalla
fine degli anni Ottanta. Alcuni paesi, però, come la Thailandia, l’Indonesia e la Malaysia, assieme alla Corea del Sud, incapparono nella grave crisi finanziaria asiatica della fine degli
anni Novanta, provocata da una serie di speculazioni, in seguito alla liberalizzazione dei
mercati. Gli investitori stranieri ritirarono i loro capitali e ne seguì una forte depressione e-
Appunti di Storia economica
43
conomica. Per un paio d’anni il Pil pro capite di questi paesi si ridusse, ma la ripresa fu abbastanza rapida.
I quindici paesi del Medio Oriente costituiscono il terzo gruppo, forte di circa 300 milioni di
abitanti. Esso comprende principalmente paesi produttori di petrolio (Arabia Saudita, Iran, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Iraq, Oman, Qatar, Bahrein, Siria e Yemen), oltre a Israele, Turchia, Giordania, Libano e Territori palestinesi. Il Pil pro capite è in genere abbastanza elevato,
ma dipende quasi esclusivamente dalla produzione e dall’esportazione di petrolio e di gas naturale, nonché dal loro prezzo internazionale. Molti di questi paesi sono stati interessati da una
forte immigrazione di lavoratori stranieri, per lo più provenienti dal mondo arabo e dall’India,
tanto che, dal 1950 a oggi, la popolazione degli Emirati Arabi Uniti è cresciuta di 64 volte,
quella del Qatar di 33 volte, quella del Kuwait di 18 volte e quella dell’Arabia Saudita di 7 volte. Il loro Pil pro capite, tranne che per la Palestina e l’Iraq, è abbastanza elevato e, in alcuni
casi (Israele, Kuwait, Emirati e Qatar), raggiunge i livelli delle nazioni sviluppate. Per alcuni di
questi paesi (Iraq, Kuwait, Qatar ed Emirati), la crescita non è stata lineare e negli anni Ottanta
e Novanta hanno accusato una recessione a causa di vicende politiche e militari. In particolare,
l’Iraq ha subito la dittatura di Saddam Hussein (1979-2003), ha sostenuto una lunga guerra
contro l’Iran, ha invaso il Kuwait ed è stato sconfitto nelle due cosiddette «guerre del golfo»
(1990-91 e 2003) dagli Americani, che sono rimasti sul suo territorio assieme a contingenti militari di altri paesi. La sua economia, basata sull’esportazione del petrolio, è crollata e nel 2006
il suo Pil pro capite era pari ad appena il 15 per cento di quello del 1980.
L’ultimo gruppo ha ottenuto i risultati più deludenti. Esso ospita circa 180 milioni di persone ed è composto di una trentina di paesi, fra i quali spiccano l’Afghanistan, la Cambogia,
il Laos, la Mongolia, la Corea del Nord e il Vietnam. Questi paesi, alcuni dei quali ex colonie francesi, sono stati quasi tutti coinvolti in guerre o in rivolte o sono stati governati da regimi comunisti, sicché hanno dovuto affrontare una difficile fase di transizione in seguito al
crollo di quel sistema. Il Vietnam, dopo la lunga guerra contro gli Stati Uniti (1961-75), durante la quale l’economia fu fortemente penalizzata, ha conosciuto una buona crescita che ha
fatto triplicare il Pil pro capite. L’economia dell’Afghanistan, invece, è stata distrutta da una
serie di eventi eccezionali a partire dal 1979: l’occupazione sovietica, durata dieci anni, una
guerra civile e la presenza sul suo territorio di truppe americane e di altri paesi, giunte nel
2001 per combattere i terroristi islamici, rifugiatisi sulle sue montagne. Perciò, l’Afghanistan
è oggi il paese con il Pil pro capite più basso di tutta l’Asia.
3.4. Le difficoltà dell’America Latina
La grande depressione mondiale degli anni Trenta aveva colpito pesantemente anche
l’America Latina. Fra il 1938 e il 1944, non essendo direttamente coinvolti nel conflitto
mondiale, molti paesi latinoamericani registrarono una debole ripresa, basata su un allargamento dei consumi interni, grazie al sostegno statale, e sui rifornimenti che furono in grado
di garantire agli Stati in guerra. La produzione di beni di consumo fu incoraggiata, per sostituire i prodotti che era difficile importare in tempo di guerra, e l’agricoltura fu stimolata con
riforme agrarie, che prevedevano la redistribuzione di vasti patrimoni fondiari e la messa a
cultura di nuove terre.
Negli anni Trenta e durante la guerra, l’intervento dello Stato si era fatto più massiccio ed
era stata attuata una politica protezionistica, strettamente collegata al nazionalismo allora
44
Ennio De Simone
imperante anche in quella parte del mondo. I governi erano intervenuti in tutti i settori
dell’economia, avevano nazionalizzato alcune attività produttive nel campo minerario e in
quello agricolo e avevano creato apposite aziende di Stato. Anche quando, dopo la guerra, i
principali paesi del mondo liberalizzarono le loro economie e avviarono una politica di libero
scambio, i governi populisti dell’America Latina (di «destra» e di «sinistra») 7 restarono legati
al protezionismo e all’intervento statale, presentati come una forma di difesa dell’economia nazionale, e isolarono, in tal modo, i loro mercati, peraltro di modeste dimensioni.
Gli anni successivi al conflitto furono, anche in America Latina, un periodo di crescita. I
paesi latinoamericani avevano sostanzialmente scelto il campo occidentale (tranne Cuba, che
nel 1960 passò nell’orbita sovietica) e subivano, sia pure a malincuore, il dominio economico e politico degli Stati Uniti. Ciò nonostante, essi continuarono la politica di intervento statale. L’industria fu certamente il settore più dinamico, specie negli anni Sessanta, anche se
non riuscì ad avere un ruolo propulsivo per realizzare la modernizzazione, perché rimase legata a una produzione basata sullo sfruttamento delle risorse naturali e di manodopera non
qualificata, senza investimenti di capitali in nuove tecnologie che ne elevassero la competitività. Sostenuta dallo Stato, l’industria dei paesi latinoamericani si limitò a rifornire il mercato interno e non fu in grado di espandersi su quello internazionale. La stessa agricoltura, nonostante le continue riforme agrarie, non riuscì a progredire significativamente e la produttività rimase bassa. Il controllo governativo dei prezzi agricoli, che venivano artificialmente
tenuti bassi, non incoraggiava gli agricoltori e finiva con il costituire una forma di sostegno
ai ceti urbani e industriali. La strategia di potenziare l’industrializzazione sostitutiva delle
importazioni fu appoggiata dalla borghesia latinoamericana, che sostenne i governi populisti,
in quanto quella politica le consentiva di investire nel settore industriale i capitali di cui disponeva. Gli effetti negativi di queste politiche furono una forte inflazione, specialmente nelle economie più «chiuse», come quelle di Argentina, Brasile e Cile, e il deterioramento delle
finanze statali, compromesse dalle spese e dai sussidi governativi, con una conseguente elevata pressione fiscale, specialmente sui ceti più deboli.
L’America Latina è stata caratterizzata, dal dopoguerra a oggi, da un forte incremento
demografico, al quale, nell’immediato dopoguerra, contribuì la ripresa dell’immigrazione
proveniente dall’Europa. In seguito il subcontinente latinoamericano è diventato luogo di
emigrazione, in particolare verso gli Stati Uniti. La sua popolazione si è quadruplicata dal
1945 a oggi (da 145 a 580 milioni) e continua a registrare un incremento superiore a quello
dei paesi asiatici, europei e nordamericani. L’aumento della popolazione ha sicuramente contribuito a mantenere in vita politiche economiche populiste, volte anche a contenere la disoccupazione e la sottoccupazione, ma ha ostacolato un miglioramento generalizzato del tenore
di vita dei cittadini. Per continuare la loro politica di sostegno della domanda e di spese pubbliche necessarie per assicurare i servizi ai cittadini, i paesi latinoamericani utilizzarono anche gli aiuti e i prestiti internazionali.
La situazione peggiorò con la crisi degli anni Settanta. Molti paesi furono costretti a indebitarsi ulteriormente a tassi di interessi molto più elevati di prima e il debito estero complessivo aumentò di sette volte fra il 1973 e il 1982. Quando il Messico fu costretto a dichia7
Il populismo è variamente definito dalle scienze politiche. In questo caso è riferito a quei governi latinoamericani, basati sull’esistenza di un capo carismatico (come Juan Perón in Argentina), che si rivolge direttamente, in
modo retorico e paternalistico, al popolo, in nome del quale dice di parlare e a favore del quale dice di operare,
attuando una politica nazionalista di intervento statale in economia.
Appunti di Storia economica
45
rare la sua insolvenza (1982), il flusso dei prestiti privati si arrestò di colpo e fu necessario
ridurre gli investimenti sia nelle aziende statali sia nei servizi pubblici. Si verificò, inoltre,
una consistente «fuga dei capitali» all’estero, ossia il trasferimento (anche illegale) in altri
paesi di moltissimi capitali privati delle classi agiate, in cerca di migliori rendimenti, sicché
mentre i governi latinoamericani s’indebitavano all’estero per sopravvivere, i detentori di
capitali nazionali li esportavano.
La crisi impose importanti cambiamenti nella politica economica. I governi attuarono
forme di deregolamentazione e di privatizzazione, a ciò spinti anche dalla circostanza che gli
aiuti internazionali e i prestiti esteri, che avevano consentito le spese pubbliche del lungo periodo precedente, si erano drasticamente ridotti. Le basse tariffe dei servizi pubblici dovettero essere riviste e la politica fiscale divenne più rigorosa. Le privatizzazioni furono avviate,
fin dagli anni Settanta, nel Cile governato da una dittatura militare, in seguito al colpo di Stato contro il presidente Salvador Allende. Per impulso degli economisti della scuola di Chicago, fu trasferito a imprese private un ingente patrimonio pubblico, che comprendeva risorse
naturali (petrolio, gas, petrolchimica, agroindustria, miniere), infrastrutture (porti e strade),
servizi di pubblica utilità (telecomunicazioni, elettricità, acqua), aziende industriali, servizi
finanziari e trasporti. Oggi il Cile è il paese latinoamericano con il Pil pro capite più elevato
(negli ultimi venti anni si è più che raddoppiato) e con un basso tasso di povertà. Oltre al Cile, le privatizzazioni interessarono il Messico, l’Argentina, il Venezuela e il Perù. Gli acquirenti delle imprese messe in vendita erano sia imprenditori nazionali, che utilizzarono anche
i capitali esportati negli anni Ottanta e successivamente rientrati in patria, sia imprenditori
stranieri. I loro investimenti furono spesso di natura speculativa ed essi puntarono più su risultati di breve periodo (per rivendere le aziende acquistate) che su strategie durature. Perciò,
il mercato dei titoli azionari, cresciuto notevolmente, fu caratterizzato da un’alternanza di
periodi di euforia finanziaria e periodi di panico. Crisi finanziarie colpirono paesi come il
Messico (1994), il Brasile (1999) e l’Argentina (2000). Le imprese passate ai privati continuarono a investire poco nella tecnologia e a fare affidamento soprattutto sullo sfruttamento
delle risorse naturali e sulla manodopera generica a basso costo, sicché la competitività internazionale dei prodotti latinoamericani è rimasta a livelli molto bassi.
L’inflazione fu un costante fattore di instabilità in America Latina. Le politiche populistiche avevano portato a un’espansione della spesa pubblica, senza un conseguente aumento
delle entrate tributarie, e quindi imponendo il ricorso all’indebitamento pubblico e all’aumento della circolazione monetaria. Quando, con la crisi degli anni Settanta, l’inflazione interessò tutti i paesi a economia di mercato, quella latinoamericana divenne iperinflazione e
molti paesi dovettero continuamente svalutare la loro moneta o anche ritirare quella in circolazione e sostituirla con nuove monete. Furono necessarie drastiche politiche di risanamento
per mettere sotto controllo l’inflazione e assicurare una certa stabilità monetaria.
Negli ultimi decenni è stata abbandonata la politica protezionistica e i paesi latinoamericani
sono entrati prima nel Gatt e poi nella Wto, partecipando in misura maggiore al commercio internazionale. La loro quota nei traffici mondiali è aumentata, ma ha riguardato solo pochi
comparti e si è limitata ad alcune aree geografiche. Dal 1995, inoltre, alcuni paesi (Argentina,
Brasile, Paraguay e Uruguay), cui si è successivamente aggiunto il Venezuela, hanno dato vita
al Mercosur (Mercato comune del Sud), al quale si sono associati diversi paesi dell’America
meridionale. Il Messico, invece, partecipa alla Nafta, assieme agli Stati Uniti e al Canada.
L’America Latina, che alla fine della seconda guerra mondiale era un subcontinente con
la maggior parte della popolazione legata all’agricoltura, è attualmente un’economia terzia-
46
Ennio De Simone
rizzata, con profondi squilibri fra i diversi paesi e fra i vari ceti sociali. Le differenze fra le
categorie più ricche e la massa di popolazione che, molto spesso, vive in condizioni di assoluta povertà, sono aumentate e ciò ostacola la crescita economica, che non è adeguatamente
sostenuta da un flusso continuo di consumi, dai quali moltissimi individui sono esclusi. In
alcuni paesi (Haiti, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, El Salvador) oltre il 40 per cento degli abitanti deve vivere con meno di due dollari al giorno. Ciò ha comportato sia una massiccia emigrazione verso gli Stati Uniti, da dove arriva un consistente flusso di rimesse da parte degli emigrati, sia lo spostamento di moltissime persone nelle periferie delle grandi città. Gli
agglomerati urbani di Città del Messico e San Paolo del Brasile contano quasi 20 milioni di
persone e Buenos Aires quasi 13 milioni.
Nell’area si segnalano due economie emergenti, quelle del Messico e del Brasile, che contano rispettivamente quasi 110 e 200 milioni di abitanti, vale a dire più della metà dell’intera
America Latina. Il Messico è strettamente legato all’economia statunitense, di cui subisce
l’influenza, mentre il Brasile sta puntando sullo sviluppo industriale, sulle infrastrutture e
sulla finanza, con la Borsa di San Paolo che è diventata la più importane dell’America Latina.
Nell’ultimo mezzo secolo, questi due paesi hanno goduto di una crescita abbastanza costante
e regolare, anche se il loro Pil pro capite è inferiore a quello di altri Stati latinoamericani,
come il Venezuela e l’Argentina, che però hanno avuto un andamento altalenante, fatto di
periodi di crescita e di decrescita. Tuttavia, il Pil pro capite del Brasile e quello del Messico
sono modesti se confrontati con quello degli Stati Uniti: appena il 21 per cento il Pil brasiliano e il 25 per cento quello messicano e, per giunta, queste percentuali sono peggiorate rispetto al 1980.
3.5. Il ritardo dell’Africa
Fino alla fine dell’Ottocento, la maggior parte del continente africano era ancora sconosciuta e inesplorata. Gli abitanti di molte regioni praticavano un’agricoltura di sussistenza e
le terre da coltivare erano periodicamente distribuite dai capi villaggio alle famiglie, senza
che esistessero diritti di proprietà di tipo occidentale. Dal 1880, l’Africa fu conquistata dalle
principali potenze europee (in particolare Francia e Gran Bretagna), che vi mantennero proprie colonie fino a dopo la seconda guerra mondiale. I colonialisti si appropriarono delle terre migliori, introdussero i diritti di proprietà e sfruttarono la manodopera locale nelle piantagioni e nelle miniere. Pochi furono gli sforzi compiuti per istruire la popolazione o per costruire un’efficiente rete di trasporti. Con la fine del colonialismo, fra gli anni Cinquanta e
Sessanta del Novecento, si formarono i nuovi Stati indipendenti, nella maggior parte dei casi
creati artificialmente e, perciò, privi di una chiara identità nazionale, nei quali si trovarono a
convivere diversi gruppi tribali o etnici, sovente in contrasto fra di loro. Scoppiarono numerose guerre tribali e molti Stati finirono nelle mani di governanti senza scrupoli, talvolta appoggiati dalle ex potenze coloniali.
Anche in Africa, il periodo della golden age fu caratterizzato dall’intervento statale in economia, ritenuto indispensabile per garantire la modernizzazione dei nuovi Stati formatisi
con l’indipendenza. L’azione dei governi conservò alle ex colonie la loro funzione di esportatrici di materie prime in cambio di manufatti. Si formarono gruppi di privilegiati, che trassero vantaggio da questi traffici (spesso illegali, come il contrabbando di diamanti per pagare
le forniture di armi) e furono in grado di alimentare i consumi dei prodotti importati, mentre
Appunti di Storia economica
47
la massa della popolazione viveva nell’ignoranza e nella miseria. Siccome era l’epoca della
Guerra fredda, i paesi occidentali e quelli comunisti fecero a gara per sostenere i nuovi Stati
africani con aiuti finanziari e forniture di armi, pur di attirarli nel loro campo. I governi africani fecero affidamento su questi aiuti per assicurare i servizi minimi alla popolazione. Comunque, fra il 1950 e il 1973 il Pil pro capite crebbe, in tutto il continente, a un tasso medio
annuo di oltre il 2 per cento, con differenze talvolta rilevanti da paese a paese. I risultati migliori, fra gli Stati più popolosi, furono registrati dalla Nigeria, dalla Costa d’Avorio,
dall’Algeria e dal Sudafrica.
Il primo shock petrolifero del 1973, se portò qualche vantaggio ai paesi esportatori di petrolio (Nigeria, Algeria, Libia, Gabon e Repubblica del Congo), costrinse gli altri a indebitarsi per l’acquisto del petrolio di cui avevano bisogno, portando alla formazione di un ingente
debito estero, parte del quale si è dovuto ridurre o cancellare, per l’impossibilità dei debitori
più poveri di rimborsarlo. In molti paesi furono adottate politiche neoliberiste, che portarono
alla liberalizzazione del mercato e alla privatizzazione delle imprese pubbliche, nel tentativo
di far decollare l’economia e migliorare le condizioni della popolazione. Ma sino alla fine
del secolo XX, la crescita del Pil pro capite si arrestò ed esso rimase in media, per l’intero
continente, sostanzialmente agli stessi livelli del 1973. In alcuni paesi più grandi, come il
Ghana, il Sudafrica, la Costa d’Avorio, il Madagascar, il Mozambico, la Nigeria, la Tanzania
e l’Uganda, il Pil addirittura diminuì, segnando, quindi, un peggioramento delle condizioni
di vita della maggioranza della popolazione. Nei primi anni del nuovo secolo quasi tutti i paesi africani stanno facendo registrare un buon andamento della loro economia, ma si tratta di
una crescita determinata dalle alte quotazioni del petrolio e delle materie prime minerarie che
sono in grado di esportare, sicché non è ancora sicuro che si possa trasformare in uno sviluppo duraturo.
L’Africa presenta molti problemi. La crescita demografica è stata più elevata che in qualsiasi altra area del mondo. Secondo alcuni studiosi, la popolazione africana era, agli inizi del
Novecento, uguale a quella di tre secoli prima, quando era iniziata la tratta degli schiavi verso le Americhe, che sottrasse al continente africano circa undici milioni di persone (tredici
milioni, se si considerano anche gli schiavi inviati in Asia). Secondo altri, la popolazione africana sarebbe comunque cresciuta, anche se in misura contenuta. Ciò che è certo è che dal
1945 a oggi essa è passata da circa 200 milioni a quasi un miliardo, giungendo a quintuplicarsi, con una crescita spettacolare. La vita media è dappertutto molto bassa, tranne che nei
paesi che si affacciano sul Mediterraneo, dove si avvicina ai livelli europei. Alcuni Stati a
sud del Sahara fanno registrare i valori più bassi del mondo, con una speranza di vita alla nascita che oggi a stento raggiunge i 40 anni.
Un altro problema dell’Africa è la scarsità di acqua, che provoca ricorrenti periodi di siccità, come quello degli anni Settanta e Ottanta. La siccità è sempre accompagnata da carestie, alle quali si cerca di fare fronte grazie agli aiuti internazionali. In «annate normali»,
sembra che almeno cento milioni di africani patiscano la fame e la denutrizione, che sono i
principali fattori di diffusione delle epidemie. Non è un caso, perciò, che l’Aids colpisca in
particolare i paesi dell’Africa subsahariana, vale a dire la parte più povera del continente.
Guerre, siccità e malattie contribuiscono a spingere molti poveri nelle città o a emigrare verso i paesi ricchi dell’Europa, con lunghi, pericolosi e costosi viaggi.
Le continue guerre e rivolte costituiscono un ulteriore grave ostacolo alla crescita
dell’economia africana. La maggior parte dei paesi è stata scossa da guerre civili e colpi di
Stato, che sembrano verificarsi con maggiore frequenza nei paesi a basso reddito o con una
48
Ennio De Simone
crescita molto lenta. Sembra che il possesso o la scoperta di risorse naturali (petrolio, diamanti, minerali, ecc.), invece di consentire ai paesi che ne dispongono di svilupparsi, fomentino guerre e rivolte, perché attorno ai guadagni che si possono realizzare con la loro esportazione si concentra la cupidigia di governanti intenzionati a perseguire soltanto il loro interesse privato, sovente sostenuti dai governi dei paesi importatori. Le maggiori entrate derivanti dalle esportazioni di materie prime (o anche dalle rimesse degli emigrati e dagli aiuti
internazionali) danno spesso l’illusione di un’improvvisa ricchezza, peraltro concentrata in
poche mani, e non stimolano la produzione e l’esportazione di altri beni e servizi, che potrebbero innescare un processo di sviluppo. E molte di tali risorse finiscono nell’acquisto di
armi e in progetti costosi quanto inutili, che accrescono la corruzione. Questi paesi, in genere, sono guidati da governi autoritari, ostili alla democrazia, che stenta ad affermarsi perché
spesso si fonda sul clientelismo, favorito dalla stessa disponibilità di risorse finanziarie assicurate dalle esportazioni e dagli aiuti internazionali.
Molti paesi africani, infine, hanno grande difficoltà a partecipare al commercio internazionale. Quelli che non hanno accesso al mare sono, quasi sempre, circondati da paesi altrettanto poveri e privi di efficienti sistemi di trasporto, sicché soffrono della condizione di Stati
interni, che non riescono a inserirsi nei traffici mondiali e sono condannati alla povertà, anche quando dispongono di risorse da esportare. Né la partecipazione alla Wto produce qualche consistente beneficio, per la scarsa capacità contrattuale dei paesi africani nei lunghi negoziati che precedono la stipulazione degli accordi commerciali. Perciò, la maggior parte di
questi paesi non è riuscita a profittare delle opportunità offerte dal processo di globalizzazione. D’altra parte, il costo dello sviluppo è, nel frattempo, ulteriormente cresciuto e la stessa
globalizzazione ha reso le cose più difficili per i paesi arretrati. Le persone più giovani e intraprendenti emigrano, specialmente se conoscono un mestiere o hanno un titolo di studio, e
finanche i capitali, legalmente o illegalmente accumulati dai benestanti, vengono trasferiti
all’estero.
La situazione economica del continente non è uniforme. I paesi con un reddito più elevato
si trovano principalmente a nord e sono quelli che si affacciano sul Mediterraneo (Marocco,
Algeria, Tunisia, Libia, Egitto), dove vivono circa 160 milioni di persone, ma ve ne sono anche al centro, come il Gabon e la Repubblica del Congo (esportatori di petrolio), con meno
di 5 milioni di abitanti, e nell’Africa meridionale, con il Sudafrica (quasi 50 milioni di abitanti). I paesi più poveri si trovano nell’Africa subsahariana, che accoglie più dei tre quarti
della popolazione del continente.
Nonostante i problemi che affliggono l’Africa, vi sono segni di vitalità, a cominciare da
quella demografica, che, se nell’immediato crea enormi problemi, in futuro potrebbe rivelarsi un fattore di sviluppo, specialmente per l’esistenza di una popolazione molto giovane. Non
bisogna dimenticare che gli Africani hanno dovuto affrontare, dopo l’indipendenza, una fase
molto difficile. Mancava una classe dirigente adeguata, che non si era formata durante il periodo coloniale, esisteva un grave ritardo nell’istruzione, la popolazione cresceva a ritmi incredibili e si urbanizzava (una città come Kinshasa, nel Congo, è passata dai 360 mila abitanti del 1955 agli oltre sette milioni attuali) e ha dovuto soffrire un lungo periodo di siccità, durato una ventina d’anni. Essere riusciti a mantenere una popolazione che si è raddoppiata ogni ventitré anni, sia pure grazie agli aiuti internazionali, e nonostante le inique sperequazioni nella distribuzione del reddito, è comunque un altro segno di vitalità del continente.
Appunti di Storia economica
49
3.6. Epilogo
Il cammino compiuto dall’uomo negli ultimi secoli è stato prodigioso. La popolazione
mondiale è passata dai circa 800 milioni di individui a metà Settecento ai 6,8 miliardi attuali.
Ma si è anche allungata di molto la vita media ed è cresciuto il tenore di vita di buona parte
della popolazione mondiale. L’uomo è stato affrancato dal lavoro della terra e oggi bastano
poche persone che, con l’aiuto di macchine sempre più perfezionate e di fertilizzanti chimici,
riescono ad alimentare un gran numero di individui che si possono dedicare ad altre attività,
soprattutto nel settore dei servizi, e peraltro dispongono di molto tempo libero.
Lo sviluppo è costato grandi sacrifici a intere generazioni. Lo sfruttamento dei lavoratori
nelle prime fasi dell’industrializzazione è stato molto forte, l’assoggettamento e lo sfruttamento di interi paesi sono durati a lungo e lo spostamento di tantissime persone alla ricerca
di migliori condizioni di vita è stato massiccio e continua ancora, con elevati costi sociali.
Come una volta l’uomo si spostava per inseguire il cibo, oggi si sposta per cercare lavoro, il
che in sostanza è la stessa cosa.
Le sperequazioni nella distribuzione della ricchezza, anche all’interno dei paesi più avanzati, restano, però, rilevanti. Anzi, le differenze fra i diversi ceti sociali si sono accentuate
rispetto alla società preindustriale, quando, in genere, l’accumulazione di ricchezze individuali era limitata dalla possibilità di utilizzarle per migliorare la propria condizione di vita
oltre una determinata soglia. L’esperimento di un’economia pianificata che garantisse
l’eguaglianza economica fra gli uomini è miseramente fallito. Il capitalismo trionfante, che
peraltro presenta molte varietà al suo interno, se risulta maggiormente capace di creare ricchezza, non riesce ad assicurare una sua equa distribuzione sia a livello nazionale che internazionale ed è oggetto di numerose critiche.
Lo squilibrio fra nazioni sviluppate e in via di sviluppo, categorie peraltro assai molto poco omogenee, è andato continuamente crescendo e i loro interessi continuano ad essere divergenti. Purtroppo, come si è visto dall’evoluzione dei diversi paesi negli ultimi due o tre
secoli, non esiste una sola via allo sviluppo e ogni nazione ha dovuto sforzarsi per trovare la
sua, che quasi mai è stata identica a quella dei suoi vicini. Non vi è una «ricetta» che possa
essere valida per tutti i paesi e per tutte le epoche. Tuttavia, a partire dalla metà del secolo
XX, l’Asia è stato il continente più dinamico dal punto di vista economico. Dopo essere rimasta ferma per alcuni secoli, mentre altre regioni del mondo progredivano, l’Asia ha ripreso
a crescere e ha cominciato anche a muovere concorrenza alla produzione di manufatti occidentali, potendo contare su una numerosa e finora poco esigente manodopera, e quindi a partecipare in modo più consistente al commercio internazionale.
All’inizio del nuovo millennio l’interdipendenza fra gli uomini e i popoli del pianeta è sicuramente cresciuta rispetto ai secoli precedenti. Da un lato, la complessità dei sistemi produttivi e relazionali rende gli uomini dipendenti in misura molto maggiore che in passato dal
comportamento di altri uomini. Dall’altro, le decisioni assunte in una parte del globo hanno
effetti anche in posti molto lontani. Il mondo è diventato un unico grande mercato e la vita
degli uomini ormai si svolge in un «villaggio globale», in cui le comunicazioni avvengono,
come si dice, in tempo reale.
Lo sviluppo economico è stato reso possibile da molti fattori, il più dinamico dei quali si
è dimostrato sicuramente la tecnologia, che ha contribuito significativamente al compimento
della rivoluzione industriale e che oggi permette di aprire nuovi orizzonti nel campo
dell’informazione e della conoscenza.
50
Ennio De Simone
Di recente, si sta prendendo coscienza che lo sviluppo non può essere solo economico,
misurabile con l’incremento del Pil pro capite. Esso deve essere anche «umano», cioè deve
tenere conto pure di altri parametri che riguardano le condizioni di vita degli individui e dei
popoli, e «sostenibile», vale a dire che deve soddisfare le esigenze delle generazioni presenti,
senza compromettere le capacità delle generazioni future di soddisfare le loro.
I problemi – non solo economici – che l’uomo del secolo XXI dovrà affrontare sono, perciò, enormi e vanno dall’accelerato incremento demografico al rimescolamento dei popoli,
dalle disuguaglianze fra le diverse aree del pianeta all’esistenza di armi di distruzione di
massa, dalle problematiche ecologiche (che si fanno sempre più pressanti e vitali per il futuro
del pianeta) all’organizzazione di nuove forme di produzione e di consumo. Forse la tecnologia potrà ancora venire in aiuto all’uomo per consentirgli di risolvere alcuni di questi problemi, ma i risultati dipenderanno da come egli saprà utilizzarla per il bene comune
dell’intera umanità.
51
Appunti di Storia economica
TABELLE AGGIORNATE
Le seguenti tabelle sono quelle contenute alle pagine indicate del libro.
Esse sono state aggiornate con i dati più recenti
Pag. 154
Tab. 5.1. – Tassi percentuali medi annui di crescita del Pil pro capite nei principali paesi, per periodi, dal 1820 al 2008
Paesi
Gran Bretagna
Francia
Germania
Stati Uniti
Russia (Urss)
Giappone
Italia
1820-1870
1870-1913
1913-1950
1950-1973
1,3
1,0
1,1
1,3
0,6
0,2
0,6
1,0
1,5
1,6
1,8
1,1
1,5
1,3
0,9
1,1
0,2
1,6
1,8
0,9
0,9
2,4
4,0
5,0
2,5
3,4
8,1
5,0
1973-1995
1,7
1,6
1,7
1,8
– 1,8
2,6
2,2
1995-2008
2,4
1,6
1,4
1,9
5,4
1,0
1,2
Fonte: Dati tratti da A. Maddison, L’economia mondiale dall’anno1 al 2030. Un profilo quantitativo e macroeconomico, Milano, 2008, p. 436 (tab. A.8), dal sito web di A. Maddison, all’indirizzo
“www.ggdc.net/Maddison” e, per il periodo 1995-2008, dal sito dell’Università di Groningen, Groningen Growth
and Development Centre, all’indirizzo “www.ggdc.net” (nostri calcoli).
Nota: Tutti i dati tratti da Maddison (in questa e nelle tabelle successive) sono espressi in dollari 1990; le altre
valute sono state convertite in dollari in base alla parità di potere d’acquisto. I dati della Germania sono riferiti, fino
al 1913, ai confini del 1913 (escluse Alsazia e Lorena) e, dal 1950, ai confini del 1991 (Germania riunificata). I dati
della Russia sono riferiti ai territori dell’ex Unione Sovietica (Urss), coincidenti all’incirca con quelli dell’Impero
zarista. I dati della Gran Bretagna sono quelli del Regno Unito e, perciò, comprendono anche i dati dell’Irlanda
fino al 1920.
Tab. 5.2. – Livello del Pil pro capite dei principali paesi raffrontato con quello della Gran Bretagna, per alcuni anni dal 1820 al 2008
Paesi
Gran Bretagna
Francia
Germania
Stati Uniti
Russia (Urss)
Giappone
Italia
1820
1870
1913
1950
1973
2008
100
58
50
59
32
32
53
100
54
52
70
27
21
43
100
68
71
103
29
27
50
100
76
56
138
41
28
51
100
109
100
139
50
95
89
100
95
87
131
33
95
83
Fonte: Dati tratti da A. Maddison, L’economia mondiale. Una prospettiva millenaria, cit., pp. 389-390 (tab.
B.13), 420-421 (tab. B.21), dal sito web di A. Maddison, all’indirizzo “www.ggdc.net/Maddison” e, per il 2008,
dal sito dell’Università di Groningen, Groningen Growth and Development Centre, all’indirizzo “www.ggdc.net”
(nostri calcoli).
Nota: Per la Germania e la Russia, vedi tab. 5.1. Per la Gran Bretagna sono stati considerati, fino al 1913, perché
disponibili, solo i dati di Inghilterra, Galles e Scozia (senza l’Irlanda); dal 1950 i dati sono quelli del Regno Unito.
52
Ennio De Simone
Pag. 270
Tab. 7.1. – Livello del Pil pro capite di alcuni paesi raffrontato con quello del Regno Unito, per
alcuni anni dal 1950 al 2008
Paesi
Regno Unito
Stati Uniti
Unione Sovietica
Giappone
Francia
Germania
Italia
Belgio
Olanda
Svizzera
Svezia
Norvegia
Danimarca
Spagna
Canada
Australia
Singapore
Hong Kong
Taiwan
Corea del Sud
Cina
India
Messico
Brasile
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2008
100
138
41
28
75
56
50
79
86
131
97
78
100
32
105
107
32
32
13
12
6
9
34
24
100
131
46
46
86
89
68
80
96
144
100
83
102
36
101
102
27
36
17
14
8
9
36
27
100
140
52
90
106
101
90
99
111
157
118
93
118
59
112
112
41
53
28
20
7
8
40
28
100
144
50
104
114
109
102
112
114
145
116
117
118
71
125
111
70
81
45
32
8
7
49
40
100
141
42
114
107
97
99
105
105
131
107
112
112
73
115
105
87
107
60
53
11
8
37
30
100
140
22
102
100
93
92
101
109
110
102
123
113
77
110
107
111
115
83
71
17
9
36
27
100
131
33
95
95
87
83
99
103
104
103
122
103
73
106
105
118
124
89
82
25
13
33
27
Fonte: Dati tratti dal sito web di A. Maddison, all’indirizzo “www.ggdc.net/Maddison” e, per il 2008, dal sito
dell’Università di Groningen, Groningen Growth and Development Centre, all’indirizzo “www.ggdc.net”(nostri
calcoli).
Nota: I dati della Germania sono riferiti ai confini del 1991 (Germania riunificata). I dati del 2000 e del 2006
dell’Unione Sovietica sono riferiti al territorio dell’ex Urss. I dati per la sola Russia sono: 2000 = 26; 2008= 38
53
Appunti di Storia economica
Pag. 284
Tab. 7.2. – Tassi percentuali medi annui di crescita del Pil pro capite nelle diverse regioni del
mondo, dal 1913 al 2003
Regioni
1913-1950
1950-1973
Europa occidentale
Usa, Canada, Australia e Nuova Zelanda
Giappone
Asia (escluso il Giappone)
America Latina
Europa orientale
Unione Sovietica
Africa
Mondo
0,8
1,6
0,9
–0,1
1,4
0,6
1,8
0,9
0,9
4,1
2,5
8,1
2,9
2,6
3,8
3,4
2,0
2,9
1973-2003
1,9
1,9
2,1
3,9
0,8
0,9
–0,4
0,3
1,6
Fonte: Dati tratti da A. Maddison, L’economia mondiale dall’anno 1 al 2030, cit., p. 436 (tab. A.8).