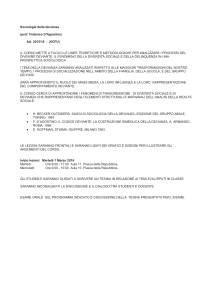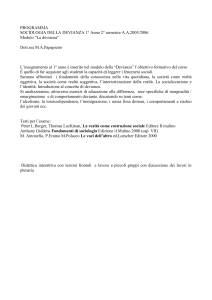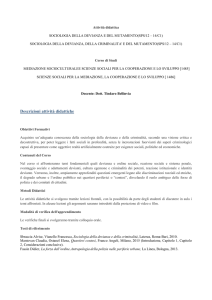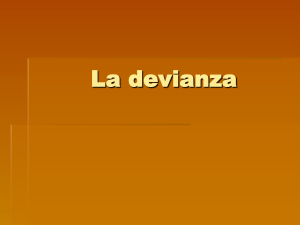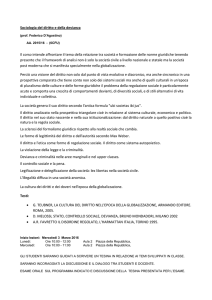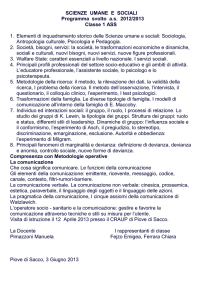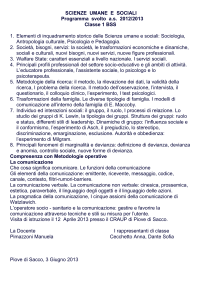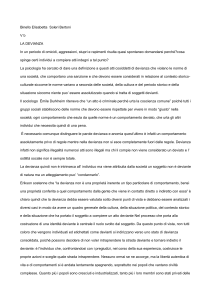Programma dell’insegnamento svolto presso
UNICUSANO - Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma
nel
Master di I livello in
“Tecniche di indagine, della sicurezza e criminologia”
Materia: Sociologia - Salvatore Licata
Anno Accademico 2011/2012
Il percorso sulle principali teorie sociologiche si articolerà in tre momenti che
esporranno la devianza come il prodotto di una costruzione sociale.
Nella prima parte saranno presentate le principali scuole di pensiero e teorizzazioni
della Sociologia, che costituiscono un punto di riferimento concettuale necessario alla
comprensione della devianza.
Nella seconda si affronteranno il controllo sociale, i processi di comunicazione
formale ed informale che determinano nella cultura generale il significato sociale e
simbolico dei molteplici avvenimenti delittuosi. Si analizzeranno le principali indagini sulla
relazione tra opinione pubblica e mass media in tema di delinquenza, la costruzione degli
stereotipi sul crimine giovanile, l’influenza della cultura degli investigatori nella selezione
del crimine e le differenti politiche del controllo territoriale.
La terza parte approfondirà la conoscenza dei devianti nell’azione comunicativa, nei
processi cognitivi, nelle relazioni significative per la crescita - la famiglia, la scuola, i gruppi
di pari nell’adolescenza- e nei percorsi di degenerazione della identità individuale, dopo il
riconoscimento pubblico dell’azione delittuosa, nell’impatto con i meccanismi selettivi della
reazione sociale.
Oltre alle principali ricerche e teorie sull’influenza della famiglia nella genesi e nella
stabilizzazione della devianza, si presenteranno i contributi dei principali teorici, studiosi
delle sub-culture devianti, i contributi di ricerca sui gruppi di pari ed i comportamenti
trasgressivi nonché le linee di evoluzione degli interventi di prevenzione e recupero della
devianza minorile e del fenomeno del bullismo, anche attraverso forme applicate di
giustizia riparativa.
La Sociologia della devianza è una disciplina che affronta l’evoluzione dell’immagine
sociale della diversità e la genesi e la stabilizzazione di comportamenti individuali e
collettivi devianti e approfondisce gli aspetti culturali e simbolici della vita quotidiana e le
prospettive del trattamento sociale e giuridico della devianza.
Programma:
Il paradigma della definizione sociale della devianza
► Le fonti culturali: l’interazionismo simbolico di Mead e la sociologia fenomenologica di
Schutz
► Il “labelling approach” e la devianza secondaria (Lemert)
► Gli Outsiders di Becker
► L’approccio dell’etnometodologia
► Goffman: l’interazione consapevole e gli adattamenti secondari
► Come si diventa devianti nell’approccio naturalista di Matza
La devianza nel paradigma conflittuale
► La prospettiva radicale della teoria del conflitto ed i processi di definizione istituzionale
della criminalità
► Lo stereotipo del criminale in Chapman
► Le funzioni della norma penale nella società in conflitto (Dahrendorf, Coser)
► La natura politica e conflittuale del potere di definizione dei soggetti devianti
nell’interpretazione di Turk
La paura del crimine
► Il valore della paura nelle politiche del controllo sociale
► Le rappresentazioni dell’insicurezza e la paura di vittimizzazione
► I riflessi della paura del crimine sui comportamenti quotidiani e sui bisogni di protezione
Le teorie del controllo sociale
► La prospettiva teorica della teoria del controllo sociale di Durkheim
► Teorie del controllo sociale basate sulla personalità
► Le teorie del legame sociale
► La teoria del controllo sociale di Hirshi
Le teorie dell’apprendimento sociale
► La prospettiva teorica e la teoria dell’apprendimento operante
► La teoria del rinforzo differenziale
Descrizione dei contenuti del programma:
Il paradigma della definizione sociale della devianza
► Le fonti culturali: l’interazionismo simbolico di Mead e la sociologia fenomenologica di
Schutz.
L’Interazionismo simbolico è una corrente di studi sviluppatasi a partire dalle teorie
introdotte nelle scienze sociali da G. H. Mead attorno agli anni '30, il primo a coniare il
termine di interazionismo simbolico fu H. Blumer nel 1937, riprendendo proprio le teorie di
Mead all'interno del suo approccio. Secondo tale corrente la realtà sociale è esito
dell'interpretazione e attribuzione di senso dei simboli o segni, creati a partire dalle
relazioni stesse fra gli individui. Inserito in una prospettiva fenomenologica,
l'interazionismo simbolico sostiene la necessità di inserire l'interpretazione e il
comportamento degli individui all'interno della realtà sociale stessa alla quale appartiene, in
quanto è dall'interazione con gli altri membri che nascono i significati attribuiti ad essa.
Ispirato dal nuovo approccio filosofico del XX secolo, il contributo di G. H. Mead, specie nel
suo libro più celebre, “Mente, sè e società", si concentra particolarmente sull'importanza
del sè sociale nella percezione e interpretazione della realtà. Attraverso un processo
comunicativo interno e internalizzato, il sè produce un discorso con l'altro generalizzato
che da forma al "Me", ossia all'individuo sociale. Nell'individuo, tuttavia, vi è anche l' "Io",
ossia l'individualità dell'individuo. Il dialogo che si "produce" all'interno della mente è
dunque un'esperienza sociale che nasce dall'incontro con gli altri, l'interazione, interna ed
esterna, strumento stesso attraverso il quale la realtà acquista significato. L'interazionismo
è stato ed è ancora oggi al centro della sociologia in quanto, ispiratasi alla fenomenologia,
ha fatto da collegamento tra la concezione filosofica e tutto un fiorire successivo di approcci
che hanno guardato alla realtà come effetto di una costruzione sociale, di interazioni e
pratiche, sottolineando come il mondo attorno non possiamo che percepirlo, conoscerlo
attraverso i suoi fenomeni (costruttivismo, costruzionismo, etnometodologia). In sociologia,
la fenomenologia è un approccio nato nella seconda metà del XX secolo, a partire dalle
teorie filosofiche di Edmund Husserl e Alfred Schutz. Secondo The Encyclopedia of
Sociology, la fenomenologia è un metodo filosofico che si sviluppa dall'individuo e dalla sua
esperienza cosciente e che cerca di evitare assunti aprioristici, pregiudizi e dogmi. La
fenomenologia prosegue l'Enciclopedia, esamina i fenomeni nella maniera in cui gli attori li
percepiscono nella loro immediatezza. In altri termini, la fenomenologia è un approccio che
considera i fenomeni della vita quotidiana (il fenomeno è ciò che appare e non ciò che è)
come non scontati, interrogandosi sul modo con cui si guarda e si è nel mondo.
L'approccio caratteristico dello studioso è quindi quello dello straniero, come spiegò
brillantemente nel suo saggio Alfred Schutz, ossia quello di chi vede le situazioni sociali
dall'esterno, come fosse la prima volta. La proposizione principale della fenomenologia,
infatti, consiste nel sostenere che la realtà quotidiana è costruita socialmente a partire da
una conoscenza pratica accumulata, condivisa e data per scontata da una collettività. Il
punto di interesse, allora, è vedere come gli attori definiscono le situazioni, il mondo così
come appare a loro, cercando di "mettere tra parentesi" proprio quelle nozioni culturali a
partire dalle quali gli attori interpretano la realtà stessa. L'eredità più importante lasciata
dalla corrente fenomenologica risiede nei lavori di Garfinkel (etnometodologia) e di Berger
(costruzionismo sociale).
Alfred Schutz, sociologo viennese, deriva la sua formazione sociologica da un attento studio
della metodologia weberiana, della quale compie un riesame critico in base alle istanze
provenienti dalla filosofia intuizionista di Bergson (prevalentemente nelle opere del periodo
giovanile, degli anni 1924-1928, raccolte nel volume Theorie des Lebensformen, curato da
Ilja Srubar), ma soprattutto in base alle istanze della fenomenologia di Husserl, che Schutz
seguirà con entusiasmo sino al 1940 circa, e da cui andrà progressivamente distaccandosi.
L’opera più nota di Schutz, Der aufbau der sozialen welt (tradotto in italiano col titolo La
fenomenologia del mondo sociale) presenta un costante rimando alla fenomenologia
husserliana, ma già vi è evidente una presa di posizione dell’autore che orienta la sua
sociologia fenomenologica al di fuori della fenomenologia trascendentale, mossa verso una
fenomenologia della vita mondana. La fenomenologia è per l’autore un puro metodo; se le
opere precedenti alla fase idealista erano accettate con interesse dal sociologo, la svolta
idealista di Husserl sarà ciò che ne sancisce il distacco definitivo. Come nota Anthony
Giddens, la fenomenologia, assumendo come punto di partenza la soggettività e
l’intenzionalità della coscienza, non riesce ad analizzare il mondo sociale come mondo
oggettivo. Schutz, come Max Scheler, trae il tema dell’intersoggettività dalla produzione
filosofica husserliana, ma si rende conto del fatto che per essere posta nel contesto
sociologico l’intersoggettività deve assumere una connotazione che oltrepassi la mera
soggettività trascendentale. Per analizzare il mondo sociale, intersoggettivo, il sociologo
deve abbandonare l’ortodossia fenomenologica di Husserl. Il sociologo tiene in sospeso
tuttavia la possibilità del cammino trascendentale per almeno vent’anni, in parallelo alla via
dell’atteggiamento
naturale,
prima
dell’abbandono
finale.
La
questione
dell’intersoggettività, che già Scheler aveva posto come indipendente dalla dimensione
trascendentale dell’io – giacché il noi è un’esperienza primaria allo stesso modo dell’io, e
dunque la cognizione del noi che esperiamo socialmente non si riduce alla cognizione di un
io trascendentale – è considerata come preminente per la fondazione di una sociologia
fenomenologica. Ma oltre all’esperienza che nella vita sociale abbiamo del noi, vi è anche
l’esperienza del tu, che è considerata parimenti originaria sia da Scheler che dal sociologo
viennese; anzi, secondo Scheler, la realtà del tu e dunque la realtà di una comunità
sarebbe precedente alla realtà dell’io come datità. Schutz condivide con Scheler la tesi
secondo cui la convinzione dell’esistenza dell’alter-ego non è fondata su atti di cognizione
teoretica. Il sociologo viennese lascia in sospeso “i problemi estremamente difficili relativi
alla costituzione del tu nella soggettività individuale” e scrive: “Non ci chiediamo quindi
come in generale in un io si costituisca un tu, se almeno come possibilità l’autoosservazione preceda l’osservazione dell’alter ego, se “l’uomo” come soggettività
psicologica rinvii ad un ego trascendentale in cui l’alter ego trascendentale sia già
costituito, se e come in forza della costituzione dell’alter ego trascendentale dell’ego
trascendentale sia possibile una conoscenza intersoggettiva di valore generale, ecc. Per
quanto simili analisi siano importanti per la generale dottrina della conoscenza e
conseguentemente per le scienze sociali, possiamo lasciarle fuori dal nostro campo senza
danno per la nostra problematica. Prendiamo quindi come oggetto della nostra analisi
l’uomo nel suo atteggiamento naturale ingenuo”.
► Il “labelling approach” e le nozioni di devianza primaria e devianza secondaria in Edwin
M. Lemert
Edwin M. Lemert e la labelling theory. Lemert, nonostante la sua ritrosia a riconoscersi in
un preciso orientamento sociologico, può esser considerato il precursore di quella corrente
sociologica sviluppatasi negli Stati Uniti a partire dalla fine degli anni cinquanta e che è
andata sotto i nomi, a seconda dei casi, di neo-chicagoans, di west coast school o labelling
theory. Qualunque sia la denominazione scelta tale indirizzo può considerarsi il frutto
dell'insoddisfazione che i suoi esponenti, compreso Lemert, hanno manifestato nei confronti
di precedenti concezioni sulla devianza, in particolare verso quella di impostazione
positivistica e deterministica. L'indirizzo neo-chicagoano, al fine di affermare un diverso
approccio allo studio dei fenomeni devianti parte da una critica e da un rifiuto dei
precedenti modi "correzionali" di studiare la devianza, responsabili di aver ridotto la ricerca
sociale a ricerca intorno alle cause dei comportamenti devianti. Una simile impostazione,
eziologica e correzionale ad un tempo, interferiva pesantemente infatti, secondo i neochicagoani, sulla capacità di comprensione dei fenomeni devianti. I neo-chicagoani, pur
nelle notevoli differenze di approccio che li caratterizzano, portano avanti una distinzione
fondamentale, operata per la prima volta da Lemert, fra "devianza primaria" e "devianza
secondaria". Essi, al contrario dei loro predecessori impegnati nell'individuazione delle
cause di insorgenza del comportamento deviante indicate di volta in volta in fattori
biologici, psicologici, culturali e sociologici, e/o nella costruzione di categorie e modelli
teorici complessi, si concentrano sull'osservazione e sulla descrizione dettagliata del
fenomeno deviante, dando rilievo preminente al processo che presiede al divenire deviante
ed al contributo dato in tale processo dall'azione di quelle istituzioni deputate proprio alla
prevenzione, controllo e repressione della devianza. Lo studio dei sistemi e degli agenti del
controllo sociale diviene dunque, nelle ricerche dei neo-chicagoans, centrale ai fini della
comprensione della devianza. In tali ricerche compaiono concetti come stigma,
degradazione, reazione sociale, mortificazione del sé. Tali nozioni dimostrano come le
istituzioni del controllo sociale diano forma e significato alla devianza, giungendo a
stabilizzarla come devianza secondaria, indicando con quest'ultima quindi la devianza che
consegue alla reazione sociale, all'etichettamento di una persona come deviante realizzato
dagli agenti del controllo sociale. Per questo, nella prospettiva neo-chicagoana viene
operato uno spostamento dalle cause dell'iniziale atto deviante - atto quest'ultimo comune,
privo o quasi di conseguenze nella vita dell'autore perché non inserito in un processo di
definizione e di stigmatizzazione ufficiale - alla reazione sociale. Devianza primaria e
devianza secondaria sono dunque due fenomeni diversi; non tutti i devianti primari (coloro
cioè che compiono comunque un atto che costituisce un allontanamento da certi valori,
norme o costumi dominanti nella società) sono definiti devianti dalle autorità. Da ciò i neochicagoani trassero un'importante, quanto innovativa conclusione: le analisi sociologiche
sulla devianza compiute sulla base delle statistiche ufficiali sono di dubbia validità, in
quanto i tassi ufficiali sul volume e sulla distribuzione dei crimini, della delinquenza, delle
malattie mentali e di altre forme devianti, possono benissimo non corrispondere al volume
reale (primario) della devianza. Lo scopo principale della ricerca dovrebbe essere l'analisi
della reazione sociale, del modo in cui le agenzie di controllo creano esse stesse la devianza
attraverso la stigmatizzazione, l'esclusione e l'isolamento. Queste ultime innescano infatti
un processo psicologico di riorganizzazione simbolica del sé del deviante al termine del
quale egli giunge quasi inevitabilmente ad immedesimarsi nel ruolo attribuitogli.
Il labelling approach, accolto al suo inizio come indirizzo profondamente innovativo, si
colloca in un preciso periodo storico, ovvero fra la fine degli anni cinquanta e gli anni
sessanta. Questi anni segnano per gli Stati Uniti una fase storica importante, di grande
fermento culturale. La scuola neo-chicagoana partecipa di questo clima culturale nel quale
la nuova sinistra americana "tenta il recupero di alternative culturali capaci di riempire di
nuovi valori il vuoto lasciato dal venir meno della pregnanza, in una società orientata ormai
decisamente verso un'economia di consumo, dei valori dell'etica protestante". Il mito
dell'"americanismo", capace fino a quel momento di unificare la composita società
americana, entra in crisi per vari motivi (non ultimo la guerra del Vietnam).
Contemporaneamente, in questo clima di trasformazione, la "preponderante e massiccia
intrusione delle organizzazioni burocratiche" nella vita degli individui, così come la definisce
Lemert, determina una loro dipendenza per la soddisfazione dei propri bisogni, dalle
suddette organizzazioni e più specificamente dallo stato assistenziale. Le teorie sociologiche
elaborate in questo periodo, avvertendo queste "interferenze" sottolineano l'importanza per
i cittadini di riappropriarsi, contro la burocratizzazione, del momento politico-culturale e
dirigono il loro interesse verso le attività di controllo sociale. Matura negli ambienti della
sociologia americana un atteggiamento di sospetto nei confronti degli sforzi compiuti dalla
società organizzata per risolvere il problema della devianza, sforzi che mal si conciliano con
i diritti della persona soprattutto considerando "il grande potere che nella società moderna
è assegnato o viene accaparrato dallo stato o dalle organizzazioni di dimensioni
gigantesche". Contemporaneamente l'attenzione degli scienziati sociali si focalizza sugli
individui, sull'interazione quotidiana e sulle regole che la guidano, andando in secondo
piano ogni considerazione più vasta di natura macrosociale e nella speranza della
ricostituzione di un tessuto sociale nel quale i rapporti fra gli individui siano liberi da ogni
condizionamento. La nuova sociologia della devianza statunitense si concentra sugli stili di
vita, sulla qualità della vita, sulle relazioni interpersonali, astraendosi dal contesto storico
ed economico-sociale come se questo rappresentasse ormai una costante immodificabile. Il
mutamento secondo questi sociologi deve avvenire ad un altro livello, meno elevato, grazie
all'iniziativa autonoma e spontanea di gruppi sociali coagulati attorno agli interessi degli
individui. Gli studi precedenti vennero accusati di scivolare in un semplicistico
determinismo in grado di negare ai soggetti ogni capacità di scelta e di valutazione in un
determinato contesto di azioni e reazioni proprie ed altrui. Riconoscere al soggetto una
capacità critica non significava tuttavia affermare l'esistenza del libero arbitrio.
Quest'ultimo infatti, secondo i neochicagoans, separava la volontà dal contesto, al contrario
la volontà doveva interpretarsi come scelta da collocarsi in un determinato contesto. Per
questo i sociologi dovevano impegnarsi a descrivere i modi in cui i soggetti avanzavano e si
comportavano in tale contesto e specificatamente nel processo del divenire devianti.
Toccherà ancora una volta a Lemert anticipare quello che sarà poi uno dei temi
fondamentali degli studi dei labelling theorists. In uno scritto che appare addirittura nel
1948 egli afferma la necessità di rompere decisamente "con le tradizioni dei vecchi patologi
sociali e di abbandonare una volta per tutte l'idea arcaica, e derivata dalla medicina, che gli
esseri umani possono essere distinti in normali e patologici...i fenomeni sociopatici
diventano semplicemente comportamento differenziato che, in un dato tempo e in un dato
luogo, è socialmente disapprovato, mentre lo stesso comportamento può essere
socialmente approvato in altri tempi e in altri luoghi". Dunque Lemert rifiuta l'idea di
patologia. Essa, a suo parere, ha pesanti implicazioni moralistiche e nessun carattere
scientifico.
Il declino della labelling theory e il distacco di Lemert. Considerata agli inizi degli anni
sessanta come una teoria profondamente innovativa, una decina di anni dopo la labelling
theory aveva già perduto parte della sua credibilità. La si accusava di cadere in quello
stesso determinismo delle teorie sociologiche precedenti che essa aveva così duramente
attaccato. La teoria dell'etichettamento, abbandonando prematuramente la ricerca sulle
cause della devianza primaria e intravedendo nella reazione sociale la spiegazione
automatica della devianza, si prestò ben presto a critiche di eccessivo relativismo,
determinismo, semplicismo, ipercriticismo non costruttivo. La semplificazione e l'evoluzione
cui andarono incontro le idee avanzate già negli anni cinquanta da Lemert, provocarono in
quest'ultimo un allontanamento polemico dal labelling approach, una precisazione delle sue
ipotesi e il tentativo di conquistare nella sociologia americana una posizione autonoma che
sfuggisse ad ogni inquadramento sul piano teorico. Potremmo dire che Lemert ha avuto
l'incontestabile merito di elaborare un'ipotesi sul comportamento deviante profondamente
innovativa, centrata per la prima volta sul ruolo decisivo che le istituzioni e i sistemi del
controllo sociale possono avere, come variabile indipendente, nel processo del divenire
devianti; che tale ipotesi è stata successivamente ripresa da una serie di studiosi che
l'hanno prima sviluppata, poi estremizzata ed infine elevata al rango di vera e propria
teoria sociologica, senza che ne avesse i requisiti, proponendosi piuttosto come un metodo
di analisi volto a restituire l'autentica essenza del fenomeno osservato ed a "demistificare
alcuni degli errori di precedenti teorie sociologiche della criminalità e della devianza di
stampo positivistico". In questo modo è stata persa di vista la valida intuizione di Lemert
che: "L'interazionismo non è assolutamente né una teoria né una spiegazione. Esso si
limita a proporre un metodo di ricerca, affermando che questa analisi dinamica deve
affiancare l'analisi strutturale".
Lemert: la reazione sociale come variabile indipendente nello studio dei fenomeni devianti.
Il concetto di devianza secondaria, e la distinzione fra devianza primaria e secondaria,
rappresentano l'estensione logica di uno studio della devianza compiuto partendo dalla
reazione sociale ad essa e ponendo al centro dell'osservazione, come importante fattore
esplicativo e significativo, il controllo sociale. Lo spostamento all'interno dell'analisi
sociologica dalle origini del comportamento deviante alla reazione sociale ad esso è
compiuto per la prima volta da Edwin Lemert nel 1951 attraverso l'osservazione che: "Noi
partiamo dall'idea che le persone e i gruppi siano differenziati in vari modi, alcuni dei quali
producono sanzioni sociali, rifiuto e segregazione. Queste sanzioni e reazioni di esclusione
da parte della società o della comunità sono fattori dinamici che aumentano, diminuiscono
e condizionano la forma assunta dall'iniziale differenziazione e deviazione". In maniera più
incisiva circa venti anni dopo riconoscerà il suo allontanamento rispetto alla sociologia
tradizionale "che tendeva a rimanere ancorata all'idea che è la devianza a dar luogo al
controllo sociale" arrivando addirittura a sostenere l'idea inversa "e cioè che è il controllo
sociale a dar luogo alla devianza". Questa affermazione non deve tuttavia ingannarci.
Lasciando per un attimo da parte l'intento provocatorio e polemico che la guida dobbiamo
precisare che lo scopo di Lemert non è mai stato quello di dimostrare come la devianza sia
niente più che una creazione artificiale risultato dell'azione dei sistemi di controllo sociale,
quanto piuttosto quello di tenere conto, nello studio di essa, dei processi di definizione ed
interazione che coinvolgono gli individui devianti e le istituzioni deputate al loro controllo.
In particolare Lemert ritiene che l'interazione tra le reazioni sociali al comportamento
deviante e il comportamento stesso sia il fatto che determina in certa misura se l'iniziale
atto non conforme diverrà devianza sistematica o se invece non si ripeterà più. Concetti
come stigmatizzazione, esclusione, degradazione, mortificazione del sé, utilizzati per
indicare la sostanza o le conseguenze della reazione sociale alla devianza, compaiono nelle
opere di Lemert per descrivere come "le agenzie e le istituzioni apparentemente
organizzate in vista di compiti assistenziali, rieducativi, riabilitativi e terapeutici, diano
forma e significato alla devianza e giungano a stabilizzarla come devianza secondaria".
Considerazioni di questo tipo conducono Lemert a operare una distinzione tra devianza
primaria e devianza secondaria basata proprio sull'assunto che il controllo sociale debba
considerarsi una variabile indipendente nello studio delle azioni devianti. Devianza primaria
e secondaria sono due fenomeni diversi. Infatti per devianza primaria si intende l'iniziale
atto deviante collegabile a tutta una serie di fattori sociali, culturali, psicologici e fisiologici.
Esso, anche se socialmente può risultare sgradito, in assenza di una reazione sociale
significativa, presenterebbe implicazioni marginali per lo status e la struttura psichica della
persona. La devianza secondaria invece è quella che consegue all'etichettamento di una
persona come deviante compiuto da agenzie di controllo sociale. Specificatamene la
deviazione secondaria consiste nel comportamento deviante posto in essere in risposta ai
problemi di stigmatizzazione, degradazione, isolamento prodotti dalla reazione sociale. La
reazione sociale - ed in particolare il fatto che la deviazione diventi pubblica e sia
ufficialmente biasimata - secondo Lemert, incide sulla concezione che l'autore dell'atto
deviante ha di sé stesso e del proprio ruolo. Essa darà il via ad un processo psicologico
attraverso il quale il soggetto provvederà ad una riorganizzazione della propria identità,
giungendo alla fine ad immedesimarsi nel ruolo attribuitogli. A questo punto la condotta
deviante diverrà mezzo di difesa, di attacco o di adattamento nei confronti dei problemi
creati dalla reazione sociale stessa. Da questa distinzione Lemert trae un'importante
conclusione: l'interesse principale della ricerca è rappresentato dall'analisi della reazione
sociale e dell'azione dei sistemi di controllo sociale.
Devianza primaria e devianza secondaria. Il concetto di devianza secondaria indica il
passaggio a status degradati a seguito di una reazione sociale prima informale e poi estesa
e formalizzata nelle azioni degli agenti del controllo sociale. Tale passaggio, sostiene
Lemert, determina dei cambiamenti nella struttura psichica del soggetto. Progressivamente
e nel quadro di un processo continuo di interazione sociale, la devianza muta
qualitativamente fino a stabilizzarsi entro ruoli sociali ben definiti. Prima di descrivere come
e perché secondo Lemert questo passaggio avviene è opportuno premettere che
l'importanza attribuita in una simile analisi sociologica ai processi di definizione ed
interazione sociale deriva dall'applicazione e dallo sviluppo, operato da Lemert, di alcuni
aspetti teorici fondamentali dell'interazionismo simbolico: corrente questa al tempo stesso
psicologica, filosofica e sociologica. Infatti proprio nell'ambito della distinzione fra devianza
primaria e secondaria gli insegnamenti di George Herbert Mead, il maggiore esponente
dell'interazionismo simbolico, hanno dato i loro maggiori frutti ed hanno trovato la loro
massima utilizzazione e dimostrazione. Lemert per primo riteneva di dover spiegare la
devianza in termini di processo sociale; per lui l'essere definiti e etichettati come devianti
costituiva una fase importante di un processo d'interazione sociale più generale teorizzato
proprio dall'interazionismo simbolico. Le premesse fondamentali dell'interazionismo
simbolico possono essere così sintetizzate:
a) la persona è il prodotto di un'interazione ed il sé è da vedersi come una costruzione
sociale, il modo in cui agiamo e ci percepiamo come individui è in parte il risultato di come
gli altri ci trattano. Dunque è probabile che se qualcuno ci vede diversi noi stessi siamo
inclini a pensarci diversi ed a comportarci in modo effettivamente diverso;
b) il comportamento umano non è predeterminato quanto costruito attraverso continui
processi interattivi. Esso non è causato soltanto da forze interne (per esempio istinti,
pulsioni o bisogni) o da forze esterne (ovvero sociali), ma da un qualcosa che sta a metà
tra queste due forze: un'interpretazione cosciente e socialmente derivata di stimoli interni
ed esterni.
Questa impostazione di natura psico-sociologica risulta evidente laddove Lemert sostiene
che l'interesse principale del sociologo deve consistere nell'accertare attraverso quali
procedimenti l'individuo, etichettato come deviante dalla collettività o da un'agenzia
preposta all'esercizio del controllo sociale, arrivi a mutare la concezione del proprio sé e
giunga a percepirsi come deviante, diventandolo progressivamente anche nei fatti. Ma
come e quando si realizza il passaggio dalla devianza primaria alla devianza secondaria? In
un primo tempo (1951) Lemert propone una versione piuttosto rigida della sequenza delle
interazioni che conducono allo stabilizzarsi della devianza, descrivendola quasi come un
processo i cui stadi l'individuo si trova costretto a percorrere in una precisa successione.
Questi stadi sono:
1) una devianza primaria, ossia un primo atto deviante;
2) sanzioni sociali;
3) un'ulteriore devianza, che Lemert definisce ancora primaria;
4) sanzioni sociali e rifiuti più forti;
5) un'ulteriore deviazione, accompagnata da crescente ostilità e risentimento indirizzati nei
confronti di coloro che mettono in atto le sanzioni;
6) crisi del quoziente di tolleranza, espressa in un'azione formale di stigmatizzazione del
deviante ad opera della comunità;
7) rafforzamento della condotta deviante in risposta alla stigmatizzazione ed alle punizioni
sociali;
8) definitiva accettazione dello status sociale di deviante e tentativi di adattamento al ruolo
relativo.
La distinzione fra devianza primaria e devianza secondaria ha proprio lo scopo di
differenziare (e mantenere una separazione fra) il comportamento deviante percepito come
una normale variazione (un problema di vita quotidiana dunque facilmente gestibile e
riassorbibile ed interpretabile in termini di motivazioni iniziali di varia natura
indipendentemente dalla reazione della società), ed il comportamento deviante che al
contrario, in risposta alla reazione sociale suscitata, conduce il soggetto ad organizzare la
propria esistenza ed identità tutta intorno alla devianza, innescando un processo sociale di
mutamento di status e di ruolo. Il problema che in quest'ultimo caso si pone Lemert è
proprio quello di analizzare come la prolungata esecuzione di un ruolo possa produrre
cambiamenti nell'identità e nel sé e contribuire ad una stabilizzazione della devianza. Il
compito del sociologo è a suo parere proprio quello di studiare tale processo prendendo in
considerazione i modi e le circostanze attraverso le quali viene attribuito ad un atto
deviante un significato negativo ufficioso ed ufficiale. Tale attribuzione prende le mosse da
reazioni sociali informali di indignazione morale, rifiuto ed umiliazione, e si conclude
nell'azione formale della comunità volta ad esercitare un controllo (implicante una
limitazione di libertà, un isolamento ed una stigmatizzazione) sull'atto deviante. In secondo
luogo lo scienziato sociale dovrebbe soffermare la sua attenzione sul fatto che in seguito
all'attribuzione di tale significato negativo venga assegnato al soggetto un particolare
status sociale degradato. L'effetto di una simile attribuzione è quello di mutare l'ambiente
simbolico ed interattivo circostante: quando gli altri decidono che una persona è
indesiderata, pericolosa o moralmente inaffidabile, si comportano nei confronti di questa
persona in modo spiacevole, o comunque diverso. Inoltre, al di là e al di sopra di un simile
atteggiamento assunto dalle persone "comuni" che entrano in contatto con il soggetto, vi è
l'azione delle forze del controllo sociale che definiscono e classificano la persona e che,
restringendo l'accesso alle ricompense ed alle gratificazioni, ponendo limiti all'interazione
sociale, e collocando i devianti in ambienti segregati e particolari, determinano
un'alterazione della struttura psichica del soggetto e danno luogo ad una nuova
organizzazione dei ruoli sociali e degli atteggiamenti nei confronti del sé. Viene portato
avanti dunque, ad un duplice livello, formale ed informale, un processo di stigmatizzazione,
ovvero un processo che conduce a contrassegnare pubblicamente delle persone come
moralmente inferiori mediante etichette negative, e che porterà alla costituzione di una
"globale identità deviante" al momento in cui si diffonderà ed eserciterà pubblicamente.
Il concetto di devianza secondaria applicato ai comportamenti devianti. Il concetto di
deviazione secondaria viene utilizzato da Lemert in numerose ricerche per richiamare
l'attenzione sull'importanza che "la reazione da parte della società assume circa l'eziologia
della devianza, le forme in cui questa si manifesta e lo stabilizzarsi di essa in ruoli sociali
devianti". Le indagini più significative condotte da Lemert a questo proposito vertono sulle
forme di devianza collegate ai disturbi mentali (compiute a partire dal 1946 fino agli anni
sessanta), alla falsificazione di assegni (nel decennio 1950-1960), all'alcolismo (nel corso
degli anni sessanta), alla balbuzie (iniziate negli anni cinquanta e riprese durante gli anni
sessanta).
► Gli Outsiders di Becker.
Per gli scommettitori è facile, “outsiders” è un termine tecnico che designa le sorprese
attese: le squadre non favorite ma comunque non escluse dai pronostici, i cavalli un po’
stracchi o troppo giovani che però ce la potrebbero anche fare a piazzarsi, il ciclista che se
non piove e non fa freddo in salita va come un treno etc. I professori universitari a volte
non conoscono la parola, ma è raro non ne abbiano sperimentato un suo significato: nel
loro caso, “outsiders” indica gli studiosi dilettanti che alle conferenze fanno domande
troppo difficili, gli esegeti in proprio del pensiero marxiano o della civiltà indiana che a volte
paiono saperne più di Balibar o di Dumont. Se poi vogliamo focalizzarci, come nel nostro
caso, sul significato di “outsiders” per chi studia la società, entriamo in acque dai moti
ondosi particolarmente accentuati. Si tratta di una parola-chiave, certamente, e come tutte
le parole-chiave appare fortemente equivoca. Cavalcando l’onda del classico Outsiders di
Howard S. Becker, cercheremo di capire perché questa parola sia così decisiva, prendendo
in esame anche declinazioni meno classiche ma più rivelatrici della sua attuale vita sociale.
Se una specifica elaborazione del problema della doppia contingenza deve accompagnare
qualsiasi lavoro che si voglia “sociologico”, il lavoro di Becker è classicamente sociologico.
Becker non fa che estendere questa problematica alla genesi e all’applicazione della parola
“outsiders”. Il termine ha corso in particolari casi di interazione a doppia contingenza,
resistenti alla stabilizzazione: “Quando una norma è imposta, la persona che si presume
l’abbia infranta può essere vista come un individuo particolare, che non si può essere sicuri
viva secondo le regole concordate dal gruppo. Tale tipo di persona è considerato come un
outsider”. La parola “outsiders” non si limita a indicare la presenza di un problema di
coordinamento delle interazioni: è anche un modo per risolverlo. Il lavoro sociale della
parola “outsiders” sta proprio nel riunire in un’unica classe individui dal comportamento
deviante, standardizzandoli e rendendoli così prevedibili. Il punto su cui Becker attira
l’attenzione è che, come tutte le azioni, anche l’atto del classificare si colloca entro una
struttura a doppia contingenza: “la persona cui viene attribuita l’etichetta di outsider può
avere un altro punto di vista sulla questione. Può non accettare la norma in base alla quale
è giudicata, e non ritenere coloro che la giudicano competenti o legittimamente qualificati a
farlo. Emerge allora un secondo significato del termine: il trasgressore della norma può
considerare i suoi giudici come outsiders”. Nei termini sociologici che stiamo usando,
Becker dice qui un’ovvietà, solo che la riferisce a un tabù: che Alter possa agire in maniera
non corrispondente alle attese di Ego è il primo problema che sorge se si guarda il mondo
con occhi sociologici; il fatto è che questa prospettiva non viene estesa all’atto del
classificare. Becker non intende produrre una contro-teoria della devianza. Quelle che
vengono presentate sono delle incursioni etnografiche in mondi devianti (in particolare,
consumatori di marijuana e musicisti di musica da ballo), in relazione alle quali le riflessioni
appena riproposte costituiscono la necessaria, ma non troppo impegnata, cornice di
legittimazione. Dal punto di vista operativo, Becker costruisce una specie di “quadrato della
devianza”. La nozione di “carriera deviante” indica l’esistenza di incroci tra condizioni
oggettive e scelte individuali. Tale prospettiva evidenzia la contingenza della condizione di
chi conduce un’esistenza radicalmente deviante e rende conto dei casi di devianza
transitoria, per esempio quei giovani delinquenti che a un certo punto cambiano vita. Il
lavoro di Becker ha il merito fondamentale di gettare luce sull’intrinseca riflessività della
categoria di “outsiders”: chi considera l’altro un “outsider” può essere giudicato dall’altro
come un “outsider”. La reciprocità del giudizio di “essere outsiders” non significa affatto che
le due categorie si trovino sullo stesso piano: entro la processualità della classificazione
reciproca agisce un’asimmetria reale che inchioda i veri outsiders, cioè i veri devianti.
Il grande interesse della parte etnografica del libro di Becker sta nel farci vedere le cose da
una prospettiva rovesciata: sentiamo parlare le persone di cui di solito si parla, e li
sentiamo parlare di quelli che di solito parlano di loro. Peraltro, all’interno di questa
dialettica di azioni e reazioni viene lasciata in secondo piano quella vastissima zona grigia
costituita da coloro che, nello schema quadripartito di Becker, sono etichettati come
“conformi”. Si tratta di quegli individui che non sono devianti ma non è detto siano degli
imprenditori morali o dei loro sostenitori: i conformi seguono le norme ma più per inerzia
che per convinzione. In altri termini, la tesi qui avanzata è che tale rovesciamento dia i
frutti migliori quando si tratta di rintracciare, sotto la maschera della conformità, il
comportamento segretamente deviante, i piccoli affari sporchi che tanti fanno ma nessuno
dice. Questa prospettiva, però, se pure crea lo spazio logico per situare il comportamento
“conforme”, cioè quello di chi non commette atti potenzialmente devianti né viene accusato
di averli commessi, ha il difetto di scambiare spesso tali individui per sostenitori attivi
dell’ordine normativo esistente. Quella che pare essere postulata, così, è una continuità
reale che unisce conformi a imprenditori morali. La legittimità di questa connessione
apparirebbe, con ogni probabilità, molto meno ovvia, se solo si ascoltassero i “conformi”
con la stessa attenzione con cui Becker ascolta i “devianti”. Qui ci si focalizzerà su un caso
di conformità che Becker non considera: capire i motivi di questa mancata messa a fuoco ci
aiuterà a chiarire i limiti della nozione di devianza in esame. Forse proprio la difficoltà di
configurare una prova all’altezza della “città per progetti” può aiutarci a definire i limiti
della forma devianza. In effetti, l’insostenibilità sociale di un capitalismo che valorizza la
rete e il sapere non si vede guardando i devianti, ma gli esclusi: chi non è abbastanza
connesso e non ha sufficiente istruzione, resta fuori. In questo caso, chi è out non ha fatto
nulla di deviante: non si tratta più, come nello schema di Becker, di persone ingiustamente
accusate per via di errori o pregiudizi, ma semmai di esclusi senza colpa. Così, se prima
abbiamo toccato l’enigmaticità del conforme qualunque, che non devia dalle norme ma non
è detto le abbia fatte proprie, ora va almeno indicato il dilemma dell’escluso qualunque,
che non trasgredisce nulla ma è in isolamento a tempo indeterminato. La parola
“outsiders”, in quanto vettore di scambi di prospettiva e di ruolo, è una categoria che
sembra impegnare l’osservatore. Nell’ammettere che il deviante e l’escluso possono essere
altrimenti, che non si tratta di parti esterne alla società ma di suoi prodotti, in ogni caso
portatori di un altro sapere sulla e della società, l’osservazione tende ad assumere un
valore che è anche politico e morale. Così, quando qualifica il proprio atteggiamento verso
gli internati psichiatrici come un piccolo risarcimento per la condizione in cui erano stati
tenuti, Erving Goffman porta allo scoperto il non detto politico che è al fondo non solo di
una certa sociologia “critica”, ma di quasi tutte le varietà che, di fatto, compongono il
catalogo delle opzioni sociologiche e antropologiche.
► L’approccio dell’etnometodologia
L'etnometodologia è una scuola sociologica in dissenso con la tradizione ufficiale. Il suo
fondatore è stato Harold Garfinkel, infatti la pubblicazione nel 1967 dei suoi Studi
etnometodologici è considerata l'atto fondante di questa nuova scuola. Il nome sta ad
indicare l'insieme dei metodi di cui i membri di un gruppo etnico si servono per
comprendere la loro stessa attività e Garfinkel lo ha coniato per assonanza con il termine
etnobotanica, usato dai botanici per indicare l'insieme dei metodi che un gruppo etnico
utilizza per comprendere la botanica. Per elaborare i principi su cui si basa la scuola
etnometodologica, Garfinkel ha preso ispirazione dalle teorie di Edmund Husserl, di Alfred
Schutz, da alcuni presupposti del funzionalismo di Talcott Parsons e dalle teorie
dell'interazionismo simbolico. L'etnometodologia costituisce una presa di posizione critica e
polemica nei confronti della sociologia ufficiale. Presupposto dell'etnometodologia è, infatti,
che la spiegazione scientifica, così come ogni altra forma di spiegazione, è comprensibile
solo in riferimento alla situazione specifica in cui è espressa. La sociologia ufficiale, invece,
ha come obiettivo giungere a spiegare in modo oggettivo l'agire sociale prescindendo dal
suo contesto, infatti, sin dalla sua origine, un problema cruciale che la sociologia ha cercato
di risolvere è quello dell'oggettività della conoscenza scientifica ed in particolare della
conoscenza scientifica nell'ambito delle scienza sociali. Quando l'espressione osservazione
partecipante compare per la prima volta negli scritti di alcuni antropologi, designa i
resoconti degli amministratori coloniali, i quali erano dei testimoni in qualche modo
privilegiati, comunque partecipanti, con uno specifico ruolo, alle vicende della cultura
descritta. I primi a praticarla, per come oggi noi la intendiamo, furono Boas e Malinovski,
padri dell'etnografia moderna, ma essi non usarono quell'espressione a designare l'opzione
metodologica compiuta. Nell’osservazione partecipante il ricercatore si cala in una
situazione, in un contesto culturale, in un gruppo sociale e ne diviene in qualche modo
parte, instaurando rapporti interpersonali coi soggetti che di quella situazione, di quel
contesto, di quel gruppo fanno parte. Provvede a registrare i fatti che osserva,
interpretandoli al fine di darne un senso. Volendo dare una sintetica definizione diremmo:
l'osservazione partecipante indica le osservazioni prolungate fatte sul campo da un
ricercatore che partecipi alla vita dei gruppi studiati. L'osservazione partecipante non
esclude l'utilizzazione oltre che degli strumenti costituiti da conversazione e colloquio anche
l'uso di materiali scritti a valenza etno-sociologica, quali registri, verbali, lettere personali,
autobiografie, diari, ecc.
Diversa è l'interpretazione del costrutto offerta da Blumer, esponente della Scuola di
Chicago, tuttavia profondamente influenzato dall'interazionismo simbolico. L'osservazione
che fa lo studioso deve essere la più oggettiva possibile. Partecipare non significa entrare in
una situazione e far valere la propria soggettività. Partecipare piuttosto significa avere la
capacità di farsi un'idea di come in una situazione sociale gli attori che ne fanno parte la
interpretano e la agiscono. Sentire come si fosse dentro una situazione, senza veramente
entrarci, per conservare lucidità e capacità effettiva di lettura. Nell'ambito
dell'etnosociologia l'osservazione partecipante è una sorta di rito di passaggio. In quanto
tale prevede una fase delicata che è l'entrata la quale deve essere opportunamente
negoziata. Segue poi il soggiorno nella comunità da studiare e infine un'uscita dal campo,
che è parte integrante del processo, in cui avviene eventualmente la restituzione dei
risultati alla comunità. Durante la permanenza il ricercatore innanzitutto procederà alla
osservazione, si avvarrà della conversazione, del colloquio e dell'intervista, più o meno
strutturata, raccoglierà delle informazioni, prenderà visione di documenti ufficiali e privati,
che indagherà o meno sulla base di un protocollo idoneo a produrre osservazione
sistematica. Si tratta di un'interazione non superficiale con i soggetti studiati con raccolta
ordinata di dati. Possono diventare oggetto di studio le interazioni sul campo tra ricercatori
ed attori. Prima però di arrivare ad osservare il suo oggetto di indagine, il ricercatore deve
farsi ammettere. Egli deve riuscire ad agganciare chi nel gruppo ha l'autorevolezza
adeguata a legittimarlo nella sua funzione di osservatore. (Negoziazione dell'ingresso)
Succede che dopo che il ricercatore ha acquisito in qualche modo il diritto di accedere ad
una situazione, debba costantemente negoziare e rinegoziare la sua presenza, e ciò
durante l'intero periodo in cui si svolge la ricerca. L'accesso sul campo si acquista non tanto
nel momento in cui formalmente si è ammessi ad osservare, ma il momento in cui i
membri del gruppo cominciano a fidarsi e ad aprirsi realmente al ricercatore. Woods, un
etnografo scolastico, ha descritto tutto il suo negoziato d'entrata in una scuola che egli
intendeva studiare. In un primo momento la scuola gli si presenta sotto il suo aspetto
migliore. Le persone cioè si comportavano come nelle migliori occasioni, come quando
venivano gli ispettori o c'erano le giornate di apertura dell'istituzione al pubblico. Ma poi le
attenzioni nei suoi confronti diminuirono, gli insegnanti cominciarono a preoccuparsi meno
di lui e con ciò diminuì pure l'autocontrollo. La sua libertà aumentò, ma certi spazi
continuavano ad essergli interdetti, per esempio non era ammesso ad assistere a certe
lezioni, a certe riunioni. Veniva insomma ancora mantenuta una certa distanza. Nella terza
fase fu ammesso a riunioni riservate in cui venivano prese decisioni importanti. Le persone
cominciarono a confidare le loro speranze, i loro timori, le loro angosce. Tuttavia il
progresso non fu omogeneo, nel senso che poteva capitare che con certi attori avesse più
confidenza, con altri meno. Cosa significa propriamente partecipare? Significa entrare a far
parte di un processo di partecipazione, cioè di un sistema relazionale. L'osservatore deve
sforzarsi di integrarsi nel gruppo, deve vivere cioè il più possibile come le persone del suo
campo di indagine, ma senza dare l'impressione di imitarle. Non per ciò deve avvenire una
conversione totale al modo di vita del gruppo studiato, è sufficiente integrarsi in alcune
attività e in altre mantenere la propria identità di ricercatore. Questi deve essere percepito
come qualcuno a cui si possano confidare delle cose, qualcuno da rendere partecipe dei
propri sentimenti. Anche per questa ragione bisogna evitare relazioni troppo strette con
alcune persone, almeno sino al momento in cui non si sia acquisita una conoscenza precisa
delle relazioni presenti nella situazione osservata.
Adler e Adler presentano tre tipi di implicazione del ricercatore nell'oggetto del suo studio:
partecipazione periferica, partecipazione attiva, partecipazione completa. Nell'osservazione
partecipante periferica i ricercatori ammettono che sia necessario un certo grado di
implicazione per cogliere dall'interno le attività delle persone, la loro visione del mondo,
ecc., ma non ritengono importante essere collocati nel mezzo delle attività, è più utile ritengono - mantenersi ai margini: non assumono, cioè, nessun ruolo importante nella
situazione studiata. Il ricercatore può scegliere una posizione periferica perché una
implicazione più profonda lo metterebbe in conflitto con se stesso, come per esempio
quando debba trovarsi a studiare gruppi sociali devianti o gruppi sociali di cui non condivida
alcune pratiche. L'osservatore partecipante periferico entra nel gruppo e ne esce
liberamente, la sua presenza è sporadica. Nell'osservazione partecipante attiva il
ricercatore si sforza di acquisire uno status all'interno del gruppo o dell'istituzione che
studia. Questo status gli permette di partecipare attivamente alle attività come un
membro, mantenendo tuttavia ancora una certa distanza. Una osservazione partecipante
attiva ha una criticità nel mantenersi osservazione partecipante e nel non diventare altro
(ad esempio una ricerca-azione o una ricerca-intervento). In altri termini come si può
essere attivi e insieme osservatori e non cioè agenti di cambiamento? La partecipazione
attiva, per tale ragione, è stata qualificato come un intervento mascherato. Il ricercatore
che entra in una situazione con uno status non ha problemi di ingresso, ma poi una volta
che è dentro la situazione rischia di diventare parte della situazione, vive i conflitti che
vivono gli attori col medesimo ruolo ed entra nelle dinamiche relazionali che possono
vedere categorie di attori in conflitto. Si immagini il caso di un ricercatore, che entri a
studiare una situazione assumendo il ruolo di docente: egli avrà difficoltà a ricostruire il
punto di vista autentico degli studenti rispetto alla situazione. Terzo tipo di partecipazione è
quella completa. Essa può essere tale o per una appartenenza preliminare del ricercatore
alla situazione studiata, ovvero può derivare da una conversione. Nel primo caso il
ricercatore si avvale dell'opportunità di indagare a partire da uno status già acquisito nella
situazione, nel secondo caso, il ricercatore, prima estraneo alla situazione,
successivamente diventa interno ad essa. Quando la partecipazione è completa il
ricercatore è o diventa l'oggetto che egli studia. L'osservatore che si reca sul campo deve
dichiarare o non deve dichiarare di essere un ricercatore che ha precise finalità di studio,
che si propone certi obiettivi, ecc.? Molti studiosi ritengono che la risposta a questa
domanda sia una sola: il ricercatore deve dichiarare in maniera esplicita alle persone che
intende studiare la propria identità professionale. Altri sono più possibilisti ed ammettono
che in talune circostanze è più opportuno procedere nascondendo tale identità. Il
ricercatore in questo caso agirà sotto copertura, non dichiarerà, entrando nella situazione,
il vero motivo della sua presenza. Spesso il ricercatore, entrando a studiare un gruppo o
una comunità, si trova ad essere coinvolto in conflitti interni al gruppo o alla comunità
stessa. Egli si trova in situazioni di oggettiva difficoltà perché viene sollecitato a prendere
parte, ma egli deve resistere, pena la perdita della sua credibilità scientifica. Tuttavia i
conflitti non vanno evitati in quanto essi fanno parte della realtà studiata e quindi vanno
documentati. D'altro canto durante i conflitti emergono alcune caratteristiche della
situazione che altrimenti rimarrebbero inattinte. Nei momenti di crisi le persone sono più
propense ad aprirsi, rivelare dettagli, a fare confidenze. L'osservazione partecipante, che,
come abbiamo visto, può prevedere diversi gradi di implicazione pone una domanda a cui
appare difficile rispondere. Come si può essere insieme implicati e trovare la giusta
distanza che consente di svolgere una ricerca adeguata? Come può il ricercatore evitare di
diventare egli stesso un indigeno?
Queste domande sono state rivolte all'etnografia in maniera pressante dalla sociologia
standard, tanto da costringere l'etnografia sulla difensiva in ordine alla necessità di
dimostrare la sua scientificità. Fin sul termine degli anni Cinquanta la ricerca etnografica
parlava, non a caso, ancora del campo come "verifica delle ipotesi". Successivamente,
liberandosi dalla soggezione alla sociologia standard, l'etnografia ha potuto sostenere di
non avere la necessità di avvicinarsi al campo avendo preventivamente formulato delle
ipotesi di ricerca da riscontrare, in quanto è proprio della ricerca etnografica produrre le
proprie ipotesi cammin facendo. Qual è la differenza tra osservazione partecipante e
ricerca-azione? La principale differenza è nel fatto che la ricerca-azione intende produrre
dei cambiamenti, chiamando gli attori di una situazione a diventare esaminatori critici della
stessa, prospettando percorsi di progettazione partecipata del cambiamento.
L'osservazione partecipante può essere qualificata come un "incontro sociale", anch'esso a
sua volta indagabile con gli strumenti messi a disposizione dalla sociologia. Come si pone il
ricercatore nei confronti del soggetto che osserva, col quale intrattiene un dialogo? Qual
grado di interazione e perché il ricercatore decide di stabilire con la situazione esaminata?
► Goffman: l’interazione consapevole e gli adattamenti secondari
Nel 1955 Erving Goffman si trasferisce nel manicomio di St. Elizabeth a Washington per
studiare il comportamento di pazienti, infermieri e medici. Ci resta diciotto mesi, in
incognito, prende appunti, frequenta ambulatori, corsie, stanze, aree comuni, scantinati,
cucine, magazzini. S'interessa in particolare degli scambi legali e illegali tra pazienti, delle
loro relazioni reciproche, delle interazioni con il personale medico e paramedico, delle
cerimonie d'ingresso, orari, cibo, curiosa tra gli oggetti personali dei degenti:
soprammobili, abiti, libri, mazzi di carte. Goffman ha trent'anni; è nato in Canada da una
famiglia di ebrei ucraini, immigrati negli anni Venti; ha studiato prima chimica, poi si è
interessato di cinema, infine si è laureato in sociologia prima a Toronto, poi a Chicago.
Mobile, curioso, osservatore acutissimo - i compagni di corso lo hanno soprannominato
"stiletto" - prima di arrivare nel manicomio St. Elizabeth, per la sua tesi di dottorato ha
condotto una ricerca sul campo per due anni nell'Isola di Unst, nelle Shetland, dove si è
finto uno studioso americano interessato alle tecniche agricole; in realtà, di nascosto, ha
studiato la struttura sociale della comunità. Goffman legge di tutto: sociologia, filosofia,
psicologia, narrativa, trattati medici, autobiografie. Asylum, il suo secondo libro (il primo è
La vita quotidiana come rappresentazione, il Mulino); esce nel 1961 e ha un impatto
notevole non solo sugli addetti ai lavori, ma anche sul pubblico dei lettori colti americani. Il
volume rende popolare una formula che condensa il senso dello studio: istituzione totale. Il
concetto non è suo. Tuttavia sono la genialità e la capacità descrittiva di Goffman a
renderla popolare nella cultura americana ed europea degli anni Sessanta. Egli è
probabilmente il più importante sociologo della seconda metà del XX secolo e i suoi libri si
leggono con piacere proprio perché innervati da una prosa fluente, ricchissima d'esempi,
capace di ridurre al minimo l'apparato concettuale, senza rinunciarci. Goffman è un occhio
che guarda e osserva, ma anche un catalogatore d'eccezione. Le istituzioni totali sono quei
luoghi, quegli spazi chiusi, in cui sono segregati gli incapaci non pericolosi (ciechi, vecchi,
orfani o indigenti), gli individui pericolosi per la comunità (sanatori, ospedali psichiatrici,
lebbrosari), quelli altamente pericolosi o ritenuti tali (prigioni, penitenziari, campi di
prigionia, lager), ma anche le istituzioni create per svolgere in un luogo concentrato alcune
attività (caserme, navi, collegi, campi di lavoro, piantagioni coloniali) o in cui ci si isola
volontariamente dal mondo (abbazie, monasteri, conventi, chiostri). L'idea da cui parte lo
studioso americano è che normalmente nella vita moderna gli uomini tendono a dormire,
lavorare, frequentare persone, divertirsi in luoghi diversi sotto differenti autorità, seguendo
schemi razionali tra loro diversi (pur essendo la stessa persona, ci si comporta in un modo
in ufficio e in un altro in un bar o locale notturno). L'istituzione totale unifica invece in un
medesimo luogo e sotto un'unica autorità tutte queste attività quotidiane, abolendo quella
sorta di "personale economia d'azione" che noi identifichiamo con la libertà individuale.
Nella vita contemporanea quasi nessuno di noi deve continuamente guardarsi le spalle per
vedere se è oggetto di critiche o di osservazioni, scrive Goffman. O almeno, esistono ambiti
in cui questo controllo ha termine. La conseguenza pratica è che esiste una distanza tra il
proprio ruolo e il pubblico di fronte a cui lo si recita, evitando in tal modo che affermazioni
o dichiarazioni su se stessi, in una particolare sfera di attività (per esempio nella seduzione
di un individuo dell'altro sesso, oppure nel gioco sportivo o d'azzardo) vengano confrontate
con il comportamento in altre situazioni (il lavoro). La piccola rivoluzione compiuta dalla
sociologia di Goffman, sia nell'indagine del comportamento in pubblico sia in quella di un
mondo separato come l'ospedale psichiatrico, è quella di attribuire un'importanza decisiva
ai rituali, alle "rappresentazioni" che forniamo agli altri o che gli altri ci offrono, piuttosto
che alle motivazioni recondite o alle cause. Lo studioso indaga le valenze psicologiche,
quanto i comportamenti esteriori. Il self è il risultato di una recita, e il testo di questa recita
è prodotto dalle interazioni tra gli attori. C'è nel sociologo una naturale attitudine
all'osservazione etologica, che non gli impedisce di interrogarsi sulla "natura umana" per lui
oggetto di indagine culturale e rituale piuttosto che morale o filosofica. Alcune pagine di
questo Asylum fanno pensare a quelle Se questo è un uomo, in particolare là dove tratta
del mondo dell'internato e delle prove iniziatiche cui si è sottoposti in un ospedale, un
convento, un campo di concentramento. Pagine analitiche, ricche di osservazioni e di
informazioni sulle tecniche utilizzate per privare uomini e donne del "corredo della loro
identità". In Asylum, libro tradotto da Franca Basaglia nel 1968 presso Einaudi, viene
messo in evidenza come proprio nelle istituzioni che scarnificano fino all'osso l'esistenza
umana, noi possiamo vedere con più chiarezza quello che le persone fanno per
sopravvivere, le tecniche che usano "per preservare le riserve del sé dalla morsa
dell'istituzione". Sono quegli "adattamenti secondari", come li definisce il ricercatore
americano, che l'individuo usa per mantenere una certa distanza, per aprirsi letteralmente
a gomitate uno spazio fra sé e gli altri che tendono a identificarlo. Chiunque abbia
frequentato un ospizio per anziani o un ospedale per lungo degenti, troverà nelle pagine di
Goffman una descrizione esatta, spietata, lucida e a tratti persino affascinante sulla lotta
che là si compie fino all'ultimo per restare liberi. La libertà, ci dice questo testo
fondamentale, non è qualcosa di astratto, ma di concreto. E' solo "lottando contro qualcosa
che il sé può emergere"; ma anche che senza qualcosa cui appartenere, non esiste
sicurezza per il sé. Tuttavia "l'inglobamento totale e il coinvolgimento con una qualsiasi
unità sociale, implica una riduzione di sé". E' un difficile equilibrio, in cui non servono
grandi strategie, ma piccole tecniche con cui resistere alla pressione: "Il nostro status è
reso più resistente dai solidi edifici del mondo, ma il nostro senso, d'identità personale,
spesso risiede nelle loro incrinature".
► Come si diventa devianti nell’approccio naturalistico di Matza.
La Devianza Minorile e il Paradigma Sociologico. La figura di David Matza occupa senza
alcun dubbio un posto di rilievo nel settore della devianza adolescenziale e, anche se il suo
lavoro appare difficilmente catalogabile, egli è molto vicino a quel gruppo di studiosi,
chiamati generalmente labeling theorists, i cui principali esponenti sono Lemert, Becker,
Cicourel e Goffman. Ovviamente, presi singolarmente evidenziano delle notevoli differenze
di approccio, anche se uniti sotto una duplice bandiera, frutto degli studi di Lemert: la
devianza primaria e la devianza secondaria. Per devianza primaria intendiamo un
"allontanamento più o meno temporaneo, più o meno marginale, eseguito con più o meno
determinazione da certi valori, norme o costumi dominanti nella società" (Matza, 1969). Da
tali atti nessuno è escluso, in effetti tutti ne compiamo occasionalmente e durante tutto
l'arco della vita. Al contrario, più rilevante è la devianza secondaria, che consegue
all'etichettamento (labeling) di una persona come deviante da parte da agenzie di controllo
sociale. Le due tipologie di devianza non necessariamente coincidono; in altri termini
possono apparire come due fenomeni diversi, poiché non tutti i devianti primari sono
definiti devianti dalle autorità, mentre alcuni devianti secondari non sono affatto devianti
primari. Da questa semplice distinzione, i labeling theorists traggono tre importanti
riflessioni:
a) Le analisi strutturali compiute sulla base di diversi tassi di devianza sono, nel migliore
dei casi inesatte; inesatte nel senso che ciò che viene comparato sono i tassi di devianza
ufficiali, che possono non corrispondere al volume reale (primario) della devianza;
b) La seconda riflessione è che il reale problema sociologico non consiste nello studio
dell'ammontare della devianza, ma il modo in cui le agenzie di controllo creano esse stesse
la devianza;
c) Un ultima riflessione è che lo scopo primario della ricerca dovrebbe essere l'analisi della
reazione sociale, cioè dell'esclusione, del confinamento e della riorganizzazione simbolica
del self del deviante.
Intorno agli anni '70, però, la labeling theory, inizialmente considerata come una vera e
propria forza innovatrice, iniziò a perdere il suo fascino. Essa in effetti era divenuta quasi
altrettanto deterministica della teoria strutturale che aveva all'inizio attaccato. A ciò si
aggiungeva l'abbandono prematuro della ricerca delle cause strutturali della devianza, che
la riduceva di frequente ad operare nello spazio di un ragionamento apparentemente
logico, ma in realtà falso e subdolo (per esempio, "è deviante chi è definito come tale"). In
effetti, questo stato di cose andava ad adottare una prospettiva, lontana dal contributo e
legame creato da Durkheim, tra analisi della devianza ed analisi della società globale.
David Matza, pur ispirandosi in gran parte alla tradizione dei labeling theorists (denominati
anche neo-chicagoans), da un lato rivendica la tradizione della psicologia sociale meadiana
e la grande importanza che essa attribuiva alla coscienza dell'attore, dall'altro elaborando
una prospettiva naturalistica, il cui fondamentale assunto metodologico consiste nella
fedeltà alla complessità del fenomeno studiato senza cedimenti a tentazioni riduttive.
David Matza e la seconda generazione della Scuola di Chicago. La Scuola di Chicago, ebbe
come riferimenti fondamentali uomini come H.S. Becker e E. Lemert. Essa era già
conosciuta negli anni cinquanta, ma si diffuse soprattutto tra il 1962 e il 1964, in una
forma diversificata, chiamata Nuova Scuola di Chicago, da cui il nome dei suoi esponenti, i
cosiddetti Neo-chicagoans. La filosofia che è alla radice della Scuola di Chicago, nuova
generazione, è data dal concetto di "naturalismo", termine che si ritrova in Aristotele e
Spinoza, ma che qui è inteso come "generale" della Scuola di Chicago e come "classico" se
parliamo del pragmatismo di G. Santayana (D'Agostino, 1984). In effetti, alcuni hanno
ritenuto distinguere il naturalismo in due parti: la prima si riferisce alle componenti
essenziali che si riferiscono alla fedeltà del fenomeno, mentre la seconda a quelle
accidentali che consistono nel ricorso alle metodologie delle scienze della natura. Nella
visione di Matza " il naturalismo, obbliga nei confronti dei fenomeni e della loro natura, non
vincola alla scienza o a qualsiasi altro sistema di norme" (Matza, 1969). Questa definizione,
varca quell'idea che considera il naturalismo come la filosofia che si basa sui risultati e sui
metodi delle scienze: "…tutto ciò che esiste o accade può essere spiegato con metodi che,
anche se esemplificati paradigmaticamente nelle scienze naturali, sono continui da un
dominio all'altro della scienza" (D'Agostino, 1984). In tal senso, tutto è riassumibile in
termini scientifici, anche se invertendo le proposizioni tutto si trasforma da naturalismo ad
uno scientismo di tipo positivistico: "metodi che, anche se continui da un dominio all'altro,
sono esemplificati dalle scienze naturali”. Questa tensione esistente nell'ambito delle
scienze sociali, si risolverà quando il naturalismo sceglierà la via dell'impostazione
soggettiva, della fedeltà al mondo sociale umano: " l'uomo partecipa ad una attività
significante. Egli crea la propria realtà e quella del mondo attorno a lui, attivamente e
strenuamente. L'uomo naturalmente, non soprannaturalmente, trascende le sfere
esistenziali in cui è facile applicare i concetti di causa, di forza e di reattività. Quindi non si
possono considerare naturalistici né una visione che concepisce l'uomo come oggetto, né
dei metodi che sondano il comportamento umano senza occuparsi del significato di tale
comportamento. Tali posizioni e metodi sono esattamente l'opposto del naturalismo, poiché
interferiscono a priori nel fenomeno da studiare. Il naturalismo, applicato allo studio
dell'uomo, non ha altra scelta che concepire l'uomo come soggetto, precisamente perché il
naturalismo rivendica fedeltà al mondo empirico" (Matza, 1969; MacRae, 1974).
La sociologia della devianza tra vecchi e nuovi paradigmi: riflessioni e attualità del lavoro
teorico di David Matza. L'analisi di David Matza, si fonda sulla premessa che occorre
studiare il significato del comportamento dall'interno della realtà quotidiana dell'attore
sociale. Egli quindi propone l'adozione di una prospettiva "naturalistica", che fornisca una
descrizione accurata dei fenomeni. Ciò permette di distaccarsi dalla rappresentazione dei
devianti come spinti alla devianza da forze sociali al di fuori del loro controllo. Diviene così,
possibile identificare gli scopi, le motivazioni e le paure che informano l'azione deviante. La
prima osservazione "naturalistica" di Matza è che i devianti non commettono reati così
disinvoltamente come si tende a credere, al contrario, essi spesso avvertono senso di colpa
e vergogna per il loro comportamento. Ciò farebbe riflettere sul fatto che i devianti sono
sensibili al codice normativo della società anche quando commettono reati. Questo accade
per due motivi:
1) le norme sociali sono ambigue, dal momento che promuovono alcuni comportamenti
trasgressivi (es. il divertimento) e, allo stesso tempo, li vietano.
2) il deviante dispone di diverse strategie psicologiche per "neutralizzare" la gravità del
proprio comportamento, come ad esempio la negazione di responsabilità, asserire di non
aver provocato danno a nessuno, screditare la vittima e rinfacciare le colpe a chi gli
contesta il reato commesso.
Conseguentemente, piuttosto che alle culture devianti esterne a quella dominante, occorre
rivolgere l'attenzione alla devianza nascosta di quest'ultima. Una volta riconosciutane
l'esistenza, per diventare un deviante, non c'è più bisogno di allontanarsi dalla società
dominante, perché ci si collocherà fra la conformità e la devianza normative, senza
dedicarsi né all'una né all'altra. In pratica, la commissione di un reato durerà solo un breve
istante, cui seguirà immediatamente la riconferma della propria dedizione all'ordine sociale
tramite l'impiego delle "strategie di neutralizzazione" (Sykes, Matza, 1957). In particolare,
questa concettualizzazione del mondo deviante è riassunta nel concetto di "deriva", che
implica la convergenza fra la cultura del delinquente e quella dell'onesto. Tuttavia, non
sono solo i devianti a rivendicare la propria pericolosità sociale. L'ambiguità delle norme
sociali, permette anche ai pochi puritani residui di fabbricarsi un falso passato di
trasgressioni o di gonfiare i loro attuali reati minimi fino a fare loro assumere uno status di
pericolosità sociale. Naturalmente, anche la teoria di Matza è stata oggetto di critiche, fino
al punto che l'autore stesso l'ha definita una mescolanza confusa di opinioni (Weis, 1971).
L'esistenza di senso di colpa negli adolescenti devianti ha suscitato perplessità (Hindelang,
1970; Hirschi, 1969), mentre considerare le "strategie di neutralizzazione" finalizzate alla
riconferma della dedizione del deviante all'ordine sociale e non alla critica di esso, esclude
la possibilità che la devianza possa rappresentare un mezzo di critica o antagonismo
sociale. Inoltre, la nozione di "deriva" è qualcosa a metà strada fra determinismo e libero
arbitrio, a considerare il modo in cui è spiegato il processo di produzione e rivendicazione
degli atti devianti (Taylor, Walton, Young, 1973). Tuttavia, il lavoro teorico di Matza spicca
sicuramente nell'ambito della sociologia della devianza e conserva intatto il proprio valore
sotto tre aspetti:
1) il primo si riferisce al fatto che, l'attenzione dai processi che generano le predisposizioni
comportamentali dell'individuo, si sposta al contesto microsociale dove gli atti di devianza
vengono compiuti
2) Secondo, ci si preoccupa di considerare la questione dal punto di vista dell'individuo,
cioè si afferma che le cognizioni sul mondo influenzano il comportamento, anche a
prescindere dalla loro correttezza
3) Infine, si impiega lo stesso modello processuale per spiegare ogni tipo di
comportamento, deviante o meno.
Concludendo, questi tre aspetti, uniti alle caratteristiche della teoria di Matza, svelano una
prospettiva concettuale, fino ad allora mai considerata e influenzata dalla teoria della
società di massa.
La devianza nel paradigma conflittuale
► La prospettiva radicale della teoria del conflitto ed i processi di definizione istituzionale
della criminalità
Le teorie sociologiche legate alla criminologia ricercano le cause della criminalità nelle
disfunzioni della società. All’interno delle teorie sociologiche troviamo 2 teorie
fondamentali: le teorie del consenso, secondo le quali le regole poste dalla società si
reggono sul consenso della maggior parte dei cittadini ai quali si contrappongono come
eccezione i devianti; e le teorie del conflitto, secondo le quali i modelli normativi e
comportamentali della società non esprimono le scelte della maggioranza, ma sono il frutto
dell’imposizione delle minoritarie classi dominanti. Cambia il modo di intendere la devianza.
All’interno delle teorie del consenso abbiamo: Negli anni 40 la scuola di Chicago elaborò la
teoria ecologica o delle aree criminali. Si osservò che nelle zone urbane economicamente e
socialmente depresse ed alta concentrazione criminale, il rischio di divenire delinquente è
molto alto. Secondo tale teoria esiste una stretta dipendenza tra destabilizzazione dei valori
culturali di una società e la irregolarità di condotta dei suoi membri. La disorganizzazione
sociale può prodursi anche quando in una società esistono contraddizioni normative o
conflitti di norme. Ciò avviene quando: a) vi sia socializzazione difettosa o mancante; b)
quando vi siano deboli sanzioni per certi delitti; c) quando vi sia inefficienza o corruzione
nell’apparato giudiziario. Per la teoria dei conflitti culturali la condotta deviante nasce da
conflitti tra norme culturali diverse alle quali un soggetto o un gruppo di persone si trova
esposto. Partecipare a due sistemi culturali diversi può generare disagio, incertezza e
insicurezza in un individuo e queste condizioni possono sfociare in malattie mentali e
criminalità. Secondo tale teoria il comportamento criminale si apprende attraverso
l’associazione interpersonale con altri individui che sono già criminali. L’unicausalità di
questa teoria fu ritenuta inizialmente un pregio, ma successivamente criticata perché
incapace di spiegare le origini della criminalità che deve esistere prima di essere appresa
da altri. I processi di socializzazione mirano a condurre l’individuo alla conformità, ossia ad
uno stile di vita regolato da norme e comportamenti conformi alla cultura dominante. In
antitesi alla conformità si pone la devianza, che si concreta nella non osservanza delle
regole normative e sociali. Per essere definito deviante, il comportamento deve violare
volontariamente la regola culturale. Il concetto di devianza si è affermato grazie allo
struttural-fuzionalismo, i cui maggiori esponenti sono Durkheim e Merton. Durkheim vide la
causa principale della devianza nell’anomia, intesa come “frattura di regole sociali”
provocata dalla società. Merton riprese tale concetto allargandone il significato: l’anomia è
intesa come sproporzione tra mete culturali e mezzi legittimi per il conseguimento di
queste ultime. Tale teoria vuole dimostrare che la delinquenza non deriva
dall’apprendimento di norme o valori devianti, ma il comportamento deviante è il risultato
di tecniche psicologiche, di razionalizzazione, così dette di neutralizzazione. Tali tecniche
sono concepite secondo 5 forme principali:
1) la negazione della propria responsabilità;
2) la minimizzazione del danno provocato;
3) la negazione della vittima;
4) la condanna dei giudici;
5) l’appello a obblighi di lealtà.
Il delinquente, mediante queste tecniche, si sente scaricato delle sue responsabilità e per le
sue azioni si considera più come soggetto passivo che come soggetto attivo. All’interno
delle teorie del conflitto abbiamo la teoria dell'etichettamento, della criminologia radicale e
della criminologia critica. Per la teoria dell’etichettamento il deviante non è tale a causa del
proprio comportamento, ma in quanto la società etichetta come deviante chi compie
determinate azioni da essa vietate. Successivamente può accadere che alcuni soggetti, le
cui condotte sono state definite dalla società devianti, reagiscano a tale etichettamento
accentuando tali condotte. A tal proposito si parla di consolidamento della devianza. Tale
teoria ritiene i ceti dominanti responsabili di definire delinquente chi si oppone al sistema
neo-capitalistica. In quest’ottica si sostiene una correlazione tra opposizione al sistema
dominante e devianza. Tale teoria muove da analisi sociali e politiche marxiste,
reinterpretando il concetto di devianza come lotta della classe operaia per l’instaurazione
del socialismo. La devianza si identifica col dissenso di un soggetto nei confronti di un
sistema che ne criminalizza la classe sociale di appartenenza.
► Lo stereotipo del criminale in Chapman.
Spesso ci capita di identificare e classificare alcuni individui come aventi "una brutta
faccia"; con questa definizione ci riferiamo generalmente ad una serie di tratti somatici che
lasciano trasparire una certa durezza e determinazione, e un ipotetico vissuto
delinquenziale che avrebbe segnato quei volti. La valutazione fisiognomica iniziale può
anche generare in noi una condizione di "allerta", di sfumato timore, nel caso in cui un
essere umano con tali caratteristiche ci si avvicini in un luogo isolato; allo stesso modo il
suo "oltrepassarci" può suscitare un certo sollievo, quando si è constatato che non è
successo niente di grave per la nostra incolumità. La dinamica appena descritta si
manifesta normalmente anche nelle persone che affermano di essere immuni da certe
valutazioni stereotipali e che intellettualmente professano una filosofia di vita "positivista."
Questo quadro emotivo è forse noto a tutti gli abitanti "per bene" delle città occidentali e
rappresenta la risposta emotivo-comportamentale ad uno stereotipo appreso assai diffuso e
radicato. Tale stereotipo, del resto, in parte affonda le sue radici in meccanismi reali,
dovuta alle conseguenze delle lotte per la sopravvivenza che avvengono frequentemente
nei gruppi delinquenziali di strada e che abituano i membri di tali gruppi ad utilizzare la
mimica facciale per "segnalare" la loro durezza agli altri membri del gruppo evitando così
continui scontri cruenti per ribadire il loro valore. Le espressioni del viso corrucciate ed in
grado di incutere timore, con il tempo si ritualizzano così come altre caratteristiche esteriori
(es. l'abbigliamento, i tatuaggi, il taglio di capelli, l'andatura) costituendo un quadro
comportamentale stabile. In alcuni luoghi del pianeta oggetto di flussi migratori, i tratti
somatici che destano allarme sono anche quelli appartenenti al fenotipo razziale della
popolazione giunta da altri luoghi che spesso presenta difficoltà di integrazione ed è
statisticamente più incline a forme delittuose di strada più che ai white collar crimes. Una
cospicua porzione dello stereotipo della "faccia da ladro" è comunque anche frutto delle
generalizzazioni cognitive tipiche del genere umano. Com'è noto, gli stereotipi diffusi sono
legati all'incapacità della mente umana di affrontare la complessità esterna con un continuo
e stressante processo di selezione e organizzazione delle informazioni. Un'esperienza
saltuaria si trasforma in una categoria interpretativa stabile e si diffonde poi come
atteggiamento a livello sociale. La dimensione stereotipale del criminale ha costituito nella
storia della Criminologia un fattore assai importante, e su di esso si sono focalizzate intere
scuole scientifiche. I più famosi teorici dell'etichettamento (Labelling approach) e degli
stereotipi in Criminologia tra cui Becker, Lemert, Kitsuse, agli inizi degli anni Sessanta,
consideravano il crimine quasi esclusivamente come l'esito di un processo di
etichettamento sociale. Tale processo, ritenuto in grado di provocare alla fine una
riorganizzazione del Sé del deviante (il delinquente comincia a sentirsi come tale), è per
questi autori dovuto ad un intervento selettivo della società sul deviante stesso. La
devianza si costruisce quindi progressivamente in base all'azione della società sui soggetti
che hanno commesso qualche piccola infrazione o che sono stati addirittura ritenuti
ingiustamente responsabili, a causa del loro modo di fare, di qualcosa di illegale. Il
Sociologo inglese Dennis Chapman, nel suo famoso saggio Sociology and the stereotype of
the criminal (1968) attribuiva proprio agli stereotipi sociali e istituzionali la responsabilità di
generare il crimine. Secondo lo studioso, la discriminazione dei soggetti in base alla classe
sociale e alla visibilità pubblica, operata a livello sociale e istituzionale, avrebbe generato
un comportamento più "ostile" nei loro confronti rispetto a quello riservato agli
appartenenti alle classi agiate. Tale ostilità avrebbe poi in qualche modo incanalato alcuni
individui (solitamente i poveri) su un percorso di devianza difficilmente reversibile.
L'individuo con l'aspetto fisico e comportamentale poco rassicurante, in tale ottica,
godrebbe di minore immunità rispetto all'individuo esteriormente rassicurante, nei processi
selettivi della rappresentazione sociale e del controllo istituzionale. Lo stereotipo di
Chapman è stato effettivamente documentato da ricerche sull'attribuzione semantica del
crimine in cui la parola "criminale" è stata frequentemente associata dagli intervistati ai
delinquenti delle classi svantaggiate mentre il termine "disonesto" è stato riservato ai
delinquenti per bene, i famosi white collars crime. Per i teorici dell'etichettamento il
delinquente sarebbe quindi come "sballottato" dal controllo sociale e avrebbe una ridotta
capacità di selezionare ed organizzare, attraverso la mente, il suo comportamento sociale.
Il deviante, colpito dagli stereotipi, entrerebbe quindi nei processi di selezione sociale solo
come oggetto di selezione, senza essere in grado in alcun modo di variare il corso della sua
storia personale.
► Le funzioni della norma penale nella società in conflitto (Dahrendorf, Coser).
Il concetto di devianza viene definito nel dibattito sociologico degli anni Cinquanta
all’interno della teoria funzionalista, in particolare grazie all’opera più nota di Talcott
Parsons “Il sistema sociale”. Lungi dal rappresentare soltanto uno scostamento
statisticamente rilevabile dalla media dei comportamenti tenuti in un dato contesto sociale,
il termine associa a tale comportamento un giudizio di valore che connota negativamente
sia il comportamento che il suo autore. La sociologia, interessata a seconda dei casi alle
condizioni dell’ordine e della stabilità o piuttosto ai conflitti e alla disorganizzazione, trova
nello studio della devianza un fertile terreno di analisi relativo in particolare allo studio del
mutamento sociale. La categoria comprende sia i comportamenti devianti che
rappresentano delle violazioni del diritto positivo, definibili come comportamenti criminali,
sia quelli che si scostano dai modelli normativi e dalle regole sociali e culturali di un dato
contesto sociale. Le teorie e le ricerche sociologiche sul fenomeno deviante sviluppatesi
dalla fine del XVIII secolo sono state schematicamente distinte in due filoni generali
(Berzano, Prina): il primo raccoglie le teorie eziologiche, ovvero rivolte allo studio dei
fattori che determinano i comportamenti devianti; il secondo comprende le ricerche che
intendono descrivere i processi di formazione, di sviluppo e di produzione dei
comportamenti devianti, sia di tipo sociale, economico e relazionale che più propriamente
istituzionale. In relazione a tale distinzione si parla di due paradigmi distinti (Pitch) ed in
particolare del passaggio dal paradigma eziologico al paradigma del controllo sociale
(Baratta). Il primo filone di studi comprende i più datati paradigmi utilitarista e positivista.
Il primo interpreta il crimine non come reazione a fattori o influenze esterne, ma come il
risultato di una decisione razionale dell’individuo volta ad ottenere benefici nel contesto di
una valutazione sulle norme e le sanzioni. Esso è stato in questi ultimi anni ripreso da
quelle teorie della scelta razionale (rational choice theory) della devianza che pongono al
centro del formarsi delle preferenze devianti l’interesse e il calcolo economico, ma anche da
quelle teorie della deterrenza (deterrence theory) che pretendono di prevenire il crimine
attraverso un inasprimento delle pene. Ad esse è possibile affiancare le più recenti teorie
situazionali del crimine, le quali sostengono la possibilità di prevenire o contenere i
comportamenti devianti aumentando le difficoltà e i rischi cui il potenziale autore di reato
dovrebbe andare incontro nel perseguire il proprio progetto criminoso. Il secondo, nato con
la statistica morale, interpreta invece il comportamento criminale come determinato da
fattori ambientali e sociali che influenzano in modo determinante il soggetto. Anch’esso ha
conosciuto nuova fortuna con la rivalutazione degli indicatori statistici nell’analisi delle
patologie sociali e nei modelli che pretendono di prevedere la devianza, ma anche con la
riproposizione dell’influenza della problematica biologica sui comportamenti psicologici,
culturali e sociali, operata dalla sociobiologia. In relazione ai potenziali contributi di questo
filone di studio e ricerca nell’analisi critica del diritto penale, è possibile affermare che essi
risultano essere praticamente nulli. Per quanto le concezioni dell’uomo e della società, e
quindi le spiegazioni del crimine, sottese alle due prospettive siano profondamente diverse,
entrambe si caratterizzano, al contrario, per la propria funzione legittimante nei confronti di
un sistema penale i cui fondamenti non vengono in alcun modo posti in discussione.
L’ideologia che esse servono è, in entrambi i casi, l’ideologia della difesa sociale,
caratterizzata da una concezione astratta e astorica della società come totalità omogenea,
la quale conduce all’indicazione univoca di valori fondamentali considerati degni di tutela.
In particolare, come esplicita Baratta in “Criminologia critica e critica del diritto penale”, ad
essere ribaditi sono: il principio di legittimità, secondo cui lo stato interpreta la legittima
reazione della società volta alla condanna del comportamento deviante e alla
riaffermazione delle norme sociali condivise; il principio del bene e del male, per cui il reato
è un elemento disfunzionale del sistema sociale e quindi un danno per la società; il
principio di colpevolezza, per cui il crimine è espressione di un atteggiamento interiore
riprovevole perché contrario ai valori presenti nella società ancor prima di essere
giuridicamente sanzionati; il principio dello scopo, per cui la pena ha la funzione di creare
una contromotivazione al comportamento deviante; il principio di eguaglianza, secondo cui
la legge penale si applica in modo uguale a tutti gli autori di reato; infine il principio
dell’interesse sociale e del reato naturale, secondo il quale gli interessi protetti dal diritto
penale sono interessi comuni a tutti i cittadini. Sono gli sviluppi del secondo filone della
sociologia della devianza, noto come paradigma sociale e consumatosi principalmente in
ambiente anglosassone, a mettere invece a disposizione della scienza penale strumenti di
conoscenza e modelli interpretativi completamente nuovi. Lo studio interdisciplinare di
criminalità e devianza consente lo sviluppo di un approccio critico anche nell’analisi del
diritto penale, per lungo tempo monopolizzata da filosofi e giuristi. Grazie ai contributi degli
studi sociologici sulla devianza che si riconoscono in tale paradigma, a venire posti in
discussione sono proprio i principi sopra richiamati che, alla base dell’ideologia della difesa
sociale, hanno una funzione legittimante nei confronti del sistema penale e delle sue
modalità di funzionamento. La teoria struttural-funzionalista della devianza e dell’anomia,
introdotta da Durkheim e successivamente sviluppata da Merton, pur interessata anch’essa
alla ricerca delle cause della criminalità, sostiene che esse non sono da ricercarsi né in
fattori di natura antropologica, né in una patologia della struttura sociale. Durkheim
afferma, al contrario, che un certo grado di devianza è un fenomeno normale per ogni
struttura sociale, che diventa negativo solo quando si accompagna ad uno stato di
disorganizzazione in cui l’intero sistema di regole di condotta perde valore (uno stato di
anomia). Il concetto di anomia viene ripreso da Merton in un'accezione parzialmente
differente da Durkheim: per Merton la devianza deve essere letta come un rapporto tra
"mete" e "mezzi" e si realizza quando le mete socialmente accettate sono irraggiungibili
attraverso mezzi leciti. Entrambe le teorie finiscono per porre in discussione il principio del
bene e del male, ovvero la concezione del reato come elemento sempre disfunzionale del
sistema sociale. Al contrario, il reato, secondo Durkheim, stimolando la reazione sociale,
rinforza il sentimento collettivo che sostiene la conformità alle norme sociali. Per Merton
esso costituisce il comportamento innovativo – adesione ai fini culturali senza il rispetto dei
mezzi istituzionali – che pretende di rispondere alle costrizioni imposte da una struttura
sociale sostanzialmente ingiusta. Le diversità strutturali delle opportunità di cui dispongono
gli individui di disporre di mezzi legittimi per raggiungere le mete sociali culturalmente
definite possono essere poste anche all’origine della formazione e del consolidamento delle
subculture criminali nelle società industrializzate. Secondo Cloward e Ohlin, le subculture si
formano perché la struttura della società impedisce ad alcuni soggetti di raggiungere i fini
socialmente accettati con mezzi leciti. In tal senso la teoria delle subculture criminali nega
il principio di colpevolezza, secondo il quale il crimine sarebbe la semplice espressione di un
atteggiamento interiore deplorevole. Ma sono soprattutto le successive applicazioni del
concetto di subcultura proposte da Sutherland (teoria dei contatti differenziali) e da Cohen
(con riferimento alle bande giovanili) a porre in discussione alcuni principi fondanti le teorie
generali del comportamento criminale: applicando il concetto di subcultura allo studio della
criminalità dei ‘colletti bianchi’, Sutherland critica la convinzione che le cause della
criminalità siano sempre da ricercare in condizioni di deprivazione, disagio sociale e
povertà. Tale rappresentazione si basa infatti su un falso campione di criminalità, quello
ufficiale, che tende ad enfatizzare la rilevanza della criminalità predatoria e della criminalità
di strada e a trascurare la criminalità dei potenti. Quest’ultima, sostiene invece Sutherland,
proprio come ogni altra forma di delinquenza sistematica, è appresa e si consolida
attraverso la frequenza e l’intensità dei contatti con coloro che già la praticano. Tale teoria,
a differenza delle precedenti, consente di spiegare tanto la criminalità degli strati sociali
inferiori che quella dei “colletti bianchi”. Cohen può così applicarla anche allo studio delle
bande giovanili, al cui interno il processo di interazione e l’assidua frequenza conducono
all’affermazione di un sistema di credenze e valori condivisi che rappresentano la soluzione
di problemi di adattamento ad una cultura dominante discriminatoria e socialmente
frustrante. In entrambi i casi, oltre al principio di colpevolezza sopra richiamato, che
vorrebbe il reato come comportamento adottato liberamente in contrapposizione a valori e
norme socialmente condivise, ad essere posto in discussione è anche il principio del reato
naturale, secondo il quale i valori e i modelli di comportamento tutelati dal diritto penale
sarebbero quelli propri dell’intero sistema sociale di riferimento, considerato come
tendenzialmente univoco ed omogeneo. La distinzione tra comportamento conforme e
comportamento deviante non è ricondotta in questa prospettiva ad atteggiamento interiore
intrinsecamente buono o cattivo, ma alla adesione a specifici valori piuttosto che ad altri.
Ciò finisce per spostare l’attenzione sulla relatività della definizione legale che in un dato
momento storico e in una data società considera determinati beni come meritevoli di
tutela. Nel momento in cui la definizione del reato non viene più data per scontata,
vengono necessariamente alla luce le implicazioni politico-sociali della tutela penale: la
criminalità e il criminale cessano di costituire il punto di partenza delle teorie sul
comportamento criminale e diventano una produzione sociale. È in particolare la teoria
dell’etichettamento (labelling approach) che, sulle orme dell’interazionismo simbolico di
Mead e dell’etnometodologia sviluppata da Schutz, si propone di evidenziare come la
qualità criminale di un comportamento, lungi dall’esistere oggettivamente, sia in realtà il
risultato di una costruzione sociale. Autori come Becker e Lemert si interrogano soprattutto
sul processo di formazione dell’identità deviante, in particolare sull’effetto dell’applicazione
dell’etichetta di criminale in capo ad un dato individuo: analizzando i processi di
stigmatizzazione che consolidano lo status sociale di deviante e danno vita a vere e proprie
carriere criminali, Lemert sostiene che la reazione sociale ad un primo comportamento
deviante (devianza primaria) finisce spesso per influire sull’identità dell’individuo
stigmatizzato che tende successivamente a permanere nel ruolo sociale che gli è stato
assegnato (devianza secondaria). È evidente come tali indicazioni finiscano per negare il
principio dello scopo o della prevenzione, che assegna alla pena il compito di creare una
contromotivazione al comportamento deviante; in particolare ad uscirne sconfitta è la
concezione rieducativa della pena, in quanto si sostiene che l’intervento del sistema penale,
lungi dall’avere un effetto risocializzante sul condannato, non fa che consolidarne l’identità
deviante. Altri Autori, quali Goffman (interazionismo simbolico) o Berger e Luckmann
(fenomenologia) si concentrano più direttamente sulla questione della definizione del
comportamento deviante: si afferma che non è il comportamento in sé a far scattare la
reazione sociale che distingue tra normale e deviante, ma la sua interpretazione, attraverso
cui quel comportamento viene fornito di un significato. Ciò trasforma i quesiti sulle cause
della criminalità in interrogativi circa le condizioni della criminalizzazione: la devianza non è
una qualità dell’atto in sé, solo la reazione sociale ad un dato comportamento definisce
l’atto come deviante. Assumono in tal senso centralità i processi di penalizzazione e
depenalizzazione di dati comportamenti (criminalizzazione primaria) e i successivi processi
di applicazione delle regole da parte delle agenzie del controllo, quali polizia e magistratura
(criminalizzazione secondaria). Ma l’attenzione alla definizione del comportamento deviante
porta alla luce anche la questione della distribuzione del potere di definizione all’interno di
una data società. La questione del potere, messa in luce in particolare dalle ricerche di
Sutherland e Aubert sulla criminalità scarsamente perseguita dei ‘colletti bianchi’ e dalle
intuizioni di Sack sulla natura della criminalità come realtà costruita attraverso giudizi
ascrittivi da parte delle agenzie del controllo, è relativa alle condizioni socio-politiche che
fanno sì che in una data società determinati gruppi e individui siano forniti del potere di
stabilire quali comportamenti e quali persone devono essere perseguiti. L’individuazione dei
beni degni di tutela penale e la conseguente applicazione delle leggi penali non possono
che presentarsi come assolutamente selettive, mettendo così definitivamente in crisi sia il
principio dell’interesse sociale e del reato naturale (non è vero che gli interessi protetti dal
diritto penale sono gli interessi di tutti) che il principio di eguaglianza (non è vero che la
legge penale si applica in modo uguale a tutti gli autori del medesimo comportamento).
Il fatto che il potere di criminalizzazione ed il suo esercizio sono strettamente legati alla
stratificazione e alla struttura antagonista della società è il tema centrale anche delle teorie
sociologiche del conflitto. Invitando la sociologia ad uscire dall’utopia di una società basata
sull’equilibrio e sul consenso, Dahrendorf e Coser indicano come fondanti le dimensioni
della coazione e del dominio politico esercitato da alcuni soggetti su altri. Il primo pone
l’accento sulla normalità del conflitto e sulla sua funzione in riferimento al cambiamento
sociale, il secondo ne sottolinea le funzioni positive anche per l’integrazione e la
conservazione della società. Applicando tali teorie allo studio della criminalità, Vold giunge
a sostenere che il crimine può essere inteso come un comportamento politico, in quanto
messo in essere da un individuo che, nel contesto di una data organizzazione sociale e
politica, non ha il potere per controllare la definizione di ciò che è normale e ciò che non lo
è, ovvero i meccanismi della criminalizzazione primaria. In tal senso, l’applicazione
criminologica della teoria del conflitto mette in crisi il principio dell’interesse sociale e del
reato naturale, negando che gli interessi tutelati dal diritto penale siano interessi comuni a
tutti i cittadini. Le teorie sociologiche del controllo sociale introducono un mutamento
dirompente nello studio della devianza e della criminalità rispetto alle concezioni
patologiche sostenute dalla criminologia positivistica. Laddove quest’ultima mutuava dal
diritto la definizione di criminale considerandola come una realtà avente caratteri e cause
naturali, esercitando così una funzione conservatrice e legittimante nei confronti del
sistema penale, le teorie sociologiche sostengono invece il carattere normale e funzionale
della criminalità, la sua dipendenza da meccanismi di socializzazione dipendenti dalla
stratificazione sociale e la sua produzione attraverso processi di definizione e
stigmatizzazione che sottendono una concezione conflittuale della società. In particolare,
con le teorie della criminalità e della reazione penale basate sulla teoria dell’etichettamento
e con le teorie conflittuali il diritto penale cessa definitivamente di essere il punto di
partenza per la definizione dell’oggetto dell’indagine criminologica e diventa oggetto esso
stesso di quell’indagine. Gli importanti contributi offerti dall’analisi sociologica, collocati
all’interno di una teoria materialista della devianza e della criminalizzazione attraverso
strumenti concettuali e ipotesi elaborati all’interno del marxismo, sfoceranno in seguito,
nell’ambito della sociologia criminale, nello sviluppo della criminologia critica. Affinché ciò si
verifichi sarà necessario che l’attenzione dei ricercatori si sposti dal rapporto di dominio
situato nella sfera politica, portato alla luce dalle teorie del conflitto, allo studio dei rapporti
materiali di proprietà, produzione e distribuzione situati nella sfera sociale ed economica ed
oggetto reale del conflitto.
► La natura politica e conflittuale del potere di definizione dei soggetti devianti
nell’interpretazione di Turk
La sociologia del conflitto presenta due versioni: una versione pluralista ed una versione
marxista. La versione pluralista (o liberale, alla Dahrendorf) sottolinea la rilevanza delle
dinamiche fra gruppi sociali in competizione per l'autorità. La versione pluralista, inoltre,
prescinde sia dal riferimento ad una dimensione strutturale del conflitto sia da una
valutazione adeguatamente critica dei reali interessi che vengono soddisfatti dal sistema
giuridico. La soluzione dei problemi emersi per effetto del conflitto, d'altronde, viene
coerentemente affidata alla mediazione politica ed al suo potere di riformare il quadro
normativo. I paladini di questa versione sono i criminologi G. Vold e A. T. Turk. Per loro il
crimine si collega direttamente e prevalentemente a situazioni di conflitto intergruppo e
alla esigenza di pervenire a degli aggiustamenti reciproci tra i vari interessi di cui i diversi
gruppi sono portatori. Il potere di produzione delle norme e della loro applicazione viene
esercitato dalle autorità ufficiali; la criminalità è connessa ai conflitti normativi derivanti
dalla eterogeneità dei sistemi di norme cui i soggetti fanno riferimento sulla base di una
loro specifica caratterizzazione sociologica. Le probabilità di criminalizzazione varierebbero
in funzione della forza a disposizione dei gruppi che confliggono; la criminalizzazione
diventa spinta a carico dei gruppi attrezzati con minori risorse. Turk trascura la classe
sociale come variabile cruciale per l'interpretazione del processo di criminalizzazione a
favore di altre variabili quali il sesso, l'età e l'appartenenza etnica. Turk propone, a questo
stesso proposito, una interessante distinzione fra processi di criminalizzazione innescati
dalle istituzioni di controllo e i processi di stigmatizzazione che invece hanno un teatro
sociale vasto. Oggetto del conflitto è qui il rapporto di dominio di alcuni (individui o gruppi)
su altri, dunque un rapporto politico.
Alcuni critici ritengono che l'adozione di un modello del conflitto siffatto non rappresenta
una reale alternativa: la devianza diventa un'espressione funzionale all'adattamento del
sistema al modello dell'integrazione. Il processo di criminalizzazione viene ricondotto (e
ridotto) all'affermazione dell'autorità da parte di chi ne è istituzionalmente il titolare.
Comunque sia, le teorie del conflitto, nella versione pluralista, promuovono la sociologia
criminale liberale rispetto alle teorie funzionalistiche nonché rispetto alle teorie della
reazione sociale sopra esaminate. L'inquadramento della devianza e del crimine nell'ambito
di difficile decodificazione delle relazioni di potere apre le porte, nel bene e nel male, alla
fase successiva di affermazione delle teorie criminologiche radicali che sostengono un'altra
versione della teoria conflittuale.
La paura del crimine
► Il valore della paura nelle politiche del controllo sociale
Con il termine “paura” qui si intende il sentimento diffuso di insicurezza e di minaccia al
proprio benessere fisico-materiale e alla propria identità soggettiva e sociale percepito dagli
individui. In tale prospettiva, paura e insicurezza verranno utilizzate come sinonimi.
Con il termine “potere”, al contrario, ci si riferisce a due differenti, e fra loro connesse,
dinamiche di dominio: sia in senso focaultiano, come circolazione di pratiche discorsive che
impongono una visione del mondo e uno specifico “sentire la realtà”; sia in senso
istituzionale, come potere organizzato all'interno di istituzioni formali e legittimate alla
gestione del controllo sociale. I due concetti, sebbene qui presentati come due momenti
distinti, nella realtà interagiscono e si contaminano in un unico processo di gestione del
dominio che concorre a formare, mantenere e riformulare l'ordine economico, sociale e
simbolico delle relazioni umane all'interno dei sistemi sociali.
Il tema diritti e paura chiama in causa necessariamente il potere e le sue forme
organizzative: Michael Moore, al termine del film Fahrenheit 9/11, come postilla di chiusura
riprende la nota riflessione di George Orwell esposta in “1984” per mostrare come le
politiche che diffondono insicurezza e paura siano uno strumento nelle mani del potere
organizzato per legittimarsi e legittimare la propria azione, ridurre le garanzie giuridiche
formali e spostare l'attenzione dell'opinione pubblica da temi più pressanti e scomodi. In
altre parole, attraverso le politiche della paura e dell'insicurezza le istituzioni di potere
hanno la possibilità di rendere legittimo un maggiore controllo sociale (il potere diviene un
meta-potere: uno strumento per rafforzare il potere stesso). L'utilizzo della paura e del
desiderio di sicurezza, tuttavia, ha risvolti non solo politici e sociali, ma anche economici.
Con l'aumentare delle politiche proattive, uno dei principi fondamentali della procedura
penale, ossia che la legge si applica quando esiste un legittimo e fondato sospetto che si
sia verificata una trasgressione, ha perso la sua centralità. La legalità, principio basilare del
diritto penale sostanziale, viene aggirata anche sulla base di considerazioni pragmatiche,
ora che l'intervento statale nei confronti della criminalità va ben oltre i casi e le competenze
stabilite dai nostri codici penali. Le politiche di prevenzione criminale riflettono una visione
attuariale della giustizia. In quest'ottica, l'applicazione della legge è diventata una delle
strategie politiche per contenere i rischi in una società non più orientata verso ideali
positivi, ma al calcolo negativo della limitazione del rischio. In questo tipo di società, la
solidarietà non si basa più su un sentimento positivo di appartenenza, ma si radica in una
generalizzata percezione di paura. L'idea che si possa "agire per il meglio" è stata
abbandonata a favore di una logica efficientista; è un approccio manageriale che ora
informa le decisioni politiche. Questa transizione viene descritta come il passaggio
dall'idealismo al realismo. L'azione della stato non è più guidata da principi normativi, ma
da uno scenario statistico. In tale contesto cambia la visione dell'umanità, non più
composta da individui responsabili ma da irresponsabili oggetti di controllo. Le violazioni
della legge non vengono più giudicate in termini di colpevolezza ma in termini di rischio
potenziale per l'ordine sociale.
► Le rappresentazioni dell’insicurezza e la paura di vittimizzazione
Il problema della sicurezza/insicurezza delle città, dalle grandi metropoli sino ai più piccoli
centri urbani, ha sollecitato negli ultimi anni un’attenzione crescente da parte degli studiosi,
degli analisti, degli organi di informazione, delle singole comunità. La delinquenza
metropolitana viene oggi diffusamente considerata «un aspetto usuale della società
moderna»: «un fatto – o meglio un insieme di fatti – che non richiede nessuna speciale
motivazione o predisposizione, nessuna patologia o anormalità, e che è iscritto nella
routine della vita economica e sociale». Svincolata dagli schemi positivistici, la dottrina
criminologica ha maturato una nuova «cultura del controllo sociale» che ha messo in
risalto, rispetto ad ogni visione enfatizzante del reo, l’esigenza di pianificare adeguate
politiche e pratiche di prevenzione della devianza urbana attraverso «tutto l’insieme di
istituzioni sociali, di strategie e di sanzioni, che mirano a ottenere la conformità di
comportamento nella sfera normativa penalmente tutelata». Tale obiettivo viene
generalmente perseguito dagli organismi istituzionali, locali e centrali, con diverse modalità
annoverabili nel quadro degli interventi di: prevenzione sociale in cui si includono iniziative
volte ad arginare la valenza dei fattori criminogeni, incidendo sulle circostanze sociali ed
economiche che determinano l’insorgenza e la proliferazione delle condotte delittuose negli
ambienti urbani; prevenzione giovanile con cui si tende a migliorare le capacità cognitive e
relazionali del minore, in maniera tale da controllare un suo eventuale comportamento
aggressivo e ad insegnare a genitori e docenti come gestire, senza traumi ed ulteriori
motivi di tensione, eventuali situazioni di crisi e di conflittualità interpersonale ed
interfamiliare che coinvolgano adolescenti; prevenzione situazionale con cui si mira a
disincentivare la propensione al delitto, aumentando le difficoltà pratiche ed il rischio di
essere scoperti e sanzionati che, ovviamente, viene ponderato dal reo. Nella loro
quotidianità, le “politiche di controllo sociale” si sono tuttavia espresse in diversi contesti ed
anche nel nostro Paese, in maniera a tratti assai discutibile e, comunque, con risultati non
sempre apprezzabili quando non - addirittura – controproducenti. La violenta repressione
dei soggetti ritenuti “devianti” (zero tolerance policy), l’ulteriore ghettizzazione di individui
di per sé già emarginati dal contesto sociale, l’edificazione di interi quartieri fortificati,
chiusi anche simbolicamente dal resto della comunità urbana, si sono rivelate, più che
misure efficaci nel contrasto alla criminalità, come dei «cortocircuiti semplificatori in
rapporto alla complessità dell’insieme dei problemi posti dall’insicurezza». L’apologia della
paura è venuta così a riflettersi, anche fisicamente, nelle forme architettoniche delle nuove
città fortificate ed ipersorvegliate; in quelle gated-communities in cui l’individuo non esita a
sacrificare una componente essenziale della propria libertà, della propria privacy, delle
proprie possibilità di contatto diretto con l’altro da sé, sull’altare di un sistema di controllo
che malcela, a sua volta, implacabili contraddizioni. Nei pressanti interrogativi circa la
percezione, la diffusione e la padronanza del rischio nella società contemporanea, va colto
l’eco delle diverse concezioni della sicurezza urbana, intesa sia in senso oggettivo, quale
«situazione che, in modo obiettivo e verificabile, non comporta l’esposizione a fattori di
rischio», che in senso soggettivo, quale «risultante psicologica di un complesso insieme di
fattori, tra cui anche indicatori oggettivi di sicurezza ma soprattutto modelli culturali, stili di
vita, caratteristiche di personalità, pregiudizi, e così via». Le amministrazioni locali sono
direttamente chiamate a garantire questo bisogno primario di sicurezza che promana dagli
individui, assumendo un ruolo di primo piano nell’adozione di innovative politiche per la
sicurezza urbana che siano fra loro complementari, funzionalmente differenziate, integrali
(in quanto parte della politica di protezione integrale di tutti i diritti), integrate (perché
rivolte a soggetti e responsabilità diverse), sussidiarie (perché non valgono a sostituire i
meccanismi spontanei di prevenzione e controllo della devianza che si sviluppano nella
società), partecipative e multidimensionali (perché attuate con il concorso di organismi
comunali, regionali, provinciali, nazionali e sovranazionali). Questa nuova assunzione di
responsabilità da parte delle Amministrazioni di prossimità contribuisce a sancire il
passaggio epocale «da una tradizionale attività di governo a una di governance» che deriva
«da un’azione integrata di una molteplicità di soggetti e si esercita tanto secondo procedure
precostituite, quanto per una libera scelta di dar vita a una coalizione che vada a vantaggio
di ciascuno degli attori e della società urbana nel suo complesso». Il paradigma teorico di
riferimento è riconducibile agli orientamenti della psicologia topologica di Kurt Lewin,
introdotti nella letteratura sociocriminologica dall’opera di Augusto Balloni. Il provvidenziale
crollo di antichi steccati di divisione, l’avvento di internet e la deflagrante estensione delle
frontiere degli «ambienti psicologici» in cui è destinata a svilupparsi, nel bene ma anche nel
male, la personalità umana non hanno scalfito, a nostro avviso, l’attualità e la validità della
«teoria del campo» lewiniana per cui il comportamento degli individui appare anche a noi,
oggi, condizionato dalla stretta interrelazione che sussiste fra le proprie connotazioni
soggettive e il proprio ambiente di riferimento, all’interno di un particolare «spazio di vita».
Su queste basi, il nostro itinerario concettuale prende avvio dall’analisi dell’ambiente
urbano, quale componente essenziale del più ampio «ambiente psicologico» e quale cornice
straordinariamente ricca di elementi di “con-formazione” dei comportamenti sociali, per poi
soffermarsi sulla disamina delle pulsioni e dei sentimenti soggettivi che agitano le persone
nei controversi spazi di vita del nostro tempo. Particolare attenzione va inoltre riservata
all’approfondimento, a tratti anche critico, della normativa vigente in materia di «sicurezza
urbana», nella ferma convinzione che proprio nel diritto – ed in special modo
nell’ordinamento penale – vada colto il riflesso e la misura del grado di civiltà ma anche
delle tensioni e delle contraddizioni sociali che tormentano la nostra epoca.
Le teorie del controllo sociale
► La prospettiva teorica della teoria del controllo sociale di Durkheim.
Come possiamo definire la normalità, la patologia e la devianza, come riconoscerla ed
analizzarla? Emile Durkheim in "Le regole del metodo sociologico" ci ricorda che la
normalità, che lui associa alla morale comune, è la media dei comportamenti: ciò che è
normale è tale per un tipo sociale determinato, in un dato momento e in un determinato
luogo (Durkheim lo considera anche un valore morale), che il tipo normale è quello già
realizzato e dato dai fatti del passato. Al contrario ciò che mette in discussione l'ordine
sociale e i valori dominanti della media della popolazione è considerato patologico per
quella società in quel momento, in relazione al grado di sviluppo raggiunto. Si deduce così
che sia il normale sia il patologico sono concetti relativi, connessi con il tempo e con
l'evoluzione di una particolare società. I mutamenti sociali implicano un cambiamento dei
valori dominanti, anche all'interno della stessa élite, che modificano le condizioni
dell'esistenza collettiva. Ciò che oggi è patologico per l'ordine sociale può essere necessario
per l'evoluzione successiva dello stesso ordine sociale. Analizzare il controllo significa anche
proporlo come fatto sociale e come tale spiegarlo, utilizzando altri fatti sociali, senza
ricorrere a tautologie. Ricorriamo ancora all'aiuto di Durkheim: egli ci suggerisce che i fatti
sociali sono fenomeni collettivi ed esistono indipendentemente dall'uso che l'individuo né
fa, esistevano prima di lui ed esistono al di fuori di lui, esistono al di fuori delle coscienze
individuali, devono essere dotati di potere coercitivo e imperativo in virtù dei quali
s'impongono all'individuo con o senza il suo consenso, anche se sono percepiti con
"naturalità". Quando ci si conforma la coercizione non si fa sentire ma essa si afferma nel
momento stesso in cui si cerca di resisterle. I fatti sociali si presentano sia in forme
cristallizzate sia sottoforma di correnti sociali. Il controllo sociale non è quindi un'entità
trascendente ma è un fatto sociale; è anche il risultato dell'interazione, aperta a qualunque
contrattazione, tra gli individui e di come essi definiscono la realtà collettiva.
È possibile riconoscere come istituzioni del controllo sociale le istituzioni totali come il
carcere o i manicomi ma anche le fabbriche e la famiglia. Anche determinate scelte
politiche producono maggiore o minore controllo sia in intensità sia in estensione. Queste
scelte, agite attraverso la legislazione, possono produrre devianza, o meglio, ciò che
l'apparato istituzionale e le costruzioni sociali definiscono come tale (labelling theory). La
devianza non è un atto ma la risposta, la definizione sociale di questo atto. Dalla devianza
alla sua criminalizzazione il passo è breve. Ma anche qui Durkheim ci ricorda che ciò che
noi chiamiamo reato è ciò che la società definisce come tale, nato da sentimenti collettivi in
un preciso momento storico e protetti dal diritto penale legato a quel momento.
Stabiliamo che un comportamento è delittuoso perché esiste una pena emessa in un luogo
a questo scopo istituito, il tribunale. Nella pena ritroviamo condensate le norme di
riferimento (ciò che è reato e ciò che non lo è) ed anche i riferimenti morali (ciò che è
giusto e ciò che è sbagliato) caratteristiche di una determinata società. Durkheim
sosteneva inoltre che nelle società a solidarietà meccanica il diritto è di tipo repressivo
perché estromette chi non si adegua mentre in quelle a solidarietà organica il diritto è di
tipo restitutivo perché non teme la trasgressione delle regole ma l'offesa ai diritti
contrattualistici dei singoli.
► Le teorie del legame sociale
Al di là degli aspetti meramente sociologici e descrittivi, ci sono due modi, radicalmente
contrapposti, di intendere la natura dei rapporti che intercorrono tra gli individui all'interno
di una realtà sociale. Il primo modo, sicuramente il più antico, si fonda sull'idea che la
società nel suo insieme sia una totalità le cui parti costitutive sono i gruppi sociali prima
ancora che gli individui singolarmente presi. Da questo punto di vista è chiaro che il tutto
precede le singole parti, nel senso che ne determina la natura, le funzioni, la stessa
possibilità di esistenza. Gli individui sono solo una variabile dipendente rispetto alla società
nella sua totalità. Di questa concezione totalitaria esistono almeno due varianti
significative: quella più antica, di tipo organicistico, quella più recente, di tipo tecnologico.
L'organicismo assume in modo metaforico la tesi che la società sia un vero organismo
vivente e che gli individui ne siano i piedi, le mani, la testa. Se la società vive, vivono i suoi
organi ma se l'organismo muore non vivranno più né piedi né mani. Organicistico è il punto
di partenza aristotelico ma ancor di più lo è quello di Platone, per il quale l'intero universo,
e non solo la società, costituisce un grande organismo vivente. Nel pensiero cristiano delle
origini gli spunti organicistici del Vangelo che descrivono il legame dei credenti con Cristo
come quello dei tralci con la vite, vengono amplificati ed estremizzati da San Paolo. Per lui
la Chiesa è un unico corpo di cui Cristo è la testa ed i cristiani sono le membra. Siamo nel
campo del più assoluto organicismo. In alcuni autori medioevali, ad esempio John di
Salisbury, la rappresentazione antropomorfica della società si spinge anche oltre lo schema
tripartito di origine platonica (classi dirigenti-testa; soldati-cuore; lavoratori-intestino) fino
a vedere nel principe il capo, nel senato il cuore, nei giudici e negli altri funzionari gli occhi,
le orecchie e la lingua, nei soldati le mani, nei consulenti i fianchi, negli ispettori l'intestino,
nei contadini i piedi, sempre a contatto con la terra. Agli schemi dell'organicismo platonico
si richiamano anche il pensiero rinascimentale (Ficino) ed in tempi più recenti quello
romantico (Schelling). L'organicismo ha trovato, in tempi a noi più vicini, molti sostenitori
tra i biologi, sempre sulla base di una estensione metaforica degli studi specifici compiuti
sugli organismi viventi; e ha trovato sostenitori tra i sociologi, anche se la maggior parte di
essi ha avvertito il carattere meramente analogico, e perciò in qualche misura inadeguato,
di tale modello esplicativo. Tuttavia "tutti i progressi intellettuali sono compiuti con l'aiuto
di metafore ed anche i nostri concetti astratti sono creati da immagini metaforiche, ed
anche nella scienza è lecito servirsi della metafora". (O. V. Gierke, 1902). In una versione
che possiamo definire totalitario-tecnologica la teoria della società come totalità si definisce
compiutamente all'interno della teoria generale dei sistemi. Alla base di questa teoria,
come la formulava L. von Bertalanffy nel 1950, c'era una esplicita critica delle concezioni
meccanicistiche e dunque individualistiche, assunte dal pensiero sociale e politico moderno,
da Hobbes in poi. Si parte dalla considerazione relativa alla società tecnologica avanzata e
dal ruolo che in essa giocano l'automazione, la cibernetica o la biologia per scoprire
l'enorme complessità della società e la quantità sterminata di interazioni che si sviluppano
al suo interno. Interpretare una società come sistema significa assumerla non come una
realtà a sé stante, spiegabile secondo i principi della causalità lineare, ma come una totalità
risultante dalla interazione dinamica delle sue parti. E quando von Bertalanffy deve trovare
un termine tradizionale per definire una tale visione della realtà, allora è egli stesso a
parlare di organicismo. Nella sua formulazione generale la teoria dei sistemi si applica ai
campi più svariati, dalla meccanica, all'elettronica, alla biologia. Utilizzando gli strumenti
raffinati della analisi matematica le interazioni sistemiche vengono misurate e valutate in
modo semplice con formule applicabili ai fenomeni più diversi. Né la teoria si presenta
diversa quando viene specificatamente applicata in campo sociale. Talcott Parsons definisce
il sistema sociale come un organismo sostanzialmente in equilibrio che tende
autonomamente a riprodursi così come è, se non intervengano dall'esterno elementi a
determinare reazioni a catena lungo tutta la struttura del sistema. Naturalmente il grado di
modificazione del sistema dipende soprattutto dalla sua elasticità, cioè dal suo carattere
aperto o chiuso. La prospettiva sistemica in campo sociale ha raggiunto il suo punto più
elevato nella ricerca di N. Luhmann, allievo di Parsons. Dal suo punto di vista la società è
un sistema che opera in un ambiente difficile che ne mette costantemente in discussione la
stessa sopravvivenza. Le difficoltà maggiori discendono dal grado crescente di complessità
sociale. Più che dal suo carattere chiuso o aperto, la capacità di un sistema sociale di
sopravvivere o di modificarsi dipende soprattutto dalla attitudine a ridurre la complessità,
selezionando elementi rilevanti per i primi fini e trasformando la complessità esterna al
sistema in complessità interna. Laddove vi sia questa attitudine l'evoluzione del sistema si
apre verso possibilità infinite. All'interno delle concezioni organicistiche, comunque
formulate, l'individuo come singolo è solo l'ultimo anello della catena sociale; la società
esiste prima di lui ed ogni individuo già dalla nascita è inserito in una società data. Nel
corso della sua vita il legame personale assume le forme e le valenze del legame sociale. In
una concezione siffatta è difficile assumere come base di partenza la libertà naturale
dell'individuo. Ogni interpretazione del legame sociale che partisse ignorando la priorità del
tutto rispetto alla parte e cominciasse dalla parte dell'individuo, sarebbe anacronistica ed
assurda, cioè una robinsonata. Contrariamente la maggior parte del pensiero moderno
parte proprio da una robinsonata: ossia che i singoli individui, in quanto tali, rappresentino
un prius reale e logico rispetto alla società, la quale risulterebbe determinata proprio dal
modo in cui le volontà dei singoli si incontrano, si scontrano, si compongono. Lo stesso
concetto viene espresso evidenziando che solo gli individui, in quanto tali, appartengono
alla natura, mentre tutto il resto, società compresa, è artificio. Il primo a formulare in
modo esplicito e completo un tale modello individualistico-meccanicistico fu T. Hobbes. In
un ipotetico stato di natura gli individui isolati sono in condizione di libertà naturale,
possono esercitare un diritto illimitato su tutti e su tutto. Di conseguenza la condizione di
libertà naturale determina necessariamente la guerra di tutti e contro tutti, fino al limite
dell'autodistruzione. Proprio per evitare ciò gli individui, dotati di potere razionale, decidono
di ricorrere all'artificio, stipulando un patto con cui conferiscono tutti i poteri e tutti i diritti
della condizione naturale, tranne quello della vita, che rappresenta la finalità primaria del
patto, ad un sovrano politico. Nel suo schema, dunque, il legame sociale o è guerra o è
sottomissione al potere politico. Una analoga struttura contrattualistica, che partendo dalla
autonomia degli individui e dalla multiformità del suo esplicarsi, ne compone
meccanicamente le risultanze sociali, è presente anche in autori come Locke o Rousseau,
che pure non condividono la totale sottomissione hobbesiana del sociale al politico.
L'interpretazione individualistica della società, aldilà delle proiezioni politiche esplicite sul
terreno del liberalismo e della democrazia, sta alla base di larga parte del pensiero
moderno in tutte le sue valenze, storiche e filosofiche. Individualistiche sono, alle origini
della modernità, la logica del mercante ma anche il tema rinascimentale della dignità
umana. Individualistica è la nuova collocazione, nella riforma protestante, dell'uomo
rispetto a Dio, una volta eliminate le varie forme di intermediazione sociale. Individualistico
è l'assunto cartesiano del dubbio metodico e della successiva accettazione di certezze, solo
se evidenti alla mente del singolo. Individualistica è pure l'istanza dell'io come viene
impostata presso le correnti di pensiero esistenzialistico. A questo punto non ci si può
esimere da qualche considerazione critica in ordine ai due modi anzidetti di intendere la
natura del legame sociale. Ciò che abbiamo chiamato organicismo presenta indubbiamente
notevoli pregi sul piano descritto. È difficile, infatti, negare che il processo di formazione
dell'io avvenga prevalentemente sotto la spinta di istanze esterne e che la socializzazione,
quale si realizza negli anni dell'infanzia e della formazione sia il risultato di dati sistemici
determinati o che i ruoli sociali risultino definiti a priori rispetto ai singoli individui che
vanno preparandosi a ricoprirli. Tuttavia i rischi che si corrono accettando le posizioni
organicistiche sono enormi: in questo caso vale tutta intera l'accusa che Marx rivolgeva al
materialismo volgare di fare dell'uomo un soggetto passivo rispetto alla realtà, data in
modo deterministico, piuttosto che l'artefice attivo della propria condizione. Così le forme
storicamente date della organizzazione sociale sono consegnate o ad una antistorica fissità
o ad un dinamismo che prescinde dalla volontà degli individui. Insomma, può facilmente
accadere che le filosofie sociali organicistiche forniscano i presupposti culturali che
favoriscono il passaggio dal totalitarismo in campo sociale a quello in campo politico. Difetti
e pregi del modello individualistico-meccanicistico sono simmetricamente opposti rispetto a
quello organicistico. Ricorrendo ad esso si evidenziano notevolmente le difficoltà di
descrivere la natura della società. L'io si gonfia smisuratamente di sé, amplificando oltre il
lecito la sfera della libertà, fino a comprendervi tutti i comportamenti dei quali si ignora la
causa. Il modello individualistico risulta comunque sicuramente preferibile sul piano
normativo o prescrittivo per la sua interpretazione attiva della possibilità dei singoli e per la
sua facile proiezione verso un sistema di valori liberi ed egualitari. Insomma, è su questo
scenario che si intravedono i lineamenti della popperiana società aperta, mentre su quello
organicistico-olistico ci sono tutti i suoi nemici. Tra coloro che cercano di sfuggire, con
aggiornate forme di pensiero, a quella schematica contrapposizione di modelli, si collocano
oggi alcuni studiosi, soprattutto antropologi, come M. Douglas o C. Castoriadis, che
affrontano il problema a partire dal ruolo e dalla funzione delle istituzioni sociali.
Riprendendo da Durkeim la convinzione che la sociologia sia la scienza delle istituzioni,
Douglas sa che i fatti sociali non possono esaurirsi nella sfera della motivazioni e delle
rappresentazioni proprie della coscienza dell'individuo; le istituzioni, in quanto nate con il
preciso scopo di garantire la continuità sociale, sono precedenti e prioritarie rispetto agli
individui. Le istituzioni, pur non essendo riconducibili agli schemi della cultura organicistica,
vengono considerate come svolgenti funzioni umane, quali vedere, pensare, decidere... Il
modo in cui gli individui interiorizzano norme, credenze e valori propri delle istituzioni,
costituisce lo scopo specifico delle scienze sociali. La ricerca sui legami sociali di Castoriadis
si muove in aperta rottura con il pensiero ereditato dalla tradizione: contro l'individualismo,
soprattutto, laddove esso si connota di componenti utilitaristiche ma anche contro le visioni
totalizzanti dei sistemi sociali che riducono l'individuo a mera conseguenza di logiche
strutturaliste. Egli mette in discussione la distinzione tradizionale tra natura e cultura, tra
bisogni naturali e storia, che domina tutto il pensiero contemporaneo, e prende le distanze
da tutte quelle concezioni antropologiche che cercano di spiegare il legame sociale come un
passaggio da una condizione biologica naturale alla organizzazione sociale. Tale è anche,
secondo Castoriadis, la posizione antropologica di Gehlen. Per l'antropologo tedesco l'uomo
è una mostruosità biologica, non essendo egli fornito alla nascita degli organismi necessari
alla sua stessa sopravvivenza. La vita dell'uomo è messa costantemente a repentaglio
dall'uomo stesso che rappresenta un errore intenzionale della natura. Animale mancante o
animale malato, l'uomo è costretto per sopravvivere a sviluppare tutta la sua artificiosità.
Così la cultura, la scienza, la tecnica, le istituzioni, sono delle vere e proprie protesi che
consentono all'uomo di uscire dalla sua condizione naturale. L'istituzione, smorzando la
plasticità delle pulsioni (paura, desideri..) seleziona le regole utili alla sopravvivenza e
fornisce alla esistenza un minimo di certezze. Ma neppure l'antropologia di Gehlen sfugge,
secondo Castoriadis, al determinismo e l'uomo viene così condannato alla prigione di
schemi totalizzanti, come accade nella teoria sistemica di Luhmann. Insomma, non si può
parlare di società escludendo gli individui: l'opposizione individuo-società è falsa. Tra
l'animale e l'uomo c'è una differenza radicale: solo la psiche umana è fornita di una
capacità di immaginazione e di rappresentazione che si dirige, a differenza di altri animali,
verso funzioni totalmente libere dal determinismo della sopravvivenza. Negli esseri umani
agisce il piacere della rappresentazione libera e solo negli uomini c'è la possibilità di
muoversi verso quelle direzioni creative che Freud riconduceva al concetto di sublimazione.
Per Castoriadis vi è dunque una rottura radicale dell'animalità, proprio perché la psiche è
fornita di una immaginazione creatrice di sensi e di significati. Se la psiche si radica nel
desiderio e se il desiderio si alimenta della mancanza, allora l'oggetto verso cui si proietta
non può essere un puro dato biologico ma costituisce una creazione originale. L'insieme di
queste creazioni si rapporta al singolo, configurando così una rappresentazione di sé come
ciò a cui non manca nulla. Già il seno materno non è per il bambino una mera fonte di
alimentazione ma la prima apertura al mondo, la prima creazione di senso, la prima
istituzione. Se la società istituita è il punto di partenza già dato che entra in rapporto con la
psiche del bambino, non si può negare che la forza istituente risiede nella psiche che è la
fonte vera di ogni significato sociale. Il processo di significazione di cui la psiche è
portatrice fa nascere le rappresentazioni immaginarie di senso e rappresenta la forza
istituente della società. Così il sociale è creazione libera; libera è pure la storia nel suo
insieme: essa non discende da leggi naturali, né da leggi storiche oggettive. Quando si
parla di istituzioni, dunque, bisogna distinguere la società istituita con i suoi significati
determinati e conclusi, dalla società istituente che è creazione di individui sociali e di tutto
il mondo umano ad essi connesso: il linguaggio, le norme, i valori, la vita e la morte.
► La teoria del controllo sociale di Hirshi.
La versione più recente della corrente sociologica che legge la devianza in termini di
controllo sociale è la teoria del legame sociale di Hirschi (1969). Similmente a Durkheim,
Hirschi pone i comportamenti su di una scala che va dalla conformità alla devianza. Il
comportamento convenzionale è il frutto dell'influenza delle norme interiorizzate, della
coscienza e del desiderio di approvazione. L'individuo è libero di accedere alla devianza,
ma, mentre Sykes e Matza spiegano l'orientamento alla devianza con il ricorso da parte
dell'individuo alle tecniche di neutralizzazione, Hirschi chiama in causa la natura dei legami
sociali e associa la devianza al loro indebolimento o alla rottura. Un individuo compie un
reato quando i vincoli che lo legano alla società perdono di forza e di efficacia nel
trattenerlo dal seguire le proprie inclinazioni e i propri interessi. I legami sociali sono
costituiti da quattro elementi: l'attaccamento, il coinvolgimento, l'impegno e la
convinzione. L'attaccamento è dato dalla forza dei legami verso altri significativi (i genitori,
gli amici, i modelli di ruolo) o verso le istituzioni (la scuola, l'associazione); il
coinvolgimento è espresso dal tempo e dalle risorse dedicate alla partecipazione ad attività
convenzionali (tanto più tempo è dedicato allo studio, allo svago, ecc. tanto meno ne resta
per compiere atti devianti); l'impegno è costituito dall'investimento sotto forma di
istruzione, reputazione, posizione economica; la convinzione, infine, consiste nel
riconoscimento della validità delle norme vigenti. La libertà di adottare comportamenti
devianti si riduce o si estende a seconda della presenza e dell'intensità degli elementi
costitutivi dei legami sociali. La teoria del controllo sociale pone, dunque, in relazione
l'aumento dei comportamenti devianti con l'indebolimento della coesione sociale. La
devianza è assunta come un dato naturale in una società. Gli individui agiscono spinti dalla
ricerca dell'autoconservazione e della gratificazione; il vivere sociale è reso possibile
dall'ordine morale formato dalle regole, che gli individui interiorizzano nel corso della
socializzazione; il legame con l'ordine sociale, imperniato sui quattro elementi individuati, è
la condizione per il mantenimento della conformità. In quest'approccio, che si fonda su di
una concezione pessimistica della natura umana, ritenuta moralmente fragile e bisognosa
di freni e di controlli, è proprio la conformità a dover essere spiegata, piuttosto che la
devianza. Una versione più recente della teoria del controllo sociale è stata elaborata da
Gottfredson e Hirschi (1990) con la denominazione di teoria generale della criminalità o
teoria del basso autocontrollo. Il crimine non nasce da motivazioni o bisogni specifici ma
dalle pulsioni di tipo egoistico quando vi è un basso grado di autocontrollo. I tratti della
personalità individuale - come l'impulsività, l'insensibilità, l'egocentrismo e le capacità
intellettive - assunti in età precoce durante il processo di socializzazione influenzano la
capacità di autocontrollo degli individui. Se le caratteristiche potenzialmente criminali sono
parte costitutiva della natura umana, la possibilità di intraprendere una carriera deviante
viene a dipendere dal successo o dal fallimento del processo di socializzazione. All'interno
della loro teoria gli autori ricomprendono anche gli assunti di altre correnti teoriche; l'atto
deviante, da un lato, è compiuto dal soggetto sulla base di un'aspettativa di gratificazione e
del calcolo dei costi e dei benefici che ne scaturiscono, che configurano una disposizione
razionale da parte del deviante, e, dall'altro, presuppone delle condizioni favorevoli esterne
e interne al soggetto.
Le teorie dell’apprendimento sociale
► La prospettiva teorica e la dell’apprendimento operante
Albert Bandura, e la sua teoria dell'apprendimento sociale, è stato un autore
fondamentale nel passaggio dall'approccio comportamentista verso la definizione del
cognitivismo. La sua teoria risulta poi una delle più rilevanti per la sua estesa analisi dei
fattori individuali e contestuali che determinano il funzionamento della personalità. Tale
teoria si costruisce intorno a due principi chiave: il primo riguarda le linee concettuali e gli
assunti alla base della condotta individuale, il secondo riguarda la tipologia di variabili
finalizzate alla costruzione di un modello teorico sui processi sottostanti alla condotta. La
teoria dell'apprendimento sociale rappresenta una delle prime teorie di Albert Bandura.
L'autore evidenziò come l'apprendimento non implicasse esclusivamente il contatto diretto
con gli oggetti, ma che avvenisse anche attraverso esperienze indirette, sviluppate
attraverso l'osservazione di altre persone. Bandura ha adoperato il termine modellamento
(modeling) per identificare un processo di apprendimento che si attiva quando il
comportamento di un individuo che osserva si modifica in funzione del comportamento di
un altro individuo che ha la funzione di modello. Esemplificativi risultano in questo senso gli
studi condotti sull'imitazione di condotte aggressive da parte di bambini che osservavano
un modello. Nell’esperimento della bambola Bobo, Bandura formò tre gruppi di bambini in
età prescolare:
• nel primo gruppo inserì uno dei suoi collaboratori che si mostrò aggressivo nei confronti di
un pupazzo gonfiabile chiamato Bobo. L'adulto picchiava il pupazzo con un martello
gridando: «Picchialo sul naso!» e «Pum!».
• nel secondo gruppo, quello di confronto, un altro collaboratore giocava con le costruzioni
di legno senza manifestare alcun tipo di aggressività nei confronti di Bobo.
• infine, il terzo gruppo, quello di controllo, era formato da bambini che giocavano da soli e
liberamente, senza alcun adulto con funzione di modello.
In una fase successiva i bambini venivano condotti in una stanza nella quale vi erano giochi
neutri (peluche, modellini di camion) e giochi aggressivi (fucili, Bobo, una palla con una
faccia dipinta legata ad una corda). Bandura poté verificare che i bambini che avevano
osservato l'adulto picchiare Bobo manifestavano un'incidenza maggiore di comportamenti
aggressivi, sia rispetto a quelli che avevano visto il modello pacifico sia rispetto a quelli che
avevano giocato da soli. Bandura sintetizza una serie di proprietà agenti in una situazione
di modellamento, che influiscono nell'impatto delle informazioni apprese sulla prestazione:
la somiglianza delle prestazioni, la somiglianza delle caratteristiche personali tra
osservatore e modello, la molteplicità e varietà dei modelli, ed infine la competenza del
modello. Viene identificata come caratteristica fondamentale dell'apprendimento
osservativo (o apprendimento vicario) l'identificazione che si instaura tra modello e
modellato. Più essa sarà elevata, più l'apprendimento avrà effetto sulla condotta del
modellato. Autori di riferimento per la teoria dell’apprendimento sociale:
• Burrhus Skinner e il suo approccio sperimentale allo studio dell’apprendimento: il
condizionamento operante. Bandura supera tale punto di vista, chiamando in causa
fattori cognitivi, che acquistano il ruolo di variabili indipendenti.
• Miller & Dollard (1941), ed in particolare il loro concetto di modellamento.
• Bandura e Walters (1964) per la definizione della teoria dell’apprendimento sociale, e
Bandura (1997) per gli sviluppi della teoria verso il costrutto delle convinzioni di
autoefficacia.
► La teoria del rinforzo differenziale
Un secondo gruppo di tecniche è invece finalizzato al decremento dei comportamenti
inadeguati, e si avvale del rinforzo differenziale di altri comportamenti. Esso è composto
da:
- estinzione, ottenuta non prestando attenzione al comportamento inadeguato;
- saziazione, cioè una somministrazione volutamente eccessiva del rinforzatore;
- pratica negativa, che prevede la ripetizione per un numero troppo grande di volte del
comportamento indesiderato;
- procedure aversive, come il mascheramento visivo, il time-out e l'ipercorrezione.
Bibliografia per l’Esame
•
F.P. Williams e M.D. McSchane, Devianza e Criminalità, Il Mulino, Bologna 2002 (i
cap. 4°,5°,6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°)
•
G. Gennaro, Manuale di Sociologia della Devianza, F. Angeli, Milano 1993 (i cap. 2°,
3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°).
•
H. S. Becker, Outsiders. Saggi di sociologia della devianza, Ed. Gruppo Abele, Torino
2002.
•
E. Goffman, Asylums – Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della
violenza, Biblioteca Einaudi, Torino 2001
•
D. Olweus, Bullismo a scuola, Giunti, Firenze 2007.
•
E. Rossi, Paure e bisogni di sicurezza degli anziani, Bruno Mondadori, Padova 2009.