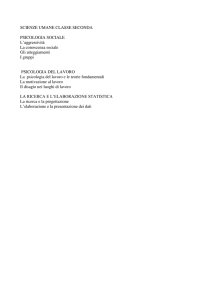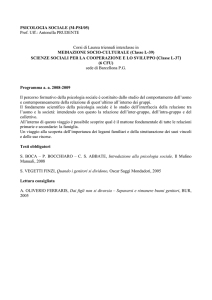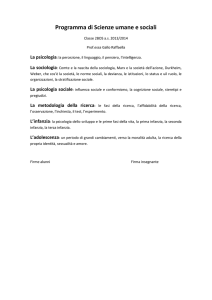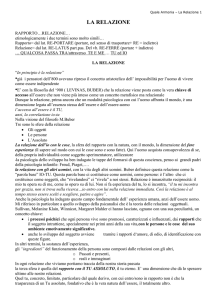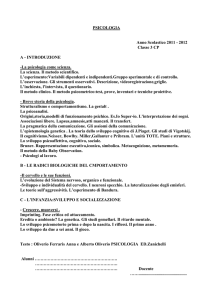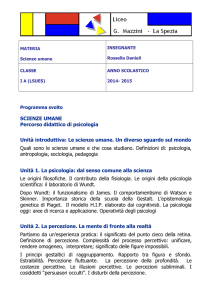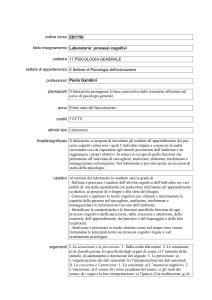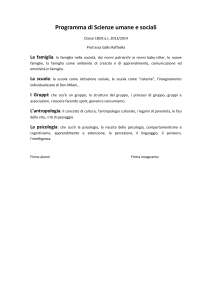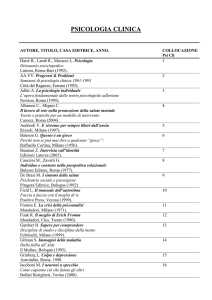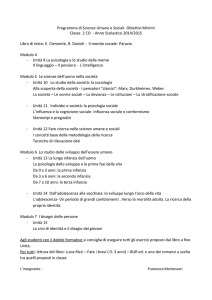Psicologia dell’apprendimento e motivazione scolastica
UNITÀ DIDATTICA 1
APPRENDIMENTO: APPROCCI CLASSICI
Lezione 1
Lo studio dei processi di apprendimento e la psicologia dell’educazione
In queste pagine saranno presentate alcune riflessioni sull’apprendimento, cercando di fornirne una
definizione, di collocarlo all’interno di un contesto, di spiegarne i meccanismi che lo regolano. È
essenziale, prima di addentrarsi nell’analisi delle differenti teorie di riferimento che nel corso del
tempo hanno cercato di dare spiegazioni di tale fenomeno, comprendere che cosa si intenda per
apprendimento e quale sia il suo scopo.
Possiamo intendere per apprendimento un qualsiasi cambiamento che avvenga nell’individuo per
effetto dell’esperienza. Apprendere significa modificare, cambiare, riorganizzare un comportamento
o una conoscenza sulla base di una nuova esperienza vissuta o di un’informazione ricevuta.
Apprendere, però, non è sinonimo di svilupparsi. Apprendimento e sviluppo sono due processi
complementari, ma il secondo termine ha un’estensione più ampia: lo sviluppo della persona
consiste, infatti, nell’insieme dei cambiamenti che si verificano nel comportamento e nelle capacità
dell’individuo con il procedere dell’età. Tali cambiamenti non avvengono necessariamente per
effetto dell’esperienza, ma anche per la maturazione fisica: nei primi anni di vita, ad esempio, si
assiste ad un accrescimento ponderale e staturale del bambino.
Apprendere, al tempo stesso, non si riduce però soltanto allo studio scolastico o all’acquisizione di
nozioni in un contesto formale come la scuola. Apprendiamo ogni giorno della nostra vita, tramite
le azioni, l’osservazione, l’interazione con l’ambiente e con coloro che sono intorno a noi. La
famiglia è il primo contesto in cui il bambino apprende: impara comportamenti, modi di pensare,
atteggiamenti propri della situazione in cui è inserito. Non tutti gli apprendimenti, inoltre, sono
intenzionali: tutti, ad esempio, sappiamo che è pericoloso toccare con una mano un corpo
1
incandescente, ma alcuni di noi lo avranno appreso, magari in tenera età, a proprie spese e
certamente non in maniera intenzionale. L’apprendimento, inoltre, non è un aspetto che riguarda
soltanto la cognizione e il pensiero in senso stretto: dipende anche dallo stato emotivo che stiamo
vivendo e racchiude in sé componenti affettive che determinano fortemente gli esiti di tale processo.
Allo studio dell’apprendimento hanno contribuito diverse branche della psicologia e, in queste
pagine faremo riferimento alla psicologia dell’educazione, alla psicologia dello sviluppo, alla
psicologia generale, alla psicologia sociale, ma anche alla psicopatologia. La psicologia
dell’educazione, in particolare, ha mosso i primi passi agli inizi del 1900, prendendo le mosse dai
primi studi di psicologia generale e sperimentali condotti a partire dalla fine del 1800 su attenzione
e memoria.
In realtà, da sempre l’uomo si occupa di psicologia dell’educazione e lo fa ogni volta in cui riflette
su una qualsiasi azione di insegnamento o di apprendimento: nel V secolo avanti Cristo, Democrito
scriveva sugli indubbi vantaggi dati dalla scolarizzazione e a tutti è noto il metodo maieutico di
Socrate, con il quale il maestro aiutava il discepolo nella ricerca della verità. Platone e Aristotele si
interrogarono su diversi aspetti dell’educazione, quali l’effetto dell’arte nello sviluppo
dell’individuo, la relazione fra insegnante e allievo, la natura dell’apprendimento. In epoca romana,
ancora, Quintiliano forniva indicazioni sulla selezione degli insegnanti e l’adeguatezza dei
curricola. Agli inizi del diciassettesimo secolo, Comenio sostenne l’importanza dell’educazione
finalizzata ad una reale comprensione (e non alla memorizzazione) e propose riflessioni tutt’oggi
attuali sul ruolo della famiglia nell’educazione dei figli. Nella prima metà del diciannovesimo
secolo Johann Friedrich Herbart fu tra i primi a sostenere l’esigenza di un approccio scientifico
all’educazione promuovendo l’istruzione educativa e offrendo validi spunti sulla formazione dei
concetti e degli schemi (Alexander, Winne, 2006).
Nel 1903, uno psicologo statunitense, Edward Lee Thorndike, pubblicò l’opera in tre volumi
Educational Psychology: con questa data si individua la nascita ufficiale della disciplina. Gli ambiti
di studio di tale disciplina sono andati progressivamente diversificandosi: in ambito anglosassone la
2
psicologia dell'educazione ha acquisito presto significato di psicologia applicata all'apprendimento
dei contenuti scolastici, mentre in ambito francofono ha assunto un significato riferito soprattutto
allo studio dei sistemi scolastici ed ai risultati del funzionamento delle istituzioni scolastiche in cui
si attivano processi socio psicologici relativi a gruppi, classi, interazioni, norme e regole, condotte e
obiettivi della loro vita quotidiana.
La moderna psicologia dell'educazione fa propri i concetti inizialmente messi a punto da altre
discipline psicologiche, con le quali ha una relazione bidirezionale e costruttiva: le conoscenze
proprie di tali discipline sono infatti condizioni necessarie ma non sufficienti per la strutturazione di
valide teorie sull’insegnamento. Per molti anni, lo stato scientifico di tale disciplina è stato molto
dibattuto e per lungo tempo essa è stata considerata una disciplina di second’ordine, di esclusivo
carattere applicativo e senza una propria identità. Oggi può essere considerata una disciplina ponte
(Coll, 1988) fra le scienze psicologiche e le scienze dell’educazione: essa infatti è in una relazione
di interdipendenza con le altre branche della psicologia, affianca le scienze dell’educazione per
meglio comprendere il processo di insegnamento-apprendimento e ottenere una maggiore efficacia
dei processi educativi e, infine, grazie alla sua natura anche applicativa, comprende conoscenze per
ampliare e approfondire la dimensione teorico-concettuale, la pianificazione di ricerca e l’intervento
educativo.
Nel corso degli anni, gli interessi della psicologia dell’educazione si sono ampliati ed oggi
riguardano la ricerca applicata alle situazioni educative, identificando i principi che governano la
nascita e le condizioni dell’apprendimento nelle differenti situazioni e creandone schemi esplicativi.
Temi principe oggetto di ricerca sono ad esempio le variabili personali (con riferimento alle
rappresentazioni formali della conoscenza e dei processi ad essi sottesi, le conoscenze di base degli
studenti, la autoregolazione dell'apprendimento, la motivazione, le pre-conoscenze), i processi di
apprendimento (le sue componenti, le strategie di apprendimento, le strategie metacognitivi), la
costruzione di modelli teorici che possano illustrare come si verifica l'apprendimento e quali siano
le relazioni fra le componenti in esso coinvolte, la relazione insegnante-allievo e, più in generale, le
3
relazioni in classe, gli insegnanti e il processo di insegnamento, lo studio delle nuove tecnologie
come mezzo per favorire l’apprendimento, la diversità e le difficoltà di apprendimento, il contesto
familiare e le modalità educative che in essa si attivano.
In queste pagine saranno affrontati solo alcuni aspetti della psicologia dell’educazione e si farà
riferimento particolare alla psicologia dell’istruzione, ossia a quella parte di studi che si rivolgono
principalmente all’analisi dei processi di apprendimento in contesti formali, come la scuola. E’
essenziale che un insegnante e un educatore siano in grado di conoscere i meccanismi fondamentali
dell’apprendimento in modo tale da saper educare i propri allievi. Con educazione, infatti,
richiamiamo il processo attraverso il quale l'individuo impara e fa proprie capacità e facoltà
intellettuali e morali, ad esempio determinate regole di comportamento, condivise dalla famiglia e
dal contesto sociale e culturale. L’etimologia del termine educazione rimanda al latino e-ducere,
che significa letteralmente condurre fuori, portare alla luce qualcosa che è nascosto.
Proseguiremo, ora, affrontando le principali teorie postulate dalla psicologia, partendo da due
approcci classici, il comportamentismo e il cognitivismo, riflettendo sulle correnti dell’approccio
socio-culturale, analizzeremo alcuni processi che intervengono nell’apprendimento e, infine, ci
soffermeremo sul concetto di motivazione scolastica e sui suoi legami con l’apprendimento e il
successo scolastico.
4
Psicologia dell’apprendimento e motivazione scolastica
I Unità Didattica – Lezione 2
Le metafore dell’apprendimento
Come abbiamo appena visto, l’apprendimento comprende una pluralità di abilità che convergono in
un processo complesso in continuo divenire, che si modifica per adeguarsi a forme e contesti nuovi
creati dall’ambiente socio-culturale. Ogni approccio teorico che ha cercato di dare spiegazione di
tale concetto, sottende una concezione di apprendimento particolare che mette in luce l’attività o la
passività dell’apprendente, la causalità o la linearità. In questa lezione prenderemo in
considerazione le metafore utilizzate dai vari approcci per esplicare tale processo. Il pregio della
metafora è sottolineare gli aspetti essenziali di un concetto sconosciuto per renderlo più accessibile
alla comprensione, sottolineando similitudini o affinità con concetti più noti. Considereremo quattro
metafore principali (trasmissione della conoscenza, costruzione della conoscenza, partecipazione a
un gruppo e transazione) e sottolineeremo di volta in volta le concezioni di conoscenza e mente ad
esse sottese.
La trasmissione della conoscenza
Questa metafore si basa su un assunto meccanicistico, secondo cui la conoscenza viene trasmessa
da un emittente a un ricevente in maniera fortemente meccanica. L’informazione trasmessa non è
caratterizzata da alcun tipo di trasformazione e il successo di tale passaggio è dato proprio dalla
capacità di trasferire il messaggio nella medesima forma d’origine. Tale aspetto si riverbera sugli
aspetti valutativi dell’apprendimento: la valutazione è infatti focalizzata sulla similitudine tra
quanto trasmesso dal docente e quanto ricevuto dall’apprendente. La conoscenza è considerata
come qualcosa di statico e di predefinito, che non necessita di aggiustamenti e non è facilmente
modificabile. Se l’emittente ha il compito di stabilire a priori gli obiettivi dell’apprendimento, al
ricevente rimane il solo compito di appropriarsi di tale conoscenza trasmessa, nei modi e nelle
5
forme più simili possibili al messaggio originale. La conoscenza è quindi fortemente statica ed
oggettiva.
Occorre però considerare anche quale ruolo giochino le menti dei soggetti coinvolti nel processo di
apprendimento. Colui che trasmette riveste il ruolo di esperto che è in grado di trasferire la
conoscenza sulla base di conoscenze precedentemente acquisite. Il ricevente, invece, gioca il ruolo
di novizio. La mente di entrambi è considerata al pari di un contenitore che può essere riempito di
concetti e di idee. La qualità e la quantità del contenuto delle due menti è sensibilmente diverso;
non esistono invece differenze se il ruolo di esperto è giocato da un individuo, da un libro o da un
supporto digitale: in ognuno di questi casi la conoscenza è immagazzinata e sistematizzata in una
forma che è difficilmente modificabile.
La costruzione di conoscenza
Questa metafora si incentra sulla costruzione attiva e continua della conoscenza durante il processo
educativo. Rientrano in questa concezione, le riflessioni di Dewey, Piaget, Vygotskij e Leont’ev.
Non esiste conoscenza cristallizzata che viene trasferita da un emittente a un ricevente: la
conoscenza si costruisce, è in continuo divenire grazie alle interazioni che l’individuo ha con
persone e oggetti. Manca in questo caso una corrispondenza tra conoscenza e realtà, proprio perché
la conoscenza è frutto di una costruzione attiva dell’individuo che non descrive pedissequamente la
realtà che esiste in quanto tale, ma la interpreta sulla base della propria esperienza nel mondo. La
conoscenza non è quindi più un dato oggettivo: se essa nasce sulla base di interpretazioni della
realtà, ne deriva che esistano molteplici conoscenze, frutto delle differenti percezioni della realtà di
ogni individuo. La conoscenza quindi è in continua costruzione e varia nel tempo, costruendosi su
base individuale e su base sociale; tale assunto si riflette sugli aspetti valutativi del processo di
apprendimento che non può più considerare la valutazione come un confronto fra il prima e il dopo
ma deve osservare la conoscenza nel suo dispiegarsi. È il processo e non il prodotto ad essere
importante: una valutazione ottimale secondo tale ottica può servirsi ad esempio dei portfoli
6
individuali, di valutazioni e di autovalutazioni. La mente assume un ruolo centrale in tale metafora
diventando strumento e luogo per la creazione di conoscenza. Non ha più valore la distinzione tra
esperto e novizio perché tutti sono in grado di produrre conoscenza e si parla quindi di novizio
intelligente, ossia di una persona che pur non conoscendo approfonditamente un tema, è in grado di
reperire le informazioni mancanti e con esse produrre nuova conoscenza.
La partecipazione ad un gruppo
Aspetto centrale delle due metafore precedenti era la considerazione dell’apprendimento come un
atto cognitivo; in questa metafora, l’attenzione si sposta sugli aspetti sociali e sui contesti
situazionali. L’apprendimento è considerato un processo di acculturazione, ossia un percorso
attraverso il quale l’individuo si appropria della cultura del proprio gruppo di riferimento e la
modifica mediante la sua partecipazione. Non è quindi l’atto cognitivo ad essere centrale, ma la
partecipazione ad un gruppo, la relazione con gli altri, l’essere parte di discorsi e riti di un gruppo
sociale. Questo modello si rifà alle teorizzazioni di Lave e Wenger (1991) che postularono il
modello partecipativo. Secondo tale modello la partecipazione è dapprima periferica: entrando a far
parte di un gruppo si inizia ad osservarne le pratiche, ad interagire poi in alcune attività, fino ad
assumere ruoli più centrali; la partecipazione si sposta quindi dalla periferia al centro,
abbandonando
modalità di
interazione passive per modalità più
attive.
Il
successo
dell’apprendimento è in questo caso dato dal passaggio dalla periferia al centro.
Anello debole di questo modello è dato però dalla sua applicazione alle società moderne: mentre la
partecipazione a gruppi di società, ad esempio, aborigene rispecchiano chiaramente quanto
postulato (sono culture stabili in cui i contenuti culturali, invariati da molto tempo, sono trasmessi
da una generazione all’altra senza variazioni), la stessa cosa non avviene per la nostra società, in cui
si assiste a repentini cambiamenti. L’apprendimento, allora, non è tanto un’acquisizione di pratiche
del proprio gruppo, quando un superamento di pratiche esistenti per giungere a pratiche nuove.
Anche il concetto di conoscenza si modifica radicalmente, è un corpus in continua trasformazione,
7
osservabile solo tramite le attività e le pratiche svolte in comunità. Essa emerge da una continua
negoziazione dei significati all’interno di un gruppo. Non può essere contenuta in un luogo o in un
individuo, ma è una conoscenza distribuita. La partecipazione non solo determina la conoscenza,
ma definisce anche i contesti e le azioni che in essa si verificano. La mente è soltanto uno dei
processi che definisce il processo di acculturazione: è imperscrutabile e si modifica anche solo per
effetto della sua osservazione. L’interesse si sposta sull’identità dell’individuo, come attore del
processo di partecipazione.
La transazione
L’ultima metafora proposta si rifà agli studi di Dewey e alla definizione di apprendimento come una
transazione commerciale in cui si verifica una cessione da parte del venditore e un’acquisizione da
parte dell’acquirente, apportando cambiamenti per entrambi gli attori e modificando anche il
contesto. La metafora prende in considerazione congiuntamente individuo e ambiente nell’intento di
dare una spiegazione della complessità del processo educativo. Tale metafora è stata proficuamente
applicata per illustrare il funzionamento di contesti tecnologici in cui le voci dei singoli individui,
che si producono in un contesto locale e non mediato, generano nuovi contesti telematici (si pensi
ad un forum online). Anche la concezione di conoscenza deriva dalle idee di Dewey, secondo il
quale la conoscenza è ciò che fa ritenere conclusa l’indagine, il risultato della transazione. Se
l’indagine conoscitiva corrisponde alla trattativa (ossia al reperimento delle informazioni, alla loro
valutazione, la conoscenza può essere considerato come il prezzo pagato per la compravendita. In
questo modo, però, l’apprendimento appare un processo finito e limitato nel tempo, ma la
conoscenza prodotta può dare avvio a nuove indagini in un processo circolare continuo. La mente è
uno strumento utile alla ricerca di significati e valori, anche sulla base di esperienze precedenti, con
lo scopo di aumentare il controllo del soggetto sull’ambiente. La mente, quindi, fornisce significato
e senso alla pratiche per mezzo della quali si verifica la transazione.
8
Psicologia dell’apprendimento e motivazione scolastica
I Unità Didattica – Lezione 3
Il comportamentismo
Nei primi anni del 1900 dominavano la scena psicologica gli studi di Wilhem Wundt, un fisiologo e
psicologo tedesco che fondò a Lipsia il primo laboratorio di psicologia sperimentale con lo scopo di
studiare le funzioni elementari della mente (ad esempio, sensazione e percezione) (cfr. Barone,
D’Urso, 2012). Il metodo di Wundt si basava sull’osservazione e sull’introspezione, ossia lo studio
descrittivo delle sensazioni che il soggetto sperimentale provava durante le fasi dell'esperimento.
Inoltre, anche la diffusione delle teorie psicoanalitiche freudiane avevano introdotto nell’ambito
psicologico concetti come mente, inconscio.
Negli Stati Uniti, nel 1913, John Watson pubblicò su Psychological Review, un ormai celebre
saggio nel quale affermava la necessità di rifondare la psicologia su basi scientifiche, bandendo
definitivamente i concetti di derivazione filosofica perché non riferibili a entità direttamente
osservabili. Watson riteneva che soltanto gli atti esteriori dell’individuo dovessero essere oggetto
dell’indagine psicologica; solo l’attenzione ai comportamenti osservabili, ossia qualsiasi risposta
manifesta di un organismo agli stimoli ambientali, avrebbe potuto restituire scientificità e
oggettività alle discipline psicologiche. A partire da tale rivendicazione presero avvio alcuni fra gli
studi più noti sul comportamento umano: l’approccio comportamentista dominò il panorama
internazionale per tutta la prima metà del ventesimo secolo. Secondo tale approccio,
l’apprendimento è un cambiamento che si verifica nei comportamenti dell’individuo a seguito di
una serie di stimoli ambientali.
A fondamento di tale approccio sta la centralità attribuita all’ambiente come motore di qualsiasi
apprendimento. Riprendendo le idee di Platone e di Locke, anche i comportamentisti affermano che,
alla nascita, l’essere umano è una tabula rasa: nessun comportamento e nessuna conoscenza sono
innate, tutto viene appreso grazie all’esperienza. L’apprendimento, quindi, ha un ruolo
9
fondamentale per i comportamentisti che ritenevano possibile spiegare ogni comportamento umano
sulla base delle esperienze pregresse vissute dal soggetto. Da tale assunto consegue la forza
attribuita all’apprendimento: predisponendo l’ambiente in maniera tale da far vivere ad un soggetto
determinate esperienze, sarebbe possibile veicolare l’apprendimento di qualsiasi comportamento
desiderato.
I comportamentisti ritenevano che ogni apprendimento fosse frutto di un condizionamento, ossia di
un’associazione fra uno stimolo ambientale e la risposta fornita dal soggetto. Secondo il
comportamentismo radicale, il condizionamento era in grado di spiegare ogni risposta umana. Due
sono i tipi di condizionamento: il condizionamento classico e il condizionamento operante.
Il condizionamento classico fu teorizzato da Pavlov, un fisiologo russo. Noto è il suo esperimento
sul riflesso condizionato nei cani. Pavlov osservò che, ponendo un cane di fronte ad una ciotola di
cibo (stimolo incondizionato) la sua salivazione aumentava (riflesso incondizionato). Il fisiologo
iniziò così a presentare unitamente alla ciotola di cibo il suono di un campanello o l’accensione di
una luce (stimoli condizionati). Dopo alcune presentazioni, era sufficiente che il cane udisse il
suono del campanello perché si verificasse l’aumento della salivazione (risposta condizionata),
senza che venisse presentata la ciotola di cibo. Che cosa era accaduto? Il cane aveva appreso una
nuova associazione, che faceva sì che una reazione naturale e fisiologica (l’aumento della
salivazione) venisse associato ad un evento non naturale, come la variazione delle condizioni
ambientali. Il condizionamento classico, però, poteva dare spiegazione soltanto di associazioni che
comprendevano risposte già presenti nell’individuo, mentre il modello non si applicava
all’acquisizione di nuovi comportamenti.
Gli studi di Thorndike e Skinner sul condizionamento operante o per prove ed errori cercarono
proprio di colmare questo vuoto, invertendo nei loro esperimenti le fasi del condizionamento
classico e facendo sì che la risposta fosse precedente allo stimolo con funzione di rinforzo (cfr.
Barone, D’Urso, 2012). Il condizionamento operante, infatti, centra l’attenzione sull’azione del
soggetto dalla quale deriva un rinforzo che ha lo scopo di consolidare la messa in atto del
10
comportamento precedente. Come per il condizionamento classico, cerchiamo di comprendere con
un esempio quanto appena letto. Skinner dimostrò che inserendo un topolino in una gabbia, questo
veniva ricompensato con del cibo ogni volta che premeva una leva. La prima comparsa dell’azione
desiderata, ossia la pressione della leva, avveniva in forma del tutto casuale. Il ripetersi della
successione di eventi pressione della leva somministrazione di cibo faceva sì che il topolino si
impegnasse attivamente nella riproduzione del comportamento auspicato dallo sperimentatore. La
somministrazione di cibo aveva secondo Skinner la funzione di rinforzo, ossia uno stimolo con
funzione di aumentare la frequenza del comportamento immediatamente precedente alla sua
comparsa. Skinner differenziò fra il rinforzo positivo, ossia il verificarsi di una situazione piacevole
(come trovare del cibo per un ratto affamato rinchiuso in una gabbia), il rinforzo negativo, ossia il
venire meno di una situazione spiacevole (al ratto non viene più somministrata una scossa se preme
una leva) e la punizione, cioè un evento che diminuisce la probabilità che si manifesti il
comportamento cui è associata (al ratto viene somministrata una scossa se si avvicina all’uscita
della gabbia). Il rinforzo è fondamentale: quando viene meno, i comportamenti indotti tendono a
ridurre la propria comparsa (se il topolino premerà più volte la leva senza ricevere cibo, tenderà a
ridurre il comportamento fino alla sua scomparsa).
Il condizionamento operante trovò vasta applicazione in due ambiti, quello scolastico e quello
militare.
Nel primo caso, Skinner ideò un sistema di istruzione programmata o istruzione lineare mirato a
personalizzare l’apprendimento sulla base dell’accertamento dei prerequisiti del soggetto e un
puntuale controllo e rinforzo dell’apprendimento in corso. Egli mise a punto delle macchine per
insegnare, dispositivi provvisti di schede nelle quali ogni unità di apprendimento veniva scomposta
in unità di contenuto minime e di difficoltà crescente. Sulla base dell’accertamento iniziale ogni
apprendente poteva iniziare il percorso dal segmento più prossimo alle proprie preconoscenze e
proseguire a piccoli passi con costante verifica dell’apprendimento precedente. Tale strutturazione
dell’apprendimento aveva il pregio, secondo Skinner, di minimizzare il più possibile la possibilità
11
di commettere errori. Secondo il comportamentismo, infatti, l’errore deve essere attivamente evitato
poiché impedisce la possibilità di ricevere un rinforzo e quindi riduce gli esiti del processo di
apprendimento e porta il soggetto sperimentare associazioni scorrette. Negli anni successivi, oltre
alla programmazione lineare sono state proposte la programmazione ramificata, che poneva l'enfasi
sulla flessibilità del programma più che sul rinforzo e il mastery learning (apprendimento per la
padronanza), che poneva l'enfasi sul tempo per apprendere a disposizione dello studente.
Con riferimento all’ambito militare, invece, gli assunti del comportamentismo sono stati applicati
alle procedure di addestramento; interessanti contributi sono stati apportati ai concetti di task
analysis e di feedback nell’ambito dello studio dell’apprendimento di abilità percettivo motorie
complesse. Con task analysis, ossia analisi del compito, si intendono le procedure messe in atto per
l’individuazione dei requisiti comportamentali necessari allo svolgimento di un compito, ossia
un’analisi puntuale delle caratteristiche richieste per l’esecuzione di un comportamento complesso.
Il feedback è invece un'informazione di ritorno, attraverso la quale si ottiene la conoscenza dei
risultati ed è importante per valutare l'accuratezza della prestazione in cui si è coinvolti. È, ad
esempio, un feedback l’insieme di informazioni che riceviamo da un docente cui abbiamo
consegnato un elaborato scritto: sono feedback tanto una semplice valutazione, quanto una
riflessione sui punti di forza e di debolezza della nostra prestazione (cfr. Barone, D’Urso, 2012).
12
Psicologia dell’apprendimento e motivazione scolastica
I Unità Didattica – Lezione 4
Il Comportamentismo: prospettive alternative
Nel corso degli anni, alcune critiche furono mosse ai comportamentisti, soprattutto con riferimento
all’indiscusso ruolo del rinforzo come presupposto necessario per garantire l’apprendimento di
comportamenti nuovi e alla volontà di studiare l’apprendimento umano soltanto attraverso
l’osservazione del comportamento manifesto.
Tolman, negli ani Trenta, si occupò di indagare il rapporto fra apprendimento e prestazione,
mettendo in dubbio che ad un determinato livello di apprendimento dovesse sempre corrispondere,
così come postulato dai primi comportamentisti, un medesimo livello di prestazione in un compito.
In altre parole, Tolman si occupò di dimostrare in sede sperimentale l’esistenza di un
apprendimento latente, non direttamente connesso alla ricezione di un rinforzo (cfr. Barone,
D’Urso, 2012). Per verificare la propria ipotesi, selezionò tre gruppi di ratti e osservò i loro
comportamenti in un labirinto. I topi del gruppo A ottenevano del cibo (rinforzo) ogni qualvolta
raggiungevano l’uscita del labirinto, quelli del gruppo B erano lasciati liberi di muoversi per il
labirinto senza alcun rinforzo, mentre i topi del gruppo C erano trattati, per i primi 10 giorni, come
il gruppo B e per la settimana successiva come il gruppo A. Nei primi 10 giorni di sperimentazione
il ruolo del rinforzo era evidente: i ratti del gruppo A dimostravano di aver appreso la struttura del
labirinto, raggiungendo rapidamente l’uscita con una rapida diminuzione degli errori nel tempo;
negli ultimi 7 giorni, però, i ratti del gruppo C raggiungevano rapidamente nelle prestazioni i ratti
del gruppo A, fino a superarli, ottenendo risultati migliori nella ricerca dell’uscita del labirinto.
Come ipotizzato, i topi del gruppo C dovevano avere appreso nei primi 10 giorni la struttura del
labirinto e senza la necessità di alcun rinforzo. Tolman si riferisce a questo proposito alla creazione
di una mappa cognitiva, ossia una rappresentazione mentale della meta e dello spazio che conduce
ad essa: grazie a tale mappa, secondo il principio del minimo sforzo, la meta viene raggiunta per
13
mezzo del percorso più semplice e meno dispendioso. Secondo tale prospettiva, quindi, muta il
ruolo del rinforzo ai fini dell’apprendimento: è utile per la manifestazione del comportamento, ma
non per il suo apprendimento che rimane latente in assenza di una motivazione specifica; il rinforzo
è quindi utile per manifestare un apprendimento ed è quindi maggiormente associato ad un’elevata
prestazione, piuttosto che ad un’avvenuta acquisizione.
Un altro contributo di rilievo fu apportato da Kohler, con riferimento ad un apprendimento che non
riusciva ad essere esplicato dai paradigmi del comportamentismo radicale (cfr. Barone, D’Urso,
2012). Kohler si concentrò infatti sull’apprendimento per insight, ossia quel tipo di apprendimento
che pare verificarsi all’improvviso, senza l’intervento di alcun tipo di rinforzo. Ci riferiamo in
questo caso a quelle situazioni, che tutti noi abbiamo sperimentato, in cui ci sentiamo bloccati da un
problema senza essere in grado di trovare una soluzione fino a che, improvvisamente, la soluzione
appare d’improvviso alla nostra mente, come un’illuminazione. Kohler condusse alcuni esperimenti
con uno scimpanzé rinchiuso in una gabbia. Al di fuori di essa venivano posti della frutta e due
bastoni di diversa lunghezza. Lo scimpanzé, dall’interno della gabbia, non poteva raggiungere
direttamente né il cibo, né il bastone più lungo, ma poteva afferrare il più corto. Per riuscire a
cibarsi, lo scimpanzé doveva servirsi del bastone corto per poter afferrare quello lungo e, solo
grazie a questo, raggiungere la frutta. Le sedute osservative effettuate registravano dei tentativi
dello scimpanzé di raggiungere il cibo tramite il bastone corto e poi dei lunghi momenti di
inattività, in cui lo scimpanzé sembrava disinteressarsi totalmente del problema. Improvvisamente,
poi, giungeva l’insight: lo scimpanzé si serviva del bastone corto per afferrare quello lungo e
avvicinava a sé il cibo. Anche in questo esperimento veniva meno uno degli assunti base del
comportamentismo: non si assisteva ad un apprendimento per piccoli passi o per prove ed errori, ma
l’abilità complessa sembrava venire acquisita improvvisamente e non per progressivi
avvicinamenti. L'intuizione dello scimpanzé era una modificazione repentina e unitaria del campo
che portava a riconsiderare in modo qualitativamente diverso gli elementi in esso contenuti.
Parleremo ancora di insight nel modulo 3 dedicato ai processi di apprendimento.
14
Intorno agli anni Cinquanta, i teorici dell’apprendimento sociale apportarono nuovi contributi
all’approccio comportamentista, oggetto di critiche da parte di molti psicologi in quanto ritenuto
insufficiente a spiegare la complessità del comportamento umano soltanto per mezzo del
condizionamento classico e operante.
È importante ricordare il contributo di Albert Bandura che studiò il concetto di apprendimento
sociale, cercando di calare alcuni assunti del comportamentismo all’interno della fitta rete di
relazioni in cui quotidianamente l’essere umano è inserito (cfr. Barone, D’Urso, 2012). Uno dei
motori dell’apprendimento fin dalla più tenera età, è secondo Bandura, l’imitazione, considerato in
tale prospettiva come un meccanismo autonomo di apprendimento. Dall’osservazione di altre
persone, il bambino apprende comportamenti e atteggiamenti che farà propri senza necessità di un
rinforzo esterno: questo è il motivo per cui gli individui manifestano anche comportamenti mai
rinforzati precedentemente, frutto dell'osservazione di altre persone rinforzate per il loro
comportamento.
Cambia quindi il ruolo affidato al rinforzo che risulta essere necessario più per l’esecuzione della
risposta (creando motivazione) che per l’apprendimento. Se il modello riceve rinforzi positivi questi
avranno un effetto sull’apprendimento dell’osservatore che vorrà compiere la stessa azione per
essere ricompensato; i rinforzi diretti potranno invece consolidare la risposta. Consideriamo un
esempio di apprendimento per imitazione: un bambino che osserva un’insegnante lodare spesso una
sua compagna perché si impegna molto nei compiti, può cercare di imparare a comportarsi nello
stesso modo, così come, al contrario, riuscire a imparare che può farla franca comportandosi
inadeguatamente.
Ulteriore novità apportata da tale approccio è l’attribuzione di un ruolo essenziale al pensiero
cosciente a guida del comportamento grazie alla considerazione delle aspettative, delle credenze,
delle cognizioni di ogni individuo che influenzano ogni essere umano nell’interpretazione della
realtà. Durante tutta la vita, grazie all’osservazione del proprio e dell’altrui comportamento, gli
individui regolano i comportamenti sulla base delle conseguenze delle proprie azioni,
15
considerandone i successi e i fallimenti: in tale modo sono in grado di comprendere che cosa sia
adeguato in una determinata circostanza e di anticipare il risultato di un comportamento.
Ma in quale modo si apprende osservando un modello e cercando di imitarlo? Affinché tale
processo abbia successo e sia efficace è necessaria l’attivazione di alcuni processi cognitivi, ossia:
a) processi attentivi, che consentono la messa a fuoco del modello oggetto di imitazione
b) processi rappresentazionali, che permettono la rappresentazione in memoria della sequenza di
azioni compiuta dal modello e la relativa interpretazione
c) processi di riproduzione, che riguardano la capacità da parte dell’individuo di attuare una
riproduzione motoria, ossia ripetere la sequenza osservata a livello motorio
d) processi motivazionali, ossia la presenza di autoconsapevolezza che permette di individuare quali
vantaggi derivino dall’esecuzione del modello.
A ben vedere, pur nascendo in ambito comportamentista, la teoria di Bandura si colloca più
giustamente nell’ambito cognitivista, richiedendo l’abbandono della sola considerazione del
comportamento manifesto per spiegare l’apprendimento e inserendo la considerazione delle attese
di conseguenze sulla base di eventi passati e l’influenza di opinioni e credenze nell’interpretazione
del mondo.
16
Psicologia dell’apprendimento e motivazione scolastica
I Unità Didattica – Lezione 5
Il cognitivismo HIP
A partire dagli anni Cinquanta, mentre l’egemonia del comportamentismo veniva sempre meno a
causa delle crescenti critiche mosse alla visione meccanicistica dell’apprendimento, presero avvio
alcuni studi che ritornarono a studiare la mente umana tramite le inferenze tratte dai comportamenti
osservabili. Il successo di tali studi fu di portata elevata tanto da trasformare tale prospettiva di
indagine nella prospettiva dominante sulla cognizione e l’apprendimento umano.
Il termine cognitivismo venne però coniato molto più tardi, soltanto nel 1967, quando Neisser, in un
volume dal titolo Cognitive Psychology, esplicitò in una trattazione organica l’attenzione riservata
ai processi cognitivi offrendone un nuovo paradigma esplicativo (cfr. Barone, D’Urso, 2012).
Neisser propose infatti il modello HIP (Human Information Processing) che considerava la mente
umana come un elaboratore di informazioni.
Prima di addentrarci in tale modello, è importante definire, però, che cosa sono i processi cognitivi:
sono le rappresentazioni e i processi mentali che permettono di percepire ed elaborare le
informazioni alla base del comportamento (Job, 1988). Gli individui possono conoscere il mondo
attraverso le funzioni mentali come la percezione, l'attenzione, la memoria, il pensiero. Grazie ai
processi mentali possiamo trasformare, ridurre, lavorare, immagazzinare e recuperare le
informazioni che arrivano ai nostri sistemi sensoriali. Tutte le attività che svolgiamo grazie ai
processi cognitivi sono per la maggior parte consapevoli e attengono alle nostre risposte volontarie
piuttosto che involontarie.
17
Il modello HIP del processo di elaborazione dell'informazione
Neisser riteneva che si potesse effettuare un parallelo fra i processi cognitivi umani e le modalità di
elaborazione dell'informazione svolte da un computer. Un software è infatti formato da una serie di
istruzioni perché possano essere compiute delle operazioni passo passo, che vengono raggruppate e
riunite secondo forme differenti. Alcune istruzioni, vengono conservate nel computer per un tempo
limitato, utile all'applicazione delle operazioni in una memoria temporanea, di servizio, oppure
possono essere conservate in una memoria a lungo termine, un disco fisso, perché possano essere a
disposizione ogni volta che siano necessarie all'elaboratore. Così come il computer, anche l'essere
umano manipola delle informazioni, trasformando le informazioni in ingresso per produrre
informazioni in uscita; così come un computer, l'essere umano ha dei limiti circa la quantità di
informazioni che può manipolare e circa il tempo impiegato per elaborare le stesse. Non stiamo qui
formulando un parallelo fra le caratteristiche fisiche di un elaboratore e di un essere umano: la
metafora propone un'analogia fra le modalità di processare l’informazione.
Confronto dell’informazione
Trasduzione sensoriale
Registro
sensoriale
INPUT
ambientale
o stimolo
Mantiene
l’informazione
nella forma originaria
a cessata stimolazione
Informazione
riconosciuta
Informazione
ignorata
MBT o
memoria
temporanea
di lavoro
MLT o
magazzino
permanente
Compiti cognitivi,
processi di controllo
OUTPUT o
risposta dell’organismo
Fig. 1. Il modello dei magazzini di memoria (Atkinson e Shiffrin, 1968)
Nel 1968, Atkinson e Shiffrin, all'interno degli studi condotti sulla memoria umana, proposero il
modello dei magazzini di memoria al fine di spiegare in che modo l'informazione venisse recepita,
trasformata e conservata dall'essere umano. Se il comportamentismo fino ad allora si era interessato
18
alle associazioni che determinavano un legame fra un determinato input e un corrispondente output,
il cognitivismo cercò di indagare quali erano i processi mentali che intercorrevano fra la ricezione
di un input dall'ambiente e la produzione di un output da parte dell'individuo. Secondo tale modello
esistono tre principali magazzini di memoria, attraverso i quali l’informazione viene processata: il
registro sensoriale, la memoria a breve termine e la memoria a lungo termine. Ogni qualvolta i
nostri sensi percepiscono una sensazione, il registro sensoriale si occupa di conservare tale unità
informativa per poche frazioni di secondo, durante le quali lo stimolo viene confrontato con alcune
informazioni presenti nella memoria a lungo termine, al fine di giungere al riconoscimento dello
stimolo (operando una trasduzione sensoriale). Se lo stimolo viene considerato non utile, viene
ignorato; in caso contrario, l'informazione passa alla memoria a breve termine (o memoria di
lavoro). Tale memoria ha una capacità limitata, sia in termini di tempo (qualche decina di secondo),
sia in termini di spazio (in media 7 unità informative). La memoria a breve termine ha un ruolo
duplice e fondamentale: è il magazzino nel quale transitano le informazioni provenienti dal registro
sensoriale prima di essere trasmesse e conservate nella memoria a lungo termine, ma soprattutto è lo
spazio in cui le informazioni vengono elaborate, integrate e modificate al fine di poter produrre un
output. Il terzo magazzino è la memoria a lungo termine, ossia un archivio potenzialmente illimitato
nel quale vengono conservate, per alcuni minuti o per tutta la nostra vita, le conoscenze, le
esperienze, i fatti personali che caratterizzano la nostra persona. Nell'unità didattica riservata alla
memoria, saranno approfondite le modalità attraverso le quali l'essere umano ricorda più facilmente
determinati informazioni rispetto ad altre.
Un tale cambio di prospettiva nell'indagine dei processi cognitivi, porta con sé una concezione
totalmente diversa del concetto di apprendimento, che non pone più attenzione al prodotto ma al
processo. Il focalizzare l'attenzione sui processi che intervengono tra rappresentazioni di stimoli e la
produzione di risposte richiede nuovi metodi di indagine e nuove concezioni dell'essere umano che
elabora
attivamente
l'informazione.
L'individuo
diventa
costruttore
dell'informazione,
un'informazione che viene rappresentata internamente e che può raggiungere diversi livelli di
19
astrazione; essa si costruisce grazie a più attività separate che operano in concerto e tali attività
possono essere distinte fra loro, ma non possono essere esplicative della complessità del pensiero se
non sono considerate nella loro interezza. L'apprendimento è, quindi, secondo i cognitivisti, un
processo costruttivo, strategico-attivo e interattivo. L'individuo, infatti, costruisce la propria realtà e
la propria conoscenza, compiendo inferenze anche su base motivazionale e affettiva. Le
rappresentazioni del mondo sono organizzate secondo schemi mentali (vedi unità didattica
successiva) che sono creati, modificati, ristrutturati sulla base dei nuovi stimoli e delle nuove
informazioni che pervengono alla nostra mente. L'apprendimento infatti nasce dal confronto tra
l'informazione in arrivo e le conoscenze depositate in memoria; la conoscenza si costruisce sulla
base della conoscenza precedente e a partire da questa si organizza.
L’apprendimento è anche definito strategico perché richiede una strategia, un'attività specifica da
parte del soggetto. Una strategia è una modalità, una procedura per affrontare un compito in vista di
un obiettivo da raggiungere. Le strategie sono in genere attività intenzionali e controllate
dall’individuo, anche se a livelli esperti possono diventare automatizzate. L'uso di strategie
consente di realizzare prestazioni cognitive differenti, più o meno efficaci ed esistono molteplici
strategie funzionali al raggiungimento di obiettivi specifici e all'esecuzione di diversi compiti
scolastici. L'uso di strategie è in stretta relazione con le componenti metacognitive e motivazionali
dell'apprendimento e su di esse si può intervenire per migliorare il processo di apprendimento: le
strategie sono, infatti, modificabili e insegnabili.
Infine, l’apprendimento è un processo interattivo perché nell'elaborazione dell'informazione è
fondamentale l'interazione tra processi dal basso e processi dall'alto, ma anche l'interazione tra il
vecchio e nuovo. Inoltre, ogni apprendimento è risultato dell'interazione tra i processi cognitivi e tra
quelli metacognitivi.
20
Psicologia dell’apprendimento e motivazione scolastica
I Unità Didattica – Lezione 6
La conoscenza: tipologie e strutture. Gli schemi
Uno dei maggiori contributi dell’approccio cognitivista riguarda lo studio approfondito delle
strutture, dei meccanismi e delle strategie che consentono all'essere umano di acquisire conoscenze.
Gli studi che hanno elaborato teorie generali dell'attività cognitiva hanno contribuito ad esplicitare
la distinzione fra alcune conoscenze possedute dall'essere umano.
Anderson ha definito la memoria dichiarativa come l’insieme dei nomi, dei significati, dei fatti,
delle regole e delle date conosciute da un individuo e la memoria procedurale come i modi o le
procedure attraverso le quali l'individuo esegue compiti; se la conoscenza dichiarativa riguarda il
sapere cosa, la conoscenza procedurale riguarda il sapere come.
Tulving ha esplicitato maggiormente le caratteristiche della conoscenza dichiarativa, postulando
l'esistenza di due ulteriori tipi di conoscenza. Nella memoria episodica sono immagazzinate le
informazioni sugli episodi e gli eventi che hanno una precisa collocazione nel tempo (e che quindi
consentono di ricordare un appuntamento o il fatto di aver incontrato un amico): grazie ad essa
possiamo di collocare i fatti su una precisa sequenza temporale, in confronto ad altri momenti e alla
luce delle relazioni con gli altri; nella memoria semantica, invece, possiamo reperire tutte le
conoscenze relative ai simboli verbali, ai significati e abbiamo la possibilità di ascrivere
un'informazione in una classe precisa. Se la memoria episodica è più esposta all'oblio (a causa di
interferenze o di sovrapposizioni con altri ricordi), la memoria semantica è più stabile, poiché tutte
le informazioni sono inserite all'interno di strutture complesse composte da concetti e da relazioni;
nel primo caso le informazioni sono aggregate sulla base di una vicinanza temporale, nel secondo
caso l'aggregazione è relativa ad un'appartenenza categoriale o ad una somiglianza sintattica.
21
Le informazioni contenute nella conoscenza procedurale, invece, si distinguono per la loro
caratteristica di maggiore o minore accessibilità. A volte può accadere infatti che, pur sapendo
eseguire un compito, non siamo in grado di spiegare il procedimento seguito per giungere alla
soluzione. Tale memoria riguarda le abilità e si evidenzia tramite il miglioramento di un fatto
percettivo, motorio, cognitivo. Questo tipo di memoria, per esempio, ci permette di migliorare
sempre di più nel digitare le lettere sulla tastiera di un computer, aumentando rapidità e precisione:
non sappiamo quando e come abbiamo appreso tale capacità, siamo sono consapevoli di possederla.
La memoria procedurale, quindi, si esprime in modo implicito, mentre quelle dichiarativa si esprime
in modo esplicito.
Appurata l'esistenza di diversi tipi di memoria e di conoscenza, è necessario ora soffermarsi su quali
siano le strutture attraverso le quali viene rappresentata tale conoscenza. È necessario introdurre,
quindi, la nozione di schema mentale, ossia unità organizzative della memoria attraverso le quali
rappresentiamo le nostre conoscenze con riferimento ad oggetti, situazioni, eventi e azioni. Gli
schemi possono essere considerati come i mattoni grazie ai quali costruiamo la nostra conoscenza,
gli elementi fondamentali utilizzati per elaborare l'informazione. Ci serviamo degli schemi
ogniqualvolta dobbiamo interpretare i dati provenienti dalla realtà, comprendere situazioni, creare
nuova conoscenza, recuperare determinate informazioni dalla memoria, stabilire scopi e finalità.
Gli schemi mentali possono essere descritti attraverso alcune analogie: possono essere considerati
come un copione di una pièce teatrale, nella quale vi sono personaggi che, pur potendo essere
interpretati da attori diversi di volta in volta, mantengono delle caratteristiche proprie, e nella quale
si tratteggiano situazioni e ruoli diversi. Uno schema può anche essere paragonato ad una teoria
perché viene utilizzato dall'individuo per interpretare situazioni eventi e fenomeni che toccano la
propria vita: grazie agli schemi l’essere umano è in grado di effettuare previsioni e compiere
inferenze su aspetti non direttamente osservabili. Uno schema, infine, ha analogie anche con il
software per un computer: così come un programma è composto da moduli e sotto programmi, così
uno schema è composto da sotto schemi in un continuum fra generale e particolare.
22
Riassumendo, le caratteristiche generali degli schemi sono: avere delle variabili, essere inseribili gli
uni negli altri, rappresentare conoscenze a vari livelli di astrazione, rappresentare conoscenze e non
definizioni, essere stati elaborati attivamente, essere dispositivi di riconoscimento utili alla
valutazione dell'adeguatezza dell'informazione.
La memoria di un individuo è composta da un numero elevatissimo di schemi che vengono di volta
in volta attivati a seconda della situazione. L'attivazione può avvenire secondo processi dal basso,
ossia quando sono i dati ad attivare direttamente gli schemi corrispondenti, oppure secondo processi
dall'alto, quando concetti già posseduti si attivano per cercare di dare interpretazione della realtà.
Una tipologia particolare di schema è lo script, vale a dire la rappresentazione di una sequenza di
eventi che organizza in ordine temporale una serie di azioni compiute per conseguire uno scopo.
Costituisce uno script, ad esempio, l'andare a cena fuori: si entra in un locale, si chiede al cameriere
un tavolo, si prende posto, si ordina, si mangia, si chiede il conto, si paga, si esce dal locale. Gli
script costituiscono una sequenza di azioni predeterminata e stereotipata, definendo situazioni ben
conosciute: non sono quindi facilmente modificabili, né sono utili per affrontare situazioni
completamente nuove. Quando la comprensione, infatti, è guidata da uno script, in una prima fase
viene individuato lo script più adatto alla situazione da comprendere e in una seconda fase si
ricostruiscono gli eventi affinché siano ascrivibili allo script selezionato. Nel caso in cui ci si trovi
in una situazione totalmente nuova, lo script non può essere di aiuto e l’individuo è costretto ad
interpretare la situazione utilizzando soltanto le informazioni che possiede circa il comportamento
delle persone.
Se l’individuo organizza tutta la sua conoscenza attraverso schemi, allora è necessario interrogarsi
sul modo in cui essi si strutturano. Come può l'apprendimento intervenire sugli schemi? Secondo
Rummelhart e Norman (1978) possono avere luogo tre tipi di apprendimento: per accrescimento,
per sintonizzazione o per ristrutturazione.
L'apprendimento per accrescimento si verifica quando vengono incorporate informazioni nuove
entro schemi già disponibili e presenti nella mente di un soggetto. Tali schemi non vengono
23
sottoposti ad alcuna modifica, semplicemente sono aggiunte ulteriori informazioni; in questo caso
l'apprendimento è semplice e non è dispendioso né dal punto di vista cognitivo né dal punto di vista
motivazionale.
L'apprendimento per sintonizzazione (o tuning) avviene quando è necessario modificare gli schemi
attivati al fine di poter interpretare nuove conoscenze. Esistono differenti tipi di sintonizzazione:
una mira a migliorare l'applicabilità dello schema grazie ad una maggiore specificazione dei
concetti e delle relazioni che li caratterizzano, rendendo lo schema più appropriato; una seconda
modalità consiste nel generalizzare l'applicabilità dello schema a più variabili; infine, la
sintonizzazione può consistere anche nella riduzione delle variabili alle quali è applicabile uno
schema o nell'individuazione di dati mancanti che consentono una maggiore chiarezza dello schema
stesso.
L'apprendimento per ristrutturazione si verifica nel momento in cui le nuove informazioni
dell'ambiente non si adattano ad alcun schema preesistente. In questo caso è necessario
l'elaborazione di una nuova struttura o la riorganizzazione in una nuova forma della conoscenza già
immagazzinata. La ristrutturazione è considerabile come il tipo di apprendimento più raffinato,
significativo e impegnativo per il soggetto, sia sul piano cognitivo sia sul piano motivazionale.
24
Bibliografia
Alexander, P., Winne, P. (2006). Handbook of educational psychology. LEA.
Baroni, M.R., D’Urso, V. (2012). Psicologia generale. Torino: Einaudi.
Piaget, J. (1932). Il giudizio morale del fanciullo. Trad. it., Firenze: Giunti, 1973.
25
Psicologia dell’apprendimento e motivazione scolastica
UNITÀ DIDATTICA 2
L’APPROCCIO SOCIOCULTURALE E RELAZIONI IN CLASSE
Lezione 1
Approccio socio culturale e la scuola storico-culturale russa
Nel primo modulo di questo corso, abbiamo affrontato due approcci classici allo studio
dell’apprendimento. In questo secondo modulo ci soffermeremo sugli studi che hanno legato il
concetto di cultura alle teorie sull’insegnamento-apprendimento. A partire dagli anni Settanta, si
affacciò sulla scena psicologica un nuovo approccio allo studio dell’apprendimento che prese avvio
dalle critiche mosse al cognitivismo. Gli studi condotti sulla cognizione umana avevano permesso
di conoscere meglio i processi attraverso i quali l’individuo elabora le informazioni provenienti
dall’ambiente, ma, proprio a causa della metafora proposta dalla HIP, avevano postulato un modello
di cognizione fredda, che non prendeva in considerazione gli aspetti emotivi e sociali del processo
di apprendimento. Inoltre, le prospettive universaliste, che postulavano uniche modalità di sviluppo
e apprendimento per qualsiasi individuo, risultavano poco esplicative di quanto la cultura e il
contesto all’interno del quale viveva la persona potessero influenzare il processo di apprendimento.
Il maggior esponente dell’approccio socio-culturale è Michael Cole, il primo studioso ad inserire il
concetto di cultura come centrale nello studio dell’apprendimento. A Cole va il merito di aver
collocato in una teoria organica il concetto di cultura, ma anche di essere stato il principale
diffusore delle idee di Lev Semënovič Vygotskij, uno psicologo russo, capostipite della scuola
storico culturale russa.
Cole formulò le sue considerazioni partendo dal fatto che le attività quotidiane sono rese possibili
soltanto attraverso oggetti e persone; esse sono cioè mediate da oggetti, persone, strumenti di vario
26
genere, sia materiali sia simbolici, primo fra tutti il linguaggio. Gli strumenti di mediazione del
comportamento umano sono gli artefatti culturali: un artefatto è un qualsiasi aspetto del mondo
materiale, modificato nel corso della storia della sua utilizzazione, all'interno di attività umane
dirette ad uno scopo. Gli artefatti sono al tempo stesso materiali (hanno una forma e un materiale
specifico), ma anche concettuali (hanno un nome, sono stati inventati e creati da qualcuno, sono
stati originati da interazioni sociali). Cole propone tre livelli di artefatti: il primo livello comprende
utensili, strumenti per scrivere, o anche il linguaggio stesso; il secondo livello è rappresentazione
degli artefatti di primo livello e può essere descritto come l’insieme dei modelli di azioni nei quali
gli artefatti sono impiegati; il terzo livello, infine, comprende concetti, convenzioni, norme che
costituiscono sistemi di credenze, come ideologie, filosofie, religioni. Se gli artefatti sono il perno
della mediazione culturale, allora la cultura è l’insieme organizzato degli artefatti.
Cole trasse profonda ispirazione dalle opere di Vygotskij, secondo il quale gli artefatti, e di
conseguenza le attività pratiche della vita quotidiana, si sviluppano nel corso della cultura
all'interno del suo sviluppo storico. Le attività pratiche consentono all'individuo di appropriarsi
degli artefatti culturali, i quali per la maggior parte appartengono anche alle generazioni precedenti;
gli artefatti, quindi, diventano mediatori della cultura producendo effetti sull'uomo, sui suoi
comportamenti e sulle sue caratteristiche psicologiche. Se l'essere umano si appropria di artefatti già
prodotti e utilizzati da generazioni precedenti, diventa allora fondamentale il dispiegarsi della
cultura nella storia: appropriandosi di artefatti già prodotti, l'uomo si appropria della cultura delle
generazioni precedenti, ma produce anche nuove possibili forme e usi di artefatti per le generazioni
successive.
Le fonti ispiratrici dell’approccio vygotskiano possono essere rintracciate nella filosofia di Hegel e
di Marx, che costituivano anche gli strumenti culturali utilizzati in Russia a partire dalla rivoluzione
del 1917 per fondare la nuova società comunista. In contrapposizione delle idee di Piaget,
conosciuto da Vygotskij attraverso le prime opere degli anni Venti, sostiene la relatività dello
sviluppo cognitivo in rapporto alla cultura di appartenenza del singolo. Lo sviluppo cognitivo deve
27
essere, quindi, inquadrato secondo quattro diversi ambiti che concorrono al formarsi della mente: lo
sviluppo della specie, lo sviluppo storico e culturale dell'umanità, lo sviluppo del singolo individuo
e quello di ciascun singolo processo psicologico. Ogni qualvolta, quindi, si parli di sviluppo
cognitivo dell'individuo, tale sviluppo deve tenere conto dei processi di cambiamento che agiscono
sui restanti tre piani.
Vygoskij affermava che lo sviluppo umano ha una doppia matrice: una biologica e una culturale.
Alla matrice biologica, universale per ogni individuo, corrisponde lo sviluppo delle funzioni
psicologiche primarie (come la percezione, l’attenzione…) che l’essere umano condivide anche con
il mondo animale. Le funzioni psicologiche secondarie, invece, hanno una matrice culturale, sono
ossia determinate dalla cultura in cui l’individuo è immerso.
A partire da tali assunti, Vygotskij enuncia la legge generale dello sviluppo culturale: ritiene cioè
che ogni funzione psichica superiore si presenti due volte nel corso dello sviluppo culturale degli
individui e si possa già osservare nello sviluppo dei bambini: inizialmente si presenta sul piano
sociale (interpsichico) e, solo successivamente, sul piano individuale (intrapsichico). Il processo
sociale evidenziato da Vygotskij riguarda il rapporto tra individui coinvolti in interazioni in piccoli
gruppi, mediato dall'uso di strumenti prodotti dalla cultura e trasmessi di generazione in
generazione, di cui devono appropriarsi. Lo psicologo russo distingueva fra gli strumenti tecnici,
definibili semplicemente strumenti, da quelli psicologici o segni. Se uno strumento è rivolto al
mondo esterno per produrvi un cambiamento, un segno (ad esempio, il linguaggio, il calcolo, la
scrittura, le opere d'arte, le tecniche mnemoniche) è, invece, rivolto all'interno per influenzare
psicologicamente il comportamento, ossia regolarlo e controllarlo. I processi mentali hanno uno
sviluppo culturale in quanto vengono trasformati dai segni o strumenti psicologici: ad esempio, il
linguaggio scritto, usato per ricordare meglio qualcosa, trasforma la memoria stessa oltre che
aiutarla, mettendo l'individuo in grado di essere consapevole di tale funzione e di poterla
controllare. Pensando ad esempio al linguaggio, osserviamo come questo permette al fanciullo di
comunicare con gli altri, di regolare il loro comportamento chiedendo che facciano o che gli diano
28
qualcosa, così come di essere a sua volta regolato dagli altri, facendo ciò che gli dicono. Le capacità
interpsichiche sono gradualmente interiorizzate, trasformandosi in individuali e intrapsichiche:
grazie ad esse il bambino è in grado di regolare il proprio comportamento e di progettare le proprie
azioni. In un primo tempo, il fanciullo è capace di orientare il proprio comportamento soltanto
parlando a voce alta da solo, ad esempio commentando cosa sta disegnando o esplicitando ciò che
fa. Solo in un secondo tempo, intorno ai sette-otto anni, egli non avvertirà più la necessità di parlare
a voce alta o bassa: a quel punto il fanciullo dispone di un linguaggio interiore per mezzo del quale
pensare a ciò che sta facendo o intende fare. Il linguaggio interiore rende accessibili altre attività
psichiche, come il ragionamento. Ecco come un'attività, inizialmente eseguibile dal bambino solo
sul piano sociale, diventa ragionamento come attività intrapsichica.
L'interiorizzazione viene descritta da Vygotskij attraverso quattro fasi identificabili nell'interazione
tra un bambino e un adulto su un problema da risolvere. Inizialmente, il bambino risponde alle
stimolazioni ambientali in maniera diretta, non mediata cioè da alcun segno; l’adulto in interazione
con lui può controllare il suo comportamento solo agendo sugli stimoli. Ad un certo punto, il
bambino comincia a utilizzare un segno esterno che non padroneggia completamente, ma che lo
svincola dalla risposta immediata allo stimolo; in seguito, il bambino, ripetendo l'operazione con
l'aiuto dell'adulto, diviene consapevole del ruolo del segno come supporto della sua attività mentale.
Infine, il bambino non ha più bisogno del supporto dell'adulto né del segno materiale, perché ha
effettivamente interiorizzato la funzione del segno ed è in grado di utilizzarla autonomamente.
29
Psicologia dell’apprendimento e motivazione scolastica
II Unità Didattica – Lezione 2
Il concetto di Zona di Sviluppo Prossimale
In questa lezione, focalizzeremo la nostra attenzione sulle ricadute evolutive della teoria di
Vygotskij. Il forte ancoraggio delle funzioni psicologiche umane ad origini sociali porta con sé la
necessità di porre attenzione fondamentale alle condizioni concrete nelle quali i bambini crescono,
in particolare al ruolo degli adulti o comunque delle persone più grandi, come già esperti della
cultura. Se ogni funzione psicologica superiore si presenta prima a livello interpsichico, non è allora
possibile valutare le abilità cognitive del bambino secondo una concezione statica (si pensi al QI
così come valutato da Binet e Simon): è necessario utilizzare una concezione dinamica, partendo
dall'assunto che esista un potenziale intellettuale che non viene messo in luce se si utilizzano
strumenti di misura esclusivamente individuali.
Vygotskij definisce la zona di sviluppo prossimale come la distanza fra il livello di sviluppo attuale,
definito dal tipo di abilità mostrata da un soggetto che affronta individualmente un compito, e il
livello di sviluppo di cui un soggetto dà prova quando affronta un compito del medesimo tipo, con
l'assistenza di un adulto o di un coetaneo più abile. Si tratta, ossia, di una zona determinata da due
limiti: il limite inferiore è dato dalla capacità individuale, il limite superiore dalla capacità della
stessa persona quando svolge un compito aiutato da una persona più esperta. Le misure statiche dei
testi intellettivi, quindi, non possono misurare in modo esauriente il funzionamento mentale di un
individuo: le funzioni mentali, in costante sviluppo, dovrebbero essere osservate non durante prove
individuali, ma durante la loro costruzione, cioè in attività di collaborazione.
Proprio a partire dal concetto di zona di sviluppo prossimale, Vygotskij ha elaborato il metodo
funzionale della doppia stimolazione per studiare la formazione degli strumenti cognitivi. Vygotskij
presentava ai soggetti una prova considerata al di sopra delle loro possibilità attuali, poiché non
avevano a disposizione gli strumenti adatti a trovare la soluzione. In un secondo momento offriva ai
30
soggetti un nuovo set di materiali, osservando se e come questi diventavano parte della soluzione
del compito; attraverso l'osservazione dei comportamenti messi in atto da un soggetto per giungere
alla soluzione, Vygotskij poteva comprendere come il soggetto costruisce specifici significati e
come organizza l'intera situazione allo scopo di raggiungere la meta. La nozione di zona di sviluppo
prossimale è stata utilizzata da Vygotskij anche nella valutazione di bambini con ritardo nello
sviluppo: egli era convinto che, proprio valutando in modo accurato il potenziale di sviluppo di tali
bambini, fosse possibile assicurare loro un apprendimento più efficace.
Le ricadute del concetto di zona di sviluppo prossimale sull'insegnamento sono fondamentali. Se la
Zona di Sviluppo Prossimale definisce i limiti cognitivi superiori ed inferiori, necessariamente
qualsiasi attività di insegnamento-apprendimento dovrà collocarsi all'interno di tale zona.
L'insegnante dovrà essere capace di proporre compiti adeguati, che non superino i limiti cognitivi
superiori, in modo da non scoraggiare il bambino che non avrebbe alcuna possibilità di risolverli,
ma che si collochino all'interno di tale zona; grazie all'interazione con il bambino su un determinato
prima, l'insegnante spiega, indaga, informa, corregge e spinge il bambino a illustrare il proprio
punto di vista.
I docenti hanno disposizione una pluralità di tecniche e di strumenti utili a stimolare la zona di
sviluppo prossimale; analizzeremo ora in breve l'osservazione di comportamenti, l'utilizzo della
contingenza, il feedback, le istruzioni sul compito, il porre domande, la strutturazione cognitiva.
Durante la sua azione didattica, un insegnante ha la possibilità di offrire comportamenti,
intenzionali o meno, da osservare ed eventualmente imitare. Durante le attività quotidiane
domestiche, ad esempio, è frequente apprendere tramite l'osservazione di modelli: si pensi al
preparare la tavola, aggiustare oggetti, rifare il letto; i bambini partecipano in forma guidata a
queste attività, avendo l'opportunità di osservare e chiedere di collaborar e a parte o a tutta l'attività.
Questo tipo di apprendimento è, però, diverso dall'osservazione diretta comportamentista, poiché,
durante la partecipazione, i soggetti negoziano il significato delle azioni e degli oggetti presenti in
quella situazione.
31
L'utilizzo della contingenza, invece, fa riferimento a una modalità di controllo della produzione dei
comportamenti: l'insegnante, o il genitore, può fare uso di premi o punizioni di vario genere con lo
scopo di ottenere dal bambino la produzione del comportamento auspicato, oppure la non
ripetizione di un comportamento non desiderato. I premi utilizzati possono essere diversi:
incoraggiamenti verbali, piccoli doni, denaro, privilegi simbolici. In ambito educativo, le punizioni
fanno quasi esclusivamente riferimento alla mancata consegna di un premio, o alla sua sottrazione,
o a rimproveri di tipo verbale. L'utilizzo della contingenza, soprattutto se legato alla concezione
meccanicistica del condizionamento operante, può esser a volte inadeguato: Vygotskij criticò
ampiamente gli assunti comportamentisti, ma è necessario sottolineare che tali modalità non sono
comunque incompatibili con un'azione positiva sulla zona di sviluppo prossimale, soprattutto
quando si tratta di riconoscere positivamente e premiare dei successi, e incoraggiare in caso di
fallimento.
Un altro concetto studiato dal comportamentismo che può avere utili ricadute è il feedback, ossia
l'offerta all'allievo di informazioni sull'attività in corso o appena compiuta. Un feedback può essere
tanto una valutazione esplicita (valutazione, voto) anche in riferimento a prestazioni di altri, o un
commento fornito dall'insegnante all'allievo nel corso dell'attività. Nel contesto scolastico tanto gli
insegnanti quanto gli allievi forniscono costantemente feedback; le informazioni di ritorno
dell'insegnante, inoltre, diventano un criterio di riferimento non soltanto per l'alunno a cui è
indirizzato il commento, ma per tutta la classe che dispone di un obiettivo per il quale regolarsi
nell'esecuzione di compiti futuri.
Tanto nella vita quotidiana così come scuola, ai bambini è spesso richiesta l'esecuzione di un
compito o di un attività. Per far sì che il bambino possa operare in modo corretto, è fondamentale
che l'insieme di informazioni ricevute siano chiare e poste all'interno di un sistema di obiettivi
condivisi e espliciti. Il fornire istruzioni sul compito, quindi, esplicita al bambino un contesto di
azione che giustifica e orienta il comportamento in funzione dello scopo.
32
Una delle attività più frequenti svolte dall'insegnante è il porre domande agli allievi. Le domande
che innescano un'attività cognitiva e verbale negli alunni (che cos'è la fotosintesi clorofilliana?)
consentono all'insegnante di osservare il livello potenziale di funzionamento cognitivo degli allievi
e di assisterli nella formulazione di ipotesi e di concetti, nell'individuazione di esempi e nella
elaborazione di conclusioni. Non tutte le domande però innescano attività cognitiva: alcune
domande sono esclusivamente valutative, retoriche, fuorvianti; nel formulare la domanda è
fondamentale che l'insegnante trasmetta un genuino interesse al pensiero del bambino e non
all'espressione di un giudizio su di esso.
L'insegnante, infine, può rendere disponibile al bambino le modalità adulte di strutturazione del
pensiero e dell'azione. Può fornire all'allievo strutture di spiegazione, ossia definizioni di concetti o
relazioni che intercorrono fra gli elementi di un tutto, o strutture che permettono di organizzare
attività cognitive, ossia suggerimenti su come memorizzare meglio, raccogliere in maniera adeguata
dati scientifici o organizzare le conoscenze.
33
Psicologia dell’apprendimento e motivazione scolastica
II Unità Didattica – Lezione 3
Lo scaffolding: una riflessione sulla figura del tutor
Tutti gli strumenti fino qui elencati trovano applicazione all’interno dello scaffolding. Il termine
significa letteralmente “creare un’impalcatura” ed è stato introdotto nel 1976 da Wood, Bruner e
Ross come metafora per illustrare le modalità degli adulti di organizzare le attività con i bambini.
Gli studi sull’argomento hanno interessato soprattutto l’interazione delle madri con i propri figli nel
secondo semestre di vita, ma le stesse caratteristiche sono state riscontrate anche nelle attività con
bambini di età prescolare.
Le funzioni dello scaffolding sono molteplici: riguardano il coinvolgimento del bambino ed il suo
interesse per l’attività, il mantenimento dell’attenzione, la riduzione delle difficoltà che il compito
può presentare, la segnalazione delle caratteristiche specifiche dell’attività per favorirne la
comprensione e il controllo degli insuccessi al fine di evitare la frustrazione che può impedire la
prosecuzione del compito. Vengono utilizzate le varie componenti elencate precedentemente:
nessuna di esse garantisce da sola il raggiungimento dell’obiettivo, ma la combinazione dei diversi
interventi si rivela essere più efficace per ottenere un progresso delle abilità individuali del
bambino.
Un’estensione della nozione di scaffolding si ritrova con la nozione di tutor, ossia quella particolare
figura professionale che si assume il compito di sostenere un allievo (o un gruppo di allievi)
guidandone le attività formative o lavorative per mezzo di un rapporto personalizzato e mediando i
rapporti fra le figure di riferimento e l’allievo stesso.
Wood (1989) ha evidenziato un modello di apprendimento nel quale tutor e allievo si distribuiscono
in modo diverso i compiti e le decisioni per la realizzazione di un’attività. Gli interventi dell’adulto
variano attraverso cinque livelli secondo le competenze dell’allievo: più questo è responsabile e
abile nella gestione del compito, meno il tutor interverrà direttamente nel lavoro, lasciando
34
maggiore libertà di azione al bambino, limitandosi soltanto ad indicazioni generiche mirate più alla
motivazione e all’attenzione che a fornire strutture di spiegazione per la prosecuzione del compito
tramite istruzioni verbali o dimostrazione concreta di azioni.
La Zona di Sviluppo Prossimale, oltre alle interazioni fra adulto e bambino, trova applicazione
anche fra i coetanei. I primi studi risalgono agli Stati Uniti dei primi anni Sessanta di fronte ai
problemi di scolarizzazione di massa e insuccesso scolastico. Molti autori hanno documentato gli
effetti dell’insegnamento fra pari, notando che erano i tutor coloro che traevano maggiore profitto
dall’attività con l’aumento della fiducia nelle proprie capacità, della socializzazione, dell’impegno e
il miglioramento del profitto. Tutto questo sembrava riconducibile alle dinamiche di socializzazione
che si attivavano grazie alla responsabilizzazione dei tutor da parte degli insegnanti.
Le metodologie dell’apprendimento cooperativo o dell’apprendimento reciproco, ad esempio, sono
nate da studi condotti sulla ZOPED e si rivolgono a bambini in età scolare.
Esperienze positive si trovano anche in ambito lavorativo e formativo. Nell’ottica della prospettiva
teorica situazionista, che considera l’acquisizione della conoscenza come il frutto di una
negoziazione dei significati fra una pluralità di soggetti, Lave e Wenger (1991) hanno proposto la
nozione di partecipazione periferica legittima secondo la quale gli individui che vivono in una
specifica comunità di pratiche si appropriano progressivamente del linguaggio e delle pratiche
sociali che si sviluppano all’interno della comunità stessa, diventandone partecipanti attivi
attraverso la partecipazione guidata e l’appropriazione partecipata. La prima presuppone una
condivisione degli scopi, delle responsabilità ed il rispetto dei compiti assegnati: il ruolo di guida è
attribuito in funzione dei valori culturali e sociali; il concetto di appropriazione partecipata vede
invece l’individuo modificare gradualmente i suoi comportamenti verso modalità più competenti
grazie proprio alla partecipazione all’attività della comunità: tutto ciò gli consente di partecipare in
maniera più fattiva allo sviluppo ed alla trasformazione della comunità stessa.
35
Bruner (1983), in un prolungamento delle idee di Vygotskij, considera lo sviluppo come un
processo di assistenza, di collaborazione fra il bambino e l’adulto, quest’ultimo nel ruolo di
mediatore con la cultura e il mondo esterno. Caratteristiche degli esseri umani sono la capacità di
apprendere e in ugual modo quella di insegnare.
Nella ricerca educativa sui processi cognitivi, il ruolo dei processi intrapsichici è in secondo piano
rispetto a quelli interpsichici: l’attenzione è quindi rivolta a rendere accessibile il sapere e facilitare
la comprensione nelle interazioni. La negoziazione, la costruzione e la condivisione del sapere si
fondano sull’intersoggettività che Bruner considera una delle caratteristiche più specifiche
dell’essere umano. La capacità di esplicitare il proprio ragionamento, di renderlo più accessibile
attraverso la metacognizione, è molto importante per colui che deve imparare ad apprendere:
conferisce al pensiero un carattere pubblico, negoziabile ed estremamente formativo. In questa
prospettiva, in cui apprendere è un processo interattivo nel quale le persone imparano le une dalle
altre, Bruner vede l’insegnamento mutuo come un metodo efficace che permettere di gestire meglio
la diversità con il sostegno agli alunni meno esperti, favorisce l’emulazione e, sul piano della
costruzione dell’identità personale, facilita l’inserimento nella comunità scolastica.
Wertsch (1985) ha indagato i rapporti dialettici fra i processi psicologici individuali e i processi di
interazione sociale. Negli scambi la mediazione ha un ruolo essenziale, soprattutto attraverso il
linguaggio, fondamentale per l’organizzazione cognitiva. La mediazione semiotica non è propria
solo dei processi intrapsichici ed è attivata dal tutor, ad esempio, durante la ricerca dei termini per
aiutare lo studente durante la realizzazione del compito: lo scopo non è soltanto quello di facilitare
il lavoro dell’allievo ma, come già detto, di fornire anche strutture cognitive che consentano di
ottimizzare la logica di risoluzione dello studente e, nello stesso tempo, diventino più consapevoli e
controllate dal tutor stesso grazie ad un processo metacognitivo. Per essere efficace, infatti, il tutor
deve capire quali sono le difficoltà dell’allievo per potergli offrire l’aiuto necessario: riflette quindi
sull’intelligibilità del compito e sulle procedure di risoluzione che possono essere messe in atto.
36
Spesso si può essere portati a pensare che gli effetti positivi derivanti da pratiche di tutorato
ricadano maggiormente su colui che riceve l’aiuto ma, anche se meno visibili, sono molti i benefici
che il tutor può trarre.
Bruner, riflettendo sugli scambi per la negoziazione di significati fra tutor e tutee e la conseguente
costruzione dell’intersoggettività, definisce transazionale la natura del tutorato (Bruner, 1983). La
sua efficacia si fonda proprio sulla qualità degli scambi, su quanto il tutor sa percepire la difficoltà
del tutee e aiutarlo a superarla: i benefici tratti dallo studente dipendono in buona parte dalla
pertinenza e dalla chiarezza delle spiegazioni fornite dal tutor.
L’aspetto transazionale si accosta alla forma di mutualità che contraddistingue gli scambi di tale
tipo di apprendimento: scambi che si fondano sul compito, ma che sono personalizzati e diversi in
ogni situazione e in cui gli aspetti cognitivi e sociali si fondono. Hartup (1988) sottolinea la
presenza di elementi di mediazione freddi e caldi: i primi si riferiscono agli scambi cognitivi e
riguardano le indicazioni per la prosecuzione del compito, i secondi coprono la sfera più emotiva,
mirano al mantenimento dell’interesse e dell’attenzione attraverso un incoraggiamento costante.
Il tutor elabora il sapere in modo tale da non guidare direttamente l’allievo, ma condurlo a
modificare il suo comportamento: deve quindi ricostruire sul piano logico e verbale la sua
conoscenza per poterla rendere accessibile allo studente. Il lavoro di ricostruzione è oltremodo
formativo per il tutor: dovendo costantemente adattare il suo pensiero a quello dello studente, sulla
base delle informazioni tratte dagli scambi che si verificano nella risoluzione del compito, egli
mette in funzione le proprie capacità metacognitive non soltanto per la produzione di spiegazioni,
ma anche durante il controllo e la valutazione delle risposte del tutee; queste potranno poi essere
reinvestite dal tutor e condurranno ad una maggiore consapevolezza del proprio sapere e ad una
migliore organizzazione dello stesso. In un’attività di tutorato, riflettere sull’azione consente al tutor
di crearsi una rappresentazione mentale della risposta dello studente e su di esse riorganizzare la
qualità del proprio intervento.
37
Psicologia dell’apprendimento e motivazione scolastica
II Unità Didattica – Lezione 4
Tutorato fra pari e conflitto socio-cognitivo
La corrente della psicologia sociale genetica colloca il tutorato fra pari nella prospettiva generale di
una costruzione sociale dell’intelligenza: in questo ambito sono numerosi i lavori di Doise, Mugny
e Perret-Clermont. Nelle loro ricerche hanno posto l’accento sull’effetto insegnante (tutoring effect)
vale a dire il vantaggio personale che un bambino può trarre dall’insegnamento che lui stesso dà ad
uno dei suoi compagni. Le interazioni sociali giocano un ruolo fondamentale nello sviluppo
cognitivo: dovendo aiutare un compagno nella soluzione di un compito e esplicitare le modalità di
risoluzione, il “bambino-tutor” compie una profonda rielaborazione del proprio sapere che lo porta
ad accrescere le sue competenze.
Non bisogna, però, pensare che tutte le interazioni sociali abbiano a priori caratteristiche tali da
favorire uno sviluppo: è necessario che si crei un conflitto sociocognitivo fra soluzioni divergenti
proposte dai partners, ad esempio tramite un confronto fra studenti con livelli cognitivi differenti o
durante un’interazione tutoriale asimmetrica.
In quest’ultimo caso, il tutee si trova di fronte ad una divergenza fra la sua risposta e il modello
indotto dal tutor: l’intervento di quest’ultimo ha un effetto destabilizzante che consente al discente
di distanziarsi dalla propria soluzione e di riflettere con maggiore obiettività, portandolo a nuove e
costruttive elaborazioni. Diverso è il punto di vista del tutor perché la risposta dell’allievo non
genera in lui un conflitto sociocognitivo, ma innesca soltanto delle strutture di spiegazione: grazie a
queste, però, i tentativi di valutazione e d’aiuto, messi in atto per ridurre la distanza fra le due
risposte, consentono di essere reinvestiti successivamente in funzione del proprio sapere. Alcuni
autori si sono interessati agli effetti positivi del tutorato sul bambino aiutato, riconoscendo a questa
tipologia di interazione un ruolo importante per l’educazione e lo sviluppo. L’ambiente sociale
stimola la motivazione ad apprendere del bambino, gli fornisce strumenti e mezzi d’apprendimento,
38
regola gli atteggiamenti consentendo una migliore valutazione del proprio prodotto e del risultato a
cui deve tendere. Sono svariate le tipologie di interazione che mettono in relazione gli individui e
che consentono l’acquisizione di nuove conoscenze attivando una pluralità di processi cognitivi e
sociali dipendenti dall’esperienza dei soggetti, dalle conoscenze in gioco, dal contesto e dai rapporti
esistenti fra i soggetti implicati nella relazione: ogni tipologia necessita dello sviluppo di un
modello esplicativo che ne illustri le modalità sociali di acquisizione; tre fra esse sono considerate
particolarmente importanti:
-
la co-costruzione paritaria è caratterizzata da una simmetria di competenze e di relazioni in
cui la realizzazione del fine comune si ottiene attraverso la cooperazione o il superamento di un
conflitto;
-
la tutelle si distingue per l’asimmetria delle competenze in cui un esperto mette le sue
conoscenze e abilità a disposizione di un principiante con l’obiettivo di portarlo alla costruzione di
nuove competenze e all’autocontrollo;
-
l’imitazione è intesa come un utilizzo intenzionale dell’azione dell’altro quale punto di
partenza o guida verso l’obiettivo che si intende raggiungere.
Lo studio del ruolo delle variabili sociali nello sviluppo cognitivo è stato argomento d’indagine di
ricerche che hanno sottolineato l’interesse del tutorato per lo sviluppo della meta cognizione.
Tra le forme di collaborazione messe in atto da un gruppo di soggetti nella realizzazione di un
compito, la collaboration acquiesçante (collaborazione acquiescente, tacita) e la co-construction
consentono di ottenere una maggiore comprensione della dinamiche interattive presenti nel tutorato.
La collaboration acquiesçante è spesso presente nelle interazioni fra partner: si intende con questo
termine il controllo che un soggetto opera sull’altro, incoraggiandolo a proseguire l’esecuzione del
compito e si associa spesso agli interventi che un insegnante mette in atto per rinforzare l’attività
dell’allievo; la co-construction si verifica, invece, quando, a turno, ciascuno contribuisce alla
realizzazione comune dell’attività.
39
Durante queste forme di collaborazione, entrano spesso in gioco due importanti funzioni: quella di
destabilizzazione delle rappresentazioni iniziali e quella di controllo. La prima chiarifica
l’importanza dell’intervento iniziale di un esperto, il quale fa sì che l’allievo ripercorra in modo
critico le fasi che lo hanno portato alla formulazione dell’ipotesi di risoluzione, cosicché possa
cogliere gli eventuali passaggi deboli e trovare nuove strategie di risoluzione, e ha un effetto
positivo anche sul pari più esperto attraverso l’impegno cognitivo che richiede l’argomentare e il
giustificare il proprio punto di vista per renderlo accessibile all’allievo. La funzione di controllo, in
atto in diversi momenti dell’intervento del tutor, evidenzia la natura del suo sforzo cognitivo che si
realizza particolarmente in tre differenti modalità: il controllo verbale dell’attività del tutee, la
precisione nella presentazione del compito e le spiegazioni fornite durante la risoluzione.
Il conflitto socio-cognitivo, però, diventa produttore di apprendimento anche in situazione di
collaborazioni fra bambini di pari livello che interagiscono nella risoluzione di un compito al quale
non riescono a fornire una soluzione corretta a livello individuale. Per giungere alla risoluzione di
un compito occorre collaborazione all’interno del gruppo: solo tramite un lavoro di negoziazione,
che coinvolge processi cognitivi, relazionali e sociali, si può ottenere il consenso dei membri circa
gli obiettivi da raggiungere e il quadro di riferimento: in questa situazione un’insegnante o un tutor
diventano i facilitatori e i garanti dell’attivazione dei processi che conducono alla costruzione
dell’intersoggettività, aspetto cardine di qualsiasi interazione.
A partire dagli anni 70-80, molti studi hanno focalizzato e approfondito aspetti differenti del
conflitto socio-cognitivo. I primi studi hanno avuto origine dall’ipotesi che le interazioni sociali
diventano fonte di progresso cognitivo grazie ai conflitti di comunicazione che si creano fra i
partner, anche quando nessuno dispone della risposta corretta che può costituire il modello da
imitare. Gli esperimenti condotti in tali ricerche richiedevano una risoluzione interattiva alle prove
piagetiane per studiare l’effetto della cooperazione e delle divergenze di punti di vista sulle
acquisizioni cognitive.
40
Tali studi ebbero il merito di sottolineare quali elementi potevano creare difficoltà nell’attivazione
del conflitto socio-cognitivo, che si verifica spesso quando è richiesta la co-costruzione di strumenti
cognitivi più avanzati da parte di soggetti che non sono in grado di risolvere un compito da soli.
Tale richiesta, infatti, implica la comprensione della legittimità di una risposta diversa dalla propria:
se il conflitto si basa e si orienta con riferimento alla relazione interpersonale che lega i partner e si
trasforma in una competizione di forza o bravura, il conflitto non si attiva perché non si creano le
condizioni per un confronto e per l’accettazione di un diverso punto di vista.
Una volta accettato il confronto della propria risposta con quella del partner, però, occorre saper
regolare il conflitto. Questo, infatti, diventa produttore di conoscenza solo quando non viene risolto
da un punto di vista esclusivamente relazionale (compiacenza, condiscendenza, conformismo…): la
soluzione a cui i partner pervengono non è determinata da una negoziazione dei significati a livello
cognitivo, ma ad una regolazione sociale del conflitto, come l’accettazione acritica o la rinuncia ad
integrare diversi punti di vista.
Diversi studi hanno invece focalizzato il proprio interesse sugli aspetti facilitanti la risoluzione del
compito cognitivo assegnato, considerando il ruolo delle norme sociali che il compito stesso evoca.
Per un bambino, ad esempio, è più facile comprendere l’uguaglianza di quantità nei compiti di
conservazione piagetiani1 di due liquidi quando il contenuto dei bicchieri è una bibita, presentata
come ricompensa, offerta in uguale quantità per la partecipazione all’attività. La connotazione
sociale e la sua efficacia dipendono però dalla maniera in cui le norme richiamate dall’adulto sono
comprese dai bambini nella specificità della situazione.
1
Piaget, per dimostrare l’avvenuta acquisizione dell’operazione della reversibilità, utilizzava delle prove chiamate
Compiti di conservazione. L’esperimento più noto prevedeva di porre il bambino di fronte a due contenitori di diversa
forma: il primo, alto e stretto, era pieno di un liquido colorato mentre nel secondo, basso e largo, veniva travasato, di
fronte al bambino, il contenuto del primo bicchiere. Fino ai sei-sette anni, i bambini non sono in grado di comprendere
che
la
quantità
di
liquido
contenuta
nei
due
bicchieri
non
varia.
Si
veda:
http://www.youtube.com/watch?v=B65EJ6gMmA4
41
Psicologia dell’apprendimento e motivazione scolastica
II Unità Didattica – Lezione 5
L’apprendimento cooperativo
L’apprendimento cooperativo è un metodo didattico che si fonda su piccoli gruppi in cui gli studenti
lavorano insieme per migliorare reciprocamente il loro apprendimento.
Per la sua peculiarità organizzativa si distingue sia dall’apprendimento competitivo (in cui gli
studenti lavorano per raggiungere un giudizio migliore di quello ottenuto dal compagno) sia da
quello individualistico (in cui gli studenti lavorano da soli per raggiungere obiettivi di
apprendimento indipendenti da quelli dei compagni). A differenza dell’apprendimento competitivo
e di quello individualistico, l’apprendimento cooperativo può essere applicato a ogni compito, ogni
materia ed ogni curricolo, promuovendo la costruzione di conoscenza tramite la collaborazione in
gruppo.
Centinaia di studi hanno dimostrato che, quando correttamente applicato, l'apprendimento
cooperativo è superiore all'istruzione tradizionale, poiché garantisce un migliore apprendimento,
facilita lo sviluppo di abilità cognitive di alto livello e l'attitudine a lavorare con gli altri; aiuta gli
studenti ad avere fiducia nelle proprie capacità, preparandoli all'ambiente di lavoro.
E' stato dimostrato che il cooperative learning approfondisce le capacità di comprensione e rende
significativo e stabile nella memoria ciò che si è appreso; inoltre, crea relazioni più positive tra gli
studenti, creando uno spirito di squadra, rapporti di amicizia e sostegno reciproco in un ambiente in
cui la diversità viene rispettata e apprezzata. Il Cooperative Learning garantisce inoltre un miglior
adattamento psicologico degli studenti, così come un maggior senso di autoefficacia, una migliore
autostima e immagine di sé: grazie a tale organizzazione gli studenti sviluppano competenze sociali
e una maggiore capacità di affrontare le difficoltà e lo stress.
L’apprendimento cooperativo si contrappone a una conduzione della classe in genere definita come
tradizionale o rivolta a tutta la classe. È un metodo che si fonda sulla mediazione sociale, anziché
42
sulla mediazione dell’insegnante. Nelle modalità con mediazione sociale, le risorse e l’origine
dell’apprendimento sono soprattutto gli allievi. Essi si aiutano reciprocamente e sono
corresponsabili del loro apprendimento, stabiliscono il ritmo del loro lavoro, si correggono e si
valutano, sviluppano e migliorano le relazioni sociali per favorire l’apprendimento. L’insegnante
diventa soprattutto un facilitatore e un organizzatore dell’attività di apprendimento.
Nell’insegnamento reciproco (peer tutoring) gli studenti rispecchiano le differenze esistenti tra
insegnante ed allievo: pur lavorando in coppia, ristabiliscono una relazione asimmetrica, nella
collaborazione fra pari (peer collaboration), invece, gli studenti si trovano alla pari di fronte al
compito da svolgere. Nessuno è in una posizione migliore rispetto agli altri in relazione al contenuto
del compito e tutti devono aiutarsi e collaborare per portare a termine il loro lavoro di
apprendimento.
Quindi, l’apprendimento cooperativo propone un gruppo composto da più persone impegnate su un
compito, realizzando un’interdipendenza positiva tra i membri del gruppo: una volta svolto il
compito non è più possibile attribuire ad una persona soltanto quanto è stato realizzato.
Le caratteristiche tipiche che possono essere importanti per la riuscita di un apprendimento
cooperativo sono la presenza di compiti strutturati, una classe di dimensioni relativamente piccole,
la formazione di gruppi eterogenei per livelli, la somministrazione di frequenti test individuali per
verificare l’apprendimento, il miglioramento delle abilità sociali di ciascun gruppo.
Inoltre, perché il gruppo sia realmente cooperativo occorre che gli insegnanti verifichino che i
gruppi collaborativi siano retti da cinque principi:
- Interdipedenza positiva. I membri del gruppo fanno affidamento gli uni sugli altri per raggiungere
lo scopo. Se qualcuno nel gruppo non fa la propria parte, anche gli altri ne subiscono le
conseguenze. Gli studenti si devono sentire responsabili del loro personale apprendimento e
dell'apprendimento degli altri membri del gruppo.
43
- Responsabilità individuale. Tutti gli studenti di un gruppo devono rendere conto sia della propria
parte di lavoro sia di quanto hanno appreso. Ogni studente, nelle verifiche, dovrà dimostrare
personalmente quanto ha imparato.
- Interazione costruttiva diretta. Benché parte del lavoro di gruppo possa essere ripartita e svolta
individualmente, è necessario che i componenti del gruppo lavorino in modo interattivo, verificando
gli uni con gli altri la catena del ragionamento, le conclusioni, le difficoltà e fornendosi il feedback.
In questo modo si ottiene anche un altro vantaggio: gli studenti insegnano a vicenda i contenuti
oggetto di studio.
- Sviluppo delle competenze sociali. Gli studenti nel gruppo vengono incoraggiati e aiutati a
sviluppare la fiducia nelle proprie capacità, la leadership, la comunicazione, il prendere delle
decisioni e il difenderle, la gestione dei conflitti nei rapporti interpersonali. Le abilità sociali sono
insegnate direttamente, dai livelli più bassi (mantenere un tono di voce basso per non disturbare gli
altri) ai livelli più elevati (saper controbattere costruttivamente in una discussione)
- Valutazione del lavoro. I membri, periodicamente, valutano l'efficacia del loro lavoro e il
funzionamento del gruppo, e individuano i cambiamenti necessari per migliorarne l'efficienza.
Gli esperti di Cooperative Learning distinguono tra cooperative learning informale, esercizi brevi
assegnati in classe a gruppi non fissi di due o più studenti, e cooperative learning formale, esercizi
più lunghi e impegnativi assegnati a gruppi di studenti che lavorano insieme per una parte
significativa del corso. I risultati didattici in entrambi i casi sono efficaci.
Nel Cooperative Learning informale, viene chiesto agli studenti di comporre gruppi per attività
brevi ed estemporanee. I gruppi si formano sulla base del caso e i ruoli all’interno assunti dai
membri senza regole precise. Le attività sono scarsamente strutturate e raramente si reggono sui
cinque principi sopra enunciati.
La questione posta dal docente può riguardare spiegazioni precedenti, l'impostazione della
soluzione di un problema, il completamento di passaggi mancanti in un procedimento di calcolo o
in una procedura sperimentale, la formulazione di una spiegazione su una osservazione
44
sperimentale, l' ipotesi di una serie di cause, il riassunto di una lezione, la formulazione di una o due
domande sugli argomenti relativi ad una certa lezione, l'elenco di possibili difetti di un esperimento
o di un progetto, o la risposta a domande che il docente normalmente fa alla classe durante una
spiegazione.
Una variante a questo metodo è la coppia che ragiona insieme (think-pair-share). Il docente prima
chiede a ciascuno studente di formulare singolarmente la risposta, poi di unirsi in coppie e
costruirne una sola, a partire dalle due risposte individualmente già date. Infine il docente invita
alcuni studenti, appartenenti a coppie diverse, ad esporre la risposta.
La scelta di questi studenti non deve essere fatta né in anticipo, né sulla base della volontarietà.
Infatti se il docente chiedesse di rispondere solo a dei volontari o ad alunni preventivamente
individuati, verrebbe meno l' incentivo per la partecipazione attiva di tutti, che è invece l'essenza di
questo metodo . Se gli studenti sanno che chiunque può essere chiamato, tutti, o quantomeno la
maggioranza, sono motivati a predisporre la miglior risposta possibile.
Nel Cooperative Learning formale, gli studenti lavorano in gruppi su problemi, su progetti o su
relazioni di laboratorio. Il lavoro può essere fatto tutto o in parte in classe, o fuori della classe. Una
interdipendenza positiva si ottiene assegnando ruoli differenti ai vari membri del gruppo, fornendo
un training specifico sui differenti aspetti del progetto ai diversi membri del gruppo e assegnando a
caso a ciascuno studente una relazione su una parte del progetto.
Alla fine si valuterà sia ogni singola relazione, sia il progetto complessivo del gruppo.
L'impegno individuale viene assicurato esaminando ogni studente su ogni aspetto del progetto
elaborato dal gruppo.
45
Psicologia dell’apprendimento e motivazione scolastica
II Unità Didattica – Lezione 6
Relazione insegnante-allievo
Il contesto scolastico e quello della classe rappresentano un terreno fertile per la formazione e lo
sviluppo di esperienze relazionali da parte dei bambini e offrono loro molte occasioni di instaurare
rapporti significativi con figure adulte non genitoriali. Le relazioni tra bambini e adulti in ambito
scolastico rispecchiano il genere di relazioni che gli stessi bambini vivono a casa, nella loro
famiglia. Prima di chiarire bene che cosa si intende per relazione insegnante-allievo, è bene
soffermarsi sul termine “relazione”. Esso presenta una doppia radice semantica con un duplice
significato connesso ai due verbi costitutivi: il verbo referre, che significa riferire, e il verbo
religare, cioè legare. Il primo verbo rimanda all’immagine della scuola come portatrice di senso;
l’insegnante, infatti, non si limita a trasmettere contenuti disciplinari, ma comunica modi di sentire,
di percepire e di pensare la società. Il verbo religare vuole rendere evidente che, per trasmettere una
qualsiasi informazione tra due posizioni, deve necessariamente esistere un collegamento. Questo
ponte di contatto, tra l’insegnante e l’allievo, risiede nel sentimento della fiducia, fondamento sicuro
per creare legami affettivi importanti.
La relazione diadica tra alunno e insegnante costituisce una particolare risorsa, soprattutto nelle
prime classi della scuola primaria, quando ciascun bambino sente di intrattenere un rapporto unico e
privilegiato con il docente. Il maestro instaura con gli allievi una relazione molto importante, in
quanto si ritrova a ricoprire il ruolo di sostituto dei genitori.
In effetti, con l’ingresso nella scuola elementare si consolida il processo di parziale separazione
dalla famiglia e il ruolo dei genitori si differenzia da quello rivestito dall’insegnante; anche le regole
di convivenza diventano più complesse, infatti, i legami affettivi privilegiati che il bambino
intrattiene con i familiari devono integrarsi con nuove relazioni di diversa intensità e rilevanza, in
46
cui gli adulti sempre più si predispongono come modelli di crescita intellettuale e mediatori
nell’acquisizione di strumenti sociali piuttosto che come figure di attaccamento.
Anche la giornata assume una struttura organizzativa diversa e le richieste di apprendimento
diventano sempre più mirate. L’ingresso nella scuola porta il bambino a eliminare i modi consueti
di parlare, di chiedere e di spiegare per far posto a quelli richiesti all’istituzione. L’alunno tende a
richiamare su di sé l’attenzione dell’insegnante, cercandone l’approvazione per ogni suo atto.
Inoltre, desidera stabilire con lui un contatto oculare, fisico e avere conversazioni, ma cerca anche
di coinvolgerlo nei giochi e nelle attività, preferendo quasi la sua presenza a quella dei compagni.
Dall’altro versante, il maestro svolge un compito molto importante, quasi da poterlo definire
“funzione cerniera” tra il mondo della famiglia e la società più ampia.
Se, da un lato, l’allievo si mostra disponibile a mettersi in relazione con l’insegnante, dall’altra
parte, l’insegnante deve saper sfruttare al meglio questa predisposizione, cercando di avvalersi delle
energie e delle risorse dell’allievo nelle attività formative. Per giungere ad una vera conoscenza
reciproca è necessario molto tempo, e tutto questo risulta essere favorito dai contatti giornalieri.
Le forme relazionali tra bambino e insegnante, così come quelle tra genitore e bambino, possono
variare per natura e qualità.
Alcune relazioni presentano caratteristiche di vicinanza e intimità e sono più affettuose, altre
distanti e formali, altre ancora conflittuali (Pianta, 2001). Da uno studio sulle percezioni degli
insegnanti circa il loro rapporto con gli alunni, Pianta ha individuato sei tipi di relazione insegnanteallievo:
dipendente: in questo caso, la relazione è caratterizzata da un affidamento eccessivo e il soggetto
che apprende è legato alle azioni dell’insegnante, è poco autonomo e responsabile.
Egli ha una forte paura di sbagliare e così interviene poco nelle attività di socializzazione. Tutto
questo può comportare l’isolamento del bambino dai suoi compagni e gelosia verso l’insegnante;
disfunzionale: è il caso in cui la relazione che si instaura tra il docente e l’alunno è mal tollerata,
provoca rabbia e fastidio. Le motivazioni possono essere diverse, ad esempio ingiustizie subite o
47
solamente percepite. Nelle situazioni più estreme la relazione può persino scomparire e le due
figure si ignorano completamente;
mediamente funzionale: è tale la relazione che si esprime in ambito scolastico e scompare al di fuori
di esso. E’ funzionale, ma solo a livelli formali e siccome si consuma all’interno dei ruoli di docente
e alunno, può essere definita come relazione didattica;
rabbiosa: è il caso in cui la relazione presenta conflitti elevati tra insegnante e discente. I due
soggetti sono ostili l’uno all’altro, non si sopportano e non si preoccupano di esprimere con toni
accesi la loro ostilità. Possono subentrare anche comportamenti aggressivi; l’aggressività se
superata, non costituisce un problema grave poiché può dare origine ad un dialogo costruttivo, può
diventarlo se l’ostilità permane, come unica forma di comunicazione;
non coinvolta: indica la relazione che presenta scarso calore, scarsa comunicazione, quasi come se
venisse imposta dalla necessità. Non si avverte il bisogno di contatto;
positivamente coinvolta: è la relazione in cui l’insegnante e l’allievo stanno bene insieme e si
comunicano stima e ammirazione. La comunicazione è buona, il calore e l’affetto permettono a tale
relazione di evolversi nel tempo e l’allievo si sente motivato ad apprendere e ad apprezzare le
attività scolastiche (Iannaccone, Longobardi, 2004).
Altre caratteristiche della relazione riguardano la responsabilità diretta dell’insegnante, in quanto
figura capace di vedere negli allievi i futuri uomini.
Un insegnante, venendo a contatto con gli allievi, dovrebbe porsi alcuni obiettivi fondamentali.
Innanzitutto, un insegnante dovrebbe cercare di aiutare gli allievi a crescere come persone,
sviluppando in loro tutte le potenzialità, sia a livello motorio e intellettuale, che sul piano degli
interessi e della socialità. Tutto questo significa favorire nel bambino lo sviluppo di una fiducia di
base in se stesso e nelle proprie potenzialità, ma anche l’acquisizione della capacità di interazione
con gli altri. Significa poi portare l’alunno ad assumersi delle responsabilità e a saper reagire di
fronte agli insuccessi, senza per questo arrendersi.
48
L’insegnante è colui che si preoccupa anche della crescita intellettuale e culturale degli allievi.
Promuovere lo sviluppo intellettuale del bambino significa favorire lo sviluppo delle capacità di
sintesi, di analisi, di rielaborazione, di simbolizzazione e di ragionamento.
E’ bene ancora che l’insegnante coinvolga gli alunni nelle attività di apprendimento, in modo tale
da far “immergere” l’allievo e le sue energie psichiche in esse.
Infine, l’ultimo obiettivo deriva dal conseguimento dei tre precedenti e riguarda lo sviluppo
affettivo: un bambino instaura un rapporto affettivo con quelle persone che, prendendosi cura di lui,
favoriscono la sua crescita. E’ proprio tale aspetto a gratificare il maestro e a rendere più semplice il
suo lavoro. Altrettanto fondamentale è l’atteggiamento dell’insegnante nei confronti degli allievi;
tale atteggiamento deve essere caratterizzato da accoglienza, per poter individuare e riconoscere le
esigenze dell’allievo, da protezione, per costruire un legame forte e duraturo con il bambino, da
valorizzazione, per individuare le potenzialità del bambino, da tolleranza per l’accettazione delle
infrazioni alle norme, da ascolto, per comprendere i segnali inviati dal bambino e, infine, da
rispetto, per saper riconoscere il bambino come individuo diverso dall’insegnante, ma con bisogni
simili, come quello di conoscere e capire.
E’ bene infine menzionare i requisiti che una buona relazione tra insegnante e allievo deve
soddisfare. Reciprocità, sincronia e coordinazione sono tutti aspetti che permettono al bambino di
autoregolare il proprio comportamento in vista delle richieste educative.
49
Bibliografia
Bruner, J. (1983). Il linguaggio del bambino. Trad. it. Roma: Armando, 1991.
Hartup, W.W. (1983). Peer relations. In P.H. Mussen (Ed.), Handbook of Child Psychology (pp.
103–196). New York: John Wiley & Sons.
Iannaccone, A., Longobardi, C. (a cura di) (2004) Percorsi educativi in psicologia scolastica: dalla
prescuola alla scuola dell'obbligo. Milano: Franco Angeli.
Lave, J., Wenger, E. (1991). Situated learning. Legitimate peripheral participation. Cambridge,
Cambridge University Press.
Pianta, R.C. (2001). The Student–Teacher Relationship Scale. Charlottesville: University of
Virginia.
Tirassa, M. (2010). La natura e il ruolo dell'intersoggettività nella comunicazione. In F. Morganti,
A. Carassa, G. Riva (a cura di), Intersoggettività e interazione. Un dialogo fra scienze cognitive,
scienze sociali e neuroscienze (p. 117-135). Torino: Bollati Boringhieri.
Vygotskij, L.S. (1934). Pensiero e linguaggio. Ricerche psicologiche. Trad. it. Roma: Laterza,
1992.
Wood, S. (1989). The Transformation of Work? Skill, Flexibility and the Labour Process. London:
Unwin Hyman.
50
Psicologia dell’apprendimento e motivazione scolastica
UNITÀ DIDATTICA 3
PROCESSI DELL’APPRENDIMENTO
Lezione 1
Memoria
La memoria è la funzione che ci permette di codificare, conservare nel tempo e recuperare le
informazioni tratte dalla nostra esperienza quotidiana. Come abbiamo visto nell’unità didattica sul
cognitivismo, non abbiamo una memoria, ma molte memorie: essa infatti è composta da una serie di
sistemi interconnessi complessi, ognuno dei quali svolge una specifica funzione.
A differenza di sistemi di registrazione come una videocamera o un registratore, la memoria non
porta a una riproduzione fedele della realtà, ma svolge un’attività di ricostruzione: le informazioni
che arrivano dall’ambiente vengono lette, interpretate e ricostruite sulla base dei nostri schemi
mentali e, sulla base di questi, immagazzinate. I primi studi a sostegno del carattere ricostruttivo
della memoria furono condotti da Bartlett (1932; cit. in Antonietti, 1998), il quale domandò ad un
gruppo di soggetti di leggere e rievocare a più riprese una storia della tradizione indiana. Lo
studioso notò che nelle successive rievocazioni i soggetti aggiungevano o eliminavano elementi alla
storia, mostrando così di non ricordarla passivamente, ma di applicare su questa processi di tipo
ricostruttivo, che potevano aver luogo sia nel momento della lettura (codifica) che in quello
successivo della rievocazione (recupero). Tramite la storia proposta da Bartlett, cerchiamo di
comprendere quali processi intervengono nell’elaborazione mnestica. Ecco il testo originale della
storia:
“Una notte due giovani di Egulac si recarono al fiume a caccia di foche e, mentre si trovavano
là, scese la nebbia e l’aria diventò stagnante. Udirono allora grida di guerra e pensarono:
“forse si tratta di una spedizione di guerra”. Scapparono verso la spiaggia e si nascosero
dietro ad un tronco. C’erano delle canoe che risalivano il fiume, ed essi potevano udire il
rumore delle pagaie e videro una canoa che si dirigeva verso di loro. Dentro c’erano cinque
uomini ed uno di loro disse: “che cosa ne dite? Vogliamo portarvi con noi. Stiamo risalendo il
fiume per andare a fare la guerra alla gente.” Uno dei due giovani disse : “Ma non possiedo
51
frecce” “le frecce sono nella canoa” risposero. “Io non verrò. Potrei essere ucciso. I miei non
sanno dove sono andato. Ma tu - disse, rivolgendosi all’altro, - potresti andare con loro”. Così
uno dei due giovani andò, mentre l’altro tornò a casa. E i guerrieri continuarono su per il
fiume, fino ad una città all’altro lato del Kalama. La gente scese vicino all’acqua,
incominciarono a combattere e molti vennero uccisi. Ma ben presto il giovane sentì dire da uno
dei guerrieri: “Presto, torniamo a casa: l’Indiano è stato colpito”. Allora pensò: “Oh, sono
fantasmi”. Non sentiva dolore, ma dicevano che era stato colpito. Le canoe tornarono a Egulac
e il giovane tornò alla sua casa alla spiaggia e accese il fuoco. E raccontò a tutti: Pensate, ho
accompagnato i fantasmi e sono andato a combattere. Molti dei nostri compagni sono stati
uccisi, come anche molti di coloro che ci attaccarono.” Raccontò tutto questo e poi si calmò.
Quando il sole sorse, cadde a terra. E qualcosa di nero gli venne fuori dalla bocca. Il suo volto
si contrasse. La gente balzò in piedi e gridò. Era morto.”
e si veda ora una delle storie narrate alla decima rievocazione:
“Due indiani erano a pesca di foche nella baia di Momapan, quando si fecero avanti altri
cinque indiani in una canoa da guerra. “Venite con noi - dissero i cinque ai due - a
combattere”. “Non posso venire - fu la risposta di uno - perché ho una vecchia madre a casa
che dipende da me”. Anche l’altro disse che non poteva venire perché non aveva armi. “Questa
non è una difficoltà - replicarono gli altri - perché ne abbiamo in abbondanza con noi sulla
canoa”; così egli entrò nella canoa e andò con loro. Poco dopo, in una battaglia, l’Indiano
ricevette una ferita mortale. Ritenendo che fosse venuta la sua ora, gridò che stava per morire.
“Sciocchezze -- disse uno degli altri - non morirai. Invece morì.”
Che cosa è accaduto? La nostra memoria lavora ai fini di agevolare la comprensione del testo: i
dettagli non capiti sono più facilmente eliminati, altri particolari possono essere aggiunti o cambiati
al fine di rendere le storie più plausibili e più comprensibili ai nostri schemi mentali.
Ma quali sono i passaggi che consentono di memorizzare un’informazione ed essere poi in grado di
richiamarla quando necessario? Nell’elaborazione mnestica è necessario distinguere tre processi o
fasi:
1) la codifica (encoding), attraverso la quale l’input in ingresso viene trasformato nel tipo di
codice o rappresentazione che la memoria accetta e riconosce;
2) l’immagazzinamento (storage), che consiste nell’attività di mantenere in memoria
l’informazione codificata;
3) il recupero (retrieval), che corrisponde alla fase in cui l’informazione viene ritrovata per essere
utilizzata.
Le attività ricostruttive, e anche le perdite di memoria, possono riguardare tutte e tre le fasi. A
seconda poi del sistema di memoria coinvolto, codifica, immagazzinamento e recupero avvengono
in modo diverso ed hanno una rilevanza differente.
52
Fin dall’inizio, nella fase della lettura e comprensione del testo, i soggetti interpretavano gli
avvenimenti narrati alla luce dei loro schemi conoscitivi e perciò la storia veniva codificata in
memoria con alcune modifiche. La narrazione subiva poi ulteriori cambiamenti con il passare del
tempo, prima nella fase della conservazione dell’informazione nella memoria a lungo termine ed,
ancora, al momento del recupero.
Nella memoria a lungo termine si hanno relazioni strette tra codifica, immagazzinamento e
recupero. La grande varietà di informazioni contenute nella memoria a lungo termine porta a
modalità di codifica differenti a seconda della tipologia di materiale in ingresso.
Tale materiale viene elaborato al fine di fornire a questo un significato. Il codice preferenziale è
quello verbale, ma possono essere usati anche altri codici, in relazione alle caratteristiche del
materiale e alle caratteristiche individuali delle persone. Si può ad esempio ricordare il timbro di
una voce, l’odore di un piatto particolare, il colore di un fiore.
Sostenere che la codifica richiede elaborazione, attenzione, ricerca di significato del materiale, può
far pensare che l’intenzione di ricordare, la volontà, lo sforzo siano fondamentali per apprendere. Ci
sono però tante situazioni, soprattutto nella vita di tutti i giorni, in cui non ci proponiamo di
ricordare qualcosa, ma ricordiamo in modo incidentale.
Rispetto a queste due tipologie di memoria, qual è più efficace? Un interessante esperimento
condotto da Mandler (1967; cit. in Antonietti, 1998) ha messo a confronto le prestazioni di 4 gruppi
di soggetti: a due gruppi (A e B) veniva esplicitato di memorizzare una lista di parole, agli altri due
(C e D) non veniva richiesto nulla in proposito. I gruppi venivano poi ulteriormente suddivisi: ai
gruppi A e C era richiesto di ripetere le parole della lista più volte e, ai restanti, di raggruppare le
parole in base a categorie di appartenenza. Alla richiesta di indicare la parole ricordate, solo il
gruppo che non sapeva di dover memorizzare e che aveva ripetuto le parole mostrò una prestazione
bassa, mentre i due gruppi che dovevano formare delle categorie avevano, sia in situazione
intenzionale che in quella incidentale, la stessa prestazione. Inoltre tale prestazione era simile a
quella del gruppo che sapeva di dover ricordare e aveva ripetuto le parole. Il sapere di dover
53
ricordare aveva dato gli stessi risultati della categorizzazione. In conclusione, l’intenzionalità, la
volontà e il desiderio di ricordare qualcosa, non producono da soli un miglior ricordo; sono utili
solo nella misura in cui inducono a mettere in atto, nella fase della codifica, processi volti ad
integrare le informazioni in arrivo all’interno della memoria permanente.
L’esperimento precedente focalizza l’attenzione sui livelli di elaborazione della codifica. Negli anni
Settanta, alcuni studiosi cercarono di studiare non tanto i sistemi di memoria ma i processi che
consentivano il ricordo. In un famoso articolo, Craik e Lockhart (1972; cit. in Antonietti, 1998),
svilupparono
il concetto di profondità della codifica, secondo il quale si ricorda meglio un
materiale che è stato elaborato in modo profondo, e quindi significativo, indipendentemente
dall’intenzionalità di apprendere o meno il materiale proposto. La regola è che quanto più profonda,
ricca, ampia è stata l’elaborazione, cioè quanto più è stato profuso uno sforzo per dare significato al
materiale collegandolo con le informazioni che già possediamo, tanto migliore sarà il suo ricordo.
Alcuni materiali sono già di per sé significativi ed interessanti, altri invece richiedono uno sforzo
attivo che dia loro un senso.
In un esperimento, divenuto ormai classico, gruppi differenti di soggetti furono istruiti a codificare a
diversi livelli di profondità lo stesso materiale (Craik e Tulving 1975; cit. in Antonietti, 1998). I
soggetti erano invitati ad analizzare liste di parole ed a rispondere sì o no a domande quali la parola
è scritta in maiuscolo (elaborazione percettiva), fa rima con un’altra parola (elaborazione
fonologica), potrebbe completare la seguente frase (elaborazione semantica). Alla fine,
inaspettatamente, i soggetti erano invitati a ricordare le parole. Le prestazioni migliori si ottenevano
con l’elaborazione semantica, ossia la più profonda.
Come sostenere allora i nostri allievi nell’apprendimento di determinati concetti? Se una buona
memorizzazione dipende dalla profondità dell’elaborazione, sarà fondamentale mettere a loro
disposizione le strategie migliori per affrontare di volta in volta i vari compiti cognitivi, strategie
che punteranno ad una comprensione profonda del materiale piuttosto che ad una pedestre
ripetizione dei contenuti proposti.
54
Psicologia dell’apprendimento e motivazione scolastica
III Unità Didattica – Lezione 2
Attenzione
Prima di iniziare questa unità didattica, il lettore è invitato a visionare il video disponibile
all’indirizzo http://www.youtube.com/watch?v=wg96RSsrXk0 e a cercare di dare una definizione
di attenzione.
Se chiedessimo ad un insegnante o a un educatore di dare una definizione di attenzione,
raccoglieremmo una serie di definizioni incentrate sul rapporto con diversi aspetti connessi
all'apprendimento, quali la memoria, l'interesse, l'esperienza di disattenzione legata alla distrazione
o alla noia.
William James, uno dei più grandi psicologi americani, nel 1890, descriveva l'attenzione in questo
modo:
Ognuno di noi sa cosa sia l'attenzione. Essa è l'atto per cui la mente prende possesso in forma
limpida e vivace di uno fra tanti oggetti e fra diverse correnti di pensieri che si presentano
come simultaneamente possibili ... Essa implica l'abbandono di certe cose, allo scopo di trattare
più efficacemente con altre, ed è uno stato che trova precisamente il suo opposto in quello stato
di dispersione, confusione, che ... viene detto distrazione.
Ma quali sono i meccanismi che permettono di concentrarsi su un determinato oggetto? Perché è
un determinato oggetto e non un altro a colpire i nostri organi sensoriali? Perché ci distraiamo?
L'attenzione ha una durata? E' possibile prestare attenzione a più cose contemporaneamente?
A tutti noi sarà accaduto almeno una volta di giungere a una destinazione familiare in automobile
senza ricordare assolutamente nulla del viaggio compiuto: eravamo talmente assorti nei nostri
pensieri da guidare in completo automatismo. Accade di frequente che molte abilità come nuotare,
andare in bicicletta, leggere o parlare una lingua straniera abbiano richiesto nella fase iniziale
d’apprendimento molto sforzo ed impegno da parte nostra, siano state controllate nella loro
esecuzione e solo successivamente, con l'esperienza e l'esercizio, siano diventate automatiche. Nel
55
momento in cui però ci rendiamo conto che qualcosa differisce dagli abituali schemi di azione,
abbiamo comunque la facoltà di controllare in modo maggiormente consapevole tali attività.
Buona parte dei nostri comportamenti quotidiani è governata da processi automatici che sfuggono
alla nostra consapevolezza, che non richiedono cioè sforzo attentivo o intenzioni precise e hanno la
caratteristica di essere relativamente rapidi, di utilizzare un'elaborazione parallela e simultanea
(pensiamo alle azioni compiute al ritorno a casa come infilare la chiave nella toppa, aprire la porta,
accendere la luce…); tali processi possono essere talmente superappresi da essere innescati anche
quando non si vorrebbe.
Altri comportamenti, come prendere una decisione, risolvere un problema, o compiere una ricerca
sono, invece, processi controllati e si basano sulla consapevolezza, sull’intenzionalità di
raggiungere un certo scopo; hanno una natura seriale e richiedono attenzione, pianificazione e
controllo. Molti apprendimenti scolastici di base dovrebbero con il passare del tempo, e grazie alla
pratica, assumere le caratteristiche dei processi automatici: leggere, calcolare, ascoltare e parlare in
una lingua straniera sono esempi di compiti che dovrebbero diventare automatici, liberando molte
risorse cognitive utilizzabili per altri apprendimenti di natura più complessa e ad alto sforzo
cognitivo.
Quando l’attenzione è cosciente può essere benefica per tre finalità: monitorare le interazioni con
l’ambiente per informare sul grado
di adattamento in esso;
offrirci il senso di continuità
dell’esperienza, grazie al recupero di ricordi e sensazioni; controllare e pianificare le nostre azioni
future. Occorre però distinguere fra attenzione e coscienza: la prima riguarda tutta l’informazione
che viene manipolata cognitivamente, mentre la seconda si riferisce a quella quantità limitata di
informazione che il soggetto è consapevole di manipolare.
La selezione delle informazioni da elaborare avviene grazie all’apprendimento che consente
all’individuo di ignorare gli stimoli diventati familiari e sintonizzarsi su quelli nuovi privilegiandoli.
Si definisce abituazione il processo cognitivo governato dalla relativa stabilità e familiarità dello
stimolo che consente di “risparmiare” capacità attentive da indirizzare sugli stimoli nuovi.
56
Ma quali sono le funzioni dell’attenzione? In questa sede ci soffermeremo su quattro fondamentali:
Attenzione selettiva, permette di “scegliere” alcuni stimoli piuttosto che altri (è la tipologia di
attenzione che ci consente di parlare con amico durante una festa molto rumorosa, in cui sono in
corso diverse conversazioni);
Vigilanza, capacità di prestare attenzione per un periodo prolungato ad un campo di osservazione,
in attesa di un certo segnale (è l’attenzione messa in atto quando attendiamo il suono del clacson
dell’amico che passa a prenderci per uscire la sera).
Ricerca attentiva, un tipo di vigilanza attiva nella quale eseguiamo una scansione dell’ambiente alla
ricerca di stimoli con particolari caratteristiche (entrare in un’aula gremita di studenti, cercando
dove è seduto il nostro compagno di studi);
Attenzione divisa, nella quale suddividiamo le nostre risorse attentive su più compiti
contemporaneamente (leggere un libro sulla metropolitana, in attesa della propria fermata) (Polito,
2012).
Se pensiamo ad una situazione di insegnamento-apprendimento è palese che l’attenzione e la
concentrazione sono prerequisiti fondamentali. Anche le consegne basilari, richiedono durante le
prime esecuzioni un’elaborazione cosciente degli elementi necessari per portare a termine il lavoro.
I compiti scolastici, anche i più semplici, nella fase iniziale richiedono sempre una manipolazione
cosciente delle informazioni necessarie all’esecuzione. Solo l’automatizzazione di determinati
processi permette un’elaborazione al di sotto della soglia della consapevolezza che comporta,
quindi, la liberazione di risorse attentive a vantaggio delle operazioni cognitive più complesse.
Comprendere un testo e studiare, produrre una composizione scritta richiedono processi controllati,
intenzionali e sotto il controllo della coscienza.
Grazie anche alle attività che compie a scuola, lo studente apprende a escludere pensieri distraenti,
emozioni e situazioni non rilevanti con il compito che sta svolgendo. Il livello di concentrazione è
regolato non solo da caratteristiche interne al soggetto (scopi, motivazione, stile cognitivo), ma
57
anche da fattori ambientali ed in relazione con il tipo di compito che deve essere portato a termine.
Sia un ambiente rumoroso pieno di persone che parlano, sia condizioni personali quali stati di
malattia, di stanchezza vanificano lo sforzo per apprendere. Riconoscere che il livello di attenzione
varia in base a differenti fattori può essere il primo passo per riuscire a regolare il livello di
impegno e di sforzo necessario per portare a termine un compito e prevedere se sarà ultimato con
successo o meno.
Con riferimento alla situazione di apprendimento che si sta vivendo, la conoscenza di se stessi e
delle proprie caratteristiche rappresenta un momento fondamentale per giungere alla gestione
consapevole degli stati attentivi; altrettanto importante, però, è anche la riflessione sull’influenza
che l’ambiente fisico ha sulla propria psiche. Una stanza poco luminosa, ad esempio, potrebbe
essere scarsamente stimolante per le capacità attentive, tanto da indurre sonnolenza, stanchezza,
noia. Uno stato di bassa attivazione potrebbe essere indotto anche da compiti troppo facili: eseguirli
anche bene non porterebbe alcuna soddisfazione. Queste consapevolezze dovrebbero far parte delle
conoscenze possedute da un ragazzo che vuole apprendere in maniera strategica, consentendogli di
individuare le modalità a lui più congeniali per il mantenimento dell’attenzione.
58
Psicologia dell’apprendimento e motivazione scolastica
III Unità Didattica – Lezione 3
Problem solving
Spesso ci accade di essere assorti nei nostri pensieri: che cosa facciamo quando pensiamo? Quali
processi attiviamo? Siamo sempre consapevoli di ciò a cui stiamo pensando?
L’azione del pensare richiama, da un lato, l'attività rappresentativa e, dall'altro, la capacità che abbiamo
di ragionare, valutare, risolvere problemi per adattarci alla realtà esterna: con il termine pensare
intendiamo la capacità di manipolare i simboli, sia per entrare in interazione con l'ambiente esterno, ma
anche per ipotizzare nuove e possibili alternative.
Pensiero, però, non è sinonimo di intelligenza: il primo, sostenendosi sull’attività rappresentativa, non
compare prima dei 18-24 mesi del bambino, successivamente, cioè, all’acquisizione della funzione
simbolica; la seconda, invece, fa la sua comparsa più precocemente quando il bambino, in grado di
coordinare gli schemi motori, è capace di eseguire azioni in vista di uno scopo, ossia è capace di
eseguire un comportamento intelligente senza che ancora vi corrisponda una rappresentazione mentale
dei risultati attesi.
Studiare i processi di pensiero significa concentrare la propria attenzione sulla relazione fra gli scopi che
l’individuo si prefigge e le modalità selezionate per raggiungere il proprio obiettivo.
Per un insegnante è fondamentale focalizzare l’attenzione su tali aspetti: conoscere quali sono i modi
spontanei di ragionare dell’essere umano consente di individuare quelli che possono essere gli snodi
fondamentali di una disciplina sui quali è necessario insistere, con le metodologie adeguate, per
garantire la piena comprensione e un apprendimento fattivo.
Che cosa accede nel momento in cui un individuo deve risolvere un problema (ossia superare un
ostacolo per raggiungere un particolare obiettivo o rispondere ad una curiosità)?
Bransford e Stein (1993) sostengono che, di fronte ad una situazione che richiede uno sforzo cognitivo
per essere superata, si attivano una serie di operazioni, aventi caratteristiche di ciclicità.
59
Anzitutto è necessario identificare il problema: a volte capita di non saper riconoscere una situazione
problematica (il dovere evitare di trovarsi sulla traiettoria di una macchina che non viene vista); soltanto
in tal caso siamo in grado di definire e rappresentare il problema in modo adeguato.
Una volta che il problema è stato rappresentato in modo tale da consentire delle operazioni, il passaggio
successivo consiste nella pianificazione di una strategia di soluzione. Tale strategia richiede un'analisi,
ossia la scomposizione del problema complesso in più parti, e una sintesi, grazie alla quale
ricomponiamo in modo utile i diversi elementi. In associazione a queste strategie, un'altra coppia di
azioni cognitive è rappresentata dal pensiero divergente, che tenta di generare il maggior numero di
alternative possibili al problema, e dal pensiero convergente, che dovrebbe orientare verso la strategia
più adeguata e permettere una verifica.
A seguito della definizione della strategia, è fondamentale organizzare le informazioni in modo da
costituire uno scenario nel quale applicare le strategie formulate. Ogni strategia richiede sforzi mentali e
a volte anche risorse materiali, allocando le risorse necessarie sulla base delle forze disponibili. È quindi
necessario dedicare una quantità di risorse mentali alla pianificazione del lavoro complessivo o globale,
focalizzandosi sul suo insieme, per arrivare alla soluzione più adeguata. Alcuni studi hanno evidenziato
che gli studenti migliori, solitamente, impiegano più tempo nella pianificazione della fase iniziale della
crisi, decidendo come risolvere il problema, rispetto gli studenti meno bravi. Probabilmente,
nell'impiegare più tempo per decidere che cosa fare, gli studenti più efficaci hanno meno probabilità di
intraprendere percorsi sbagliati o al di sopra delle proprie potenzialità. Durante la risoluzione del
problema è poi necessario un costante monitoraggio delle attività in corso: le verifiche frequenti
consentono infatti di valutare l’efficacia della strategia adottata e eventualmente ritornare sui propri
passi o apportare lievi aggiustamenti. Infine, giunti al termine del lavoro è necessaria una valutazione
globale che consenta di verificare se l’obiettivo è stato raggiunto o se è necessaria la formulazione di
una nuova strategia, riavviando il ciclo risolutivo.
Definite le tappe fondamentali di risoluzione, consideriamo ora le caratteristiche intrinseche del
problema. In letteratura vengono individuate diverse tipologie di problemi: di trasformazione, di
60
ordinamento, induttivi o deduttivi. Più in generale gli psicologi cognitivisti distinguono i problemi in
problemi ben strutturati o ben definiti e problemi mal strutturati o mal definiti.
I problemi ben strutturati richiedono per la loro soluzione una serie preordinata di mosse. Implicano
percorsi di soluzione chiari anche se non facili. Sono caratterizzati da uno stato iniziale e da uno finale:
il solutore ha il compito di dell'identificare le mosse che permettono la transizione dall'uno all'altro.
Ecco un esempio:
Tre monaci e tre cannibali si trovano sulla riva di un fiume: tutti devono attraversare il fiume
per giungere all'altra sponda. A questo scopo dispongono di una piccola canoa su cui possono
trovare posto solo due persone. Se il numero di cannibali in una delle due sponde supera il
numero di monaci, i cannibali divorano i monaci. Come si può fare affinché tutte le sei le
persone giungano sull'altra sponda, garantendo che i cannibali non divorino i monaci?
La soluzione da individuare è fortemente lineare poiché, nella maggior parte dei passi da compiere,
esiste una e una sola mossa possibile senza che siano violate le regole date. In questi problemi è
necessario un numero minimo di mosse per poter giungere alla soluzione: un numero maggiore di
passaggi si effettua quando inavvertitamente si ritorna ad una situazione precedente invece di
avvicinarsi allo stato finale.
Nello studio di questi problemi, spesso, è stata usata anche la simulazione al computer. Nel modello di
Newell e Simon (1972; cit. in Antonietti, 1998), l’eleboratore considera gli stati iniziali e finali
all'interno di uno spazio problemico che rappresenta l'universo di tutte le possibili azioni che possono
essere eseguite: il problema viene scomposto in passi, e ciascun passo deve attenersi alle regole relative
alle procedure che possono essere implementate. Molti dei programmi di risoluzione consistono in
algoritmi, ossia sequenze di operazioni ripetibili più volte finché non è soddisfatta la condizione posta
dal programma. Un algoritmo è la descrizione esatta di che cosa è necessario fare in una certa situazione
(un po’ come una ricetta di cucina esplicita tutti passi necessari per preparare la pietanza prescelta). Per
mezzo di un algoritmo adeguato, il computer può facilmente calcolare tutte le operazioni e le
combinazioni possibili all'interno dello spazio problemico, determinando la migliore sequenza possibile
per risolvere quel problema.
A differenza del computer, la mente umana non riesce a eseguire tutte le possibili computazioni e alla
stessa velocità per i limiti della nostra memoria di lavoro. Per questo motivo è spesso necessario
61
ricorrere a delle scorciatoie mentali, delle euristiche, ossia strategie di ricerca generali, intuitive e
informali di combinazione degli elementi del problema (si veda l’unità successiva). Le euristiche
entrano in gioco soprattutto quando la soluzione del problema non è immediatamente visibile; a volte
conducono a soluzioni efficaci, a volte no.
Caratteristica dei problemi mal definiti invece è una modalità di presentazione che influisce fortemente
sulla sua soluzione.
Una donna che abitava in un piccolo paese sposò venti uomini diversi del luogo. Tutti sono
ancora viventi e non ha mai divorziato da nessuno di loro; eppure non ha violato la legge.
Come è possibile?
Per risolvere questi problemi è difficile basarsi su una sequenza di mosse che si avvicini sempre più alla
soluzione. È molto più probabile che per risolverli dobbiamo considerare il modo originale, cioè diverso
da come li abbiamo percepiti inizialmente e da come si tende risolvere i problemi in genere. In questo è
probabile che entri in gioco una risoluzione per mezzo dell’insight poiché richiede una
concettualizzazione o ristrutturazione del problema. La ristrutturazione, che fa apparire immediata e
semplice la soluzione, è spesso associata all'idea di illuminazione.
Gli psicologi sono interessati soprattutto comprendere il perché certi problemi siano particolarmente
difficili da risolvere e hanno scoperto che sono molti e diversi i fattori ostacolanti, alcuni dei quali
insospettabili, come una precedente esperienza con problemi di un certo tipo. Alcuni ricercatori
affermano che i problemi più difficili da risolvere sono quelli più astratti o che rendono difficile o
impediscono l'uso delle rappresentazioni mentali. Affrontare un problema con un set mentale (o
trinceramento) che implica un modello preesistente inadeguato alla rappresentazione del problema è uno
dei principali ostacoli. Ne è un esempio il problema della donna: la fissazione su una procedura
conosciuta, un oggetto o sul significato di una parola è ostacolo alla soluzione. La soluzione dell’ultimo
problema? La donna è il sindaco del piccolo paese.
62
Psicologia dell’apprendimento e motivazione scolastica
III Unità Didattica – Lezione 4
Decisione e ragionamento
Spesso dobbiamo decidere aspetti rilevanti per la nostra vita: la scelta di un lavoro, l'acquisto
dell'auto o della casa. Come ci regoliamo quando prendiamo una decisione? Secondo la teoria
classica della decisione, elaborata negli anni Cinquanta, si compiono le scelte sulla base del
principio della razionalità illimitata. Questo modello assume che l'uomo sia totalmente informato,
infinitamente sensibile all'informazione e completamente razionale. Le scelte, quindi, avverrebbero
a seguito di un calcolo probabilistico volta massimizzare i benefici e minimizzare i costi.
L'insoddisfazione per questi modelli indusse Herbert Simon (1957; cit. in Antonietti, 1998), un
economista, a proporre un modello decisionale basato sulla razionalità limitata, partendo dalla
considerazione l’essere umano è soltanto limitatamente razionale. Egli sosteneva che, per decidere,
si utilizza generalmente una strategia basata sul soddisfacimento: tale strategia non conduce a
considerare tutte le azioni possibili, ma a valutare differenti opzioni, una ad una, fino ad individuare
quella che appare accettabile, rispetto a un livello minimo stabilito a priori dal soggetto.
Negli anni Settanta, questa teoria venne rivista da Tversky (1972), il quale osservò che quando ci si
trova di fronte a più alternative che possono essere ragionevolmente prese in considerazione,
utilizza un processo di eliminazione per aspetti. In altre parole ci si focalizza su un aspetto,
stabilendo per esso un criterio minimo ed eliminando tutte le azioni che non lo soddisfano. Questo
processo continua fino a quando non resta che un'unica opzione. Ad esempio, se decidiamo di
affittare una casa, ci possiamo focalizzare sulla dimensione, trascurando fattori come costi,
manutenzione, disposizione. Una volta che abbiamo escluso tutte le alternative che non soddisfano
il nostro criterio di grandezza, scegliamo un altro aspetto e procediamo nello stesso modo, ma in
maniera sempre più accurata, finché arriviamo all’unica scelta possibile. Questo significa che per
scegliere la casa da affittare non abbiamo eseguito precisi calcoli di costi/benefici così come
63
previsto dalla teoria classica della decisione, né abbiamo visionato tutti gli appartamenti in affitto
della città: dopo averne visitati alcuni, abbiamo eliminato ad una ad una le possibili alternative,
utilizzando di volta in volta criteri diversi, fino a quando non ne è rimasta una sola possibile per noi.
Tversky ha inoltre osservato che non solo non prendiamo decisioni ottimali, ma anche che
frequentemente utilizziamo scorciatoie mentali, e persino distorsioni, che limitano e talvolta
alterano le nostre decisioni razionali.
Le scorciatoie che utilizziamo, nel prendere decisioni importanti, spesso implicano il calcolo della
probabilità, ossia un calcolo estremamente complesso, assolutamente non intuitivo e che richiede un
apprendimento formale. Proprio per tale difficoltà cadiamo frequentemente in distorsioni.
Kahneman e Tversky (1979; cit. in Antonietti, 1998) rivoluzionarono la ricerca sul giudizio sulla
presa di decisione facendo notare che le persone prendono decisioni sulla base di euristiche e
distorsioni. Tali scorciatoie mentali alleggeriscono il carico cognitivo, ma aumentano la probabilità
di commettere errori. I due autori sostengono che la nostra tendenza a giudicare più probabili certe
sequenze piuttosto che altre dipende dall’euristica della rappresentatività, con la quale cerchiamo
la probabilità che un certo evento accada sulla base di quanto pare simile o rappresentativo della
popolazione da cui deriva e sulla base del grado in cui esso riflette le caratteristiche salienti del
processo da cui è generato.
L’euristica della rappresentatività ci porta considerare certe sequenze che sembrano casuali
piuttosto che considerare le probabilità effettive di tali occorrenze. Ad esempio, viene interpretata
come segnale positivo la coincidenza di giorno o mese di nascita tra due o più membri di un gruppo
quando invece la probabilità che ciò accada è elevata. Un altro esempio di questa euristica è dato
dalla fallacia del giocatore d'azzardo che ritiene, erroneamente, che la probabilità dell'evento
casuale sia influenzata da eventi casuali precedenti. Quindi, i giocatori d'azzardo pensano che un
numero abbia maggiori probabilità di uscita solo perché non è stato estratto da alcune settimane!
Una delle ragioni per cui le persone utilizzano in modo fuorviante l’euristica della rappresentatività
è costituita dalla mancanza di attribuzione di peso al concetto di frequenze di base, che si riferisce
64
alla frequenza prevalente di un evento o di una caratteristica all'interno di una popolazione di eventi
di caratteristiche. Ad esempio, se a un medico venisse detto che un bambino accusa dolori al torace
non tenderebbe pensare che si tratti di un possibile attacco di cuore perché molto improbabile
quell'età; ci penserebbe, invece, se la persona con dolori al torace avessi 50 anni.
L’euristica della rappresentatività è utile e facile da usare: basti pensare alle previsioni
meteorologiche, quando stiamo per uscire e temiamo che possa scoppiare un temporale sulla base di
alcune caratteristiche quali il periodo dell'anno, le nuvole in cielo, eccetera.
Tuttavia, tendiamo usare queste euristiche più frequentemente del necessario. Accade per esempio
quando veniamo a conoscenza di aneddoti che confermano le statistiche delle frequenze di base.
Davanti a statistiche sui danni causati da un eccesso di grassi nell'alimentazione, potremmo pensare:
io ho conosciuto un uomo che mangiava solo cibi grassi e ha vissuto bene fino a cent'anni e non
dare alcun peso quelle informazioni che denunciano, invece, un rischio autentico. Questa nostra
disponibilità a richiamare alla mente quelli che vengono percepiti come esempi rilevanti di un
fenomeno è stata definita euristica della disponibilità. Ad esempio, alla domanda Nella lingua
inglese ci sono più parole che iniziano con la lettera R o che hanno la lettera R come terza lettera?,
la maggior parte delle persone intervistate sosteneva che esistevano più parole che iniziano con la
R. La maggiore disponibilità, ovvero la maggiore facilità di recupero per la prima modalità,
induceva stime di probabilità errate.
La fallacia di congiunzione, invece, porta ad attribuire probabilità di occorrenza più elevata a un
sottoinsieme di eventi, piuttosto che all’insieme degli eventi che comprende anche quel
sottoinsieme.
Interessante è anche la tendenza a scegliere le opzioni che implicano un’avversione al rischio,
quando ci troviamo di fronte una possibilità che presenta dei guadagni potenziali, ma non certi. In
altre parole scegliamo di guadagnare poco ma in modo sicuro piuttosto che molto ma senza
certezza. L’avversione per il rischio è ancora più forte su questioni di vita e di morte.
Si vedano le situazioni qui riportate: quali programmi di intervento scegliereste?
65
Si immagini che un governo che deve affrontare un'epidemia. 600 persone rischiano di morire.
Vi sono due programmi. Se venisse adottato il programma A si salverebbero 200 persone, se
venisse usato il programma B ci sarebbe la probabilità di 1/3 di salvarle tutte e 2/3 di
probabilità che muoiano tutte.
Si immagini un governo che deve affrontare un'epidemia. Se i 100 persone rischiano di morire.
Se venisse adottato il programma C morirebbero 400 persone, se venisse usato il programma
D ci sarebbe la probabilità di1/3 che non muoia nessuna di esse, e 2/3 di probabilità che
muoiano tutte.
Le nostre predilezioni per l’avversione o per la ricerca del rischio portano a scelte piuttosto
differenti sulla base dei modi in cui una decisione viene presentata, anche quando gli esiti effettivi
delle scelte sono gli stessi.
Un altro errore molto comune è causato dall’eccesso di sicurezza, ovvero una sopravvalutazione
individuale delle proprie capacità, conoscenze o giudizi: a causa di questo eccesso a volte si arriva a
compiere decisioni inappropriate.
Gli studi sulle scelte degli individui mostrano che la maggior parte degli esseri umani decide sulla
base del soddisfacimento personale, utilizzando quelle strategie che portano a limitare
convenientemente l'insieme delle opzioni che potrebbe essere sovrabbondante, tanto da renderne
impossibile la gestione. Inoltre, spesso mostriamo una preferenza accentuata per l’euristica della
rappresentatività per la quale crediamo che campioni piccoli somiglino alla popolazione totale in
tutti gli aspetti.
66
Psicologia dell’apprendimento e motivazione scolastica
III Unità Didattica – Lezione 5
Intelligenza
Dare un definizione di intelligenza è un compito complesso. L’aggettivo intelligente viene spesso
associato, nella vita quotidiana, a persone con un buon rendimento scolastico o lavorativo, a
inventori o personaggi che hanno contribuito con le loro azioni a risolvere determinati problemi. Il
termine intelligente viene anche associato, ad esempio, a sistemi per la gestione della propria casa a
distanza. Ma quali sono le caratteristiche di una persona intelligente? E come definirla? Alcune
ricerche hanno dimostrato che il senso comune ci porta a creare diverse misconcezioni, ossia
concettualizzazioni che si discostano dal pensiero scientifico e sono in buona parte veicolate dalla
cultura di appartenenza o determinate da un pensiero di tipo intuitivo. Questa lezione è dedicata a
sfatare tali misconcezioni e a riflettere sulle caratteristiche dell’intelligenza in relazione ai processi
di insegnamento-apprendimento.
Intelligenza come abilità cognitiva multidimensionale. Spesso siamo portati a considerare una
persona intelligente o meno, in senso generale, credendo che l’intelligenza sia una caratteristica che
si riflette su tutti i comportamenti dell’individuo permettendogli di raggiungere meglio i propri
scopi. In realtà, diversi studi hanno cercato di individuare quali abilità possano comporre
l’intelligenza umana. Nel 1938, Thurstone (cit. in Antonietti, 1998) sosteneva l’esistenza di 7 abilità
primarie componenti l’intelligenza umana: la comprensione verbale, la fluidità verbale, la capacità
numerica, la visualizzazione spaziale, la memoria, il ragionamento, la velocità percettiva. Guilford,
nel 1958 (cit. in Antonietti, 1998), giunse ad individuarne ben 120. Ciò che conta, comunque, è che
studi sperimentali hanno dimostrato che un individuo può eccellere in determinate abilità più che in
altre, e che quindi l’intelligenza non può essere un’abilità unitaria, ma è composta da una pluralità
di abilità.
67
Intelligenza come abilità cognitiva specifica. Le riflessioni precedenti ci portano a supporre che se
esiste una pluralità di abilità, esse allora saranno applicabili a campi specifici. Ognuno di noi si
sentirà maggiormente portato per l’ambito letterario o per quello scientifico e, a seconda delle
proprie propensioni, avrà trascorso parte della propria vita a migliorare e a lavorare in quegli ambiti
verso i quali si sente maggiormente portato. Ogni volta che ci siamo accostati ad una disciplina
differente abbiamo dovuto apprendere nuove modalità di ragionamento e nuovi linguaggi idonei
alla materia studiata. Anche le abilità trasversali, come, ad esempio, la pianificazione assumono
caratteristiche differenti a seconda che si debba pianificare la composizione di un testo scritto o la
risoluzione di un problema matematico. La ricerca ha anche dimostrato che essere esperti in un
determinato campo significa anche avere abilità molto sviluppate in quell’ambito e disporre di
strategie affinate per elaborare le informazioni specifiche. Le abilità e le strategie di un esperto in
fisica possono però non essere di alcun aiuto per esprimersi, ad esempio, in una lingua diversa dalla
propria: il trasferimento di abilità domino-specifiche non è sempre possibile.
Intelligenza come abilità cognitiva appresa. Spesso nei discorsi quotidiani siamo portati a
considerare l’intelligenza come un dono, qualcosa di geneticamente definito, di innato. Tale
considerazione aveva trovato in passato conferma anche nel fatto che molte abilità mentali erano
distribuite nella popolazione secondo una curva normale, come molte altre caratteristiche innate. Al
tempo stesso, però, la ricerca educativa ha dimostrato che le abilità mentali possono essere
insegnate e quindi apprese e modificabili. Fermo restando il fatto che vi possono essere alcune
componenti a base genetica, queste da sole non possono rendere conto dell’intelligenza
dell’individuo.
Intelligenza come abilità cognitiva dinamica. Per molti decenni, l’intelligenza è stata considerata
come un’abilità cognitiva statica, un prodotto quindi facilmente misurabile tramite test volti a
valutare il livello di abilità di un individuo nel risolvere una serie di prove. Come già abbiamo visto
nelle unità precedenti, l’individuo, però, è dotato di un potenziale di apprendimento. Gli studi sul
rapporto fra intelligenza e apprendimento condotti da Brown e Campione hanno messo in luce che
68
una valida teoria sull’intelligenza dovrebbe da un lato esplicitare quali caratteristiche deve
possedere un soggetto per ottenere una buona prestazione ad un test (e quindi raggiungere elevati
livelli nella misurazione del comportamento intelligente) ma anche specificare le modalità secondo
le quali gli individui si differenziano fra loro. Secondo tali studiosi, le differenze individuali si
possono situare a livello di hardware o di software. Con differenze di hardware, i due studiosi si
riferiscono a differenze rilevabili nelle architetture di sistema, ossia nei magazzini di memoria dei
soggetti, sia a livello di capacità (spazio utilizzabile per l’archiviazione dell’informazione), sia di
durata (il tempo di permanenza nelle varie strutture del sistema), sia di efficienza (velocità di
codifica dell’informazione, ritmo di ricerca dell’informazione in memoria); le differenze a livello di
software, invece, riguardano, da un lato, la base di conoscenze che si acquisisce (con riferimento
alla quantità e alla tipologia delle informazione, ossia le strutture di rappresentazione dei dati) e,
dall’altro, i processi di controllo che gli individui attivano per svolgere tutte le attività cognitive. La
prestazione di un individuo in un compito complesso è determinata quindi dalle potenzialità
dell’individuo in tutti i campi sopracitati.
Per ragioni di spazio non ci soffermeremo in questa sede sulle varie teorie dell’intelligenza che sono
state proposte nel corso del tempo, e ci limiteremo soltanto ad accennare che dai modelli gerarchici,
che prevedevano un fattore unico legato alla prestazione in qualsiasi attività mentale (al quale erano
sottesi una serie di altre capacità mentali ordinate gerarchicamente), si è passati a modelli
contestuali che sottolineavano il ruolo della cultura nella determinazione di quali comportamenti
possano essere considerati intelligenti. Oggi ricevono maggiori riscontri i modelli complessi, come
la teoria triarchica dell’intelligenza di Stenberg o la teoria delle intelligenze multiple di Gardner. La
prima sostiene che l’intelligenza si fonda su tre grandi componenti: l’abilità di elaborare
l’informazioni che guidano il comportamento intelligente, l’applicazione di tali abilità nei contesti
reali e la capacità dell’individuo di fare riferimento alle proprie esperienze per risolvere problemi
nuovi. Mentre la teoria di Sternberg (cit. in Antonietti, 1998) si focalizza sui processi mentali,
quella di Gardner puntualizza gli ambiti in cui si può manifestare l’intelligenza, giungendo ad
69
individuare otto tipologie di intelligenza: linguistica, logico-matematica, musicale, corporeocinestetica, intrapersonale, interpersonale, visivo-spaziale, naturalistica. Ogni individuo possiede
tali intelligenze secondo gradi e combinazioni diverse, le quali determinano il profilo della persona.
Si rimanda ad un testo di psicologia dell’educazione o di psicologia cognitiva per un maggiore
approfondimento di tali aspetti.
In chiusura di questa unità è d’obbligo proporre una riflessione: come insegnare ad essere più
intelligenti? Se l’intelligenza non è geneticamente determinata, in quale modo un insegnante può
sostenere l’allievo nel far progredire la propria intelligenza?
La ricerca educativa sottolinea che è necessario curare l’insegnamento di tutte quelle abilità
cognitive che sono alla base dell’apprendimento in ambito scolastico e accademico.
L’insegnamento deve focalizzarsi sulla comprensione del processo piuttosto che sulla produzione di
un prodotto finale. È altresì importante che l’insegnamento avvenga i contesti specifici e non
generici, in modo che l’apprendente abbia la possibilità di sperimentare determinate abilità in un
contesto d’uso idoneo. Infine, è fondamentale puntare inizialmente alla padronanza delle abilità di
base, prerequisito necessario per tutti gli apprendimenti successivi e modello per la costruzione di
apprendimenti più complessi.
70
Psicologia dell’apprendimento e motivazione scolastica
III Unità Didattica – Lezione 6
Stili di pensiero
Un’altra modalità per rendere conto delle differenze individuali nell’apprendimento e nelle
prestazioni fa riferimento agli stili di pensiero dell’individuo: in questo caso il focus non è il livello
di abilità raggiunto, ma la modalità preferenziale con cui un individuo affronta la risoluzione di un
compito. Lo stile di pensiero, in altre parole, è una modalità prevalente di funzionamento cognitivo.
Mentre un’abilità riguarda un preciso livello di cognizione, si riferisce a un dominio specifico, va
misurata in termini di accuratezza e velocità, è unipolare, ha un valore assoluto e consente di
svolgere un compito in un’area specifica, lo stile di pensiero si riferisce alla modalità di pensiero, è
pervasivo nelle azioni dell’individuo, riguarda l’individuazione di una modalità preferenziale di
risposta, ha più polarità, ha un valore che dipende dalla natura e dal contesto dell’attività in cui
viene applicato e organizza il funzionamento cognitivo. Ci soffermeremo in questa lezione sugli
stili di pensiero postulati da Sternberg all’interno della teoria dell’autogoverno mentale.
Il cuore della teoria è l’idea che le persone necessitano di governare, dirigere, controllare le proprie
attività quotidiane sia a scuola che fuori. Esistendo molteplici modalità di azione, ogni individuo
preferisce scegliere lo stile a sé più congeniale. Molte persone sono piuttosto flessibili nell’uso degli
stili e cercano, con vari gradi di successo, di adattarsi alla richiesta stilistica di una situazione. L’uso
flessibile della mente per l’autogoverno mentale tiene in considerazione la varietà di stili di
pensiero. Secondo la teoria sull’autogoverno mentale, i diversi modi in cui ci organizziamo possono
corrispondere a tipi di governo che esistono nel mondo: monarchico, gerarchico, oligarchico,
legislativo, esecutivo, giudiziario. Sternberg evidenzia tredici stili che vengono classificati in cinque
categorie: per funzione, forma, livello, scopo e inclinazione. Molti di noi propendono per uno stile
in ognuna delle categorie, sebbene queste preferenze possano variare a seconda del compito e della
situazione. Per esempio bambini che hanno uno stile liberale in scienze (amano fare cose in modi
71
nuovi) possono avere uno stile conservativo in cucina o in ginnastica (preferire situazioni familiari);
insegnanti che hanno uno stile legislativo nel lavoro (preferiscono creare, inventare) possono avere
uno stile esecutivo a casa (eseguire o dare direttive, preferire strutture).
L’autogoverno mentale implica tre funzioni: legislativa, esecutiva e giudiziaria. In ogni persona una
delle funzioni è dominante ed orienta lo stile della persona. Una persona legislativa ama credere,
inventare, progettare, fare le cose a modo proprio, avere compiti poco strutturati, un’esecutiva,
invece, ama eseguire direttive, fare ciò che le viene assegnato, operare in situazioni strutturate, una
giudiziaria, infine, ama valutare ed esprimere giudizi su cose e persone
In situazioni di insegnamento-apprendimento, ogni disciplina può essere insegnata in modo da
essere congruente con qualsiasi stile: proprio per questo, gli studenti cercheranno attività di
apprendimento che siano compatibili con il loro stile preferito, così come gli insegnanti tenderanno
ad insegnare in modi compatibili con il proprio stile, creando a volte un mancato incontro fra stile
del docente e del discente. È, perciò, importante che gli insegnanti siano consapevoli dello stile
preferito da ognuno dei propri studenti, così da promuovere maggiori opportunità di apprendimento
per tutti.
Come le funzioni dell’autogoverno mentale assomigliano ai rami del governo, così le forme
dell’autogoverno mentale assomigliano a forme di governo: monarchico, gerarchico, oligarchico e
anarchico. Nella forma monarchica predomina un solo obiettivo o un unico modo di fare le cose, la
persona monarchica ama fare una cosa alla volta, impegnandovi quasi tutte le energie e risorse.
Nella forma gerarchica sono ammessi molteplici obiettivi, ognuno con diversa priorità. Un
gerarchico, quindi, ama fare molte cose contemporaneamente stabilendo priorità per quale fare,
quando, per quanto tempo e quante energie impiegare per ogni aspetto. Nella forma oligarchica
sono ammessi molteplici obiettivi, ognuno ugualmente importante. Il soggetto oligarchico ama fare
molte cose contemporaneamente, ma ha problemi nello stabilire priorità. Nella forma anarchica,
infine, le procedure, le regole e le linee guida appaiono come un anatema. L’anarchico ama avere
72
un approccio casuale nella risoluzione di problemi; non ama i sistemi, le linee guidate e
praticamente tutte le costrizioni.
I livelli sono le variabili stilistiche più modificabili dell’autogoverno mentale. Alcune situazioni e
certi compiti richiedono un livello globale di elaborazione. I problemi che richiedono questo tipo di
approccio sono di natura generale e richiedono un pensiero astratto. Per risolvere questo genere di
problemi, un individuo deve essere in grado di vedere la complessità del problema nella sua
interezza e non ogni aspetto nella sua singolarità. Altre situazioni e compiti, per contrasto, vengono
svolti meglio ad un livello locale. Questi problemi tendono ad essere specifici e richiedono un
pensiero concreto; per risolverli occorre essere in grado di cogliere ogni singolo aspetto, non solo la
globalità del problema. Un individuo con stile globale preferisce occuparsi di questioni ampie ed
astratte e spesso esclude i dettagli, mentre un individuo con stile locale preferisce occuparsi di
questioni più maneggevoli e concrete e spesso gradisce i dettagli.
Gli scopi dell’autogoverno mentale possono essere interni o esterni. Gli scopi interni riguardano
compiti in cui gli studenti lavorano da soli; gli scopi esterni comprendono compiti in cui gruppi di
studenti collaborano, indipendentemente dal livello dei membri.
I governi, infine, possono avere varie tendenze politiche, dall’ala destra all’ala sinistra: Sternberg,
da questo parallelo, deriva due inclinazioni: conservativa e liberale. Gli individui con uno stile
conservativo tendono ad aderire alle regole e procedure che già esistono, minimizzando i
cambiamenti ed evitando le situazioni ambigue quando è possibile. Una persona può essere sia
conservativa che liberale se ama sviluppare nuove idee con modalità che tengono fortemente in
considerazione ciò che è stato fatto nel passato. Una persona con uno stile liberale ama andare oltre
le regole e le procedure esistenti, provocando cambiamenti e cercando situazioni incerte ed
ambigue.
La scuola insegna agli studenti ad essere fruitori di conoscenze più che produttori di conoscenze,
ma, al tempo stesso il mondo del lavoro richiede loro di essere produttori di cultura e conoscenze;
dopo anni di richieste di tipo esecutivo ci si aspetta che nella professione siano creativi. Perciò gli
73
insegnanti dovrebbero apprezzare e valorizzare non solo gli stili che ripagano nel presente, ma
anche quelli che possono risultare proficui nel futuro. Se la scuola deve promuovere negli studenti
l’abilità di passare da uno stile all’altro secondo la richiesta della situazione, ciò significa che anche
gli insegnanti devono essere istruiti ad usare stili diversi. Un modo per sviluppare tale flessibilità è
quello di descrivere vari compiti agli insegnanti durante la loro formazione o agli studenti durante le
attività di classe e poi di chiedergli quale stile di pensiero sarebbe più efficace per lo svolgimento di
ogni compito. Successivamente si può chiedere agli insegnanti o agli studenti di motivare le loro
risposte ed infine di svolgere il compito usando lo stile ottimale. Lo sforzo per capire gli stili di
pensiero e il loro uso flessibile richiede che prima si sia in grado di identificare lo stile preferito di
un individuo. Gli insegnanti possono raggiungere un maggior numero di studenti se si preoccupano
di variare i tipi di suggerimenti che usano nell’insegnamento e nella verifica. Variare
sistematicamente il modo di insegnare e di verificare è un ottimo metodo per rispondere ai bisogni
di un numero maggiore di studenti.
74
Bibliografia
Antonietti, A. (1998). Psicologia dell'apprendimento. Processi, strategie e ambienti cognitivi.
Brescia: La Scuola.
Polito, M. (2012). Atleti della mente. Il potere dell'attenzione e della concentrazione. Editori
Riuniti Univ. Press.
75
Psicologia dell’apprendimento e motivazione scolastica
UNITÀ DIDATTICA 4
ASPETTI MOTIVAZIONALI
Lezione 1
Motivazione
In questo modulo ci occuperemo degli aspetti emotivo-motivazionali connessi all’apprendimento,
ossia alla motivazione, all’emozione, all’affettività.
La motivazione è un concetto ampio, che è stato affrontato secondo approcci teorici molto diversi
fra loro. La definizione classica, ascrivibile all’approccio comportamentista, considera la
motivazione come una spinta del soggetto verso la soddisfazione di un bisogno; il bisogno spinge
l'organismo alla ricerca della sua soddisfazione, cioè ad aggiungere l'equilibrio che la privazione ha
causato. La soddisfazione del bisogno, secondo i comportamentisti, diventa rinforzo che consolida
la risposta dell'organismo, cioè il comportamento che ha immediatamente preceduto l'evento
rinforzante. Ogni organismo agisce per ridurre dei bisogni, i quali determinano delle pulsioni cioè
degli stimoli che sorgono da uno stato di bisogno che hanno la funzione generale di attivare il
comportamento. Le pulsioni primarie, come fame, sete, sonno, sono associate agli stati di bisogno
innati; le pulsioni secondarie, come la paura, possono essere apprese per condizionamento. In
ambito scolastico gli studi sulla motivazione hanno quindi sottolineato l'importanza del rinforzo: il
ruolo dell'insegnante è quindi quello di predisporre un ambiente rinforzante al fine di avere sempre
un allievo motivato grazie al sapiente dosaggio dei rinforzi ricevuti.
Una definizione più generale di motivazione indica la configurazione organizzata di esperienze
soggettive che consente di spiegare l'inizio, la direzione, l'intensità e la persistenza di un
comportamento diretto a uno scopo. Il concetto di bisogno, legato alla teoria motivazionale, è stato
76
fortemente criticato dal cognitivismo: né il semplice bisogno, né un rinforzo meccanico, sono in
grado di dare spiegazioni della motivazione di un individuo.
I cognitivisti sottolineano tre dimensioni fondamentali del concetto di motivazione. In primo luogo
assegnano un ruolo attivo all'individuo: la motivazione non è una soddisfazione esclusivamente
passiva dei bisogni primari o secondari, ma nasce nel momento in cui l’individuo più si pone degli
obiettivi. Il soggetto costruisce attivamente la propria motivazione, agendo intenzionalmente nel
mondo, valutando le proprie capacità, facendo uso dei mezzi a disposizione per raggiungere
l’obiettivo. È più corretto, quindi, definire la motivazione come l'attivazione e la direzione del
comportameto teso verso il raggiungimento di un obiettivo.
In secondo luogo è necessario considerare la percezione che l'individuo ha di se stesso in rapporto
all'obiettivo e al risultato. Tale percezione fa sì che l’individuo costruisca sulla base della sua
prestazione, convinzioni circa la propria competenza dalla quale deriverà aspettative di riuscita o di
fallimento per le situazioni future.
In terzo luogo, è necessario considerare gli strumenti che l'individuo applica al fine di raggiungere i
suoi obiettivi. Con strumento si intendono tanto gli strumenti materiali, quanto, soprattutto, le
strategie di studio, di monitoraggio, di controllo, di azione attraverso le quali uno studente orienta il
proprio comportamento allo scopo; è ossia fondamentale considerare l'autoregolazione
dell’individuo.
Una distinzione classica che viene effettuata con riferimento il concetto di motivazione è la
suddivisione fra motivazione intrinseca e la motivazione estrinseca. La prima si basa sulla curiosità,
che viene attivata quando un individuo incontra caratteristiche ambientali strane, sorprendenti,
nuove; in tale situazione la persona sperimenta incertezza, conflitto concettuale e sente il bisogno di
esplorare l'ambiente alla ricerca di nuove informazioni e soluzioni; le seconda fa sì che il
comportamento sia retto da scopi esterni all’attività stessa: l’apprendimento di una nozione in
questo caso diventa non il fine ma lo strumento per raggiungere il proprio scopo. Tale suddivisione,
per quanto molto nota, non tiene conto della distinzione fra motivazioni innate (come i bisogni
77
primari) e motivazioni mediate cognitivamente, come le aspettative e gli obiettivi. È comunque utile
soffermarsi sul concetto di motivazione intrinseca poiché molto funzionale per un apprendimento
efficace. Essa infatti porta l’individuo a affrontare un compito per se stesso, senza finalità esterne,
traendo soddisfazione dalla propria azione, spesso dettata da un bisogno innato di essere curiosi. La
curiosità epistemica è un bisogno universale di conoscere ed apprendere, che si origina
dall’esplorazione dell’ambiente ed è giustificata dal desiderio di sapere. Essenziale per l’attivazione
di tale curiosità sono le caratteristiche collative degli stimoli come la novità, la complessità e
l’incongruenza. Data l’importanza dell’attivazione di una curiosità epistemica a scuola, dovrebbe
essere compito fondamentale dell’insegnante il cercare di predisporre le attività e i materiali di
studio cercando di soddisfare tali caratteristiche dello stimolo, agendo sull’organizzazione della
lezione, sulle richieste presentate all’allievo o sulle caratteristiche del problema presentato.
L’osservazione del comportamento degli individui ha però portato alcuni studiosi a concludere che
l’azione del soggetto non è soltanto spinta dal desiderio di appagare una curiosità, ma soprattutto
dalla necessità di autodeterminarsi, esercitando forme di controllo sul proprio comportamento e
sulla realtà in cui vivono. Deci e Ryan (1985), nel postulare la teoria dell’autodeterminazione,
hanno considerato l’essere umano come un organismo attivo avente la tendenza innata a sviluppare
un senso di sé unitario e integrato, tramite lo sviluppo armonico di vari aspetti della propria vita.
Secondo tali studiosi, infatti, esistono tre bisogni psicologici fondamentali, la cui soddisfazione,
essenziale al pieno benessere dell’individuo, può essere ostacolata dall’ambiente sociale. Tali
bisogni sono esigenze innate, non mediate dalla cultura e pertanto comuni a tutti gli individui. La
competenza si riferisce al sentirsi efficace nelle interazioni con l’ambiente sociale e nell’esercitare
ed esprimere le proprie capacità. È il bisogno di competenza che porta gli individui a conservare ed
accrescere le proprie abilità, cercando anche stimoli per svilupparle. Nel momento in cui, infatti, ci
dedichiamo ad una attività che ci piace, da un lato ci impegniamo perché ci sentiamo in grado di
eseguirla, dall’altro siamo stimolati a proseguire poiché essa racchiude sempre per noi una nuova
sfida: la competenza non può essere considerata una capacità appresa, ma ci offre un senso di
78
sicurezza e capacità di agire. L’autonomia è stata definita come il sentirsi origine del proprio
comportamento grazie alle azioni dettate dalla nostra volontà e non da cause ambientali esterne al
nostro essere. Il comportamento, in questo caso, diventa espressione del Sé dell’individuo che è
capace di controllare l’ambiente in cui vive. Autonomia però non è sinonimo di indipendenza dagli
altri: è questa un’autonomia caratterizzata da convizione e coerenza e ha al suo opposto
atteggiamenti conformistici. Il terzo bisogno fondamentale è quello che porta ad instaurare relazioni
con gli altri, per il bisogno di sentirsi parte di un gruppo sociale, formale o informale, per il
desiderio di occuparsi degli altri al fine di costruire un progetto di vita o per motivazioni altruistiche
come il volontariato o per il puro piacere di stare con gli altri.
79
Psicologia dell’apprendimento e motivazione scolastica
IV Unità Didattica – Lezione 2
Obiettivi di riuscita
Affrontati da un punto di vista più generale le caratteristiche della motivazione, come motore
dell’individuo per il raggiungimento di fini ed obiettivi, ci concentreremo ora su quali siano i
rapporti tra motivazione e apprendimento, analizzando le riflessioni sugli obiettivi di riuscita.
Come abbiamo visto nell’unità precedente, la motivazione si attiva quando un individuo ha un
obiettivo da raggiungere, un risultato che si vuole ottenere o evitare: si parla in questo caso di
obiettivi target, ossia dei traguardi che consentono facilmente la verifica dell’avvenuto
raggiungimento. Diversi, invece, sono gli obiettivi di riuscita (achievement goal): non ci si riferisce
in questo caso ad un risultato da raggiungere, ma al perché un individuo si impegna in un compito o
in un’attività di apprendimento. Gli obiettivi di riuscita, quindi, sono sovraordinati rispetto agli
obiettivi target: rispetto al medesimo obiettivo target, due individui possono collegare obiettivi di
riuscita differenti. Uno studente può decidere di conseguire un perfezionamento perché lo ritiene
interessante o utile per la sua professione, un altro per conseguire un titolo con il quale mettersi in
luce di fronte ad amici e colleghi. L’obiettivo di riuscita è un insieme di convinzioni, attribuzioni e
affettività che determina le intenzioni del comportamento e che si esprime in modalità diverse di
affrontare l’obiettivo target; non indica un traguardo, ma un orientamento dell’individuo verso la
realizzazione del Sé e comporta una credenza dell’individuo circa la propria abilità, una
propensione ad attribuire a determinate cause i propri successi o i propri fallimenti, la capacità di
perseverare nel raggiungimento di una meta. La teoria degli obiettivi di riuscita fu elaborata da
Dweck nel corso degli anni Ottanta, a partire da ricerche che dimostravano quanto gli studenti
reagissero secondo modalità diverse a seguito della sperimentazione di un insuccesso scolastico.
Alcuni studenti non si scoraggiavano, dimostravano persistenza nell’impegno e ricercavano nuove
strategie per affrontare il problema, dimostrando dei pattern di comportamento adattivi; altri erano
80
invece colti dallo sconforto, manifestavano frustrazione e aggressività, si irrigidivano sulla strategie,
riapplicate in maniera rigida e ripetitiva, rispondendo, in altre parole, con pattern di comportamento
mal adattivi.
Dweck formulò quindi l’esistenza di due tipi di achievement goal: gli obiettivi di padronanza o di
prestazione. Gli studenti orientati alla padronanza, ossia centrati sul compito, sono motivati a
capire ciò che affrontano e a svolgere una buona attività. Sono studenti fiduciosi in se stessi,
persistenti in caso di difficoltà, maggiormente in grado di autoregolarsi e di elaborare strategie
flessibili. Tali studenti svolgono volentieri le attività perché sorretti dalla curiosità epistemica, ma
anche perché possono ritenere utile tale attività per altri scopi. Essere orientati alla padronanza,
quindi, non sempre corrisponde ad avere una motivazione intrinseca. Gli studenti orientati alla
prestazione, quindi centrati sulla dimostrazione della propria abilità, cercano di ottenere risultati
legati alle aspettative sociali associate al compito, come ottenere buone valutazioni dal docente e
evitare quelle negative, effettuare una prestazione migliore di quella dei propri compagni; tali
studenti però sono maggiormente esposti allo sconforto, soprattutto nei casi i cui l’individuo
percepisca un basso livello nelle proprie abilità: proprio per questo motivo, Dweck ha definito
l’approccio alla prestazione come un pattern mal adattivo. Dweck ha inoltre sottolineato che riveste
una fondamentale importanza la definizione che l’individuo dà di abilità: coloro che ritengono che
un’abilità sia un qualcosa di statico, considera il successo come un’affermazione rispetto ad altri,
come risultato di una valutazione; chi invece ritiene che un’abilità sia apprendibile e sviluppata, si
orienta più facilmente verso obiettivi di padronanza essendo capace di considerare un successo
l’aumento di competenza in un determinato compito.
Studi successivi a tale teoria, contestarono la dicotomia proposta da Dweck. Elliot, in particolare,
mise in dubbio il fatto che gli obiettivi di prestazione conducessero sempre a pattern maladattivi per
l’apprendimento: propose quindi di differenziare gli obiettivi di prestazione a seconda che fossero
caratterizzati da componenti di approccio o di evitamento del compito. Sia la padronanza che la
prestazione, infatti, sono obiettivi di approccio: nel primo caso, lo studente desidera riuscire
81
sviluppando la propria competenza, nel secondo caso manifesta invece il bisogno di dimostrarla.
Caratteristica dell’orientamento di approccio, infatti, è proprio la riuscita; l’orientamento di
evitamento è caratterizzato, invece, dalla volontà di evitare di dimostrare la propria incapacità.
Eliott propone quindi una nuova tricotomia circa gli obiettivi di riuscita, che si distinguono in
obiettivi di padronanza (focalizzati sullo sviluppo della competenza, l’individuo si confronta con se
stesso), obiettivi di approccio di prestazione (focalizzati sul raggiungimento di competenza in
relazione ad altri), obiettivi di evitamento della prestazione (focalizzati sull’evitare uno standard di
competenza in rapporto ad altri). Ad essi si aggiunge un quarto pattern, ossia l’orientamento
all’evitamento della padronanza che però si allontana, nelle sue ricadute, dagli aspetti legati alla
scuola e alle richieste che tale ambiente pone allo studente.
Dei primi tre orientamenti indicati, solo il terzo costituisce un pattern maladattivo; è la percezione
circa la propria competenza che spinge l’individuo ad adottare obiettivi di prestazione o di
evitamento.
L’adozione di un determinato obiettivo pare essere anche fortemente legata alle metodologie di
lavoro adottate in classe e agli obiettivi dominanti che tali metodologie intrinsecamente
trasmettono. Alcuni studi hanno dimostrato che studenti posti davanti allo stesso compito,
presentato, però, secondo modalità differenti che di volta in volta sottolineavano l’importanza di
impadronirsi di una tecnica, di ottenere una vittoria su tutti i partecipanti o di essere individuati per
la propria incapacità, dimostravano livelli differenti di motivazione intrinseca e percepivano un
maggiore o minor livello di piacere nello svolgimento del compito. Dal gruppo di studenti in cui
veniva indotto l’obiettivo di evitamento, la prova era svolta con scarso piacere e reticenza e la
motivazione intrinseca dei soggetti di attestava su livelli decisamente inferiori rispetto a quella degli
altri gruppi.
Non sono quindi solo gli obiettivi personali a determinare l’approccio ad una attività ma anche i
messaggi che giungono dal contesto classe, ossia la struttura di obiettivo. Con tale termine si
designa l’insieme dei messaggi dominanti in una classe o in una scuola, che possono influenzare gli
82
obiettivi personali del soggetto: l’organizzazione di un gruppo classe si esplicita nei modelli di
compito, di autorità e di valutazione, nel modo in cui, cioè, un insegnante assegna attività, pone
regole e valuta gli studenti. Anche in questo caso, allora, è fondamentale che l’insegnante sia
estremamente consapevole dei messaggi trasmessi al proprio gruppo classe, dato che dal suo
atteggiamento derivano influenze sull’adozione di atteggiamenti di padronanza o di prestazione.
Infine, è necessario tenere in considerazione che i tentativi di riuscire comportano nello studente la
sperimentazione di una vasta gamma di emozioni che sono sì legate al vissuto di successo o di
insuccesso, ma anche alla valutazione che ne viene data dal contesto di appartenenza. Gli obiettivi
di padronanza sembrano favorire la sperimentazione di emozioni positive e la riduzione di quelle
negative; l’emozione positiva concorre all’adozione di una motivazione intrinseca e al perseverare
nel raggiungimento dell’obiettivo prefissato.
83
Psicologia dell’apprendimento e motivazione scolastica
IV Unità Didattica – Lezione 3
Teoria dell’attribuzione
Un’ulteriore modalità per lo studio della motivazione alla riuscita fa riferimento al comprendere
come gli individui spiegano i risultati differenti che raggiungono, a quali cause, cioè, tendono ad
attribuire i propri successi o insuccessi. Heider, nel 1958 (cit. in Antonietti, 1998), si concentrò sulla
tendenza dell’individuo ad attribuire le cause delle proprie azioni a due fattori principali: se stessi o
l’ambiente, ossia a cause interne a sé (locus of control interno) o esterne a sé (locus of control
esterno). A partire da tale teoria molti ricercatori hanno specificato maggiormente alcuni aspetti
dell’attribuzione causale. Ci occuperemo in questa sede di affrontare il contributo di Weiner.
Gli individui tendono a addurre quattro motivi per i risultati delle proprie azioni: queste possono
essere determinate da abilità, sforzo, difficoltà del compito o fortuna. Tali motivazioni si possono
articolare secondo alcune dimensioni: il locus of control, la stabilità/instabilità della causa e la sua
controllabilità. La stabilità attiene alla possibilità che i criteri presi in considerazione cambino nel
tempo, mentre la controllabilità si riferisce alla possibilità da parte del soggetto di controllare la
causa che ha determinato il successo o il fallimento. La combinazione delle tre dimensioni conduce
l’individuo a compiere otto differenti tipi di attribuzione, come si può vedere nello schema
seguente.
Locus
Stabilità
Stabile
Interno
Instabile
Stabile
Esterno
Instabile
Controllabilità
Controllabile
Incontrollabile
Controllabile
Incontrollabile
Controllabile
Incontrollabile
Controllabile
Incontrollabile
Attribuzione
Tenacia
Abilità
Impegno
Tono umore
Pregiudizio
Difficoltà
Aiuto
Fortuna
Le aspettative sono determinate dalla percezione della propria abilità e da quanto si è disposti a
impegnarsi in base alla difficoltà del compito, alla percezione del proprio controllo della situazione
e alla precedenti esperienze proprie ed altrui. Le aspettative sono influenzate dalla dimensione di
84
stabilità (abilità/inabilità – facilità/difficoltà del compito): l’attribuzione a cause stabili porta ad
aspettarsi in caso di successo, un ulteriore successo e, in caso di insuccesso, un nuovo fallimento.
Allo stesso modo, un insegnante che nutre aspettative positive o negative sulla bravura di uno
studente, sarà più facilmente portato a credere che quello studente sarà sempre, o non sarà mai,
bravo.
Ogni attribuzione porta con sé degli effetti sulle emozioni. Chi attribuisce all’impegno il proprio
successo sperimenterà soddisfazione, mentre chi vi attribuirà l’insuccesso sperimenterà il senso di
colpa e la vergogna per non aver perseverato abbastanza; l’attribuzione all’abilità del successo
aumenta la propria fiducia in sé e i vissuti di autostima, l’attribuzione dell’insuccesso fa
sperimentare l’impotenza, l’apatia, la depressione e la vergogna. Diverse sono le emozioni
sperimentate quando la attribuzione è data a cause esterne. La difficoltà del compito in caso di
successo scatena emozioni di sorpresa per il buon esito conseguito e di pietà e compatimento di se
stessi quando gli esiti sono, invece, negativi; quasi gli stessi effetti sono riscontrabili nelle
attribuzioni al caso. Infine, quando si considera il proprio successo legato ad un aiuto altrui si
sperimenta un’emozione di gratitudine che diventa, invece, rabbia se l’aiuto altrui ci ha condotto al
fallimento. Le attribuzioni influenzano fortemente anche gli esiti delle prestazioni e
dell’apprendimento.
Esiste una relazione tra cognizione, meta-cognizione, prestazione, stili attributivi, motivazione al
compito e autostima: in tale sistema complesso riveste un ruolo centrale l’uso di strategie che
pongano l’enfasi sul processo di istruzione. L’insegnante è il mediatore culturale che deve
contribuire a sviluppare negli alunni un positivo atteggiamento verso lo studio, collegando in modo
efficace la prestazione all’impegno strategico, attraverso feedback appropriati e l’organizzazione di
situazioni stimolo, materiali e compiti funzionali alle varie strategie. La probabilità d’uso di
strategie di apprendimento è fortemente legato al tipo di attribuzione che influenza direttamente la
prestazione in compiti scolastici. Chi crede infatti di riuscire o non riuscire per effetto dell’impegno
personale, dell’interesse, della motivazione presenta un atteggiamento strategico che lo porta ad
85
avere buone abitudini di studio e ad applicare correttamente le strategie, tende a prodigarsi per
ottenere un successo, ha un maggior senso della realtà e una maggiore fiducia in se stesso. Essendo
più motivato al successo, ottiene prestazioni superiori, soprattutto nell’applicazione di strategie di
memoria e di studio. Chi, al contrario, pensa di riuscire o fallire a causa di un’abilità innata, stabile
e non modificabile, o, per effetto di fattori esterni come difficoltà o fortuna, è meno portato ad
utilizzare strategie o a adottare corrette abitudini di studio perché meno convinto di poter controllare
gli eventi, tanto da ritenere inutile anche impegnarsi ulteriormente. Una situazione di questo tipo,
protratta nel tempo attraverso continui fallimenti, potrebbe condurre il soggetto a sviluppare un
senso di impossibilità a riuscire in contesti simili o, peggio ancora, a sviluppare la sindrome
dell’impotenza appresa per cui l’individuo è portato a credere che non sia possibile fare nulla Né
per affrontare una situazione positiva, né per evitarne una negativa.
Dalle varie esperienze vissute, l’individuo sviluppa uno stile attributivo. Esistono differenti stili
attributivi, ognuno dei quali è utile, secondo modalità diverse, per difendere la propria immagine
personale o la specifica situazione in cui ci si trova. Nella situazione di apprendimento lo stile più
funzionale per il successo nello studio è quello che si caratterizza per il fatto di riconoscere una
grande importanza all’impegno personale. Infatti, lo studente che attribuisce i propri risultati
prevalentemente al proprio lavoro ed alle modalità da lui adottate riesce da un lato ad ottenere
prestazioni migliori e dall’altro a affrontare positivamente l’insuccesso, vissuto come tappa
necessaria del processo di apprendimento per imparare ad adottare le strategie di risoluzione più
adeguate al compito.
Il sistema attributivo non è innato, ma trae origine sia dalle esperienze passate di successo o
insuccesso ma anche dall’ambiente culturale, familiare e scolastico cui l’individuo appartiene.
Anche gli atteggiamenti e le concezioni degli insegnanti influenzano diversi aspetti emotivomotivazionali dei ragazzi. Gli alunni, infatti, sono generalmente sensibili nel cogliere le reazioni
emotive che gli adulti manifestano in relazione al successo o all’insuccesso e a coglierne
l’atribuzione sottostante. Tali aspettative, noinché il generale atteggiamento dei genitori e degli
86
insegnanti sono anche una delle cause determinanti le alcune differenze individuali, come le
differenze di genere. Le ragazze, ad esempio, vengono criticate più spesso in caso di una
prestazione scolastica non adeguata e ricevono quindi un feedback negativo: mentre i maschi
presentano un atteggiamento di negazione che tende ad attribuire l’insuccesso a cause esterne, le
femmine tendono a sviluppare più facilmente un sentimento di incapacità e una bassa stima di sé.
Così come lo stile attributivo può essere appreso, nello stesso modo può essere modificato per
mezzo di interventi didattici mirati. La letteratura educativa fornisce una vasta gamma di prodotti
per la valutazione dello stile attributivo dello studente e di tecniche per lavorare verso l’assunzione
di uno stile attributivo maggiormente adattivo per il successo scolastico.
87
Psicologia dell’apprendimento e motivazione scolastica
IV Unità Didattica – Lezione 4
Autoefficacia
Secondo la definizione generale, il senso di autoefficacia rappresenta la convinzione nelle proprie
capacità di organizzare e realizzare le azioni necessarie per gestire adeguatamente le situazioni che
si incontreranno, in modo da raggiungere gli obiettivi prefissati. Le credenze di autoefficacia
possono essere definite, quindi, come le determinanti prossimali delle azioni umane, in quanto ne
influenzano in modo significativo le componenti cognitive, emozionali e motivazionali; gli
individui che si ritengono in grado di risolvere un problema, di intraprendere la carriera lavorativa
per loro più vantaggiosa, di affrontare una nuova esperienza nel modo migliore e che effettivamente
risultano molto attive ed efficienti nell’eseguire le azioni necessarie per realizzare i loro progetti,
sono dotate di un buon livello di senso di autoefficacia; coloro che, invece, nutrono dubbi sulle loro
capacità o sulle loro scelte e che risultano dunque poco impegnati e poco produttivi nelle attività,
sono dotati di un basso livello del senso di autoefficacia. Chi nutre buone credenze di efficacia
riesce inoltre ad anticipare e prevedere esiti positivi nelle attività che compirà e questa capacità di
“vedersi” impegnati in azioni di successo, a sua volta, influenza positivamente le credenze di
efficacia del soggetto.
In una società globale come quella attuale, basata sulla conoscenza, sulla continua trasformazione e
sulla necessità di essere costantemente aggiornati sui vari sviluppi, le prospettive future di ogni
individuo dipendono dalla sua capacità di guidare se stesso, di evolversi e di rinnovarsi
continuamente ed un elevato senso di autoefficacia risulta essere l’elemento fondamentale per
l’effettiva realizzazione di tutto ciò.
A Bandura va riconosciuto il merito di aver attirato l’attenzione degli studiosi su questo argomento,
sottolineando quanto il concetto di senso di autoefficacia sia molto importante nella vita di ogni
individuo, in quanto può essere validamente esteso alla risoluzione di tutti i problemi, da quelli
88
cognitivi a quelli interpersonali, facendo riferimento alle convinzioni di ognuno sulle abilità di
controllare il proprio comportamento e determinare il successo o l’insuccesso delle varie azioni.
La teoria dell’autoefficacia definisce le convinzioni sulle propria capacità non come un tratto
generale, ma come un insieme differenziato di convinzioni sulla propria persona, legate a sfere di
funzionamento distinte; bisogna precisare, tuttavia, che il senso di efficacia non riguarda il numero
di abilità possedute, quanto piuttosto ciò che si crede di poter fare in una particolare situazione con i
mezzi a propria disposizione, dando un importante contributo alla qualità della prestazione.
Ulteriori elementi che determinano la complessità del concetto sono dati dal fatto che le convinzioni
di autoefficacia assumono configurazioni diverse in persone diverse, cioè ogni singolo modello di
configurazione assunto dal senso di efficacia personale rappresenta la disposizione di autoefficacia
di una data persona. Inoltre si possono creare delle discrepanze tra le convinzioni di efficacia e le
azioni corrispondenti, e questo accade perché il semplice fatto di esprimere un giudizio sulla propria
autoefficacia può non riflettere ciò che si crede realmente e può, dunque, non produrre la
prestazione corrispondente; dunque la differenza è data dalla discordanza tra il pensiero di sé e
l’azione. Ancora questo concetto dimostra la sua duttilità e dinamicità attraverso la necessità di
essere analizzato utilizzando giudizi particolareggiati su capacità che possono variare a seconda
delle caratteristiche della situazione e del contesto, del livello di difficoltà del compito e di sviluppo
e maturazione raggiunti dall’individuo. Infine altre discrepanze derivano da difetti di valutazione,
da una notevole quantità di tempo trascorsa dall’azione alla valutazione e dall’ambiguità delle
richieste.
L’autoefficacia viene generalmente analizzata considerando tre importanti elementi che la
caratterizzano: la grandezza, che si riferisce al numero crescente di difficoltà che la persona ritiene
di saper affrontare, la forza, che riguarda il grado di convincimento con cui un individuo pensa alla
sua efficacia, anche di fronte a situazioni complicate, e infine la generalizzazione, che indica la
capacità di trasferire il senso di autoefficacia, provato per un particolare comportamento, su
situazioni simili ma in ambiti diversi.
89
Il comportamento umano è costantemente influenzato dal senso di autoefficacia, il quale agisce:
•
sull’individuazione e selezione degli obiettivi personali;
•
sulla scelta di compiti, azioni e situazioni;
•
sul grado di persistenza dei tentativi di raggiungimento degli obiettivi, anche di fronte ad
eventuali difficoltà o ostacoli;
•
sul tipo e sull’intensità di emozioni provate in una particolare situazione (compresi stress e
depressione).
Bisogna sottolineare il fatto che il senso di autoefficacia influisce su questi fattori e da questi viene,
a sua volta, incrementato o decrementato, attraverso un circolo vizioso. Inizialmente un individuo si
cimenta in un compito nuovo ed il senso di autoefficacia agisce sugli sforzi e sulla persistenza nelle
azioni del soggetto, accompagnati da particolari stati emozionali, ed il tutto è finalizzato al
raggiungimento dell’obiettivo, che l’individuo stesso aveva scelto; in base al risultato ottenuto il
livello del senso di efficacia personale può aumentare o diminuire e ciò influisce sulla scelta di
nuovi obiettivi e nuovi compiti, ricominciando il ciclo. Tutti questi elementi fungono da feedback, i
quali sono fondamentali per il soggetto, nel determinare le sue credenze e le sue scelte successive.
E’ importante analizzare il senso di autoefficacia attraverso una sua distinzione da altri concetti, ai
quali spesso erroneamente è stato legato. La percezione di efficacia fa riferimento ai giudizi che un
individuo formula riguardo ai comportamenti che pensa di poter attuare di fronte ad una particolare
situazione e per questo tale concetto si differenzia dai tratti di personalità e dal concetto di sé, i
quali sono in grado di predire i comportamenti specifici della persona in misura minore, dal
momento che derivano da valutazioni generali e globali del soggetto su se stesso. Bandura, inoltre,
distingue l’autoefficacia dall’autostima, in quanto la prima riguarda giudizi di capacità personale,
mentre la seconda riguarda giudizi di valore personale e non è mai stata stabilita una relazione tra le
convinzioni riguardo alle proprie capacità e il fatto di apprezzarsi o disprezzarsi. Il senso di
efficacia personale deve essere distinto anche dalla moralità, poiché l’innalzamento e
l’abbassamento del livello di autoefficacia sono indipendenti dai giudizi morali sulla propria
90
persona e dalla vittimizzazione o colpevolizzazione personale in base ai risultati ottenuti. Un’altra
linea di separazione deve essere posta tra l’autoefficacia ed il locus of control, ovvero il grado in cui
le persone pensano che l’azione compiuta ed il risultato raggiunto dipendano da loro stessi e dal
loro controllo piuttosto che da fattori esterni come il destino, la fortuna o altri individui;
l’autoefficacia riguarda, invece, la capacità di organizzare ed eseguire determinate azioni per
raggiungere gli obiettivi. Da questa distinzione deriva quella tra l’efficacia personale e le aspettative
di risultato: le convinzioni di autoefficacia costituiscono il giudizio sulle proprie capacità di
organizzazione e gestione delle proprie attività per giungere ad una particolare meta, mentre
un’aspettativa di risultato è un giudizio sulla probabile conseguenza che tali prestazioni potranno
produrre. Infine un’importante precisazione di Bandura riguarda il legame tra l’autoefficacia e gli
stili attributivi: nonostante alcuni autori ritengano che sono gli stili attributivi ad influenzare le
aspettative di autoefficacia e di conseguenza il comportamento e lo stato emozionale della persona,
si può affermare che in realtà la situazione è opposta.
Un’analisi ed una valutazione del senso di efficacia personale delle persone risultano molto
complesse, soprattutto se si tengono in considerazione le notevoli differenze individuali e la
complessità e varietà della popolazione della nostra società. A questo proposito vari studiosi si sono
chiesti se gli effetti del senso di autoefficacia possano essere ritenuti universali, ossia se possano
essere generalizzabili a tutte le culture nonostante le loro differenze di principi, valori e credenze; i
dati dimostrano che effettivamente il senso di autoefficacia è universale, dal momento che trae
origine da meccanismi psicologici essenziali, propri dell’attività umana in generale (Bandura,
1999).
91
Psicologia dell’apprendimento e motivazione scolastica
IV Unità Didattica – Lezione 5
Autoefficacia dell’insegnante
Gli insegnanti hanno il compito di creare situazioni e ambienti favorevoli all’apprendimento e allo
sviluppo delle competenze cognitive dei bambini, di sfruttare tutte le risorse disponibili per
giungere a questo risultato e di contrastare le influenze sociali che pregiudicano l’impegno degli
studenti a scuola; gli insegnanti assolvono tale compito grazie al loro talento e al loro senso di
autoefficacia.
Un concetto centrale nella definizione di benessere dell’insegnante è la soddisfazione lavorativa. Il
grado di soddisfazione è, infatti, correlato alla probabilità di abbandono della professione. In
particolare, è stato osservato che gli insegnanti impegnati in programmi di educazione speciale sono
più insoddisfatti di quelli coinvolti nell’istruzione generale o in entrambi i contesti e
particolarmente insoddisfatti risultano gli insegnanti più giovani e con minore esperienza.
Tra i determinanti della soddisfazione lavorativa si annoverano l’interazione con gli studenti, gli
atteggiamenti sociali, lo stile di leadership dei dirigenti scolastici e il riconoscimento sociale della
professione. Coloro che hanno elevate concezioni di autoefficacia educativa dedicano gran parte del
loro tempo alle attività scolastiche e alla loro programmazione, gratificano i successi scolastici degli
studenti, forniscono loro una valida guida e predispongono esperienze in cui gli alunni possono
sperimentare sensazioni di padronanza; coloro che, viceversa, non credono fermamente nelle loro
abilità, dedicano poco tempo libero alle attività scolastiche, criticano spesso i loro allievi, si
arrendono di fronte alle prime difficoltà, non sanno gestire la classe, sono stressati e pessimisti, si
focalizzano sull’insegnamento della disciplina piuttosto che sull’effettivo sviluppo degli allievi,
tendono ad evitare le materie che corrispondono alle loro aree di inefficacia percepita e, se
potessero scegliere, cambierebbero mestiere.
92
Spesso un insegnante si trova esposto a situazioni stressanti ed è importante che sappia dirigere i
suoi sforzi verso la soluzione del problema, piuttosto che limitarsi a lenire il suo disagio
emozionale, e in tutto questo è ampiamente aiutato da un elevato livello di efficacia personale.
Una scuola efficace è caratterizzata da un sistema di causazione reciproca: il senso di efficacia degli
insegnanti influisce sulle concezioni personali, le aspirazioni e l’apprendimento degli studenti, in
particolare i più piccoli, e sul livello di partecipazione dei genitori alla vita scolastica dei figli; a sua
volta le caratteristiche, i risultati degli allievi ed il loro background familiare possono modificare le
convinzioni di efficacia degli insegnanti. Una causazione reciproca positiva può dare origine ad un
progressivo aumento del successo scolastico e del livello di efficacia personale degli insegnanti,
mentre una causazione reciproca negativa può demoralizzare gli studenti e gli insegnanti e
decrementare il loro livello di autoefficacia. Un esempio del secondo tipo di relazione è dato dalla
presenza nella scuola di studenti svantaggiati; numerosi studi dimostrano che gran parte del
personale scolastico possiede un basso senso di efficacia personale quando deve affrontare
l’istruzione di studenti poveri o extracomunitari e nutre basse aspettative rispetto al loro futuro, dal
momento che tali allievi presentano difficoltà cognitive, motivazionali e sociali che vengono spesso
interpretate, da parte degli insegnanti, come mancanza di interesse ed impegno. Per modificare tale
situazione, che è caratterizzata da una relazione bidirezionale negativa, è fondamentale costruire un
resistente tessuto connettivo tra scuola, famiglia ed enti esterni e impegnarsi in iniziative collettive,
in modo che gli insegnanti ricevano un sostegno ed un aiuto nel gestire le attività educative e
possano così ottenere dei buoni risultati anche con gli studenti svantaggiati, aumentando la loro
concezione di autoefficacia (Bandura, 1999).
E’ importante sottolineare che le convinzioni di efficacia degli insegnanti, come di molte altre
persone quando si analizza il loro senso di efficacia occupazionale, non corrispondono ad un
generico senso di competenza o di autostima, ma sono l’espressione di un costrutto legato a
situazioni e realtà specifiche.
93
A.C. Porter e J. Brophy (1988) mostrano un quadro sintetico delle caratteristiche degli insegnanti
efficaci, proveniente da studi dell’IRT, cioè l’Institute for Research on Teaching. Gli insegnanti
sarebbero professionisti semi autonomi che:
-
sono chiari riguardo ai loro obiettivi educativi
-
sono bene informati riguardo ai contenuti e alle strategie per insegnarli
-
comunicano ai loro studenti ciò che si aspettano da loro ed il perché
-
usano in modo esperto i materiali educativi esistenti per dedicare più tempo alle pratiche
che arricchiscono e chiarificano il contenuto
-
sono ben informati sui loro studenti, adattano l’istruzione ai loro bisogni e prevengono le
idee sbagliate sulla loro effettiva conoscenza
-
insegnano agli studenti le strategie metacognitive e danno loro l’opportunità di impararle
-
si pongono obiettivi cognitivi sia di livello superiore che di livello inferiore
-
controllano la comprensione degli studenti offrendo un regolare e appropriato feed-back
-
integrano la loro istruzione con quella in altre aree di contenuti
-
accettano la responsabilità per i risultati dei propri studenti
-
pensano e riflettono sulla propria pratica.
A.E. Quagliozzi (2003) ha invece sintetizzato un’indagine svolta dalla società inglese Hay McBer
su incarico del Ministero dell’Istruzione e del Lavoro nel 2000. La ricerca compiuta ha identificato
tre fattori che accrescono l’efficacia dell’insegnamento: le competenze didattiche, le caratteristiche
professionali ed il clima di classe.
Le competenze didattiche sono micro-comportamenti che possono essere appresi, mentre le
caratteristiche professionali hanno radici molto più profonde; sono quei modelli di comportamento
che spingono ad agire in un certo modo, e servono a sostenere le prime. Il clima della classe
rappresenta, invece, una verifica degli esiti dell’insegnamento, indica infatti come gli allievi si
sentono in classe, aspetto determinante per la motivazione ad apprendere.
94
I tre fattori interagiscono e, insieme, possono migliorare il rendimento degli alunni di oltre il 30%.
È stato riscontrato invece che alcuni fattori non sono determinanti, ad esempio fattori come le
informazioni sull’età degli insegnanti, sugli anni di servizio, ecc. non consentono di predeterminare
l’efficacia dell’insegnamento. Ciò significa che l’uso di tali dati non è significativo al fine della
valutazione dell’efficacia degli insegnanti. Infine, secondo la ricerca compiuta, nemmeno il contesto
scolastico comprendente la percentuale dei bambini appartenenti a minoranze etniche, la
dimensione della scuola ecc. è risultato pertinente per la predizione dei progressi degli studenti.
La ricerca, infine, dimostra che gli insegnanti efficaci sono in grado di trasformare le aule in
ambienti stimolanti, che motivino gli alunni e facilitino l’apprendimento. Il clima presenta diverse
caratteristiche, ognuna delle quali ha una determinata influenza sugli allievi e sul loro modo di
sentirsi in classe. L’analisi svolta ha messo in evidenza tre fattori che hanno una certa rilevanza per
l’apprendimento: la mancanza di disturbo e di interruzioni, l’incoraggiamento all’impegno e le
elevate aspettative da parte dell’insegnante.
95
Psicologia dell’apprendimento e motivazione scolastica
IV Unità Didattica – Lezione 6
Autostima
L’autostima rappresenta una componente essenziale di ogni individuo; essa non deve essere però
confusa con il concetto di sé. Il concetto di sé è l’insieme di elementi cui una persona fa riferimento
per descrivere se stessa, mentre l’autostima è una valutazione delle informazioni contenute nel
concetto di sé, e deriva dai sentimenti che un individuo prova nei confronti di se stesso in senso
globale. In concreto, essa si esprime nel valore positivo o negativo che la persona generalmente si
attribuisce.
Il processo di formazione dell’autostima si snoda lungo due componenti: il sé percepito ed il sé
ideale. Il sé percepito equivale al concetto di sé, cioè ad una visione oggettiva di abilità,
caratteristiche e qualità presenti o assenti nel soggetto. Il sé ideale è l’immagine della persona che ci
piacerebbe essere, non sulla base di aspettative irrealistiche, ma alla luce della convinzione di
possedere determinate qualità. La discrepanza tra sé percepito e ideale crea i problemi di autostima.
Si può considerare l’autostima come un processo circolare in quanto, chi nutre fiducia nel possesso
di determinate sue abilità, tende a conseguire buone prestazioni e quindi ad incrementare
l’autostima, mentre chi ha un’autostima scarsa, tenderà a conseguire risultati sempre più scadenti
che faranno peggiorare maggiormente l’autovalutazione.
Una persona caratterizzata da un buon livello di autostima è estroversa e la sua sicurezza in sé le
permette di non farsi cogliere facilmente dall’ansia. Chi possiede uno scarso livello di autostima
tende all’introversione ed è facilmente preda di ansia e preoccupazioni.
In caso di bassa autostima l’intervento di persone significative quali ad esempio gli insegnanti, può
determinare un aumento di fiducia nelle proprie capacità spezzando, così, il circolo vizioso.
L’autostima non è un elemento statico, ma è soggetta a mutamenti e aggiustamenti nel tempo, in
particolare durante le varie fasi di sviluppo o in situazioni critiche. L’evoluzione dell’autostima è
96
presente già dalla prima infanzia, per poi maturare e consolidarsi acquisendo nuove informazioni
nel corso dello sviluppo successivo.
Nel periodo adulto risulta articolata in più aree: capacità intellettuali e culturali, successo lavorativo,
rapporti familiari, rapporti sociali, aspetto fisico e così via.
L’autostima, in sintesi, può essere definita come l’insieme dei giudizi di valutazione che il soggetto
esprime su se stesso. Dal punto di vista evolutivo, essa si differenzia progressivamente in varie
dimensioni sulla base delle quali il soggetto compie una valutazione articolata in ambiti specifici:
- dimensioni del successo interpersonale ( possibilità di accettazione e simpatia);
- dimensioni della competenza (essere capace di fare determinate cose);
- abilità diverse (fisiche, scolastiche ecc.);
- autostima sociale (rapporti con i coetanei, con i colleghi, con i genitori, ecc.).
L’autostima può essere percepita dall’individuo globalmente, in rapporto al suo valore complessivo
o in modo specifico. L’autostima specifica è una guida che dirige il comportamento e deriva dal
rapporto fra le aspirazioni di successo del soggetto e le sue competenze effettivamente acquisite.
L’autostima globale è legata al livello di auto-accettazione e rispetto per se stesso dell’individuo
(connotata più dagli affetti che dalla razionalità) e non fornisce indicazioni precise riguardo al
comportamento specifico. Sono le forme di autostima specifiche ad avere effetti su quelle globali.
L’entità di questo effetto dipende dall’importanza assegnata all’ambito in cui ci si valuta.
M. Kernis si è occupato del tema dell’instabilità dell’autostima nell’ambito di numerose ricerche.
L’instabilità del livello dell’autostima può essere valutata:
•
su fluttuazioni a lungo termine. L’instabilità riflette cambiamenti nel livello di base che si
verificano lentamente e su di un lungo periodo di tempo:
•
su fluttuazioni a breve termine. L’instabilità si manifesta con incrementi o decrementi
temporanei, causati da specifici eventi che vengono utilizzati per l’autovalutazione.
All’instabilità dell’autostima si associano:
•
elevata sensibilità agli eventi valutativi;
97
•
aumento dell’attenzione alla propria valutazione di sé;
•
eccessiva fiducia nelle fonti sociali di valutazione.
Per quanto riguarda la sua origine, cioè se l’autostima sia generata da fonti esterne o si formi
all’interno dell’individuo, Cooley ritiene che il sé si formi rispecchiandosi nelle reazioni degli altri.
Ciò sta ad indicare che il modo in cui consideriamo noi stessi dipende dal modo in cui gli altri ci
riflettono le nostre azioni, quindi se veniamo trattati con disprezzo dagli altri, tenderemo, di riflesso,
ad adottare il punto di vista negativo dell’altro che ci è stato comunicato.
Anche Rosenberg sostiene che la valutazione che l’individuo compie di se stesso è influenzata
fortemente dalle reazioni altrui. Il concetto di sé e l’autostima, secondo tale prospettiva, si
sviluppano attraverso un continuo processo di interazione tra l’individuo e il suo ambiente, tra i
quali c’è un rapporto di reciprocità, poiché l’individuo agisce sull’ambiente e l’ambiente, a sua
volta, reagisce influenzando l’individuo.
L’autostima ha dunque diverse fonti: può derivare da autovalutazioni sulla competenza personale o
sul possesso di caratteristiche culturalmente investite di valore positivo o negativo. Nell’autostima
che deriva dalla competenza personale, gli individui si sentono soddisfatti quando riescono a
raggiungere i loro standard, quando svolgono bene il proprio lavoro, mentre sono insoddisfatti se
non sono all’altezza di raggiungere gli obiettivi prefissati. Le competenze personali, quindi,
possono offrire una solida base di autostima.
Spesso le valutazioni compiute dagli individui riflettono l’apprezzamento o il disprezzo per le
caratteristiche personali piuttosto che il giudizio sull’operato; sono legate, cioè, ad esempio a
caratteristiche fisiche o allo status sociale invece che alle competenze. Questo aspetto è da tener in
considerazione soprattutto perché il senso di valore personale di ognuno tende a riflettere le
valutazioni ricevute dagli altri.
Il senso di valore personale è influenzato poi dagli stereotipi culturali. A volte le persone vengono
classificate in gruppi socialmente apprezzati o disprezzati, in base a etnia, razza, sesso,
98
caratteristiche fisiche, e vengono trattare con atteggiamenti dettati dallo stereotipo sociale e non in
base alla loro individualità; in queste situazioni, nelle vittime subentra una perdita di autostima.
In genere le pratiche sociali di svalutazione poggiano su giustificazioni che attribuiscono ai gruppi
svantaggiati alcune colpe. Se tale attribuzione è convincente, gli stessi membri del gruppo
disprezzato possono arrivare, col tempo, a condividere la caratterizzazione denigrante fatta loro. Si
crea così un effetto di autosvalutazione maggiore, e le persone che possiedono attributi denigrati
dalla società, accettando le valutazioni negative dettate dagli stereotipi, avranno una bassa stima di
sé indipendentemente dal loro impegno.
Proprio perché l’autostima ha diverse fonti, i modi per svilupparla sono vari. L’autosvalutazione
che si origina dall’incompetenza necessita della coltivazione di capacità che favoriscano risultati
positivi e di un recupero della soddisfazione di sé. Chi si è posto standard troppo elevati da
raggiungere, e quindi si svilisce, può essere aiutato attraverso l’adozione di standard più realistici.
L’autosvalutazione derivante da giudizi sociali disprezzanti necessita di un sostegno maggiore da
parte degli altri, in modo da riaffermare il valore della persona.
Se l’autosvalutazione è la conseguenza di uno svilimento discriminatorio di attributi personali, può
risultare utile incentivare il senso d’orgoglio per tali caratteristiche.
Se poi la svalutazione è dovuta a molteplici cause, è necessaria una correzione su più fronti, ad
esempio non solo incoraggiando l’orgoglio per le proprie caratteristiche ma anche coltivando
competenze che permettano l’instaurarsi di un elevato senso di efficacia.
99
Bibliografia
Alexander, P., Winne, P. (2006). Handbook of educational psychology. LEA.
Antonietti, A. (1998). Psicologia dell'apprendimento. Processi, strategie e ambienti cognitivi.
Brescia: La Scuola.
Bandura, A. (1999) Moral disengagement in the perpetration of inhumanities. Personality and Social
Psychology Review, 3, 193-209.
Baroni, M.R., D’Urso, V. (2012). Psicologia generale. Torino: Einaudi.
Borgogni, L. (2005). Efficacia organizzativa. Il contributo della teoria sociale cognitiva alla
conoscenza delle organizzazioni. Milano: Guerrini Studio.
Bruner, J. (1983). Il linguaggio del bambino. Trad. it. Roma: Armando, 1991.
Hartup, W.W. (1983). Peer relations. In P.H. Mussen (Ed.), Handbook of Child Psychology (pp.
103–196). New York: John Wiley & Sons.
Iannaccone, A., Longobardi, C. (a cura di) (2004) Percorsi educativi in psicologia scolastica: dalla
prescuola alla scuola dell'obbligo. Milano: Franco Angeli.
Lave, J., Wenger, E. (1991). Situated learning. Legitimate peripheral participation. Cambridge,
Cambridge University Press.
Novak, J.D. (2001), L'apprendimento significativo. Trento: Erickson.
Piaget, J. (1932). Il giudizio morale del fanciullo. Trad. it., Firenze: Giunti, 1973.
Pianta, R.C. (2001). The Student–Teacher Relationship Scale. Charlottesville: University of
Virginia.
Polito, M. (2012). Atleti della mente. Il potere dell'attenzione e della concentrazione. Editori
Riuniti Univ. Press.
Quagliozzi, A.E. (2003). Divenire Insegnanti Efficaci. In www.graffinrete.it/tracciati/articolo.php
Tirassa, M. (2010). La natura e il ruolo dell'intersoggettività nella comunicazione. In F. Morganti,
A. Carassa, G. Riva (a cura di), Intersoggettività e interazione. Un dialogo fra scienze cognitive,
scienze sociali e neuroscienze (p. 117-135). Torino: Bollati Boringhieri.
Vygotskij, L.S. (1934). Pensiero e linguaggio. Ricerche psicologiche. Trad. it. Roma: Laterza,
1992.
100
Wood, S. (1989). The Transformation of Work? Skill, Flexibility and the Labour Process. London:
Unwin Hyman.
101
102