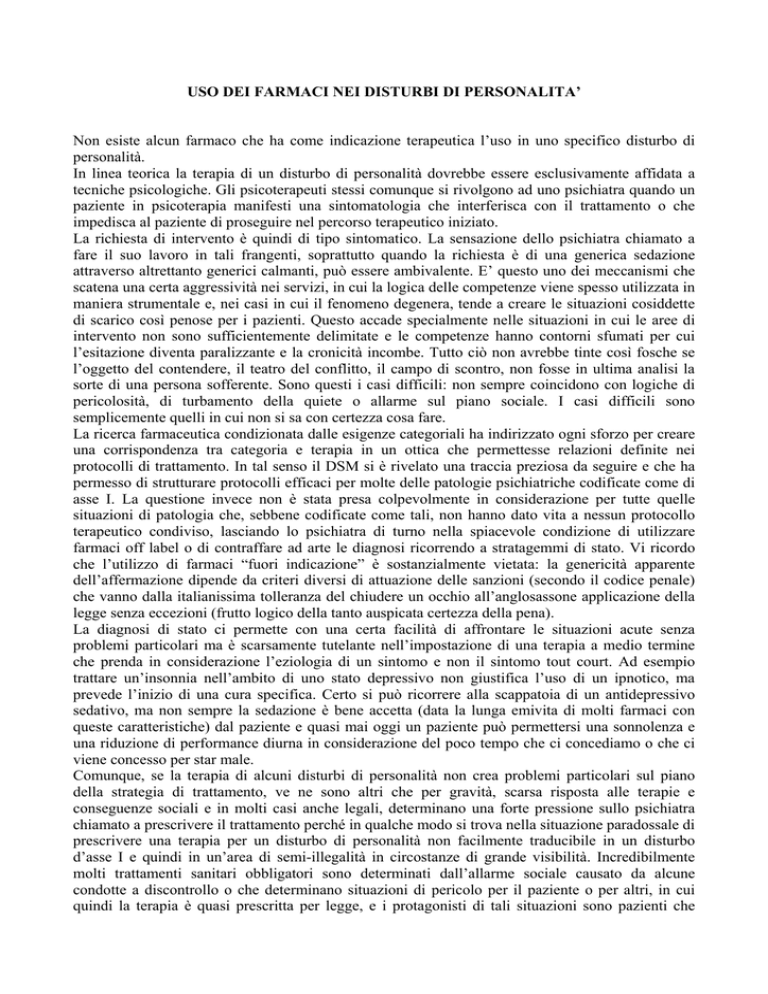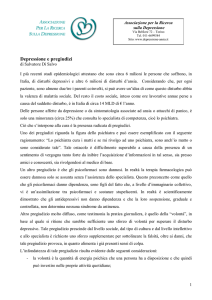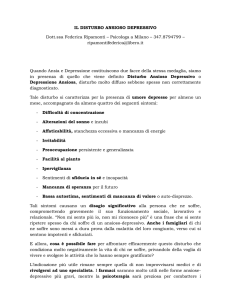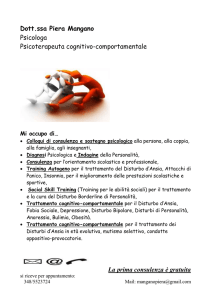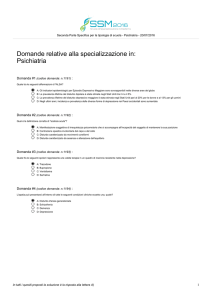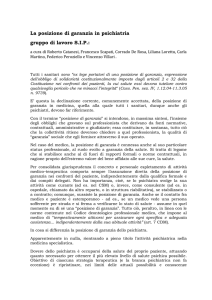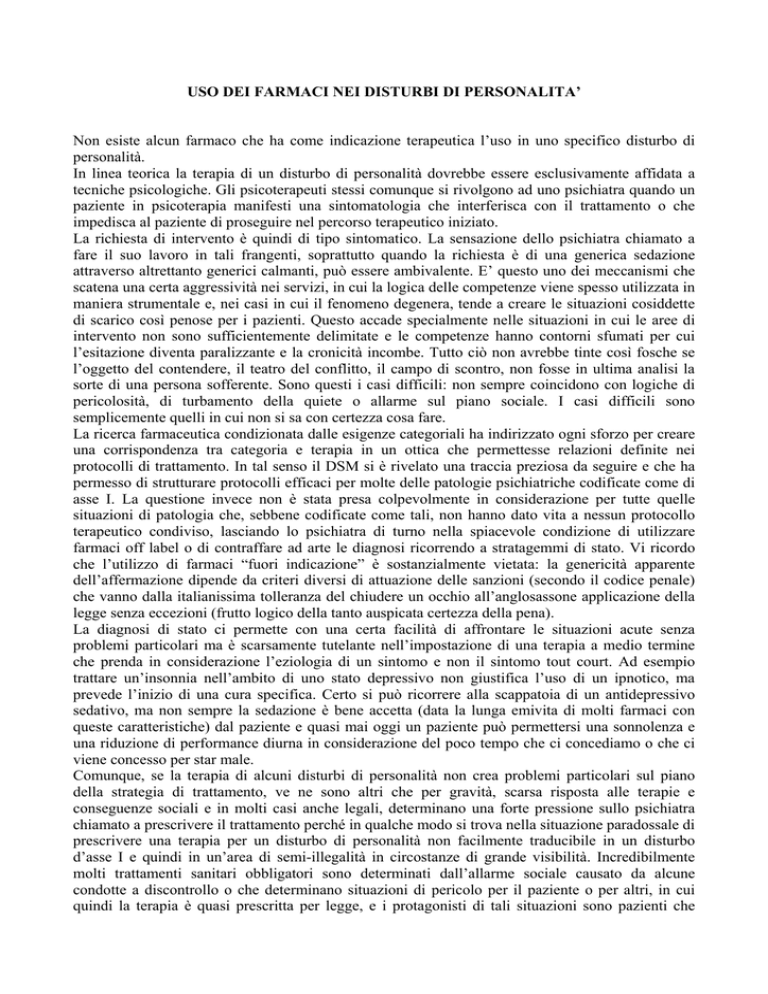
USO DEI FARMACI NEI DISTURBI DI PERSONALITA’
Non esiste alcun farmaco che ha come indicazione terapeutica l’uso in uno specifico disturbo di
personalità.
In linea teorica la terapia di un disturbo di personalità dovrebbe essere esclusivamente affidata a
tecniche psicologiche. Gli psicoterapeuti stessi comunque si rivolgono ad uno psichiatra quando un
paziente in psicoterapia manifesti una sintomatologia che interferisca con il trattamento o che
impedisca al paziente di proseguire nel percorso terapeutico iniziato.
La richiesta di intervento è quindi di tipo sintomatico. La sensazione dello psichiatra chiamato a
fare il suo lavoro in tali frangenti, soprattutto quando la richiesta è di una generica sedazione
attraverso altrettanto generici calmanti, può essere ambivalente. E’ questo uno dei meccanismi che
scatena una certa aggressività nei servizi, in cui la logica delle competenze viene spesso utilizzata in
maniera strumentale e, nei casi in cui il fenomeno degenera, tende a creare le situazioni cosiddette
di scarico così penose per i pazienti. Questo accade specialmente nelle situazioni in cui le aree di
intervento non sono sufficientemente delimitate e le competenze hanno contorni sfumati per cui
l’esitazione diventa paralizzante e la cronicità incombe. Tutto ciò non avrebbe tinte così fosche se
l’oggetto del contendere, il teatro del conflitto, il campo di scontro, non fosse in ultima analisi la
sorte di una persona sofferente. Sono questi i casi difficili: non sempre coincidono con logiche di
pericolosità, di turbamento della quiete o allarme sul piano sociale. I casi difficili sono
semplicemente quelli in cui non si sa con certezza cosa fare.
La ricerca farmaceutica condizionata dalle esigenze categoriali ha indirizzato ogni sforzo per creare
una corrispondenza tra categoria e terapia in un ottica che permettesse relazioni definite nei
protocolli di trattamento. In tal senso il DSM si è rivelato una traccia preziosa da seguire e che ha
permesso di strutturare protocolli efficaci per molte delle patologie psichiatriche codificate come di
asse I. La questione invece non è stata presa colpevolmente in considerazione per tutte quelle
situazioni di patologia che, sebbene codificate come tali, non hanno dato vita a nessun protocollo
terapeutico condiviso, lasciando lo psichiatra di turno nella spiacevole condizione di utilizzare
farmaci off label o di contraffare ad arte le diagnosi ricorrendo a stratagemmi di stato. Vi ricordo
che l’utilizzo di farmaci “fuori indicazione” è sostanzialmente vietata: la genericità apparente
dell’affermazione dipende da criteri diversi di attuazione delle sanzioni (secondo il codice penale)
che vanno dalla italianissima tolleranza del chiudere un occhio all’anglosassone applicazione della
legge senza eccezioni (frutto logico della tanto auspicata certezza della pena).
La diagnosi di stato ci permette con una certa facilità di affrontare le situazioni acute senza
problemi particolari ma è scarsamente tutelante nell’impostazione di una terapia a medio termine
che prenda in considerazione l’eziologia di un sintomo e non il sintomo tout court. Ad esempio
trattare un’insonnia nell’ambito di uno stato depressivo non giustifica l’uso di un ipnotico, ma
prevede l’inizio di una cura specifica. Certo si può ricorrere alla scappatoia di un antidepressivo
sedativo, ma non sempre la sedazione è bene accetta (data la lunga emivita di molti farmaci con
queste caratteristiche) dal paziente e quasi mai oggi un paziente può permettersi una sonnolenza e
una riduzione di performance diurna in considerazione del poco tempo che ci concediamo o che ci
viene concesso per star male.
Comunque, se la terapia di alcuni disturbi di personalità non crea problemi particolari sul piano
della strategia di trattamento, ve ne sono altri che per gravità, scarsa risposta alle terapie e
conseguenze sociali e in molti casi anche legali, determinano una forte pressione sullo psichiatra
chiamato a prescrivere il trattamento perché in qualche modo si trova nella situazione paradossale di
prescrivere una terapia per un disturbo di personalità non facilmente traducibile in un disturbo
d’asse I e quindi in un’area di semi-illegalità in circostanze di grande visibilità. Incredibilmente
molti trattamenti sanitari obbligatori sono determinati dall’allarme sociale causato da alcune
condotte a discontrollo o che determinano situazioni di pericolo per il paziente o per altri, in cui
quindi la terapia è quasi prescritta per legge, e i protagonisti di tali situazioni sono pazienti che
hanno una struttura fondamentalmente borderline ed organizzazioni narcisistiche, paranoidi ed
antisociali (raramente schizoidi). In pratica si accetta un principio borderline in cui la negazione
diventa meccanismo fondamentale di relazione con la realtà e si agisce in nome di questo. Qualcuno
direbbe che si fa “di necessità virtù”, o che “tra il dire e il fare…”, o che “fatta la legge trovato….”.
Ecco perché le organizzazioni antisociali e paranoidi oggi sembrano avere una pressione selettiva
sul piano sociale.
Ritorniamo però a ciò che si può fare oggi dal punto di vista farmacologico nella terapia dei disturbi
di personalità.
Come accennato fra le righe poco fa, le situazioni differiscono a seconda delle organizzazioni di
personalità che ci troviamo di fronte e dalla coincidenza o meno di organizzazione, disturbo di
personalità ed eventuale disturbo d’asse primo correlato. In realtà come diceva Lucrezio “natura
non facit saltus” per cui si tratta di capire a che punto di patologia si è spinto il fallimento
dell’organizzazione di personalità di base. Questa variabile dipende probabilmente più dalla
struttura (nevrotica-borderline-psicotica) del paziente che dall’organizzazione e dal disturbo di asseI
che ci troviamo a trattare.
In pratica, nel caso più semplice di un personalità depressiva che presenta un episodio depressivo
di varia entità conseguenza di un evento stressante (per es. di perdita), la logica farmacoterapeutica
ortodossa prevedrebbe l’utilizzo di un antidepressivo. Tutto dovrebbe andare bene se non accadesse
che il paziente anziché migliorare come ci si dovrebbe aspettare, quindi gradualmente e con un
tempo di latenza di almeno due settimane, vira in tre giorni in uno stato di estremo benessere. Lo
psichiatra spaventato dalla mania che incombe come una nube minacciosa sulla testa di chiunque
presenti un episodio depressivo (tanto che con il senno di poi qualcuno dirà al malcapitato
psichiatra di turno che doveva mettere uno stabilizzatore subito) sospende il farmaco bruscamente.
Il paziente rimane un po’ sconcertato ma accetta sentendosi come ogni buon depresso
assolutamente colpevole di non aver risposto alla terapia come doveva. Non accade quindi più nulla
se non che il paziente resta, con qualche titubanza, in uno stato di benessere. Lo psichiatra intanto
medita sulla necessità di un neurolettico o di uno stabilizzatore, poi, seguendo un certo buon senso,
aspetterà di vedere il da farsi. Qualcosa gli dice che non può essere andato tutto così dritto, infatti a
distanza di qualche mese il paziente si ripresenterà dallo psichiatra per una recidiva: allora il
paziente rischierà di sentirsi dire che l’altra volta è fuggito nella guarigione ma che questa volta non
sarà così facile sfuggire ad una terapia. Non tutti i pazienti hanno fiato sufficiente per cavarsela
scappando … purtroppo.
Il senso di questa storia è che una terapia farmacologica può essere semplice in un disturbo d’asse I
per cui molte volte un antidepressivo rimette in sesto un paziente con una depressione dopo 4-5
settimane, un serotoninergico controlla l’ansia anticipatoria e le crisi di panico o riduce la tendenza
alla ruminazione di un pensiero ossessivo. Ma che succede quando l’attacco di panico è l’esordio di
uno scompenso psicotico in una struttura paranoide? Che succede se lo stato depressivo è il primo
segno di cedimento e di richiesta d’aiuto di una persona con una struttura antisociale?.
Riprendendo un esempio di Nancy McWilliams: “Per chiarire (a costo di insistere sullo stesso
punto): se si sta lavorando con una donna bulimica che ha sviluppato il disturbo alimentare nel
periodo dell’università e riconosce che quel comportamento è autodistruttivo e indipendente dalla
sua volontà, si hanno aspettative diverse da quelle che si avrebbero con una donna borderline che ha
avuto cicli di abbuffate e vomito fin dalla scuola elementare e considera ragionevole il proprio
comportamento in base alle pressioni sociali che impongono alla donna di esser magra. E’ lecito
attendersi di riuscire a dare un aiuto duraturo alla prima cliente in poche settimane, mentre con la
seconda un obiettivo realistico della terapia sarebbe che in un paio d’anni la paziente si renda conto
del prezzo che ha pagato alla sua bulimia e si fidi del terapeuta abbastanza da cominciare a cercare
di cambiare sul serio”. E’ chiaro quindi che enfatizzare il sintomo e arrivare a generalizzare sulla
base di questo, senza contestualizzarlo in una organizzazione o struttura di personalità, può
determinare da una parte il fallimento della terapia e dall’altra, come conseguenza, la perdita della
speranza in una possibile “guarigione”.