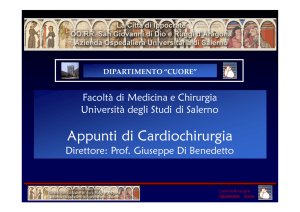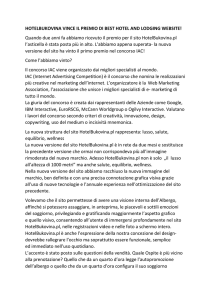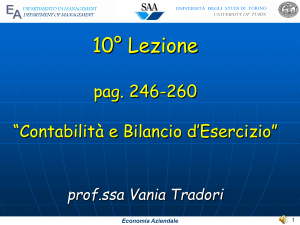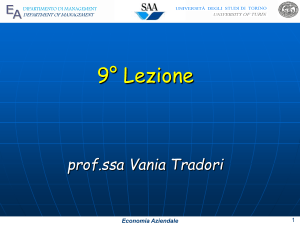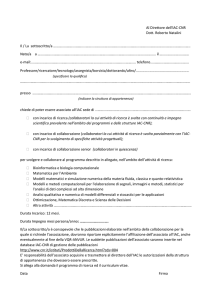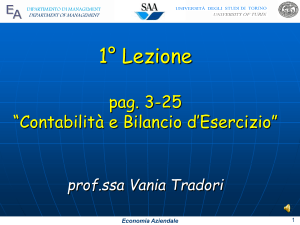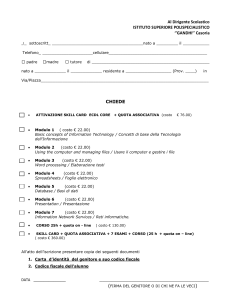DIPARTIMENTO “CUORE”
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Salerno
Appunti di Cardiochirurgia
Direttore: Prof. Giuseppe Di Benedetto
Card iochiru rgia
Dipartimento Cuore
Principi di circolazione
extracorporea (CEC)
II parte
dr. Antonio Longobardi
dr. Antonio Panza
Prof. Giuseppe Di Benedetto
Card iac Su rgery
“Heart” Department
Circolazione extracorporea
COMPONENTI STRUTTURALI
OSSIGENATORE
venous
line
POMPA
SCAMBIATORE DI
CALORE
arterial
line
arterial filter
ABF 25/40
gas blender
air
O
2
FILTRI
MONOLYTH
CANNULE
suction pump
main pump
Card iac Su rgery
“Heart” Department
Componenti strutturali
SCAMBIATORE DI CALORE
In tutti gli ossigenatori attuali è
contenuto uno scambiatore
termico, al fine di mantenere
costante la temperatura del
sangue di perfusione e/o di
indurre un certo grado di
ipotermia
Card iac Su rgery
“Heart” Department
Circolazione extracorporea
COMPONENTI STRUTTURALI
OSSIGENATORE
arterial
line
venous
line
POMPA
SCAMBIATORE DI CALORE
FILTRI
arterial filter
ABF 25/40
gas blender
air
O
2
CANNULE
MONOLYTH
suction pump
main pump
Card iac Su rgery
“Heart” Department
Componenti strutturali
FILTRI
Hanno lo scopo di bloccare materiali
provenienti dal campo operatorio,
particelle di grasso, microtrombi e
bolle d’aria
Struttura:
Maglie di nylon con pori di 40-200 µ
Card iac Su rgery
“Heart” Department
Circolazione extracorporea
COMPONENTI STRUTTURALI
OSSIGENATORE
arterial
line
venous
line
POMPA
SCAMBIATORE DI CALORE
FILTRI
CANNULE
arterial filter
ABF 25/40
gas blender
air
O
2
MONOLYTH
suction pump
main pump
Card iac Su rgery
“Heart” Department
Componenti strutturali
CANNULE
La macchina cuorepolmone viene collegata
al paziente mediante un
serie di cannule
Caratteristiche:
Flessibilità
Trasparenza
Inerzia biologica
Card iac Su rgery
“Heart” Department
Componenti strutturali
CANNULAZIONE ARTERIOSA
Serve per l’immissione nel sistema circolatorio del
paziente del sangue proveniente dalla macchina cuore
polmoni
Cannulazione Centrale
Cannulazione Periferica
Card iac Su rgery
“Heart” Department
Componenti strutturali
CANNULAZIONE ARTERIOSA
Cannulazione Centrale
Aorta
Card iac Su rgery
“Heart” Department
Componenti strutturali
CANNULAZIONE ARTERIOSA
Cannulazione Periferica
• Aorta ascendente calcifica
Femorale
• Aneurismi arco aortico
Ascellare
• Dissezioni aortiche
Succlavia
• Reinterventi
Card iac Su rgery
“Heart” Department
Componenti strutturali
CANNULAZIONE VENOSA
Serve per il drenaggio del sangue venoso dal paziente alla
macchina cuore-polmone
Cannulazione Centrale
Cannulazione Periferica
Card iac Su rgery
“Heart” Department
Componenti strutturali
CANNULAZIONE VENOSA
Cannulazione Centrale
Atrio destro
Bicavale
Card iac Su rgery
“Heart” Department
Componenti strutturali
CANNULAZIONE VENOSA
Cannulazione Periferica
Femorale
Card iac Su rgery
“Heart” Department
Conduzione della CEC
EPARINIZZAZIONE
Meccanismo d’azione
Si lega all’antitrombina III (principale inibitore della trombina)
Il complesso Eparina-Antitrombina III ha maggior affinità per la
trombina
Somministrare 3 mg/kg di peso corporeo prima della cannulazione
Al termine dell’intervento l’eparina viene neutralizzata mediante
infusione di solfato di protamina (1,3 mg di solfato di protamina ogni
mg di eparina somministrata)
Card iac Su rgery
“Heart” Department
Conduzione della CEC
Cannulazione arteriosa
Cannulazione venosa
Collegamento delle cannule al
circuito per la circolazione
extracorporea
Inizio bypass cardio-polmonare
Flusso continuo di 2,2 – 2,4 l/min/m2
Pressione di perfusione 50 – 100 mmHg
Svantaggi flusso continuo rispetto a quello pulsatile (fisiologico):
↑ delle resistenze periferiche → ↓ perfusione tessutale → accumulo di
metaboliti acidi intracellulari (acidosi metabolica)
↑ consumo di O2
Fenomeni degenerativi a carico delle cellule dei tubuli renali e cerebrali
Card iac Su rgery
“Heart” Department
Conduzione della CEC
IPOTERMIA
Razionale
Proteggere il cuore e gli altri organi riducendo la richiesta di
O2
L’attività metabolica si raddoppia o si dimezza per ogni 10 C
in più o in meno di temperatura
Ipotermia moderata: fino a 28 C
Ipotermia intermedia: da 28 a 20 C
Ipotermia profonda: meno di 20 C
Monitoraggio:
T Rettale: T viscerale
T naso-faringea: T cerebrale
Card iac Su rgery
“Heart” Department
Conduzione della CEC
ARRESTO DI CIRCOLO IN IPOTERMIA
PROFONDA
In caso di chirurgia dell’arco aortico
Safe period:
Periodo durante il quale non si evidenzierebbero danni funzionali
clinicamente evidenti
La sua durata è inversamente proporzionale al grado di
temperatura
Temperatura ( C)
Consumo di O2 (%)
Safe period
arresto circolatorio (min)
37
100
4-5
29
50
8-10
22
25
16-20
16
12
32-40
10
6
64-80
Card iac Su rgery
“Heart” Department
Conduzione della CEC
CARDIOPLEGIA
Razionale
Gli interventi cardiochirurgici a cuore aperto vengono condotti in
arresto anossico del miocardio indotto con clampaggio aortico
L’anossia prolungata induce modificazioni metaboliche e strutturali
irreversibili della fibrocellula miocardica
Necessità di adottare tecniche di protezione miocardica in modo da:
• Ridurre il danno ischemico
• Mantenere il cuore in uno stato energetico adeguato
• Permettere una ripresa valida della sua contrattilità globale
Card iac Su rgery
“Heart” Department
Conduzione della CEC
CARDIOPLEGIA
Definizione
Soluzione elettrolitica o ematica, solitamente fredda (4 C), e ricca
di potassio
Obiettivi
Arresto del cuore in diastole
Protezione miocardica durante il periodo di clampaggio aortico
Consente
Abolizione del lavoro elettromeccanico
Riduzione della domanda energetica (80-85%)
La combinazione cardioplegia-ipotermia costituisce la protezione
miocardica ideale
Card iac Su rgery
“Heart” Department
Conduzione della CEC
CARDIOPLEGIA
Classificazione
Composizione
Cristalloide
Ematica
Temperatura d’infusione
Calda: 37 C
Fredda: 4 C
Via d’infusione
Anterograda
Retrograda
Combinata
anterograda-retrograda
Intervallo d’infusione
Intermittente
Continua
Card iac Su rgery
“Heart” Department
Conduzione della CEC
CARDIOPLEGIA
Via d’infusione
Anterograda
Bulbo aortico
Osti coronarici
Retrograda
Seno coronarico
Combinata
anterogradaretrograda
Card iac Su rgery
“Heart” Department
Circolazione extracorporea
FISIOPATOLOGIA
EFFETTI POSITIVI:
Riduzione del lavoro
cardiaco
Adeguata perfusione ed
ossigenazione periferica
Protezione miocardica e
tissutale (ipotermia)
EFFETTI NEGATIVI:
Flusso continuo
Alterazioni dell’ematocrito
e della viscosità’ ematica
Alterazioni dell’equilibrio
acido-base
Alterazioni dell’equilibrio
idro-salino
Attivazione della risposta
infiammatoria
Card iac Su rgery
“Heart” Department
Fisiopatologia
Risposta infiammatoria sistemica
Conseguenze
Generali
Vasoplegia
Locali (danno d’organo)
Cuore
Polmone
Rene
Cervello
Card iac Su rgery
“Heart” Department
Circolazione extracorporea
COMPLICANZE
Cardiache
Sindrome da bassa portata
Aritmie
Infarto miocardico perioperatorio
Card iac Su rgery
“Heart” Department
Circolazione extracorporea
COMPLICANZE
Pleuro-polmonari
Versamento pleurico
Rischi broncopneumonici
Atelettasia
Card iac Su rgery
“Heart” Department
Circolazione extracorporea
COMPLICANZE
Neurologiche
Ischemia cerebrale
Emorragia cerebrale
Disturbi più o meno transitori
della cognizione (memoria,
apprendimento, ecc.)
Disturbi psichiatrici
Card iac Su rgery
“Heart” Department
Circolazione extracorporea
COMPLICANZE
Ematologiche
Riduzione globuli rossi
Riduzione piastrine
Riduzione fattori della
coagulazione
Card iac Su rgery
“Heart” Department
Circolazione extracorporea
COMPLICANZE
Renali
Insufficienza renale acuta
Card iac Su rgery
“Heart” Department