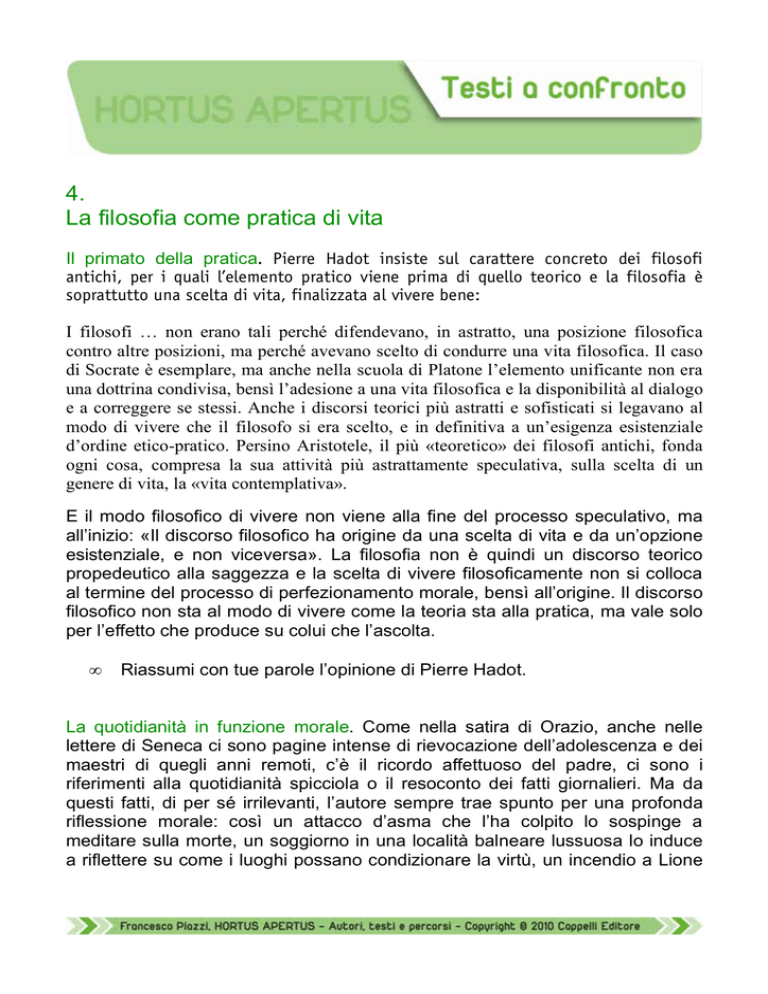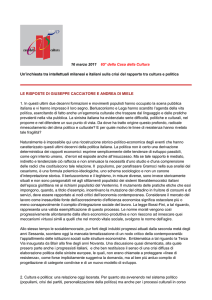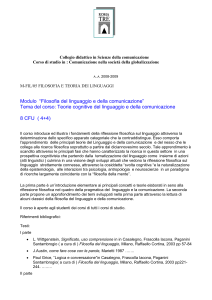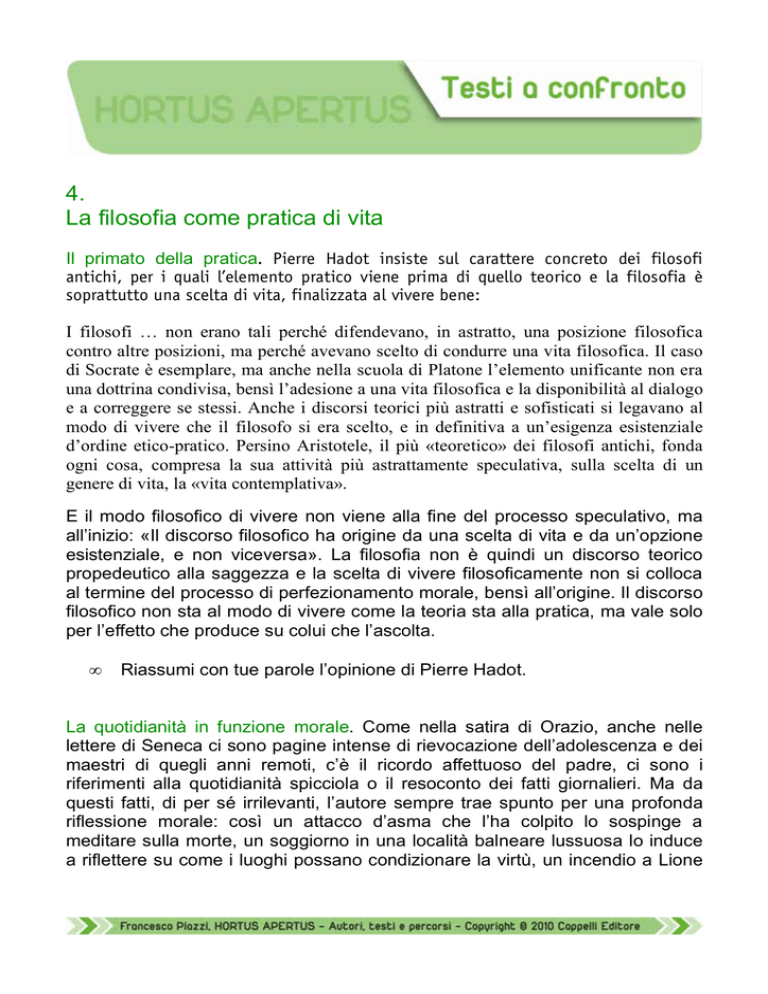
4.
La filosofia come pratica di vita
Il primato della pratica. Pierre Hadot insiste sul carattere concreto dei filosofi
antichi, per i quali l’elemento pratico viene prima di quello teorico e la filosofia è
soprattutto una scelta di vita, finalizzata al vivere bene:
I filosofi … non erano tali perché difendevano, in astratto, una posizione filosofica
contro altre posizioni, ma perché avevano scelto di condurre una vita filosofica. Il caso
di Socrate è esemplare, ma anche nella scuola di Platone l’elemento unificante non era
una dottrina condivisa, bensì l’adesione a una vita filosofica e la disponibilità al dialogo
e a correggere se stessi. Anche i discorsi teorici più astratti e sofisticati si legavano al
modo di vivere che il filosofo si era scelto, e in definitiva a un’esigenza esistenziale
d’ordine etico-pratico. Persino Aristotele, il più «teoretico» dei filosofi antichi, fonda
ogni cosa, compresa la sua attività più astrattamente speculativa, sulla scelta di un
genere di vita, la «vita contemplativa».
E il modo filosofico di vivere non viene alla fine del processo speculativo, ma
all’inizio: «Il discorso filosofico ha origine da una scelta di vita e da un’opzione
esistenziale, e non viceversa». La filosofia non è quindi un discorso teorico
propedeutico alla saggezza e la scelta di vivere filosoficamente non si colloca
al termine del processo di perfezionamento morale, bensì all’origine. Il discorso
filosofico non sta al modo di vivere come la teoria sta alla pratica, ma vale solo
per l’effetto che produce su colui che l’ascolta.
•
Riassumi con tue parole l’opinione di Pierre Hadot.
La quotidianità in funzione morale. Come nella satira di Orazio, anche nelle
lettere di Seneca ci sono pagine intense di rievocazione dell’adolescenza e dei
maestri di quegli anni remoti, c’è il ricordo affettuoso del padre, ci sono i
riferimenti alla quotidianità spicciola o il resoconto dei fatti giornalieri. Ma da
questi fatti, di per sé irrilevanti, l’autore sempre trae spunto per una profonda
riflessione morale: così un attacco d’asma che l’ha colpito lo sospinge a
meditare sulla morte, un soggiorno in una località balneare lussuosa lo induce
a riflettere su come i luoghi possano condizionare la virtù, un incendio a Lione
gli ricorda la necessità di non legarsi ai beni materiali. In questa dimensione
riflessiva, in questo rendere gli episodi privati funzionali alla ricerca morale è la
novità del genere epistolare senecano: un genere che prelude alle forme della
confessione, del diario, del saggio filosofico, care ai letterati d’ogni tempo, da
Agostino a Montaigne, a Leopardi. Ne è un esempio l’epistola 12, di cui
riportiamo una parte.
Dovunque mi volgo scorgo prove del mio invecchiare. Mi ero recato nella mia villa
vicino a Roma e mi lamentavo delle spese necessarie per l’edificio ormai cadente. Il
fattore disse che non dipendeva dalla sua negligenza; lui faceva tutto il possibile, ma
purtroppo la villa era vecchia. Eppure l’ho vista sorgere pietra su pietra. Che dev’essere
di me, se già se ne vanno in polvere queste pietre che hanno la mia età? Irritato con lui,
colgo la prima occasione per sfogare il mio malumore. «È chiaro» dico «che questi
platani sono trascurati; non hanno fronde. Come sono nodosi e secchi i rami, ruvidi e
squallidi i tronchi! Tutto questo non accaderebbe se ci fosse qualcuno a scavare un po’
intorno e ad irrigarli». Egli giura sul mio genio tutelare che fa tutto il possibile, che
continua a prodigare ai platani ogni cura, ma sono ormai vecchi. Sia detto fra noi: li
avevo piantati io e ne avevo visto spuntare le prime foglie. Voltandomi verso la porta,
«Chi è costui?» chiedo «codesto vecchio decrepito che ben a proposito si è posto
davanti alla soglia? Infatti guarda verso l’esterno. Dove l’hai trovato? Che gusto hai
avuto a portar qui il cadavere di un estraneo?». «Ma non mi riconosci?» dice il vecchio.
«Sono Felicione, a cui eri solito recare in dono statuette d’argilla; sono il figlio del
fattore Filosito, il tuo bimbo prediletto». «Ma costui» dico «è davvero fuori di sé; è
diventato anche il mio bimbo prediletto? Senza dubbio è così: proprio ora gli cadono i
denti». Debbo dunque questo alla mia villa suburbana: in tutte le cose a cui ho rivolto
lo sguardo, ho visto chiaramente riflessa la mia vecchiaia. E accogliamola di buon
grado e amiamola; può dare tanta gioia a chi sa goderne (Ep. 12, 1-4).
•
Quali conclusioni trae Seneca dalle pessime condizioni della villa?
•
Che cosa rimprovera al fattore?
•
Che cosa obietta il fattore?
•
C’è resistenza psicologica in Seneca nell’accettare che lo stato di
deterioramento della villa sia dovuto alla vecchiaia e non alla cattiva
manutenzione?
atteggiamento?
Quali
espressioni
denunciano
questo
suo
•
Commenta l’episodio dell’incontro col vecchio Felicione.
•
Di quale acquisizione morale Seneca si ritiene debitore nei confronti
della sua villa?
•
Quali sono le gioie che la vecchiaia può dare a chi sa apprezzare il
buono della vita?
•
Sapresti fare, come avviene in Orazio e in Seneca, una lettura di alcuni
fatti della tua giornata in chiave simbolica, cioè assumendo quel dato
evento, di per sé irrilevante, come testimonianza di una verità più
profonda? Ad esempio, considerando una malattia tua o di un
conoscente come segno della debolezza della natura fisica umana, un
incontro o un colloquio con qualcuno, un tuo successo o insucesso
come fatti emblematici di una verità che trascende l’evento puro e
semplice.
Lo «spirito pratico» dei Romani. Attribuire ai Romani una mentalità pragmatica
è forse un luogo comune, ma non privo di motivazioni. Fin dall’età arcaica i
Romani hanno dimostrato scarso o nullo interesse per la filosofia e, in genere,
per il pensiero astratto, per la riflessione fine a se stessa e non finalizzata
all’azione concreta. Il loro universo mentale era quello di una società a base
contadina e familiare, dove è scontato il primato del fare sul conoscere, della
pratica sulla teoria. I concetti più astratti, di natura teorica o psicologica, sono in
genere metafore agrarie («pensare» da putare «potare», «lieto» da laetus «ben
concimato», «delirare» da delirare «uscire dal solco dell’aratro», ecc.). «Per
loro natura – scrive Max Pohlenz – i Romani erano alieni dal filosofare ed
esclusivamente interessati agli scopi pratici della vita reale. Erano loro estranei
il pensiero speculativo e la passione tipicamente ellenica per la theoria, per la
contemplazione e la conoscenza fine a se stessa». La filosofia poteva essere
ammessa solo in quanto forma di pensiero che serve a progettare un’azione o
a risolvere un problema, come si evince da questa affermazione di un
personaggio di un dramma di Ennio, citata da Cicerone nelle Tusculanae:
Philosophari mihi necesse est paucis, nam omnino haud placet, e cioè «In
poche cose mi serve filosofare, e non mi piace affatto la filosofia in generale»,
cioè non applicata a una specifica questione di rilevanza pratica.
•
Trova i segni di questo pragmatismo nella satira di Orazio. In particolare
riporta la frase nella quale il padre del poeta distingue nettamente
l’interesse teorico del filosofo professionale, interessato a definire i
perché delle scelte umane, dall’interesse dell’uomo comune, che cerca
solo il come si possa vivere in modo saggio e sereno.
Otium e negotium. A Roma otium e negotium, cioè vita contemplativa e vita
attiva, sono sempre stati contrapposti e la preferenza era di solito accordata al
secondo. Per l’otium intellettuale bisognava trovare scusanti, motivazioni che lo
giustificassero in una prospettiva di pubblica utilità. In età repubblicana lo
storico Sallustio, nelle introduzioni delle sue monografie storiche (Bellum
Catilinae e Bellum Iugurthinum), s’interrogava sul significato di un’attività
intellettuale «disinteressata» in una civiltà nella quale solo l’azione dedicata allo
stato sembrava degna di considerazione sociale, mentre l’impegno per la
storiografia, la letteratura, la filosofia non pareva fondato su valori certi. Ancora
nella successiva età augustea il ceto intellettuale romano s’interrogava sul
valore della storiografia, della letteratura, della filosofia, della ricerca scientifica
«pura», cioè sul senso della cultura: in quanto strettamente legata alla prassi
politica o in quanto dotata di un valore autonomo. Sallustio, e con lui la
maggioranza degli intellettuali romani, avevano optato per la prima alternativa
subordinando la storiografia all’attività politica e assegnandole una funzione
nella formazione dell’uomo di stato. Anche Cicerone aveva sciolto l’antitesi tra
otium e negotium subordinando il primo al secondo: l’utilità della riflessione
filosofica è misurata col metro dell’utilità sociale. Ma i poeti pre-augustei come
Catullo e augustei come Orazio, Tibullo, Properzio, Ovidio attribuiranno – in
sintonia con l’individualismo della cultura ellenistica – un valore sempre
maggiore all’otium e alle attività legate alle esigenze affettive, sentimentali,
esistenziali del singolo.
•
Nella satira in questione Orazio lega all’otium la propria attività di filosofo
pratico, precisando che talora butta giù sulla carta le proprie riflessioni
morali (in particolare nelle Satire e nelle Epistole). Ritrova la frase latina
nella quale Orazio fa questa dichiarazione.
•
Nell’espressione usata da Orazio, hai l’impressione che egli voglia
annettere grande importanza a questi suoi prodotti dell’otium? O che
invece tenti di ridimensionare, quasi svalutare questa attività? Perché?
Pochi problemi filosofici e sempre gli stessi
Secondo il filosofo M. Dummet le questioni alle quali i filosofi tentano di dare
una risposta nei secoli sono relativamente poche. L’attività filosofica esplora
possibilità di soluzioni di una gamma stabile e limitatissima di problemi.
Secondo il filosofo contemporaneo Nagel questi problemi essenziali, e
riproposti sempre identici nei secoli, sarebbero solo nove.
I nove problemi sono:
1. conoscenza del mondo al di là delle nostre menti;
2. conoscenza di menti al di là della nostra;
3. la relazione tra mente e corpo;
4. come è possibile il linguaggio;
5. se abbiamo libero arbitrio;
6. il fondamento della moralità;
7. quali ineguaglianze sono ingiuste;
8. la natura della morte;
9. il significato della vita.
(Dummet. La verità ed altri enigmi, trad. it., Milano, il Saggiatore 1986)
L’elemento pratico nelle filosofie antiche
Longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla (Seneca, Ad
Lucilium VI)
La prevalenza dell’elemento pratico su quello teorico nelle filosofie antiche
comportava che i maestri delle scuole filosofiche tendessero a formare i loro
discepoli, piuttosto che ad informarli riguardo ad un pensiero già pronto,
confezionato in forma definitiva. Per ottenere questo risultato, cercavano di
vivere in modo coerente con la loro filosofia, rendendo la loro vita un esempio
da imitare, ricorrendo alla disputa e al dialogo. Sul valore dell’esempio concreto
offerto dal maestro – ma anche dell’esempio che i discepoli, nella comunità
filosofica, si offrivano vicendevolmente comunicandosi i progressi raggiunti
sulla via della saggezza, facendosi reciproco dono dei rimedi che ciascuno ha
sperimentato come efficaci nel curare i mali dell’animo – è istruttivo questo
passo di Seneca (Ad Lucilium VI).
[1] Intellego, Lucili, non emendari me tantum sed transfigurari; nec hoc promitto iam
aut spero, nihil in me superesse quod mutandum sit. Quidni multa habeam quae
debeant colligi, quae extenuari, quae attolli? Et hoc ipsum argumentum est in melius
translati animi, quod vitia sua quae adhuc ignorabat videt; quibusdam aegris
gratulatio fit cum ipsi aegros se esse senserunt. [2] Cuperem itaque tecum
communicare tam subitam mutationem mei; tunc amicitiae nostrae certiorem fiduciam
habere coepissem, illius verae quam non spes, non timor, non utilitatis suae cura
divellit, illius cum qua homines moriuntur, pro qua moriuntur. [3] Multos tibi dabo qui
non amico sed amicitia caruerint: hoc non potest accidere cum animos in societatem
honesta cupiendi par voluntas trahit. Quidni non possit? Sciunt enim ipsos omnia
habere communia, et quidem magis adversa.
Concipere animo non potes quantum momenti adferre mihi singulos dies videam. [4]
«Mitte» inquis «et nobis ista quae tam efficacia expertus es». Ego vero omnia in te
cupio transfundere, et in hoc aliquid gaudeo discere, ut doceam; nec me ulla res
delectabit, licet sit eximia et salutaris, quam mihi uni sciturus sum. Si cum hac
exceptione detur sapientia, ut illam inclusam teneam nec enuntiem, reiciam: nullius
boni sine socio iucunda possessio est. [5] Mittam itaque ipsos tibi libros, et ne multum
operae inpendas dum passim profutura sectaris, inponam notas, ut ad ipsa protinus
quae probo et miror accedas. Plus tamen tibi et viva vox et convictus quam oratio
proderit; in rem praesentem venias oportet, primum quia homines amplius oculis quam
auribus credunt, deinde quia longum iter est per praecepta, breve et efficax per
exempla. [6] Zenonem Cleanthes non expressisset, si tantummodo audisset: vitae eius
interfuit, secreta perspexit, observavit illum, an ex formula sua viveret. Platon et
Aristoteles et omnis in diversum itura sapientium turba plus ex moribus quam ex verbis
Socratis traxit; Metrodorum et Hermarchum et Polyaenum magnos viros non schola
Epicuri sed contubernium fecit. Nec in hoc te accerso tantum, ut proficias, sed ut
prosis; plurimum enim alter alteri conferemus.
[7] Interim quoniam diurnam tibi mercedulam debeo, quid me hodie apud Hecatonem
delectaverit dicam. «Quaeris» inquit «quid profecerim? amicus esse mihi coepi».
Multum profecit: numquam erit solus. Scito esse hunc amicum omnibus. Vale.
[1] Mi accorgo, caro Lucilio, che non solo mi vengo correggendo, ma mi sto anche
trasformando. Non che io creda o voglia far credere che in me non resti nulla da
mutare. Perché non dovrei avere molti impulsi e sentimenti che debbono essere
dominati, frenati o stimolati? Ma anche il vedere i difetti prima ignorati è indizio di un
animo che ha fatto progressi. Ci si rallegra con certi malati, quando sono divenuti
coscienti della loro malattia. [2] Avrei perciò desiderio di renderti partecipe di questo
mio improvviso mutamento: allora comincerei ad avere maggiore fiducia nella nostra
amicizia, quella vera amicizia che né speranze, né timori, né alcuna preoccupazione del
proprio interesse riescono a spezzare; quell’amicizia che non cessa con la morte e per la
quale gli uomini sono disposti a morire. [3] Potrei citarti molti ai quali non mancarono
gli amici, ma mancò l’amicizia: ciò non può accadere quando gli animi sono uniti da un
concorde desiderio di bene. E questo non è forse possibile? Sanno infatti di avere tutto
in comune, e soprattutto le sventure.
Non puoi immaginarti quali progressi spirituali io veda in me ogni giorno che passa. [4]
«Comunica» mi dirai «anche a me codesti rimedi che hai sperimentato così efficaci». E
in verità desidero trasfondere tutto me stesso in te, e godo d’imparare qualcosa, appunto
per insegnarla. Né infatti potrebbe recarmi diletto alcuna cosa, per quanto eccellente e
utile, se dovessi saperla per me solo. Se mi fosse concessa la saggezza, a patto di
tenerla nascosta in me, senza comunicarla ad altri, la rifiuterei: nessun bene ci dà gioia,
senza un compagno. [5] Perciò ti manderò questi libri, e perché tu non faccia molta
fatica a ricercare qua e là i brani più utili, apporrò dei segni, per metterti subito
sottocchio quei passi che destano in me diletto e ammirazione. Tuttavia ti recherà
maggior giovamento il poter vivere e conversare insieme, che un discorso scritto: è
bene che tu venga qui, anzitutto perché gli uomini credono più agli occhi che agli
orecchi, poi perché i progressi ottenuti per mezzo degli ammaestramenti sono lenti,
quelli invece che si ottengono con gli esempi sono più immediati ed efficaci. [6]
Cleante non avrebbe espresso compiutamente il pensiero di Zenone se si fosse limitato
ad udirne le lezioni; egli entrò nella vita del maestro, ne esaminò tutti gli aspetti più
segreti, osservò se viveva in conformità della sua dottrina. Platone e Aristotele e tutta la
schiera dei filosofi che avrebbero poi seguito vie diverse, trassero più vantaggio
dall’esempio di vita che dalle parole di Socrate. Non la scuola di Epicuro, ma la
convivenza con lui, rese grandi uomini Metrodoro, Ermarco e Polieno. E non ti faccio
venire solo perché ne tragga profitto, ma perché tu possa essere di giovamento a me; ci
daremo l’un l’altro un grandissimo aiuto. [7] Intanto, poiché ti debbo il mio piccolo
tributo giornaliero, ti dirò che cosa oggi mi è piaciuto in Ecatone. «Mi chiedi» egli
scrive «quale è stato il mio progresso? Ho cominciato ad essere amico di me stesso».
Grande è stato il suo progresso: non rimarrà più solo. Sappi che tutti possono avere
quest’amico. Addio.
(Trad. G. Monti)
1. transfigurari: «assumere una diversa figura». Figura indica sia la struttura e la configurazione fisica di una persona sia,
come in questo caso, il carattere e l’aspetto morale. – quae debeant: relativa consecutiva. – hoc ipsum argumentum:
anticipa (prolessi) la dichiarativa quod vitia sua quae adhuc ingnorabat videt: «proprio questo stesso fatto, di vedere i
propri difetti che prima ignorava». – est ... animi: «è proprio di un animo che è progredito verso il meglio». Secondo il
precetto socratico del «conosci te stesso», la consapevolezza dei propri difetti e dei propri limiti è già un segno di
progresso morale e di saggezza.
2. Cuperem: apodosi di un periodo ipotetico di terzo tipo. L’irrealtà si giustifica col fatto che Seneca vorrebbe subito
mettere a parte l’amico dei propri progressi morali, ma non può farlo, perché manca la condizione, che più avanti (par. 6) è
considerata essenziale al filosofare, del contubernium, cioè della convivenza. – tam subitam mutationem mei: nel
cammino di ricerca del proprio perfezionamento morale si producono modifiche improvvise, che si vorrebbe comunicare
tempestivamente ai compagni.
3. Multos … caruerint: il congiuntivo è caratterizzante, o più semplicemente esprime una sfumatura consecutiva («molti
… tali che»). Seneca vuol dire che a molti non mancarono gli amici, ma mancò la vera amicizia, intesa nella prospettiva
filosofica di un reciproco ammaestramento come viene qui chiarito. – cum animos … trahit: costr. cum par voluntas
cupiendi honesta trahit animos in societatem. L’amicizia si basa sulla comune volontà di cercare ciò che è buono e onesto.
– et quidem magis adversa: quidem magis è avverbio: «è ancor più»; adversa è aggettivo sostantivato («le avversità»). –
quantum momenti: momentum, da un sostantivo non attestato movimentum che si connette a moveo, indica qui il
progredire in senso non fisico, ma spirituale. Momenti è genitivo partitivo.
4. et nobis: «anche a noi»; et ha spesso il valore di etiam. – transfundere: lett. «versare da un vaso a un altro», come se
l’acquisizione morale fosse un liquido travasabile. – in hoc … ut doceam: hoc è prolettico rispetto alla sostantiva
epesegetica ut doceam; in altre parole: hoc anticipa la proposizione ut doceam, che spiega il valore di hoc: «in questo, cioè
nell’insegnare». – licet sit eximia et salutaris: congiuntivo concessivo. – mihi uni: dativo di vantaggio. – hac exceptione
… ut … teneam nec enuntiem: hac exceptione è prolettico rispetto alle due sostantive ut … teneam nec enuntiem. –
nullius … possessio est: costr. possessio nullius boni est iucunda sine socio, nessun possesso materiale o morale vale se
non è condiviso con gli amici.
5. sectaris: intensivo di sequor «andare a cercare qua e là». – convictus: «il vivere insieme» (convivo, da cum e vivo). – in
rem praesentem: nella situazione concreta, direttamente vissuta, non riferita attraverso una lettera. – venias oportet:
comune la costruzione col congiuntivo senza ut. – per praecepta … per exempla: complementi di moto attraverso luogo
figurati.
6. Metrodorum et Hermarchum et Polyaenum: filosofi minori di scuola epicurea. – contubernium: il condividere
l’abitazione, il vivere insieme (da con e taberna). – in hoc … ut proficias … ut prosis: solita prolessi del dimostrativo
rispetto alle due sostantive al congiuntivo con ut. – alter alteri: comune espressione per indicare la reciprocità tra due
persone.
7. quid profecerim: «in che cosa io sia progredito»; quid è accusativo di relazione («relativamente a che cosa»). – Scito:
l’imperativo futuro, normalmente usato nelle leggi e nei documenti religiosi, conferisce particolare solennità a questa
considerazione finale.
•
Commenta il primo paragrafo alla luce del comandamento di Socrate
«conosci te stesso», che faceva coincidere la saggezza con la
consapevolezza della propria ignoranza e dei propri limiti.
•
Perché chi riconosce i propri difetti è già sulla strada della saggezza?
•
Commenta il senso di concretezza che i verbi videre e sentire danno alla
ricerca filosofica nelle espressioni vitia sua quae adhuc ignorabat videt e
cum ipsi aegros se esse senserunt.
•
Perché Seneca sente il bisogno di comunicare all’amico il proprio
progresso spirituale (Cuperem itaque tecum communicare tam subitam
mutationem mei)? Cosa significa esattamente – in italiano e in latino – il
verbo comunicare? Quali estensioni di significato ha subito in ambito
cristiano?
•
Commenta alla luce della tua esperienza di vita la massima nullius boni
sine socio iucunda possessio est.
•
Perché Seneca usa un periodo ipotetico dell’irrealtà (cuperem,
coepissem, III tipo), cioè nel quale si considera che l’ipotesi non si
verifichi?
•
In quali righe del testo risulta che la saggezza è un bene sociale, da
mettere in comune con gli altri?
•
Commenta l’affermazione viva vox et convictus quam oratio proderit («la
viva voce e lo stare insieme ti gioverà più di un discorso») anche alla
luce della tua esperienza personale (nei vari ambiti della tua vita: a
scuola, con gli amici, ecc.).
•
È vero che «gli uomini credono più agli occhi che alle orecchie»?
Perché?
•
Perché è fondamentale, nella formazione del filosofo stoico Cleante,
avere verificato personalmente, nel suo maestro Zenone, la coerenza tra
il concreto modo di vivere e i precetti filosofici (formula)?
•
Che cosa pensi di chi, come si dice con colorita espressione popolare,
«predica bene e razzola male»?
•
Che cosa significa esattamente il termine latino contubernium? (cerca i
due elementi che lo compongono sul vocabolario di latino).
•
Riesci a leggere e tradurre la scritta latina, nella quale si sottolinea il
significato filosofico e morale dell’opera di Seneca?
Il carattere pratico e il valore dell’esempio. Al di là delle differenze che
caratterizzarono i vari indirizzi, c’è un aspetto comune a tutte le «scuole»
filosofiche dell’antichità, almeno a partire dall’età ellenistica. Si tratta del
carattere pratico, che identifica la filosofia con la scelta di una concreta vita
filosofica, basata sull’esercizio spirituale condotto dal filosofo in prima persona
e sulla sua scelta di vivere la filosofia in comunità. Di qui anche il grande valore
dell’amicizia.
Nelle scuole filosofiche antiche il maestro agiva attraverso l’esempio almeno
altrettanto che attraverso la parola. È noto che le vite di Diogene e di Epicuro
fornirono, molto tempo dopo la morte, un ricco soggetto di meditazione. Anche
l’opinione pubblica preferiva giudicare i filosofi in base ai loro atti piuttosto che
in base alle loro dottrine. Così, tanto all’interno quanto all’esterno della scuola,
la filosofia era, più che un’attività intellettuale, un modo di vita. La convivenza,
la disputa e il dialogo finalizzati alla ricerca della saggezza contraddistinguevano la vita filosofica.
•
Ricerca nei due passi di Seneca le espressioni e le frasi che fanno
riferimento:
– alla concretezza della testimonianza basata sull’esempio di una vita
filosofica vissuta in prima persona;
– alla priorità della pratica sulla «teoria», cioè della concreta
testimonianza di una vita filosofica sui precetti astratti;
– al valore della disputa, del dialogo, dello scambio d’esperienze
concrete.
Il carattere terapeutico. Il carattere «terapeutico» – cioè curativo dei mali
dell’anima – è comune a tutte le filosofie ellenistiche. In particolare l’aspetto
consolatorio sembra caratterizzare le filosofie che si diffusero in Grecia quando
la crisi, frutto dell’individualismo e del ripiegamento interiore, rese gli animi
inclini ad ascoltare parole di conforto, piuttosto che esortazioni al dovere. Allora
«la Polis ateniese continua ad essere il quartiere generale della Filosofia, ma
d’una filosofia che mira solo a consolare» (Rostagni). Oggi si direbbe che tutta
la filosofia ellenistica sia consolatoria in quanto forma di «pensiero debole»,
dopo le grandi scuole di Platone e Aristotele. Proprio in questo periodo si
diffusero le consolazioni, trattati che costituiscono un genere filosofico-letterario
previsto per fortificare gli animi contro i casi della vita, in particolare la morte,
mediante la somministrazione di argomenti atti a consolare e confortare.
Anche in Seneca è frequente la metafora della filosofia-medicina. Ecco come il
filosofo giustifica il fatto d’essersi, a un certo punto della sua vita, appartato per
dedicarsi alla riflessione morale e filosofica:
Non solo lasciai gli uomini, ma anche le faccende, in primo luogo le mie, per attendere
al bene dei posteri. Per essi scrivo qualcosa che possa riuscire giovevole: si tratta di
precetti salutari, simili a ricette di medicine utili, di cui ho già sperimentato l’efficacia
sulle mie piaghe, le quali, è vero, non sono del tutto guarite, ma hanno cessato di
estendersi. Indico agli altri la via giusta, che tardi ho conosciuto, e quando ero già
stanco di errare.
(Epist. VIII, 2)
•
Ricerca nella lettera VI di Seneca le espressioni e le frasi che fanno
riferimento alla dimensione terapeutica del filosofare (Ci si rallegra con
certi malati, quando sono divenuti coscienti della loro malattia …).