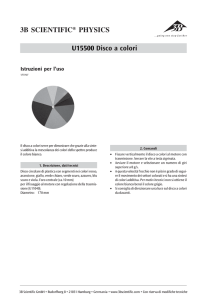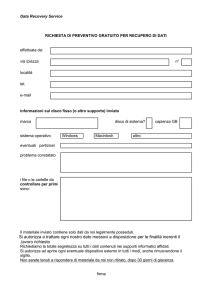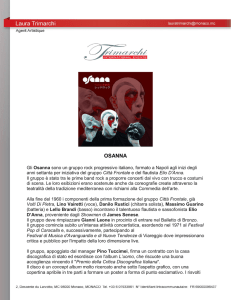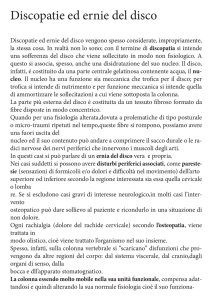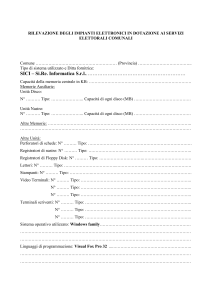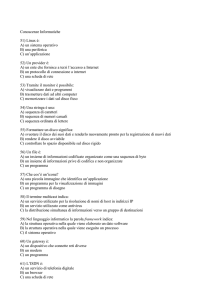digital magazine marzo 2011
N.77
Aucan
Cocteau Twins
Arcobaleni neri e orizzonti post-electro
italia improvvisa
Die Schachtel/Fratto9/Boring Machines
Hundebiss/Von Archives
Gay Beast
Planet Soap
Hercules And Love Affair
Fitzsimmons
Dirty Beaches
p. 4
Turn On
Gay Beast, Planet Soap, Fitzsimmons, Dirty Beaches
p. 10
Tune IN
Aucan, Hercules And Love Affair
sentireascoltare.com
p. 18
Drop Out
Italia improvvisa
p. 34
Recensioni
p. 88
Rearview Mirror
.
Cocteau Twins
Rubriche
p. 80
p. 82
p. 84
p. 96
p. 97
Gimme some inches
Reboot
China Files
Campi Magnetici
Classic Album
SentireAscoltare online music magazine
Registrazione Trib.BO N° 7590 del 28/10/05
Editore: Edoardo Bridda
Direttore responsabile: Antonello Comunale
Provider NGI S.p.A.
Copyright © 2009 Edoardo Bridda.
Tutti i diritti riservati.La riproduzione totale o parziale,
in qualsiasi forma, su qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo,
è proibita senza autorizzazione scritta di SentireAscoltare
Direttore: Edoardo Bridda
Direttore Responsabile: Antonello Comunale
Ufficio Stampa: Teresa Greco
Coordinamento: Gaspare Caliri
Progetto Grafico e Impaginazione: Nicolas Campagnari
Redazione: Andrea Simonetto, Antonello Comunale, Edoardo Bridda, Gabriele Marino, Gaspare Caliri, Nicolas Campagnari, Stefano Pifferi, Stefano Solventi, Teresa Greco
Staff: Marco Boscolo, Edoardo Bridda, , Luca Barachetti, Marco Braggion, Gabriele Marino, Stefano Pifferi, Stefano Solventi, Teresa Greco, Fabrizio Zampighi, Luca
Barachetti, Andrea Napoli, Diego Ballani, Mauro Crocenzi, Fabrizio Zampighi, Giulia Cavaliere, Giancarlo Turra
Copertina: Aucan (foto di Giordano Garosio)
Guida spirituale: Adriano Trauber (1966-2004)
Turn On
Dirty
Beaches
—Generazione noir
post lynchana—
Misteriosi, romantici e claustrofobici.
Sono i 50s riletti dalla lente
deformante di Alex Zhang Hungtai.
Facciamo la conoscenza del segreto
meglio custodito della scena lo-fi
d'oltreoceano.
L
e canzoni di Alex Zhang Hungtai, in arte Dirty
Beaches, stanno in quella zona del crepuscolo fra
grottesco e noir tanto cara a David Lynch. In quell'attimo prima che il sogno si trasformi in incubo, quando
la voce del crooner svampa in un riverbero assordante
e la scena assume connotati agghiaccianti. Il suo recente Badlands è un precipitato romantico di rockabilly, surf music e hot rod minimale che pare uscire da
una radiolina sintonizzata sui 50s.
E’ lui stesso a definirla "soundtrack per un film inesistente", conscio della potenzialità cinematiche del
suo progetto. "Il cinema ha sempre fatto parte della mia
vita. – racconta – Da ragazzo lavoravo in una videostore, in cui si tenevano molti film stranieri. Di notte, quando
non affittavo porno, ne guardavo tonnellate. Per tutta la
notte, tutte le notti."
Badlands è frutto di un percorso artistico condotto
in perfetta autonomia, documentato in numerose cassette incise dal vivo. Un apprendistato casalingo in cui
l’artista ha imparato a maneggiare rumori d'ambiente,
sonorità radicali e drum machine di “pesantezza” industriale. Ora sembra il figlioccio di Alan Vega intento
a distorcere stereotipi dell’America rurale. "L'album si
basa sull'esperienza del mio lungo peregrinare in macchina per le piccole città degli Stati Uniti, sulle persone
4
curiose e sulle donne che ho incontrato.”
Capelli impomatati, baffetti e sguardo sfuggente
(in una somiglianza prodigiosa col Bobby Perù/William Defoe di lynchana memoria) è facile immaginarselo guidare la sua corvette per le strade impolverate
alla periferia del sogno americano. “Quello che cerco di
creare con le mie canzoni è un personaggio basato su me
stesso, un mix di fiction e realtà, che è un modo più interessante di mettere in musica intime confessioni."
Eppure Hungtai è culturalmente apolide. Taiwanese di nascita, immigrato in Canada da bambino, ha frequentato le high school alle Hawaii e girato decine di
città prima di trovare base a Montreal. "Non posso dire
di avere un vero senso di appartenenza. Allo stesso modo
il protagonista delle mie canzoni è sempre qualcuno in
esilio o costretto ad abbandonare le proprie sicurezze per
trovarsi straniero in una nuova città."
Badlands non è ancora stato ufficialmente pubblicato che già è partita la campagna acquisti da parte
delle label. “Fino ad ora ho realizzato tutto da solo – confessa – Ma quella del lo-fi per me è una necessità, non è
una scelta estetica." Prepariamoci, dunque, a vederlo
uscire presto dall’ombra.
Diego Ballani
si con
e
m
i
i
t
t
u
azine
tal mag
il digi
in pdf
to è t
n
e
m
a
t
L’appun
orni su
i
.com rofondimenti
g
i
e
i
r
t
t
a
u
t
l
et
o
sc
a
t, app
e
s
r
i
e
t
t
n
n
o
c
e
www.osncerti, recensioni,
News, c
su
tis
a
r
g
o
t
ut
anche
t
click
n
u
i
d
ata
e a port
5
Turn On
Gay Beast
— Queerness bestiale —
Adam Bubolz
Un suono che tra tutto e niente
sceglie il tutto. La bestia raggiunge la
maturità, al freddo di Minneapolis e
sotto il faro di Beefheart.
C
on un nome così è difficile non porre la domanda. Eppure non è stato difficile distrarsi dalla questione e
puntare più sul sodo. Dopo tutto, tra i compagni di label (la Skin Graft) troviamo moniker che alzano il benchmark, come Aids Wolf e Dazzling Killmen. E soprattutto è bastato ascoltare il concerto al Covo di Bologna lo
scorso inizio febbraio e intuire, dietro qualche imprecisione al mixer, le potenzialità dei Gay Beast.
Non che i diretti interessati fossero tra gli ultimi arrivati. To Smithereens, l’LP in uscita che ha dato il la alla
tournée europea attualmente in corso, è la terza fatica in long playing della band. Il packaging del vinile – e il
libretto allegato - è di quelli che dimostrano una grande attenzione all’arte dell’illustrazione, al valore aggiunto
materico del supporto. Dentro, tra i solchi, l’ennesima avventura a tremila che vorticosamente sprigiona un mazzo di altri suoni e di riferimenti, che puntualmente abbiamo snocciolato chiedendo direttamente a Isaac Rotto,
chitarrista della band.
Alcuni di questi sono figli della potenza e dell’incisività diretta che conducono l’avventura Gay Beast fin dalla
sua nascita, a metà del 2005. Il risultato dell’amalgama sonoro, già dalle prime mosse della band, denota come i
tre componenti - Angela Gerend, Daniel Luedtke, e il citato Isaac Rotto – siano “interessati più a come gli strumenti
suonino insieme, che a come le parti appaiono scritte sul pentagramma”. L’effetto d’insieme, aggiungiamo noi, è però
fortemente legato all’estetica dello strumento utilizzato: non ci sarebbe il suono Gay Beast senza il sax e le tastiere
6
cheap and garage di Daniel e il torrenziale drumming
e gli accenni di elettronica vintage di Angela.
È divertente ed espressiva l’autodescrizione compilata da Isaac e soci, tradotta nella web del trio nell’italiese da bestiario di Google Translate: “Brandendo una
batteria di tamburi, chitarre raschiate e martellate, parole cantate, synth dal retro-futuro, sassofono, e altri dispositivi elettronici, il trio costruisce canzoni per motivi che
congiungono la complessità e orecchiabilità, uno spazio
dove l'abrasione e la 'tunefulness' abitano insieme”.
Tornare alla domanda con cui aprivamo l’articolo ci
consente di sviscerare il concept del progetto Gay Beast. “Dan decise il nome dopo aver visto un film della New
Wave giapponese dove un uomo continuava a chiamare
“bestia” una donna. La cosa lo impressionò e pensò che
Gay Beast potesse essere tanto decisivo sia nei confronti
della coscienza degli etero che del mondo queer”.
Il nome è dunque una risposta all’ansia generata
dalla passività – aggressiva come l’offesa – del Midwest nei confronti dell’omosessualità. Nei freddi di
Minneapolis, Isaac, Angela e Daniel decidono di proporre la propria “Minnesota’s premier agit-prop queer
band” e di dedicarsi a un’estetica ironica ma fortemente battagliera. Daniel e Angela erano già adusi all’attivismo di genere, nonché all’agit-prop musicale con
altre band. Dopo un breve periodo in duo, pubblicano un annuncio online per trovare una nuova voce e
una seicorde conforme al progetto che hanno in mente; Isaac risponde e il suo ingresso nell’organico (solo
come chitarrista, di fatto) sancisce l’assetto del gruppo
da sei anni a oggi.
I tre iniziano da subito a praticare il suono che più
gli interessa, una miscela esplosiva che tanto ci ha
ricordato la scena detroitiana dell’“android punk”, e
quindi quel calendario di proposte che va dai Piranhas a Human Eye. Interpellati in proposito, i tre si dimostrano incuriositi ma ignari di tali evoluzioni della
Motor City, della quale citano al massimo gli Ottanta
dell’esperienza Cybotron. I riferimenti che si sentono
di esprimere sono esplicite guide all’ascolto dei tre album pubblicati dalla bestia. I Gay Beast sono un vortice di elementi, un fiume in piena. Non si fa fatica a
cogliere come faro il primo disco degli Hella, già dalla
prima traccia di Disrobics (DNT, 2008), What You Want.
Isaac cita poi Zoo Psychology degli Ex Models come
modello riuscito di intersezione tra aggressività, cervello, ballabilità e astrazione. Gli ultimi due dischi dei
Portal come mistero e teatralità del sound.
Ma la vera passione è Captain Beefheart, ovviamente. Lui e tutte le intelligenze che ha prodotto.
Sempre in Disrobics, Mama, Wrap My Coffin In The
A.I.D.S. Quilt Cuz It's Cold In Hell sembra cantato da Arrington De Dyoniso che si fa la doccia ubriaco. Segue
i solchi di Von Vliet anche l’improvvisazione rumorista
– e cupa – simulata che fa da perno di Second Wave
(2009), album con cui i Gay Beast entrano nel roster
Skin Graft. C’è forse meno intensità strumentale fine
a se stessa ma certamente un taglio più duro, deciso, indirizzato verso le atonalità e le stecche della No
Wave, nonché sottolineato da un mood consono alla
scena citata. In alcuni momenti (Make A Map, Pressing
Hard), in Second Wave pare sentire Arto Lindsay e i
suoi DNA accompagnati dalla grandine di Kevin Shea
alla batteria.
Di certo, i Gay Beast non si fanno – e non ci fanno
– mancare la cura per il risultato finale. Dentro Second
Wave – e forse ancor più nei solchi di To Smithereens
– si sentono le giornate passate a provare e riprovare,
costruire e stravolgere, produrre opposti e poi tenerli
insieme. “A Minneapolis, se vuoi fare qualcosa di creativo, hai un sacco di tempo per realizzarlo. Freddo e buio
per nove mesi l’anno, e la perenne minaccia di veder cancellati un tuo live per una tempesta di neve”.
Tanto tempo a disposizione per raggiungere la
complessità. E un mucchio di band amiche con cui
confrontarsi quotidianamente, in città e fuori. “Gruppi
come Tips for Twat, Condominium, Mother of Fire,
Skoal Kodiak fanno cose davvero uniche. E altri amici
– Aids Wolf, Child Abuse, TWIN, Conformists - vivono
lontani ma attraversano continuamente gli States e capita un confronto diretto”. Ora che è toccato a Gay Beast
fare un lungo viaggio, e girare l’Europa, ci chiediamo, e
domandiamo anche a Isaac, quale siano i passi successiva dell’esperienza del trio. “The future is wide open, as
someone once said. Tom Verlaine?”
Gaspare Caliri
7
Turn On
Planet Soap
— Il baco della scena —
Qualcosa in Italia si sta muovendo. E
dopo aver tanto tessuto, Planet Soap
comincia finalmente a raccogliere...
8
Q
ualcosa in Italia si sta muovendo. Finalmente,
lentamente (italianamente), ma si sta muovendo. Lo dicevamo tempo fa, parlando di uno dei personaggi più interessanti e importanti di questa scena/
non-scena, Cristiano Crisci aka Digi G’Alessio. Ci sono
le community di producers (essi stessi principali fruitori delle loro creazioni, con modalità da “giro turco” e
cioè passaggi di mano in mano, di piccì in piccì, tutto
d’un fiato e a più non posso), ci sono le community più
o meno (de)localizzate (ci sono le crew, come quella
toscana di Digi, OverKnights, e ci sono le individualità
sparpagliate unite dalla rete, come gli AvantHopperz),
ci sono i dischi (quasi sempre in free download, divisi/
moltiplicati tra mille alias), ci sono le produzioni uploadate in tempo reale sulle nuvolette di Soundcloud
(vetrine sempre più interessanti e sempre meno facilmente monitorabili).
Nell’ultimo annetto, per chi segue il settore (certa electronica non-specificamente-dance con le radici
piantate nell’hip hop strumentale), c’è stata come una
accelerazione: dischi e personaggi sono emersi oltre
la cortina delle solite cerchie (Digi appunto, ma anche
Marco Acquaviva aka UXO e Ad Bourke) e progetti
importanti si sono cominciati a profilare all’orizzonte,
su modello di quanto si è già cominciato a fare all’estero con le varie “scene nazionali” (prima fra tutte, quella
russa; importante qui da noi - per una volta - un gruppo facebookiano attorno al quale si sono coagulate/si
stanno coagulando le forze in campo).
Ecco, il progetto portato avanti da Planet Soap lungo tutto il 2010 ci pare proprio uno dei primi output
importanti in tal senso, un bel biglietto da visita per la
scena tutta e non solo a livello italiano. PS sono Federico Monguzzi aka FedeDsm, classe ‘86, dalla pronvincia
di Monza, beatmaker da ormai quasi dieci anni, e Luca
De Giuli, aka Snooze (produttore “in seconda”, addetto
alle rifiniture). Li abbiamo scoperti con l’ottimo EP Silkworm (settembre 2010, parole chiave trip Nintendo,
cybertronica, grime, Mochipet, J Dilla; 7.0/10) e ora si
ripresentano con un After Silkworm che di quel mini
è la trasfigurazione e il magniloquente compimento.
Come il baco di cui al titolo, i ragazzi hanno lavorato
alacremente, spargendo produzioni, seminando remix e tessendo contatti, e ora raccolgono: un remixorama golosissimo ed enciclopedico a base di uonchi
sperticato che flirta/diventa dubsteptronica estrema,
super-effettata. E viceversa.
Il taglio dell’operazione è programmaticamente
internazionale, con un inedito firmato dal duo e tre
rmx da produttori italiani (UXO, 3 Is A Crowd, sempre da Milano, e Apes On Tapes, Bologna) e il resto a
cura di ben cinque russi (Pixelord, DZA, Damscary,
Demokracy, Moa Pillar; di loro si è occupato anche
Pitchfork), tre francesi (Harrison Blakoldman, Miqi
O., Moresounds), due olandesi (Coco Bryce e Halp),
due giappa (BD1982 e Kay Tee), un tedesco (B-Ju),
un americano (+verb). Una barzelletta molto affollata e anche molto seria. Inutile rincorrere la tracklist
(anzi no; ma lo facciamo in sede di recensione), perché
dentro ci sono tutte ma proprio tutte le sfumature del
continuum hip hop strumentale-mutazioni electro, a
dare le coordinate di una koiné internazionale che si
costruisce con i barcollamenti e la cheaptronica propri
del wonky, la secchezza e le dilatazioni sottovuoto del
dubstep (fino alle sue propaggini grime), il clap mutuato da Dilla e un’effettistica forte, praticamente noise, che a seconda della prospettiva è tanto industrial
quanto post-fidget.
E’ con progetti come questo che l’Italia può finalmente cominciare a essere riconosciuta dagli altri e
può quindi cominciare a riconoscersi sul serio. Oltre le
frammentazioni, i provincialismi, le rivalità, le invidie;
puntando sulla qualità, selezionando con attenzione,
concentrando le forze e gli sforzi su prodotti validi,
inattaccabili. Come questo. Qualcosa in Italia si sta
muovendo e noi vogliamo essere in prima fila.
Gabriele Marino
9
Tune-In
Un prisma di electro per il nuovo millennio. Black
Rainbow è una oscura, tribale, dancey e psichedelica
fusione di rock ed elettronica e fotografa gli Aucan al
proprio zenith creativo.
Aucan
C
— Arcobaleni neri e orizzonti post-electro—
Giordano Garosio
Testo: Stefano Pifferi
10
’è una componente rituale e mistica, sia nel disco
che in sede live. C’è un significato ancestrale nella
nostra musica che è qualcosa che ti permette di entrare in
contatto con un’altra dimensione.
Ce lo aspettavamo diverso Black Rainbow. Le avvisaglie ci facevano propendere per un disco nero pece,
tribale, massicciamente noisy e disturbante: DNA,
l’embrione del comeback sotto forma di mini album,
rimandava a suoni da dancehall del dopo-bomba tanto erano caliginose le atmosfere da rave post-nucleare,
mentre il teaser promozionale circolato online come
apripista dell’album metteva in scena una sorta di primitivismo tribaloide e weird, quasi si trattasse di un rituale atavico messo in scena da tre druidi incappucciati
e impazziti.
Il sophomore del trio bresciano (Giovanni Ferliga e
Francesco D’Abbraccio a synth e chitarre e Dario Dassenno alla batteria) si presenta invece come un vero e
proprio prisma multicolor di musiche elettroniche in
espansione. Vario e screziato nelle forme, eterogeneo
nei risultati, mette in scena un concentrato di elettrock
moderno, potente ed eclettico, capace di risemantizzare le elettroniche degli ultimi vent’anni in maniera
personale e coesa. Non un monolite come era lecito
attendersi, ma una struttura imponente e mobile che
condensa l’atteggiamento cerebrale e meccanico
dell’elettronica con quello muscolare e fisico d’ascendenza rock. Musica oscuramente ballabile e perversamente groovey, dal battito talmente profondo che si
fa ipnosi al limite del ritualistico. Ci piace pensare alla
nostra musica come psichedelica – confermano i tre
all’unisono –ma sempre mescolata ad attitudine più fisica, perché anche muoverti, ballare ti porta in un’altra dimensione. Ecco, dall’unione di queste cose nasce la nostra
esperienza sonora.
Di questa sorta di psichedelia post-electro (o viceversa) è evidente dimostrazione l’artwork curato da
Francesco D’Abbraccio: una esplosione di luci e colori su sfondo scuro che si fa galassia in espansione. Un
vero e proprio arcobaleno virato al nero che ha una
storia particolare. Ho lavorato all’artwork mentre eravamo in studio a registrare il disco – conferma lo stesso
autore –poiché ci piace seguire tutti gli aspetti della pro-
duzione del disco, dalla registrazione al prodotto finito.
Prima di entrare in studio avevamo in mente l’immagine
di una luce nel buio e ho costruito un prisma in plexiglass
arcobaleno, per poi illuminarlo dall’interno e fotografarlo
in uno scenario molto lugubre (il giardino di una grande
casa abbandonata). L’effetto era molto strano, ricordava
le atmosfere di “The Road”. Man mano che il disco veniva
fuori, però, ci accorgevamo che era molto più “esplosivo”
e colorato di quanto avessimo pensato e che forse l’immagine del prisma coglieva solo alcuni aspetti della musica. Ho cominciato a fotografare i fumogeni colorati di
notte, sotto la pioggia, con flash e generatore. È sembrata
da subito una immagine più adatta e spontanea.
Black Rainbow sembra prendere il sopravvento sui
suoi propri autori, configurandosi come una vera e propria esplosione di suoni e suggestioni dall’elettronica
degli ultimi venti anni tutta: passaggi ambient e atmosfere da hauntology, squarci dubstep e virate idm, cadenze da trip-hop gotico e witch-house ectoplasmica
si alternano e convivono in un unico percorso formativo per electro-addicted. Ormai quasi tutta la musica
interessante ha a che fare con l’elettronica, esordiscono
i tre, noi siamo cresciuti con elettronica ed è normale che
si senta. Personalmente – prosegue Giovanni – uno degli
eventi che mi hanno segnato come musicista è stato un
live di Aphex Twin: esperienza piuttosto intensa, che non
ricordo mi sia mai successa con un gruppo rock. Considera però che ascoltiamo poca musica, abbiamo ascoltato
sempre meno musica ultimamente perché siamo presi col
concetto nostro e non ci interessa tanto riuscire a rientrare in un genere, essere incasellati.
C’è una rivendicazione forte nelle musiche degli
Aucan. Scegliere la varietà formale ancorandosi a una
precisa filosofia. Abbiamo deciso di NON diventare un
gruppo di genere: né math, né rock, né electro. Anche
da questo nasce il concetto dell’arcobaleno: cercare di
inserire, di mettere in gioco più elementi possibili e far sì
che dall’unione di tutti questi elementi anche eterogenei
uscisse qualcosa di nuovo.
Le parole di Francesco confermano l’assunto: Il disco
è il tentativo di far sì che quello che era Black Rainbow e gli
Aucan al momento della registrazione del disco non fosse
tanto legato ad un determinato tipo di musica, ma a qual11
cosa che emergeva a prescindere dal tipo di musica. Una
filosofia legata però anche a elementi formali che renda
riconoscibile quello che stiamo facendo a prescindere se
stiamo facendo un pezzo ambient o se stiamo facendo un
pezzo con la cassa dubstep o un pezzo strumentale.
L’imprinting comune, sia esso filtro, matrice o semplice atmosfera, è evidente in tutti i brani: segna quel prisma iridescente di influenze e rimandi e fa del terzetto
bresciano una vera mosca bianca in una scena elettronica italiana povera o legata a schemi passati (Il dubstep
è l’unica ondata di freschezza degli ultimi anni, ma in Italia
siamo ancora ancorati alla house). L’estetica di riferimento possiede una matrice dubstep, oscura e esoterica;
l’orizzonte oltre il quale si guarda è quello made in England, vera mecca per l’electro e modello ispirativo per
molti che si cimentano a trafficare con beats e ritmi. Eppure i tre rivendicano la natura “di gruppo” del progetto
Aucan: Ovvio, c’è la passione per il fenomeno del dubstep,
uscito fuori in questi ultimi anni, ma non abbiamo deciso
di suonare come un progetto dubstep. Non abbiamo fatto
un disco dubstep perché noi siamo un gruppo, un gruppo
che suona e non una produzione elettronica, anche se il disco è fatto con le modalità delle produzioni elettroniche (il
mastering è opera del guru del dubstep Matt Colton,
nda). Considera Black Rainbow come un ibrido, perché è
un disco electro ma frutto di una band. E di una band che
funziona dal vivo, perché è la dimensione live che ci ha fatto crescere, che ci ha dato un seguito.
C’è un senso del rock potente che vibra sotto la
coltre elettronica già evidente nei solchi e nella cover
dell’omonimo, Aucan, in quei vinili spezzati che frantumavano barriere e confini. Abbiamo iniziato a suonare a inizio 2000 io (Giovanni Ferliga, nda)e Dario per
fare math-rock strumentale, alla Don Caballero e tutta
quell’ondata lì. Poi l’evoluzione è venuta naturale: ho
comprato il primo synth, abbiamo cominciato a fare cose
più elettroniche e quando anche Francesco ha preso un
synth abbiamo fatto il primo degli Aucan. Che è già qualcosa di altro rispetto a ciò che facevamo in precedenza. È
un ibrido, influenzato dai Battles ma pur sempre con cose
nostre. La maturazione avviene con il citato ep DNA,
in cui il suono vira verso l’electro più drogata e oscura,
l’approccio rock si stravolge, l’orizzonte generale si incupisce. Una cattedrale di suoni scurissimi e synthetici
come un party post-mortem. DNA è l’embrione di Black
Rainbow. I due dischi sono quasi incollati l’uno all’altro
tanto che nella versione in doppio vinile in uscita per Tannen c’è un pezzo dell’ep riregistrato e rivisto (l’uscita europea sarà targata AfricanTape, quella giapponese per
Stiffslack, nda).
Gli Aucan di Black Rainbow mantengono molto di
quelle origini rock, seppur trasfigurate e assorbite nel
particolare insieme sonoro dell’album: Restano sicuramente certe atmosfere, un approccio materico, la ritualità, che la musica sia esperienza psichedelica…poi il fatto
che dal vivo pestiamo di brutto. A testimoniare l’importanza della dimensione live per i bresciani ci sono i
cinque tour esteri, la partecipazione a festival europei
come l’Eurosonic olandese d’inizio anno e un seguito
crescente che supera i confini italiani. In quella sede
emerge la carica rock: la trascendenza trance-oriented
sembra impossessarsi dei tre druidi incappucciati e il
dancehall si trasforma in un sabba post-industriale. La
sezione ritmica è il punto di snodo, un panzer cadenzato e mobile. Fondamentale è l’apporto della batteria di
Dario, un vero e proprio metronomo dall’approccio fisico e digitale: Il drum-kit si è evoluto anch’esso col nostro
suono. Ora è un ibrido tra batteria acustica e elettronica
in cui ho eliminato un tom sostituendolo con dei pad elettronici aggiunti da suonare in contemporanea col rullante. Questo per sommare due suoni in tempo reale e creare
un ibrido ancora più profondo. Anche i pezzi acustici saranno triggerati per arrivare ad un suono più stratificato
e pieno.La potenza di fuoco che i tre sprigionano live è
ben catturata su disco dal lavoro dietro la consolle di
12
Giovanni Ferliga. Un lavoro professionale e maniacale,
attento ai dettagli che si stratificano nelle complesse strutture dei brani. Il disco ha avuto una gestazione
lunga: abbiamo registrato tre volte in ambienti e ambiti
completamente diversi: la nostra sala prove qui a Brescia,
poi in montagna in un ritiro solitario in un paesino di 70
abitanti sulle Alpi, per registrarlo una seconda volta, infine in studio in Francia per la versione definitiva. Il disco
si è manifestato da solo, si è imposto su di noi per certi
versi. Ci siamo ritrovati che una volta finito non era come
l’avevamo concepito un anno fa, nemmeno come l’idea
che avevamo del disco stesso. Una cosa completamente
nuova e spiazzante anche per noi.
Ibrido di carne e metallo, analogico e digitale, rock
ed elettronica, Aucan è il Tetsuo del terzo millennio, The
shape of electro to come, parafrasando Coleman e Refused. Una catarsi tra un rock che-non-è-più-rock e quelle
elettroniche che sono il vero liquido amniotico di una
manciata di giovani band nostrane. Aucan, Everybody Tesla, Gr3ta, Fauve! Gegen A Rhino tanto per fare
nomi, ognuno con la propria sensibilità e peculiarità si
muovono senza più confini tra corde e pulsanti, distorsori e manopole. Annientano la dicotomia insuperabile
del secolo scorso e aprono nuovi stimolanti orizzonti, illuminati da un arcobaleno nero. Quello degli Aucan.
13
Tune-In
Hercules And
Love Affair
Andrew Butler ci parla di Blue Songs, il sophomore album
della sua creatura post-disco Hercules And Love Affair
— Hercules, You Were Born At Night—
Testo: Marco Braggion
14
L’album che spinniamo da un paio di settimane ininterrottamente sui nostri lettori CD e che probabilmente
resterà ai piani alti nella top 2011, è una riconferma di
quanto avevamo già capito ascoltando l’esordio omonimo del gruppo/progetto di Andrew Butler: il ragazzo
rievoca l’eredità disco newyorchese e se ne esce con
un riassunto di quello che è stata la cultura dance degli
ultimi trent’anni, proponendo una nuova strada per il
suono da dancefloor. Oltre a ciò, Blue Songs è anche
una introspezione dell’anima, canzoni che scandagliano il sentimento di chi ha marchiato nel cuore il motto
‘Last night a DJ saved my life’ e seppur abbia passato
l’età del partying selvaggio, sa cosa vuol dire credere
nei laser, nelle luci al neon e nell’eredità dancefloor.
Dopo aver cercato Andy invano, tra segreterie telefoniche che scattavano, numeri sbagliati e scazzi con il
fuso orario, ci ha richiamato lui. Già da qui abbiamo capito che non siamo in presenza di un poseur, anzi ci ha
colpito nella sua onestà intellettuale e artistica, nella
sua semplicità di chi ama parlare di musica, quasi come
se avessimo chiamato un amico che non sentivamo da
tempo. Questa dimensione casalinga e ‘laid-back’ nasce forse anche dal suo recente trasloco da New York a
Denver. Dai fasti della big town alla riflessione più accorata e personale che motiva lo scarto intimista per
rinforzare uno stile oggi pienamente maturo. Sentiamo cosa ci ha detto.
Appena abbiamo sentito l’album abbiamo visto che
non c’è Anthony (il cantante di Anthony & The Johnsons, ndSA) nei featuring. Perché non l’hai chiamato anche in questa occasione?
Già dal primo disco sapevo che Anthony non sarebbe
stato nei successivi. Oltre a lavorare con me ha collaborato con Rufus Wainwright, Naomi, Cocorosie, Lou
Reed, Björk e altri. C’è stato un tempo - appunto quando abbiamo registrato quelle due canzoni nel primo
disco - in cui sapevamo che andava bene lavorare insieme; ma prima o poi sarebbe stato giusto tornare alle
nostre carriere soliste, lasciando da parte i featuring. Ed
è quello che abbiamo fatto.
Recensendo questo disco, ho scritto che è un riassunto di culture musicali differenti, come la disco,
Jimmy Somerville, il sound garage di New York, gli
anni Ottanta, Arthur Russell e altre cose. Sei d’accordo?
Penso che tutti questi riferimenti siano più calzanti per
il primo disco, che è stato un hommage a molti produttori disco e dance. In quest’ultimo disco penso che
ci siano ancora influenze di Arthur Russell. Se vuoi ci
puoi sentire anche qualcosa di Brian Eno, qualche influsso techno o dei classici di Chicago. In generale questo disco è più difficile da collegare a riferimenti del
passato rispetto all’esordio.
Mi stai dicendo che hai cercato di costruire una cosa
più tua? Con uno stile personale?
Sì, ho cercato di capire meglio la mia vena compositiva. Volevo capire il perché ho deciso di scrivere proprio
questa musica. Perchè ho deciso le note che ho scritto? Perché vogliono dire qualcosa di speciale per me?
e qualcosa di diverso per qualcun’altro? Mi sono messo
al piano, ho suonato un accordo e ho pensato a cosa
stavo suonando, ho cambiato l’accordo. Così ho tentato di catturare la mia voce.
All’inizio del disco c’è un verso che mi piace molto:
“Elegance / You were born at night”. Cos’è l’eleganza
per te?
L’eleganza per me... [ci pensa un po’, ndSA] è una domanda difficile!
Penso che sia importante questa domanda, dato
che il disco mi sembra molto elegante...
Sì, era proprio una delle mie intenzioni quando l’ho
scritto; quella canzone l’ho scritta per Chanel. Me l’ha
15
commissionata proprio la casa di moda. Quando ho iniziato a scriverla, mi sono messo a pensare: di cosa dovrebbe parlare la canzone? Ho deciso che la cosa più
importante per me era di guardare all’inizio di Chanel,
all’esordio, alla donna che iniziato tutto e che ha definito
tutti i cento anni successivi di fashion. In un certo senso
ho dedicato la canzone a lei. Il primo verso si riferisce
proprio a Coco, dato che era una creatura della notte.
L’eleganza per me è riassumibile in tre parole: modestia,
sorpresa ed emozione.
Perché hai scelto di intitolare il disco così? Ti riferivi
anche al blues o ad altri tipi di blu?
Mi piace questa domanda, perché di solito mi chiedono
se il blu del titolo si riferisce alla tristezza o alla malinconia o bla bla bla... e io ho diverse risposte: la prima risposta - molto ovvia - è che nell’album c’è una canzone che
si chiama Blue Song e che ho scritto tante canzoni che
usano la parola blu; è una risposta un po’ stupida, ma è
vero che uso il blu molto spesso. Quella canzone è in un
certo modo il centro del disco e volevo sottolinearla.
In generale per la poesia e per i testi delle canzoni, l’uso
dei colori agli occhi di chi legge (o ascolta) è molto provocante. I colori evocano immagini differenti a persone
differenti, penso sia utile incorporare i colori nei testi:
per qualcuno il mio disco sarà triste, per qualcun’altro
sarà un album calmo e pacifico, qualcun’altro può pensare che sia profondo, come l’oceano, o che parli della
notte. Ho usato quella parola per provocare la gente.
In più i colori sono stati già utilizzati nella tradizione
musicale: pensa all’album Blue di Joni Mitchell o al
Brian Eno di Another Green World. Per tornare alla tua
domanda. Nel blues americano le canzoni parlano di
lotta, lamenti, cuori spezzati. Quando ascolti i dischi di
Robert Johnson o Bessie Smith si sente che questi artisti
parlavano di quei sentimenti... non è detto che la gente
che ascolta il mio disco senta solo quelle cose però.
Hai lavorato con molta gente a questo disco (Kele
Okereke dei Bloc Party e altri). C’è stato qualcuno
che ti ha colpito di più?
Con ogni cantante che ha partecipato al disco la collaborazione è stata diversa. Per esempio Anthony in
studio è completamente diverso da Kele, Kim Ann o
Shaun. Bisogna adattarsi al loro modo di lavorare. Devi
aggiustare il tuo ego, e devi cercare di risolvere delle
situazioni del tipo: “Ok, questa è la mia idea e forse non è
quella migliore”. La cosa più importante è che esca una
buona canzone, quindi in molti casi devi cambiare le
cose che hai in testa. Le collaborazioni devono essere
aperte e comunicative, devono manifestare sentimenti
positivi e che portino a fare la musica più bella possibile. Penso che Kele sia stato molto professionale nel
16
lavoro che ha fatto anche se è un po’ timido.
Ho letto che hai iniziato a stampare del materiale su
un’etichetta tutta tua, la Mr. Intl. Cosa stai preparando?
Abbiamo già 3 uscite. E tre programmate nelle prossime settimane. Sto tentando di fare qualcosa old-school
che si differenzi dalle etichette che ci sono in giro, che
pubblicano dischi di house troppo veloci (gli artisti che
per ora militano nella label sono lo stesso Butler e Kim
Ann Foxman con il 12’’ Creature/What You Need, ascoltabile in streaming su Soundcloud).
Altri progetti per il futuro? Sarete in Italia? Eccome!
Passeremo molto tempo in Italia nel 2011, quindi veniteci a vedere (la prima data confermata è al Tenax di
Firenze il prossimo 24 febbraio). Per quanto riguarda i
progetti, sono molto impegnato con la label e curo anche le produzioni di Kim Ann. La settimana scorsa, per
la prima volta in vita mia, ho composto le musiche per
un film spagnolo. Mi piacerebbe andare avanti a comporre musiche per film, entrare nel mondo della musica
classica contemporanea.
Come si chiama il film?
Abraza Mis Recuerdos del regista spagnolo Horacio Alcalá (in realtà è un corto di 12 minuti, ndSA). Narra la
storia di un bambino che perde la nonna. Mi è piaciuto
molto.
17
italia improvvisa
—il suono, l’arte, il diy nell’era della infinita riproducibilità tecnica—
Drop Out
Più che un viaggio in senso
stretto, una mappatura
effettuata su quattro realtà
nodali dell'impro italiano. Boring
Machines, Fratto9, Hundebiss e
Von Archives.
Testo: Stefano Pifferi
e Gaspare Caliri
18
Un CD o un LP diventano parte del corredo personale, del dintorno
oggettuale che definisce il nostro essere nel presente, e ancor più il
nostro passato.
(Bruno Stucchi, Die Schachtel)
L’occasione per dare forma compiuta a una idea che da tempo
si covava qui a SA ce la offre l’uscita del box Musica Improvvisa
edito dalla milanese Die Schachtel, vero e proprio monumento
più che semplice manifesto di una scena che definiremmo senza
volontà di completezza “impro”. L’incompleta rassegna fotografa
in dieci avventurosi scatti un intero brulicare di band e progetti
più o meno radicali, fornendoci la sponda ideale per allungare lo
sguardo non sui protagonisti, quanto sui marchi che ne stanno
suggellando il successo critico.
Nell’era del 2.0, del download selvaggio e degli streaming integrali, degli apparecchi con il prefisso “i” e dei cellulari tuttofare,
la label DIY è ancora una realtà centrale nel panorama indipendente e lo è ancor di più quando la ricerca sonora s’interseca con
quella artistica tout court, dove alla mancanza cronica di denaro
e alle ore di sonno perso sopperiscono creatività e manualità. Fattori che generano release spettacolari, anticonformiste e al limite
del masochistico, fatte di edizioni curate in ogni dettaglio grafico,
19
fisico, visivo e tattile. Immagini coordinate del contemporaneo sottobosco
che non rifiuta il web, anzi lo considera un’estensione del banchetto della distro poiché centrale e non incompatibile con l’idea dell’oggetto disco
come artygianato concreto e durevole nella quotidianità della musica registrata.
Abbiamo individuato tra le tante realtà una doppia coppia di label: la
prima viaggia sull’asse Boring Machines / Fratto9 Under The Sky, la seconda prende in esame un paio di giovani realtà perfettamente sposate
all’arte come la Von Archives di Nico Vascellari e Carlos Casas e la Hundebiss di Barbara Bertucci e Simone Trabucchi. Le abbiamo scelte perché
muovendosi tra art-rock e musica sperimentale, elettroacustica e industrial, wave e impro-jazz, i loro cataloghi risultano tra i più avventurosi ed
eccitanti in circolazione. Inoltre, con le loro curatissime e spesso limitate
edizioni – siano esse cd, vinili, tapes o dvd – cortocircuitano alla perfezione
l’attenzione al connubio tra arte e suono tipico di questo “DIY professionale”, facendosi carico dell’intero ciclo produttivo: dalla scelta di materiali e
taglio grafico, all’assemblaggio spesso manuale dell’artwork, fino a distribuzione e vendita.
Quattro mondi accomunati da grande credibilità e riconoscibilità. Ma
anche da una sostenibilità di esercizio, basata su supporti, accuratezza e
qualità. Come primo passo, però, nel connubio tra ricerca sonora sperimentale e raffinatezza grafica, non potevamo non sentire la Die Schachtel di
Bruno Stucchi e Fabio Carboni, maestra riconosciuta le cui edizioni valgono
tanto sul piano musicale (i recuperi dell’elettronica storica italiana, il nuovo
rock d’avanguardia, ecc.) quanto su quello artistico e grafico. In un suo romanzo William Gibson descrive un futuro nel quale l’arte esiste
solo in forma digitale e virtuale. In questo futuro le opere più ricercate e quotate sono delicatissimi e fisici “assemblages” di frammenti poveri quali carte,
legni, piccoli trucioli di metallo, materiali vegetali, schegge di plastica e vetro.
La rimozione della materialità va contro un bisogno primario dell’uomo di
20
esperire il mondo in modo (pluri)sensoriale e “caldo”. Inoltre la materia fisica
“contiene” la durata nel tempo e, di conseguenza, un valore di permanenza
“individuale” superiore a qualche stringa di bit. In parole nostre, un CD o un LP
diventano parte del corredo personale, del dintorno oggettuale che definisce
il nostro essere nel presente, e ancor più il nostro passato. Vale per la musica
da quando esiste il supporto registrato. Il nostro mondo musicale è definito
anche da quegli oggetti, per quanto ingombranti e limitati nella loro capacità
contenitiva e riproduttiva.
Die Schachtel ci sottolinea quello che è già una netta chiave di lettura
di questo articolo: i supporti sono centrali e hanno un loro prezzo. Non è
una scelta che paga, ma non siamo qui per i soldi, come diceva Zappa, prosegue Bruno. Da un punto di vista di ricerca di una “voce” visiva ed espressiva che denoti Die Schachtel, paga molto di più. È quello che stiamo facendo
con le nostre scelte grafiche, di packaging e di stampa: tentare di costruire una
dialettica forte tra contenitore e materiale, tra editore ed artista, tra oggetto e
fruizione del fatto musicale o sonoro che possa rendere anche più accessibili
informazioni e materiali di contesto, e perché no, si ponga anche come linea
di resistenza ad una smaterializzazione che spesso è anche svuotamento di
contenuto.
Dello stesso avviso Luca Vinciguerra, responsabile unico di A Dear Girl
Called Wendy, che in tandem con l’altro Die Schachtel Fabio Carboni è
un’altra figura chiave che era giusto sentire in proposito.
L’etica del fai-da-te è principalmente passione, e se si ha passione, il fottersene di quello che gli altri pensano diventa del tutto naturale. Gestire un’etichetta diy è tentare di usare la musica come mezzo informativo, di portare
avanti un’idea, di essere congruenti in primis con il proprio codice etico. Un
impegno totale e una forza di volontà invidiabili nel creare reti di rapporti
interpersonali che formano una scena. Senza il diy e la sua etica ci sarebbero
moltissimi generi che sarebbero già morti. Senza diy, tutte le musiche non popolari sarebbero solo un ricordo.
La A Dear Girl Called Wendy ruba il nome a South Park (Amavo quando
Stan vomitava solo nel vedere Wendy. Pensare che una persona sia il tuo ipecac mi piacque molto) e cerca di “approfondire il rumore” con un catalogo
tra i più efferati del lotto. Luca segna un altro punto a favore delle label italiane, quando individua nella eterogeneità la caratteristica del movimento:
Etichette come Hundebiss, Presto?!, Von Archives, Boring Machines et similia
portano avanti un discorso musicale con passione e gusto. Si cerca la qualità e
non la quantità. E se si controlla attentamente, a differenza di altri paesi in Italia non esistono etichette fotocopia. Ognuna porta avanti un’idea personale
sia musicale che visiva, e questo sicuramente vuol dire carattere e personalità.
Infatti, accanto a queste label, se ne muovono moltissime altre, molte
delle quali affrontate da SA in speciali, approfondimenti, recensioni negli
ultimi anni: dalla negazione del medium (i digipack in “odorama tossico”
e no-info) della Niente dei St. Ride Maurizio Gusmerini e Edo Grandi alle
eleganti grafiche che la Presto?! di Lorenzo Senni utilizza per le sue indagini in campo noise-elettroacustico; dalle evoluzioni impro-jazz in edizioni
viniliche d’alto pregio della Ultramarine alle asperità da sottobosco noise
via tapes e vinili one-sided della 8mm. Dalle eleganti edizioni in cd-r d’area
post-psych primitivista della Sturmundrugs di Donato Epiro ai cartonati
digipack della storica A Silent Place e giù fino alle ricercatissime edizioni
post-Grey Area di Silentes o Radical Matters, o ai vinili spesso etched e
21
one-sided di Xhol e Holidays per non parlare dei cataloghi delle storiche
(anche queste da noi già indagate) Wallace e Setola Di Maiale e delle tantissime che rimarranno fuori da questo incompleto elenco.
I ntervista doppia B oring M achines /Fratto 9
U nder The S ky
Boring Machines e Fratto9 Under The Sky. Due label, due uomini, una
garanzia. La prima, nata dalla passione del deus-ex-machina Onga (un passato come collaboratore di Post-it Rock?, organizzatore di concerti, agitatore della prima ora e molto altro) si dichiara in difesa della musica noiosa. A
scorrere il catalogo però drone, Mamuthones, Expo ’70, folk-noir, elettroacustica, Father Murphy, noise, kosmische, Claudio Rocchetti, sembrano
dargli decisamente torto. Non musica leggera, ma sicuramente nemmeno
noiosa. Così come solo artwork non si possono definire le edizioni cartonate, piacevoli all’occhio e al tatto prima ancora che all’udito.
La seconda muove “dalla passione per i perdenti e per quelle forme d’arte minori” che porta Gianmaria Aprile a suonare (Ultraviolet Makes Me
Sick), scrivere (la webzine Post-it Rock?), registrare (la serie Private Works)
e infine gestire, in omaggio allo zio prematuramente scomparso (Al Aprile), la Fratto9 Under The Sky. Catalogo altrettanto valido e eterogeneo, con
una lieve predominanza per l’avantgarde e le forme più aperte di jazz: dai
seminali Caboto ai napoletani Illàchime Quartet e A Spirale fino al noise
kosmische (Detrimental Dialogue di Marutti/Balbo), dronico (Luminance Ratio) o nero pece (Aspec(t)). Produzioni ottime dal punto di vista della
ricerca musicale e curatissime sotto quello grafico-estetico per entrambe,
con punti di contatto in catalogo (Luminance Ratio, Marutti/Balbo) e una
simile concezione dell’impegnarsi in prima persona. Abbiamo lasciato loro
la parola per saperne di più sulla loro storia e sul loro pensiero sull’Italia
improvvisa.
Da realtà ormai consolidate vorrei la vostra opinione sulla scena impro e/o elettroacustica. Vi sentite rappresentati? Manca qualcosa? C’è
anche troppo rispetto allo scarso pubblico?
ONGA Boring Machines ha le sue radici in un mondo molto eterogeneo,
che va dalla marziale techno di Detroit alla musica classica, passando per i
13th Floor Elevators, Tangerine Dream, Fela Kuti e l’Art Ensemble of Chicago, perciò è difficile per me essere rappresentato da qualcosa di definito.
Quello che ascolto ora o che mi appassiona, è spesso figlio di movimenti artistici che datano ’60/’70/’80 e che sono state rimasticate, rielaborate, ricodificate nel tempo. La scena elettroacustica è vastissima e la sua emersione
è dovuta, come per altri fenomeni underground, alla grande democratizzazione che la rete ha portato da metà anni novanta. La musica disponibile
così come i gruppi che suonano non sono mai troppi. Molti sono mediocri,
d’accordo, ma i mediocri non vanno molto lontano e se si ha pazienza chi
ha delle qualità emerge, poco magari, ma emerge. Potrei citare i “miei” Father Murphy gruppo che negli ultimi sei anni ha lavorato sodo sul proprio
suono, divenendo un gruppo raro, per non dire unico. Ancora adesso l’investimento in termini artistici e di energie da parte del gruppo è tanto, ma
qualche piccola soddisfazione, dopo tre tour negli States e non si sa più
quanti in Italia ed Europa, comincia ad arrivare.
F9 È bello essere considerati una realtà consolidata. Il problema è che
forse lo siamo per quei 100 scrutatori dell’underground, ma per il resto ri22
23
maniamo delle piccole etichette con tanta voglia di portare avanti un progetto nel tempo. Comunque sia, penso che parlare di corsi e ricorsi storici
sia sempre funzionale anche in queste occasioni, nel senso che ciclicamente
passano i generi e gli approcci musicali. La facilità con cui oggigiorno tutti
noi possiamo mettere insieme un computer e un po’ di suoni ha aiutato
molte persone a sviluppare nuovi percorsi, ma ha anche creato una quantità di materiale inutile che sta saturando il piccolo circuito, e purtroppo ad
emergere non sono sempre le realtà e i progetti più interessanti.
L’improvvisazione è una brutta bestia, con cui ci si confronta in maniera
spesso troppo superficiale, ingannati dal fatto che essendo improvvisazione non ci sia bisogno di preparazione e di studio, ma per fortuna è tutto il
contrario. In generale penso che in molte occasioni manchi l’autocritica da
parte degli stessi musicisti nel saper giudicare il proprio lavoro e capire se è
necessario o meno cercare di pubblicarlo; inoltre penso manchino spesso
anche la cultura e gli ascolti da parte dei musicisti e anche dei giornalisti
pronti a “giudicare” lavori senza conoscerne gli antefatti o il percorso sonoro affrontato.
Siete label quasi homebased, con uscite centellinate ma curatissime
dal punto di vista grafico…c’è una idea di base dietro la scelta estetica?
ONGA L’idea di base dietro all’estetica Boring Machines si basa sul mio amo24
re per i prodotti fatti bene tout-cour. Se un disco è bello musicalmente, e
si presume che io faccia uscire dischi che reputo essere belli in tal senso, si
merita di essere bello anche esteticamente. Odio i jewel cases, mi piacciono molto la carta e gli inchiostri e quindi da quando sono partito mi sono
fatto creare delle fustelle di stampa per le mie copertine che fossero adatte
all’utilizzo di carte particolari o alla stampa degli artwork più bizzarri.
La scelta degli artwork in sé spetta alle band, voglio che ogni artista di
cui faccio uscire il disco si senta rappresentato in tutto e per tutto dal suo
disco. Ho avuto la fortuna negli anni di collaborare con un grafico dal gusto eccezionale (Be Invisible Now!) e di avere artisti che fossero anche dei
gran fotografi (la copertina di Piallassa (Red Desert Chronicles) di Punck,
ad opera dello stesso Zanni). Io ci ho messo del mio e mi ritengo sufficientemente esperto da tirar fuori il meglio dalle idee di artwork che gli artisti mi propongono. Compro ancora molti dischi e ammetto che il tipo di
packaging usato è ancora una forte discriminante per me, al punto di aver
anche preso dischi mediocri, con delle copertine eccezionali.
F9 Basti pensare che il CD è un supporto che ormai non ha più valore
e probabilmente continuerà a perderlo con il passare del tempo, quindi
oltre alla musica c’è la necessità di creare un oggetto completo, in tutte
le sue sfaccettature. Di conseguenza si sceglie il cartonato/digipack anziché il jewelcase, si creano inserti e altri dettagli che arricchiscono e che
completano tutto il lavoro. Per quanto riguarda invece i contenuti musicali,
per mia/nostra fortuna abbiamo sempre lavorato con musicisti che hanno
dedicato molta attenzione anche al suono, al mixaggio e al mastering, riuscendo a completare il lavoro nel migliore dei modi. Lavori come quello
dei Luminance Ratio (dove ho curato personalmente i contenuti musicali
e la grafica), Aspec(t), Balbo-Marutti sono sicuramente prodotti studiati a
tavolino e curati nei minimi dettagli sonori cercando di ottenere il meglio
dalle nostre possibilità e competenze.
Cosa significa condividere dischi per voi? Dà coesione ad una ipotetica scena o è legato soltanto a questioni pratiche ed economiche?
ONGA Fare dischi assieme, in coproduzione, è una tendenza in aumento
in molti settori negli ultimi anni, retaggio del punk e dell’hardcore adesso
utilizzata da molti. Inutile nascondersi dietro un dito, le motivazioni economiche sono forti, dividere le spese per la produzione di un disco, in un
periodo nel quale dischi se ne vendono comunque pochi, può essere vitale. Certo è che le collaborazioni avvengono sempre tra spiriti affini, io e
Gianmaria ci conosciamo da un decennio e abbiamo condiviso molte cose,
la sua webzine, i concerti del suo gruppo, il Tagofest al quale lavoriamo insieme da anni. Quando poi si parla di artisti come Andrea Marutti e Fausto
Balbo, o gli stessi Luminance Ratio, l’acquolina alla bocca viene immediatamente. Sono dischi che avrei fatto uscire anche da solo, la condivisione
nasce anche dal desiderio di tutti di “spingere” un buon prodotto.
La parola scena è sempre schifata in qualche modo dalle persone, trovo
invece che delle scene in italia ci siano per davvero, e sono quelle non celebrate pubblicamente. Il giro elettronico/noise italiano, che da Marutti a
Punck, da Pietro Riparbelli ai Logoplasm passa attraverso Luca Sigurtà (ora
nei Luminance Ratio), il giro di Hundebiss a Milano, Codalunga a Vittorio
Veneto piuttosto che il giro romano, ha una serie di contatti, di permeazioni ed incroci che sfociano in collaborazioni e mutuo aiuto che definiscono i
confini di una scena. L’unico peccato è che in molti casi finora il giornalismo
25
italiano si è limitato ad importare la “scena” di Brooklyn, Providence o Portland senza mai gettare un occhio attendo a quanto succede nello stivale.
F9 Sicuramente vuol dire che abbiamo in parte la stessa direzione artistica e in parte, come dici tu, è anche uno stimolo per condividere assieme
una piccolissima fetta del circuito. La coproduzione aumenta anche le possibilità di distribuzione del supporto, si hanno più contatti da condividere
e giornalisti a cui far arrivare il prodotto. Per fortuna abbiamo dei canali di
promozione un po’ diversi, e c’è sempre stato un ottimo rapporto collaborativo. Naturalmente l’aiuto economico è una forte componente quando si
tratta poi di fare i conti della stampa, a maggior ragione quando il packaging diventa più elaborato e quindi dispendioso.
Operate in ambiti diversi, ma pur sempre in musiche di confine. La nicchia da coda lunga profetizzata da Anderson funziona?
ONGA Ho guardato quel grafico decine di volte, sono quasi arrivato a convincermi che ci fosse del vero in quelle teorizzazioni, ma pur sempre tali rimangono per quanto mi riguarda. Ci sono delle manifestazioni di fenomeni riconducibili alla teoria di Coda Lunga che possono essere messe in luce:
alcuni artisti, distillando sui più svariati formati per le più svariate etichette
nei più svariati paesi, hanno raccolto una microscopica promozione locale
da ognuna di queste uscite, assurgendo allo status di artisti rispettati ovunque in poco tempo. Naturalmente, ancora, è la qualità che conta. Justin
Wright (Expo ’70) ha fatto uscire cd, cd-r, cassette e vinili in mezzo mondo,
ed è ormai artista riconosciuto di livello internazionale. Ma lui è molto, molto bravo. Molti altri hanno passato la vita a disseminare brani qui e là, ma
brani mediocri che non li hanno portati da nessuna parte.
F9 A parte il seno prosperoso (e purtroppo fintissimo) della fanciulla
che di cognome fa Anderson, penso che la coda lunga di Chris Anderson
sia troppo lunga per riuscire a coprirne anche solo una minima parte con
etichette del calibro della Fratto9. In effetti il mercato indipendente è davvero fiorente, e molto spesso sforna prodotti di ottima qualità, ma forse è
davvero troppo prolifico, e la domanda non è ancora così forte da giustificarne la produzione a volte esasperante di tutte le etichette indipendenti.
Penso ci sia di base un grave deficit da parte della popolazione nel riuscire
a “guardare” oltre alle grandi produzioni e ad interessarsi a quelle di nicchia.
Sicuramente i media non aiutano nell’atto di promuovere tutto questo micromondo sommerso e quindi bisogna perseverare e continuare a lavorare
aumentando i canali di promozione/distribuzione/contatti. Quella parte di
coda che riusciamo a coprire con i nostri mezzi è ancora troppo piccola per
poterla applicare al modello di Anderson, che nella sua concettualità è vincente. Forse etichette come la Wallace o Afe ce la stanno facendo, perché
lavorano su grandi quantitativi di materiale pubblicato e quindi aumentano di più lo spettro dei possibili acquirenti, avendo più varietà di scelta. In
generale bisogna sempre lavorare molto perché di dischi purtroppo, se ne
vendono ancora troppo pochi.
Le vostre label agiscono molto sul territorio italiano, sia come catalogo che con altre iniziative. Cosa ne pensate della territorialità?
ONGA Ah! la territorialità! Non era pianificato, ma è successo che nella maggioranza delle mie uscite mi trovassi a lavorare con artisti italiani. Questo è
dovuto al fatto che riconosco a molti di loro uno spessore tale da non avere
nulla da invidiare a questo o quell’altro progetto straniero di genere. In più,
in casi (disperati) come quelli delle etichette underground credo che il fat26
tore umano conti molto. Voglio potermi incontrare e parlare con gli artisti
con cui lavoro, certo ci sono le mail e i social network, ma davanti a una
birra si finge peggio. Oltre ad un discorso ristretto a BM, allargherei la questione ad un mio tentativo di entrare in contatto con quante più persone
interessanti che provengono dalle realtà italiane, siano essi musicisti, grafici, videomakers o altro. Una rete di contatti spalmata sul territorio tra persone che hanno interessi in comune facilita la circolazione delle idee, aiuta
semplicemente a reperire materiali, informazioni, aiuti anche alle band che
incidono sulla mia etichetta.
Il Tagofest è una esperienza illuminante in tal senso, negli ultimi sei anni
ha rappresentato un punto di incontro per un sacco di musicisti, ma anche
artisti di altro tipo, che ha allargato le conoscenze, ha messo a disposizione
delle persone il supporto di altre persone, una maniera per crescere insieme con il mutuo aiuto (visto che aspettarselo dall’alto non è una buonissima idea).
Tutto questo senza dimenticare un atteggiamento di apertura verso le
vicende che capitano all’estero o che dall’estero passano attraverso l’Italia.
Nelle mie collaborazioni discografiche figurano etichette americane, francesi, artisti da tutta Europa, dalla Russia. Tutto questo aiuta a consolidare la
credibilità del lavoro che sto portando avanti, oltre a farmi fare un sacco di
amici nuovi.
F9 Per quanto riguarda la distribuzione e la commercializzazione dei
prodotti, non parlerei di territorialità visto che ormai lavoro con distribuzioni sparse per l’Europa, e sto lavorando anche per avere qualche disco in
America. Le iniziative come il Tagofest e altre collaborazioni atte ad organizzare concerti aiutano e ci sostengono nel nostro lavoro. E riallacciando27
mi al discorso di prima devo dire che se mi fermassi a lavorare soltanto con
il territorio Italiano finirei cotto nel mio stesso brodo.
Una scena circoscritta aiuta a rinsaldare i legami tra musicisti, giornalisti, promoter, etichette?
ONGA I legami si rinsaldano con la partecipazione, più questa aumenta più
si consolidano i rapporti tra le diverse entità del mondo musicale. L’offerta
musicale è vastissima e lo sono pure le strutture di promozione. È naturale
che nel percorso di ognuno ci siano dei legami più stretti con quelli “del
giro” ma io trovo importante allargare questo giro il più possibile, non limitarsi mai ad operare in territori conosciuti e rischiare invece l’avventura con
nuovi interlocutori. Il rischio, ad operare in un circuito ristretto artista/etichetta/giornalista per esempio, è quello della autocelebrazione e dell’eccessiva indulgenza nei propri confronti. Nel tempo si corre il rischio che il
rapporto tra una etichetta ed i giornalisti di riferimento venga a mancare
di obiettività, oppure che un artista perda gli stimoli non dovendosi confrontare col giudizio ex-novo di una nuova etichetta. Confrontarsi aiuta a
crescere.
F9 Direi che un po’ un’arma a doppio taglio, perché succede che poi
continui a guardare in faccia le stesse persone, ad avere le stesse frequentazioni ai concerti e quindi i dischi vanno a finire esauriti perché li hai scambiati, dati in promozione ai giornalisti (alcuni dei quali ormai tuoi amici)
o lasciati ai locali, ma non perché siano stati effettivamente venduti. È un
ragionamento che funziona e fa piacere fino ad un certo punto, perché poi
c’è bisogno di cambiare aria e purtroppo in diverse occasioni sembra che
sia una guerra tra poveri per riuscire ad accaparrasi qualche concerto e c’è
ancora tanto egoismo per riuscire a creare davvero un bel circuito fatto di
collaborazioni e condivisione d’intenti.
H undebiss . Carta , onestà e rumore
È famosa per gli show milanesi al Secret Place, capannone sperso nel Lambrooklyn al nord-est della città. Lì, in un luogo senza orpelli né attrattive
alla moda, si è alternata la créme de la créme della scena weird-noise-impro
mondiale: da Ducktails a Wiese, da Burial Hex a Aaron Dilloway arrivando
a Sun Araw per il gran finale. Oltre questo però la Hundebiss è anche raffinata label che unisce efferatezze sonore a ricercatissime edizioni homemade, con una spassionata predilezione per la carta. Affare anche questo
di una coppia di fruitori e appassionati musicali, prima che di “esperti del
settore”, Barbara e Simone Hundebiss. HUNDEBISS inizia nel 2007 come piccola distribuzione di materiale che all’epoca faticavamo a trovare in Italia (e
a volte in Europa). Nasce quindi dall’esigenza di avere a propria disposizione
dischi e documenti di quello che stava accadendo in US (Fort Thunder a Providence, i concerti nei sottoscala del Mid-West) e in alcune parti d’Europa (Belgio
ed Inghilterra soprattutto).
Non di solo acquisto di dischi però si tratta, quanto di creare una rete di
contatti più ampia e profonda. In Italia contemporaneamente sembravano
nascere (o risorgere) fermenti di quella che potremmo definire “un’attitudine
alla sperimentazione non accademica”, questo per includere e non escludere,
difetto che hanno spesso alcune (troppo) facili definizioni quali noise, experimental, hypnagogic (brrr). Raccogliendo questi vagiti siamo partiti con l’etichetta, esperienza che continua tutt’ora.
C’è una filosofia e una estetica forte dietro il marchio col cane. Che si fa
28
29
ricerca, nel primo caso, e artygianato, nel secondo. La filosofia di Hundebiss
è piuttosto semplice, si potrebbe parlare di una mappatura di tutto quello che
ci sembra fresco e onesto nel panorama sperimentale contemporaneo. Fondamentalmente produciamo quello che ci piace, e quello che ci piace ha di solito
una visione solida alle spalle. Pensiamo a Raphael/Mudboy, a Henrick/Popol
Gluant, e, ovviamente, a James Ferraro.
Noise concreto e massiccio, elettroacustica frantumata, experimental
maltrattata. Queste le lande di riferimento sonoro di Hundebiss, sviluppate attraverso supporti che variano dal 12” screenprinted (Popol Gluant,
Hair Police) alla cassetta (Francesco Cavaliere, Aaron Dilloway, Dracula
Lewis), passando per i 7” (Olyvetty) e il vhs (l’upcoming Rapture Adrenalina di James Ferraro, presentato all’ultimo Netmage). La peculiarità fondante di Hundebiss risiede proprio nella tangibilità arty di ogni singola opera,
in una esperienza che è visiva e tattile prima che uditiva. La nostra particolarità è la cura totale dell’oggetto “disco”, con un’ossessione maniacale per
packaging e grafica. Le nostre uscite sono in poche parole una collaborazione
tra noi e l’artista. Il tutto viene fatto a mano, esasperando il concetto di diy, cercando di svoltare il risultato in un prodotto il più possibile completo. Evitando
banali discussioni, crediamo però che scaricare un’uscita Hundebiss equivalga
a perdere almeno la metà della carica esperienziale del prodotto originale.
Come accennavamo in apertura, la spinta propulsiva della label milanese oltrepassa quella puramente discografica. I concerti in spazi desueti o
atipici, esteriormente disadorni ma pregni di significati, ne sono la caratteristica principale; una tendenza che rinsalda il legame del circuito diy creando una comunità. Crediamo che dopo tanta fatica sia ora possibile organizzare tour in Italia, dopo anni di buio dove la penisola veniva spesso evitata
come la peste. Senza falsa modestia, la presenza del Secret Place a Milano ha
giocato un ruolo fondamentale. I motivi sono molteplici, il primo è semplicemente strategico: Milano è la prima grande città italiana raggiungibile quando
si sta facendo un tour in Europa, il che significa che da lì in poi scendere è una
spesa affrontabile per il gruppo. All’inizio è stato difficile, ma avendo lavorato
duro per oltre due anni, ci siamo costruiti un pubblico di affezionati che rendeva possibile dare ottimi fee alle band. Inoltre, l’accoglienza e l’organizzazione
dello spazio rendevano il Secret Place un’isola felice nel grigio milanese, dove
spesso le band passavano ben volentieri più di un giorno.
Quel senso di comunità, fatto di identità di vedute e di condivisione di
ideali, spazi e obbiettivi è in crescita anche in altre realtà geografiche, ponendo il panorama italiano alla pari con quello di paesi con altre tradizioni
rumorose. Lo accennava Onga di Boring Machines poco prima, ce lo confermano i due Hundebiss, ora: Lo stesso lavoro è stato fatto a Vittorio Veneto,
Roma, Napoli, già da molto prima a Bologna, e credo che a catena anche altre
città si stiano svegliando. Ora che il Secret Place è andato per sempre rimane
un grosso vuoto. Continuano altre esperienza milanesi, ma con un’attitudine
diversa dalla nostra. Onestamente crediamo che mancherà uno spazio come
il Secret Place, anche per la sua rude ma liberissima accoglienza, la semplice
possibilità di fumare e bere a poco prezzo oppure il lusso di poter suonare a volumi inauditi o bassissimi. Oppure poter semplicemente chiacchierare all’aperto, senza limiti di tempo o di volume (ancora una volta). A volte viene trascurata la valenza sociale (o asociale, visto che con orgoglio Hundebiss ha sempre
chiamato a sé un bel mucchio di coloratissimi weirdos) di situazioni del genere.
Ci piace pensare che tutti gli orfani di questo posto e di questo momento si
30
stiano sparpagliando in giro per far nascere situazioni analoghe in ogni posto.
Sogniamo un mondo di Secret Place.
Von . A rchivio e raffinazione del nostro tempo.
Facile a dirsi, breve a spiegarsi. Lasciando la parola al sito web dell’etichetta,
“VON is a label interested in releasing experiments in contemporary sound and
visual arts.
VON is interested in the intersection of the visual and sound arts.
VON releases limited and special editions.
VON is run by artists.”
La Von nasce deliberatamente come intersezione e messa a sistema dell’esistente e delle sue eccellenze. La label nasce nel 2008 e a oggi conta undici
uscite, dallo split DVD Choir (se così si può chiamare un matrimonio audiovideo), originato dalla collaborazione tra Carlos Casas e Nico Vascellari
– prima e unica release del 2008 – fino a Inner Shine, in uscita sempre in
formato DVD (anche se ristampa, almeno lato audio, della cassetta omonima uscita nel 2009 per Second Sleep) e firmato da WW – detto per esteso
Women in the Woods, progetto che coinvolge lo stesso Vascellari. In mezzo, giusto per citare uno dei picchi in vinile, l’ellepì Blind Jesus, fotografia
della collaborazione tra Stefano Pilia e Edward T. Hooker, secondo chi
scrive una delle uscite più convincenti dell’anno appena concluso.
I tratti distintivi sono tutti già detti: roster selezionatissimo, visual e
sound art e produzioni di poche – e sicure – centinaia di copie. Il protagonista dell’impresa è Vascellari, artista nato in seno al nido dei With Love,
oggi ormai arcinoto nel circuito dell’arte contemporanea; figura di cui qui a
SA abbiamo parlato spesso, data la pertinenza del personaggio nello sdoganamento e maturità sperimentale del post hc della band madre.
Le coordinate su cui si muove la musica prodotta da Von sono inequivocabilmente settate sul noise elettroacustico in kraut-sourcing e all’impro
sperimentale. Epperò Nico ha dato anche spazio, nell’uscita n° 7 dell’etichetta, alla propria creatura Lago Morto, hard core senza compromessi e
local-oriented. Altro aspetto interessante è proprio il ragionamento sulle
dinamiche geografiche. L’ultima uscita del 2009 (VON005) è una compilation che raccoglie gli ereditieri del sound With Love, fa quadrato attorno a
Vittorio Veneto, paese natale e residenza di Vascellari, e mette soqquadro
grazie ai partecipanti del festival Three days of struggle e ai frequentatori
del Codalunga.
Ciononostante, non si può certo dire che Von equivalga al luogo dove
nasce. Ancora una volta, basta scorrere i titoli per smentire. Dagli States
provengono John Wiese e C. Spencer Yeh, autori di Compound (VON002),
secondo 7” dell’etichetta, forte di un lato A (Compound I) che è gemma angolare nell’economia del sodalizio tra John e Spencer (ulteriormente siglato, nel 2010, da Cincinnati, edito da Dronedisco). Burial Hex costruisce
intensità da kosmische musik, prima carezzando il noise con un guanto
indossato da Popol Vuh, poi rotolandosi nella sua sostanza più vivida. Girando l’LP, il lato B suiteggia a sua volta una danza Tangerine Dream, tutta volta all’oscuramento dei riferimenti, con la pece del rumore. E ancora:
Ultradeath condensa la sua morte (Condensed Death) con una purissima
mancanza di compromesso. Se deve essere rumore, è rumore bianco che
non lascia spazio a nient’altro.
31
Non c’è però solo Vascellari dietro ai Von Archives, così come il sound
non può che essere solo parte del discorso. La “fotografia”, in senso cinematografico, dell’estetica dell’etichetta è curata dal co-animatore della label, quel Carlos Casas con cui Nico aveva condiviso il DVD Choir. Le undici
copertine del catalogo sono altrettanti ritratti in bianco nero, immagini di
impressionante coerenza post-coloniale che a loro volta fotografano Casas
nelle vesti di ricercatore da archivio di inquietanti primi piani ottocenteschi.
L’impatto e l’assertività muta dell’impianto visivo della Von è tale che
Netmage – sede perfetta per mettere in mostra i risultati della label, che
evidentemente centra il core business del festival – decide di affidare a
Carlos la propria immagine coordinata dell’edizione 2010, cogliendo l’occasione dei primi risultati del suo lavoro di ricerca sui cimiteri degli elefanti. Cemetery è titolo del suo contributo a Netmage10 così come Cemetery
Archive Works lo è del DVD VON009, pubblicato nel 2010 dall’etichetta. Il
racconto si sviluppa su un collage narrativo di paesaggi di antiche giungle
e antiche ombre animali, montato su composizioni acustiche espressioniste, anch’esse lontano nel tempo.
Niente a che vedere con il noise senza compromessi e con le sovraposizioni di layer video di Choir. Ma, nell’economia della label, l’anello mancante è possibile, e si sostanzia in Vezdekhod (sorta di omaggio al tank russo
omonimo), firmato da Casas stesso con i Prurient. Lato video, lande esotiche – a colori – a bordo del carro armato. Lato audio, basta dire Prurient, per
sentire la sordità che si avvicina. Anche in questo caso, l’estrema coesione
è l’obiettivo percepito.
Il concetto è chiaro: Von raccoglie un mondo di altissima qualità, e coordinate molto precise, sottolineature nette del nostro tempo e del gusto che
esso promuove. Von è un esperimento ma anche un packaging minimale e
raffinato, una selezione scolpita dal pieno fino a raggiungere forme essenziali. Rispetto a Second Sleep, Boring Machines ecc, la Von è già un’etichetta
di seconda generazione, che raccoglie i frutti e la cultura delle esperienze
precedenti. È l’archivio visivo e musicale di uno spazio-tempo, di un tessuto
locale (veneto, italiano) e internazionale che si propone, forse più delle etichette che l’hanno preceduta, come marchio a garanzia di qualità.
Sarebbe interessante sapere se della Von è prevista già la fine, un numero di pubblicazioni predefinito dalla sua apertura. Siamo infatti convinti
che l’etichetta sia – anche - il “lavoro” di Vascellari come artista. Nico non è
solo abilissimo networker che raccoglie il meglio dell’unione di due mondi
(quello dell’arte contemporanea performativa e quello della musica di sottobosco, che veleggia tra hc, noise ed elettroacustica), ma anche traghettatore imprescindibile, caronte del noise in galleria e viceversa. Guardando
le produzioni Von una accanto all’altra su un tavolo, ci appare chiaro il loro
statuto di “opera” contemporanea che sancisce quell’unione, quello sdoganamento reciproco. Von Archives è poi, più tradizionalmente dentro al
mondo della musica, un’esperienza che sappiamo avere la facoltà di diventare un “cofanetto” di culto, un organismo di release coese che parlano e
parleranno in modo quasi documentaristico della fine degli ’00 e dell’inizio
dei Dieci del Duemila. Personale e “penetrante” come una warburghiana.
32
33
Recensioni
— cd&lp
highlight
AA. VV./AGF/Ellen Allien/Sascha Funke/
Vladislav Delay/Telefon Tel Aviv/Paul
Kalkbrenner/We Love - Werkschau (BPitch
Control, Gennaio 2011)
Genere: House, techno
In dodici anni di pubblicazioni la Bpitch Control di Ellen
Allien ha spaziato in moltissimi campi dell’elettronica
90/00. Lo ha fatto senza porsi limitazioni tra dance e
salotto, idm, electro e formato canzone. Su tutto pare
dominare uno sguardo art techno, di musica come abbigliamento sonoro e tech-fashion tra minimal e groove asciutti. Poche sorprese: se la label ruota attorno
alla dj, musicista, stilista e producer, l’etichetta fornisce
l’export, assieme alla Kompakt, del suono berlinese di
qualità.
Oltre a Ellen (il taglio deep old school di The Kiss), in
Werkschau troviamo campioncini indietronici (Telefon Tel Aviv, the sky is black con Robin Guthrie) e persino dubstep (Marc Broom, Refund), alcuni nuove leve
come i nostrani We Love, la cui techno elfica è piaciuta
molto (Harmony Of The Spheres), Coma con feat Dillon
(la fiabesca track in odor di Cocorosie Aiming For Destruction) e Zander VT (classic jazz house Gotta Look Up
to Get Down), oltre naturalmente agli immancabili Agf
/ Delay (ambient techno in field recording vari, Most
Beautiful Kill), Sascha Funke (la scura soundtracky Hiddensee) e il blasonato Paul Kalkbrenner (il quadretto
narrativo Plätscher).
La qualità media è indiscutibilmente buona e all’assenza di picchi si compensa con fare uber cool che regge
il tempo.
(6.8/10)
Edoardo Bridda
AA. VV./Wolf + Lamb/Soul Clap - Dj Kicks
(!K7, Marzo 2011)
Genere: house
I Soul Clap (Eli Goldstein e Charles Levine) fanno bisboccia con i Wolf + Lamb (Gadi Mizrahi e Zev Eisenberg) nel settembre del 2008 a Brooklyn. Location: ovviamente il club Marcy Hotel dove i W+L sono di casa.
I bostoniani si trovano a loro agio nelle atmosfere soul
dell’house newyorchese e lasciano un nastro di edit in
34
mano a Gadi e Zev, che iniziano a macinarsi i rispettivi
cervelli.
La liaison dangereuse si fa più concreta quando la !K7 li
vuole unire per uno storico DJ Kicks. Ovviamente visto
che di Wolf + Lamb c’è pure un’etichetta, perché non
puntare proprio su quei suoni che oggi stanno spopolando? E allora ci si va di anima e di chichness downtempo. I nomi sono quelli di cui in questi giorni si sta
celebrando il boom: Nicholas Jaar, Deniz Kurtel, Slow
Hands, Greg Paulus dei No Regular Play (per la scuderia
Marcy), Voices Of Black e altri gentleman dell’ambient
house a bpm molto poco tirati. Una cosa che sembra
provenire direttamente dal ricordo newyorchese dei
grandi Metro Area, mescolando le origini di club storici che puntavano su una nozione di community, più
che di stardom (e qui non può che venire in mente il
Loft mancusiano). In più (per la parte bostoniana) non
mancano i personaggi: Tanner Ross, SECT, Eli Gold (il
debutto di Goldstein da solo), Lee Curtiss e Benoit &
Sergio.
Una selecta che ci fa conoscere un nuovo modo di fare
house, quasi un ritorno alle avventure F-Comm dei Novanta francesi o alla cometa St Germain. Il tutto traslato
di vent’anni nel futuro, con il cuore che batte sempre e
solo ambience Big Apple. Ascoltatelo, ballatelo, bevetelo. Uno dei primi mix dell’anno.
(7.3/10)
Arnaud Fleurent-Didier - La reproduction (Sony BMG Music Entertainment,
Gennaio 2010)
Genere: pop, french
La reproduction nasce dall’idea di un infinito possibile ripetere, ricreare e riprodurre nel mondo contemporaneo: riproduzione sessuale, ideologica, meccanica e non naturale. Un riprodursi che consuma,
allontana i significati e il valore delle cose.
Composto interamente in un piccolo scantinato a Place de Clichy, Parigi, il secondo album solista del talentuoso Arnaud Fleurent-Didier, ne traduce perfettamente il concept attraverso una commistione di generi,
riferimenti e sguardi, dal pop al punk, dall’elettropop alla classica, passando
attraverso le variazioni su Marilou tanto care a Serge Gainsbourg.
E’ un concept importante e lo si comprende subito, a partire dalla copertina con un Didier/Nanni Moretti in una delle scene più emblematiche del
film Bianca quella in cui il protagonista osserva l’amore riprodotto in ogni
angolo della spiaggia; stiamo parlando,a tutti gli effetti, di un lavoro dai
forti riferimenti cinematografici, dalla ritrattistica raffinata - un giovane
uomo nella Parigi di oggi, che si muove tra una vita amorosa dissoluta e
ancora non disillusa e considerazioni acute sull’educazione culturale e politica ricevuta dalla famiglia (French culture, Mémé 68).
Riflessioni amare quelle di Didier, musicate con riferimenti nostrani (Morricone, Battisti) senza dimenticare certi barocchismi francofoni come le lezioni di Michel Polnareff (noto in tutto il mondo per la
sua eccezionale Love me, please love me baluardo della chanson d’amour tutta miele, classicità e violini)
o di Pierre Vassiliu.
In definitiva,ecco l’other side del cantautorato francese, un contraltare a Benjamin Biolay. La reproduction è un lavoro irresistibile capace di ridare al pop d’autore una voce forte e profonda. (7.7/10)
Giulia Cavaliere
Marco Braggion
Alexander De Large - Nothing Exists
(Lepers Produtcions, Febbraio 2011)
Genere: chamber avant pop
Tutto puoi aspettarti da un tipo come Alexander De
Large, da uno cioè che in casa Lepers non si fanno scrupolo di presentare come “probabilmente l’artista più
puzzolente del sud Italia”, già autore assieme al sodale
Superfreak di deliranti e scellerate adulterazioni rockblues. Tutto e di tutto, ok, ma non certo un album di
piano-solo. Undici tracce che si disimpegnano morbide e febbrili, agili e ossessive, masticando malinconia,
dolciastra inquietudine ed ebbrezza insidiosa.
Più che la qualità dei pezzi, è centrale la sgraziata
compostezza del tocco, la cui conseguente sfrangia-
tura timbrica produce un senso di tangibile autenticità
espressiva, di consistenza poetica indocile. Siamo più
meno agli antipodi rispetto alle edulcorate insulsaggini
d’un Giovanni Allevi coi suoi sottofondi salottieri per
anime bidimensionali, col suo neo-accademismo informale appiattito su nefaste prospettive buoniste. In
Nothing Exists il pianoforte si confronta anima e corpo
coi crucci e le seghe mentali d’un musicista che arriva
ad offrirsi con disarmante sincerità.
(7/10)
Stefano Solventi
Altierjinga Lepers - Ghost Friends (Lepers
Produtcions, Febbraio 2011)
Genere: art noise
I padrini della benemerita Lepers Produtcion tornano a
scuotere la coda del serpente col solito piglio balzano e
insidioso che li vide aprire le danze oltre un lustro fa. Ed
è un subbuglio di visioni sferzanti, di garage-surf avariato e funky cocainico in differita dai Novanta losangelini, di folk abbacinato e polvere da sparo noise-punk, di
hard-psych delirante e no-wave patafisica.
Prendete i più nevrastenici Janes Addiction sgambettati dai primi Flaming Lips, immaginatevi una via di
mezzo plausibile tra X-Mary e Bugo (nell’unico pezzo
35
in italiano, Pasta col formaggio), frullate l’impeto deragliato Mc5 con emulsione acida Butthole Surfers e
frenetico disincanto Gang Of Four: oltre le oscillazioni
del baricentro stilistico, domina un piglio da outsider
generosi e imprendibili, come se provenissero da una
realtà parallela dove dare fondo all’estro più sbrigliato
è requisito primario e irrinunciabile. Per questo suonano così liberatori e donchisciotteschi, col loro gettarsi
anima e corpo oltre le barricate. Dove tutto un altro
pop-rock è (forse) possibile.
(7.2/10)
con una parolina di tre lettere: “pop”.
Grazie ad una produzione che bilancia perfettamente
il chitarrismo caotico con melodie assai più accentuate
rispetto al passato, i Deads ci conducono nei meandri
di una narrazione musicale densa ma mai velleitaria,
sempre in bilico fra estasi ed euforia.
E’ l’inizio di una nuova fase per combo di Austin, ma
chissà che la loro esperienza non induca tutta una generazione di noisemaker a confrontarsi con operazioni
di ampio respiro.
(7/10)
Stefano Solventi
Diego Ballani
And You Will Know Us By The Trail Of Dead
- Tao Of The Dead (Century Media, Febbraio
2011)
Genere: Alt rock
E’ come se la band texana si fosse da sempre preparata a questo Tao Of Dead, avvicinandovisi per continue approssimazioni. Chiariamolo subito: si tratta di
un album che non raggiunge le vette di Source Tags &
Codes (più disarmonico e acerbo, ma di efficace scelleratezza) ma si pone come sua naturale evoluzione, al
tempo stesso come ponte fra la generazione emocore
(almeno la sua parte migliore) e le grandi rock opera
dei 70s.
Conrad Keely non ha fatto mistero di essersi ispirato
agli opulenti rock album di Yes e Rush, inducendo
molti nell’errore di considerare Tao come una sorta di
opera neo progressive. In verità, al di là della scansione dei brani (due lunghe suite, la seconda delle quali
composta da un’unica traccia di sedici minuti), i Deads
evitano accuratamente tutta l’autoreferenzialità del
prog, concentrandosi sull’impatto frontale di ciascun
frammento.
Chi li conosce sa che si tratta della via più ovvia per
portare a compimento la magniloquenza che accompagnia la band dagli esordi; del modo migliore per arginarne la furia e disciplinarne la tensione in un’epicità
eroica (più che in un’epica fiabesca).
L’emotività viene messa così al servizio di potenti strutture scolpite nell’hard rock più classico: c’è l’esplosività whoiana (è il caso del singolo Summer Of All Dead
Souls), il rifforama degli Stones (con l’incipit di Pure Radio Cosplay che cita apertamente Jumpin’ Jack Flash) e
le divagazioni psych che rimandano ai Pink Floyd più
sgamati (quelli di The Dark Side Of The Moon, ma
anche A Momentary Lapse Of Reason). Miracolosamente tutto funziona grazie ad una concretezza difficilmente riscontrabile in altre fasi della carriera della
band; una maggiore incisività che si può riassumere
36
Arbouretum - The Gathering (Thrill
Jockey, Febbraio 2011)
Genere: neo-hard
Ciò che impressiona degli Arbouretum, costanza della
scrittura a parte, è la capacità di imprimere al loro stile
variazioni nella continuità. Pur restando riconoscibili, risultano insomma fedeli a se stessi a ogni passo e
dunque anche in questo terzo, nel quale l’impasto tra il
Richard Thompson solista e il Neil Young in versione
elettrica corteggia un suono più heavy, contaminato
tramite lo space-rock degli Hawkwind e un’idea cupa
di psichedelia californiana. Avvicinandosi in tal modo
ai loro amici Pontiak - si prenda il monolito finale Song
Of The Nile - con i quali il gruppo di Baltimora ha in passato condiviso l’e.p. Kale e numerosi palchi, nondimeno
trattenendo un’identità “cantautorale” sia nella voce del
“deus ex machina” Dave Heumann (che ricorda un po’
Warren Zevon e un po’, giustappunto, Mr. Thompson)
che nelle tracce di più stretta derivazione folk.
Difficile che la metamorfosi possa essere scaturita
dall’ingresso in line-up di un tastierista: semmai, pare
più sensato considerare Heumann musicista “d’altri
tempi” per linguaggio (tutt’altro che passatista, peraltro
) e piglio esecutivo; soprattutto per la maniera in
cui forgia la propria musica instillandovi le esperienze
quotidiane, nel caso specifico la passione per Carl Jung
di cui risentono i testi. Incupiti i panorami sonori, cosparsi di disturbi e tessiture tastieristiche, e appesantito il passo, di una scaletta solida e destinata a crescere
con gli ascolti impressionano soprattutto l’apertura
innodica The White Bird, le atmosfere di Destroying To
Save, un’intensa The Highwayman - dal repertorio di
Jimmy Webb - che diresti tra le cose milgiori degli
ultimi Earth. Convince e piace anche in questa veste,
Dave: la certezza è che possa farlo sempre e comunque, a prescindere dalle future metamorfosi.
(7.2/10)
Giancarlo Turra
Aspec(t) - Waspnest (Fratto9 Under The
Sky, Febbraio 2011)
Genere: impro-noise
Si alterna tra black e white side questo vinile nero pece
a firma Aspec(t), esoterica sigla che coinvolge due
esponenti della scena impro partenopea già noti alle
pagine di SA.
Mario Gabola (feedback & acoustic sax, resonant/feeddrums, già parte del trio A Spirale) e SEC_ (laptop, nastri processati, synth, al secolo Mimmo Napolitano, cuore di Weltraum) giostrano con sapienza “mutazione” e
“feedback” in un impasto ad alto tasso ambiental(ista)filosofico e concettual-rumoroso.
Il primo deforma il sax attraverso le drum-kit, il secondo gira manopole e traffica coi volumi. Insieme frantumano ritmi (Donoso Against Oscene Wasp), padiglioni uditivi (People Of Refusal, GD Meets dp), strumenti
(l’elettroacustica concreta di Birdnest, la tensione borderline di Waspnest), confini (l’impro radicale virata
noise concreto di EA Environmental Assassination) superando i limiti di una poetica sonora che è, per forza
di cose, una giungla di suoni inestricabili e stordenti.
Citano avanguardie storiche, improvvisatori radicali,
new aktionism e concreta. In realtà ne fanno pienamente parte.
(7.2/10)
Stefano Pifferi
Baby Dee - Regifted Light (Drag City, Marzo
2011)
Genere: chamber pop
Ti chiede di entrare nel suo boudoir di sogni appassiti. Una stanza di bambola dove si agitano fantasmi
romantici e derelitti. Bohemienne fuori tempo massimo, cocciuto nostalgico di cabaret andati, regina delle
illusioni desuete che puoi indossare e togliere dal corpo ma non dall’anima, Baby Dee torna con un album
breve e perlopiù strumentale - sono 4 su dodici i pezzi
cantati - dove il piano, l’amato Steinway D, diventa materia e scalpello, calligrafia fervida e malferma di miraggi fatui nel loro struggente manifestarsi.
Archi, ottoni e poco altro (un vibrafono qui, un sassofono là...) sono arredamento per un’atmosfera raccolta,
in cui ogni traccia diventa l’atto di un teatrino di posa,
un romantico baluginare, un guizzare giullaresco tra
lirismo friabile e vampe indolenzite (tra parentesi, stupisce trovare accreditato come producer il famigerato
Andrew W.K.). C’è qualcosa di irriducibile in questo ardente e un po’ disperato tentativo di rappresentare se
stesso, come se ne andasse del proprio stesso esistere.
Inevitabile uno spiccato gusto di autoreferenzialità. Ti
chiede di entrare nel suo malinconico, decadente, capriccioso boudoir.
(6.9/10)
Stefano Solventi
Bandwidth - Trinite (Mia Cameretta,
Gennaio 2011)
Genere: wave noise
Garage punk cubisti, crossover psicopatici, sincopi wave-noise e bailamme arty. Sperimentazione spigolosa
che molla gomitate soniche tra sussulti math e intruppamenti ritmici dalla neanche troppo vaga ascendenza krauta. E quindi? T’immagini i Liars a precipizio, una
versione nevrotica - quasi zappiana - dei Blue Cheer,
gli Shellac strattonati Gang Of Four, i Sonic Youth ipnotizzati da Mike Watt e via discorrendo.
Ne esce questo Trinitite, opera terza dei laziali Bandwidth, mini album dall’ostica empatia, otto congetture impetuose e cervellotiche che colgono nella delirante ChatRoulette e nella convulsa Nails And Glue due
brillanti ragion d’essere e perseverare.
(7/10)
Stefano Solventi
Beady Eye - Different Gear, Still Speeding
(Beady Eye Recordings, Febbraio 2011)
Genere: rock, pop
Gli anglofoni lo chiamano “reality check”, il momento
del “controllo realtà”. Un confronto tanto franco quanto
letale: da una parte i sogni, i proclami, le speranze (e
le sparate). Dall’altra la realtà. Da una parte Liam Gallagher coi Beady Eye, dall’altra la realtà. Da una parte
chi ha sostenuto per quindici anni che tutto quel che
c’era di buono negli Oasis nascesse con Noel, dall’altra
l’ideatore primo della band di Definitely Maybe, deciso
a riprendersi quel che è sicuro gli spetti di diritto. Che
sia la fama o il riconoscimento artistico, sta al mancuniano dirlo.
Quel che dice invece, lungo i 13 pezzi di Different Gear,
è che ha ancora voglia di esserci, di riempire gli stadi,
di farsi sognare da una legione di adolescenti. Se è certo che le teenager preferiscano ormai tenersi alla larga
dall’incartapecorito Liam, è invece tutta da capire la
“portata” musicale di un disco che non va al di là degli
episodi meno riusciti degli Oasis.
Che, detta così, suonerebbe anche come una considerazione di un certo pregio per i Beady Eye. E in effetti
se è vero che nessuno avrebbe puntato un penny sulla
capacità di Liam di tenere in piedi un intero album, è
altrettanto vero che Different Gear non è il prodotto di
certe drammatiche seconde carriere. Dentro c’è l’esplo37
sione controllata di Four Letter Word, il citazionismo di
Bring the Light, il comunicato stampa di Beatles and
Stones (“I wanna stand the test of time, like Beatles and
Stones”) e la più clamorosa delle dichiarazione d’amore
che sia mai stata recitata a Champagne Supernova (The
Morning Son).
Fin qui quello che si ascolta con gusto, senza mai levarsi
il cappello e senza riuscire per davvero a farsi prendere
dal sacro fuoco di un rock sempre elargito col misurino
tanto abile quanto canonizzante di Steve Lillywhite
(produttore). Poi, però, c’è il gruppetto di ballate che
mina le certezze: Millionaire, infilata all’inizio dell’album, rischia di regalare catalessi ad ampie manciate.
And the Beat Goes On è scoppiettante quanto la sigla
di un cartone animato per bambini e dei sei minuti di
Wigwam è difficile capire che farsene. Il limite del Liam
compositore è quello già mostrato nella sua vita precedente: una cronica mancanza di profondità e di idee.
Meglio di tanti episodi del passato, i brani di Different
Gear tendono comunque, troppo spesso, ad appiattirsi
e a replicarsi.
La realtà restituisce un Liam ad alto tasso di fallibilità,
ma a cui non va solo dato atto di essersi voluto rimettere in gioco, ma anche di esserci riuscito perlomeno
per mezzo album.
(6/10)
Mattia Ravanelli
Beans - End It All (Anticon, Febbraio 2011)
Genere: rap /electrohop
Sempre mantenutosi, nel post-gloriam post-Consortium, sulla linea di galleggiamento di una carriera
solista ovattatamente targata Warp e sorretta da un
carisma e una tecnica eccezionali, Beans torna senza
troppi clamori e pubblicando su una Anticon (in altri
tempi la cosa sarebbe stata un vero evento, la chiusura
di un cerchio alt-hop eccetera) che nello sbaraglio generale riesce ancora a intercettare qualche colpaccio.
End It All è un discone electro-hop da favola, con basi
approntate da un parterre di produttori eterogeneo e
goloso (Nobody, i Bumps della Stones Throw e cioè i
batteristi dei Tortoise, Sam Fog degli Interpol, Tobacco, Son Lux, Four Tet, Clark, lo stesso Beans) e i rappati
del nostro che sono una lezione pratica di incisività e
quadratura newyorkesi dall’impatto quasi stordente.
Tribalismi (Deathsweather, Electric Eliminator), wonky
(Hunter, Anvin Fallin), urban funk (Gluetraps), elettrorock (Glass Coffins, Blue Movie) ed elettro-blues (Mellow
You Out), secchezze street che sono bisturi e frustate
(Air Is Free) per un eccezionale disco minore, che non
sposta nulla in nessun campo, aggiorna semmai leg38
germente l’ambito di azione di Beans, ma lo fa con
uno stile e una padronanza che pochissimi possono
permettersi. Per quanto giocato su territori e con modi
diversi, tre spanne sopra Fluorescent Back.
(7.3/10)
Gabriele Marino
Ben Ottewell - Shapes & Shadows (Eat
Sleep, Marzo 2011)
Genere: pop-folk singer
Piace dei Gomez, la band britannica in cui Ben Ottewell è cantante e testa pensante, il fascino sincero per
sonorità d’oltreoceano che un approccio svagato ha
saputo rendere personali e immediatamente riconoscibili. Una fusione stralunata di Beatles e The Band,
la loro, che col tempo è andata normalizzandosi senza perdere dignità e che Ottewell ripropone in questo
suo album solista, trentacinque minuti all’insegna di
un folk-rock dalle venture ora pop ora “roots” dipanato con voce calda e profonda, con quel timbro un po’
Richard Thompson e un po’ (tanto) Eddie Vedder che
arriva dritto al cuore.
Ciò che ti aspetti da un artigiano di razza con lo sguardo rivolto oltreoceano, insomma, come spiegano l’atmosfera anni ’70 del brano omonimo e il rigore formale
di All Brand New e Blackbird. Oppure gli arrangiamenti
curati però bilanciati e una penna che evita il calligrafismo (la struttura aperta di Step Right Back), al massimo
inciampando nella prosopopea radiofonica (Lightbulbs) per raggiungere vertici di rispetto nell’articolata
dolenza di Chicago, in una malinconica Chose degna
del miglior Neil Halstead, nel Nick Drake rasserenato
da cori tra Beach Boys e 10CC della conclusiva Take
This Beach. Più che abbastanza per interessare i fan dei
Gomez e chiunque cerchi conforto in canzoni classiche
ma di classe.
(6.8/10)
Giancarlo Turra
Bibio - Mind Bokeh (Warp Records, Marzo
2011)
Genere: funkyglo-tronica
Impossibile essere più espliciti. Se il “mind” del titolo agisce da selezionatore generico di pubblico, ribadendo i
toni e i modi inequivocabilmente arty (quindi pensati)
del nostro, il “bokeh” allunga la sua ombra sulle wave
della nowness più cool (...), parola giapponese che indica la confusione di forme e colori propria del fuori
fuoco e, meglio ancora, la loro qualità estetica: ecco
allora i coriandoli luminosi della copertina, tra simbolico e decorativo, sicuramente evocativo. Aggiungi poi
highlight
Cesare Basile - Sette pietre per tenere il diavolo a bada (Urtovox, Marzo 2011)
Genere: cantautorato rock
Settimo album a proprio nome in diciassette anni. Sette come le pietre del titolo, ogni disco un amuleto o una poltiglia di viscere da interpretare. Quanto al diavolo, è quello che cova dentro e pervade
le cose. Spesso, in Basile, la canzone indaga la vita mettendone a nudo le ombre, scavandone il cuore
fino alla radice del dolore. Il senso di atavica prevaricazione. Il male come una condanna che fa a pezzi
la morale nella culla. La sua musica sempre più una conseguenza rock di travagliati metabolismi folk e
blues, di umori mediterranei e balcanici, di codici tradizionali riaffiorati come salnitro.
Il sud - la Sicilia - è la ferita che non cicatrizza, provocando indolenzimenti pensosi (E alavò) e sussulti
febbrili (la vibrante La Sicilia havi un patruni, pezzo di Rosa Balistreri). L’espressione sempre in bilico
tra ricercatezza e brutalità, un disequilibrio emotivo che esige asprezza (l’elettricità bieca di Strofe della
guaritrice) e suadenti scenografie (i fiati, l’armonica e lo xilofono in L’ordine del sorvegliante, gli archi ed
il clarino de Il sogno della vipera), abiti sonori resi insospettabilmente preziosi dal contributo fondamentale di Rodrigo D’Erasmo, Alessandro Fiori, Enrico Gabrielli, Lornzo Corti e Roberto Angelini tra gli altri.
Nel mezzo, la fatamorgana orchestrale di Elon lan ler, registrata a Skopje in occasione di un documentario sul “funambolo del palcoscenico” macedone Frane Milenski Jezek.
Le coordinate poetiche sono indocilmente sperse, raggrumandosi più spesso attorno a suggestioni
Leonard Cohen (la toccante Questa notte l’amore a Catania) e Fabrizio De André (Sette spade, Lo scroccone di Cioran), spiriti guida di quello spirito sempre più terrigno e imprendibile che risponde al nome
di Cesare Basile.
(7.5/10)
Stefano Solventi
che il disco è fatto bene e frizza anche, ma non sembra
segnare particolarmente il suo tempo, quanto semmai
farsi segnare dal suo tempo, e hai fatto la recensione.
Bibio mette sullo sfondo (li usa come intarsi, vedi Feminine Eye) le sciccherie seppiate della folktronica boardsiana di Ambivalence e si accoda, con stile, nel mettere a fuoco l’estetica glo (proprio mentre uno come Toro
Y Moi sta andando tanto indietro nella sua hauntologia da distaccarsene, puntando praticamente al jazz).
Ne viene fuori un lavoro più massiccio e più electro/
elettro (addirittura elettro-rock, se Take Off Your Shirt è
un numero consapevolmente tamarretto che schitarra
alla Celebrity Skin). C’è il glitch/wonky (Artist’s Valley), c’è
l’ambient ondosa (della title track), c’è l’elettronica tastierosa vitrea e scampanellante (Saint Cristopher), ma
c’è soprattutto un funkysoul dinoccolato, giocoso (K for
Nelson è praticamente una walking song da cartoon
Disney) e agrodolce (particolarmente immersa in una
dolente e compiaciuta malinconia teen la bella More
Excuses), condito con quei falsetti sporcati sussurrati ed
echizzati che ben conosciamo.
Un lavoro meno firmato, meno personale, adattivo, sicuramente godibile ma che, appunto, più che aggiungere qualcosa, in una qualsiasi misura e con qualsiasi
giudizio, sembra essere esso stesso il semplice frutto di
una furba e ben condotta operazione aritmetica.
(7/10)
Gabriele Marino
Biscuits - Biscuits (Black Needle, Marzo
2011)
Genere: hip hop
“Uàn cciù trì metereopàtici emsì”, i biscotti sono tre e si
chiamano Tripla, Gransta e Dyna (Gianluca Vitiello, Marco Villa e Claudia Di Martino), tre rapper napoletani con
tante esperienze alle spalle (anche e soprattutto extra o
para-musicali; Gianluca, per esempio, conduce un programma su RadioDeejay) che si sono incontrati a Milano. Biscuits è il loro debutto con questa ragione sociale.
Basi electro/funk meticce e rappati tra dialetto e italiano, comunque con un forte accento, il tutto buttato sul
divertimento e anche piuttosto ballabile, con i numeri
migliori che fanno passare in secondo piano quelli meno
riusciti (The Moon, ID), tra scazzo (ma niente depressione,
tutto molto dinamico e fluido in Metereopatici MC), cazzeggio al limite del demenziale (ma comunque “contro”,
Ciu Ciu), contestazione vera e propria (Fortapasc) e - soprattutto - escapologia del quotidiano (il singolo di lan39
cio Exit, Astronauta e minatore, Ritardi e traguardi, forse il
pezzo migliore), con forti richiami ai suoni, alle cadenze
e in generale al mood delle Posse anni Novanta.
(5.8/10)
Gabriele Marino
Blown Paper Bags - Back To Square Three
(Marsiglia Records, Febbraio 2011)
Genere: synth-punk
Dopo una gestazione decisamente d’altri tempi - concepimento nel 2007 e realizzazione a fine 2010 - i Blown
Paper Bags tornano in pista con un album che riattiva
la sigla ormai attestatasi a terzetto e ripensa dalle fondamenta il proprio suono.
Synth punk e krauti a colazione, tendenza al groove
profondo, melodie vocali in alternanza male/female.
Pezzi-bomba che tracimano p-funk schizoide, postpunk bianco e nevrastenico, teatrale synth-punk tra
Blood Brothers sotto metadone e Talking Heads /
Cure da cabaret vittoriano (Intimacy Shield).
Con almeno un paio di pezzi memorabili (Topless Meeting rielabora la Francia bastarda delle banlieu in un
frullato di electro post-moderna con la faccia rivolta ad
oriente, e Body=Temple che si offre come l’unica reincarnazione plausibile dei B-52’s nell’era post-DFA) è
questo il concentrato che i tre mettono sul piatto: musica non originale ma energica, sentita, spinta e creativa, che rielabora e ricicla, cita e stravolge senza timori
reverenziali nè citazionismo spicciolo.
Morale: fare musica per se stessi, lontano da scadenze, impegni o cartellini da timbrare stancamente, vale
molto più in termini di credibilità di tanto altro.
(7/10)
Stefano Pifferi
Boris Savoldelli - Biocosmopolitan (Moon
In June, Marzo 2011)
Genere: vocalese
Un paio d’anni son passati dal buon Protoplasmic ed
è tempo per Boris Savoldelli di tornare ad esalare il suo
vocalese sempre più duttile e dinamico. Nel nuovo Biocosmopolitan, terzo lavoro solista e secondo per la
benemerita etichetta newyorkese Moon In June, il quarantenne bresciano sbriglia la sua tipica rielaborazione
assieme cerebrale e divertita di topoi jazz, gospel, soul
e funk, mettendo in mostra una vena mai tanto black e
groovy. Il tutto ovviamente strutturato sulla voce - stratificazioni a cappella, scat e beatbox - col prezioso aiuto
del bassista Jimmy Haslip nella title track e della tromba di Paolo Fresu in Concrete Clima e Kerouac In New
York City.
40
Le quattordici tracce del programma sono un’immersione ubriacante nell’arte gioiosa e a tratti geniale di
Savoldelli, una zona franca dove le coordinate si smorzano e confondono, s’impastano idiomi e s’incrociano
forme (afro, blues, hip hop, pop, psych, musical...) con
l’obiettivo di escogitare forme d’intrattenimento che
stemperino suggestione, leggerezza e profondità. L’impeto luminoso quasi The Who di Lovecity, quella specie
di Beatles in orgasmo Weather Report di Disarmonia
ed il Quartetto Cetra spedito a New Orleans del singolo The Miss Kiss sono i momenti migliori di una scaletta
deliziosa.
(7/10)
Stefano Solventi
Bright Eyes - The People’s Key (Saddle
Creek, Febbraio 2011)
Genere: pop rock
Da Conor Oberst siamo abituati ad attenderci di tutto.
Quattro anni dopo il buon Cassadaga, album di sostanziale impronta cantautorale, l’entità Bright Eyes torna a
mostrare il lato più estroso col lavoro lungo numero nove
The People’s Key. Il programma si apre con una lunga
intro recitata da Denny Brewer - chitarrista dei Refried
Icecream e grande amico di Oberst - intento a spiegarci
la sua visione delle cose in merito al rapporto tra alieni
e Storia. Così, tanto per capire dove andremo a parare.
Ovvero, dalle parti di una folleggiante fregola wave-psych-pop, appassionata e beffardella, forse metaforica ma
anche patafisica, a cavallo di melodie sì carezzevoli però
col piglio obliquo di chi cova un irriducibile sconforto.
Si prenda il singolo Haile Selassie, tipo gli Smiths come
li rifarebbe Brian Eno, oppure la baldanza New Pornographers riprocessata Sufjan Stevens di Triple Spiral, i
R.E.M. immersi in un ipercromatismo Xtc di A Machine
Spiritual, o ancora quella Shell Games che guizza adrenalinica tra civetteria Patrick Wolf, enfasi Arcade Fire,
spasmi The Who e tutto uno sbocciare di synth come
usava fare il buon Eddie Van Halen.
Fermo restando l’elemento umano indolenzito del
canto, le dieci tracce sembrano voler giocare con la capacità assieme affabulatoria, ipnotica ed euforizzante
del power-pop, i cui codici vengono liberamente mischiati con modalità post-wave in modo da rendere
l’impasto il più brioso ed accattivante possibile. Eppure
non smetti di avvertire un’angoscia di fondo, la consapevolezza di guardare le cose dall’interno di un immaginario ormai esausto, incapace di interpretare/rappresentare la tumultuosa gravità dei tempi. Viene perciò
da leggere questa disperata effervescenza come una
reazione all’impasse espressivo, sensazione palpabile
highlight
Cut Copy - Zonoscope (Modular, Febbraio 2011)
Genere: 80s pop, house
Il terzo album del duo Cut Copy porta a completamento il disegno di 80s pop innestato di groove ed
elettroniche citazioniste iniziato nel 2001 con l’eppì I Thought of Numbers.
Zonoscope segue il fortunato In Ghost Colours (del 2008) e come riportato da Dan Whitford a Pitchfork, il
combo ha cercato di favorire la componente ripetitiva, ipnotica e ritmica, ripescando le attitudini che i
Midnight Juggernauts (australiani pure loro) avevano tentato di sfruttare
per il boom con il loro irrisolto The Crystal Axis. In pratica, roland, drum machine e altre sintetiche old skool (tra groove e quattro quarti in bassa battuta) sono diventati gli arrangiamenti ritmici prediletti di un caleidoscopio
pop intelligentemente (post)post(quante volte volete)moderno.
A inizio anni dieci, i ragazzi bazzicano ancora addobbati con lustrini dagli
svagati riferimenti arty (Talking Heads, Xtc, Paul Simon, il David Bowie berlinese) ma lo fanno come se questo fosse l’ultimo album pop 80 ad essere
stampato sul pianeta terra, come se non ci fosse domani direbbe qualcuno. L’immaginario è ricostruito attorno a inappuntabili strutture melodiche (a tratti ricordano anche
i Field Music) e rotondissimi arrangiamenti in continuum tra synth, space, disco, etno, old techno e
house, psych, funk, soul e, perché no, un pizzico di big beat (Where I’m Going).
È il sincopato sintetico a farla da padrone, ma è soprattutto l’assimilazione della lezione Hercules And
Love Affair (la dance di New York innestata appunto di pop), e l’approccio live ereditato dai fasti di
gente come gli Empire Of The Sun a fare di Zonoscope ben più di una risposta agli hitmaker rivali dei
Duemila, Peter Bjorn And John in testa.
Similarmente al Living Thing degli svedesi infatti, il quartetto rinuncia all’hit di pronto consumo per una
polpa scintillante e variegata, in un album vacanziero-around-the-world-definitivo fin dall’iniziale Need
You Now. A fine scaletta troviamo infine le vincenti Hanging Onto Every Heartbeat e Corner Of The Sky e
fuori programma tra motorik e space disco intinta Kraftwerk come Alisa e Sun God. Lo splendido colpo
di coda della decade che rivisse gli ‘80.
(7.2/10)
Edoardo Bridda
fin dall’iniziale Firewall, dove un arpeggio à la Kurt Cobain finisce in una fatamorgana popadelica ed etnofunk che non spiacerebbe agli Iron & Wine. Idem dicasi, anzi con maggiore evidenza, in Ladder Song, dove
t’immagini Moz e Stipe abbracciati in una cameretta
alla fine del mondo, così come nella languida Approximated Sunlight, che non sfigurerebbe nel repertorio
degli ultimi Flaming Lips col suo afflato orchestrale, il
country-soul traslucido ed i miraggi sintetici.
Malgrado la sostanziale assenza di colpi di genio - Stevens e i Lips sono su un altro pianeta - e una certa prevedibilità melodica, The People’s Key è disco di buone e
diverse vibrazioni, dove ombre e luci stanno sulla stessa
faccia di una medaglia insospettabilmente affilata.
(7.1/10)
Stefano Solventi
Buffalo Tom - Skins (Scrawny, Marzo 2011)
Genere: american indie
Fu un ritorno di quelli graditi assai Three Easy Pieces, che
nel 2007 riportava i Buffalo Tom sulle scene e a livelli di
forma inattesi. Non mancava nulla, colà: armonie alla
Big Star, sentimento in buccia d’elettricità chitarristica,
soprattutto quel respiro malinconico e nel contempo
liricamente esaltante così importante per certe frange del primo emocore. Ci sentivi il peso dei ’90 che ne
fecero dei grandi e che per l’occasione permetteva di
rinascere, di offrire magia sostanzialmente inalterata e
scrittura come al solito di valore. Scriviamo “come al solito”, però ricordando che talvolta ai bostoniani qualche
ciambella senza buco usciva anche nel periodo d’oro;
che lo Smitten posto a sigillare il primo scioglimento
era la loro cosa peggiore.
41
Sono umani, del resto, e comunque gli è superiore
Skins, alla regia il solito Paul Kolderie e ospite la concittadina Tanya Donnelly nell’aggraziato country acustico Don’t Forget Me. Sicurezze che vanno di pari passo
con la novità di un’edizione deluxe ovviamente limitata con demo e b-side senza aspettare i canonici dieci/
venti anni. Così va il mercato e così se vanno tre quarti
d’ora, tra momenti in cui prevale il mestiere e una bella
manciata di fulgidi bagliori (le innodiche The Big Light e
Guilty Girls; la crepuscolare Out In The Dark e la straziata
Arise, Watch; una Down che rimarca certe affinità con
gli Afghan Whigs e il country-rock metà Dylan e metà
Stones The Hawk & The Sparrows), tra appannamenti e
cose gradevoli però marginali (The Kids Just Sleep: gli
Weezer che riscrivono Green). Tra alti e bassi, in fondo,
scorre anche la vita di ognuno.
(6.8/10)
Giancarlo Turra
Butcher Mind Collapse - Night Dress
(Bloody Sound Fucktory, Febbraio 2011)
Genere: noise-rock
I reietti delle Marche marce sono cresciuti. La All Star
Band della regione più rumorosa dell’ultimo quinquennio (Jonathan Iencinella, voce; Riccardo Franconi,
chitarre, synth; Nicola Amici, chitarra, sax; Giampaolo Pieroni, pelli) torna con un secondo disco che è un
gran bel passo in avanti rispetto all’incompromissorio
debutto Sick Sex And Meat Disasters In A Wasted
Psychic Land.
L’irruenza sboccata dell’esordio e il background rumoroso ultra-citazionista covano arcigni sotto le ceneri, ma
si fanno più attitudine che cifra stilistica vera e propria:
il synth’n’roll circense e orgiasticamente horror-punk di
Complicity, il patchwork depravato di Killing A Fly With A
Sword o l’attacco panzer pienamente Unsane della title
track lasciano pochi dubbi al proposito.
Sono però le strutture e gli orizzonti a cambiare quasi drasticamente, facendosi più complesse, le prime, e
free, i secondi. Le jazzate aperture paranoiche sciolte
in estatici paesaggi di The Loss, il post-rock che guarda
ad oriente di Flameless Hell o lo sludge spaziale della
conclusiva Spiderwebs dicono di una personale ricerca
di vie altre, coraggiose e mai lineari, al rumore. Ricerca
spesso e volentieri centrata in Night Dress.
(7/10)
Stefano Pifferi
Caribbean (The) - Discontinued Perfume
(Hometapes Records, Febbraio 2011)
Genere: indie pop
Oramai veterani di una scena che non c’è, quella indie
pop di Washington DC, i Caribbean giungono con questo Discontinued Perfume alla quinta prova in un decennio. Quella di Michael Kentoff e soci è una vita da
non-musicista, quella tipica di tanti protagonisti della
musica indie, ma che raramente si ha l’occasione di
conoscere. In questo nuovo capitolo della narrazione
semi-autobiografica, Kentoff ci racconta che la mattina
si mette la sua bella camicia inamidata e si reca al lavoro a Georgetown, è sposato, ha dei parenti, dei gatti
e una lavatrice da riempire di tanto in tanto. Insomma
una vita normale, come quella che abbiamo tutti noi,
lontana dalle luci della ribalta di band cariche di hype
o dagli stereotipi degli artisti. La vita di Kentoff e degli
altri membri dei Caribbean assomiglia a quella della
persona comune, con in più una sola passione particolare: fare musica.
Che tradotto in note, significa pop sotterraneo e soffuso, caratterizzato dalla voce ovattata e sinuosa dello
stesso Michael Kentoff. Per il resto della strumentazione, piuttosto variegata e corposa, i singoli membri
della band si scambiano gli strumenti di continuo, in
un continuum che sa tanto del migliore artigianato.
Le coordinati di riferimento sono sempre le stesse: le
polaroid colorate dei Death Cab For Cutie e i Postal
Service con una spruzzata di Appalacchi. Ma il sound
dei Caribbean ama inerpicarsi su strade poco battute,
senza perdere in identità, e i testi si abbandonano a
un sano chiacchiericcio di ogni giorno (Thank You For
Talking To Me About Israel, Municipal Stadium), talvolta
immerso nell’attualità sociopolitica, come nel caso di
Artists In Exile: “le case sono vere/ e il giardino pure/ e
tutto sembra abbastanza carino da poter essere rubato” mentre qualcuno in segreto registra tutto su nastro.
Così assomiglia a una minaccia lo statement stampigliato nell’interno della copertina “respira e cerca di
rilassarti: siamo completamente soli”. Pop da musicisti
segreti, poco luminoso, ma avvolgente e genuinamente disturbante.
(6.5/10)
Marco Boscolo
Carlot-ta - Make Me A Picture Of The Sun
(Anna The Granny, Marzo 2011)
Genere: pop d’autore
Il primo disco lungo di Carlot-ta è un ottimo esempio
di come si possa mettere ordine in una giovinezza esuberante mandando a mente quanto di meglio il can-
42
tautorato femminile abbia prodotto negli ultimi tempi.
Tori Amos, Joanna Newsom, St. Vincent, ma anche le
nostre Mimes Of Wine e Beatrice Antolini, quest’ultima promossa a pieni voti da icona indie a modello
di riferimento (sospettiamo) per tutta una nuova generazione di “cantantesse” innamorate del pianoforte.
Oltre al piano, Make Me A Picture Of The Sun prevede archi, flauto, fisarmonica, rhodes, theremin, chitarra,
quasi tutto suonato dalla padrona di casa (Carlotta Sillano). Un esotico da camera costruito su voci spaziose
e strutture poco lineari, ben filtrato dalla produzione e
dagli arrangiamenti di Gianmaria Ciabattari e Gianluca
Cangemi (già al lavoro con profitto sul primo disco di
UnePassante).
Quel che si ascolta nella quarantina di minuti del disco
è fondamentalmente ciò che una nata nel 1990 ha pieno diritto di fare, ovvero una ricerca di contenuti che è
prima di tutto una ricerca di identità. Portata a termine
con buona perizia, qualche citazione illustre nei testi
(Baudelaire, Blake, Shakespeare), un serioso eclettismo
e la convinzione (condivisa dal sottoscritto) di essere
già sulla buona strada.
(6.6/10)
Fabrizio Zampighi
Carmine De Maria - Robot Kaard - The Love
Movement (Autoprodotto, Febbraio 2011)
Genere: beats, produzioni
Carmine De Maria, classe ‘85, è un produttore napoletano della cerchia AvantHopperz la cui iperattività
è testimoniata dall’aver pubblicato ben 10 dischi dal
2009 a ora (sono tutti in free download su vari canali),
prima come duo 2Cam, poi come solista a nome DMC,
J. Cardema e infine Robot Kaard. Carmine produce per
lo più strumentali (electro, funk, videogame, ambient,
influenze dubstep, ecc.) ma ha anche ospitato feat di
rapper, cercando sempre di coinvolgere qualche nome
della scena (su Overtime c’erano FedeDsm dei Planet
Soap e Mar Delle Blatte; su ElectroNapoli2, il suo lavoro più ambizioso, Zona Mc, Smania Uagliuns e
Helphetoz degli AlitoTetro). Il problema di Carmine è
che produce troppo e seleziona poco, col risultato che
i suoi pezzi sono spesso esercizi da producer, stilisticamente trasparenti (manca quello scatto in potenza e
personalità), magari curati sotto l’aspetto ritmico ma
totalmente disinteressati a quello melodico e alla creazione del brano come qualcosa di univocamente riconoscibile: non ci sono killer track e anche il concept
dietro ai dischi appare quasi sempre nebuloso.
The Love Movement non sfugge a questa regola, ma
si candida comunque a suo lavoro migliore finora, con
ottimi esercizi appunto (l’ipnotico breakbit jazzato di
Alfred; il funk madlibiano di Joy; l’electro scura e giocosa di Textures; il wonky “malacarne” di Robot Balbio,
davvero ottimo; il divertente doppio pedale iPhonato
dell’ossessiva Monster) e qualche pezzo inevitabilmente buttato lì (Goooood Morning, un po’ electro un po’
King Crimson; il collage psych della title track; le suggestioni ancora madlibiane di Dolphy Digital; l’atmosfera
sospesa di Tight). Carmine, come dice il pomodoro, stai
più concentrato.
(6/10)
Gabriele Marino
Carneigra - Fumatori della sera (,
Gennaio 2011)
Genere: folk, pop
Fumatori della sera, terzo album in studio per i Carneigra, è un perfetto mix derivativo eppure fresco di
cantautorato folk italiano. Prodotto e registrato ottimamente, il disco ripropone molti riferimenti eccellenti
della nostra musica d’autore: molto Vinicio Capossela,
qua e là il miglior Paolo Conte e Fabrizio De André
nell’incipit di L’acrobata. Non mancano riferimenti alla
musica popolare, quella greca e mediterranea in genere e un’esplicitissima citazione di Nino Rota nel brano
Click che ricorda nettamente alcuni temi delle colonne
sonore della filmografia di Fellini, non un caso considerando che Matteo Pastorelli, alla chitarra, militava negli
Snaporaz che devono certamente il loro nome al soprannome del protagonista di “Otto e 1/2”.
Fumatori della sera è senz’altro un lavoro riuscito che
ben si direziona, con l’uso di una strumentazione tipica
della musica popolare (mandola e mandolino la fanno
da padroni), verso una giusta modernizzazione di un
genere che tende a subire un po’ il peso del tempo.
Se un difetto va trovato a un disco come questo è una
certa tendenza ripetitiva delle ritmiche che finisce per
raffreddare i toni togliendo emotività a suoni che sembrano invece naturalmente nati per rappresentarla. La
reiterazione allontana l’ascoltatore, soprattutto distoglie l’attenzione dai testi e la sensazione è che ci siano,
in questi tre musicisti, le capacità per non cadere nel
tranello.
(6.5/10)
Giulia Cavaliere
Chaim - Alive (BPitch Control, Febbraio
2011)
Genere: house
Chaim Avital da Tel Aviv approda in debutto su Bpitch
Control con la sua house detroitiana tagliata di spezie
43
mediorientali. 13 tracce che non sconvolgono ma che
fanno il loro lavoro con onestà e passione certosina:
quella di chi ha nelle tasche la mano calda con boutades per le consolles del Panorama Bar o dei Fabric (posti in cui l’uomo si esibisce di solito).
Si va da accenni di balearica in progressione Novanta
(Runaway Voices) al tribalismo solare (Don’t Shout), dal
bel featuring in odore NY con lo chicchissimo vocal di
Meital de Razon (U & Eye) al dub solare della Thievery
Corporation (Love Rehab). Per decorare, ci sono anche
ammiccamenti al nu-rave DFA (Robots On Meth bel singoletto ballabile) e alla progressività in filtering per pareti strobo (Popsky).
Dopo le collaborazioni con Ruy Gerber il passaggio in
solitaria è d’obbligo. Alive vale l’ascolto per i clubbers
e anche per chi si sta infatuando delle nuove tendenze house, che dal quattro vanno all’indeterminatezza
e alla decompressione dell’ambient. Se volete vederlo
sarà presente alle celebrazioni del decennale della storica label tedesca.
(6.8/10)
Marco Braggion
Chapel Club - Palace (Universal, Gennaio
2011)
Genere: Wave, noir
Lo scorso marzo parlavamo di come act à la Two Door
Cinema Club, Big Pink e Delphic avessero spostato la
lancetta delle produzioni UK verso un altrove ancora
nebuloso ma dai contorni piuttosto chiari. Dalle chitarre garage e, in generale, dall’estetica r’n’r più o meno in
bassa fedeltà, evidenti erano i segnali verso un sound
corposo, stratificato, potente e - perché no - moderno.
Di quale modernità stavamo parlando lo scopriamo ora
nei The Joy Formidable e soprattutto in questi Chapel
Club. Due formazioni che arrivano quasi contemporaneamente all’esordio e che nel range Ottanta/Novanta
puntano il dito decisi verso il secondo polo.
La sintetica che si ascolta nelle loro tracklist è una questione di rivedere le chitarre alla luce della rivoluzione
che cambiò per sempre il rock di quegli anni, il suono
My Bloody Valentine. Ci si rinnova con un suono shoegazey (Ride), magari sull’eco delle recenti produzioni Interpol e soprattutto Editors, e lo si fa per dare un
contorno di forza e magnificenza a liriche di converso
angeliche e spirituali, in cerca di nuovi intimismi.
Nei giri di basso e in qualche strofa, i legami con il postpunk si sentono ancora. In particolare, nei londinesi
Chapel Club: il crooning è una faccenda smithsiana
(Fine Light), d’amore per i classici della celluloide, dai
richiami fifties, che se a tratti ha del rockabilly di certo
44
Billy Idol in serenata (The Shore) deve molto di più, se
non tutto, agli Echo & the Bunnymen.
Venendo all’esordio, Palace, come The Big Roar del
terzetto del Welsh, ha innanzitutto un’eccellente produzione. Merito di Paul Epworth che di contaminazioni
tra chitarre e sintetiche se ne intende (Bloc Party, Florence And The Machine) e dell’abile intreccio di queste con i suoni più vintagisticamente rock. Il resto ce
lo mette una band con un buon gusto melodico e arrangiativo. Magari ancora in cerca di una personalità
forte, eppure vestita inappuntabilmente degli intrecci
chitarristici di Alex Parry e Michael Hibbert e dell’affascinante crooning di Bowman che dei Chapel Club è
front man, lyricist e ideatore del brand (in fissa con tematiche religiose pare).
Nella tracklist troviamo singoli indie-a-porter funzionali all’hype (O Maybe I, la cover ‘modificata’ Dream A Little
Dream Of Me intitolata Surfacing), ed episodi dal buon
afflato e costruzione melodica come Five Trees (che si
posiziona dalle parti del McCulloch più efficace) e Blind
(ancora i Bunnymen romantici). I mezzo, altri buoni
scatti (After The Flood dalle tese trame psych e intimismi Coldplay) e senz’altro una ballata da ricordare (The
Shore). Non il vero e proprio colpo al cuore. Allo stesso
tempo: un buonissimo esordio.
(7.1/10)
Edoardo Bridda
Cloud Nothings - Cloud Nothings (Wichita
Recordings, Febbraio 2011)
Genere: power-pop
Ennesimo virgulto cresciuto a pane, cameretta e mp3,
Dylan Baldi from Cleveland è il responsabile unico dietro la sigla Cloud Nothings e rinnova il trend del bedroom lo-fi pop d’ordinanza di questi ultimi anni.
C’è però nel self titled una bella sterzata rispetto alla
solita tiritera ormai quasi nauseabonda fatta di isolazionismo posticcio e cessofonia indotta. Memore del
post-indie made in Olympia, della attitudine slacker
più tradizionalmente americana (alla Guided By Voices, per capirsi), dei rigurgiti seattleiani più aggressivi (Dinosaur Jr più che Pavement a giudicare da Not
Important) e di un senso evidentemente british nella
spinta melodica (vedi alla voce Smiths per pezzi come
Heartbeat o gli incastri chitarristici di You’re Not That
Good At Anything) il ragazzetto mette su un disco di solare power-pop niente male. Tutto melodie sghembe e
iper-catchy, scazzo giovanile mai sopra le righe, poppunk sgrezzato, vitaminico e velocizzato che va giù tutto in un sorso solo e si fa ricordare ben oltre la esigua
mezzora del disco.
highlight
Dirty Beaches - Badlands (Zoo Music, Marzo 2011)
Genere: 50s’n’roll madness
Riecheggiano pesantemente i Suicide più bluesy e martoriati nell’incipit di Badlands: Speedway King
è un macilento, straniante e industrial-oriented blues che riesuma la sofferente voce di Alan Vega e la
cala in un cabaret infernale e fumoso di scorie post-industriali.
L’ambiente ideale, dopotutto, perché Alex Zhang Hungtai, l’unico uomo
dietro Dirty Beaches, è un crooner e di quelli maledetti: ciuffo ribelle, nuvole di fumo di sigaretta e immaginario fifties ben saldo in testa. Rockabilly
d’impianto di base e cinematico nelle atmosfere, Dirty Beaches arriva al debutto lungo dopo una serie sterminata di pezzi piccoli, cd-r e tapes, segno
di un apprendistato lungo e sofferto. Proprio come le sue musiche e le sue
struggenti storie di spaesamento e disperazione.
Il bello è che in pratica suona sempre la stessa canzone: ritmicamente ossessiva grazie ai loop della drum machine, lo-fi nelle offuscate coltri di rumori ambientali, voluti o meno, anni cinquanta (stravolti) nelle melodie. Eppure il surf r’n’r di Sweet 17,
il reiterato pop fifties sporcato di rumori di Hundred Highways, la malinconia in bassa battuta di True
Blue o Lord Knows Best, per non parlare delle horrorifiche visioni di Black Nylon o Hotel - vero e proprio
immaginario stuprato da middle-class americana - sono piccole gemme di uno dei segreti meglio custoditi d’America. A voi scoprirlo, prima che sia troppo tardi.
(7.4/10)
Stefano Pifferi
Con un buon 90% di potenziali singoli Baldi/Cloud Nothings è il più serio candidato al trono della decadente
stella di Wavves, anche se siamo sicuri che verremo
contraddetti dalla prossima next-little-thing proveniente da qualche garage della provincia americana.
(6.9/10)
Stefano Pifferi
Cocoon - Where The Oceans End (Sober &
Gentle, Marzo 2011)
Genere: country/folk pop
Morgan Imbeaud e Mark Damail sono compagni di
viaggio al termine di tutti gli oceani, compagni di cammino musicale e di vita. Una delle classiche coppie che
affollano il mondo del folk-pop internazionale, facendo dell’intreccio delle voci maschili e femminili uno
dei tratti dominanti della loro musica (leggasi alla voce
‘Richard e Linda Thompson’). A dispetto della norma,
Morgan non ha la voce sottile e delicata di molte sue
colleghe, ma una timbrica più profonda e rotonda, per
cui capita che in alcune canzoni, come nella movimentata e divertente Dee Doo, infarcita anche di fiati, sia lei
a condurre le melodie principali mentre Mark si dedica
al controcanto in falsetto. Altrove, invece, come nella
delicata Super Powers si invertono i ruoli e si ristabilisce
la forma più tradizionale.
Where The Oceans End, il secondo disco per il duo
francese, si avvale della collaborazione di Dickon Hinchliffe dei Tindersticks, fatto che mostra quanto il
successo della prima prova li abbia proiettati in una
posizione di primo piano in Francia (centomila copie,
specie di questi tempi, non sono certo poche) e che
dona all’insieme raffinati arrangiamenti cinematografici. Il secondo album mette ancora di più a fuoco le radici tra Appalacchi e Midwest del loro sound, che non
disdegna di guardare alla Grand Bretagna dei Fairport
Convention e dei Pentagle, e trasfigura il tutto in un
un folk-pop moderno che sa tanto di Sufjan Stevens
quanto di Devendra Banhart. Nei brani più upbeat,
ovvero sostanzialmente la prima parte della scaletta,
da Sushi a Mother (dove appare anche il tocco à la Ben
Harper), le cose funzionano a meraviglia. Non altrettanto bene la seconda metà della scaletta, più monotonamente adagiata su torch song e ballad, che se mescolate agli altri brani avrebbero probabilmente reso di
più. Così si tende a ricorrere al tasto skip.
Problemi di scaletta a parte, il vero unico limite che ci
sentiamo di imputare al duo è una pronuncia inglese
che talvolta sa di pecoreccio. Per il resto bisseranno il
successo del primo disco, ma a dispetto delle intenzio45
ni non sembrano avere i muscoli per uscire dal giro folk
e sfondare definitivamente anche fuori dai patri confini.
(6.8/10)
Marco Boscolo
Com Truise - Cyanide Sisters (Ghostly
International, Gennaio 2011)
Genere: Synth, 80s, glo-fi
Analogico vintage Settanta e sensibilità retrò Ottanta sono ormai poco più che un infausto cliché a causa
della quantità di progetti che da più di un anno e mezzo rilanciano l’hype a tutto spiano. Il caso Com Truise si
è però rivelato singolare, non tanto da un punto di vista
creativo, quanto per la fervida vena di producer che ha
destato parecchi consensi e drizzato non poche orecchie (Pitchfork per ultimo).
Se la ristampa di Cyanide Sisters (i sette pezzi originali dell’estate scorsa più quattro bonus track) fornisce
l’occasione per approfondire la storia di Seth Haley,
dapprima dj, passando per vari progetti paralleli (Sarin
Sunday, SYSTM, Airliner), infine in odor di successo
grazie ai remix delle hit di Twin Shadow e Neon indian, è al producer/remixer che noi guardiamo.
In tutte le produzioni sound design e architettura sono
superiori alla media: dalla soundtrack hollywoodiana ai
New Order fino all’alt-funk e alle immancabili sonorità
liquide new age, Seth ne sa quasi quanto James Ferraro e i remix di Castles In The Snow e di Sleep Paralysist
ne evidenziano l’abilità nel gioco di sponda: dai vezzi
new wave alle camerette infestate da allucinazioni settantine.
L’ep oltre a ciò ha tutto il sapore del sunto: dancefloor,
bandane, Festivalbar random, videogiochi e vocoder.
Haley è un cultore del genere e con la materia preferita è pulito e rigoroso. Anche troppo. Del resto, la lente
glo-fi si è ormai cicatrizzata e il pozzo senza fondo è un
buco nero da cui non si esce vivi, come diceva qualcuno. Sette e mezzo al producer e sei e mezzo al disco.
Si fa la media, in attesa del full-lenght che uscirà nei
prossimi mesi.
(7/10)
Francesca Marongiu
Cult Of Youth - Cult Of Youth (Sacred
Bones, Febbraio 2010)
Genere: Western Folk
Secondo capitolo su lunga distanza nella giovane discografia del newyorkese Sean Ragon, dopo l’esordio
A Stick To Bind, A Seed To Grow su Dais di due anni fa
esatti. Per sancire l’entrata nell’ormai sconfinato roster
46
Sacred Bones, l’organico si allarga a quattro elementi
fissi, col fondatore sempre dietro a microfono e chitarra
acustica, coadiuvato ora da sezione ritmica e violino.
Come già si paventava da alcuni episodi del mini Filthy Plumage In An Open Sea! il gruppo di Brooklyn
si lascia quasi interamente alla spalle i toni angusti del
classico folk-apocalittico (fa eccezione la sola Lorelei), e
sterza vigorosamente verso polverose terre di frontiera
western (è un caso che il pezzo che apre Cult Of Youth si
chiami New West?). Niente più ballate brown&grey alla
Death In June, ma un nuovo sound tribale e guerriero,
assai più prossimo a David Eugene Edwards che a Douglas Pearce, che alterna il country irruento di Monsters
alla seraficità crepuscolare di Waery passando per paesaggi lunari come l’immagine di copertina (The Lamb)
e le coralità solenni di The Pole-Star.
E se le nuove versioni di Cold Black Earth e Lace Up Your
Boots non rendono pienamente giustizia alla rabbia degli originali, è proprio per il significativo cambiamento
di rotta apportato. Bisogna guardare avanti.
(7.2/10)
Andrea Napoli
Daniele Brusaschetto - Fragranze
Silenzio (Sincope, Marzo 2011)
Genere: cantautorato avant
Abbandonate da un paio di album le asperità neo(post?)-industrial noise che nella loro efferata crudezza
ne limitavano il raggio d’azione, il lungocrinito chitarrista italiano è ormai padrone di muoversi all’interno di
un più ampio raggio di possibilità senza che per questo
a perderne sia l’omogeneità di fondo della propria poetica o la ricerca sonora.
La personale via al cantautorato di Brusaschetto trova
in Fragranze Silenzio una perfetta equilibratura tra le
due anime dicotomiche e conflittuali che lo sottendono. Da un lato, quella delicata, romantica, in punta di
corda e/o sussurro, quasi solare verrebbe da dire, che si
manifesta sotto forme astratte e post-moderne: siano
essi i fruscii da glitchtronica concreta (Ali Di Mosca), la
bossanova disturbata di Cauterization, il pop minimale e strumentale di Fiori Finti. Dall’altro, quella oscura
e minacciosa, risvolto dai contorni dark di ogni animo sensibile che assume le forme malinconicamente
struggenti di Clouds o quelle mostruose della conclusiva title-track: un monolite drone-metal in modalità
sludge sfiancante e estatico.
Su tutto, una forma di lirismo personale e dal retrogusto amaro, che procede per lampi di pura poesia esistenzialista e flash introspettivi di un intimismo palese.
Se per i Bachi da Pietra di Non Io bisognava “perdere
gli occhi per poter vedere”, nell’apocalisse casalinga e
intima di Brusaschetto (casa mia, per quanto ti odi sei
il posto dove voglio stare, da Fragranze Silenzio) l’unica
possibilità è che “bisogna saper perdere, bisogna sapere come perdere” (Raccontamelo Come Fosse Una Favola). Mai come stavolta però a vincere è Brusaschetto,
mosca bianca e gioiellino da tener da conto.
(7.4/10)
Stefano Pifferi
Deaf Center - Owl Splinters (Type Records,
Febbraio 2010)
Genere: doom ambient
I gufi non sono quello che sembrano. Vecchio leitmotiv
che aggiungeva mistero al mistero, in quella girandola
impazzita che era la seconda stagione di Twin Peaks.
Erik K. Skodvin e Otto A. Todland si ritrovano sotto il
segno del gufo, a comporre di nuovo insieme dopo che
un’intera stagione è passata via come se niente fosse,
visto che sei anni separano l’atteso ritorno dall’illustre
primo disco dei Deaf Center, lavoro che può ormai dirsi,
a tutti gli effetti, di culto.Il gusto un po’ macabro di lasciare che l’attimo si stiracchi fino allo spasimo è il tratto dominante del nuovo disco. Dopo sei anni era poco
probabile che l’abile duo norvegese ci fornisse un sequel sulla falsariga del predecessore. Owl Splinters rivela qualità opposte a Pale Ravine. Tanto quest’ultimo
era affidato ad un’elettronica sparsa e brumosa, tanto il
nuovo lavoro fa delle timbriche acustiche il motivo del
suo fascino, forte com’è della produzione di lusso a firma Nils Frahm. Questione di duelli ideali tra i due. Erik
al cello si è perfezionato negli anni, facendosi le ossa
con la maschera di Svarte Greiner, Otto invece suona le sparute note di piano con la cadenza esistenzialista dell’ultimo sopravvissuto tra i malinconici cultori
di Satie.Come è facile intuire, la qualità monocroma e
grigiastra di Pale Ravine qui si perde, perché la musica nasce giocoforza dal contrasto tra i due autori. Si
ottiene così un lavoro che purtroppo lascia per strada
buona parte della malinconia che aveva reso celebre
il marchio Deaf Center, in favore di una vera e propria
svolta horror doom che nei frangenti principali (New
Beginning (Tidal Darkness), The Day I Would Neer Have,
Close Forever Watching) li fa rimare con il Murcof di Cosmos. Stesso clangore atmosferico, stessa propensione per la tensione drammatica. Tutto il resto ragiona di
scenografie di contorno. Timidi lieder malinconici per
piano (Time spent, Fiction Dawn), crudi bozzetti di una
dark ambient ormai calligrafica (Animal Sacrifice).In definitiva un disco con qualche qualità e molte perplessità. La mano forte rimane quella di Skodvin e il taglio
d’insieme al disco lo dà evidentemente lui, ma a questo punto con un po’ di delusione potremmo semplicemente dire che questo Owl Splinters altro non è che un
disco di Svarte Greiner più morbido e rifinito.
(7/10)
Antonello Comunale
Death Of Anna Karina (The) - Lacrima /
Pantera (Unhip Records, Marzo 2011)
Genere: post hc / noise
Ancora una volta il passaggio ai testi in italiano rappresenta uno spartiacque. Ciò che era accaduto agli Zen
Circus di Andate tutti affanculo e implicitamente al Teatro degli Orrori, accade ora agli emiliani The Death
Of Anna Karina, che in Lacrima / Pantera toccano
l’apice del proprio percorso di crescita adottando la
lingua di Dante. Quasi si trattasse di un nuovo punto
di equilibrio per materiale che dell’equilibrio stesso è
sempre stato un po’ il contraltare, post-hardcore fulminante ai tempi dell’omonimo esordio del gruppo, postpunk virato noise in New Liberalistic Pleasures e assalto
sonico di scuola At The Drive In ora.
L’impressione è che proprio l’esempio del Teatro degli
Orrori, quel conciliare contenuti e chitarre lancinanti
con un recitato strafottente e incurante della metrica,
abbia fatto scuola. Sdoganando tra i fautori delle sonorità più heavy l’idea che far convivere velocità, spigoli e
italiano sia non solo possibile, ma quasi un atto dovuto.
Soprattutto se a raccogliere c’è un pubblico ricettivo e
attento, come testimoniano i sold out collezionati dalla
band di A Sangue Freddo nell’ultimo tour italiano.
C’è margine, insomma, e i TDOAK ne sono consapevoli.
E pur non avendo lo stesso spessore semantico di un
Capovilla, riescono comunque a sintetizzare una poetica personale e uno stile riconoscibile. Innescando un
meccanismo virtuoso che porta la musica ad adattarsi
al nuovo approccio vocale e il cantato ad abbandonare
le isterie del passato in favore di una maggiore linearità.
Una formula che, filtrata dal buon lavoro in appoggio
di Giulio Ragno Favero, Giovanni Ferliga e Giovanni
Versari, convince in pieno, come dimostrano anche il
tappeto di distorsioni di Gli errori e di fronte a noi il nulla,
la cavalcata in odore di psichedelia di Strumentale o il
punk-hardcore contaminato della conclusiva Vile Omicidio.
(7.2/10)
Fabrizio Zampighi
47
highlight
Devotchka - 100 Lovers (ANTI-, Marzo 2011)
Genere: roots/folk
Mamuthones - Mamuthones (Boring Machines, Marzo 2011)
Genere: avant-rock
La novità più grossa è indubbiamente che Mamuthones non è più un solo-project, bensì una band
al completo, anche se il progetto rimane appannaggio di Alessio Gastaldello. L’ingresso di Marco
Fasolo(l’uomo dietro Jennifer Gentle e amico/collega di vecchia data) alla chitarra e della vecchia gloria
Maurizio Boldrin alla batteria ne allarga, però, gli orizzonti e fornisce nuove ed interessanti vie di fuga.
Dal folk esoterico virato kosmische degli esordi ad una più varia e corposa
interpretazione di un rock lisergico, ipnotico, posseduto e a tratti ossessivamente violento, il passo può sembrare breve ma il compierlo in maniera
esauriente e soddisfacente è cosa per pochi.
Mamuthones vi riesce alla grande, giostrando con retaggio del passato - Ota
Benga, Kash-o-Kashak o Ave Maria, (ri)prese da Sator o MJ74 concepito e registrato da Boldrin nel 1974 (!) - e spirito nuovo, dimostrando capacità sperimentali fuori dal comune nella rielaborazione del concetto stesso di musica
psichedelica e aprendosi ad una nuova indagine interiore. Senza tagliare
i ponti col passato o rimuovendo una parte del proprio essere (i liquidi passaggi dell’esplicativa A New
Start, l’esoterismo witchy dell’opener The Call, gli stessi svolazzi raga di MJ74 stanno lì a conservare la propria memoria, il proprio passato fatto di atmosfere esoteriche e lande di suono nero-pece); quanto spingendo piuttosto sull’acceleratore ritmico. Incendiando quelle lande angosciose e oscure che ne hanno da
sempre contraddistinto l’operato, aprendosi a forme più umane (bestiali) e materiche, carnali e tangibili,
pagane e ataviche, come nei fragorosi tour de force ritmico-ossessivi di The First Born o Ota Benga.
Mamuthones svela l’ennesimo suo volto travisato dalle maschere folkloriche sarde e offre a noi poveri
mortali il picco più alto della sua pur eccellente produzione.
(7.5/10)
Stefano Pifferi
Desolate - The Invisible Insurrection
(Fauxpas Musik, Gennaio 2011)
Genere: post-garage, ambient
Non è più tempo di rivedere le principali lezioni prealla luce di un nuovo importante tassello nel continuum UK Bass. A un lustro abbondate dalle manipolazioni soniche dubstep, agli Untrue e ai A Mutual Antipathy,
sono subentrate produzioni smarcate, ibride e luminose, in cerca di nuovi equilibri e occhi di riguardo verso
istanze e tool differenti.
Con Mount Kimbie e James Blake, avevamo evidenziato come laptop, campionamenti, pianoforte e un’estetica deformata ma diurna, fossero state pratiche liberatorie quanto efficaci: da una parte, tagliavano il cordone
ombelicale con le frange scure dei club (Benga, Pinch
ecc.), dall’altro, aprivano alle contaminazioni arty.
Post-soul e il garage Burial-iano sono gli spunti dai quali
Sven Weisemann, ovvero Desolate, riprende un discorso
che ha fatto storia. Lo fa appunto con lo sguardo smaliziato di chi frequenta gli stessi luoghi elettroacustici e
nel contempo ha frequentato i tanti salotti buoni di Ger48
mania (dance e non dance) nei quali piano e manipolazioni elettroniche si sono sposati tante e più volte.
The Invisible Insurrection ne è il raffinato risultato. Il primo album lungo ad essere pubblicato sulla Fauxpas
Musik di Amburgo, label che aveva inaugurato proprio
con lui (Heroic Death EP) giusto un anno fa, vede Weisemann come il perfetto esempio di Burial nel 2011.
Peccato per Burial che ancora tace.
Molto bene per uno come lui che lo brucia sul tempo
cogliendo le evoluzioni sopracitate e coerentemente si
riconduce all’approccio “suonato” di Xine (Wandering,
2009), tolto quasi del tutto degli aspetti ambient techno-dub lì presenti, e addizionato dell’ambient-soul del
ragazzo misterioso (più campionamenti vari e manipolazioni laptop).
Il cuore narrativo si riconduce a un soffusa quanto
superficiale melanconia ambient. E’ il lato debole di
un’operazione di notevole sintesi e capacità tecniche
però. Un ottimo artigianato.
(7.1/10)
Edoardo Bridda
Il loro attimo di notorietà i quattro polistrumentisti di
Denver (Colorado) che rispondono al nome collettivo
di Devotchka lo hanno avuto nel 2006, quando firmarno alcuni brani della colonna sonora di un film, Little
Miss Sunshine, che si è guadagnato una visibilità internazionale per certi versi inattesa. Con 100 Lovers arrivano al traguardo del loro quinto long playing senza
che la formula sia davvero mutata. Quello che si nota è
un avvicinamento al modo di amalgamare voce e strumenti che ricorda l’ultimo lavoro degli Arcade Fire. Ma
questo, sebbene debba essere sottolineato, non tragga in inganno: stiamo pur sempre parlando di musica
a base gitana, balcanica, caraibica e spagnoleggiante.
Anzi, a volte queste influenze sono talmente forti che
anche le parole cantate da Nick Urata assumono sfumature esotiche e, talvolta, inintelleggibili.
Si comincia con una marchetta in crescendo, The Alley,
adagiata su un letto di archi sognanti per proseguire
con l’eco Arcade Fire che dicevamo di All The Sand In
All The Sea e The Common Good (ma basata su di un
hanclapping in stile flamenco). In mezzo, gli strumenti
in reverse della stoppata One Hundred Other Lovers, che
sa di Field Music al loro meglio. The Man From San Sebastian è tango-rock, mentre Bad Luck Heels è musica
mariachi in salsa europea.
L’ultima fatica della band è un giro del mondo sonoro
in dodici movimenti che lascia stupiti per la padronanza con cui i Devotchka parlano tante lingue musicali,
ma che può far venire il mal di mare a chi avvicini a 100
Lovers senza aver ben allacciato le cinture di sicurezza.
(7/10)
Marco Boscolo
Disappears - Guider (Kranky, Marzo 2011)
Genere: psych-kraut
Riattiva alla memoria l’immaginario hard psichedelico
inglese di fine anni ’80 il comeback dei Disappears. Tutto quel sottobosco di rockers duri in fissa con la psych più dilatata e le ossessive reiterazioni kraute - dagli
Spacemen 3 ai Loop fino ad arrivare agli Hair & Skin
Trading Co. - sembrano convenuti al sabba orchestrato dall’ex 90 Day Men Brian Case (voce e chitarra) in
combutta col chitarrista Jonathan van Herik, il bassista
Damon Carruesco e il dimissionario drummer Graeme
Gibson. C’è lo stesso gusto per ambientazioni postindustriali seppur con le debite distanze: l’Inghilterra
tatcheriana dei sobborghi post-crisi era molto più deprimente e oscura rispetto alle lande da cui provengono i quattro ceffi qui presenti.
Fatta salvo questo lieve scarto, gli strumenti in mano ai
Disappears e i risultati non sono poi dissimili da quelli messi in atto ormai quasi un ventennio addietro da
Loop et similia. Ossessività e reiterazione, distorsioni
chitarristiche e drumming incessante, bassi groovey
e atmosfere claustrofobiche, trance indotta a furia di
procedere ipnotico: questi gli ormai ben noti ingredienti dispensati a piene mani in Guider e che pongono il quartetto americano sullo stesso piano di altri
sbandati americani, drogati di kraute ossessività come
Moon Duo o Wooden Shjips. Certo poi che un pezzo
come Revisiting, 16 minuti di ipnosi spossante e urbane
allucinazioni alla maniera dei krauti più drogati, rimette
profondamente in pace col mondo in disgregazione.
(7/10)
Stefano Pifferi
Discodeine - Discodeine (Pschent,
Febbraio 2011)
Genere: nu-french touch
Benjamin Morando aka Pertile e Cédric Marszewski aka
Pilooski: il primo (già Octet) era nel giro Diamond Traxx
dello storico Benjamin Diamond che con gli Stardust
ha definito il revival balearico (quella Music Sounds Better With You cui sappiamo essere stato uno dei punti
di svolta fondamentali della carriera Daft Punk). Il secondo ha militato e risiede tutt’ora su DT ma collabora
anche con Eddyee’s Theme e C. Denner.
Assieme sono i Codeine, già avvistati con Jarvis Cocker su DFA e con il fido Mathias Aguayo nelle rispettive track Synchronize eSingular, ora il debutto con
quest’omonimo dall’incatalogabile fascino: balerina
80s giocattolo (vedi qui il ricordo dell’ultimo Munk),
effetti sintetici da studio (Relapse), visione slo-mo Air
(D-A in combutta con Baxter Dury), ritmica minimalworld in stile DFA (Falkenberg), quattro techy più classico (Antiphonie, Ring Mutilation), progressività (Homo-Compatible) e uno stipendo finale che ricorda lo
stupore di Luciano (Figures In A Soundscape).
Dopo il lavoro di Agoria, questo disco è l’ennesima
uscita dai binari french touch che mantiene un piglio
soggettivo e credibile e che conferma così una distanza
feconda dalla (ormai) old-school di Busy P e soci. Pregevole anche l’iconografia delle copertine à la Gustave
Doré. Un disco che per la sua capacità di non ancoraggio a coordinate troppo monolitiche sarà apprezzato
sul lungo periodo. In odore di top. Bravi.
(7.3/10)
Marco Braggion
49
highlight
Marco Parente - La riproduzione dei fiori (Woland, Marzo 2011)
Genere: canzone d’autore
Materia sfuggente, la musica di Marco Parente. Suoni che devono respirare, sedimentare, nella speranza che il loro modo di vedere il mondo prima o poi diventi anche il nostro. E’ stato così fin dagli esordi e il qui presente La riproduzione dei fiori non fa eccezione. Declinando i soliti testi antitetici in intrecci
strumentali dal passo irregolare e affezionati a un’etica libertina di matrice
jazz che è anche rock, canzone d’autore e molto altro.
Cinque anni fa il binomio Neve ridens 1 / Neve ridens 2 rappresentò uno
scatto in avanti sul versante della credibilità e dell’autorevolezza per un
artista maturo e per nulla spaventato dalla sperimentazione. Il qui presente La riproduzione dei fiori assomiglia invece a un trait d’union tra il pop
allargato di Trasparente e la complessa contemporaneità del musicista
napoletano. Complessa, perché non rinuncia nemmeno in questa occasione a confezionare un ideale rebus, tra punti di riferimento solidi (il binomio
voce-chitarra de Il diavolaccio, le malinconie immediate della title-track, gli archi Beatles/Nick Drake
arrangiati da Robert Kirby di Sempre) e rimandi che sembrano veri e propri salti nel vuoto. Quelli che
si colgono da alcune citazioni piuttosto radicali (i Rolling Stones di Sympathy For The Devil adottati da
una funkeggiante L’omino patologico, l’elettricità di una C’era una stessa volta che fa le pulci alla Hurricane di Dylan o i Radiohead posti in chiusura de La grande Vacanza) e da certe scorribande stilistiche
vorticose (DJ J) comunque in linea con l’ingorgo concettuale ed estetico tipico di Parente.
Il risultato è un disco dal carattere scontroso, ma solo in apparenza. Perché alla fine Marco è ancora uno
di quelli che riesce a rendere credibile anche la carne viva, oltre che un musicista capace di dettare i
tempi a chi gli si avvicina. Aiutato in questo da collaboratori prestigiosi come Andrea Allulli, Andrea
Angelucci, Emanuele Maniscalco e Asso Stefana, bravi nell’interpretare nella maniera migliore l’aliena eleganza della scrittura parentiana.
(7.5/10)
Fabrizio Zampighi
DJ Rashad - Just A Taste (Ghettophiles,
Gennaio 2011)
Genere: Juke, Ghettotech
L’avevamo già sentito nelle varie compilation di footwork e in un singolo lungo su Mu-ziq (Itz Not Rite) che
prometteva bene. DJ Rashad torna con la sua spezzettata teoria di tracce in visibilio per il breaking, il
pitchshifting e le beatbox, e prosegue la strategia del
suddetto esordio, cioè ’osare’ con la varietà in un genere che sembra fatto solo ed esclusivamente per ballare
e che quindi riduce la musica a mero strumento tecnico.
Qui il cut-and-paste diventa una malattia infarcita di
voci angeliche (Ghost), percussioncine spastiche da
beatbox (Make It Happen), il cool jazz soul degli anni
Sessanta (We Run It), samples di Gil Scott-Heron (I’m
Gone) e di Bobby Caldwell (Ghetto Tekz Runnin It), il
funk UK più tirato e sporco (You Azz) e l’epifania cosmic
blues (Love U Found, I’m Gone).
50
Un piacevole e necessario ripensamento di un genere che sembrava essere nato già per implodere su se
stesso, e che invece con personaggi come Rashad ci fa
intravedere un futuro pieno di cose da dire e da mixare.
Il ragazzo da Chicago si accosta con questo suo full ai
lavori che hanno definito il genere di DJ Roc e DJ Nate,
prendendo la via del soul sulla sua neonata etichetta
Ghettophiles. La sacra trimurti del Chicago Juke è così
formata. Adorateli.
(7.3/10)
nici. E’ un genere di percorso che a quanto pare fa gola
a molti, come testimonia ad esempio l’ultimo Tapes
N Tapes, ma che difficilmente porta risultati incisivi,
e infatti entrambi gli album hanno lasciato i rispettivi
gruppi in un limbo: le aspettative dei fans sono state
disattese e al contempo i riferimenti cui si tendeva non
sono stati raggiunti.
Ora esce No Color, quarta prova per il duo californiano,
e subito traspare l’ammissione di questo passo falso e
la volontà di recuperare: nella cartella stampa non si
fa alcun riferimento al disco precedente e ci si affretta
invece a nominare John Askew, già produttore dei primi due dischi e qui nuovamente in console. Certo non
possiamo dire che questa mossa sia sufficiente a tornare indietro davvero: la freschezza delle prime due prove sembra persa definitivamente in luogo di un profilo
più alto. Semplicemente stavolta ci si rivela abili ad approfittare dello status raggiunto per contemplare una
gamma di possibilità più ampia, mentre sottotraccia si
recupera in parte la formula magica che fece da ponte tra la vecchia scuola folk di un John Fahey e quella
contemporanea dei Fleet Foxes (Don’t Try And Hide It e
Don’t Stop).
Ecco allora ancor più di prima le chitarre elettriche a
declinare riff sulle armonie acustiche di Meric Long
(Black Night); e a mescolare ulteriormente le acque
ecco chiamata in causa nientemeno che Neko Case, i
cui cori spingono qua e là in direzione Canada: inevitabilmente la Vancouver dei suoi New Pornographers,
ma forse ancor di più la Montreal degli Arcade Fire,
soprattutto nei momenti in cui il drumming si fa meno
brioso e più cadenzato. Un suono generale più ricco di
prima, insomma, ma pure l’impatto energico che ricordavamo, quelle tentazioni melodiche puntualmente
stemperate da serratissime fughe strumentali (Going
Under), la voglia genuina di divertirsi applicata a un linguaggio fortemente personale sul piano delle liriche
così come degli arrangiamenti: i marchi di fabbrica dei
Dodos, che oggi sposano un’autentica voglia di rinnovamento. Siamo di nuovo sui binari.
(7/10)
Simone Madrau
Marco Braggion
Dodos (The) - No Color (Wichita
Recordings, Marzo 2011)
Genere: Indie-pop
Avevamo lasciato i Dodos alle prese con il produttore
Phil Ek (Built To Spill) e con la svolta di Time To Die: un
album che prendeva le mosse dal fingerpicking cristallino di Visiter per avvicinarsi a modelli ‘indie’ più cano-
Ducktails - Ducktails III: Arcade Dynamics
(Woodsist, Febbraio 2011)
Genere: hypna-pop
A piccoli passi Matt Mondanile aka Ducktails, affermatosi come uno dei migliori interpreti del recente trend
tropical-hypno-pop, si va smarcando dall’etichetta che
lo ha consacrato. La sua musica resta strettamente legata ai paesaggi evocati, tra canzoni da spiaggia, no-
stalgie surfiste, tramonti on the road chitarra alla mano,
ma uno slittamento percettibile sembra far svanire
quell’aura di sporca vaghezza e indeterminatezza in lofi che la contraddistingueva.
L’album, infatti, è un insieme di composizioni brevi,
spari da due minuti o poco più in cui la chitarra di Mondanile scorazza libera e ispirata sul versante sixties-pop:
siano esse beach song dal riff scanzonato quanto efficace, immerse in coretti mid-80s alla Real Estate (Killin’ The Vibe), piccoli capolavori pop in stile Guided By Voices, arrendevoli nella propria semplicità (Art Vanderlay)
o assolate coralità da spiaggia (Don’t Make Plans).
Il passato non si dimentica né si rinnega, ovviamente. I
dieci minuti di chitarre impastate tra strilli di gabbiani
e fruscii filtrati dalla spirale di una conchiglia sono l’emblema hypnagogic dell’universo Ducktails, solo che
l’hic et nunc di Mondanile è molto più messo a fuoco
sul versante delle songs e l’immaginario scivola in secondo piano.
(7/10)
Stefano Gaz
Dum Dum Girls - He Gets Me High (Sub Pop,
Febbraio 2011)
Genere: Indie Rock
Un ep che suggerisce molte considerazioni, quello in
questione, ancor prima di addentrarci nei suoi contenuti musicali.
Kristin Gundred (aka Dee Dee) in posa da star sulla copertina. Pensiero #1: sono passati i tempi della foto sfocata rubata dall’album di famiglia (sembra infatti che la
donna intenta a rovistare nell’armadio che campeggiava sulla cover di I Will Be, fosse la madre della cantante). La normalizzazione aggredisce innanzitutto il lato
estetico del progetto.
Pensiero #2: per quanto si sia parlato “delle” Dum Dum
Girls, e la Grunded abbia intrapreso il recente tour con
una formazione affiatata che anche in fatto di look
vantava una compattezza degna dei Ramones (ma con
molto più glamour), il progetto resta affar suo. Sebbene le aspirazioni crescano a dismisura.
He Gets Me High è il definitivo sdoganamento dell’ex
generazione lo-fi di questo primo scorcio di secolo.
La title track è semplicemente il miglior brano inciso
dall’artista, sotto ogni punto di vista: dai suoni perfettamente bilanciati fra pulizia sonora e lucentezza delle
chitarre noisy, alla melodia che rappresenta il mix ideale di innocenza 60s e cuor di tenebra post punk.
Take Care Of My Baby ribadisce il concetto aggiungendo una buona dose di romanticismo e pompa spectoriana. L’apertura di Wrong Feels Right è forse meno con51
vincente ma altrettanto efficace.
La sorpresa sta tutta nella quarta traccia: la cover di
There Is A Light That Never Goes Out degli Smiths testimonia una discendenza poetica che si sarebbe potuta
intuire, ma che in questa occasione viene ribadita con
un’interpretazione senza fronzoli, che coglie l’urgenza
e lo spirito esistenzialista del pezzo originario.
Un ep luminoso, dal primo all’ultimo secondo, il cui
unico limite è la breve durata.
(7/10)
Diego Ballani
Dustin O’Halloran - Lumiere (Fat Cat,
Marzo 2011)
Genere: strumentale
Dall’Arizona, passando per le Hawaii e per Los Angeles
fino ad approdare a Ravenna e a Berlino: questo il lungo percorso di Dustin O’Halloran, dal 1996, con Sara
Lov, fondatore dei Devics e dal 2004 - anche - music
maker in solo. Un disco sospeso, onirico, questo nuovo Lumiere, arrivato dopo Piano solo vol. 2 del 2006,
qualche soundtrack (ricordiamo la partecipazione
all’OST di Marie Antoinette di Sofia Coppola), e Runner
del 2007.
Un album dove non si dimenticano le grandi citazioni,
da Chopin a Debussy passando per Satie e Sakamoto senza che si lascino da parte le tensioni alla musica
classica contemporanea e, in primis, a una nuova modalità, più completa e stratificata, di concepire l’orchestrazione. In suo aiuto c’è l’ensemble ACME, già, tra gli
altri, con Owen Pallett, Grizzly Bear e Matmos.
Figlio di una lunga gestazione - più di tre anni - Lumiere
sta alla musica come la luce, appunto, alle immagini,
ricordando una candela capace con il tremolio del suo
barlume, di illuminare l’incontro tra spazi sonori antichi
e nuovi. La perla? Quintette n.1.
(7/10)
Giulia Cavaliere
Dwayne Omarr - Multi Funk (Rephlex,
Gennaio 2011)
Genere: Space funk
Non occorre essere addetti ai lavori dello space funk o
di certo vocoder r’n’b primi Ottanta per conoscere ogni
singola sfumatura del suono del bostoniano Dwayne
Omarr. Lui è sicuramente un ghost writer, un producer
per cultori del suono Giorgio Moroder quali Daniele
Baldelli, Daft Punk, Dam-Funk o Squarepusher, eppure la sua musica, grazie a loro, e alla cultura mediatica che li ha preceduti, è patrimonio di tutti. Riascoltarlo oggi con il primo album a suo nome grazie
52
a una Rephlex archelogica e affamata del suono delle
origini pre-IDM, è dunque un assoluto piacere. Multi
Funk non è propriamente una raccolta di inediti, anzi
rappresenta una compila di vecchi successi degli 80s
(This Party’s Jam Packed, Save The Children, Breakdown
New York Style, Mr. Gigolo) e qualche nuova track very
old fashioned, in pratica, un tuffo nei primi Ottanta
della grande mela, un monumento alla r’n’b robotica
con tastiere e drum machine primo Prince e Madonna,
sincopi e scratch à la MC Miker G & DJ Sven (quelli di
Holiday per capirci), claps old skool, luci strobo, e una
tonnellata di robot vocal funkato che è il vero marchio
di fabbrica dell’uomo.
Indispensabile per chi voglia scoprire l’origine di ogni
funk electro contaminato e altrettanto imperdibile per
chi, in epoca wonky e sound retrò, voglia fregiarsi di
qualche citazione di lusso.
(7.2/10)
Edoardo Bridda
Electric (The) - Life Is Moving (Organically
Grown Sounds, Marzo 2011)
Genere: soul, hip-hop
DJ Vadim ritorna dal tour del suo ultimo U Can’t Lurn
Imaginashun con due voci nella manica: il rapper chicagoano Pugs Atomz e la soulness inglese di Sabira
Jade. Dopo il successo in giro per il mondo, il DJ ha
voglia di formare un supergruppo. Presto fatto, dato
che già a novembre scorso avevamo sentito il loro singolo Beautiful. Oggi esce il full, un disco, secondo Daddy Vad, che “ha in sè elementi di hip-hop, soul e musica
elettronica, ma che per me suona come hip-hop fatto in
maniera innovativa”.
Ovviamente la matrice street non può mancare: le
tracce sono state registrate e pensate on the road, in
camere d’albergo, in macchina e in aereo. Un disco
che ritorna al vecchio amore di Vadim per il soul, viene
pubblicato ’in casa’ per la sua neonata etichetta Organically Grew Sounds (che per ora ha nel suo roaster Yarah Bravo) e che spazia con un suono classico tra lascivi
ammiccamenti (Overloaded), giochini di synth (Electric
Company) basi ultrablack (il funk Settanta di So Now
You Know) e atmosfere da struscio soul pompate con
bassi giocattolosi, decorati con i classici catenoni dorati
e con gli sculettamenti d’ordinanza. Il gioco di dialogo
tra i due pupilli incolla ancora di più l’idea del maestro,
formando una melassa compatta, che si lascia ascoltare senza soluzione di continuità e che si può ricollegare
alle esperienze del neo-soul di Andreya Triana e della
cricca now Ninja Tune (label su cui Vad ha stampato più
di qualche album memorabile).
Quei leoni che a volte ritornano (vedi su altri lidi la rinascita di Wagon Christ) e riportano suoni e atmosfere
d’antan a galla. E noi che ci accorgiamo di come ogni
tanto abbiamo bisogno di certezze. DJ Vadim c’è, per
fortuna sempre vivo e vegeto. Respect Vad, guys.
(7/10)
Marco Braggion
Eternal Tapestry - Beyond The 4th Door
(Thrill Jockey, Marzo 2011)
Genere: psych
Ne parlavamo come di una band dall’immaginario
space-primitivista in occasione del precedente The Invisible Landspace. Ora, passati dalle etichette di culto
Digitalis e Not Not Fun alla prestigiosa Thrill Jockey, i
tre di Portland sembrano darci ragione. L’incipit del comeback infatti si intitola Ancient Echoes ed è nulla più
di quello che potete immaginare: lontani, ancestrali
echi di psichedelica soffusa tra chitarre che cinguettano e tappeti ritmici da raga per un immaginario da
pieno trip ’60/’70.
Non è questione di singola canzone però. È il senso del
tutto a connotare Beyond The 4th Door come un unicum di psichedelica morbida e vellutata, impreziosito
anche dall’uso del sax. Fatta eccezione per l’epica heavy di Galactic Derelict - meno dirompente delle ambientazioni kraute del precedente, ma pur sempre una
bella botta di psych spacey a volumi pieni - l’album si
muove su continui rimandi floydiani, visionarie evanescenze da contorni sfocati (Reflections In A Mirage) e increspature ambientali tra corde pizzicate e dilatazioni
ipnotiche (Time Winds Through a Glass, Cleary).
Molto meno corposi e cosmici che in passato e più
radicati ad una visionarietà terrena e deserticamente materica, Dewey Mahood (chitarra) e i fratelli Nick
(chitarra e voce) e Jed Bindeman (batteria) mettono da
parte l’irruenza e puntano sui dettagli per oltrepassare
le porte della percezione.
(6.9/10)
Stefano Pifferi
Eveline - αω (Sonic Vista, Marzo
2011)
Genere: psych-wave
Terzo album in sei anni per i bolognesi Eveline, e il
mistero s’infittisce. Ascolti questo brodo apocalittico
Low, la fregola psichedelica Doors e l’estro art-wave
vagamente Stranglers, non manchi di intercettare capricci insidiosi Afghan Whigs, cori ectoplasmatici Sigur Ros per poi atterrare in un dolce tedio glitch, ed è
comprensibile uscrine senza una fisionomia precisa, le
coordinate poetiche e atmosferiche irrimediabilmente
sfalsate. Sai solo che in qualche modo le otto tracce di
αω sono riuscite a farti fare il giro di giostra.
E non senza effetti speciali: come le vibrazioni desertiche rimbalzate fino al cielo di Omega, il teatrino tra
il brechtiano e l’acido di Last Time at Alpha Centauri, la
suite ieratica e schizofrenica di Terrible n.1 e - appunto quella Lunar 8 che spedisce i Mùm in un’orbita geostazionaria - ohibò - quasi Nick Drake.Ti resta una sensazione strana, come aprire un cassetto pieno di oggetti
apparentemente scollegati e scoprire che in qualche
modo sono riusciti a sviluppare una connessione, a
raccontare una storia. Come leggere un libro costruito
scozzando pagine di libri già letti e trovarlo incredibilmente congruo, stranamente sensato.
Chi siano davvero gli Eveline, cosa vogliano fare da
grandi, è questione secondaria fintanto che lo spettacolo d’arte varia sarà tenuto assieme dal filo sottile ma
tenace della convinzione.
(7/10)
Stefano Solventi
Ex-Otago - Mezze stagioni (Autoprodotto,
Marzo 2011)
Genere: pop
Il terzo disco degli Ex Otago fissa alcuni punti importanti: il primo è che la formazione genovese ha ormai
raggiunto una cifra stilistica riconoscibile e a suo modo
esemplare; il secondo è che i testi in italiano di questo
Mezze stagioni funzionano quasi meglio di quelli in inglese del precedente Tanti saluti; l’ultimo è che chiedere al gruppo qualcosa che vada oltre la leggerezza
pop scazzata e in bilico tra synth estivi, coretti e chitarrine sincopate significa spersonalizzarlo.
Gli Ex Otago sono questi, prendere o lasciare. Dei Beach Boys involuti, dei buskers mancati, una band legata a un immaginario indie da loser che macina una
quotidianità ironica (Patrizia, Una vita col riporto) e una
sincera sensibilità alla costante ricerca della perfetta
melodia pop. In conclusione tutto funziona come dovrebbe e chi ha apprezzato la produzione passata della band non faticherà a trovare nuovi spunti anche in
questo disco. Finanziato, tra l’altro, con un progetto di
azionariato popolare senza precedenti in Italia che ha
coinvolto direttamente i fans.
(6.7/10)
Fabrizio Zampighi
53
Exploding Star Orchestra - Stars Have
Shapes (Delmark Records, Settembre
2010)
Genere: freejazz
È sufficiente concentrarsi sulla ragione sociale Exploding Star Orchestra per capire dove ci accompagna
oggi Rob Mazurek - ma anche dove ci ha sempre condotto. La stella esplode, e noi guardiamo il big bang,
parte di una platea che non può che essere interessata
dalla portata cosmica dell’evento. L’esplosione non è
affidata tanto a prime voci, a protagonisti, ma è disseminata coralmente nella collettività di un’orchestra.
Non possiamo che pensare a Sun Ra, non nel sottotesto ma nel testo stesso della musica. Mazurek aveva
probabilmente questo obiettivo in testa, quando ha
deciso di chiamare così il combo multiforme. E Stars
Have Shapes, doppia sottolineatura della questione, è
il compimento del fine.
Conosciamo fin troppo bene il talento sconfinato di
Rob nel saper creare con la musica dei mondi interi, se
non rappresentazioni di universi. L’Exploding Star Orchestra, nella maturità più estromessa dal tempo che
si possa pensare, procede mettendo a frutto una capacità che le sembra innata, ossia la tenuta di uno stato
d’animo. Sulla lunga durata come sulla breve. La prima
traccia (i venti minuti di Ascension Ghost Impression no.
2) è l’apoteosi del free jazz, un flusso libero, una destrutturazione supersonica che scatena una grande cacofonia patemica, in realtà scientifica come fosse elettroacustica. Questo è il nuovo mondo di riferimento
che vediamo mostrare i muscoli sotto le briglie sciolte
del jazz. È la composizione, il Novecento, la “colta” che
prende forma nella complessità delle partiture apparentemente del tutto libere. L’altro brano lungo (Three
Blocks of Light) è ancora un viaggio astrale, ma a diversa velocità, una lunga scia decostruita con micro-suoni
avanguardistici.
Non esiste più la pertinenza locale, né l’antropologia di
Chicago come un modello di mondo musicale. Come a
dire che un’era è finita, e che la Exploding Star Orchestra - comunque chicagoana per organico e definizione - fa a meno di un luogo preciso per dialogare con la
classicità contemporanea, e con uno stile irresistibile.
(7.4/10)
Gaspare Caliri
Fergus & Geronimo - Unlearn (Hardly Art,
Gennaio 2011)
Genere: indierock, punk
A cavallo tra il garage punk e il rock’n’roll puro, i texani
Fergus&Geronimo sanno ben distinguersi dalla massa
54
di prodotti beachpop.
Colpisce di Unlearn la capacità di spiazzare l’ascoltatore spingendosi verso direzioni inattese: in Wanna know
what I would do? in mezzo a tanto istinto punk & roll ci
trovi il Bowie della trilogia berlinese o il primo David
Byrne, qua e là s’affacciano, tra una ballata e un inserto di world music (Where the walls are made of grass), il
primo Elvis Costello (Powerful lovin’), Richard Hell (Michael Kelly) e uno a scelta tra quei cantanti di fine anni
‘50 da milkshake on the road (Unlearn).
Talvolta stonati e spesso nostalgici e onirici nel sound,
i Fergus & Geronimo, con questo nome da cartoni animati e le inquietanti maschere indossate nella foto in
copertina, hanno anzitutto il pregio dell’inconsueto e
dell’eterogeneità della proposta.
Un ellepì distante da tutto quello che l’indie - tra più o
meno fortunate imitazioni dei Beach Boys - ci sta donando in questi ultimi tempi.
(7.4/10)
Giulia Cavaliere
Found - Factorycraft (Chemikal
Underground Records, Marzo 2011)
Genere: Indie
Dimmi con chi vai e - all’incirca - ti dirò come suoni.
Compagni di palco e merende della Phantom Band, gli
scozzesi Ziggy Campbell (voce, chitarra), Tommy Perman (basso, synth) e Kev Sim (percussioni, elettronica)
possiedono piglio acuto studenti di scuola d’arte, ma al
contempo irridono i vacui intellettualismi con la faccia
tosta di chi s’appoggia spesso e volentieri al bancone
del pub. Lo capisci al volo nei loro gustosi sberleffi che
spruzzano di tecnologico avant-garage una new wave
venata d’obliquo pop e viceversa: grossomodo i DNA
di Wire e Maximo Park, di Art Brut e Supersystem
shakerati in laboratorio per la gioia dei sostenitori della
melodia subdola e gli amanti della ricerca sonora.
Tipi non banali, avrete inteso, dotati d’efficace senso
della misura e che forse ci stanno prendendo in giro
(gli inizi da collettivo nelle gallerie d’arte, un “robot
emotivo” di loro invenzione Cybraphon che ha interessato BBC e CNN
). Anche fosse, poco importa alla luce
di due lp e svariati singoli di pregio consegnati in un
paio d’anni, perché rimarrebbe tutto un hype se la loro
personalità spigliata e schizoide non regalasse Every
Hour That Passes (Young Marble Giants felici ed ebbri
di malto) e Blackette (melodia irresistibile, passo di ballata disturbata), Shallow (gemma in furente però leggiadro volo tra Sheffield e Manchester) e Johnny I Can
Walk The Line (i James ridotti all’osso e alle prese con
un folk girato space-rock).
highlight
Martial Canterel - You Today (Wierd, Febbraio 2011)
Genere: synth-wave
Si nutre dello stesso marziale lirismo dei cantori del folk apocalittico made in England, il newyorchese
Sean McBride aka Martial Canterel. Come un novello Douglas P - si ascolti la conclusiva For Us col declamato stordente e enfatico di mr. Death In June, per farsi una idea - si staglia
algido e fiero sulle ceneri dell’esistente imbastendo un disco di synth-wave
ben al di sopra della media dell’attuale revival.
Metà Xeno & Oaklander e agitatore della prima ora nel sottobosco electro
dark-wave della grande mela, McBride ruba il nome al protagonista del
Locus Solus di Raymond Roussel e i suoni all’ala più gloomy e minimale
della cold-wave e di quella meno ossessiva ed electro-oriented dell’ebm.
Fa tutto da solo, Martial Canterel, con grazia ed eleganza: ipotizza canzoni
insieme ballabili e malinconiche, dalle atmosfere oscure e impenetrabili,
ossessivamente robotiche ma dal cuore innegabilmente umano. Proprio
come le opere del suo omonimo narrativo. Procede in modalità visionaria e strettamente analogica,
stratificando visioni e suoni intorno ad un concept sulla “crescente difficoltà nel connettersi con persone reali”. Ha una filosofia forte, un immaginario ben delineato e una visione d’impatto. Soprattutto,
nessuna remora nel manifestarle.
Immaginate un cantautorato al limite dell’esistenzialismo ma impiantato in un retro-futurismo dal sapore amaramente dark e avrete You Today. Le atmosfere create dall’uso di synth datati, “carcasse di un
futuro fallito”, e l’immaginario evocato fanno della musica di Martial Canterel una delle più originali e
sincere visioni distopiche su un futuro mai manifestatosi.
(7.5/10)
Stefano Pifferi
Canzoni che paiono palline di vetro (I’ll Wake With A Seismic Head No More schizza e si rifrange incontenibile,
la sardonica You’re No Vincent Gallo, una Machine Age
Dancing pastello e sghemba) gettate per farci cadere
con un sorriso di soddisfazione. Canzoni che v’invitiamo a scoprire perché i Found sono ragazzi, dunque c’è
da capirli e non da caricarli di responsabilità. Parafrasando quei giovani XTC coi quali hanno più d’un punto
di contatto, anche questo è pop. E meno male.
(7.3/10)
Giancarlo Turra
Frankie & The Heartstrings - Hunger
(Wichita Recordings, Marzo 2011)
Genere: Brit rock
All’appello del new wave revival mancavano ancora i
suoni scabri della Postcard (se si esclude il colpo di fulmine dei quasi dimenticati Hatcham Social: una rondine che evidentemente non ha fatto primavera).
Ora arrivano Frankie Francis e i suoi Heartstrings a
metterci una pezza. A partire dalla produzione, affida-
ta all’ex Orange Juice, Edwyn Collins, Il quintetto del
Sunderland non fa certo mistero della propria discendenza spirituale. Il “suono della giovane Scozia” funge
da punto di partenza per un guitar pop sovraeccitato a
colpi di jingle jangle d’assalto, romantico e gentile ma
tutt’altro che oleografico.
Frankie è finalmente un performer di razza come non
se ne vedeva dai tempi di Brett Anderson, ha un look
vagamente rockabilly e una voce che modula in sinuose melodie blue eyed soul.
La chiave di lettura di Hunger sta tutta lì, in quei 50s
edulcorati e cromati da una lucente produzione 80s.
Photograph, ad esempio, parte a razzo per aprirsi ad
avvincenti stacchetti doo wop.
Ungrateful riprende il chitarrismo mercuriale di Josef K
e Orange Juice, su cui, il crooning di Francis, appiccica
una della melodie più romantiche dell’album. Possibilities è un divertentissimo Elvis finito a Glasgow a duettare con gli Aztec Camera.
C’è anche il tempo per la citazione scherzosa di That
Postcard, a riprova di un’attitudine scanzonata che fa
55
degli Heartstrings uno dei nomi più freschi e promettenti del nuovo indie rock britannico.
(7/10)
Diego Ballani
Gay Beast - To Smithereens (Skin Graft
Records, Marzo 2011)
Genere: Android math
La passione per gli Hella e per quel mondo antitetico
alla sintesi si sente ancora molto, in To Smithereens.
Eppure, rispetto a Disrobics e Second Wave, c’è più
pensiero, nel sound del terzo album dei Gay Beast.
Per quanto il tachimetro non accenni a scendere dalla
zona rossa, le atmosfere sono meno frenetiche, le idee
musicali - specie nel lato B - appaiono pretendere che
si dia loro una forma riconoscibile prima che il delirio
strumentale le spazzi via per sempre. La quasi titletrack (Smithereens) fa persino baluginare gli Animal
Collective e una certa pasta di studio che non passa
necessariamente dalla pasta tutta live-oriented degli
strumenti che suonano in contemporanea.
Se To Smithereens è classificabile come la Third Wave
della Bestia, essa è comunque catastrofica e apocalittica come la wave di San Francisco di fine Settanta
(Chrome è il nome da spendere) e compressa in granate prog che il reparto artiglieria del math cervellotico ha insegnato a costruire. Collage è ancora, dopo sei
anni, la parola chiave dei Gay Beast. Un taglia e cuci improvviso - improvvisato?, dato che la band dichiara di
comporre tracciando dei segni ritmici e dei grafi su un
foglio. Una materia di chitarra tastiere drumming non
sempre facile da seguire, decostruito come le chitarre
di US Maple, spesso incapace di sedimentarsi nelle
orecchie.
L’unico appiglio cognitivo è il grezzume estetizzato da
synth e punk androide, in mezzo al flusso. Si rischia che
l’etica di composizione, che lascia una sensazione di
stordimento inevitabile, in un tale coacervo arrangiativo, resti come unico ricordo. Ciò che riesce meglio ai
Gay Beast è mantenere invece la tensione, l’attenzione,
ed è con la personalità di alcune opzioni di timbro che
questo accade (We Keep Our Victims Ready). Su tale terreno, i Gay Beast lasciano gli Hella per strada, e puntano
a un immaginario deciso (musicale e visivo), necessario
per gli intenti attivisti che propugnano.
(7/10)
Gaspare Caliri
56
Germanotta Youth - The Harvesting Of
Souls (Wallace Records, Febbraio 2011)
Genere: grind-techno
È un catalogo non ragionato delle musiche estreme
quello messo in atto dai tre Germanotta Youth. Tutto
istinto, cuore e coglioni, The Harvesting Of Souls è un
concentrato di blast beats, techno madness, grindcore
afono e hardcore impazzito sempre in bilico tra umano
e meccanico, analogico e digitale.
Massimo Pupillo (basso), Andrea Basili (batteria) e Reeks (synth e sampler), geniali sin dal titolo nel riecheggiare l’operazione sonicyouthiana sul corpo vivo del
mainstream (allora Veronica Ciccone aka Madonna,
oggi Stefani Joanne Angelina Germanotta conosciuta
ai più come Lady Gaga), mostrano di saper trafficare
con rumore e ironia. Titoli come Honey Bee Dapopulation Syndrome o A Closer Look Into The Mind And Soul Of
Pope Benedict XVI dicono di sfuriate strumentali degne
di Locust, Melt Banana e Phantomsmasher o, per
rimanere a casa, Inferno virati universo electro postclicks’n’cuts: ovvero, grind’n’roll senza voce e technologia debordante e devastata. A volte i ritmi rallentano
e la visione si dilata verso forme synth-sludgey inquietanti e malsane (Blackfriars Bridge), potenziale via di
fuga per sviluppi futuri.
Da dove vengono è evidente, anche nei curriculum
personali; dove vogliano andare è ignoto. Di fatto resta
una mezzora di devastazione strumentale in modalità
elettrochoc, a volte fine a se stessa.
(6.8/10)
Stefano Pifferi
Gil Scott-Heron/Jamie xx - We’re New Here
(Young Turks, Febbraio 2011)
Genere: dubstep
I’m New Here aveva riproposto un Gil Scott-Heron
sempre uguale a se stesso eppure “nuovo”, con la sua
voce ruvida e profonda adagiata su scenari elettronici
pauperistici, in salsa new-trip hop. Tutto perfetto sulla
carta. E invece, nonostante qualche brano realmente
da brividi, l’insieme mancava di qualcosa, tanto sotto il
profilo musicale quanto dell’interpretazione del nostro
(sul cui carisma immenso era giocata, stringendo stringendo, l’intera riuscita del disco).
Pur consapevoli del carattere furbo e modaiolo dell’operazione (il disco era stato osannato dalla critica; Jamie
xx è ovviamente il Jamie Smith dietro gli xx; da tutto il
2010 tirano forti venti di riduzionismo e revisionismo
dubstep, vedi James Blake), eravamo molto curiosi e
ben speravamo in questo remixaggio: dopo un soul, ci
aspettavamo magari anche un blues post-dubstep. E
invece niente, stessa storia di cui sopra. Giusto qualche
sprazzo della tanta grandezza possibile, nessun vero
azzardo sul fronte delle produzioni, tanti interludi inutili e soprattutto pochissimi pezzi penetranti (che sono
poi praticamente gli stessi dell’originale, per quanto
virati su altri toni).
In salsa dubstep, My Cloud è una bellissima sospensione
trip-hop; The Crutch un bel breakbeat; Ur Soul and Mine
una house trascinante; N.Y. Is Killing Me rimane il ‘nuovo
classico’ che era, magnificamente poeticamente disperata; I’ll Take Care Of U diventa una disco barcollante e
ubriaca. Ma il resto non esiste. Occasione sprecata.
(6/10)
Gabriele Marino
Gli Ebrei - 2010 (Sinusite, Gennaio 2011)
Genere: post-punk lo-fi
Piccoli Altro crescono. Stessa nervosa attitudine postpunk liofilizzata e stesso lirismo incisivo nell’idioma
patrio. 2010 segna la nascita di una piccola e curiosa
etichetta, la Sinusite di Duilio Scalici e Marco Gargiulo,
interessata a scandagliare i patri terreni alla ricerca di
eccitanti realtà. Proprio come questi Ebrei marchigiani,
quartetto non di facce nuove - gente del giro Soviet
Soviet, The Barbacans, Obelisco Nero e Uzi - che mette
in scena il proprio “flusso di coscienza purificatore”. Proposta altisonante che in musica si rivela essere un rock
in registrazione lo-fonica, urlato ma aggraziato e in the
vein of italian post-punk: bianco e nero, lirismo ribelle
e da istantanea rabbiosa che non disdegna aperture
melodiche e passaggi riflessivi, chitarre come stiletti e
sezione ritmica scarnificata.
Composizione e registrazione praticamente in presa
diretta rendono l’idea dell’immediatezza del disco: 20
minuti dritti in faccia in un tourbillon di Diaframma e
Altro, Sonic Youth e CCCP, punk italiano più scomposto e rigido e ironia tagliente nei testi, alla Bugo dei primordi. L’iniziale La Noia, 2010 Anno Di Cambiamento e
Maratona sono un ottima ragione per spingere sull’acceleratore.
(6.9/10)
Stefano Pifferi
Grimes - Halfaxa (Arbutus Records,
Settembre 2010)
Genere: Goth pop
Canadese classe 1988, Grimes è Claire Boucher da
Montreal, un’artista/musicista che sonicamente rappresenta una via di mezzo tra l’art techno dei Knife e
gli spettri goth - a partire dall’influenza dichiarata dei
Salem - della Witch House.
La troviamo dunque nei panni della musa folk (Devon)
dagli ovvî rimandi dream Ottanta (Cocteau Twins,
Dead Can Dance), e in quelli cassa quattro negli episodi riconducibili alla scena nordica. In pratica, Claire
sembra la versione Bedroom e weird pop di Likke Li,
si occupa personalmente di tutto l’output musicale,
dall’artwork alla miriade di riferimenti sonici, hip hop
(le drum machine, la boombastica ritmica) e traduzioni
mesmeriche del r’n’b da classifica comprese.
Halfaxa, debutto ufficiale che segue una cassetta (Geidi Primes) disponibile in free stream sul sito della Arbutus, è dunque un album che sa di hype annunciato e
che ha già raccolto buoni consensi dalla sua pubblicazione (settembre 2010) ad oggi.
Niente di sbagliato, pure con le citazioni ‘per connoisseurs’ di Burial e certo dubstep in Hallways; per promettere la Boucher promette bene, eppure il mix è fin
troppo variegato e il pop che lega le tracce, benché
decostruito e smaterializzato ad hoc, scivola spesso in
una generica vaghezza e inconsistenza arty-. Aspettiamo la prossima mossa, e di certo non ne sconsigliamo
l’ascolto. Le antenne di Claire sono ben rizzate, si tratta
di sintonizzarle meglio.
(6.8/10)
Edoardo Bridda
Guido Maria Grillo - Non è quasi mai
quello che appare (AM Productions,
Febbraio 2011)
Genere: canzone d’autore
Lo stile è barocco, la voce volutamente teatrale, l’obiettivo chiaro: far convergere gli esuli di Jeff Buckley, gli
estimatori di Antony Hegarty e il seguito fedele di
Alessandro Grazian su una proposta che li sintetizzi tutti nella maniera migliore. O che almeno ci provi.
“Servirebbe uno scatto di reni” osservava giustamente il
nostro Luca Barachetti nella recensione dell’omonimo
esordio del musicista salernitano. Scatto che anche in
questo secondo disco non si coglie, per lo meno dal
punto di vista della personalità. Perché se il labirinto di
arrangiamenti d’archi, pianoforte, synth che regge Non
è quasi mai quello che appare ben enfatizza la melodia e in qualche occasione rapisce con la sua eleganza,
assomiglia anche più a un rimirarsi da esteta che a un
reale mettersi in gioco.
Guido Maria Grillo è bravo. Nel forgiare un suono che
ha mille livelli di interpretazione, nel pettinare a dovere
una voce piena di orpelli, nel fondere classica e tradizione autoriale (il Fabrizio De Andrè della cover di Il
sogno di Maria) in una musica filigranata e concettualmente “alta”. Quel che ancora gli manca, pero’, è l’indi57
highlight
Missill - Kawaii (Atmospheriques, Febbraio 2011)
Genere: Mesh-up
Ci mancava un disco di classe dopo Tons Of Friends dei nostrani Crookers. Classe che mescola voci dal
mondo, che supera i confini geografici e musicali. Missill, la DJ francese campionessa del mesh, ritorna
con una cosa mutante che evolve in positivo il successo di Targets, con cui
ci eravamo esaltati qualche anno fa.
Il mix/mesh/meltin’/patchwork è la base estetica su cui costruire il nuovo
sound che oggi osa sulla pesantezza dei problematici lidi del fidgeting e
sulle spiagge pixellate degli 8-bit nippo. Lei, che ha progettato per l’imminente tour un controller midi con cui spara video a ripetizione sul palco,
musica e come in un videogioco si trasforma in una creatura nippo-fantasy,
spacca con una crew di tutto rispetto: l’amica di M.I.A. Rye Rye (Kawaii), la
pupilla di DJ Vadim Yarah Bravo (Fire), Dynamite MC, Spoek Mathambo
(Invincible), la cantante giapponese Tigarah in Feel That Bit, Plastic Little in Raw Dog (due MC da Philly
nel giro Spank Rock) e molti altri.
La prima parte del disco si assesta su un post-hop con bassi overloaded che fa molto Kanye West, un
colpo che ad un primo ascolto potrebbe essere pensato come una caduta, ma dopo un po’ ci si accorge
che invece la cura tecnica delle basi in visibilio hyperbass e le ritmiche pressoché perfette sono la giusta
mediazione tra l’al-di-qua e l’al-di-là del palco. Street e rispetto nella title track parlano con La Roux
tagliando i suoni con gli 8 bit dei giochini che i nerd poshy hanno già scaricato sul nuovo e fiammante
iPhone. Cantabilità che potrebbe stare nel disco di Kylie Minogue (vedi anche la leccata in Fire e le
paillettes in Glitter), ma che con gli inserti degli MC giusti trova il contrappeso ottimale.
Si passa poi a dei colpi di basso taglienti e spaccapetto, una Starz che preannuncia la seconda metà
del disco e una Be More che ricorda le percussioni dei Beastie Boys rinnovate con il bbreaking in acido now-bass. Dopo il Music Box Interlude si approda al pesissimo ballabile del fidget: Magic Potion è il
singolo da salto e da smascellamento, una cosa che non prevede coming back, Missill allo stato brado,
movimento e ballo, crescendi e filtering, scuola french rivista da angolature videodromiche. Chuppa
rilegge i Korn e ci butta dentro le rasoiate di Steve Aoki e di Bob Rifo in un tourbillon trash che emette
luci al led squadrate e deformi, Terrible Square è il Tetris in crescendo tastieroso e deeppissimo, una cosa
senza peli sulla lingua che parla robotichese.
Le possibili uscite dalle crew parigine di Busy P e dalle reginette del banghra pop spocchiose e atteggianti. Missill esce dal mondo del palco ed entra nella fascinazione nipponica a 8 bit, tanto che il disco
è anche un gioco per iPhone in stile retrofuturistico platform à la Mario Bros. Il disco ’carino’ (questo il
significato dela parola kawaii) della DJ gallica ci fa vedere come si possa ancora far ballare con gusto,
charme ed energia. Il gioco non è ancora finito, abbiamo ancora una vita. Giochiamocela. 12 tracce, 12
schermi.
(7.4/10)
Marco Braggion
pendenza stilistica, l’emarginata impudenza e lo spessore nella scrittura di chi lo ha preceduto e ispirato.
(6.5/10)
Fabrizio Zampighi
58
I Blame Coco - The Constant (Universal,
Novembre 2010)
Genere: synth-pop
Una voce un po’ androgina e roca che ricorda quella
del papà Sting per la giovane Eliot Pauline ’Coco’ Sumner. Il debutto sfoggia un synth pop in odore Ottanta,
tune che si avvicinano alle prove di Lykke Li e La Roux
senza dimenticarsi della classe di Robyn (il featuring in
salsa electro-Cure in Caesar) e un certo sentimento di
incompiutezza che si rifugia nel più classico e squadrato pop uber-prevedibile (già successone guardacaso in
Svezia).
Il singolo Selfmachine non è malaccio, ricorda in qualche modo le tastiere degli Animal Collective mescolate ai ricordi futur-pop dei Police di Synchronicity; la
cover reggaetronica di Only Love Can Break Your Heart (Neil Young) con quel piglio po’ onirico e un po’
malinco-teen funziona, mentre il resto è mainstream
fischiettabile che sale il giusto e rimane a mezz’asta.
La ragazza sembrerebbe avere una voce interessante
(vedi i giochi nella title track) e The Constant è, di fatti,
un punto di partenza.
(6/10)
Marco Braggion
Isolée - Well Spent Youth (Pampa Records,
Gennaio 2011)
Genere: house eclectica
Torna sei anni dopo l’eccellente We Are Monster il buon
vecchio Rajko Müller. Dalla Playhouse alla Pampa di DJ
Koze ne sono passati di momenti, di EP e di remix, ma
quello che l’uomo non si toglie di dosso - per fortuna
- è una fruttifera nostalgia per i suoni pop degli anni
Ottanta, quelli che riuscivano a costruire canzoni memorabili, con strumentazioni e suoni che costruivano
un mood epocale.
Più che ripercorrere la strada indie-minimal dello scorso album (che era un ottimo prototipo di quella che al
tempo chiamavamo micro-house), Isolée si rintana su
sciccherie degne dei Japan (Paloma Triste), clubbismi
per party di classe in slo-mo (Thirteen Times An Hour,
One Box), l’immancabile balearica (Taktell, Journey’s
End), ambient eccellente che ricorda i suonini di Four
Tet (Going Nowhere) e una puntatina di acido, ma sempre imbrigliata con il soul (Hold On).
Un suono più maturo, meno catchy, ma non per questo meno intrigante. Rajko ha ancora qualcosa da dire
al pubblico dell’house. Un produttore come pochi che
se ne esce con qualcosa fuori dal tempo. Necessario in
tempi di plagi ed effimere sciacquette. Preferibilmente
da lasciare in loop.
(7.3/10)
Marco Braggion
J Mascis - Several Shades Of Why (Sub Pop,
Marzo 2011)
Genere: Alt Rock
Con un piccolo aiuto da parte dei suoi amici J Mascis
abbandona ogni indugio e scrive quell’album folk che
ha nella penna sin dagli esordi con i Dinosaur Jr
Il Neil Young dell’alternative rock non ha mai fatto mistero delle proprie radici culturali, pur mascherate a
suon di densi fiotti di elettricità. Naturale dunque che
questo Mascis “naked” paghi pegno al grande cantautore canadese, suonando tuttavia meno calligrafico di
quanto ci si sarebbe potuto aspettare.
A dispetto dei numerosi ospiti (si va dal talentuoso
Kurt Vile a Ben Bridwell dei Band Of Horses) Shades
è un album che fa della dimensione intima il proprio
punto di forza. In Make It Right, ad esempio, la slide si
carica sulle spalle tutta la malinconia dei grandi spazi
americani, mentre a Too Deep, bastano poche e insistite pennate di chitarra per arrivare dritta al cuore.
In generale la specificità dell’album sta nell’immediatezza delle melodie, colorate a posteriori di tutte le sfumature del folk. Come nel madrigale romantico della
title track, cui l’utilizzo misuratissimo degli archi conferisce una inattesa classicità, o nel West Coast corale
“circa ‘67” di Not Enough.
Very Nervous And Love è il piccolo capolavoro dell’album e come i tanti capolavori ha il dono della concisione, con la voce ridotta ad un sospiro, la chitarra acustica che lavora ai fianchi e una seconda chitarra elettrica
ripresa in lontananza a donare un tocco di spettrale
eleganza.
Alla fine Mascis l’ha scritta la sua personale elegia folk
soul; ci sono voluti un pò di anni per estrarla dai rottami metallici delle sue produzioni noisy, ma ora che ce
l’ha fatta possiamo solo dire che ne è valsa la pena.
(7/10)
Diego Ballani
Jacob 2-2 - Cabazon EP (Cereal System,
Gennaio 2011)
Genere: electro-glo
Jacob 2-2 (dal nome di un cartone animato canadese) è un giovane produttore di New York che ha esordito lo scorso settembre con un EP autoprodotto di
quattro tracce, Gifted Child. Lavoro buono (6.9/10) ma
decisamente surclassato da questo secondo EP di sei
pezzi, disponibile in free download sul suo canale bandcamp.
Cabazon propone in sintesi una hauntologia electro
che è una hip house in salsa spacey messa a stingere
in candeggina Ottanta glo/wonky. Ci sono i tastierisimi
di un Jarre o di certo prog/Kraut (Down the Hydrolator),
ricordi addirittura Synclavier/drum machine (Cuckle
Buckle Houses), un immaginario che nei titoli e in certe
conditure produttive cita videogame e tivvù via cavo
59
(Episode Never Aired). E poi c’è Brainstorms, pezzo bomba dal grip giocoso ed efficacissimo.
Ecco, pur inserendosi in un filone coi piedi ben piantati
nella nowness anche più modaiola (sponsorizzatissimo
da Com Truise, per dire) e quindi facile a invecchiare
presto sotto i colpi di follower vari e seconde file derivazionali, Jacob/David, oltre ad essere molto bravo,
riesce a suonare fresco e personale.
(7.3/10)
Gabriele Marino
James Walbourne - The Hill (Heavenly,
Gennaio 2011)
Genere: americana
Quando dici l’iperattività: poco più che trentenne, Walbourne ha già prestato la propria abilità di strumentista a Pernice Brothers e Son Volt, Jerry Lee Lewis
ed Edwyn Collins, Pogues e Pretenders. Il ragazzo di
Muswell Hill - lo stesso quartiere dove è nato Ray Davies: le assonanze finiscono lì - possiede entusiasmo ed
energia, nondimeno farebbe meglio a capire cosa vuol
fare. Perché un conto sono le composizioni altrui: le tue
sono come figli che devi nutrite e allevare. Non basta
abbellirle per cavarsela, altrimenti rimangono esempi
di bella calligrafia persi nell’iperproduzione odierna.
Nonostante la buona volontà, il Nostro (coadiuvato da
navigati strumentisti come il batterista Jim Keltner e
Ivan Neville alle tastiere) propone infatti un rock bagnato di folk e country che persuade solo nel Richard
Thompson senza pathos di Northern Heights, nei Little
Feat “giù alla fattoria” di Waiting Room Blues e nell’Irlanda a stelle e strisce di Sailed The Seas. Principalmente
smarrendosi dentro un patinato songwriting primi anni
’70 (BBC), carinerie dal basso peso specifico (Songbird)
e presentazioni impeccabili (il Paul McCartney zuccheroso in Fool, laddove Road guarda a Harrison; meglio però l’Elvis Costello convocato per Never Going To
Leave). Gioca a nascondino con l’ascoltatore e forse anche con se stesso, James, ma l’impressione è che debba
ancora sgobbare per sé, e parecchio.
(6.5/10)
Giancarlo Turra
Jang Senato - Lui ama me, lei ama te
(Pippolamusic, Gennaio 2011)
Genere: indie, italiano
All’attivo il premio Fabrizio Dé Andrè e il premio Lucio
Battisti, vittorie a numerosi concorsi musicali di prestigio e una partecipazione al Tenco nel 2008, gli Jang Senato sono una rivelazione per modo dire.
La band romagnola, che da diversi anni tenta il degno e
60
meritato ingresso nel panorama musicale italiano, arriva
soltanto ora alla pubblicazione sulla lunga distanza ma
lo fa nelle giuste mani con Pippola music, una di quelle
label indipendenti oggi capaci di dare giusto prestigio e
volto adeguato al nuovo cantautorato italiano.
Matrimonio più calzante, in effetti, faticava a esistere
visto che Lui ama me, lei ama te si presenta come un
perfetto mix di leggerezza pop e di quella solo apparente lievità nell’approccio alle parole, già caro ad altre
band di punta della scuderia (in primis Brunori Sas).
Quelle che in apparenza sembrano piccole canzonette
orecchiabili che passano per non tornare o quantomeno senza chiedere di essere riascoltate nascondono,
in realtà, piccoli drammi amorosi affrontati con un impeccabile e pressoché perfetto gusto per il pop. Brani
come L’americano, Io e te, Respirare che si dividono tra
synth, chitarre acustiche e lievi riferimenti a Lucio Battisti, sono dimostrazioni d’abilità non consueta nella
costruzione di una giovane canzone italiana che non
abbandona i dettami del passato e sa collocarsi perfettamente nel nuovo.
L’impressione è che gli Jang senato siano un altro di
quei nomi (il già citato Brunori Sas e prima e meglio di
lui Dente) capaci di proseguire una tradizione di musica italiana non forzatamente impegnata ma capace di
raccontare l’intimo e la contemporaneità.
(7/10)
Giulia Cavaliere
Jovanotti - Ora (Universal, Gennaio 2011)
Genere: pop
Lorenzo che così ’giovanotto’ più non è - porta comunque bene i suoi 44 anni - ritorna con un album pop
dance che si configura come una ’playlist di singoli’ più
che come un concept (così ha dichiarato ai giornalisti
appena è uscito). Il leitmotif c’è, e non può che essere
l’amore. Impantanarsi su un terreno inflazionato dalle
melme pop dei vari Amici et similia è sempre rischioso,
ma Jova stavolta non fa male il suo lavoro di onesto
scribacchino electro pop.
Già dal singolo Tutto l’amore che ho (più venduto in Italia
nel 2010) si capisce che la melodia la fa da padrona, però
non è la solita minestra da classifica: la tracklist infatti è
imbevuta di tecnicismi electro che smuovono sottopelle il buon vecchio ballerino che è in tutti noi. Seppur ci
siano le ballad d’obbligo (Le tasche piene di sassi, Ora e
l’ispirata Un’illusione) i pezzi che si ricordano subito sono
quelli più ritmati e positivi: l’hip-hop sporco di Megamix,
il quattro delicato di Amami, il rockettino basico di Il più
grande spettacolo dopo il Big Bang, il ritmo ‘afrik c’est chic’
di La bella vita, il bbreaking di Io danzo.
In più c’è un buonissimo disco di bonus (solo nella versione deluxe) che tenta di spingersi sulle lande
dell’elettronica più tirata, quasi a rivendicare una carriera di DJ, che Lorenzo non ha peraltro mai abbandonato: la deep-tribal di Dabadabadance, l’acid di Spingo
il tempo al massimo, il trip-hop ne La medicina e il classico 4 a 8-bit in Go!. Ogni tanto ci sono le solite liste
di nomi e di parole messe lì per far colpo su qualche
innocente ragazzina, qualche ’concetto di sinistra’ che
sottolinea un’appartenenza ad un orizzonte alternativo che oggi appare sempre più sbiadito, ma quando
Lorenzo si mette a parlare dei sentimenti che conosce
meglio (vedi la versione acustica di L’elemento umano)
o prevede di spinnare i suoi pezzi su qualche consolle,
beh, ci sa ancora fare. Jovanotti for President?
(6.8/10)
Marco Braggion
Joy Formidable (The) - The Big Roar
(Atlantic Records, Gennaio 2011)
Genere: Pop-Rock
Se si parlò di rigurgiti Novanta nei Blood Red Shoes il
fatto era prettamente isolato e ininfluente. Trovarci di
fronte a un disco potente e magico (Florence And The
Machine, Bat For Lashes) dominato da sprawl (shoe)
gaze devastanti, vuol dire che ci troviamo davanti a un
probabile momento si svolta.
Il debutto sulla lunga distanza dei Joy Formidable è
ancor prima uno statement che un qualcosa di specifico: sembra voler chiudere i conti con una generazione
di waver e post-punker (gli Wombats altezza 2007 di
Candle, qualcosa dei Bloc Party in Chapter 2) a bordate
di feedback.
The Big Roar taglia deciso l’emo su arrangiamenti
chitarristici grungey (Smashing Pumpkins), hard psych (Flaming Lips in Buoi) o glam (Placebo). Ti stende
l’ascoltatore sotto un mulinello post-My Bloody Valentine (A Heavy Abacus). Impressionanti la forza e la
compattezza della produzione eppure questi brani,
come il sogno ad occhi aperti e le pose punky à la Yeah
Yeah Yeahs di Ritzy Bryan, cadono spesso in banali copia incolla.
I chorus e i trick melodici di questo trio, da oltre tre anni
sotto i riflettori dei media, sono presi di peso da altre
ricette, omologati a qualche standard radiofonico (ancora echi Bloc Party nel singolo Whirring). Un peccato,
considerando la potenza sonica espressa. The Big Roar
è un formidabile falò che brucia in fretta. Fatene ciò
che meglio credete.
(6.5/10)
Edoardo Bridda
Julianna Barwick - The Magic Place
(Asthmatic Kitty Records, Marzo 2011)
Genere: drone folk
A quasi un lustro dal debutto, il breve e autoprodotto
Sanguine, la newyorkese Julianna Barwick approda
su Asthmatic Kitty per dare forma ben più compiuta al
proprio immaginario etereo, alla congerie di giustapposizioni e loop vocali, a quella fatamorgana scarnificata così inquietante e fascinosa. Sospesa in un limbo
indefinito electro-ambient, freak-folk, neo-gospel e
new age, Julianna sembra voler azzardare una sorta di
simbiosi con le (presunte) vibrazioni della Natura, prefigurando un ritorno allo stato d’innocenza che ovviamente non può non sembrare pernicioso e incongruo.
E’ un effetto voluto? Credo di sì.
Le nove tracce di The Magic Place definiscono una dimensione tanto incantata quanto problematica, una
trance spettrale infarcita di retropensieri e sbigottimento. E’ tutto un baraccone e lei sembra saperlo, sono
tentativi velleitari in nuce di escogitare altrove mitologici. Funziona eccome la formula quando si limita a
qualche pennellata pastello come una ninfa bucolica
col cuoricino trepido (i cartigli di chitarra, la caligine di
piano, le ascensioni vaporose del canto in Bob In Your
Gait), ma quando sale sulla cattedra della solennità
(Cloak, la title track) ahinoi facciamo subito i conti con
una disarmante, supponente, arida monotonia. Non so
dove voglia andare a parare, ma i margini di manovra
appaiono strettini.
(5.8/10)
Stefano Solventi
La Sera - La Sera (Hardly Art, Febbraio
2011)
Genere: Indie pop
Non contenta di averci deliziato con il fuzz pop ricoperto di detriti lo-fi delle sue Vivian Girls, Katy Goodman,
che alle ragazze di Brooklyn presta voce e basso, torna con un progetto che rappresenta la glorificazione
dell’epoca aurorale del teen pop.
Con i suoi La Sera tira a lucido le melodie dei girl
groups e intraprende un percorso lineare che dalle Velvelettes porta ai Talulah Gosh, seguendo il filo rosso
della naiveté. Certamente la Goodman ha il dono della
semplicità, sia livello vocale (muovendosi sul filo della
stonatura, crea quella sensazione di precarietà un pò
paracula che, diciamocelo, ci piace) che strumentale,
giocando con l’immediatezza di riff e melodie, grazie
alle quali riesce a portare a casa gioiellini pop che non
raggiungono mai il traguardo dei tre minuti.
In brani come I Promise You e Never Come Around (di
61
cui gira un bellissimo video che rilegge l’estetica pulp
horror dei giornaletti di serie z, con grande ironia), gira
al minimo la manopola del distorsore e insuffla più folk
celtico che punk. Condisce il tutto con una produzione
sontuosamente spectoriana che iperamplifica le ritmiche ed esalta riverberi della chitarra, coprendo con stile i vuoti di un arrangiamento minimale e trasformando ballate surf come Under The Trees (con i suoi soffici
twang crepuscolari) un piccolo capolavoro di minimalismo pop.
Niente di nuovo sotto il sole, certo, ma dopo il successo
di Best Coast e Wavves, act come i La Sera, restano
fra le cose più cool che si possano ascoltare in ambito
strettamente rock, anche se è difficile stabilire ancora
per quanto.
(6.9/10)
Diego Ballani
Laradura - Senza fine (Red Birds, Gennaio
2011)
Genere: rock, italiano
Su tappeti sonori lievi e dal gusto post rock, una sonorità e un cantato decisamente affiliabili a quelli, ancora
una volta, dei Massimo Volume, nasce Senza fine, secondo lavoro dei Laradura, band di stanza a bologna
delle provenienze variamente legate al sud della nostra
penisola (un po’ di Calabria e po’ di Sicilia e Sardegna).
Suoni ben registrati, curati, una capacità innegabile di
mantenere alto il livello dei brani vanno a scontrarsi
con la reiterazione di un sound risaputo e con poche
varianti tra una traccia e l’altra: s’alternano lunghi momenti strumentali a più rari spazi concessi a un cantato
che spesso si fa subito parlato. Di converso, la bellissima voce di Luca Li Voti, che a tratti ricorda quella di
Max Collini (Notte verde), è un amalgama di linee sonore attentamente composto e i testi, cosa essenziale
e assai rara, sono ben lontani dalla retorica.
Peccato per la formula appunto, laddove finiscono in
un angolo Clementi & soci, s’ascoltano belle e riuscitissime ballate à la Marta sui tubi.
(6.4/10)
Giulia Cavaliere
Le Singe Blanc - Babylon (Bar La Muerte,
Gennaio 2011)
Genere: schizo-wave
Avvistati nel 2007 (Strak!) e poi persi di nuovo di vista
(l’ottimo cd+dvd Bai Ho del 2009, che in allegato documentava il tour in Cina) in un continuo saliscendi di
notorietà mai privo di energia e presenza discografica,
i tre francesi Le Singe Blanc si ripresentano sotto l’egida
62
del Bar più mortifero del panorama europeo.
Introdotto da una cover sinceramente brutta (ripresa
da un menù da kebabbaro) ma esemplare del melting
pot ad alto contenuto vitaminico del trio, Babylon si
apre nel segno della schizofrenica muscolarità di stampo Primus (Bombadilhom) per poi proseguire nei saliscendi tra vuoti pneumatici e accelerazioni schizo-core
di Ouzfat. Cifre stilistiche che si ripropongono durante
l’album in un vorticoso procedere che prende e rilascia,
tritura e mescola insieme prog, funk-metal, noise-core,
noise-rock e altro ancora.
Roba che fa fruttare al meglio l’insolita e atipica strumentazione (doppio basso e batteria a garantire mobilità e resa corposa) e le schizofreniche vocals in semifalsetto (Electromax su tutte), fornendo incastri ritmici
repentini e scioglilingua quasi nonsense di alto impatto. È musica (quasi) fuori moda, ma energica e slanciata, proud to be unhype. Per questo da premiare.
(6.9/10)
Stefano Pifferi
Low Anthem (The) - Smart Flesh (Bella
Union, Febbraio 2011)
Genere: folk roots
Si diceva un anno e mezzo fa, in occasione del bel debutto della band di Providence, della sua attitudine al
recupero vintage in musica, in questo caso l’Americana, con un approccio estetico DIY alla materia e un disco metamusicale sul recupero dell’analogico, e insieme l’uso di altri linguaggi, in quel caso gli stilemi della
world music.
Il comeback della band, Smart Flesh, è se possibile,
ancora più ancorato al passato, sempre in riferimento
all’acustico e alla roots music di The Band, Bob Dylan
e del folk rock USA tra Sessanta e Settanta. Album più
crepuscolare e spoglio del precedente, si snoda acusticamente tra omaggi al maestro Neil Young e all’amata Band, con aggiornamenti all’oggi che ricordano gli
analoghi Fleet Foxes e Midlake riguardo alla materia,
a formare tematicamente un ideale seguito al primo
album Oh My God, Charlie Darwin.
Scheletrico e ridotto all’osso, Smart Flesh dimostra
il valore e le scelte fuori moda della band, capace di
esprimersi al meglio in forma concentrata e meditata.
(7/10)
Teresa Greco
Malachai - Return To The Ugly Side
(Domino, Marzo 2011)
Genere: psych rock
Dopo un cambio nel nome (hanno perso la K di Mala-
highlight
Papercuts - Fading Parade (Sub Pop, Marzo 2011)
Genere: dream pop
Quarto disco per Jason Robert Quever e la sua creatura Papercuts, e il primo inciso per la Sub Pop. Per
queste dieci tracce di pure dream pop al caramello, il musicista californiano ha messo da parte quasi del
tutto le influenze folk dell’inizio (quando collaborava con Vetiver) per accentuare la sua immersione in atmosfere da West Coast Sixties, accentuando quell’operazione di ripescaggio di quel genere di pop che l’anno scorso
ha dato fama ai Morning Benders. Oramai pare che su questo filone, fatto
di ripescaggi Beach Boys, Zombies, Van Dyke Parks (per citare solo i nomi
di maggior rilievo), si giochi una grossa fetta del mercato indie.
La particolarità di Quever, qui ai massimi livelli di maturità, è di riuscire a
dare a questa materia sonora una veste spectoriana, cercando di costruire
un vero e proprio muro di suono fatto con una miriade di strumenti diversi:
archi, Mellotron, moog assortiti, chitarre acustiche ed elettriche, pianoforte, echoplex, più tutta una
serie di trick di registrazione sia analogici che digitali. Provate a sentire quello che verrebbe da chiamare “pieno orchestrale” dell’iniziale Do You Really Wanna Know o la profondità del paesaggio sonoro di
I’ll See You Later, I Guess (alla quale si sommano anche un coro di voci). La piano ballad Winter Daze fa
nevicare sulle note, mentre l’eco del folk si manifesta almeno in Marie Says You’ve Changed che sembra
un incrocio Vetiver/Belle And Sebastian.
Meno solare rispetto ad altri colleghi di (sotto)genere, Quever sembra possedere la chiave che apre le
porte verso atmosfere ovattate, eteree e agrodolci come pochi altri, riuscendo a coniugarle con linee
melodiche che si appiccicano alle orecchie nella migliore tradizione pop.
(7.3/10)
Marco Boscolo
kai per problemi di copyright) e il passaggio ad altra
etichetta (dalla Invada di Geoff Barrow alla Domino) i
Malachai ovvero il cantante e songwriter Gee e il musicista Scott, rispettivamente un dj e un MC, tornano con
un nuovo album, che sin dal titolo è un ideale proseguimento del fortunato precedente Ugly Side Of Love
di un paio di anni fa.
Il trattare la materia con divertita autoironia e un’attitudine al cut up post-tutto sono le caratteristiche del duo
di Bristol, che prosegue su questa scia, usando sempre
basi e samples per costruire stratificando per arrivare
alla loro forma canzone. Allo psych rock sixties piuttosto acido e garagistico aggiungono influssi di marca
portisheadiana, insieme alle consuete coloriture funkadeliche e black.
Di nuovo e più preponderante in questo Return To
The Ugly Side c’è un’attitudine maggiormente psichedelica (in pieno trip Beatles in alcuni pezzi) e persino
lounge tropicale, che si assomma alle precedenti incarnazioni dei due. Echi e citazioni sixties (SF Sorrow dei
Pretty Things in My Ambulance) e più contemporanei
(il riferimento alla colonna sonora di Eternal Sunshine
of The Spotless Mind di Jon Brion nell’opener Monsters;
la loro ammirazione per il recente Gonjasufi e per i
Flying Lotus) fanno ancora questa volta del disco un
collage coeso, che ci ha ricordato il Beck soul funk dei
tempi andati (Mellow Gold e dintorni). Una bella conferma.
(7.2/10)
Teresa Greco
Marcellus Hall - The First Line (Glacial
Pace, Marzo 2011)
Genere: modern folksinger
Suppongo non siano in molti a ricordare i Railroad
Jerk, che attraversarono i ’90 senza clamore ma tanta
sostanza, dimostrando profonda conoscenza delle radici e la ferra volontà a strapazzarle. Grossomodo quel
che avrebbe fatto Jon Spencer avesse guardato più
a Captain Beefheart e ai Fall che a Rolling Stones e
Cramps. Nonostante ciò, chiudevano bottega dopo
un pugno di lp e il cantante e fondatore Marcellus Hall
63
(laureato alla Rhode Island School Of Design, lavora
come illustratore free lance per il New Yorker, il Wall
Street Journal e Time; nel tempo libero disegna libri
per bambini e pubblica da solo racconti) ci riprovava
con i White Hassle.
Stessa solfa di grana meno fine, così che nel 2006 arrivava una carriera solista. La quale, radici per radici, non
può che assumere la forma del songwriting; e il Nostro,
trapiantato a New York, non può che guardare all’epoca
d’oro in cui chitarre acustiche e armoniche cambiavano il modo di vedere il mondo. Approdato sull’etichetta di Isaac Brock dei Modest Mouse, Hall consegna
così canzoni poetiche e ironiche di una solidità lontana
dal vuoto revival, alternando ballate spruzzate d’archi a
parentesi un filo più ruvide (un’obliqua During The War;
la garagistica When You Can), dichiarazioni in punta di
jazz-folk (Laughing With You) a virile country inurbato
(Don’t Go).
Sorretta da una voce che ricorda Robyn Hitchcock (Star
Position, Broken Phone), la penna s’accosta a Bob Dylan
(il blues funereo Wishing My Heart Was Stone, soprattutto
The First Line: tristallegra gemma tra Moss Elixir e Another
Side), reca visita ad Aftermath (It’s My Life) e mostra alle
generazioni odierne come si scrivono brani - basterebbe
da sola One Drop Of Rain - che si reggono in piedi senza
effetti speciali e orpelli. Disco intenso e frizzante come
un pomeriggio invernale nel Greenwich Village, si consiglia l’edizione che allega un tomo di quaranta pagine
con disegni del buon Marcellus.
(7.3/10)
Giancarlo Turra
gan) alle più stagionate Goin’ Back (di una struggente
Carole King, portata al successo da Dusty Springfield), quella Love Song che Lesley Duncan - deceduta
lo scorso anno - prestò ad Elton John, una Past Present
And Future che spalma talking allampanato su tema
pianistico di Beethoven (fu un successone pop per le
Shangri-Las) e quella No Reason presa dal repertorio
di Jackie Lomax e pervasa di ragguardevole estro stoniano.
Tra patinature folk-soul e guizzi acidi, brume cameristiche e una sottile strategia di sample, ne esce un’istantanea vivace, quasi festosa, malgrado tutto quel senso
di dolore metabolizzato, di vita stropicciata, di amarezze tenute al guinzaglio nel canto di Marianne (che tra
le altre cose deve fare i conti con l’ennesima relazione
andata a rotoli). La aiutano nell’impresa le chitarre di
Lou Reed e Wayne Kramer, nonché Dr. John al piano in quella Back in Baby’s Arms scritta nel ‘75 da Allen Toussaint. Tutto bene, se non fosse che la Faithfull
sembra un po’ troppo presa dall’affanno di convincere,
di non venire meno alla propria fama. Finendo così per
sedersi spesso sullo scranno del proprio status, esalando affettatezza da polvere di stelle, una sindrome da
piacionismo a fine corsa strisciante sia nei passaggi
languidi che nei ruvidi sussulti errebì, così evidente nel
country blues Gee Baby e in quella The Old House scritta
per l’occasione da Leo Abrams su testo del drammaturgo Franck McGuiness.
Non è il caso di biasimiarla troppo, ma non è un difetto
da poco.
(6.1/10)
Stefano Solventi
Marianne Faithfull - Horses and High
Heels (Naive, Gennaio 2011)
Genere: folk rock errebi
Due anni e spiccioli dopo il buon Easy Come Easy Go,
Marianne Faithfull torna a recitare il ruolo di signora
del Rock. Se quello si dedicava ad esplorare il presente
ed il passato proponendo un manipolo di cover disparate, questo Horses And High Heels - inciso a New Orleans e prodotto nuovamente da Hal Willner - alterna
alle rivisitazioni, quattro originali che vedono la Nostra
tornare a cimentarsi con la composizione. Tutte ballate, quelle firmate Faithfull, dalla dylaniana Prussian Blue
alla speziata Eternity fino al respiro Fairport Convention di Why Did We Have to Part e della title track.
Venendo alle cover, è una selezione di perle insolite,
dalle recenti That’s How Every Empire Falls (del poeta,
cantautore e attore RB Morris, di Knoxville, Tennessee)
e The Stations (già opening track di Saturnalia, album
dei Gutter Twins ovvero la premiata ditta Dulli & Lane64
Max Petrolio - Telefoni Mortimer (Red
Birds, Febbraio 2011)
Genere: electro
Lo aspettavamo al varco, Max Petrolio. Curiosi di sapere se le nostre perplessità su un secondo disco filiazione diretta dello stile di artisti come Le luci della
centrale elettrica - soprattutto nei testi - si sarebbero attenuate con la terza prova discografica. In realtà
Telefoni Mortimer non aggiunge nulla a quanto già
ascoltato in Discussioni in farmacia con animali abili, riconfermando in toto i grossolani difetti e gli stretti
legami di parentela del Nostro con una serie B del cutup brondiano.
Dove Brondi contestualizza ricorrendo a una dimensione autobiografica che quantomeno offre una chiave di
lettura solida al materiale - e una giustificazione non da
poco -, infatti, Petrolio colleziona semplicemente una
narrativa frammentaria, ammiccando costantemen-
te a un immaginario volutamente disturbante, cinico
ma francamente poco credibile. Per nulla valorizzato
da un’elettronica claustrofobica vagamente Depeche
Mode / Burial che si sostituisce alla wave del primo
disco evidenziando ancora di più la monotonia di una
formula che vorrebbe veicolare un supposto disagio e
invece mostra ampiamente la corda.
(4.8/10)
Fabrizio Zampighi
Micha Soul - Seven Soul Sins (Semai,
Febbraio 2011)
Genere: soul
Italo-belga perfettamente a proprio agio con l’inglese,
Leocadia Duggento aka Micha Soul, classe 1978, si è
fatta le ossa nella stessa crew bolognese, Fuoco Negli
Occhi, da cui proviene Brain (di cui lo scorso anno abbiamo recensito l’esordio da solista: in due parole, ottimo ottimo rap su basi un po’ così). Esercitatasi sulla
black con una cover band di classici funksoul, adesso
anche Micha esordisce in proprio, e sempre su Semai, etichetta gestita dal breaker Andrea Scardovi aka
Duna.Impeccabile sotto il profilo squisitamente vocale,
uno smooth soul dalla chiara impostazione funky (le
basi di Freshbeat e Hiko la servono alla perfezione; dei
due preferiamo il primo, più rifinito e affusolato), il disco ha un appeal, anche pop, potenzialmente internazionale, tocca punte di concitazione r’n’b e rilassatezze
ballad/jazzy (nei momenti più soffusi potrebbe anche
sembrare una Corinne Bailey Rae), riuscendo a scavalcare quel sentore come di eccessivamente artigianale
che spesso si avverte in prodotti simili. Buono il feat di
Brain, molto oldskool Italia svacco. E brava davvero Micha.
(6.7/10)
Gabriele Marino
Minks - By The Edge (Captured Tracks,
Gennaio 2011)
Genere: indie wave
Passato l’entusiasmo della prima ondata DIY, sarebbe
forse il caso di mostrarsi più esigenti di fronte ad uno
stillicidio di produzioni indipendenti che finiscono per
appiattirsi su un minimo comune denominatore assai
poco confortante.
I Minks, ad esempio, costituiscono l’epitome del Captured Tracks sound, sedimentatosi ormai dalle parti
di una wave pop, con svolazzi shoegaze, declinata in
bassa fedeltà. Quel canovaccio viene interpretato dalla band newyorkese con la più fiera ortodossia e senza
particolari slanci di originalità.
Il risultato è che il loro primo album prende il peggio
di entrambe i mondi, nella fattispecie la volatilità della melodie dreamy e la peggiore effettistica post punk:
provare per credere il terribile vocoder che affligge Funeral Song. Un peccato, perchè By The Edge ha pure
i suoi momenti validi; i Minks sono maestri nel creare
eteree suggestioni ambientali e lo dimostrano nei diafani deliqui chitarristici di Indian Ocean o nel finale mesmerico di Arboretum Dogs.
Falliscono invece quando cercano di portare a casa il
risultato, apparentemente più abbordabile, della pop
song, finendo impantanati in un’aurea mediocritas che
non turba ma non provoca nemmeno un’alzata soddisfatta di sopracciglia.
Il buon Mike Sniper, in qualità di talent scout, ci ha abituato decisamente meglio.
(6/10)
Diego Ballani
Mondongo - Transparent Skin
(Megaplomb, Marzo 2011)
Genere: jazz funk
Il batterista canadese André Michel Arraiz-Rivas è tipo
versatile, uno che te lo ritrovi a macinare prog coi Quasiviri e spettri post-folk coi Ronin, tanto per dire. Capita
poi che gli prenda l’urgenza del jazz, ed eccolo imbastire d’amblé un quartetto made in Italy, battezzarlo
Mondongo - come una ipercalorica zuppa tradizionale sudamericana - e licenziare un album da far drizzare
le orecchie. Transparent Skin - questo il titolo - sono
otto tracce più una (fantasma) all’insegna di modern
jazz molto groovy, due sax - l’alto di Piero Bittolo Bon
e il tenore di Francesco Bigoni - a pennellare melodie
calde, duttili e pensose sulla trama ritmica ora serrata,
ora sinuosa e mai banale intrecciata da Arraiz-Rivas col
basso elettrico di Giacomo Papetti.
Il lirismo cinematico di Wayne Shorter e l’immediatezza angolosa di Steve Coleman sono i riferimenti dichiarati, l’esito è un post-bop che ammicca l’improvvisazione con una brama di nuove direzioni prediligendo
all’astrazione una fisicità coinvolgente, al cui orizzonte
estetico non sono estranee movenze hip-hop più o
meno omeopatiche (Our Connection, Unconcurred).
Non capita spesso d’imbattersi in un jazz tanto contemporaneo.
(7.4/10)
Stefano Solventi
65
Munk - The Bird And The Beat (Gomma,
Febbraio 2011)
Genere: nu-disco
Ad ottobre dello scorso anno usciva il suo Mondo Vagabondo EP con l’anthem italo La Musica usato in prerelease già a giugno 2010 da Erol Alkan, Ellen Allien,
Tim Sweeney, Aeroplane e Luciano tra gli altri. Busy
P l’ha inserita nel suo primo CD mixato, ed è stata utilizzata anche dal gotha delle compilation mainstream
house come Kitsuné, Bugged Out (il volume dei Friendly Fires) e Hed Kandi. Per finire l’hype ci ha messo lo
zampino pure Karl Lagerfeld che l’ha voluta nel suo
film Remember Now sul personaggio di Chanel.
Oggi Mathias Modica (dopo aver remixato negli ultimi
tempi pezzi per Etienne de Crecy, Bottin, Yeasayer e Social Disco Club) prova a sbancare sulla lunga durata e
assembla il tanto agognato successore di Cloudbuster
che già di lounge ne sapeva a pacchi. La moda ormai
sdoganata della chill in ambito house trova terreno
fertile nell’operazione dell’uomo che coinvolge 12 voci
femminili per aggraziare ancora di più il cocktail. Tra le
altre la parigina Clara Cometti (già nei Koko Von Napoo
e alle tastiere nei The Teenagers) in Violent Love, Lou
Hayter dei New Young Pony Club e Pollyester dalla
scuderia Permanent Vacation.
Il risultato è un mix di influenze 90 tagliate con un piglio soft-house che sbassa i toni da pista. Salotteria innocua? Non proprio. Tutto il disco è stato suonato dal
vivo dallo stesso Mathias, che si è prodigato tra drum
machines, synth, piano, basso, chitarra, xylofono e percussioni varie. Uno one man show che merita per la
sciccheria e per il buon gusto. Potrebbe garbare molto
agli estimatori di Air, de Crecy e - perché no - pure Stereolab.
(6.9/10)
Marco Braggion
Natural Snow Buildings - Waves Of The
Random Sea (Blackest Rainbow, Gennaio
2011)
Genere: folk-drone
Per ascoltare la nuova uscita di Mehdi e Solange bisogna accomodarsi in una poltrona o in un cuscino,
avvolgersi in qualche drappo di batik a tinte forti e lasciarsi andare. Abbandonarsi all’ascolto multiple volte,
farsi attraversare dalle lunghe note distorte degli effetti
(chitarristici?) o ascoltare le vocals in lo-fi cantate come
se fossero in qualche landa desolata (la fine di This Ice
Fortress ad esempio), come quei trip psicofisico che
Vashti Bunyan fece attraverso l’Inghilterra con l’amico
Robert Lewis nel lontano 1967.
66
Tracce che rispetto alle produzioni precendenti sembrano essere più compatte (il disco ne presenta solo
sei, anche se comunque le durate sono quasi sempre
superiori ai dieci minuti), come a dire che si stava odorando un sentore di ruggine nel meccanismo compositivo del duo folk francese. Ma non solo. Qui c’è anche
molto post-rock (perché non catalogarle anche così,
affezionate come sono a quelle distorsioni quasi coniugabili ai live dei PiL?) e molta voglia di sperimentare,
con un piglio che ricorda i Current 93 più sciamanici
e visionari.
L’eredità degli NSB probabilmente ha già segnato parecchi sentieri, e questo disco non dice molto di nuovo
rispetto ai primi e più significativi capolavori; quello
che importa però è che il progetto riesce comunque
a trasmetterci una visione, un futuro, una possibilità. E
perciò, almeno per chi scrive, è il primo disco di folkdrone del 2011 da segnare con il pollice su. E facciamoci ’sto trip!
(6.5/10)
Marco Braggion
Oh No Oh My - People Problems (Moelloux
Records, Febbraio 2011)
Genere: indie-pop
Esordiscono nel senso propriamente detto, ovvero con
alle spalle una vera etichetta, i quattro polistrumentisti
texani (di Austin), che come altre band prima di loro (e
c’è da scommettere, sempre di più in futuro) hanno costruito le premesse della loro visibilità attraverso l’autoprodotto omonimo del 2006 distribuito via web. Le
ambizioni sono grandi, per gli Oh No Oh My, che dopo
aver fatto cadere i punti esclamativi della ragione sociale hanno realizzato una cartella stampa da major e costruito una modalità tutta loro di rinsaldare il rapporto
con i fans. Trattandosi di People Problems, ovvero di
problemi della gente, di tutti noi, chiusi o meno dentro
a camerette in qualche angolo del globo, ora sappiamo che possiamo scrivere direttamente alla band, che
ci risponderà. La band del cuore che apre una posta del
cuore (e non solo).
Ma se vi aspettate di essere sopresi dai brani degli Oh
No Oh My, avete sbagliato indirizzo. Fatta salva la capacità di costruire testi non banali, sul fronte musicale si
prendano un po’ di band indie oramai consacrate sull’altare della critica (a volte anche mainstream) come Death Cab For Cutie, Midlake e i Travis meno “sboroni”,
si aggiunga qualche tocco Eighties, che di questi tempi
non si può evitare (in questo caso guardando a Mike
+ The Mechanics e al mood naive degli Young Marble
Giants). Il tutto senza rinunciare a qualche tocco tardo-
highlight
Peaking Lights - 936 (Not Not Fun, Febbraio 2011)
Genere: psych-dub, glo-fi
La prolifica Not Not Fun tra alti e bassi ha recentemente licenziato il buon LA Vampires Featuring Matrix Metals (So Unreal, Not Not Fun, 2011) e ora, a pochi mesi di distanza, rifà il colpaccio con l’opera
seconda del duo nerd sott’acido a nome Peaking Lights.
Rifugiati nel Wisconsin, lontani dalle palme losangeline della scena di provenienza, Aaron Coyes e Indra Dunis mettono a segno una rivisitazione
On-U Sound con Adrian Sherwood a lasciar accumulare sporcizia lo-fi
negli angoli di casa ed echi sparsi di Slits e New Age Steppers.
Sei tracce dalla lunghezza media di sei minuti ciascuna segmentano il
mantra ossessivo officiato dal duo, a partire dal post-reggae ipnagogico
della single track, cartina di tornasole di un disco che si muove al di qua
di un dub allucinato, abbagli kraut, vizi new age primi Ottanta e spruzzate
analogiche tardo Settanta.
E scusate se è poco: il giochino ormai noto di inumidire vecchie glorie in scolorina glo-fi è qui perfettamente calibrato, benché al solito c’è coolness là dove c’era battaglia e fur&gold là dove c’erano rasta e
tette all’aria. La pratica hauntologica è invece giocata quasi sottobanco (si veda ad esempio la coppia
di sei rovesciati sul pick-up di Aaron nel clip di All The Sun That Shines). Se il maschio ci mette la predilezione per oscillatori home made, la femmina intona neniette narcotiche care al ricettario due cuori,
un synth e una capanna.
Sarà ossessione, sarà hype, ma la psych youth anni Duemila continua a mietere vittime e a fare proseliti
anche tra gli addetti ai lavori.
(7.3/10)
Francesca Marongiu
Nineties che ricorda tanto i Sixpence None The Richer
(So I Took You, I Don’t Know) quanto i Counting Crows,
per mettere d’accordo anche qualche ascoltatore più
maturo, e una spruzzatina di Sufjan Stevens (Walking
Into Me), che fa tanto trendy. People Problems suona
che è una meraviglia, soprattutto quando incontra certi echi college/power (You Were Right), probabilmente
il brano più incisivo del lotto, ma raramente scalfisce
l’anima. Ciò non impedirà agli Oh No Oh My di calcare
tutti i maggiori palchi festivalieri dell’anno.
(6.6/10)
Marco Boscolo
Om’Mas Keith - Uh Oh It’s Love (Plug
Research, Gennaio 2011)
Genere: black tamarra
Da mesi aspettiamo City Pulse, l’album solista di
Om’Mas. Le registrazioni a quanto pare sono terminate e l’uomo sta smanettando di post-produzione.
Vedremo. Questo dodici pollici in 300 esemplari intanto, tre brani per club puttaneschi e fumosi con relativi
strumentali e a cappella, è di fatto la sua prima release
pubblicata come solista (la bomba Wind it up era cointestata con Pritchard). Tamarra come (forse) non ce la si
poteva aspettare. E poi qui di bombe non ce n’è.
La title track sfiora tranquillamente certe schifezze TPain; China White è una appiccicosa psych-pimperia in
perfetto stile Sa-Ra, ma senza quel tocco magico che i
tre finora hanno dimostrato di avere quando si muovono assieme; Suga Lady è il pezzo migliore e più divertente, da solo riesce quasi a tenere in piedi il 12’’ (che,
per inciso, costerebbe 21 bigliettoni), con fortissimi sapori Ottanta, molto Prince sopra le righe, e Rozzi Daime alla voce. Speriamo l’album sia di tutt’altra pasta...
(5.1/10)
Gabriele Marino
Paolo Benvegnù - Hermann (La Pioggia /
Venus, Febbraio 2011)
Genere: canzone d’autore
Nell’ottobre dello scorso anno i Paolo Benvegnù trovano e leggono un manoscritto di tale Fulgenzio In67
nocenzi, titolo Hermann, e decidono di realizzarvi a
riguardo un disco. Non si trova una riga di questo Innocenzi in rete e la cosa sa di fantasioso espediente per
raccontare la genesi del primo disco dell’ex Scisma e
compagni dopo la conclusione con il live Dissolution
della sua «educazione sentimentale».
Hermann infatti smette le peregrinazioni interiori degli splendidi Fragili piccolissimi film e Le labbra per
rivolgersi all’intera storia umana, scandagliata nella
sua continua tensione verso l’impresa, la conquista, la
sconfitta, l’Amore. L’intento è ambizioso, ma d’altra parte i Paolo Benvegnù non hanno mai rinunciato ad una
complessità talvolta esclusiva nonostante l’intensità di
un percorso ad oggi senza un passo falso.
Ed alla fine è probabilmente questo il difetto di Hermann: ambizioso, denso, certamente non brutto, ma
anche difficile e fin troppo carico, a fronte di una serie
di episodi interlocutori che ne appiedano il percorso.
Dunque, mescolanze di letteratura (Melville, Sartre, Miller) e mitologia (Narciso, Perseo ed Andromeda, Ulisse)
a parte, non ci rimane che il computo delle canzoni
per trovare la chiave di un meccanismo volutamente
intricato. A rilento le iniziali Il pianeta perfetto (trama
acustica e archi, con sentore da ultimi Afterhours) e
Moses (quadratura Coldplay con ritornello marchio
di fabbrica). Da antologia la terzina formata da Love is
talking, Avanzate, ascoltate e Ho visto un sogno, segnali
di una tensione fra l’epico e il cosmico che riassumendo l’intera geografia del disco si fa prima fluorescenza
wave, poi pop-song d’alta classe con sontuosità d’archi
e infine epopea folk di uno sguardo sul mondo ebbro
di sangue e amore (lo stesso di una non meno bella
Achab in New York, vitalistica invettiva su crescita orchestrale).
Tuttavia, lo preannunciavamo, Hermann è anche l’avviso di una certa ripetitività nella produzione di Benvegnù, mai come oggi allo svicolo fra evoluzione e riscrittura di sé. Perché se da un lato non manca la volontà
d’intraprendere direzioni nuove (l’aurea fra il funky e gli
Wilco di Sartre Monstre, la somiglianza Beck nell’arrangiamento delle strofe di Good morning, Mr. Monroe, la
geometria Police di Date fuoco), dall’altro questi stessi
episodi mostrano un po’ la corda.
Una corda di buonissima fattura, certo, ma anche prevedibile nel replicare rotondità pop e volute d’archi
(Andromeda Maria), o nel frugare ancora una volta le
tasche in cerca di una zampata new-wave (il ritornello
di Good morning, Mr. Monroe), o ancora nell’andare a
scovare soluzioni di volontaria semplicità non sorrette dalla giusta ispirazione (Johnnie and Jane). Paolo
Benvegnù rimane comunque una delle migliori penne
68
d’Italia, fa solo strano ritrovarlo (giusto un filo) sottotono.
(7/10)
Luca Barachetti
Parts & Labor - Constant Future
(Jagjaguwar, Marzo 2011)
Genere: noise-pop
Più che di un futuro costante, il quinto album della
combriccola newyorchese è in onore di un suono costante. Accantonate le prime, rovinose formule noiserock tutte spigoli e velocità da brividi e fatta eccezione
per la serie sperimentale denominata Escapers, da un
paio d’album a questa parte il quartetto americano si
è infatti attestato su un noise-rock corposo nei volumi, reiterato nelle forme e melodicamente weird-pop
nelle vocals (i Butthole Surfers di Pepper riecheggiano nella title track, per capirsi). In una parola art-punk
post-moderno e futuristico che viaggia ora a media
velocità, ottenuto fondendo tastiere distorte oltre misura, drumming intenso e ipnotico, chitarre granitiche
e compatte.
La resa è indubbiamente meno dispersiva rispetto a
Receivers, quando gli input dei molti samples inviati
dai fan e rielaborati come un collage gigantesco all’interno dei pezzi tendeva naturalmente alla frammentazione. In Constant Future art-wave, space-rock mutante
e post-punk futuristico mantengono una linea coesa e
compatta e gli evidenti rigagnoli di suoni “altri” (disturbi electro, noises, stratificazioni di ampli) pronti a sgorgare dal flusso centrale non disturbano la pienezza di
pezzi carichi e anthemici.
Ad aleggiare sul tutto è però un senso di vaga ripetitività o di accademica riproposizione di uno standard
sonoro che ormai sembra avere poche frecce al proprio
arco. Non un brutto disco, ma nemmeno il passo decisivo che ci saremmo aspettati.
(6.7/10)
Stefano Pifferi
Psychic Paramount (The) - II (No Quarter,
Febbraio 2011)
Genere: avant-rock
Ci hanno messo solo 6 anni a dare un seguito a Gamelan Into The Mink Supernatural, ma ora che ce lo abbiamo tra le mani lamentarsi diventa l’ultimo dei pensieri.
Data infatti 2005 l’esordio del trio formato dagli ex Laddio Bolocko Drew St. Ivany e Ben Armstrong, rispettivamente chitarrista e bassista, col drummer extraordinaire Jeff Conaway a completare un terzetto onnivoro
e forsennato. Uno iato pluriennale che - escluso il dop-
pio Origins And Primitives Vol. 1 & 2 dell’anno successivo
- non sembra aver minimamente placato il sacro fuoco
dell’avant-rock che arde nelle vene dei newyorchesi. I
tre riprendono, infatti, il discorso interrotto col debutto
e se possibile lo amplificano e irrobustiscono ancor di
più. Quello cioè che parla di un avant-rock corposissimo
e reiterato, in accelerazione spacey e con scorie kraut
disseminate qua e là a far pendant con una attitudine
jazzy nella deflagrazione ritmica libera e incompromissoria del batterista Conaway. “A jazzier John Bonham”
com’è definito nella press, capace di sparare ad alzo
zero come un terrificante black metaller o contrappuntare elegantemente gli squarci elettrici dei compagni.
Forza d’urto a livelli da noisers e mobilità strutturale da
(hard)proggers intrippati con l’acid-rock e la psych più
densa sono poi il marchio di fabbrica dei due ex compagni di mathematiche evoluzioni strumentali. Che si
espleti sotto le forme di una ossessione circolarmente
jazzy (RW, la conclusiva N5 CODA), di frenetiche scosse
telluriche (N5), di mareggiate di distorsioni heavy virate weird-sound (N6) o di reiterate stratificazioni avantnoise alla Chatham (DDB), il tour de force mantiene
sempre altissimo il livello dell’attenzione senza scadere
nel già sentito. Di questi tempi, una gran cosa senza
dubbio.
(7.3/10)
Stefano Pifferi
Radiohead - The King Of Limbs
(Autoprodotto, Febbraio 2011)
Genere: Electronic, Alt-Rock
La storia del rock è fatta di molteplici vicende: percorsi
lineari, parabole artistiche, passi indietro ed in avanti,
scarti di lato. Senza dilungarci sul percorso Radiohead
fino qui, potremmo sintetizzare quantomeno le varie
‘nature’ espresse a seconda del periodo: attenti manipolatori di suoni e segnali, abili creatori di codici, propagatori di etiche e slogan, scaltri operatori di marketing 2.0 e infine autori di grandi canzoni pop.
Da quest’ultima attitudine The King Of Limbs, ottavo
capitolo della saga nuovamente prodotto e distribuito
dal gruppo stesso, si discosta. Il tentativo pare quello di
una nuova svolta, e sarebbe quindi già pronto e servito
il paragone con la premiata coppia Kid A / Amnesiac.
Non fosse che quelli erano titanici esempi di musica in
rappresentanza di un’epoca (statuario il primo fin dalla
sua copertina: la ‘ice age coming’ che era fotografia di
un presente storico, oltre che musicale), mentre qui la
chiave di lettura è differente. Mancano nelle nuove liriche quella serie di immagini e riferimenti tra il colto e
il metaforico che erano la forza del gruppo tra Ok Com-
puter e Hail To The Thief e tutto suona invece più che
mai diretto e intimo, un po’ alla guisa dell’opera solista
di Thom Yorke, ovvero The Eraser. E’ un paragone, quello con quest’ultimo disco, reso lecito anche dal primo
blocco di nuove tracce che si muove all’insegna di fascinazioni elettroniche ben esplicitate dalla mente dei
Radiohead nelle recenti playlist ospitate sul blog del
gruppo: su tutto spiccano le andature asincrone (Morning Mr Magpie) e scoordinate (Bloom) di Flying Lotus,
il primo Four Tet a punteggiare di folktronica la trascinante Little By Little, gli echi dubstep di Burial che svecchiano Feral dalla possibile outtake di Amnesiac che sarebbe altrimenti. E’ un flusso in cui i cinque marciano
compatti, con Yorke a dispensare le usuali melodie e
gli altri più intenti ad armonizzare il beat che a personalizzarne le trame. Gli strati di suono, i rimandi e le pur
buone idee che costellano questo ritorno spiazzano e
danno da riflettere ai reduci di In Rainbows.
Solo nella seconda metà del disco il gruppo rimette in
gioco lo spleen di cui è capace, ma sempre meno di
quanto potrebbe. Perchè Give Up The Ghost è un brano che gioca molto più sui crescendo e le intersezioni
della voce magistralmente loopata che sulla forza del
testo, invece esiguo e diretto come mai prima. Perchè
Codex sembra fin dalle prime note di piano l’ennesima
ballad per cuori infranti, invece è ancora Yorke che rievoca i grandi della musica pop con cui è cresciuto, e
quindi altro che pianti in cameretta: eccoci alla finestra
di un grattacielo che domina su una metropoli in piena
notte in compagnia di Scott Walker, Brian Eno e i Talk
Talk di Spirit Of Eden. Quanto a Lotus Flower, l’elettronica che le fa da sfondo segue pattern e ritmiche più
familiari ai Radiohead classici: seducente e falsettata,
spettrale quanto una House Of Cards e al contempo
più soulful e calorosa; ma nondimeno un singolo che
nemmeno da lontano può vantare l’appeal corale di
una All I Need, per rimanere su esempi recenti. Solo Separator tradisce degli slanci epici per cui gli U2 simpatizzerebbero, nel testo e nelle linee vocali, ma è sempre
un guizzare in mezzo al quasi onnipresente pastiche di
suoni sintetici e i curiosi ma riusciti inserti di chitarra
prelevati da quell’altro storico punto di riferimento che
è Tim Buckley.
Quando credevamo che la band di Oxford iniziasse a
vivere di rendita su quelli che erano gli schemi degli
ultimi album, eccoci di nuovo alle prese con un disco
che mostra desideri di cambiamento. L’asteroide Radiohead non ha mai smesso di ruotare intorno a quello
che succedeva nell’underground, e oggi come ieri si
mostra abile a reinterpretare tutto in un’ottica personale. Ne risulta una svolta che, come detto in apertura,
69
highlight
PJ Harvey - Let England Shake (Island, Febbraio 2011)
Genere: folk rock
Che White Chalk fosse un album definitivo per PJ Harvey, la chiusura della parabola introspettiva iniziata con
Dry, era facilmente ipotizzabile. In venti anni sette dischi (tolti quelli assieme a John Parish) ed altrettante maschere, ognuno una tappa sentimentale, culturale e geografica, uno specchio in cui riflettersi, cui concedere
l’onere della prova. Dalla periferia alla metropoli e ritorno, con l’obiettivo di indagare i tumulti e ricomporre
l’inquietudine. Fino ad accettare se stessa - il contrasto tra le proprie radici e le
aspirazioni, tra anima e natura - come una dolce inevitabile maledizione.
Con Let England Shake inizia quindi a tutti gli effetti una nuova fase nella carriera di PJ. Niente più maschere, niente più ricerca di sé: sarà un caso se per la
prima volta Polly non compare in copertina? La sua emotività è libera di indagare altrove, di aprirsi al mondo prendendosene cura, mettendo al centro della questione il tema evergreen della guerra, o meglio l’idea del conflitto come
mito fondante di un popolo. Lo fa esplicitamente senza rinunciare ad una spiazzante elusività, ovvero parlando a nuora perché suocera intenda, all’Inghilterra
assunta come simbolo arcaico di un imperialismo globale che - mutando modi,
forme, alibi, nome - continua ad essere la spinta che pianifica le sorti della nostra civiltà. In questo senso, Let
England Shake è un disco d’altri tempi, nel quale puoi addirittura avvertire la fragranza folle e urticante dei
Sixties californiani antagonisti (in All And Everyone, con la sua madreperlacea solennità, sembra ammiccare al
lirismo emblematico dei Jefferson Airplane). E’ solo un rumore di fondo tra gli altri di un programma che con
gli ascolti svela un variegato ventaglio di frequenze e radici, non a caso inaugurato dalla grottesca ambiguità
della title track, imperniata sul sample di Istanbul (Not Constantinople), uno swing ibrido inciso negli anni Cinquanta dai The Four Lads.
Siamo lontanissimi dalla vecchia, selvatica PJ. La rocker aspra e convulsa degli esordi ha lasciato progressivamente il posto ad una cantastorie conturbante e riflessiva, che ha imparato a manipolare l’irrequietezza
per farne narrazione, a trasfigurare la patologia in racconto, lo schizzo furibondo in una trama di cromatismi
ammalianti. C’è ancora un lato rabbioso che sgomita per farsi luce, ma è come domato, ricondotto nei ranghi
come una frase che sta tra le righe (vedi il folk blues indiavolato di Bitter Branches). L’abito sonoro - allestito assieme ai fidi John Parish, Mick Harvey e Jean-Marc Butty, con Flood ad occuparsi del missaggio - è parco ma
prezioso, fatto di percussioni terrigne e frugali, di chitarre semiacustiche ed elettriche dal timbro morbido, mai
invasive, spesso echoizzate come un sogno esotico. Poi c’è l’autoharp, diventato un po’ il feticcio della rinata
Polly Jean (e quanto se ne sia ormai impadronita è palese in The Words That Maketh Murder, sorta di pseudorumba col veleno dentro), quindi discreti ma incisivi interventi di sax e trombone, le apparizioni commoventi
del piano, pochi e vaghi sfondi di tastiera.
Il canto stesso di Polly è ormai strumento versatile, capace di sconcertanti mutazioni secondo le necessità
espressive, vedi il lalleggiare ruvido in England, con quella studiata mancanza di grazia che rievoca la struggente devozione delle preghiere popolari, oppure l’incedere beffardello e l’isteria pilotata nel finale di The
Glorious Land, o ancora l’afflato operistico della flamencata On Battleship Hill. Soprattutto, la scrittura rivela una
bellezza desueta, scostante, capace di esaltarsi nei dettagli d’arrangiamento (In The Dark Places sarebbe stata
l’ennesima ballad ingrugnita altezza Uh Huh Her, non fosse per la magnifica apertura di sax e cori nel bridge),
di misurarsi con frequenze diverse (vedi quella specie di post-reggae di Written On The Forehead, quasi un
Moby nobilitato Brian Eno) senza tradire l’unicità del mood e la poetica di fondo.
Oltrepassata la soglia dei quarant’anni, PJ Harvey è diventata artista dalle molte sfaccettature e imprevedibili
prospettive. La sua figura forse non sarà mai più centrale come lo è stata in passato: l’epoca reclama interpreti
nuovi e diversi, ed è giusto così. Ma tutto lascia credere che saprà condurre una marginalità intensa e staordinariamente peculiare.
(7.5/10)
Stefano Solventi
70
non bissa quella ormai storica di Kid A, ma nemmeno
sembra volerlo. Consapevole dell’epoca in cui esce The
King Of Limbs abbassa invece il profilo del gruppo e lo
riconfigura intenzionalmente da stadium band a gruppo quantomai mutante: si propone come un album di
elettronica molto più che di canzoni, e quand’anche
mira al cuore lo accarezza molto più che colpirlo. Più di
tutto è un oggetto che fin dal ridotto numero di tracce
si mostra agile e veloce, in qualche misura fresco. Non
un classico, nè tantomeno un’uscita determinante per
il presente musicale, ma un disco da consumare e godersi qui e ora. Fast music for a fast era.(7/10)
Simone Madrau
Sara Lov - I Already Love You (Irma Group,
Febbraio 2011)
Genere: folk-pop
A due anni da Seasoned Eyes Were Beaming torna la ex
Devics Sara Lov, (anche se definirla “ex” sarebbe inappropriato, visto che i Devics si sono ritrovati tra ottobre e novembre dello scorso anno per un tour in Cina),
questa volta con un disco di sole cover riarrangiate
seguendo i propri canoni musicali. Il che significa pop
da camera, atmosfere intime e una naturale eleganza,
il tutto prodotto in maniera impeccabile dallo stesso
Zac Rae che già si occupò del disco precedente. Il fine
ultimo è scovare la grazia nascosta di brani come Papa
Was A Rodeo dei Magnetic Fields, Square Hearts dei
Black Heart Procession, Just My Heart Talkin’ di Ron
Sexsmith o magari rileggere una The World We Knew
(Over and Over) di Frank Sinatra con un un’inquietudine solenne e dolorosa. Apponendo una firma non invadente ma ben riconoscibile su tutto il materiale.
Nessuna sorpresa, quindi, ma nemmeno una delusione, perché l’intensità e il sincero trasporto con cui la
cantante americana affronta la prova non hanno nulla
a che vedere col mestiere. Una voce placida e riconoscibile, la sua, che riesce a glassare la poesia intrinseca
di brani come Cape Canaveral di Conor Oberst, I Want
To Vanish di Elvis Costello, Winter Is Blue di Vashti Bunyan o magari a stupire con una La Bambola cantata in
italiano e arrangiata alla maniera di Nancy Sinatra/Lee
Hazlewood.
(7.1/10)
Fabrizio Zampighi
Sidi Touré - Sahel Folk (Thrill Jockey,
Marzo 2011)
Genere: african blues
Ha ragione Bassekou Kouyaté quando, interpellato
circa il valore di Sidi Touré, si lascia sfuggire che sia il
“degno successore di Ali Farka Touré”. Non che nel resto della stessa dichiarazione faccia sfoggio di cautela,
eleggendolo il ”migliore tra i musicisti Songhaï”, ma di
essere così entusiasta ha tutti i motivi. Almeno nove
come i brani che sfilano qui, rilasciando un profumo di
blues atavico che giunge dal cuore e dal quale promana un calore al quale non siamo forse più abituati.
Facile capirne le ragioni, pensando alla vicenda di questo cinquantaduenne del Mali, nato nella città di Gao da
nobili origini e costruitosi la prima chitarra quand’era
ancora bambino. E che crescendo affrontò il dilemma
tra le aspettative dei genitori e una passione divorante
per la musica, accontentata senza starci troppo a pensare sopra. Ben gliene incolse, dato che entrava adolescente nell’orchestra regionale Songhaï Stars e a metà
degli ’80 iniziava a portare a casa onorificenze e premi.
Mettendo in atto piccole ma significative rivoluzioni,
come affidarsi a materiale autografo nell’idioma della
tradizione Songhaï e cercando ispirazione in occidente
senza forzature.
Ascoltando J.J. Cale e comprendendo come le radici
siano in fondo le stesse; che le sue, anzi, si estendono
molto più in profondità e oggi donano linfa a un secondo album sensazionale. Sahel Folk si giova infatti di
pienezza ed equilibrio garantiti dalla registrazione “sul
campo” e della presenza, in ogni brano, di un diverso
collaboratore. Con spontaneità, Sidi e l’amico di turno
sceglievano il brano e lo suonavano con tranquillità per
registrarlo il giorno seguente, concedendosi al massimo una seconda take. Con l’obiettivo ampiamente raggiunto di fissare la spontaneità e il senso di comunanza
dell’evento.
Da qui origina in parte il calore di cui sopra, che rende vieppiù splendide gemme come le Artiatanat e Sïnji
che scambieresti farina del sacco di John Fahey, come
le ipnosi profonde Taray Kongo e Bon Koum, come gli
arabeschi d’anima Wayey Zarrabo e Adema. Non esagera, Bassekou, e l’impressione forte è che Sidi possa
arrivare ancor più lontano.
(7.4/10)
Giancarlo Turra
Sohrab - A Hidden Place. (Touch Music UK,
Novembre 2010)
Genere: elettroacustica
L’isolazionismo sembra essere la chiave di A Hidden
Place., primo LP dell’iraniano Sohrab. La questione
è sia personale che globale: va dalla piccola scala alle
frontiere di una scena intera. Da un lato, infatti, l’autore
dell’album è un ventiseienne musicista di Teheran che
comunica con il mondo la vicenda individuale e solip71
sistica della creazione, la breccia tentata in un mondo
non certo uso alla musica elettroacustica. Sohrab sceglie un moniker che viene da un poema tragico che
parla di guerra e di solitudine, di individuo e mancata
accettazione. Ma quanto si avverte, nel linguaggio della musica elettroacustica, l’emarginazione? Ce ne accorgiamo per differenza, quando ne sappiamo l’origine
- di cui la Touch, in questo caso, si prodiga a metterci a
conoscenza.
Il discorso si estende però anche a un contesto musicale
- occidentale - dove l’ascoltatore è talmente abituato a
suoni che mal celano un’inquietudine da rischiare perdere lo stupore per lo stato d’animo connotato. A Hidden Place. ci riporta al significato immediato di questi
suoni, al senso di un paesaggio musicale quasi rasserenato nella rassegnazione, che si chiude (Pedagogicheskaya Poema) con un guizzo di noise. Le voci stradaiole
di un mercato (nella title-track), che invadono la parte
forse più oscura dell’album, sono semplicemente uno
schiaffo all’isolamento, un violento ritorno alla realtà.
Allo stesso modo, il contrappunto di un canto del gallo strozzato e trattato in background (Somebody) non
dà l’impressione percettiva del field recording o della
concreta, ma ci restituiscono una quotidianità che non
riesce a fuoriuscire dalla testa di Sohrab, filtrando l’everyday life ed entrando prepotentemente nelle sue ambientazioni. E cos’è l’ambiente se non questa dialettica
tra un posto nascosto e la realtà con cui si scontra?
A Hidden Place. è un’ottima applicazione dell’espressività ambient. Nasce la curiosità di sapere quanto
l’esposizione ai nostri palchi possa cambiare la materia
da cui è scaturita questa finestra con gelosia.
(7.1/10)
Gaspare Caliri
Soni sfardati - Tri Soni (Improvvisatore
Involontario, Febbraio 2011)
Genere: avant jazz
Il chitarrista Enrico Cassia ed il batterista Antonio Quinci
hanno avuto un’idea meravigliosa e vagamente blasfema, quella cioè di dare vita ad una musica improvvisata
senza interazione, cioè eseguendo le proprie parti in
perfetto isolamento, uniti dal cordone ombelicale del
suono attraverso le cuffie. Per questo hanno deciso di
farsi chiamare Soni sfardati, anche se alla resa dei conti quel che ci è dato sentire suona straordinariamente
organico. Improvvisazione sì, però su canovacci che
rimandano spesso a fatamorgane psych in un ampio
scenario di fusion davisiana, colta nel suo dispiegarsi
più essenziale (la title track), l’attitudine lirica/esoterica
capace altresì di razzolare in un divertissement febbrile
72
figlio di evidente devozione post-bop (Beneamata improsatura).
Altrove capita d’imbattersi in fregole etniche nonché
atmosferiche (vedi l’arpeggio sperso tra Peter Gabriel
e Brian Eno di Culur’i vitru), in suggestivi bozzetti postfolk (l’afosa pensosità di U cantu da lupa, quasi un John
Fahey mediterraneo) o ancora in un brancolare ipnotico abbastanza fricchettone, tipo gli esotismi acidi di
Musciaccà (echi dei primi Grateful Dead e qualcosina
dei Floyd). E’ un gran bel disco, assorto e appassionato, vago come certi sogni estivi e chirurgico come una
vendetta d’innamorato.
(7.3/10)
Stefano Solventi
Soviet Soviet - Nice (Tannen , Febbraio
2011)
Genere: wave punk
La ricerca dell’essenzialità wave condotta fino ad una
purezza che non sai bene se più entusiastica, ingenua
o asettica. E quell’insidioso, inevitabile suppurare noise che ammicca ai primi Sonic Youth, senza peraltro
mancare di omaggiarli esplicitamente. I Soviet Soviet
vengono da Pesaro e sono in tre: il basso che trincia
l’aria come un ordigno invasato, i flash affilati e convulsi di chitarra, il rutilare meccanico della batteria, due
voci a giostrarsi le invettive. Forma e sostanza punkwave appunto, storia che si ripete come un frammento
sfuggito al controllo, un’allucinazione metodica o una
lucidissima paranoia.
Il bello sta nel contrasto tra il piglio filologico e la frenesia espressiva, nello sbattersi entro codici riconoscibilissimi fidando in una calligrafia propria. Metterci quintali di convinzione per ogni grammo di devozione in
eccesso: questa la ricetta, questo il difficile. Il risultato,
alla fine, è accettabilissimo: molto più che divertente,
un po’ meno che coinvolgente.
(6.8/10)
Stefano Solventi
Space Invadas - Soul:Fi (Invada, Febbraio
2011)
Genere: spacey blaxsoul
Anticipato dal mixtape in free download Follow The
Signs a fine 2009 e pubblicato praticamente già un
anno fa, aprile 2010, arriva solo adesso qui da noi con
distribuzione BBE il debutto della coppia di antipodi,
nativo il primo, acquisito il secondo, Ashley Anderson
aka Katalyst (sua e di Geoff Barrow la label Invada)
e Steve Spacek (dal quale aspettiamo nuove prove a
nome Africa Hitech, assieme a Mark Pritchard). Perché
highlight
Thousands - The Sound Of Everything (Bella Union, Marzo 2011)
Genere: folk duo
Leggendo le note che accompagnano l’uscita del primo disco per un’etichetta dei Thousands si scopre che quasi tutto quello che ci si trova è frutto di session in fienili, cimiteri abbandonati, giardini in
campagna e altri luoghi bucolici di tal fatta. Ed è un paesaggio, quello che il duo di Seattle ha deciso
di far entrare nel proprio disco, che va a coincidere velocemente con quello dell’anima. La musica del
duo non è niente più che un intreccio di due voci e due chitarre acustiche, occasionalmente supportate
da un harmonium. Quindi, facile pensare a Simon And Garfunkel, Kings Of Convenience e a tutta la
combriccola del folk intimista che ha fatto capolino negli ultimi anni.
Ma c’è molto altro, perché l’ariosità che Kristian Garrad e Luke Bergman hanno scelto per registrare i
loro brani ha permesso al suono di arricchirsi di sussurri della natura (ascoltare in cuffia, please), di riverberi naturali, di sfumature che (probabilmente)
non sarebbero state possibili in un canonico studio di registrazione, o per lo
meno non sarebbero suonati così naturali. A dispetto di questo viaggio in
loci amoeni sparsi nella grande pianura interiore, il disco suona fresco, a tratti
divertente, mai monotono come alcune produzioni di questo genere a volte
si rivelano (ma che non vengono definite tali perché non è chic).
A fare davvero la differenza, oltre alla cura particolare delle atmosfere, è sicuramente la capacità di scrittura, che supera abbondantemente la media di
oggi. Le linee melodiche di Sun Cuz, Big Black Road e Everything Turned Upsidedown sono appiccicose e
scaldano il cuore come fossimo con il duo attorno al fuoco di un bivacco. Ma è la perizia messa in tutto
il disco a mettere i Thousands tra le realtà da tenere sott’occhio per quanto riguarda l’indie-folk.
(7.3/10)
Marco Boscolo
ancora questi slittamenti nell’epoca del web (e del peer
to peer)? In ogni caso il disco è in streaming integrale
sul sito ufficiale.
Poco da dire, per altro, se non che c’è da togliersi il cappello davanti al falsetto soul di Spacek, perfettamente
incastrato sui ruvidi sample funk Settanta e Blax in salsa
hop di Anderson. Il tutto avvolto da sentori vagamente
futuristici e spacey, cui contribuiscono per buona parte
quelli sembrano essere dialoghi estratti da film di Sun
Ra. La formula è davvero semplicissima, i pezzi molto
omogenei, giocati su poche significative variazioni melodiche e ritmiche, ma la resa è eccezionale e molti dei
diciassette numeri in scaletta spaccano senza appello,
a partire dall’iniziale Imaginist. Un paio di feat femminili a condire e una vecchia conoscenza di Spacek fin dai
tempi della comune collaborazione con Dilla, Dank del
duo Frank’n’Dank.
(7.3/10)
Gabriele Marino
Stearica/Acid Mothers Temple - Stearica
Invade Acid Mothers Temple (Homeopathic
Records, Gennaio 2011)
Genere: impro-rock
Colpevolmente sottovalutati in casa propria, tanto da
attualizzare l’assunto per cui nemo profeta in patria, gli
Stearica si sono costruiti con anni di forsennata presenza sul campo un invidiabile seguito di pubblico e stima
di colleghi in giro per il mondo.
Ne è ulteriore dimostrazione, dopo la parata di stelle
sul debutto Oltre, questo comeback in cui il terzetto
torinese condivide l’esperienza sonora coi maestri del
psych-rock made in japan AMT di Kawabata Makoto.
In realtà l’album è figlio di un tour comune e frutto di
una vera e propria invasione reciproca in una sessione di improvvisazione collettiva presso l’Ortosonico
di Pavia. Anzi, una “fotografia scattata il 32° giorno del
tour” in cui le band hanno “invaso un pezzo di storia gli
uni degli altri”, nelle loro parole. E l’invasione si manifesta sotto forme cangianti e mobili, muovendosi tra
industrial-rock groovey e corposo (Queen Kong), space73
rock tribale e futurista (Warp Leg), post-rock materico
e psichedelico (Noodles + Peperoncino), isolazionismo
avant-rumorista from outer space sgretolato in assalto
noisy (I Nani). Non è però un caso che il più alto tasso
di freakedelia si presenti nella lunga jam conclusiva 7
Alieni Al Di Sopra Di Ogni Sospetto: dilatata, spacey, rumorosa e aliena mostra al meglio il terreno d’incontro
dei due progetti.
Un disco - anche in ricercata edizione vinilica con accluso dvd per l’inglese Robot Elephant - che unisce alla perfezione la mobilità del post-rock futurista degli Stearica
e le dilatate atmosfere post-psych dei nippos e che fa,
insomma, della libertà d’azione la sua forza principale.
(7/10)
Stefano Pifferi
no la bontà iniziale ma ne limano l’arrangiamento (Trust
Me è una deliziosa ballad dai sapori soul-hop primi Nineties, Outside Inside gioca in meteoropatia e forse ha
il testo migliore del lotto), e propone una manciata di
freschi episodi antologici come Omg (ennesima ballad
sul filo del kitch r’n’b), Trying to Kill M.E. con Laura Vane
(bell’intreccio chamber folk e strofe love) e il finalone
blaxploitation di Lock The Locks con Clare Maguire.
Pelle d’oca per gli hip-hopper sensibili. Grande generosità e grande verve per un Mike Skinner a grandi livelli, che furbo e intelligente gioca sul doppio binario
di personaggio da nuovi e da vecchi media (per i primi,
occhio anche al mixtape uscito il mese scorso via iphone, titolo Cyberspace and Reds).
(7.3/10)
Edoardo Bridda
Streets (The) - Computer And Blues
(Atlantic Records, Febbraio 2011)
Genere: slack hop
“I blip on a screen / You don’t know me / I think about you
/ What you’ll grow to be” (Bleep On A Screen). “Life isn’t
easy / You can’t google the solutions” (Puzzled By People).
Mike Skinner ha tribolato fino alla fine sulla scaletta definitiva che doveva comporre il dark e futuristico Computer And Blues e del resto l’album crudo e diretto dalle
basi sporche e cattive i fan lo avevano già ascoltato.
Twitter Album, un bootleg che raccoglieva le pubblicazioni web (dal sito e da Twitter) di The Streets, era un
lavoro coeso e qualitativamente già rifinito a sufficienza da essere definitivo, recensibile e quindi recensito,
figlio di uno Skinner secco e senza fronzoli come aveva
dichiarato, una ventata di freschezza dopo i buonismi
al giro dei trenta di Everything Is Borrowed.
Sul contributo e la collaborazione di Robert Harvey,
ex cantante degli sfigati The Music, avremmo fatto a
meno sentiti ora i risultati (il pur simpatico singolo à la
Aerosmith/Run Dmc Going Through Hell, le cheesy ballad Soldiers e We Can Never Be Friends) e di ‘computer’,
nel senso di elettronica analogica e cruderie street, rimane veramente poco nell’album (la sola già nota Bleep On The Screen identifica appieno lo spirito del sentirsi blues nell’era dei social network). Eppure lo Skinner
perfezionista, a sorpresa con un disco solare, variegato
e dominato da una bucolica vena indie-pop (Roof Of
Your Car in particolare, in stato di grazia), tutta protesa
mainstream però, riesce persino a superare le aspettative o i classici sospetti.
Computer And Blues è il vero disco della maturità: si
pone oltre le pose e i ghetti sonici, contiene gli episodi
migliori del Twitter Album in versioni che non ne altera74
Sword (The) - Warp Riders (Kemado,
Settembre 2010)
Genere: metal, stoner
Se il nuovo album dei The Sword ha un pregio è quello di mettere in chiaro le cose già dalla cover: il nero
dominante e l’impaginazione retrò sono l’analogo di
un’enorme etichetta con scritto Thrash Metal. Ascoltandolo però ci si accorge che Warp Riders punta
invece verso sonorità più moderne e tenta di ibridare
con lo stoner quella scrittura di derivazione sabbathiana a cui la band di Austin ci ha abituato già dall’esordio Age Of Winters. E subito, quindi, sorgono le prime
perplessità.Nonostante l’ottimo lavoro del produttore
Matt Bayles, il sound potente e ben definito che Cronise e soci hanno in questo set non basta a risollevare la
situazione e a parte pochi buoni episodi (Acheron / Unearthing the Orb e Arrows in the Dark) il resto è una sequela di cornucopie tra Metallica e Monster Magnet (Tres
Brujas). Nei momenti migliori suonano sinistramente
simili ai Mastodon - di cui Bayles ha prodotto Blood
Mountain - anche se non gli si avvicinano nemmeno
lontanamente per qualità tecnica e compositiva.L’idea
che lascia Warp Riders è quella di un disco furbo che
punta sul sicuro inseguendo la moda stoner. Non scontenteranno gli headbangers più incalliti, ma a mancare
è qualcosa di fondamentale, la personalità.
(5.5/10)
Alberto Lepri
Taprikk Sweezee - Poly EP (Musik Aus
Strom, Febbraio 2011)
Genere: club electro-soul
Eccolo qui l’EP di collaborazioni con alcuni produttori
americani che ci aveva promesso Taprikk. Il suono è gio-
highlight
Tim Hecker - Ravedeath, 1972 (Kranky, Febbraio 2011)
Genere: Ambient, noise
La foto in bianco e nero che emerge dalla copertina del nuovo disco di Tim Hecker ferma un attimo
preciso, quello in cui l’analogico cede il passo al digitale e l’atto stesso di gettare il pianoforte dal tetto
di un edificio si cristallizza filosoficamente come un addio eterno al suono che fu. L’ultima volta che
una foto in bianco e nero è apparsa su un disco di Tim Hecker, vivevamo i tempi di Radio Amor e dello
scatto romantico di un pescatore aggrappato acrobaticamente tra le funi e le vele di una imbarcazione
in mare aperto.
Questione di fascinazione per gli equilibri precari, che sono il focus perenne delle geometrie sonore
del musicista di Vancouver, eppure è proprio dai tempi di Radio Amor che la sua musica, pur all’interno
di un progresso costante sul piano della forma, non riusciva al tempo stesso a
trovare un concept altrettanto denso, capace di reggere architetture sempre
più alienate e virtuose.
Sarà la chiesa a Reykjavik in cui è stato registrato, le parti d’organo registrate dal vivo in un giorno di session, eppure il terzo album di Tim Hecker per
Kranky non è quella voragine nera che, titoli delle tracce, liner note e copertina paventavano.
Al pastoralismo del predecessore An Imaginary Country, il canadese sostituisce un gioco di vetrate e sprazzi luminosi, osservando il gotico nei contrasti di luce e tenebra. Più che un requiem per il pianoforte raffigurato nella cover, è come se le ceneri
di Vangelis, Pink Floyd e Bach venissero gettate in mare (o dalla palazzina). La maniera del “noise nonnoise” dagli effetti cosmici, inaugurata all’altezza di Harmony In Ultraviolet, con Hecker che si toglieva
di dosso le scaglie dell’ambient tout-court o per lo meno di quel tipico suono mid nineties che fece la
fortuna di etichette come Mille Plateaux e Staaplaat, con Ravedeath, 1972 subisce, se possibile, uno
scarto ulteriore.
Lavoro fortemente spirituale dove trascendenza, forza wagneriana e dialoghi con la cosmica tedesca
(Irrlicht di Klaus Schulze sembra espressamente citato in In The Fog II) s’intrecciano in spirali ascendenti (Studio Suicide, 1980). La varietà dell’indagine (l’organo di marmo della terna In The Fog e del dittico Hatred Of Music s’avvicenda incantevolemente ai droni celestiali, al piano eno-iano e ai cluster di
noise della trilogia In The Air, forse il picco del disco), il fantastico riverbero ottenuto nella location d’eccezione, nonché l’ottimo contributo e engineering di Ben Frost, che più di qualche idea di mastering
sembra averla presa dal suo primo disco, Steel Wound (si senta la densità fumosa dei corridoi cosmici
di Analog Paralysis, 1978) completano infine quella che è l’ennesima grande opera del canadese. Più
che l’ultima lost tape di William Basinski o l’avant classica fennesziana, è il caso di vedere in lui la mente
più vitale dell’ambient music contemporanea.
(7.7/10)
Edoardo Bridda, Antonello Comunale
coforza meno intimista e affilato, una versione da club
e a tinte forti del suo space-soul. Newend (prodotto da
E.A.R.L.) è un Prince spastico; Volt (HBO) è autotunato
e pimpato come potrebbe farlo un Om’Mas Keith dei
Sa-Ra (e farcito di trapani post-fidget); Eating the Void
(BUSY) un esercizio lidelliano/chelonisiano. Bonus per
la sola versione digitale una Mercury autoprodotta
molto più vicina alle atmosfere siderali e “collassate” di
Conversea (per quanto animata da un certo feel psych/
prog Settanta). Un lavoro in cui Taprikk cerca nuove vie,
ma tutto sommato un lavoro di stretto mantenimento.
(6.5/10)
Gabriele Marino
Tennis - Cape Dory (Fat Possum, Gennaio
2011)
Genere: Indie-Pop
Curiosa la storia dietro a questa band di Denver. Due
75
ragazzi in età da college ma già sposati completano
gli studi e mollano tutto, comprano una barca e girano
per mesi nei mari dell’Est. Poi tornano e mettono insieme questo progetto, i Tennis, le cui liriche si basano sui
loro trascorsi sull’oceano.
Come accompagnare musicalmente un’idea tanto insolita? In maniera purtroppo meno interessante. Sul
piano della produzione la formula è sempre quella che
parte dagli Strokes e incrocia il presente gusto lo-fi ma
se parliamo di arrangiamenti tutto, dalla voce suadente
della brava Alaina Moore fino alle ritmiche di chitarra,
rimanda molto più indietro: siamo ancorati ai 60’s più
melodici, voci e coretti (Marathon) che sembrano uscire tanto da un varietà statunitense dell’epoca (Pigeon)
quanto dalle spiagge californiane più drogate.
Ciò che spicca in questo esordio è l’abilità nel saper
costruire canzoni. Non è una raccolta di brani epocali,
Cape Dory, ma la cura certosina dietro ognuno di essi è
evidente quanto inappuntabile: la rievocazione di certe
sonorità non sembra casuale, anzi il gruppo deve averle mandate a memoria a giudicare dalla competenza e
dalla sicurezza con cui va riproducendole. Banalmente,
però, un buon disco ha bisogno anche di altre qualità
per farsi riconoscere. Diversamente la parola ‘gradevole’ rischia di divenire sinonimo di ‘prescindibile’, tanto
più se contempla un range di suoni inflazionato: e qui,
per tornare all’oggi, ci si muove in un territorio dove
Best Coast e Dum Dum Girls già primeggiano.
(6.3/10)
Simone Madrau
Those Dancing Days - Daydreams And
Nightmares (Cooperative Music, Marzo
2011)
Genere: pop
Una svolta radiofonica era ipotizzabile, ma non ovvia.
Dopo il piccolo scrigno indie di In Our Space Heroes
Suits, un’alternativa a probabilità forse maggiore era
una replica fotocopia che cercasse di replicarne l’onda.
Le cinque ragazze svedesi sono ancora giovanissime e
nella gioia dei vent’anni l’attenzione della cerchia dei
club indie non sembrava necessariamente dovesse intaccarne l’approccio.
In Daydreams And Nightmares, produzione Whichita
/ Cooperative, tutto o quasi è invece cambiato, sia nella
scrittura che nella produzione. La prima non cerca più
la semplicità e l’efficacia ma segue direzioni che ogni
tanto sembrano perdere l’orientamento. La seconda,
a sua volta, imbriglia la messthetics dell’organico, appiattendo le tastiere, pulendo dove prima si decideva
di non correggere, tirando una linea dritta verso suo76
ni meno connotati da un universo indie, per quanto
leggero e già spendibile. La voce di Linnea Jönsson,
trascinatrice nell’album d’esordio, non rimanda più al
Northern soul; le chitarre - e le tastiere - non ricordano più il primo post-punk, ma semmai occhieggiano al
pop marcato Cure (Can’t Find Entrance): inquadrando
col grandangolo, si è passati dalla leggerezza dei wultitzer di fine Settanta alla pillola indorata degli Ottanta inoltrati (Help Me Close My Eyes). Reaching Forward,
brano numero uno della scaletta, sembra essere su più
fronti il manifesto di quanto detto. Un manifesto radiooriented, con poca personalità e senza più un briciolo
di quella freschezza trascinante dell’esordio.
Non tutto il disco, per la verità, soffre la stessa povertà differenziale. Non il singolo Fuckarias, che però, posizionato così com’è a metà disco, pare un baricentro
forzato. Risparmiamo anche I’ll Be Yours (con tanto di
video sulla quotidianità, dove la band recupera qualcosa in leggerezza) e soprattutto One Day Forever, forse
il brano più convincente, che conclude il lotto lasciandone tutto sommato un buon ricordo, e soprattutto
un’impressione di crescita. A quanto pare, insomma,
le TDD cercano la propria maturità. Il vero problema è
che si vede il gesto di cercare.
(5.7/10)
Gaspare Caliri
Unthanks (The) - Last (Rough Trade, Marzo
2011)
Genere: UK folk
A rendere il progetto Unthanks speciale, oltre la raffinata rielaborazione del folk albionico, è la capacità di
impregnare ogni disco con lo spirito del momento che
lo ha generato. Se l’opera seconda The Bairns ne imponeva quattro anni or sono il talento, Here’s The Tender
Coming raccontava nel 2009 una formazione “vera” e
capace di cambiamenti nella continuità. Oggi, Last ne
conferma la natura multiforme nel solco della tradizione rinnovata, siccome un anno di frenetici impegni
(film, televisione e teatro; collaborazioni sparse con
Anthony & The Johnsons, Damon Albarn, Joan As A
Police Woman; un bimbo in arrivo per Rachel, sposata
con il collega di banda Adrian McNally) si traduce in un
lasciapassare tra presente e futuro di robustezza e inventiva mai dome.
Figlio di un “aiutare” le cose ad accadere da sole che è in
parte zen e in parte empirismo anglosassone, Last accosta originali, traditional e una cover dei King Crimson Starless, leggiadra e appassionata - senza che si notino
cesure. Gioco di prestigio da cantastorie che portano
con sé la spontaneità e la saldezza di registrazioni svol-
highlight
Toro Y Moi - Underneath The Pine (Carpark Records, Febbraio 2011)
Genere: sweet & sour ‘Muzak ’
Il debutto Causers Of This è stato uno dei dischi più compiuti dell’ondata glo/chill, candidando il ragazzo a ‘musicista più consapevole dei propri mezzi’ di tutta la compagine. Invece di battere la stessa
strada, adesso Toro mostra (ampiamente anticipato dai due singoli) l’altra faccia del suo revisionismo
nostalgico, una faccia - apparentemente - meno postmodernamente costruita e meno intellettuale:
spostando leggermente l’asse, lo scarto con i modelli si fa più sottile, puntando a una godibilità meno
obliqua dell’ascolto. Abbandonati gli spasmi ritmici e il taglio -tronico, del glo di Causers restano allora
le fonti hauntologiche e il gusto insistito per la voce annebbiata, echizzata, sfocata.
Feel decisamente caldo e suonato, Toro scava a ritroso nella propria memoria e mescola ad arte funkydiscomusic (i due singoli appunto), westcoast Sessanta, colonne sonore e pop Settanta (certe progressioni alla Todd Rundgren), folkie (Before I’m Done) e soft (Machine) prog in odor di fusion (il basso
pulsante, i fondali e gli intrecci di tastiere elettriche), illuminando il tutto di soffice luce psichedelica.
Operazione parallela e diversa, condotta però con lo stesso humour e lo stesso amore per i materiali di
partenza, a quella di un Destroyer (e altrettanto capace, aggiungiamo, di farsi ridurre dai possibili detrattori a un - pur intelligente - manierismo). Quello che ascoltiamo è un raffinato - agrodolce - impasto
easy listening (le dinamiche della batteria, gli arrangiamenti di piano, archi e fiati), tutto miele, tramonti
e zucchero di canna.
Toro padroneggia linguaggio e strumenti, cresce (diventa?) come autore di ‘canzoni’, espone con stile
e personalità il proprio immaginario (in un continuo ma tutto sommato soprassedibile ammiccare ai
modelli di riferimento), staccandosi di un palmo da certe recenti marmellate automatiche dei compagni di banco (Ariel Pink, El Guincho). Un disco molto più jazzy di quanto non sembri al primo ascolto,
e sicuramente di genere, da sottofondo. Ma da ascoltare con attenzione.
(7.3/10)
Gabriele Marino
te in un’antica sala da concerto e in una fattoria del nevoso Northumberland, lontani da cartoline vetero-hippie e fieri della propria chiarezza d’intenti. Pescando a
caso in un felice ibrido d’intimismo ricercato ed epica
trattenuta, impressionano la complessità solenne però
asciutta di Gan To The Kye, una Close The Coalhouse Door
prossima ai Rachel’s di Music From Egon Schiele, il Tom
Waits riletto à la Nick Drake in No One Knows I’m Gone.
Attestati di una classicità che guarda avanti partendo
da lontano e che lontano ci arriverà. Anzi, che lontano
è giunta di già, senza stanchezza né retorica.
(7.4/10)
Giancarlo Turra
Valentina Lupi - Atto terzo (Alì Bumaye,
Febbraio 2011)
Genere: pop rock
Chissà che fine ha fatto il secondo degli atti di Valentina Lupi, classe 1981 da Velletri (non esattamente Brooklyn o Londra), che con il terzo torna a cinque anni di
distanza dall’esordio Non voglio restare Cappuccetto
Rosso. Testi adulti e maturi si confanno perfettamente
a una voce tra le più interessanti del panorama italiano,
incastrata tra la grinta della cantantessa Consoli, il velluto graffiante di Syria, ma anche le ruvidezze di Nada.
Il tutto attingendo da una tavolozza di sfumature che
va dal mainstream al rock più muscolare.
Valentina Lupi canta delle difficoltà del cuore (Il modo
migliore), delle nostre manie da social network consumistico (la nervosa Non è cambiato nulla) e dell’amore
su un tappeto di organo (L’essenziale) facendo quasi
sempre centro. La band supporta la sua interpretazione andando a pescare spesso e volentieri da quell’immaginario indie italico da anni Novanta che tanto sta
continuando a riverberare in giovani artisti. I riferimenti sono quelli del rock americano, dal grunge (versante
Peal Jam post-Ten) al mainstream, fino agli onnipresenti tocchi à la Ritmo Tribale. L’intensità è sempre alta,
alcune soluzioni sono interessanti (la sincope de L’antieroe, brano da Carmen Consoli in trip Teatro degli
77
highlight
Wagon Christ - Toomorrow (Ninja Tune, Marzo 2011)
Genere: kitch-tronica Vibert
Richard D. James (Aphex Twin), Tom Jenkinson (Squarepusher), Mike Paradinas (µ-Ziq) e Luke Vibert.
Vi abbiamo tessuto più volte le lodi della cricca illuminata che ridisegnò le coordinate dell’elettronica
britannica e mondiale nei Novanta. Di ragazzi che consapevoli o meno, aggiornarono alcune avanguardie novecentesche (Musique Concrète e da tappezzeria, Stockhausen) al proprio tempo donando
ritmo e urgenza a una tradizione e rompendo così barricate (ballo non ballo), mode (house vs techno)
e steccati (drill’n’bass).
L’hip hop aveva forgiato una nuova cultura sulle stesse basi (synth, drum machine, sampler), formati,
limiti e modalità che i briannici riadattavano al proprio contesto, cultura e visione. In particolare, Luke
Vibert, con Wagon Christ, fu la classica anomalia all’interno di un più vasto terreno d’analisi interlacciato con Techno e (hip)House. Un’idea che ritornava al cut up del ghetto: un mix tape dove collage di
cassettacce da autogrill e effetti analogici gareggiavano per una personale idea di retro-futuro ad alto
tasso di THC.
Il ragazzo inventò la sua cosa, la kitch-tronica, una modalità buffa e stonata che a suon di sarcasmo e cinismo era diventata missione, collante di tanti passati per una nuova easy listening nell’epoca post-E.
A riposo dal 2004 (Sorry I Make You Lush) la sigla Wagon Christ aveva lasciato il posto a Luke Vibert in
solo, che ci metteva nome e cognome, allargando lo spettro d’analisi dei diversi alias specialistici (Plug,
Amen Andrews, Kerrier District, The Ace of Clubs) secondo uno sguardo autoriale. Fondamentale, infine, la collaborazione con il Jean Jacques Perrey, una sorta di padre kitchtronico riconosciuto e ritrovato,
un bagno di storia che rigenerando il ragazzo lo ringiovanisce talmente bene da farlo suonare - nell’ultimo biennio - più fresco di tutti, persino di Aphex Twin.
In epoca oltre glo e wonky non c’è momento più propizio per un mix già propiziatorio. We Hear You è
stato forse il miglior album in solo per Luke. Adesso non vi sorprenderete se Toomorrow gareggia come
il best del moniker preferito. La zampa dell’uomo, aggiornata un filo dubstep, accortissima nell’incamerare la nuova hip-hop strumentale per bianchi post-Harmonic 313, è libera di masticare l’ennesimo mix
a base di funk, etno e soul soffritto nei soliti ingredienti Christ (sci-fi, muzak, easy listening, acid, hip hop
e altre perle old skool house) sotto il tipico riff stoned che è ancora una volta brand, garanzia, illuminazione. E’ come sentirlo per la prima volta, quando sarà la centesima o la millesima. A Sound for today.
(7.3/10)
Edoardo Bridda
Orrori), e l’impressione generale è di un’artista che può
dire la sua nel panorama italico. Benvenuta.
(7/10)
Marco Boscolo
Valerian Swing - A Sailor Lost Around The
Earth (Antistar, Marzo 2011)
Genere: heavy post-rock
Trio in assetto prevalentemente strumentale e dal respiro internazionale, i Valerian Swing partono da Correggio e vanno alla conquista del mondo.
Registrano in quel di Seattle con Matt Bayles (Mastodon, Isis e Pearl Jam) e hanno le carte in regola per catturare quell’ampio segmento di fan delusi dall’ultimo
Mogwai, orfani degli Explosions In The Sky o legati
78
romanticismo post- targato Sigur Rós.
Stefano Villani (chitarra, voce, elettronica), David Ferretti (batteria) e Alan Ferioli (basso, tastiere) non rappresentano l’ennesima sterile riproposizione dei cliché
del genere. La loro è una foga non equiparabile alle ormai bagnate polveri degli scozzesi o alle delicate atmosfere diafane dei nordici, così come il raggio d’azione
non si riduce a statici passaggi ambientali o dicotomie
vuoto/pieno.
Gli innesti da truce rock hard’n’heavy (Since Last Century è un r’n’r d’assalto che transita per hard-rock seventies e heavy metal del terzo millennio), le aperture jazzy aliene (ospite in un paio di pezzi anche il trombone
del jazzista Gianluca Petrella) di Dr Pengl Is There o certi
passaggi da prog-metal alla maniera di Voivod, Cynic
o King Crimson (How Far?) dicono di un trio energico,
denso e muscolare eppure coraggioso nelle scelte sonore e attento a sfumature e umoralità.
Nota di merito ulteriore per l’artwork opera di Luca Zamoc e per il 7” allegato al vinile con due remix di Simon
Scott (Slowdive) e Isan.
(7/10)
Stefano Pifferi
Versailles - Dust & Chocolate (Stop
Records, Febbraio 2011)
Genere: power noise
Uno è la batteria dei Damien*, l’altro è voce e chitarra nei Container 47. Incontrandosi hanno avvertito la
possibilità/necessità di allestire un duo power-rock. Distorto, veemente, tosto, devoluto, arguto, trafelato, essenziale, massimalista. Tra wave punk, garage avariato
e fregole noise, sbrigandosela in inglese tranne in un
caso (la stolida Credere), omaggiando l’immarcescibile
verbo Devo con una adrenalinizzata Mongoloid, bazzicando certo revanscismo funk-punk (Hate) e carbonizzando i White Stripes in un calderone hard-psych (The
Summer) senza smettere di far pulsare la vena pazzarella che diresti un po’ P.I.L. (Very Nice) e un po’ Ramones
(Shoot The Band).
Ci sono i pezzi, c’è l’avventatezza, c’è un suono che si
sgrana come certe ferite dure a rimarginarsi. Non manca nulla, o manca poco. Dipende dagli obiettivi.
(7.2/10)
Stefano Solventi
William Fitzsimmons - Gold In The Shadow
(Gronland Records, Marzo 2011)
Genere: american songwriter
Sulle prime e sulla base del ricordo di The Sparrow And
The Crow colgono incredulità e dubbio. Poi ti documenti, e capisci che per chi da sempre colloca il proprio
vissuto nella musica è normale che le cose della vita dicano la loro. Che le canzoni ne siano plasmate e rese
materia pulsante cui oggi, sommersi di dischi precotti
e canzonette finger food, non siamo quasi più abituati. Anche se magari il risultato non convince del tutto,
lasciando nuovamente l’impressione di splendide potenzialità autoriali sul punto di sbocciare.
Fuor di metafora, l’album di cui sopra ruotava attorno a
un asciutto folk confessionale perché esponeva senza
pudore lo sfasciarsi del matrimonio di William. Siccome dalle disgrazie per fortuna si esce, il ragazzo ha poi
ritrovato amore e serenità, qui palesi in arrangiamenti
ricchi (elettronica di gusto “organico”, bassi rotondi, archi) e una scrittura che lascia intravedere il sole, ogni
tanto accogliendolo a braccia aperte. Novità che talvolta zavorra le composizioni (la piatta Let You Break, le
maniere alla lunga stucchevoli di Psychastenia e Fade
And Then Return) e talaltra ne agevola il passo (The Tide
Pulls From The Moon).
Perché l’autore è di vaglia dentro l’audace folk-pop Bird
Of Winter Prey e nella spedita The Winter From Her Leaving, spirito di Elliott Smith e respiro di Neil Halstead
dove il solo Elliott illumina il valzer Wounded Heart e
Nick Drake apprezzerebbe la delicata gemma Beautiful Girl. Può bastare a dimenticare il resto, come a consigliare Gold In The Shadow basta l’emotività pura della
conclusiva What Hold.
(7.1/10)
Giancarlo Turra
Yut - Yut! (Smoking Kills, Marzo 2011)
Genere: New Wave italiana
Una manciata di anni fa Yut! sarebbe stato annoverato come un album in pieno revival post-punk italiano.
Oggi è un esercizio che procede a cavallo tra quei primi
Ottanta italiani e la loro riproducibilità nel presente.
I milanesi Yut fanno riferimento a quel mondo che si
trascinò dal punk al “dark”, come si chiamava in Italia,
e a quel bacino di new wave italiana (con accenni funkpunk, forse il tratto più interessante) che nell’ultimo
lustro abbiamo imparato un po’ tutti a riprendere in
mano e riconoscere, nell’interesse storiografico o nella qualità effettiva di alcune produzioni. All’interno del
mondo dei primi Eighties italiani, tra i club e le scene
cittadine, il modello per Yut! è la situazione fiorentina
di quegli anni. Quei suoni che vanno dai primi Litfiba
(accumunati agli Yut dalla scelta della lingua italiana,
allora controcorrente nell’imperativo - comprensibilmente - esterofila del contesto), ai Diaframma (Luminoso & Nero), ai Neon.
Non si tratta però davvero solo di applicazione pedissequa, anche se il mimetismo in certi casi (Martin Eden,
RUV) non lascia spazio ai dubbi - o ne crea almeno uno,
circa le coordinate temporali della band, formata invece solo dal 2009. È nei testi (e raramente, come in Sciamenna, nelle strutture musicali) che si coglie lo sforzo
di declinazione al presente. Anche se va detta una cosa:
l’incaponimento su ciò che non va è comune a oggi e
ad allora. Ma questo non dipende da Yut.
(5.9/10)
Gaspare Caliri
79
Gimme Some
Inches #14
Molte anticipazioni di album upcoming questo mese su GSI.
Puerto Rico Flowers, l'ex Gowns EMA, Dirty Beaches fanno compagnia alle efferatezze di Fecalove, Compoundead e altri manipolatori del rumore.
Graditi ritorni e ghiotte anticipazioni sul giradischi di SA. Alla prima categoria appartiene Axion, 7” grigio
targato Public Guilt in cui James
Plotkin e il suo alter ego Phantomsmasher rielaborano due tracce degli Zu. Solita trasfigurazione
in un concentrato di devastante e
futuristico assalto tra glitchtronica
e rimasugli di sax per la title track,
a firma Phantomsmasher, mentre
sul lato b Plotkin svisa verso una
allucinazione orientale Chthonian,
sempre dall’epocale Carboniferous. Della serie, la musica degli Zu
si presta ad ogni trattamento.
Ben più corposa la seconda categoria. EMA è la sigla dietro cui si
nasconde Erika Anderson, già metà
Gowns, da quando quest’ultimo
progetto ha detto stop gettando nello sconforto fan e critica. La
chitarrista pubblica l’ultimo passo
prima del debutto Past Life Martyred Saints sotto forma di 7” digitale per Souterrain Transmissions.
80
La Anderson si muove drammaticamente ispirata nella title track, 7
minuti di fantasmatiche visioni per
chitarra acustica e voce, prima, e
esplosioni di feedback e incedere
ritmicamente acceso, poi. Sul lato
b, invece, la cover di Kind Hearted
Woman di Robert Johnson è un
tour de force di 17 minuti teso, epico e sinfonico come nella miglior
tradizione di casa Gowns.
Altro nome in procinto di debuttare è quello di Alex Zhang Hungtai
aka Dirty Beaches, di cui leggete
ampiamente altrove. L’apolide dal
ciuffo ribelle non disdegna puntate
a 45 giri se è vero che ha disseminato qua e là molte prove piccole
nel formato, non nella qualità. Si
prendano le ultime due uscite che
aprono la strada a Badlands: nello
split con Conor Prendergast uscito per gli scozzesi di Soft Power, il
nostro rilegge alla sua maniera la
cashiana The Singer, ossia seppellendola tra riverberi lo-fi e echi di
corde. Nell’upcoming per Italian
Beach Babes, invece tocca al classico No Fun degli Stooges venire trasfigurato in una essiccata e ballabile, seppur disperatissima versione
in cui stacca la voce baritonale di
Alex. Indubbiamente uno dei nomi
più caldi (e ostici) del momento.
Nuovo EP su 12” anche per i Beach Fossils da Brooklyn. Dopo il
successo di pubblico e di critica del
self titled, un tour che li ha portati
anche in Italia per un paio di date,
e il singolo Face It/Distance, ecco
What A Pleasure, ovviamente per
l’etichetta di Sniper Captured Tracks,
EP che recupera entrambi i pezzi del
suddetto 7”, aggiungendovene altri
sei. Queste le note tecniche; la musica non si sposta di un centimetro
da quella che ci aveva piacevolmente ammaliato negli scorsi mesi: pop
sfuocato, melodie semplici e velate,
tiro da band surf sotto tranquillanti.
I fan del gruppo sanno già tutto e
potranno ora placare la sete in attesa del prossimo full-length.
Discorso analogo per Puerto
Rico Flowers, il progetto solista
dell’ ex-Clockcleaner John Sharkey
III, che giunge al terzo singolo su
Fan Death. 3 Sisters apre la strada
a 7, l’album previsto per questa primavera e per ingannare l’attesa il
nostro ci regala un’anticipazione degna dell’attenzione che si è creato
attorno. Solo una manciata di minuti
per synth solenni, percussioni marziali e il cantato torbido, baritonale
ed intimista di Sharkey. Un ulteriore
singolo (House) è previsto prima
dell’uscita del disco vero e proprio,
come a dire: coltiviamo l’attesa con
la lentezza di uno stillicidio.
Dei //Tense// di Houston e della
loro EBM in salsa Wax Trax! abbiamo già avuto modo di parlare ma
torniamo a segnalarveli grazie alla
ristampa su 10” di Consume. Precedentemente edito in sole cento copie su cd-r da Disaro, l’EP viene ora
riversato su polivinile dalla francese Desire, la label che per prima si
è accorta del potenziale del duo
texano. Per l’occasione viene scelto
il formato meno convenzionale del
già minoritario vinile, stampato in
300 esemplari e in colore viola, per
dare il giusto risalto alle sei tracce
di electro dance-industriale che
compongono il mini. Nei prossimi
mesi verrà dato alle stampe anche
un nuovo 12” (Escape) per la ro-
mana Mannequin, affermata realtà
del giro electro-dark; nel frattempo
gustatevi le pulsazioni meccaniche
di TV Teach Me e Cash In cercando
di resistere all’impulso di ballare in
modo compulsivo.
Chi invece proprio non sa stare
con le mani in mano è Viktor Ottosson. Non pago di suonare negli
Ättestupa e Street Drinkers, e di
gestire l’etichetta di vinili Nattmaran con il sodale Dan Johansson
(Ättestupa e Sewer Election), il
ragazzo di Goteborg ha deciso di
aprire una nuova tape label. E con
ben tre cassette prende il via l’opera di Järtecknet, tutte per altrettanti progetti del nostro. La prima
del lotto, Hämnaren, è la seconda
release diBlodvite, act solista di
noise/industrial minimale e carica
di feedback. Med Repet Runt Halsen è invece la prima uscita a nome
Hängd, nuovo duo locale prossimo
alle distorsioni e ai clangori parossistici del power electronics più incompromissorio. La terza e ultima
cassetta vede un’ulteriore nuova
formazione in cui Viktor è coinvolto, Niding. Probabilmente l’uscita più particolare di questa prima
tranche, Afgudaskymning si colloca
in un ideale punto di incontro tra
i citati Ättestupa e Street Drinkers.
Percussioni cadenzate, melodie funeree, cantato scandito e liturgico
all’interno di una forma canzone,
questa volta, dal giusto perimetro.
Full-length in arrivo da cui ci aspettiamo grandi cose.
Prima di concludere, buttiamoci nell’underground più rumoroso
con due tapes targate Sincope recs.
La prima è l’ennesima prova di forza
di Fecalove aka Nicola Vinciguerra:
Wrong, definita dall’autore ugly
Motorhead harsh noise, mantiene
fede alla fama del noiser e offre
due prove di puro dolore in modalità harsh : in overdrive Trash & Void,
in modalità spacca-subwoofer Motorizer II. Rispondono nella seconda
l’americano Regosphere e i padroni di casa Compoundead, anch’essi anime pie della sottomissione al
rumore. Se il primo gioca tra basse
frequenze e cut-up rumoristico, ma
tedia un po’, Mara e Truculentboy
si mostrano più astratti e droning
e, sinceramente, pronti per un fulllength dai contorni più definiti. Lo
aspettiamo.
Stefano Pifferi, Andrea Napoli
81
Re-Boot
#13
Un mese di ascolti
emergenti italiani
Mutazioni cantautorali e rigurgiti grunge: questa la nota dominante di un mese al solito prodigo di proposte emergenti ed
emergenze propositive. Avanti così.
Tre pezzi di hard-psych tosto e melmoso per i Joykin, trio al debutto
con questo The New Raw (autoproduzione, 6.7/10). Se volete, una
mutazione acida del grunge che va
a grattarsi i gomiti in uno spigoloso cantuccio tra garage e stoner,
da cui i nostri spremono cavalcate
ingrugnite e ghirigori intossicati.
Mi piace il piglio, malgrado gli esiti
tutt’altro che inauditi. Se sapranno
scrollarsi dalle spalle il fantasma di
Cobain (appollaiato nel caracollare
mattoide di Break2), se sapranno
cioè metabolizzare la residua devozione per digrignare calligrafia propria, potremo sentirne delle belle.
Licenza Creative Commons per
gli Anelli Soli, dei quali via Jamendo potrete scaricare Il super razzo
e il cane stanco (autoproduzione,
6.9/10). Sono un duo messinese
con le stimmate Marlene Kuntz
cauterizzate con impacchi arty
Marco Parente e certe rielaborazioni etno-folk già Sursumcorda,
82
salvo poi risalire le radici fino ai De
André e alle congetture tra prog e
cantautorato di PFM e Le Orme.
Interessante l’approccio, il piglio
selvatico e veemente ma stringato,
senza teatralità o autocompiacimenti. Il passo più difficile adesso è
confezionarsi una statura contemporanea. Possono farcela.
Torna la Mescal con Retròattivo (7.1, Mescal), primo disco dei
Versus. Curiosa quanto riuscita la
mistura di atmosfere sognanti à la
Pink Floyd (altezza Shine On You
Crazy Diamond ma anche The Division Bell) e Ottanta pop à la Bluvertigo della band, nobilitata anche dalla presenza di ospiti illustri
come Lele Battista, Andy, Franco
Battiato e Megahertz (responsabile della produzione artistica).
Assoli à la Gilmour in Cosa ti aspetti
da questa notte, certi Ride inconsapevoli disegnati dall’Antonio De
Curtis psych di Stare Alzati, il pop
morbido decodificato da violoncel-
lo, slide guitar e theremin di Frasi a
metà: c’è più di un motivo di interesse nel disco di Daniele Dupuis,
Sandro Martino, Francesco Costantino e Andrea Dupuis. Non ultimo,
una classe lontana anni luce dal tritatutto in forma di bit con cui dobbiamo confrontarci giornalmente.
Annalaura Avanzi è il volto
che si cela dietro al progetto Aua,
cantautorato al femminile con in
testa Joni Mitchell e il cuore diviso
tra un folk acustico chitarra, archi,
pianoforte e certo pop contaminato da drum machines marginali e
soffuse. Progetto in comproprietà,
a dire il vero, visto che delle musiche di Martedì (6.5, Tomobiki) è responsabile la Avanzi più tutta una
serie di collaboratori tra cui Giovanni Ferrario, Terje Nordgarden
e Stefano Stefanoni. Leggerezza e
voce gradevole, qualche nota familiare (la Cristina Donà de Il ballo dei
Tigli, l’Anna Calvi più blues di Reincontrarti) e una spiccata femminilità, in un pugno di melodie intime e
sbarazzine cui però manca forse la
zampata decisiva. Nonostante una
rilettura della Canta Ragazzina di
Bobby Solo davvero niente male.
La compagnia del tuo pensiero
(6.3, autoproduzione) è un libro che
raccoglie piccoli frammenti di narrativa scritti da Alessandro Muroni
degli Charme De Caroline e ispirati a Nessuno scrive al colonnello di
Garbiel Garcia Marquez, L’odore di
Rocco Familiari, Il pomeriggio del
Sig. Andemas di Marguerite Duras
e La casa di Michele Perriera. Prosa efficacie, quella del Muroni, che
genera veri e propri testi e musiche
(allegate al libro). In un morphing
metalinguistico coerente con le linee guida di una band da sempre
vicina alle forme d’arte ibride (nel
passato del gruppo, reading di poesia e spettacoli teatrali). La parte
narrativa del progetto è apprezzabile, mentre la musica si adagia troppo spesso su forme di cantautorato
jazz-folk piuttosto stereotipate e
non del tutto in grado di rendere il
forte senso di partecipazione e di
attesa creato dai racconti.
Dopo numerosi cambi di formazione e una storia quindicennale,
The Dust, dalla provincia di Treviso,
sono ora un duo che ruota attorno
al fondatore Roberto Grillo e ad
Andrea Gottardi. Arrivano al quarto disco autoprodotto, Portrait Of
A Change (6.8) dove ripercorrono
il rock inglese di Sessanta e Settanta, tra glam e pop, blues e hard
rock, progressive e psichedelia; un
ampio catalogo di ispirazioni e un
cantato in inglese, per una canzone
d’autore sufficientemente poliedrica che si regge sulle proprie gambe, mostrando discreta personalità
compositiva e melodica.
Ci spostiamo a Genova, da dove
proviene Matteo Calabrò, che
dopo varie esperienze e un altro
progetto in corso, fa uscire Arte
Povera (Tesla Dischi 7.1). Trattasi di
EP di cinque pezzi di cantautorato,
che usa tra l’altro il recitativo anche
in lingua genovese, tra rumorismi
di fondo e concisività. Canzoni arrangiate insieme a Matteo Filippone per un disco altamente evocativo, che si fa notare per espressività.
Una bella sorpresa e l’augurio di un
proseguimento in questa direzione.
Concludiamo col tarantino
Michele Maraglino ed il suo ep
Vogliono solo che ti diverti (autoproduzione, 6.8/10). Trattasi di
cantautore con lo sguardo ad altezza d’uomo, arguto quanto basta
per allestire un teatrino che pesca
dalla post-disco targata Zero e dal
Battisti dei tardi settanta, tenuti a
bada da un’amarezza disarmante
e apatica à la Luca Carboni, capace altresì di rievocare l’incantesimo
amniotico d’un Al Stewart. Detto
ciò, vi parrà strano ma possiede
una propria coerenza e persino un
senso, gli manca semmai il segno
forte che lo imponga ai nostri tempi. Chissà.
Stefano Solventi,
Teresa Greco,
Fabrizio Zampighi
83
ME:MO
China underground#4
Quando la musica è memoria
Me:Mo e l’indietronica cinese. Le ultime fatiche (italiane e non) di
un musicista pechinese: dalla collaborazione con la Disasters By
Choice all’ultimo album Peking Scenes...
“Berlino ama la musica”. È il nome
di un complesso residenziale costruito da un architetto tedesco
alla periferia di Pechino. In una di
quelle zone della città tutte uguali
tra loro: alti palazzi spersonalizzati,
le strade dominate dai centri commerciali di prodotti di elettronica e
dai punti vendita delle compagnie
di telefonia mobile. Un quartiere
raggiungibile dal centro con due o
tre cambi di metropolitane o con un
paio di ore di traffico. Zhai Ruixin,
alias Me:Mo, vive qui, in un palazzo come tanti e fra i tanti del compound, dove l’immaginario di una
scena musicale può rimanere solo
sospirato in un nome. Poi, però, entro dentro la sua casa e tutto cambia: migliaia di dischi, cd, libri e dvd
di ogni genere e provenienza geografica. Pc e chitarre. Ogni oggetto
nel piccolo salotto riesce a rendere
reale un mondo che fuori sembrava
distante anni luce. Un mondo confortante, fatto di calore musicale.
84
Alfiere della musica indietronica
in Cina, Zhai Ruixin è un giovane
di trent’anni che non ama il partito comunista e i suoi dirigenti. Lo
dice senza troppi peli sulla lingua
ed è convinto che la maggioranza
dei cinesi la pensi come lui. Ricorda
Tiān’ān mén. All’epoca aveva solo
dieci anni, ma viveva nei dintorni
della centralissima piazza. Nei successivi vent’anni ha assistito allo
sviluppo economico da una posizione privilegiata, il cuore di una
città piena di storia come Pechino,
che ha saputo però svecchiarsi (ma
anche snaturarsi) a velocità inimmaginabili imponendosi come una
delle capitali moderne nel mondo
globalizzato. Gli hútòng, i labirintici
vicoli della vecchia Pechino, hanno
fatto spazio a grandi viali; le basse
case tradizionali e i courtyard che li
affiancavano hanno ceduto a grattacieli, shopping mall e marchi commerciali. La storia di Zhai Ruixin è
quella di tanti pechinesi, sradicati e
rilocati ai margini della nuova città,
negli alti grattacieli dei compound,
lungo i bordi di una metropoli.
Me:Mo
significa
memoria:
“All’inizio ho scelto il nome senza prestarci troppa attenzione, ma poi è divenuto un simbolo per me, un segno
distintivo della mia musica”. Musica
come ricordo di una città che non
c’è più, delle case e di uno stile di
vita privati di identità. Come fossero
rievocazione di quelle ‘scene di Pechino’ che danno il nome all’ultimo
album di Me:Mo, uscito alla fine del
2010 per la giapponese Plop (Gel,
Kazumasa Hashimoto, Fonica,
Sora) con la partecipazione della
indie-label malese Mü-nest. Quello
di Me:Mo è un atto di amore verso
una città scomparsa: “Non mi sento
di rappresentare la Cina, ma nei miei
pezzi c’è una percezione di Pechino,
delle sue trasformazioni in negativo e
della mia nostalgia verso l’ambiente
in cui sono cresciuto da piccolo, verso
la cultura della Pechino sparita. Questo è il tema costante del mio ultimo
lavoro, dall’inizio alla fine. Malgrado
allora non vivessimo bene come oggi
e non avessimo nulla, c’era una dispo-
sizione di spirito diversa, più comunitaria e meno disordinata rispetto a
oggi”.
Memoria tracciata nella rielaborazione di un percorso ben preciso,
fatto di elettronica soffusa e di una
moltitudine di suoni sovrapposti,
dove però le tradizionali campionature sono al servizio di un’attitudine
acustica e che ricerca la melodica.
“Per la mia musica non amo la definizione di glitch pop, perché rimanda subito a un idea precisa di suono.
Invece mi piace parlare di indie electronic, perché è un’espressione molto
aperta e non una vera etichetta di genere; è quel tipo di definizione che può
prestarsi a vari generi senza esaurirsi
in uno di essi, lasciando un artista libero di fare la musica che preferisce.
Se dovessi indicare degli stati d’animo
rappresentativi per la mia musica direi che è un qualcosa che scuote l’animo, qualcosa di nostalgico del passato. Un’atmosfera ambient, acustica”.
Nel 2008 la storia di Zhai Ruixin
si intreccia con quella di un altro appassionato di musica, questa volta
proveniente dall’Italia: Salvo Pinzone, il creatore della Disasters By Choice, etichetta di culto romana attiva
dalla seconda metà degli anni ’90
con pubblicazioni di elettronica di
riconosciuto spessore. A metterli in
contatto è Layer, un altro degli artisti della label, emigrato in terra cinese. Attraverso la passione di Salvo, la
musica di Me:Mo arriva in Italia, divenendo uno dei primissimi esempi
- se non il primo - di pubblicazione
di musica cinese indipendente in
Italia. L’operazione riflette un modo
di essere condiviso tra Me:Mo, la
Disasters By Choice e i suoi artisti,
dedito alla valorizzazione di opere
indipendenti. Più che essere diffusi
in un mercato, questi lavori vengono estratti direttamente dalle case,
con l’idea di favorirne la circolazione tra gli amanti della musica. Dalla
fine del 2008 la collaborazione cre-
sce spontanea e nell’autunno 2010
diviene realtà: Acoustic View, secondo album di Me:Mo, viene pubblicato in versione italiana, con l’aggiunta di quattro remix effettuati da
diversi artisti legati alla Disasters By
Choice (Obsil, Layer, Populous e
Slow motion): “Layer mi ha contattato dicendomi di avere apprezzato
il mio lavoro. Poi lo ha fatto ascoltare
a Salvo. È stato tutto molto semplice,
non si è trattato di una transazione
commerciale; a loro piaceva e volevano pubblicarlo in Italia. È un progetto
nato tra appassionati di musica e che
è rimasto tale. Una volta Salvo è venuto a Pechino, in quei giorni con Layer
abbiamo improvvisato anche un live
gratuito per il suo compleanno”.
Un percorso simile si sarebbe delineato anche durante la produzione
di Peking Scenes: “La collaborazione
con la Plop è nata perché un giornalista cinese ha intervistato il suo fondatore [Nao Sugimoto n.d.r.], che gli ha
chiesto se in Cina ci fossero dei progetti simili a quelli da loro prodotti. Il
giornalista ha fatto il mio nome, così
mi hanno contattato, io ho inviato il
mio demo ed è iniziata la collaborazione”. Nella discografia di Me:Mo,
Peking Scenes è il primo album con
parti di cantato. Per molti versi questo lavoro rappresenta un nuovo
punto di partenza: “Le differenze con
i due lavori precedenti ci sono, anche
se non così grandi. Probabilmente è
un album meno elettronico, ho fatto
molto lavoro sulle chitarre e le parti
elettroniche sono ridotte al minimo
indispensabile. Non è un disco standard di elettronica. Si è trattato di un
mio bisogno personale, come un’affermazione del mio modo di fare musica, che nei lavori precedenti non era
stata mai così completa come ora”.
L’autenticità del percorso musicale è un tema ricorrente nelle conversazioni con Zhai Ruixin. Quando è
entrato in contatto con l’elettronica
(attraverso i To Rococo Rot), a col-
pirlo è stata l’esistenza di un modo
diverso di fare musica, totalmente
estraneo a una scena musicale cinese allora dominata da stereotipi
punk e rock. Nell’elettronica Me:Mo
aveva trovato delle propensioni al
cambiamento e all’innovazione, che
riteneva ben distanti dalla sterile
reiterazione di un genere musicale.
Dalla sperimentazione-assimilazione di un modo totalmente nuovo di
fare musica, riprodotto e proposto
in Cina nei suoi primi due lavori, egli
si è quindi sempre più impegnato
nell’emancipazione da questi modelli per trovare delle forme creative
strettamente personali: “Quando ho
iniziato a suonare non ho mai pensato di considerarmi un artista, ero solo
un ragazzo che ascoltava tantissima
musica. Solo verso il 2007 ho iniziato
a riflettere sulle relazioni tra quello
che stavo facendo e qualcosa di assimilabile a forme artistiche, ma ancora oggi non mi ritengo di fare arte.
Parlando da ascoltatore e da amante
della musica, in Cina adesso ci sono
troppe persone che fanno musica
male e si propongono come artisti,
perciò preferisco evitare di definirmi
un artista. Delle persone che fanno
arte in Cina oggi ce ne sono un buon
70% che in realtà non conoscono né
capiscono l’arte. E ci sono tanti potenziali artisti che per questo motivo e per
l’esistenza di un mercato dell’arte non
riescono a emergere e desistono”.
Il problema è quello di un mainstream all’interno della musica non
commerciale: “Il pubblico è troppo
influenzabile negli ascolti. Se un genere musicale va di moda all’estero,
anche in Cina cominciano a replicarlo all’infinito. In fondo è un problema
di assenza di creatività, in giro ci sono
un sacco di idioti che copiano e basta.
Negli anni ’90 in Cina ascoltavano
tutti heavy metal, a cavallo del 2000
tutti hanno iniziato a fare punk, poi
sono comparsi gli indie e gli emo. In
Cina tutto cambia nell’arco di pochi
85
anni, poiché abbiamo cominciato in
ritardo. Prendi il Giappone, anche lì i
generi musicali sono giunti dagli USA
e dall’Inghilterra, ma il Giappone si è
aperto prima della Cina e ha seguito
gli sviluppi musicali contemporaneamente all’Occidente, maturando
anche forme musicali ed estetiche
proprie, come dimostra l’influenza
dell’elettronica giapponese nel mondo”.
Ormai Me:Mo sembra avere trovato il suo spazio in una nicchia
che non ambisce a divenire mercato. In parte rassegnato alla mancata crescita di una scena musicale
pressoché inesistente e in parte
anche limitato dall’assenza di locali dove esibirsi nella Pechino dei
rock-livehouse: “Nelle date che ho
fatto recentemente in Giappone mi
sono reso conto di come là gli spazi
per le esibizioni sappiano valorizzare
la musica elettronica come un genere
adatto a un live”. Ma senza dubbio sa
di godere allo stesso tempo di una
sostanziale libertà e indipendenza
nel proprio percorso artistico.
C’è chi ha bisogno di riconoscersi
in una scena musicale e chi sente il
bisogno di sfuggire a delle etichette. L’ultima via è sicuramente quella
che rende meno e che ha minore
riscontro esterno, ma anche quella
che riceve dagli ascoltatori l’apprezzamento più autentico. Poi, quando
arrivano i momenti difficili, la musica è sempre un buon rimedio. My
Spiritual Medecine è il podcast che
Me:Mo dedica al ritmo della musica anni ’50: “Abbiamo iniziato nel
2007. È un’esperienza che condivido
con un mio amico, principalmente è
nata come un divertimento e tale è
rimasta. In questo periodo mi piace
sentire musica del passato, mi aiuta
molto e mi stimola anche dal punto
di vista musicale. In realtà ho sempre
ascoltato tutti i tipi di musica, esclusa quella classica (tutta) e il metal (ne
sento solo un po’). Forse ultimamente
sento meno musica di una volta, mi
concentro più sull’elettronica e sulla musica del passato, ma meno sul
rock. Sta di fatto che tutta la musica
occidentale per i cinesi è nuova, non
importa se sia di due anni fa o degli
anni ’50”.
Mauro Crocenzi
D iscografia :
ME:MO (demo autoprodotto, 2003)
Static Scenery (2006)
Acoustic View (2008)
Peking scene (2010)
www.sentireascoltare.com
86
87
Rearview Mirror
—speciale
Cocteau Twins
Dream A Little Dream Of Me
Negli ultimi tempi non si fa che citarli. Dall'indie al recupero
dream dei bedroom artist, dai rigurgiti shoegaze alla Witch
house. La lezione Cocteau. Più che mai viva
Testo: Antonello Comunale
88
La storia del rock fino ad ora ha ragionato per decenni. Negli anni ’50 il rock’n’roll ed Elvis si incaricavano di
seminare il germe della presa di coscienza individuale,
mentre nei ’60 e ’70 tutto questo irrompeva nelle dinamiche sociali, nella ribellione collettiva. Gli anni ottanta
in questo senso non potevano che ripiegare sull’individuo, ma da una prospettiva profondamente diversa. In
superficie tutto era finito in un bagno di sangue ed in
vita erano rimasti pochi di tutti quegli slogan che erano
stati il leitmotiv del ’68. I Beatles e John Lennon icone
di massa polverizzate in un attimo, in un colpo di pistola in Central Park. E cosa dire poi del punk? Il ’77 e i Sex
Pistols erano durati lo spazio di una risata maligna, la
stessa con cui John Lydon apriva sarcastico Never Mind
the Bollocks e metteva in piedi la grande rapina di Malcolm Mclaren. Di contro il post punk dei sobborghi inglesi nemmeno aveva avuto tempo di prendere piede
che già viveva sul lutto per la corda tesa di Ian Curtis. E’
in questi anni, all’inizio di una decade sottovalutata, vilipesa e mai compresa del tutto come quella degli anni
ottanta che muovono i primi passi gli scozzesi Robin
Guthrie e Will Heggie, prima embrionale e iper acerba
formazione di quelli che di li a poco sarebbero diventati i Cocteau Twins, band di culto, intergenerazionale
e fuori dal tempo.
Ci sono band che vivono lo spazio di una decade e
ne incarnano perfettamente lo spirito del tempo. Altre
che invece allungano la propria esistenza su due o tre
decenni, spesso proprio le formazioni più scaltre sul
piano commerciale. Sono davvero poche invece quelle
che inventano un suono e vivono tanto a lungo da vederlo crescere e fiorire nel corso degli anni. I Cocteau
Twins sono fra questi, un caso emblematico. Attraversano gli ’80 e i ’90, inventando ex novo una forma di
psichedelia molto elegante, soffice ed eterea che ormai
viene generalmente identificata con il termine “dream
pop”, sottogenere tra i più influenti per più di una generazione di musicisti. Come se non bastasse il lavoro
immane fatto sul suono gli scozzesi diventano un caso
anche sul piano più strettamente vocale, per la vocalist
Elizabeth Frazer e quella che qualcuno ha definito “The
voice of God”. Va da sé che tolte le ascendenze strettamente gotiche degli esordi il loro è un suono che davvero poco ha a che spartire con il classico rock’n’roll, di
cui diventa infatti una via di fuga, un sogno ad occhi
aperti / chiusi che non si vergogna di andare a prendere influenze dalle musiche colte del passato per quello
che, diventa il primo fenomeno di suono “non rock“
dedicato ad un pubblico “rock” che esula dalle avanguardie in senso stretto. E questo è l’ultimo dei tre meriti storici della band, perché fondamentalmente nes-
suno sta a sentirti se ti metti a predicare da un serioso
pulpito pieno di retorica e supponenza. Gli effetti più
forti si ottengono nascondendosi nelle melodie più
sottili e nelle canzoni più orecchiabili e i Cocteau’s hanno sempre avuto il merito di cercare la melodia perfetta per i tre minuti, spesso riuscendoci e diventando nel
corso del tempo, forse anche per le qualità immaginifiche della loro musica, uno dei nomi più sfruttanti dai
creatori di immagini, siano spot pubblicitari o film.
“I t would have been the S ummer
of 1981. I really enjoyed what I
heard even though the voice was
barely audible”.
(Ivo Watts-Russell a proposito del primo demo tape dei
Cocteau Twins)
Primissimi anni ’80 quindi. Robin Guthrie e Will
Heggie sono due giovanotti scozzesi originari di Grangemouth, piccolo centro urbano tra Glasgow e Dublino, che Robin descrive amorevolmente con il termine
di “toilet”. I due, compagni di scuola, stanno al passo
con i tempi, quindi portano i capelli con il ciuffo dark
e passano le giornate ascoltando Birthday Party, Cure
e Joy Division. Fanno anche il giro dei pub ed è proprio in uno di questi che una sera vedono ballare Elizabeth Davidson Frazer, ragazza cresciuta sotto l’egida
di Siouxsie, di cui condivide lo stile diafano e goth e
un’ugola stentorea e veemente, seppure già padrona
di una serie di inflessioni che alla signora dei Banshees
resteranno per sempre preclusi. Il trio si forma presto
sulla falsariga delle formazioni britanniche dell’epoca
con Robin alla chitarra, Will al basso, Elizabeth al canto
e una drum machine a tenere il tempo. I primi esperimenti producono subito una musica tesa ma languida,
con il taglio post punk già sul punto di evolversi verso una nuova ragione del suono. Per darsi un nome i
tre prendono in prestito il titolo provvisorio di una
canzone dei Simple Minds, altra formazione scozzese
che andava muovendo i primi passi all’epoca e che poi
pubblicherà la canzone con il titolo No Cure sul primo
album ufficiale, Life in a Day.
Alla ricerca di un’etichetta che potesse pubblicare
il loro materiale, Robin decide di inviare una cassetta
ad Ivo Watts Russel, ovvero la stessa 4AD che stava ottenendo un discreto successo con i Birthday Party. Ivo,
da sempre alla ricerca di un sound che avesse qualità
originali e fuori dal tempo, rimane sufficiente impressionato dal gruppo da rispondergli a stretto giro ed
esortandoli alla produzione di nuovo materiale. Detto
fatto. I tre si ritrovano rapidamente con un piccolo re89
disegno generale che è fondamentalmente quello di
costruire madrigali ultraterreni che si appoggiano a
nient’altro se non all’interiorità di ciascuno. E’ il viaggio
interiore che evocheranno da qui in poi centinaia di
band che manderanno a memoria la lezione di questi
anni e di questi dischi. Centinaia di band, eppure nessuna che possa vantare una sola voce capace di avvicinarsi a quella di Liz Frazer che qui prende il sopravvento e diventa il vero e proprio strumento aggiunto del
gruppo. Brani misteriosi, energici eppure elegantissimi
come When Mama Was Moth, Five Ten Fiftyfold, In the
Gold Dust Rush, Musette And Drums forniscono alla
vocalist l’occasione per giocare ad incastri infiniti in
labirinti mentali dal fascino arcano. Magnifiche le doppie voci di The Tinderbox e My Love Paramour, mentre
nel frattempo la vena più propriamente pop è già capace di produrre piccoli classici come Sugar Hiccup. Il
disco ottiene un successo planetario e consacra l’icona dei Cocteau Twins e di Liz Frazer. Ivo Watts-Russel
non potrebbe essere più contento anche perché ormai
la sintesi tra la band scozzese e la 4AD diventa quasi
simbiotica e a rinforzarla ulteriormente, forse in maniera indelebile, ci pensa proprio lui con il progetto This
Mortal Coil al cui primo disco, It’ll End In Tears, i Twins
contribuiscono con una reinterpretazione di Song To
pertorio che di li a poco andrà a formare il primo album
vero e proprio, il mesmerico Garlands.
La tradizione gotica è ancora predominante e i tre
vengono etichettati frettolosamente come epigoni di
Siouxsie and The Banshees. Accusa da cui si tirano rapidamente fuori, in virtù tanto della carica preveggente
del sound quanto del piglio eretico dato ai vocalizzi da
Liz Frazer. Basta del resto ascoltare tesi lieder con il carattere del thriller come Wax And Wane e Blood Bath per
capire che quelle con gli autori di Scream e Juju sono
solo assonanze dettate dall’aria dei tempi e dal carattere ancora acerbo della formazione. Ciò non toglie che
i Twins assurgano velocemente al rango di culto. John
Peel se ne accorge e li invita per una delle sue classiche
session radiofoniche con tanto di Gordon Sharp dei Cindytalk in veste di guest star, per quattro tracce successivamente incluse nella versione cd di Garlands. Nello
stesso anno, il 1982, i Twins danno alle stampe il primo
di una lunga e fortunata serie di ep che diventeranno
presto il ritratto nascosto della band. L’ep in questione è
Lullabies, con tre tracce sulla falsariga di quelle inserite
90
The Siren di Tim Buckley, in una versione magica ed
eterna, tanto che diventerà rapidamente più celebre
della versione originale stessa.
“C im
keel makilagh teluxa
sulomegh yeilck vola - vola coco la
fullagh me - nag”
(Trascrizione del testo di Whales Tails, fatta da Liz Frazer
leggendo le parole alla BBC Radio 1 nel 1994)
Dopo alcuni sparuti concerti di supporto all’uscita
di Head Over Heels e un altro ep, il denso Surnbust
And Snowblind, i due si convincono che serve un altro elemento nella band che possa rimpiazzare il vuoto lasciato da Will. Il sostituto viene trovato verso la
fine del 1983, nella persona di Simon Raymonde, già
musicista nei Drowning Craze e soprattutto personalità sulla stessa lunghezza d’onda dei due. Di nuovo in
formazione di trio, i Cocteau Twins producono il loro
primo e vero hit da classifica, ovvero Pearly-Dewdrops’
Drops successivamente inclusa nell’ep The Sprangle
Maker che marca un’altra profonda evoluzione del
loro sound: meno tenebra, più profondità del suono,
taglio degli acuti – soprattutto della voce – ancora più
marcato, in definitiva una ulteriore progressione verso
nell’album con il taglio gotico, le primitive e timide inflessioni traditional gaeliche, un marziale mesmerismo
macabro e soprattutto il canonico dialogo di chitarra e
basso che cercano già a più riprese di evolversi verso partiture più aliene dei classici canovacci post punk. Lo
stesso si avverte in Peppermint Pig, ep dell’anno successivo che precede di poco il secondo disco ufficiale
della band, che da trio si trova in un attimo ad essere un
duo. Will Heggie decide amichevolmente di lasciare la
barca e Robin e Liz si trovano così a fare tutto da soli per
Head Over Heels, disco intorno alla cui gestazione cominciano ad avvertirsi estenuanti pressioni, sia da critica che da pubblico. La defezione del bassista fornisce
però il pretesto ai due per ripensare al proprio sound e
quello che ne consegue è il primo disco propriamente
etereo e atmosferico dei Cocteau Twins, in altre parole
la prima prova che può definirsi dream pop.
Head Over Heels può addirittura essere preso come
il documento definitivo dei Twins o comunque quello
più indicativo della loro poetica. Il sound non ha ancora perso del tutto la radice gotica, ma l’ha piegata al
91
un canzoniere originale e sofisticato. In pratica tutte
caratteristiche che marcano il nuovo corso dei Cocteau
Twins di Treasure, terzo disco effettivo, datato 1984 e a
tutt’oggi uno dei loro prodotti più amati.
L’influsso di Simon Raymonde si avverte subito nel
missaggio originalissimo del disco. Le linee di basso
che prima erano un’ossatura evidentemente calcata
sulle ombre della darkwave qui perdono gran parte
della loro presa, relegate in profondità per dare il giusto dinamismo ad una tela mossa da una mano quanto
mai barocca sul piano degli arrangiamenti. Ma tutto
deve servire a fornire il giusto habitat per lo strumento
principale che altro non è se non la voce della Frazer
qui ormai diventata vero e proprio trademark di un
modo di utilizzare l’ugola come tratto distintivo del
sound. Pandora è l’apice di questo suo nuovo approccio. Il nonsense dei testi, spesso ridotti alla pura elencazione di fonemi senza senso incomincia a fornire i frutti
sperati. Liz coniuga un nuovo linguaggio e per questo
92
comincia ad essere finanche inutile includere le liriche
nei booklet di accompagnamento. Una scelta questa
che porterà sia critiche che approvazioni, ma che vista
nell’ottica dell’autrice altro non è che una scelta di libertà. In un’intervista del 1994 ad Alternative Press ragionando sulle continue richieste che arrivavano dai
fan giapponesi affinché pubblicasse i testi delle canzoni Liz ammetteva candidamente di non cercare affatto
di trovare un senso alle cose che canta: “Ho scritto veri
testi per Garlands e Head Over Heels e parzialmente
per Treasure, ma dopo è stata soltanto una questione
di suono” .
Il carattere eccessivo e barocco degli arrangiamenti,
i titoli delle canzoni tutti presi da nomi storici (Aloysius,
Lorelei, Persephone, Otterley…) e il design del packaging, come sempre firmato da 23Envelope, tutto a base
di merletti e pizzi contribuirà non poco alla definizione
di novelli pseudo “vittoriani”, sottintendo in questo una
neppure tanto velata critica a certa altera pretenziosi-
tà, almeno in apparenza del tutto slegata da qualsiasi
appiglio alla realtà che ci circonda. Questioni che lasciano il tempo che trovano ma che rimangono addosso alla band per un bel po’, il tempo di produrre altri 3
ep nel 1985: Aikea-Guinea, Tiny Dynamine e Echoes
In A Shallow Bay, questi ultimi due subito riuniti in un
unico cd, mentre per il mercato americano, quasi del
tutto inesplorato dalla band, sempre lo stesso anno,
veniva data alle stampe una compilation intitolata The
Pink Opaque, che almeno nelle intenzioni della 4AD
avrebbe dovuto facilitare il contatto con un territorio
abbastanza immune dalle evocazioni prettamente albioniche dei Twins. Caratteristica predominate di questo fitto anno di pubblicazioni, un lavoro pressoché
costante sul suono, sempre più evoluto e atmosferico. Soprattutto il dittico Tiny Dynamine e Echoes In A
Shallow Bay, che infatti presto diventa un must per i
fan, mostra un evoluzione quasi inarrestabile verso un
sound sempre più alieno. I magici delay delle chitarre di
Pink Orange Road e Great Spangled Fritillary diventano
nuovi classici del settore, mentre la Frazer continua a
far parlare per le sue eccentricità, prima fra tutte quella
di Melonella, il cui testo altro non è che un semplice
elenco di nomi scientifici di farfalle.
Arrivati a questo punto non sorprende lo scarto acustico-ambient che Robin e Liz, nel frattempo diventati
coppia fissa anche sul piano affettivo, danno al nuovo
album, Victorialand. E’ un ritorno parziale alle languide
memorie di Head Over Heels, forse anche per l’assenza
del contributo di Simon Raymonde ma la sezione ritmica si è quasi del tutto dissolta in favore di un languore
celestiale e atmosferico a tratti anche estenuante. Le
volute arcane di Throughout The Dark Months Of April
And May sembrano quasi fare il verso a quelle dei compagni di scuderia Dead Can Dance, mentre tutto il canovaccio del disco poggia sull’avanguardastico lavoro
di Robin Guthrie che evolve ulteriormente lo studio
dell’effettistica per chitarra. Che sia un prodotto un po’
freddo e molto tecnico è dimostrato anche dal fatto
che tutte le registrazioni vengono effettuate nel nuovo studio della band, situato nel sud di Londra, e ribattezzato September Sound. Un esperimento dal forte
odore d’avanguardia che non porterà favori e successi al gruppo. L’ep successivo, Love’s Easy Tears, segna
un ritorno sui propri passi, quelli di Head Over Heels
e Treasure. Quindi balland malinconiche e orecchiabili
con le chitarre in delay perenne e la voce di Liz Frazer
ad intonare evocazioni eteree, ma si dimostra una parentesi veloce perché nella loro discografia va subito
ad incastrarsi The Moon And The Melodies, lavoro in
collaborazione con Harold Budd per una serie messa in
cantiere da Channel 4 dedicata agli incontri tra artisti
e che non prenderà mai davvero piede lasciando il disco come un caso isolato. Esperimento estemporaneo
per i Twins che appaiono un po’ persi negli acquerelli
ambientali del musicista inglese, tanto che risaltano
giusto i brani più autografi: Eyes Are Mosaics e She Will
DestroyYou.
“ little
fucker didn’t even ask , just
stole it ”
(Robin Guthrie riflette sul campionamento di Fifty-Fifty
Clown fatto da Prince)
Dopo un biennio di produzione bulimica il 1987
passa quasi in un attimo, giusto il tempo per Robin Guthrie di produrre il terzo disco dei Gun Club, Mother
Juno, per poi dedicarsi di nuovo alla propria band che
l’anno successivo darà alle stampe il primo di una lunga serie di uscite tendenti sempre più alle produzioni
mainstream, secondo un processo inarrestabile che
gli farà perdere fan e gliene farà acquistare altrettanti. Il disco in questione è Blue Bell Knoll, lavoro rapido, asciutto, molto solare e soprattutto forte di un
melodismo pop mai così pronunciato. Non a caso il
primo singolo tratto dall’album diventa uno dei loro
hit di maggior successo, ovvero la riconoscibilissima
Carolyn’s Fingers che sarà usata dalla pubblicità a più
riprese. I fan della prima ora del resto, non possono
che storcere il naso di fronte a canzoni come Suckling
the Mender e Kissed Out Red Floatboat, perfette ballad
pop forti di scelte d’arrangiamento assai meno pesanti che in passato. Molti prenderanno tutto questo per
una svolta dedicata alla leggerezza, scambiandola per
una contestuale perdita di autorialità. Pochi all’epoca
si rendono conto che la ricerca della perfetta pop song
presuppone un lasciarsi alle spalle le tante, eccessive
e pressanti sovrastrutture che tanti anni di carbonara
visione underground avevano imposto.
Tutto questo finisce per coincidere con il passaggio
di decade. Anno 1990, i Cocteau’s danno alle stampe
il loro lavoro in assoluto più accessibile e quello infatti
che finisce col riscuotere il maggior successo commerciale, Heaven Or Las Vegas. Disco ampiamente preveggente per il settore che decide di occupare, ovvero
quello del pop sofisticato. Le malie dream del passato
vengono asservite al disegno produttivo che inquadra
le melodie in perfetti congegni pop, con la produzione
in gran spolvero. Più di un timido accenno di trip hop
finisce così per saltare fuori dai corteggiamenti funk di
Cherry Coloured Funk, dall’elettronica rotonda di FiftyFifty Clown e dalle atmosfere malinconiche di I Wear
93
Your Ring. Ivo Watts-Russell va letteralmente in brodo
di giuggiole ed elegge il disco il migliore mai apparso
nel catalogo 4AD, giusto in tempo per vedersi le galline
dalle uova d’oro sfuggirgli di mano.
Heaven Or Las Vegas rimane infatti per i Twins, l’ultimo disco per l’etichetta che tanto avevano contribuito a plasmare con l’appellativo di “4AD sound”. Scelte
dettate da molteplici fattori, innanzitutto quello di slegarsi da l’immagine settoriale e così definita della label
inglese e poi per i mutevoli cambiamenti che stavano
minando nelle fondamenta la band stessa. A dispetto
della nascita di Lucy-Belle, primogenita della coppia
Frazer-Guthrie, segue un periodo di profonda depressione per entrambi. Lei si sottopone a ripetute sedute
di psicanalisi probabilmente anche come reazione alla
94
progressiva discesa nelle tenebra della droga e dell’alcol di Guthrie. Simon Raymonde non può fare altro che
assistere preoccupato all’evoluzione degli eventi mentre vengono assoldati due nuovi strumentisti a supporto del tour mondiale di Heaven Of Las Vegas. La
dipartita dall’etichetta di Ivo Russell fornisce il pretesto
per raccogliere tutti gli ep pubblicati fino ad allora in
un box deluxe con l’aggiunta di 4 tracce mai pubblicate prima. Classica chicca per i fan in attesa di vedere
cosa succede. La situazione si sblocca con la firma di
un contratto per la Mercury Records, affiliata alla più
grande Fontana, che si incarica di pubblicare le nuove
produzioni della band.
Il primo parto del nuovo corso arriva nel 1993 con
l’assai controverso Four-Calendar Cafè. Disco che
rispetto ai precedenti lavora di sottrazione, alleggerendo tutto quello che aveva reso il “Cocteau Sound”
così tipico e inimitabile. Innanzitutto il lavoro in sede
di produzione toglie tutte le pesanti sovrastrutture di
effettistica che avevano reso Guthrie uno dei guru della generazione post-shoegaze. Come se non bastasse
la stessa Frazer, lascia da parte l’idioma fantasy e onomatopeico che l’aveva resa celebre, per tornare a testi
veri e propri. Ne risulta un disco stanco e sfuocato. Una
collezione di ballad pop senza mordente. Si salvano
giusto i brani che hanno qualcosa che rimanda al passato: Oil Of Angels con i delay pulitissimi delle chitarre;
Essence che è ai confini con l’ambient a’ la Vangelis di
Victorialand. Il resto è semplice melassa pop zuccherosa, a partire dai singoli Evangeline e Bluebeard, tra le
peggiori cose mai pubblicate dagli scozzesi. Critica e
pubblico disapprovano in maniera manifesta e la band
perde l’equilibrio perfetto avuto fino ad ora. Lo dimostrano i due nuovi ep pubblicati nel 1995, Twinlights e
Otherness, ovvero diversi modi per ritrovare una verve creativa che sembra perduta per sempre. Il primo
è un lavoro prettamente acustico, con quattro brani
costruiti su pianoforte e chitarra. Niente effetti e una
produzione quasi da presa diretta. L’altro, di contro, è
sperimentale in senso opposto, giacché si tratta di una
collaborazione con Mark Clifford dei Seefeel che remixa alcuni brani della band, piegandoli al taglio elettronico che lo contraddistingue.
Passi confusi di avvicinamento all’ottavo disco della
band, Milk and Kisses, che è un vero e proprio ritorno
alle origini. Robin Guthrie ritrova tutta la sua maestria
produttiva forgiando, anche grazie alle evoluzioni tecniche intercorse in questi anni, un nuovo sound denso
e iper stratificato, che è pura gioia per le orecchie dei
fan della prima ora. Anche la Frazer riprende a trafficare
con il nonsense e la gestione pirotecnica dei fonemi e
degli echi. Violaine, primo singolo tratto dal disco, fa
capire subito quanta influenza abbiano avuto i Twins
su più di una generazione di musicisti impegnati ad
usare lo studio e la produzione in funzione attiva e creativa. Ma è tutto il disco che ripristina un trademark di
qualità che non si avvertiva in maniera così evidente
dai tempi di Heaven Or Las Vegas. Brani come Serpentine e Treasure Hiding sono pura magia Cocteau, con
la chitarra effettata a reggere la voce narrante e aliena
della Frazer; così come i brani più pop come Tishbite,
Half-gifts e Calfskin Smack ritrovano una quadratura
melodica che sembrava persa dietro ai corteggiamenti
mainstream di Bluebeard.
“... this
is strange i know but in two
territories we actually sold one
record per capita .
I n C hristmas
I sland we sold 424 cds and the
population in J une 2002 was cited
as ......424! Weird huh ? and in
B ikini I sland we sold 22 copies and
the pop. there is .....22 ! what can i
tell you ..?”
(Simon Raymonde a proposito di dinamiche commerciali)
Il passo successivo, quello cioè di un tour mondiale
di supporto al disco, mostra altrettanta coesione e visione di gruppo, tanto che la notizia dello scioglimento
della band, arrivata nel bel mezzo delle registrazioni di
un nuovo lavoro, nel 1997, lascia più di qualcuno sorpreso. Le motivazioni confuse addotte come giustificazione per la scelta di separarsi non possono comunque
preludere da quella principale, cioè la rottura del rapporta affettivo tra la Frazer e Guthrie. Le session per il
nuovo disco, nonostante più di qualche canzone fosse
finita, rimangono inedite e la Fontana non pubblicherà
più nulla per la band, che arrivata a questo punto deciderà di fare tutto in proprio.
Guthrie e Raymonde, nel 1999, inaugurano la Bella Union, etichetta totalmente controllata da loro, che
pubblica il doppio BBC Sessions, doppia compilation
che fotografa tutte le apparizioni live della band al
programma radiofonico inglese, dal 1983 al 1996, includendo ovviamente qualche traccia inedita. L’ultima
pubblicazione con materiale inedito a tutt’oggi. Dopo
di che sarà tutto un amarcord o un revival. 4AD pubblicherà dopo poco Stars And Toipsol, il loro best of,
tutto il catalogo rimasterizzato e soprattutto Lullabies
to Violaine, monumentale box set che riunisce tutti gli
ep e i singoli mai pubblicati dalla band. Tutte cose che
non fanno altro che aumentare la sensazione di vuoto lasciata dai tre, anche perché nel frattempo il verbo
degli scozzesi non passa affatto di moda, ma ritorna
in maniera incessante come uno delle influenze più
presenti e capillari della musica popolare degli ultimi
due decenni. A partire proprio dall’attività dei singoli.
Nessuno decide di appendere le scarpe al chiodo, ma
anzi tutti si ritagliano il proprio spazio. Robin Guthrie
rimane il più musicista in senso stretto dei tre. Al di là
dell’attività di autore di colonne sonore (Misterious
Skin) pubblica tre dischi solisti, dove riprende in larga
misura i suoni e gli effetti dei Cocteat Twins e forma una
nuova band, chiamata Violet Indiana, da cui non trarrà
però molte soddisfazioni. Anche Raymonde pubblica
un disco solista prima di dedicarsi ad una promettente carriera di produttore e tecnico del suono. La Frazer
invece rimarrà alla ribalta soprattutto grazie alle apparizioni in veste di guest star nei dischi di The Future
Sound Of London e soprattutto come voce femminile
di Mezzanine dei Massive Attack.
Ciò non toglie che il vuoto lasciato dai Cocteau Twins
rimane a tutt’oggi senza candidati ed eredi plausibili.
Neppure una reunion è stata concessa. Ad un certo
punto, sembrava che i tre dovessero apparire sul palco
dell’edizione 2005 del Coachella Festival, in perfetto timing con tanti altri (primi fra tutti i compagni di scuderia Dead Can Dance) che tornavano dall’oblio per una
nuova generazione, ma all’ultimo minuto un comunicato della Frazer rendeva la reunion impossibile per le
solite “questioni personali” che avevano minato la carriera di una delle poche band realmente fondamentali
della storia della musica popolare. L’ultima apparizione
insieme, qualche anno fa, ai Q Awards del 2008, per
ritirare il “Q Inspiration award”. Eppure alla fine poco
importa se non ci sarà mai più un nuovo disco firmato
Cocteau Twins. In ambito pop rock sono davvero pochi
i musicisti che possono vantare un lavoro altrettanto
denso, avventuroso, creativo per cui il ritornare sempre ai vecchi dischi sortisce sempre una sensazione di
riscaldamento emotivo. Come le vecchie foto ingiallite
dell’infanzia. Una volta esistenza una band che aveva
inventato un suono… malinconia. E’ questo l’umore
più aderente ai Cocteau Twins.
95
CAMPI MAGNETICI #2
classic album rev
Fabrizio De André
AR Kane
Storia di un impiegato (Ricordi, Luglio 1973)
69 (Rough Trade, Luglio 1988)
Storia di un impiegato rappresenta davvero un “campo magnetico”. E non tanto per l’influenza musicale
che ha avuto, quanto per come ha assorbito elementi
sociali e biografici dal momento storico in cui è stato
pubblicato. Sociali, perché il disco (uscito nel 1973)
rielabora le tematiche dei movimenti studenteschi
sessantottini, della controcultura ma anche dell’epoca
delle stragi (piazza Fontana risale al 1969). Biografici,
perché costringe per la prima volta il De Andrè anarchico e fuori dalle correnti politiche a prendere posizione sui cambiamenti in atto. Tanto da portarlo ad
esprimere una sorta di disagio postumo nei confronti
di un parto evidentemente sofferto: “Quando è uscito
Storia di un impiegato avrei voluto bruciarlo. Era la prima
volta che mi dichiaravo politicamente e so di avere usato
un linguaggio troppo oscuro, difficile. L’idea del disco era
affascinante: dare del Sessantotto una lettura poetica.
Invece è venuto fuori un disco politico. E ho fatto l’unica
cosa che non avrei mai dovuto fare: spiegare alla gente
come comportarsi”.
In realtà l’aspetto biografico non si limita soltanto a
questo. La stessa figura dell’impiegato che riflette sul
maggio francese non avendolo vissuto in prima persona, ricalca l’esperienza di un De Andrè emotivamente
toccato dai moti studenteschi ma estraneo all’attivismo. Mescolandosi a vicende legate alla vita privata di
quest’ultimo, come dichiara una Verranno a chiederti
del nostro amore in realtà dedicata a una relazione affettiva del cantautore.
Ad ogni modo, si parla di un’opera piuttosto controversa. Per un equivoco sulle intenzioni con l’allora coautore Giuseppe Bentivoglio ma anche per una verbosità eccessiva e a volte contorta (Al ballo mascherato)
riassorbita a fatica dall’impianto musicale. Quest’ultimo in bilico tra i prodromi di quella svolta progressive
che avverrà definitivamente grazie alla PFM nel 1979
(con il doppio In concerto) e gli arrangiamenti classici
di Nicola Piovani. A parte il folk di Canzone del maggio
e Nella mia ora di libertà, il resto è mescolanza, intreccio
96
tra modernità e tradizione. Con una La bomba in testa
attualizzata dal sintetizzatore di Giorgio Carnini e dai
ritmi sincopati della batteria di Enzo Restuccia; una
Sogno numero due in cui rimembranze Jethro Tull sostanziano il recitato imperioso del giudice che ringrazia l’impiegato per aver rafforzato con le sue bombe lo
status quo; una Il bombarolo che parte come una marcetta popolare quasi comica nel descrivere l’attentato
fallito, per poi concludersi con una coda orchestrale
maestosa.
Una mescolanza affascinante ma non priva di debolezze, per un disco che rimane uno specchio fedele di
un’epoca anch’essa difettosa, prolissa e piena di contraddizioni. In cui alla solidarietà sociale e alle conquiste
di civiltà si affiancava un’ideologia capace di blindare la
ragione e di sfociare nella stagione della tensione. In
questo senso, il Fabrizio De Andrè di Storia di un impiegato si rivela una cartina di tornasole importante, oltre
che un triste profeta di un decennio di devastazioni.
Fabrizio Zampighi
L’ascolto “a posteriori” di 69 è un’esperienza in tutti i sensi stupefacente. Semplici, in fondo, le ragioni: la storia
della musica è colma di geni loro malgrado in eccessivo
anticipo sui tempi; di visionari che vanno oltre il raccogliere lo spirito dei tempi che permea l’aria e tradurlo
in canzoni, e già basterebbe. Alcuni persino scrivono
regole che, nell’indifferenza diffusa, ci mettono anni
prima di divenire patrimonio comune. Nel caso degli
A.R. Kane riconosci un misto delle circostanze di cui sopra, con un successo planetario sotto mentite spoglie
a confondere ulteriormente le carte. Un passo indietro
alla fine degli anni ’80, adesso: l’ortodossia rock sta cadendo sotto i colpi del crossover e “contaminazione” diventa la parola d’ordine, che prevarrà lungo il decennio
successivo riverberandosi fino ai giorni nostri.
In quelli, di giorni, cadevano i muri e il mondo come
lo conoscevamo perdeva le certezze su cui si era basato dal dopoguerra in poi, mentre il pop gli andava felicemente dietro. Presto il 1991 avrebbe fatto piazza pulita dei manichei e la nostra musica sarebbe cambiata
per sempre e per fortuna. A Londra, in un ’86 dominato
da bellimbusti da classifica e da un indie-sound dedito alla riscoperta - in certi casi, alla rielaborazione - dei
Sessanta, si incontrano Alex Ayuli e Rudi Tambala: il
primo singolo si guadagna spallucce e la definizione di
“Jesus & Mary Chain di colore”. Cosa che in parte sono,
ancorché più attenti alla componente ritmica (felice retaggio di negritudine) e ovviamente più psichedelici
dei fratelli Reid. Chiarisce in parte le cose il passaggio
da One Little Indian a 4AD per l’e.p. Lollita, pop onirico
asperso di feedback prodotto da Robin Guthrie di Cocteau Twins. Ancora non lo chiamano shoegaze, però in
anticipo ci siamo eccome.
Succede poi che il capo dell’etichetta Ivo WattsRussell persuada il duo a far comunella con Martyn e
Steven Young dei Colourbox, più l’asso della consolle
Chris “C.J.” Mackintosh e il DJ Dave Dorrell: in testa
l’idea meravigliosa di un brano prodotto basandosi
solo su campionamenti e breakbeat. Dell’epocale Pump
Up The Volume si smerciano milioni di copie, portando
l’avanguardia in classifica e incidendo sulle sorti della
black music a venire. Siccome il progetto M/A/R/R/S
non va oltre, i piccati A.R. Kane approdano a Rough
Trade per un esordio che non tradisce le attese createsi nel frattempo. Gran parte della bellezza atemporale
di 69, oltre che nel tratteggiare in modo sensazionale
e con largo anticipo alcuni momenti chiave degli anni
Novanta, sta infatti in sonorità sospese e “oceaniche”.
Come dei My Bloody Valentine che trattengono le
distorsioni sullo sfondo per lavorare sul ritmo, lasciano
emergere melodie eteree e un canto che - lambendo
il Tim Buckley più trasparente - si inerpica tra volute
di psych-funk siderale toccando una musica di sfere
celesti, però fisica. Liquidi groove e slarghi dub si sciolgono dentro il noise-pop in voga e indicano la strada a
Bark Psychosis e Seefeel, si staccano per inventiva e
piglio sia dal plotone degli “osservatori di scarpe” che
dagli austeri alabastri di scuola 4AD. Miracolo a sé stante, l’estetica di 69 (ineguagliato anche dagli artefici: un
anno dopo i sarà stimolante benché dispersivo; Americana e New Clear Child avranno tra ’92 e ’94 viceversa
poco da dire) porge un’estasi sensuale e insieme spirituale, canzoni-collage che si arrestano un attimo prima
di perdere forma e trasporto emotivo. Anche in questo,
una fulgida lezione per la contemporaneità.
Giancarlo Turra
97