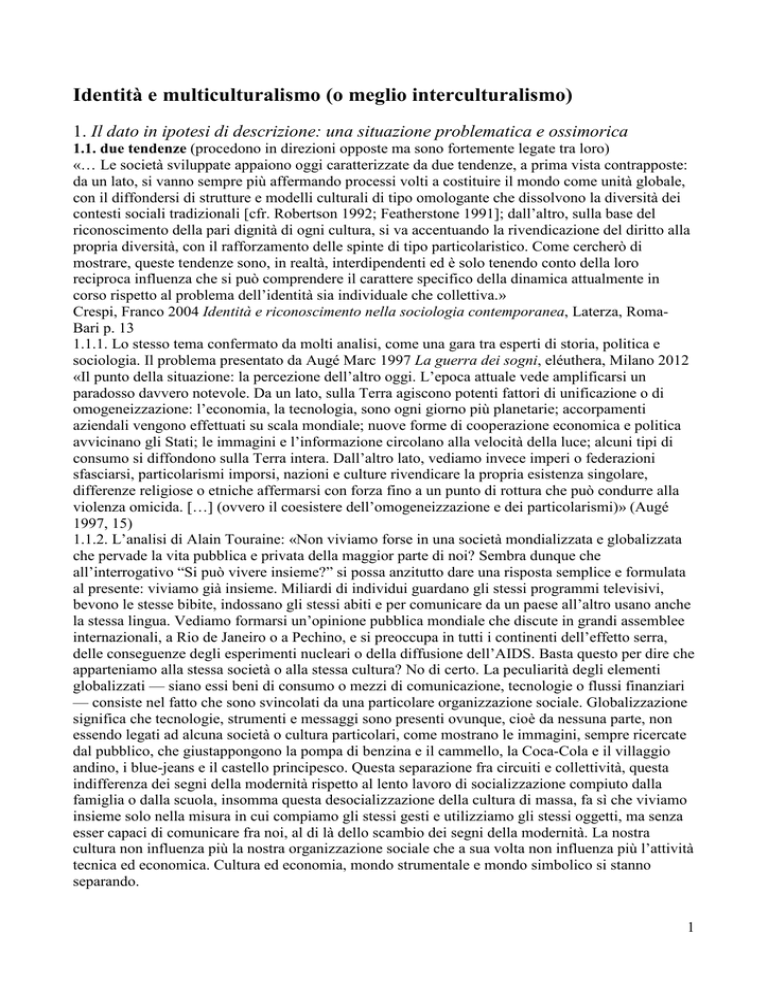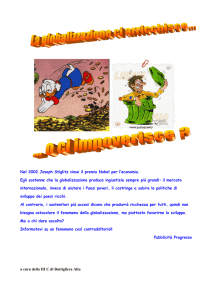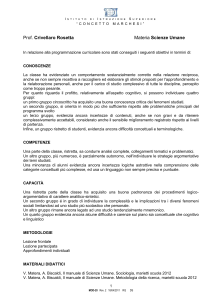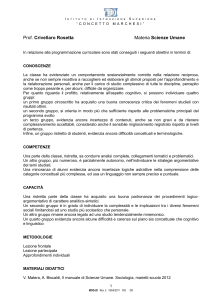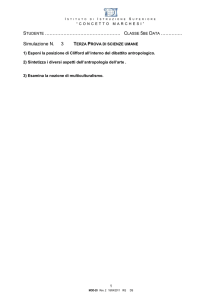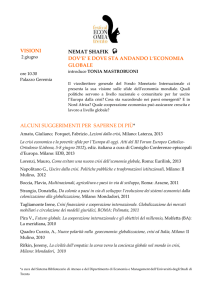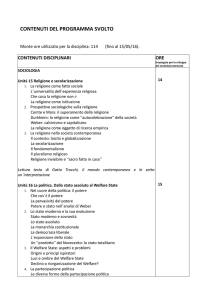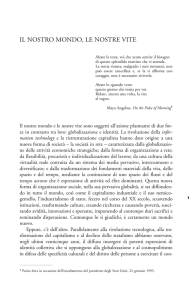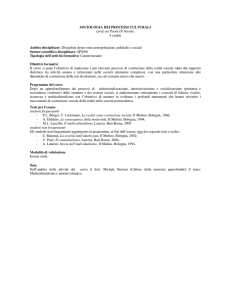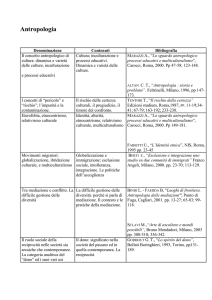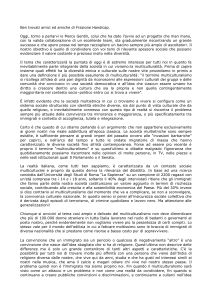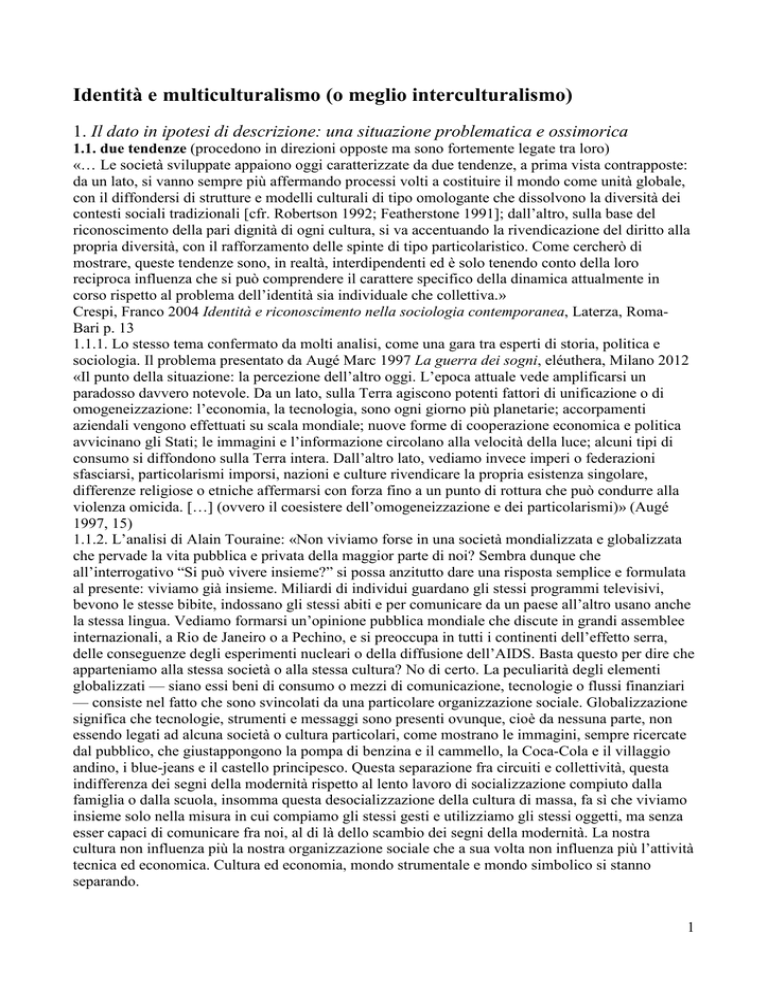
Identità e multiculturalismo (o meglio interculturalismo)
1. Il dato in ipotesi di descrizione: una situazione problematica e ossimorica
1.1. due tendenze (procedono in direzioni opposte ma sono fortemente legate tra loro)
«… Le società sviluppate appaiono oggi caratterizzate da due tendenze, a prima vista contrapposte:
da un lato, si vanno sempre più affermando processi volti a costituire il mondo come unità globale,
con il diffondersi di strutture e modelli culturali di tipo omologante che dissolvono la diversità dei
contesti sociali tradizionali [cfr. Robertson 1992; Featherstone 1991]; dall’altro, sulla base del
riconoscimento della pari dignità di ogni cultura, si va accentuando la rivendicazione del diritto alla
propria diversità, con il rafforzamento delle spinte di tipo particolaristico. Come cercherò di
mostrare, queste tendenze sono, in realtà, interdipendenti ed è solo tenendo conto della loro
reciproca influenza che si può comprendere il carattere specifico della dinamica attualmente in
corso rispetto al problema dell’identità sia individuale che collettiva.»
Crespi, Franco 2004 Identità e riconoscimento nella sociologia contemporanea, Laterza, RomaBari p. 13
1.1.1. Lo stesso tema confermato da molti analisi, come una gara tra esperti di storia, politica e
sociologia. Il problema presentato da Augé Marc 1997 La guerra dei sogni, eléuthera, Milano 2012
«Il punto della situazione: la percezione dell’altro oggi. L’epoca attuale vede amplificarsi un
paradosso davvero notevole. Da un lato, sulla Terra agiscono potenti fattori di unificazione o di
omogeneizzazione: l’economia, la tecnologia, sono ogni giorno più planetarie; accorpamenti
aziendali vengono effettuati su scala mondiale; nuove forme di cooperazione economica e politica
avvicinano gli Stati; le immagini e l’informazione circolano alla velocità della luce; alcuni tipi di
consumo si diffondono sulla Terra intera. Dall’altro lato, vediamo invece imperi o federazioni
sfasciarsi, particolarismi imporsi, nazioni e culture rivendicare la propria esistenza singolare,
differenze religiose o etniche affermarsi con forza fino a un punto di rottura che può condurre alla
violenza omicida. […] (ovvero il coesistere dell’omogeneizzazione e dei particolarismi)» (Augé
1997, 15)
1.1.2. L’analisi di Alain Touraine: «Non viviamo forse in una società mondializzata e globalizzata
che pervade la vita pubblica e privata della maggior parte di noi? Sembra dunque che
all’interrogativo “Si può vivere insieme?” si possa anzitutto dare una risposta semplice e formulata
al presente: viviamo già insieme. Miliardi di individui guardano gli stessi programmi televisivi,
bevono le stesse bibite, indossano gli stessi abiti e per comunicare da un paese all’altro usano anche
la stessa lingua. Vediamo formarsi un’opinione pubblica mondiale che discute in grandi assemblee
internazionali, a Rio de Janeiro o a Pechino, e si preoccupa in tutti i continenti dell’effetto serra,
delle conseguenze degli esperimenti nucleari o della diffusione dell’AIDS. Basta questo per dire che
apparteniamo alla stessa società o alla stessa cultura? No di certo. La peculiarità degli elementi
globalizzati — siano essi beni di consumo o mezzi di comunicazione, tecnologie o flussi finanziari
— consiste nel fatto che sono svincolati da una particolare organizzazione sociale. Globalizzazione
significa che tecnologie, strumenti e messaggi sono presenti ovunque, cioè da nessuna parte, non
essendo legati ad alcuna società o cultura particolari, come mostrano le immagini, sempre ricercate
dal pubblico, che giustappongono la pompa di benzina e il cammello, la Coca-Cola e il villaggio
andino, i blue-jeans e il castello principesco. Questa separazione fra circuiti e collettività, questa
indifferenza dei segni della modernità rispetto al lento lavoro di socializzazione compiuto dalla
famiglia o dalla scuola, insomma questa desocializzazione della cultura di massa, fa sì che viviamo
insieme solo nella misura in cui compiamo gli stessi gesti e utilizziamo gli stessi oggetti, ma senza
esser capaci di comunicare fra noi, al di là dello scambio dei segni della modernità. La nostra
cultura non influenza più la nostra organizzazione sociale che a sua volta non influenza più l’attività
tecnica ed economica. Cultura ed economia, mondo strumentale e mondo simbolico si stanno
separando.
1
Mentre le nostre piccole società vanno a poco a poco amalgamandosi in una società mondiale,
assistiamo alla dissoluzione di quei complessi, politici e territoriali, sociali e culturali, che
chiamiamo società, civiltà o più semplicemente paesi. Vediamo separarsi, da un lato, l’universo
oggettivato dei segni della globalizzazione e, dall’altro, insiemi di valori, espressioni culturali e
luoghi della memoria, che non costituiscono più delle società nella misura in cui sono privati della
loro attività strumentale ormai globalizzata, e si chiudono quindi in se stessi dando sempre più la
priorità ai valori piuttosto che alle tecniche, alle tradizioni piuttosto che alle innovazioni. É vero che
viviamo un po’ insieme su tutto il pianeta, ma e altrettanto vero che ovunque si rafforzano e si
moltiplicano i gruppi identitari, le associazioni basate su una comune appartenenza, le sette, i culti, i
nazionalismi; le società ridiventano comunità allorché riuniscono strettamente in un determinato
territorio società, cultura e potere sotto un’autorità religiosa, culturale, etnica o politica che
potremmo definire carismatica, dato che essa trova la sua legittimità non nella sovranità popolare,
nell’efficacia economica oppure nella conquista militate, ma nelle divinità, nei miti o nelle
tradizioni di una comunità. Quando siamo tutti insieme non abbiamo quasi niente in comune,
mentre quando condividiamo delle credenze e una storia rifiutiamo chi è diverso da noi.
Viviamo insieme solo se perdiamo la nostra identità; mentre il ritorno delle comunità comporta un
richiamo all’omogeneità, alla purezza, all’unità, e la comunicazione viene sostituita dalla guerra tra
coloro che offrono sacrifici a divinità diverse, si richiamano a tradizioni estranee ed opposte fra loro
e che talvolta si considerano biologicamente diversi dagli altri e superiori ad essi.» Touraine Alain
1997 Libertà, uguaglianza, diversità. Si può vivere insieme?, il Saggiatore, Milano 1998, 10-13
1.1.3. «È morta la società. Trionfa l’apparato. E sono in crescita (un’autentica resurrezione, dopo i
disastri prodotti nel passato dal trionfo delle logiche comunitarie: nazione, patria, razza, religione,
nazionalismo) le comunità: nelle retoriche del fare comunità quale via facile per avere un’identità e
per superare la paura della non identità; nelle retoriche delle comunità virtuali, diverse dalle
vecchie comunità perché faciliterebbero l’entrata e l’uscita, quindi sarebbero comunità aperte,
virtuose, condivise anche se dominate dalla liquidità e dall’instabilità. Morte le identità di classe
restano, come sottoprodotto della cosiddetta postmodernità (in realtà, nessuna postmodernità, ma
sempre, e sempre più, modernità), le identità di comunità (territoriali, etniche, virtuali, di fantasia,
di spettacolo; forti, potenti, ma ancora, come sempre, socialmente e politicamente pericolose; e poi
identità di marca, di brand, le merci, le cose). Anzi, in queste diverse modalità di ricerca e di
illusione/allusione di comunità si rafforza (viene fatta rafforzare, viene prodotta mediante
un’appropriata biopolitica) quella che Francesco Remotti ha definito come un’ossessione
identitaria. (F. Remotti, L’ossessione identitaria, Laterza, Roma-Bari 2010)» Demichelis Lelio
2010 Società o comunità. L’individuo, la libertà, il conflitto, l’empatia, la rete, Carocci editore,
Roma, p. 28)
«Perché se per Bauman l’identità è un «surrogato di comunità», per Remotti l’identità è soprattutto
una parola avvelenata, «perché promette ciò che non c’è, perché ci illude su ciò che non siamo;
perché fa passare per reale ciò che invece è una finzione o, al massimo, un’aspirazione». Non di
riconoscimenti identitari avremmo bisogno (questa la biopolitica dominante), ma (ancora Remotti)
del riconoscimento delle esistenze dei soggetti, dei loro diritti, dei loro obiettivi, dei loro progetti,
delle loro diversità.» (Demichelis 2010, 28)
1.1.4. «Stiamo entrando, temo, in un’era problematica. Non saranno soltanto i terroristi, le banche e
il clima a sconvolgere il nostro senso di sicurezza e di stabilità. La globalizzazione stessa — la terra
"piatta" di tante fantasie ireniche — sarà fonte di paura e incertezza per miliardi di persone, che si
rivolgeranno ai loro leader in cerca di protezione. Le "identità" diventeranno rigide e meschine, via
via che l’indigente e lo sradicato batteranno contro le mura sempre più alte delle comunità recintate
e sorvegliate, da Delhi a Dallas.» (Judt Tony, Lo chalet della memoria, Laterza, Roma-Bari 2011
citazione da la Repubblica 25 novembre 2011)
Globalizzazioni e rivendicazioni identitarie sono in opposizione in realtà sono strettamente
connessi. Le volontà identitarie sono reattive alle paure collegate e attribuite (più o meno
fondatamente) alla globalizzazione. Ma il timore per la globalizzazione non si traduce in negazione
2
dei vantaggi e delle opportunità che essa produce e a cui nessuno (nemmeno i no-global), nei fatti,
intende rinunciare. La possibilità di disporre di una libertà di movimento e di scelta di area sempre
più vasta, mondiale, riguardante merci e informazioni diventa spesso, paradossalmente, strumento
indispensabile per la costruzione e la rivendicazione pubblica di riconoscimenti identitari e degli
stessi movimenti antiglobalizzazione.
1.1.5. In forma di preoccupazione e domanda storica: « Che accadrà ora, nel punto storico in cui la
solidità dei «luoghi» sembra vacillare e sciogliersi sotto la spinta travolgente dei «flussi»; e quelle
linee di confine che avevano delimitato lo spazio del Logos e la signoria del Nomos farsi incerte e
impermeabili? Avevamo tutti (o quasi) provato uno straordinario senso di sollievo, e di liberazione,
al tempo del «crollo dei muri»: di quelli fisici (e politici), sotto la spinta delle rivoluzioni incruente
di fine Novecento; e di quelli economici (e finanziari), per effetto di quella grande «rivoluzione
spaziale» che è la globalizzazione. Avremmo dovuto sospettare che in quell’improvviso
abbassamento delle mura della città, attraverso le brecce aperte nelle barriere che avevano
circondato fino ad allora le nostre «sfere vitali», qualcosa sarebbe filtrato «dall’esterno» a
decostruire la nostra domesticità faticosamente stabilizzata. E, simmetricamente, che qualcosa
sarebbe fuoriuscito (si sarebbe «liberato») di quanto tra quelle mura era stato posto sotto custodia, a
cominciare da quella potenza assoluta — quella potestas superiorem non recognoscens, per dirla
con i classici — che si chiama appunto «sovranità». E che costituisce l’alfa e l’omega della
costruzione dell’ordine interno della civitas.» (Revelli Marco 2012 I demoni del potere, Laterza,
Roma-Bari, X-XI)
1.1.6. Contraddizioni e ambivalenze: torna il problema, logico e politico, di come muoversi, gestire
e stare tra gli estremi. Globalizzazione stimata e non rifiutata, rivendicazioni identitarie localistiche
ostentate ma nelle quali non si vive se non per altri fini si presentano come processi tra loro estremi.
Come gestirli. Gli estremi, correttamente gestiti all’interno di una razionalità di problem solving,
non sostengono scelte e progetti di estremizzazione (se non appunto in casi estremi, di chi
estremizza) ma indicano, in quanto estremi, l’ampiezza e i termini di un campo di azione in cui si
ragiona, si progetta e si opera: indicano l’area di gestione della politica contemporanea. Per questa
area occorre mettere a disposizione una adeguata strategia politica, ed è il filo conduttore della
analisi e proposta di John Rawls ispirate a un “liberalesimo democratico” (Rawls John 1971, 1999
Una teoria della giustizia, Milano Feltrinelli, 2008; Rawls John 2005 Liberalismo politico. Nuova
edizione ampliata, Einaudi, Torino 2012)
1.2. termini e problemi recenti identità e multiculturalismo
1.2.1. i termini identitari.
«Eric Hobsbawm fa notare come la comparsa dei termini «identità», «etnicità» e simili sia quanto
mai recente. Nell’Enciclopedia internazionale delle scienze sociali, ancora nei 1968 non compare
nessuna voce al termine identità, se non in riferimento a quella psicosociale degli adolescenti, e
all’inizio degli anni Settanta nell’ Oxford English Dictionary l’etnicità appare come parola rara
associata a paganesimo e superstizioni pagane. Rossana Rossanda afferma: «ancora trent’anni la, se
si fosse chiesto a uno o a una di noi «chi sei?», avremmo risposto in termini di «che cosa faccio» o
«da che parte mi schiero», piuttosto che da dove o da chi provengo.» E conclude affermando che
l’etnia è un soggetto moderno o postmoderno di conflitto.
È sintomatico che ci si trovi sempre più spesso a parlare di identità proprio mentre la cosiddetta
globalizzazione ci sta avvolgendo ogni giorno di più nel suo mantello uniforme. Per dirla con Regis
Debray: “gli oggetti si mondializzano, i soggetti si tribalizzano”».
Aime, Marco 2004 Eccessi di culture, Einaudi Torino p. 123
1.2.2. il multiculturalismo (società di tutti o di ciascuno)
«Ambiguo, enigmatico, irriducibilmente e costitutivamente equivoco (Leghissa, Zoletto 2002), il
multiculturalismo è oggi al centro di un ampio dibattito transdisciplinare, come uno dei cardini del
discorso pubblico sul presente e sul futuro delle società contemporanee.
Termine abusato quanto poco problematizzato, nella sua formula più astratta il concetto fa
3
riferimento alla presa di coscienza dell’esistenza di una molteplicità di differenze, quale scenario
inedito di un processo — per alcuni auspicabile, per altri minaccioso, per molti inarrestabile — di
trasformazione radicale delle società e della politica. In questo senso il multiculturalismo
presuppone, pretende di descrivere, spesso intende orientare, i processi sociali connessi a tale nuova
dimensione, in cui l’eterogeneità non è più elemento accidentale e instabile, ma è assunta come
tratto costitutivo di nuovi assetti, esprimendone tensioni e conflitti — culturali prima e politici poi
— come aspettative di riconoscimento. In questi termini, a dispetto di uno scarso livello di
chiarezza interpretativa, anzi per la caratteristica di confondere insieme diversi registri (Wieviorka
1998), esso rappresenta elemento e insieme fattore della costruzione della sfera globale della
comunicazione. Come parte del lessico ne condivide così l’incertezza epistemologica e, paradosso
della mondializzazione, quella “sovraesposizione comunicativa” che diviene direttamente
attestazione.
1.2.3. identità e multiculturalismo: reciproco influsso.
Quello che si viene configurando è un nuovo “spazio identitario” che nella “quotidianità del sistema
globale” (Friedman 2005) si esprime come aspettativa, scelta, cambiamento e gestione di una
pluralità di stili di vita, nell’inedita intensità di circolazione di modelli, flussi e consumi. Alla base
di tale ridefinizione, secondo Jonathan Friedman, c’è la dissoluzione delle identità sociali statiche e,
di conseguenza, «la comparsa del moderno soggetto individualizzato, privo di una cosmologia o di
un’autodefinizione prefissata. Le peculiarità di questo Sé sono la sua separazione in una sfera
privata=naturale e pubblica=culturale o sociale, che crea un’ambivalenza fondamentale fra il
desiderio di trovare un’adeguata espressione del proprio Sé e la consapevolezza che ogni identità è
costruita arbitrariamente, e quindi non è mai autentica.»
1.2.4. Quali differenze “identitarie” nel multiculturalismo (breve ricognizione orientativa)
Quello che è certo è che nell’uso il multiculturalismo consente di associare un ampio spettro di non
meglio definite “questioni identitarie” alla dimensione della convivenza civile e alla sfera della
politica. Parafrasando Wieviorka (1998), si può dire che esso rappresenti contemporaneamente “il
problema”, “la risposta” e, di conseguenza, la valutazione dell’“effetto”. Per restituire questa
articolazione la letteratura distingue un uso “descrittivo” più marcatamente sociologico, uno
“ideologico e normativo” di pertinenza filosofico-giuridica, e uno “programmatico e politico”
prettamente politologico (Inglis 1996; Lanzillo 2005; Watson 2000).
Un riferimento interpretativo utile è il quadro analitico proposto ancora da Wieviorka (1998), che
distingue quattro logiche della differenza: la prima è quella di cui sono portatori i gruppi che
preesistevano alla definizione politica delle società nazionali, appunto le minoranze native, gli
autoctoni, in cui l’affermazione identitaria combina il “sentimento di anteriorità”, quindi la
legittimità sul piano storico, con la coscienza di essere state vittime di pratiche etnocidarie e di
processi di inferiorizzazione sociale. La seconda è quella relativa alle “logiche dell’accoglienza”,
ovvero alle conseguenze delle migrazioni internazionali, dunque al confronto con le dinamiche di
trasformazione e con le particolari configurazioni locali di senso, nel rapporto tra persone, bagagli e
capitali culturali diversi, che il migrare comporta (Pompeo 2002). La terza è definita come “logica
della riproduzione”, in cui, in analogia con la prima, segmenti sociali portatori di un’esperienza
storica singolare cercano di mantenere legami con una cultura concepita in termini patrimoniali,
come un’eredità da mantenere viva e la cui sopravvivenza, in un modello che riprende l’ecologismo
e la tutela della biodiversità, è minacciata dalla statualità o dal mercato, infine la quarta è quella
denominata “logica della produzione” in cui la differenza culturale appare un derivato del processo
di invenzione permanente che caratterizzerebbe la globalizzazione, in cui le identità si trasformano
e ricompongono, dove non esisterebbe un principio di stabilità definitivo. A questo modello
sarebbero riconducibili le rivendicazioni di nuovi soggetti della scena pubblica, dall’universo
GLBT, acronimo che definisce la galassia gay, lesbo, bisessuale e transgender, ai “bisogni speciali”
di altre community, come nelle diverse abilità.
Pompeo Francesco (a cura di) 2007 La società di tutti. Multiculturalismo e politiche dell’identità,
Meltemi, Roma (pp. 9-17 passim e ad eccezione dei titoli di paragrafi con numeri)
4
2. Incubatori o sedi di identità
2.1. passaggio storico: l’identità romantica dei popoli (rapsodi e poemi)
«Il passato ricreato, è il grande Altro storico rispetto al quale può affermarsi un’identità presente.»
Augé Marc 1997 La guerra dei sogni, eléuthera, Milano 2012, 20
2.1.01. Due note - provocazione
una generale: «Perché la formazione di uno Stato sovrano nel sistema interstatale dovrebbe creare a
sua volta una “nazione”, un “popolo”? …discutibile fino a che punto la “nazione” come sentimento
comune avesse radici profonde prima della creazione dello Stato … perché si vuole o si ha bisogno
di un passato, di una “identità”? … tramite il senso del passato le persone si convincono ad agire nel
presente in modi in cui altrimenti non agirebbero … il presente determina il passato, e non
viceversa, come le nostre strutture analitiche logico-deduttive ci inducono a pensare»
Wallerstein, Immanuel, Alla scoperta del sistema mondo, manifestolibri, Milano 2005, p.330 ss
una realistico-ironica sul Risorgimento italiano: «Ma giugnea fraditanto una carretta tirata da uno
scheletro di mulo come quello famelico in galoppo sopra le teste di papi e principi e madame al
palazzo Sclàfani in Palermo. Un carrettiere estrano con casacca rossa, fazzoletto e berretto a
cazzarola con visiera, all’impiedi sopra il legno, strappando redini e frustando, vociava: - Uuh, uuh,
broeta bestia, marouchì poa te!
Sghignazzano altri tre appresso al carro, vestiti come il primo, che con sciabole revolver e carabine
tengon prigione in mezzo a loro un gruppo d’alcaresi. Chi sono? Sono i soldati nordici sbarcati con
Garibaldi a liberarci dal giogo del Borbone. Sì, sono d’altro lignaggio.»
Consolo, Vincenzo 1976 Il sorriso dell’ignoto marinaio, Einaudi, Torino 1992, p.109
2.1.1. Un bilancio sull’Europa delle identità popolari e nazionali
Note da Thiesse, Anne-Marie 2001 La creazione delle identità nazionali in Europa, Il Mulino,
Bologna
«Nulla è più «internazionale» della formazione delle identità nazionali. È un paradosso enorme, dal
momento che l’irriducibile specificità di ogni identità nazionale è stata pretesto di scontri
sanguinosi, eppure identico è il modello, messo a punto nel quadro di intensi scambi internazionali.
Le nazioni moderne si sono costituite in modo diverso da come raccontano le storie ufficiali. Le
loro origini non si perdono nella notte dei tempi, nelle età oscure ed eroiche descritte dai capitoli
iniziali delle storie nazionali. Neppure la lenta formazione di territori in seguito a conquiste e
alleanze è stata all’origine delle nazioni, poiché essa altro non è che la storia tumultuosa dei regni o
dei principati. La vera nascita di una nazione è il momento in cui un pugno di individui dichiara che
essa esiste e cerca di dimostrarlo. I primi esempi non sono anteriori al XVIII secolo, non essendovi
nazioni in senso moderno, cioè politico, prima di questa data. L’idea si inserisce, in realtà, nel
quadro di una rivoluzione ideologica. La nazione è concepita come una comunità vasta, tenuta
insieme da vincoli che non si riferiscono alla dipendenza da uno stesso sovrano, né all’appartenenza
a una stessa religione o a una stessa classe sociale: essa non è determinata dal monarca, la sua
esistenza è indipendente dai rischi della storia dinastica o militare. La nazione somiglia
straordinariamente al popolo della filosofia politica, quei popolo che da solo, secondo i teorici del
contratto sociale, può conferire la legittimità del potere, ma è anche qualche cosa di più: il popolo è
un’astrazione, la nazione è viva. 7-8
Il processo di formazione identitario consiste nel determinare il patrimonio di ogni nazione e nel
diffonderne il culto. La prima fase dell’operazione non è stata così evidente, poiché in realtà gli
antenati non avevano redatto un testamento indicante ciò che desideravano trasmettere ai
discendenti, ed era oltretutto necessario scegliere fra gli antenati i presunti donatori, ossia trovare
ipotetici ascendenti comuni agli alverniati e ai normanni (o agli svevi e ai sassoni, ai siciliani e ai
piemontesi). Perché si producesse il nuovo mondo delle nazioni, non era sufficiente inventariarne
l’eredità, si doveva piuttosto inventarlo. Ma come? Che cosa era necessario escogitare alfine di dare
la testimonianza vivente di un passato prestigioso e l’immagine autorevole della coesione
5
nazionale? Il compito era arduo, di lunga durata e fu svolto collettivamente. Un grande cantiere di
sperimentazione, senza capomastro eppure intensamente animato, venne aperto in Europa nel
Settecento: esse conobbe l’epoca di maggiore produttività nel secolo successivo e la sua
caratteristica fu quella di essere transnazionale. Non vi è stato accordo preventivo o divisione del
lavoro; ma ogni singolo gruppo nazionale si mostrava molto attento a quanto facevano i loro simili
e rivali, cercando di adattare alle proprie esigenze le idee degli altri e venendo a sua volta imitato,
quando aveva scoperto qualcosa di nuovo o era riuscito a migliorare l’esistente. Appena i letterati
tedeschi avevano esortato, con successo, i compatrioti a seguire l’esempio inglese nella
riesumazione del patrimonio culturale e nazionale, i loro omologhi scandinavi o russi invitavano a
prendere esempio dai tedeschi. Qualche decennio più tardi, gli eruditi francesi fustigavano i
concittadini che avevano esitato a impegnarsi in un’impresa che, nel frattempo, era stata un banco
di prova per russi, spagnoli e danesi. Le esposizioni internazionali, luoghi privilegiati di esibizioni
identitarie, sono state, a partire dalla metà dell’Ottocento, occasioni privilegiate di questo
commercio simbolico. Le rivalità furono aspre, ma in genere pacifiche, gli accordi frequenti, come
pure gli scambi di consigli o anche gli incoraggiamenti agli esordienti.
Il risultato della creazione collettiva delle identità nazionali non è un modello unico, ma piuttosto
secondo l’espressione provocatoria del sociologo Orvar Löfgren, una sorta di kit per il «fai da te»:
una serie di declinazioni dell’«anima nazionale» e un insieme di procedure necessarie alla loro
elaborazione. Oggi siamo in grado di redigere la lista di elementi simbolici e materiali che una
nazione degna di questo nome deve offrire: una storia che stabilisca la continuità con i grandi
antenati, una serie di eroi prototipi di virtù nazionali, una lingua, dei monumenti culturali, un
folclore, dei luoghi sacri e un paesaggio tipico, una mentalità particolare, delle rappresentazioni
ufficiali — inno e bandiera — e delle identificazioni pittoresche — costume, specialità culinarie o
animale totemico. Le nazioni che di recente hanno avuto diritto al riconoscimento politico, e
soprattutto quelle che ancora lo rivendicano, testimoniano, insieme ai segnali che inviano per
attestate la propria esistenza, il carattere prescrittivo di questa lista di priorità identitaria. Il «sistema
Ikea» di costruzione delle identità nazionali, che permette assemblaggi differenti a partire dalle
stesse categorie elementari, appartiene al dominio pubblico mondiale, avendolo l’Europa esportato
nello stesso tempo in cui imponeva alle vecchie colonie il proprio modo di organizzazione politica.
Il ricorso alla lista identitaria è il mezzo più banale, perché più immediatamente comprensibile, di
rappresentare una nazione, che si tratti della cerimonia di apertura dei giochi olimpici, delle
accoglienze riservate a un capo di stato straniero, dell’iconografia postale e monetaria o della
pubblicità turistica.
La nazione nasce da un postulato o da un’invenzione, ma essa vive solo per l’adesione collettiva a
questa finzione. I tentativi abortiti sono numerosissimi, mentre i successi sono il frutto di un
costante proselitismo che insegna agli individui ciò che sono, li obbliga a conformarsi al modello
proposto e li incita a diffondere a loro volta quel sapere collettivo. Il sentimento nazionale è
spontaneo solo quando è stato perfettamente interiorizzato ma per ottenere ciò occorre anzitutto
averlo insegnato. La messa a punto di una pedagogia è il risultato di osservazioni basate su
esperienze condotte in altre nazioni e trasposte quando sembrava opportuno farlo. 8-10»
Thiesse, Anne-Marie 2001 La creazione delle identità nazionali in Europa, Il Mulino, Bologna
2.1.1.1. La linea culturale in atto: la distinzione tra tre culture e formazione/invenzione, in forma di
scoperta, della cultura popolare e del soggetto popolo.
Al modello classico, che fa perno sugli autori greci e latini per tesi, stili di razionalità e canoni
estetici, e al modello della cultura cristiana, o meglio ebraico-cristiana, richiamata per gli aspetti
teologici e morali, si vuole ora affiancare (in clima politico) una terza componente dichiarata
autonoma e originaria: la cultura popolare. Il popolo è depositario orale di una cultura propria
(pagana, medievale e barbara); aedi, bardi e trovadori ne sono i cantori; quella cultura è costitutiva
di identità e permette il definirsi di un nuovo soggetto, il popolo, che proprio nell’800 prende forma
di nazione. Si tratta di una tesi romantica maturata soprattutto in clima antiassolutistico e come
espressione di nuova sensibilità (definita “romantica”) mirante a sostenere progetti nazionali, resa
6
efficace storicamente attraverso una sua opportuna collocazione in età remota, per lo più medievale,
opportunamente ripresa e rivalutata.
2.1.1.2. Passaggio storico filosofico critico: utilità e danno della storia
Dalle note critiche (“considerazioni inattuali”) di Nietzsche sulla storia monumentale, antiquaria,
critica e il nuovo senso della storia, legate al tema dell’eterno ritorno (I considerazione inattuale)
Si oppone alla storia:
a. monumentale, che si impossessa del passato, selezionandolo, per creare qualcosa di grande oggi o
pensando ad una storia affidata a grandi figure (“uomini a cavallo”)
b. degli antiquari che venera il passato per vantare e imporre lunghe tradizioni
c. critica di coloro che, afflitti dal presente, ricavano dal passato una storia per giudicare e
condannare ( i perenni laudatores temporis acti).
Vi contrappone un nuovo stile:
a. il metodo genealogico come prassi ermeneutica della liberazione: il metodo di analisi adottato da
Nietzsche è la genealogia ermeneutica: la demolizione della presa che le culture del disprezzo
esercitano sull’uomo riducendolo a gregge, massa, schiavo, venerazione… si ottiene attraverso la
ricostruzione di come queste culture sono diventate valori indiscussi e venerati; la ricostruzione
(ermeneutica) della loro affermazione (genealogia) diventa un’arte dello smontaggio, del loro
annullamento (nichilismo) e della conseguente liberazione dell’uomo verso l’oltre uomo.
b. l’amor fati (vedi sopra): liberarci di tutto ciò che il passato ha caricato sulle nostre spalle non con
il rifiuto o con la dimenticanza [resterebbe sempre attivo, alla Freud], ma con il riconoscimento che: a)
non poteva essere diversamente b) è passato e non può decidere il presente [lo voglio come passato]
c. l’eterno ritorno: nell’attimo, nel presente dell’atto di volontà, il tempo è consegnato all’azione,
all’io voglio, alla volontà di potenza … [nell’attimo e solo nell’attimo si sceglie sempre la totalità
del tempo]
2.1.1.3. Passaggio storiografico politico critico nei confronti di facili e pericolose fabbriche
politiche di identità ad hoc (gabbie identitarie confezionate per opportunità).
«Lo Stato può produrre inesistente mediante l’imposizione di una figura di normalità identitaria,
«nazionale» o altro. In Europa, in particolare, la questione dell’identità è una questione
ossessionante. […] Variamente ripetute dagli uni e dagli altri, potremmo anche considerare tali
dichiarazioni solo come una specie di follia ideologica, se non fossero sostenute dalla macchina con
cui lo Stato fabbrica «identità» fantomatiche, una macchina sempre pronta a funzionare. […] Lo
Stato può quasi essere definito come un’istituzione che dispone di tutti gli strumenti per imporre a
una popolazione una serie di norme che prescrivono quanto è di sua competenza, quanto rientra nei
diritti e quanto rientra nei doveri. Nel quadro di questa definizione, lo Stato pone la finzione di un
oggetto identitario (per esempio il «francese» medio) a cui individui e gruppi hanno l’obbligo di
assomigliare il più possibile per meritare una positiva attenzione da parte di esso. Chiunque venga
dichiarato troppo dissimile all’oggetto identitario avrà ugualmente diritto all’attenzione dello Stato,
ma in senso negativo (sospetto, controllo, internamento, espulsione ecc.).
Un nome separatore indica una particolare maniera di non assomigliare all’oggetto identitario
fittizio. Tale nome permette allo Stato di separare dalla collettività un certo numero di gruppi e di
giustificare il ricorso a particolari misure repressive. Può trattarsi di «immigrato», «islamista»,
«musulmano», «Rom» ma anche «giovane della periferia». Notiamo che «povero» e «malato
mentale» si stanno man mano costituendo sotto i nostri occhi in quanto nomi separatori.» (Badiou
Alain 2011 Il risveglio della storia, Adriano Salani Editore Milano 2012, 75, 76, 96-97)
2.2. passaggio sociologico: identità nella società multiculturale
2.2.1. descrizione “critica”: “ogni cultura è già di per sé multiculturale”
«Il tuo Cristo è ebreo. La tua macchina è giapponese. La tua pizza è italiana. La tua democrazia
greca. Il tuo caffè brasiliano, la tua vacanza turca. I tuoi numeri arabi. Il tuo alfabeto latino. Solo il
tuo vicino è uno straniero.» Da un manifesto tedesco degli anni Novanta. (Aime, o.c. p. 73)
7
L’accento è sempre posto sulla diversità, quasi mai sugli elementi comuni, che invece sono dati per
scontati taciuti, non considerati o ignorati. La diversità fa eccezione, quindi fa notizia. (Aime p.10)
Di fatto, ponendo un eccessivo accento sulle diversità culturali, si rischia di costruire barriere,
proiettando sugli «altri» differenze che, forse, potrebbero essere superate, attenuate o ignorate.
Porre in primo piano la diversità significa accentuare una presunta impermeabilità delle culture di
cui gli individui sono portatori. (Aime p.16)
Quella dello scontro culturale è una maschera che nasconde le radici della questione presentandoci
invece, con l’esasperazione talvolta caricaturale delle maschere, i tratti più estremi di quanto vuole
rappresentare. Nasconde l’universalità di molti elementi culturali, patrimonio di popoli e fedi
diverse, per dare voce solo alle possibili risposte, che sono umane e pertanto non «naturali», non
assolute. Se è vero quanto afferma Clifford Geertz, che «i problemi, essendo esistenziali, sono
universali; le loro soluzioni, essendo umane, sono diverse», è anche vero che ogni individuo non
dispone di una sola opzione culturale da esercitare. Come sostiene Eric Wolf: «È un errore
considerare l’emigrante come il portatore o il protagonista di una cultura omogeneamente integrata
che egli può mantenere o rifiutare nel suo complesso […]. Non è più difficile per uno zulù o per un
hawaiano imparare o disimparare una cultura di quanto non lo sia per un abitante della Pomerania o
della Cina.»
Il mito del multiculturalismo finisce allora per essere una riproposizione, in chiave non conflittuale,
della diversità culturale, e finisce per porre ancora una volta l’accento sulla differenza piuttosto che
sul fatto che ogni cultura è già di per sé multiculturale.
Come afferma Davide Zoletto, il multiculturalismo « è un assunto che si basa quantomeno su un
doppio errore: che un individuo sia per così dire completamente o ampiamente sovradeterminato da
una cultura, e che le nostre società fossero (o che le società in generale possano mai essere)
monoculturali prima dell’arrivo dei migranti. » (Aime p. 23-24)
Vale la pena rileggere la celebre parodia che Ralph Linton era solito proporre ai suoi studenti nella
prima lezione di antropologia culturale:
«Il cittadino americano medio si sveglia in un letto costruito secondo un modello che ebbe origine
nel vicino Oriente. Egli scosta le lenzuola e le coperte che possono essere di cotone, pianta
originaria dell’India; o di lino, pianta originaria del vicino Oriente; o di lana di pecora, animale
originariamente domesticato nel vicino Oriente; o di seta, il cui uso fu scoperto in Cina. Tutti questi
materiali sono stati filati e tessuti secondo procedimenti inventati nel vicino Oriente. Si infila i
mocassini inventati dagli indiani delle contrade boscose dell’Est, e va nel bagno, i cui accessori
sono in misto di invenzioni europee e americane, entrambe di data recente. Si leva il pigiama,
indumento inventato in India, e si lava con il sapone, inventato dalle antiche popolazioni galliche.
Poi si fa la barba, rito masochistico che sembra sia derivato dai sumeri o dagli antichi egiziani.
Tornato in camera da letto, prende i suoi vestiti da una sedia il cui modello è stato elaborato nell’
Europa meridionale e si veste. Indossa indumenti la cui forma derivò in origine dai vestiti di pelle
dei nomadi delle steppe dell’Asia, si infila le scarpe fatte di pelle tinta secondo un procedimento
inventato nell’antico Egitto, tagliate secondo un modello derivato dalle civiltà classiche del
Mediterraneo; si mette intorno ai collo una striscia dai colori brillanti che è un vestigio
sopravvissuto degli scialli che tenevano sulle spalle i croati del diciassettesimo secolo. […]
Andando a fare colazione si ferma a comprare in giornale, pagando con delle monete che sono
un’antica invenzione della Lidia. Al ristorante viene a contatto con tutta nuova serie di elementi
presi da altre culture: il suo piatto è fatto di un tipo di terraglia inventato in Cina; il suo coltello è di
acciaio, lega fatta per la prima volta nei l’India del Sud, la forchetta ha origini medievali italiane, il
cucchiaio è un derivato dell’originale romano. Prende il caffè, pianta abissina, con panna e
zucchero. Sia l‘idea di allevare mucche che quella di mungerle ha avuto origine nel vicino Oriente,
mentre lo zucchero fu estratto in India per la prima volta. Dopo la frutta e il caffè, mangerà le
cialde, dolci fatti secondo una tecnica scandinava, con il frumento, originario dell’Asia minore. […]
Quando il nostro amico ha finito di mangiare, si appoggia alla spalliera della sedia e fuma, secondo
un’abitudine degli indiani d’America, consumando in pianta addomesticata in Brasile o fumando la
8
pipa, derivata dagli indiani della Virginia o la sigaretta, derivata dal Messico. Può anche fumare un
sigaro, trasmessoci dalle Antille, attraverso la Spagna. Mentre fuma legge le notizie del giorno,
stampate in un carattere inventato dagli antichi semiti, su di un materiale inventato in Cina e
secondo un procedimento inventato in Germania. Mentre legge i resoconti dei problemi che i
agitano all’estero, è un buon cittadino conservatore, con un linguaggio indo-europeo, ringrazierà
una divinità ebraica di averlo fatto al cento per cento americano. » (Aime, o.c. p. 25-26)
Come conclusione e bilancio sul tema delle rivendicazioni identitarie pure, individuali o sociali,
osserva Todorov: «L’identità individuale risulta dall’incrocio tra diverse identità collettive; non è la
sola a trovarsi in questa condizione. Qual è l’origine della cultura di un gruppo umano? La risposta,
paradossale, è questa: proviene dalle culture che l’hanno preceduta. Una nuova cultura nasce
dall’incontro tra diverse culture di piccole dimensioni, o dalla decomposizione di una cultura più
vasta o dall’interazione con una cultura vicina. Non raggiungiamo mai una vita umana precedente
all’avvento della cultura. E giustamente: le caratteristiche «culturali» sono già presenti in altri
animali, specialmente tra i primati. Non esistono culture pure e culture mescolate; tutte le culture
sono miste (o «ibride», o «meticciate»). I contatti tra gruppi umani risalgono alle origini della
specie e lasciano sempre delle tracce sulla maniera in cui i membri di ogni gruppo comunicano tra
loro. Per quanto lontano si possa risalire nella storia di un paese come la Francia, si trova sempre un
incontro tra popolazioni e culture diverse: galli, franchi, romani e molti altri.» (Todorov Tzvetan
2008 La paura dei barbari. Oltre lo scontro delle civiltà, Garzanti, Milano 2009 p.78)
2.2.2. identità e violenza: una relazione in denuncia
2.2.2.1. identità (stereotipi) e violenza, in contesto storico politico
«Che ci sia o no disparità dipende quindi dal contesto; e se non c’è disparità, ridere della diversità
altrui può diventare un elemento di comunicazione che, pur basandosi sugli stereotipi, li
caricaturizza rendendoli accettabili. Gli stereotipi non sempre danno vita a una politica di
esclusione: per farlo occorre una strutturazione politica che trasformi un sentimento — anche forte
— in azione organizzata e mirata non più verso un singolo individuo, ma verso una categoria di
individui, e a tale scopo è indispensabile convincere gli altri di appartenere anch’essi a una
categoria omogenea. L’organizzazione e la strutturazione trasformano un disagio, un senso di
insoddisfazione, in ideologia politica e quindi in strumento di forza.
In molti casi le identità possono tranquillamente rimanere latenti e non attivarsi fino al momento in
cui non interviene un fattore scatenante, perlopiù di carattere violento. È la violenza, spesso, a
indurre identità — violenza intesa non solo come atto di forza fisica, ma anche come imposizione o
classificazione attraverso l’azione politica basata su un rapporto di forza asimmetrico.
Assistiamo continuamente a processi di politicizzazione di etnie e di religioni, finendo talvolta per
sovrapporre l’immagine che ne deriva ai contenuti originali delle une e delle altre. L’islam diventa
in tal modo la religione della guerra santa, quando è invece l’uso politico che ne fanno certi
integralisti a fomentare odio e guerra; l’identità etnica sembra essere alle radici dei massacri in
Burundi o nei Balcani, mentre le ragioni degli scontri andrebbero cercate nelle politiche recenti e
passate; si parla di tribalizzazione della politica, quando al contrario il problema sta nella
politicizzazione delle tribù. La pratica dell’identità comporta in molti casi uno snaturamento dei
valori fondamentali della cultura a cui fa riferimento.» (Aime, o.c. p. 133)
«Ricordo un’intervista televisiva nella quale il rabbino Elio Toaff, alla domanda «cosa ha
significato per lei essere ebreo?», rispose di essersi sentito per la prima volta veramente ebreo nel
1939, quando vennero emanate e applicate le leggi razziali dal governo fascista. «Prima - diceva
Toaff - mi sentivo cittadino italiano di cultura ebraica». Il suo senso di identità venne pertanto
indotto da eventi esterni. Con questo, non credo certamente volesse negare il sentimento di
appartenenza alla sua comunità religiosa, ma affermare come il passaggio da un’identità percepita a
una, seppur per forza, agita, vissuta, fu conseguenza di un atto di forza. Da quel momento, a lui
come ad altre migliaia di persone venne tolta la possibilità di scegliere chi e che cosa essere.»
(Aime p.106) « Anzi, gli ebrei, come ricorda Luzzatto, avendo vissuto esperienze diverse a causa
della loro diversa dislocazione, non possono essere incasellati in un’identità collettiva fissa, ma se
9
mai sono ed erano il prodotto di complesse dinamiche locali e relazionali. Il delirio nazista li ha
invece condannati, oltre che allo sterminio, a rappresentare una sola entità, per giunta razziale. In
questo senso la Shoah ha creato un “popolo ebraico” al fine di sterminarlo, tentando addirittura di
definirne i confini su basi biologiche.» ( Aime p. 107-108)
2.2.2.2. Si tratta di una violenza (come spesso) generata dalla paura:
«Ciò che è stato trovato nella cultura d’origine non colpisce, perché è servito alla formazione stessa
della persona. In compenso, ciò che cambia a causa di circostanze sulle quali l’individuo non ha
alcuna possibilità di intervenire è percepito come un degrado, perché indebolisce la nostra
sensazione di esistere. L’epoca contemporanea, nel corso della quale viene richiesto alle identità
collettive di trasformarsi sempre più velocemente, è dunque anche quella in cui i gruppi adottano un
atteggiamento sempre più difensivo, rivendicando con forza la loro identità d’origine.» (Todorov,
o.c. p. 82)
2.2.3. l’urgenza di una diagnosi.
Indicato e descritto il fatto, evidenziato il problema, resta aperto (e irrisolto) il cammino della sua
diagnosi e della sua eventuale terapia. Il compito difficile di una “sociologia” anche terapeutica (o
terapeutica già nella sua diagnosi). Il problema. «Di tanto in tanto sogniamo una «grande
semplificazione», ci abbandoniamo a fantasie regressive che trovano principale ispirazione nelle
immagini del ventre prenatale e della casa fortino. La ricerca di un riparo è «l’altro» rispetto alla
responsabilità, così come trasgressione e ribellione erano «l’altro» rispetto alla conformità. Oggi la
brama di un riparo sicuro ha finito col sostituire la ribellione, che ha ormai cessato di essere
un’opzione sensata; come afferma Pierre Rosanvallon (in una nuova prefazione al suo classico Le
capitalisme utopique), non esiste più una «autorità di comando da deporre e sostituire. Sembra non
esserci rimasto più spazio per una rivolta, come il fatalismo sociale vis-à-vis il fenomeno della
disoccupazione testimonia ampiamente».
I segni di malessere sono molti ed evidenti, e tuttavia — come Pierre Bourdieu ha ripetutamente
osservato — la loro ricerca di una legittima manifestazione nel mondo della politica è ancora vana.
Privi di un’espressione articolata, vanno dunque letti tra le righe, desunti dagli scoppi di furore
xenofobo e razzista: le manifestazioni più comuni di nostalgia da «riparo sicuro». L’alternativa
disponibile (e non meno popolare) ai sentimenti neotribali di intolleranza violenta — il rifiuto della
politica e il ritiro entro le mura fortificate del privato — non è più una soluzione attraente e
soprattutto adeguata alla vera origine del malessere. E dunque a questo punto che la sociologia, col
suo potenziale esplicativo che promuove la comprensione, acquista i dovuti riconoscimenti più che
in qualsiasi altro periodo della sua storia.
Secondo l’antica ma ineguagliata tradizione ippocratica, come Pierre Bourdieu ricorda ai lettori di
La misère du monde, la vera medicina parte dal riconoscimento di una malattia invisibile: «fatti di
cui il malato non parla o che dimentica di riferire». Ciò che occorre nel caso della sociologia è la
«rivelazione delle cause strutturali che i segni e le manifestazioni apparenti rivelano solo attraverso
una loro distorsione» [ne dévoilent qu’en les voilant]. Occorre analizzare — spiegare e capire — i
patimenti caratteristici dell’ordine sociale che «ha indubbiamente ridotto la grande miseria (sebbene
a volte più a parole che nei fatti), moltiplicando al contempo gli spazi sociali [...] offrendo
condizioni favorevoli per la crescita senza precedenti di ogni sorta di piccole miserie».
Diagnosticare una malattia non significa curarla. Questa regola generale si applica alle diagnosi
sociologiche quanto ai referti medici. Notiamo tuttavia che la malattia della società differisce da
quella corporea per un aspetto fondamentale: nel caso di un ordine sociale malato, l’assenza di una
diagnosi adeguata (ignorata o soffocata dalla tendenza a «interpretare e dunque liquidare» i rischi
rilevati da Ulrich Beck) è una causa determinante, forse decisiva, della malattia.
Bauman Zygmunt 2000 Modernità liquida, ed. Laterza, Roma-Bari 2002, p. 253-254
2.2.3.1. Sul tema del potenziale politico di cambiamento, di iniziativa e di rivolta della società
contemporanea, vanno prese in considerazione le analisi di Alain Badiou che occupandosi e
andando alla ricerca del “risveglio della storia” definisce e individua i segni della presenza di
diversi potenziali di rivolta, di cui specifica natura, obiettivi e potenziale: la rivolta immediata, la
10
rivolta latente, la rivolta storica. Il quadro che ne emerge è diverso da quello descritto da Bauman o
diverso dalle molte diagnosi improntate al pessimismo della iniziativa. «… questo libro — la prima
e più autorevole interpretazione filosofica della nuova stagione di rivolte mondiali, dalla primavera
araba agli Indignados a Occupy — sostiene una tesi diversa: un nuovo mondo sta nascendo, basato
su tutt’altre regole. Un mondo che rigetta le parole d’ordine della «modernizzazione» e della
«riforma», sotto le quali si traveste un tentativo di regressione politica senza precedenti, volto a
adeguare la produzione e la vita stessa ai dogmi di un liberismo oligarchico e ottocentesco; un
mondo che — sebbene in maniera ancora confusa e dispersa — a quest’ordine si ribella
esplicitamente, entrando in quello che Badiou chiama «il tempo delle rivolte». Rivolte attraverso le
quali il «risveglio della storia» dovrà dar luogo a un «risveglio dell’Idea» […] che rilanci
l’insopprimibile aspirazione dell’uomo alla giustizia, all’eguaglianza, all’universalità.» Badiou
Alain 2011 Il risveglio della storia, Adriano Salani Editore Milano 2012 (dal primo risvolto di
copertina)
2.2.3.2. Una diagnosi sulla base di stereotipi “rassicuranti” che cela il proprio inganno e impedisce
la chiarificazione: lo straniero (il “non è dei nostri”…) va sempre bene ma, paradossalmente in
modo controproducente.
«Forse la forma più seria di doratura nella politica moderna consiste nella prassi di situare i fatti in
un altro contesto. La pubblicità di auto di alto valore, descritta più sopra in base all’esempio della
Volkswagen, fa di un prodotto di piattaforma un oggetto di marca. In politica, ad esempio,
l’immigrazione può essere trasposta in un altro contesto, per poi essere commercializzata
esattamente nello stesso modo. In Germania e in Gran Bretagna la maggior parte degli immigrati
sono lavoratori che pagano le tasse, che fanno le pulizie degli ospedali e spazzano le strade, cioè
svolgono attività evitate dai «nativi». Per ricavare un capitale politico dalla presenza di questi
indispensabili out-sider, li si riconfeziona in modo che possano entrare nella stessa scatola culturale
dei rifugiati improduttivi. […] Per secoli in Europa e in Nordamerica gli stranieri sono stati
percepiti come una minaccia. Come nel passato, anche oggi lo straniero è diventato la superficie
simbolica su cui si proietta ogni genere di ansia. La differenza sta nel tipo di ansie proiettate. Oggi,
l’immagine dell’immigrato è modellata, oltre che dai vecchi pregiudizi e dai tentativi di catturare
consensi politici, anche dalle esperienze della burocrazia orientata sul breve termine, instabile. Nel
mondo del lavoro l’immagine dello straniero concentra in sé i timori di perdere l’impiego o di
diventare inutili. Come abbiamo visto, queste ansie sono senz’altro giustificate se lo straniero vive
effettivamente all’estero e lavora, ad esempio, in un call-center indiano o in un’azienda indiana
produttrice di software, ma non hanno senso se vengono proiettate su un immigrato che spazza le
strade. O, meglio, hanno un senso immaginato: la paura della perdita del controllo qui trova un
bersaglio alla propria portata. Se cadiamo prigionieri di questa immaginazione perversa siamo
facilmente indotti a trascurare il fatto che la persecuzione di questo debole out-sider che ci vive
accanto può fare ben poco per accrescere la sicurezza del nostro posto di lavoro.» Sennett Richard
2006, La cultura del nuovo capitalismo, il Mulino, Bologna 2006, 122-123
3. Note “filosofiche” sul tema identità e multicultura; strumenti concettuali per
impostare il problema. Gli irrinunciabili.
Avvertenza preliminare, come sostiene Bauman: «Mentre farsi un’identità è un’esigenza fortemente
sentita e un esercizio incoraggiato da ogni autorevole medium culturale, avere un’identità
solidamente fondata e restarne in possesso ‘per tutta la vita’, si rivela un handicap piuttosto che un
vantaggio poiché limita la possibilità di controllare in modo adeguato il proprio percorso
esistenziale.» …« Questa eccessiva sovraesposizione dell’identità, di una identità, rischia di
trasformarci in esseri unidimensionali, mentre le vicende umane dimostrano che invece siamo degli
abilissimi camaleonti culturali.» (Aime, o.c. p. 68, 56) «L’appello all’identità, si dice, può sostenere
orientamenti liberali o democratici, ma anche un comunitarismo autoritario o addirittura la ricerca
della purezza etnica, razziale o religiosa, che rappresenta una minaccia reale» (Touraine Alain 2004
11
La globalizzazione e la fine del sociale. Per comprendere il mondo contemporaneo, il Saggiatore,
Milano 2008, p. 204)
Savidan, con i termini: «Le metamorfosi democratiche dell’identità», richiama le radici storiche
filosofiche del ragionamento: «Per quale motivo oggi si dà per scontato che esista un legame
particolare fra il riconoscimento e l’identità? Da tempo gli scrittori, i filosofi, gli psicologi hanno
sottolineato che l’esperienza di sé rimanda a un’esperienza dell’altro (e a un’esperienza del «Sé»
come «altro»).»(Savidan 2010, 28); rimanda all’etica del riconoscimento.
3.1. il filone metafisico: possibilità e essenza
3.1.1 Aristotele: il divenire delle realtà naturali è dato dalla tensione verso la propria forma o
essenza. Aristotele, Fisica, tr. A Russo, Laterza, Bari 1973, pp. 27-33 (passim)
3.1.2. Hegel: «… il punto della singolarità che nel mezzo del sussistere si irradia nella
molteplicità.» (G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, La Nuova Italia, Firenze 1985, 96) La
determinatezza nella sua relazione ad altro; alterità come definizione plurima dell’io, come di ogni
finitudine.
3.1.3. Kierkegaard: esistenza é possibilità
Kierkegaard Søren, Aut-Aut. Estetica ed etica nella formazione della personalità (1843), trad. it. di
K.M. Guidbrandsen e R Cantoni, introduzione di R. Cantoni (1956), Milano, Mondadori, 1993, p.
74: «chi sceglie se stesso scopre che quell’io che egli sceglie ha un’infinita molteplicità in sé».
Kierkegaard, Søren 1844 Il Concetto dell’angoscia, Sansoni, Firenze 1965, p. 193,195
3.1.4. Heidegger: l’uomo, “l’ente che ha il carattere dell’esserci” è “aver- da- essere”
«1. L’«essenza» di questo ente consiste nel suo aver-da-essere. L’essenza (essentia) di questo ente,
per quanto in generale si può parlo lare di essa, dev’essere intesa a partire dal suo essere
(existentia). Ecco perché l’ontologia ha il compito di mostrare che, se noi scegliamo per l’essere di
questo ente la designazione di esistenza, questo termine non ha e non può avere il significato
ontologico del termine tradizionale existentia. […] Perciò il termine «esserci», con cui indichiamo
tale ente, esprime l’essere e non il che-cosa, come accade invece quando si dice pane, casa, albero.
2. L’Essere di cui ne va per questo ente nel suo essere, è sempre mio. L’esserci non è perciò da
intendersi ontologicamente come un caso o un esemplare di un genere dell’ente inteso come
semplice-presenza. […] L’ente a cui nel suo essere ne va di questo essere stesso, si rapporta al suo
essere come alla sua possibilità più propria. L’esserci è sempre la sua possibilità, ed esso non l’«ha»
semplicemente a titolo di proprietà posseduta da parte di una semplice-presenza. Appunto perché
l’esserci è essenzialmente la sua possibilità questo ente può, nel suo essere, o «scegliersi»,
conquistarsi, oppure perdersi e non conquistarsi affatto o conquistarsi solo «apparentemente». Ma
esso può aver perso se stesso o non essersi ancora conquistato solo perché la sua essenza comporta
la possibilità dell’autenticità, cioè dell’appropriazione di sé.»
Heidegger, Martin 1927 Essere e Tempo, ed. Longanesi, Milano 1976, p.64-65
3.2. il filone logico: l’alterità dialettica
3.2.1. Platone: l’altro come genere sommo: Il dialogo “Sofista” raccontando l’evento con toni
drammatici mettendo in scena un vero e proprio delitto filosofico: affermare che “il non-essere è”
significa “uccidere” Parmenide, “venerando e terribile”, poiché si trasgredisce quel precetto in cui
egli colloca l’origine della filosofia «bisogna che il dire e il pensare sia l’essere».
Platone, Sofista, Sansoni, Firenze 1974, p.269-270
2.3.2. Hegel: il determinato è tale nel suo essere altro
« [1.] Qualcosa ed altro son tutti e due in primo luogo degli esserci che sono o dei qualcosa.
[2.] In secondo luogo ciascun de’ due è anche un altro. È indifferente quale dei due si chiami per il
primo, e solo per ciò, qualcosa […] Tutti e due sono in pari maniera altri. A fissar la differenza e
quel qualcosa che si deve prendere come affermativo, serve il questo. Ma questo enuncia appunto
che un tal distinguere e porre in rilievo l’un qualcosa è un designare soggettivo, che cade fuori dal
12
qualcosa stesso. Tutta la determinatezza cade in questo estrinseco mostrare. […] [3.] Tutti e due son
determinati tanto come qualcosa quanto come altro. [4.] Il qualcosa si conserva nel suo non essere;
è essenzialmente uno con cotesto non essere, è essenzialmente non uno con esso. Sta dunque in
relazione col suo esser altro; non è puramente il suo esser altro. L’esser altro è in pari tempo
contenuto in lui, e in pari tempo ancora da lui separato; è esser per altro.»
Hegel, G.W.F. 1816 Scienza della logica, ed. Laterza, Bari 1968, pp. 112-115 (passim)
2.3.3. Levinas: l’alterità e l’immanente trascendenza
«Fuoriuscita da sé che fa appello all’altro, allo straniero. L’incontro avviene tra stranieri, altrimenti
sarebbe parentela. Ogni pensiero è subordinato alla relazione etica, all’infinitamente altro in altri, e
all’infinitamente altro di cui ho nostalgia. Pensare altri dipende dall’irriducibile inquietudine per
l’altro. L’amore non è coscienza. È perché vi è una vigilanza prima del risveglio che il cogito è
possibile, in modo che l’etica e prima dell’ontologia. Dietro la venuta dell’umano, vi è già la
vigilanza per altri. L’io trascendentale nella sua nudità viene dal risveglio attraverso e per altri.
Ogni incontro comincia con una benedizione, contenuta nella parola buongiorno. Questo
buongiorno che ogni cogito, che ogni riflessione su di sé presuppone già e che sarebbe la prima
trascendenza. Questo saluto rivolto all’altro uomo è un’invocazione. Insisto dunque sulla
preminenza della relazione benevola nei confronti d’altri. Quand’anche vi fosse malevolenza da
parte dell’altro, l’attenzione, l’accoglimento dell’altro, come sua riconoscenza marca questa
anteriorità del bene sul male.» Levinas, Emmanuel 1986 Alterità e trascendenza, ed. il melangolo,
Genova 2006, pp. 87-88
3.3. il filone psicologico: livelli e dinamica della psiche
«Secondo lo scrittore e saggista martinicano Edouard Glissant è proprio l’idea di trasparenza a
essere pericolosa: Io rivendico il diritto all’opacità. La troppa definizione, la trasparenza portano
all’apartheid: di qua i neri, di là i bianchi. «Non ci capiamo», si dice, e allora viviamo separati. No,
dico io, non ci capiamo completamente, ma possiamo convivere. L’opacità non è un muro, lascia
sempre filtrare qualcosa. Un amico mi ha detto recentemente, che il diritto all’opacità dovrebbe
essere inserito tra i diritti dell’uomo.» (Aime, o.c. p. 73)
3.3.1. Stoicismo: una logica indiziaria: l’attenzione ai segni di una realtà per natura non evidente
La natura ci offre realtà di per sé evidenti, come quelle che vediamo al momento, assolutamente
impossibili da definire, come ad esempio il numero delle gocce d’acqua di un oceano, per il
momento non evidenti, solo perché non presenti ora alle sensazioni, per natura non evidenti a causa
della loro complessità, come la natura dell’uomo, la logica delle passioni, la salute del corpo, il
corso della storia… cioè quegli elementi attorno ai quali ruota nella sua maggior parte il pensiero e
l’attenzione dell’uomo. Per queste realtà disponiamo di segni che mandano indizi (segni indiziari);
essi richiedono una interpretazione attenta e specifica (una semiotica), dei ragionamenti induttivi,
indiziari e ipotetici (sillogismi ipotetici), strumenti capaci di avviare alla scoperta e al rispetto di una
identità complessa e mai completamente definibile, aperta all’ascolto e all’interpretazione: «Ti dirò
quel che mi accade e tu troverai il nome alla malattia» (Seneca, I dialoghi).
Sesto Empirico, Schizzi pirroniani, pp. 80-82, tr. di O. Tescari, Laterza, Bari 1988
3.3.2. Freud: la complessità della psiche; topiche di orientamento e tecniche di lettura
dell’inconscio. «La teoria psicanalitica di Freud si sottrae anch’essa all’unidimensionalità in quanto,
se l’accento posto sulla rilevanza dell’inconscio ha il merito di mostrare che la coscienza riflessiva e
la razionalità non esauriscono la complessità della persona, Freud non ignora i processi di
costruzione dell’identità individuale e sociale che egli analizza in termini del rapporto tra Es, Io e
Super-Io, riconoscendo all’Io una parte attiva in tali processi. […] Uscendo dall’unidimensionalità
che caratterizza le teorie filosofiche e sociologiche contemporanee occorre quindi adottare uno
schema concettuale maggiormente aperto alla complessità.» (Crespi, o.c. p.39).
3.4. nel dato storico della complicazione, gli irrinunciabili
13
«Ora, il problema grave è questo: una società democratica moderna non è caratterizzata soltanto da
un pluralismo di dottrine religiose, filosofiche e morali comprensive, ma da un pluralismo di
dottrine comprensive incompatibili e tuttavia ragionevoli. Nessuna di queste dottrine è
universalmente accettata dai cittadini; né c’è da attendersi che in un futuro prevedibile una di esse,
oppure qualche altra dottrina ragionevole, sia mai affermata da tutti i cittadini, o da quasi tutti. Il
liberalismo politico assume che, ai fini della politica, una pluralità di dottrine comprensive
ragionevoli ma incompatibili sia il risultato normale dell’esercizio della ragione umana entro le
libere istituzioni di un regime democratico costituzionale; e assume anche che una dottrina
comprensiva ragionevole non respinga gli aspetti essenziali di un regime democratico.
Naturalmente una società può avere in sé anche dottrine comprensive irragionevoli e irrazionali, o
perfino folli; e in questo caso il problema è quello del contenimento, del fare in modo che tali
dottrine non minino l’unità e la giustizia della società.» (Rawls John 1993 Liberalesimo politico,
ed. di Comunità, Torino 1999, p. 5) Su questo quadro che si dipinge in termini di complessità,
esistono degli irrinunciabili che costituiscono non tanto dei vincoli o paletti ma degli strumenti o
segnali di direzione per comprendere e agire.
3.4.1. l’irrinunciabilità del pluralismo. «Tale pluralismo non è visto come un disastro, ma come
l’esito naturale delle attività della ragione umana entro libere istituzioni durature; vedere il
pluralismo come un disastro significa vedere come un disastro l’esercizio della ragione in
condizioni di libertà. … La cultura politica di una società democratica è sempre contraddistinta da
una molteplicità di dottrine religiose, filosofiche e morali opposte e inconciliabili; alcune di esse
sono del tutto ragionevoli, e il liberalismo politico vede questa diversità fra dottrine ragionevoli
come l’inevitabile risultato a lungo termine dei poteri della ragione umana, quando operano sullo
sfondo di istituzioni libere e durature.» (Rawls 1993,12, 23)
Il pluralismo «non è un puro e semplice dato storico che possa venir meno in breve tempo, ma un
aspetto permanente della cultura pubblica della democrazia. Nelle condizioni politiche e sociali
garantite dai diritti e dalle libertà fondamentali di istituzioni libere dovrà nascere e persistere,
ammesso che non esista ancora, un’ampia varietà di dottrine comprensive contrapposte,
inconciliabili e – quel che più conta – ragionevoli.» (Rawls 1993, 47-48)
3.4.1.1. «Dobbiamo distinguere il fatto del pluralismo ragionevole dal fatto del pluralismo in quanto
tale. Non si tratta semplicemente del fatto che istituzioni libere tendono a generare un’ampia varietà
di dottrine e opinioni, com’è prevedibile data la diversità degli interessi degli uomini e la loro
tendenza ad adottare punti di vista limitati, ma del fatto che fra le opinioni che si sviluppano c’è
un’ampia varietà di dottrine comprensive ragionevoli. Sono queste le dottrine che i cittadini
ragionevoli sostengono, ed è di esse che deve occuparsi il liberalismo politico.» (Rawls 1993, 48)
3.4.1.2. « Dunque, il fatto del pluralismo ragionevole - benché le dottrine storiche non siano,
ovviamente, opera della sola ragione pratica - non è un aspetto sfortunato della condizione umana; e
nel dare alla nostra concezione politica una forma che possa, nel suo secondo stadio, conquistare
l’appoggio di dottrine comprensive ragionevoli, stiamo adattando questa concezione non alle forze
brute del mondo, ma agli esiti inevitabili della libera ragione umana. […] … un accordo collettivo e
duraturo su una sola dottrina comprensiva (religiosa, filosofica o morale) può essere conservato solo
con un uso oppressivo del potere statale.» (Rawls 1993, 48)
3.4.2. l’irrinunciabilità della globalizzazione: contesto contemporaneo di movimento culturale delle
persone e di sviluppo delle insospettate potenzialità individuali. Vale la tesi di Aristotele: l’uomo è
una complessità che giunge a evidenza e realizzazione nelle relazioni sociali e nell’ambito della loro
ampiezza; il sociale è il luogo di scoperta e realizzazione progressive della propria natura come
natura complessa; della propria complessità. La globalizzazione può amplificare la tendenza etica
dell’uomo, indicata da Aristotele come sua specifica essenza dell’umano (e dell’animale), di
realizzarsi aprendosi alla propria complessità, alla perfezione della propria complessità.
3.4.2.1. La globalizzazione diffonde a livello mondiale stili di vita omogenei servendosi di processi
che le sociologia indica con il termine “omologazione”. Contemporaneamente essa introduce, negli
ambiti in cui opera, una rivoluzione di orientamento, scelta, progetto tale da creare inattesi, talora
14
disorientanti, livelli di complessità. Perciò bisogna camminare con tre parole: globalizzazione,
omologazione, complessità. Ognuna indica dinamiche sociali diverse, ma si sorreggono e
correggono a vicenda impedendosi reciprocamente di imporsi con enfasi eccessiva e quindi
inopportuna se il loro scopo è guidare a comprendere la dinamica della società contemporanea. Si
tratta di una di quelle parole che, tolte dall’abuso e poste in connessione, fanno scorgere la
dimensione culturale e politica in cui ogni individuo, nel presente, è collocato. «L’individualismo
imposto dalla globalizzazione ha sradicato i movimenti di massa e ha reso inservibili le categorie
politiche e sociali con cui pensavamo noi stessi e gli altri: se le grandi narrazioni collettive sono
finite, la vita del soggetto acquista la stessa drammaticità della storia del mondo. Abbiamo bisogno
di un nuovo paradigma per capire il presente e, soprattutto, per rivendicare i nostri diritti.» Touraine
Alain 2004 La globalizzazione e la fine del sociale, il Saggiatore, Milano 2008 (titolo originale in
traduzione letterale. Un nuovo paradigma. Per comprendere il mondo oggi).
3.4.3. l’irrinunciabilità all’identità: non come gabbia comunitaristica artificiale, ossessione
identitaria trappola mortale che ha come obiettivo creare appartenenze chiuse ed esercitare il
dominio sulla persona, né come destino di consumatori addomesticati o irretiti dentro un sogno di
rincorsa omologante di ciò che ora va per lo più, ma come libertà di gestire in proprio, secondo
personalizzazioni assolutamente singolari, quanto la realtà contemporanea mette a disposizione a
sostegno della realizzazione di sé. Tuttavia, «per essere cosmopoliti, bisogna avere una patria»
(Antonio Gramsci); e, anche espistemologicamente, una teoria scientifica non è mai frutto di un
rapporto diretto tra soggetto al mondo (osservo il mondo e costruisco una teoria), ma di un
passaggio da una teoria all’altra avendo come riferimento il mondo come un in sé pieno di dati e
informazioni senza fine; occorre avere un minimo di bagaglio teorico (un orientamento e una
“identità” culturale per cogliere e leggere i dati e magari mutare la propria teoria e visione del
mondo.)
3.4.4. l’irrinunciabilità dell’armonia (sociale, politica) e della vita civile ispirata a una condivisione
di criteri universali di giustizia e non a differenze di privilegio: «Il successo del costituzionalismo
liberale ha rappresentato, in effetti, la scoperta di una nuova possibilità sociale: quella di una società
pluralistica ragionevolmente armonica e stabile. Prima della pratica vittoriosa e pacifica della
tolleranza in società dotate di istituzioni liberali non c’era modo di conoscere questa possibilità; era
più naturale credere - e la secolare pratica dell’intolleranza sembrava confermarlo - che l’unità e la
concordia sociali richiedessero il consenso intorno a una dottrina, religiosa, filosofica o morale,
generale e comprensiva. L’intolleranza era accettata come condizione dell’ordine e della stabilità
sociale, e l’indebolimento di questa credenza ha aiutato ad aprire la via alle istituzioni liberali. E
forse la dottrina della libertà di fede è nata perché è difficile, se non impossibile, credere nella
dannazione di coloro con i quali abbiamo collaborato a lungo, in fiducia e sicurezza, per la
conservazione di una società giusta.» (Rawls 1993,12-13 passim)
Globalizzazione, complessità, volontà identitarie rendono più alto il prezzo da pagare per ottenere
unità e armonia, e un conflitto drammatico è stato introdotto nell’immagine della realtà sociale da
noi quotidianamente percepita e quotidianamente in imprevedibile alterazione, ma il centro della
vicenda è sempre rappresentato dall’esigenza di un’armonia che non si fondi su esclusioni
(impoverimento e violenza). Dunque occorre delineare un modello politico che porti in quella
direzione.
3.4.4.1. Dall’osservazione storico sociologica (e forse di futurologia politica in forma schematica)
sembrano delinearsi due direzioni e due scenari possibili, indicati (indicabili) con due termini
(spesso intercambiabili o considerati pressoché uguali): multiculturalismo [4.], interculturalismo
[5.].
4. le ragioni di una critica al multiculturalismo
Multiculturalismo: l’obiettivo, le debolezze, le dimenticanze, i rischi. Identità e multiculturalismo
sede di una possibile identità come frutto avvelenato, per la società e per la persona.
15
Il problema in descrizione nell’opera Liberalesimo politico, del 1993, John Rawls nel passo già
citato, e ripreso in una lettera del 1998 (e Rawls afferma di considerare quest’articolo come “la
migliore esposizione delle sue idee sulla ragione pubblica e sul liberalismo politico, soprattutto
rispetto alla compatibilità tra ragione pubblica e credenze religiose” così nella seconda edizione,
postuma, dell’opera Liberalesimo democratico, 2005 [in italiano 2012, Einaudi, Torino, p.403)
«L’idea di ragione pubblica appartiene, nella mia interpretazione, alla concezione di una società
costituzionale democratica bene ordinata. La forma e il contenuto di tale ragione — in che modo i
cittadini la intendano e come essa interpreti le loro relazioni politiche — sono elementi della stessa
idea di democrazia. Questo perché una caratteristica di base di ogni società democratica è il fatto
del pluralismo: che in una tale società esista una molteplicità di dottrine comprensive ragionevoli tra
loro in conflitto (siano esse religiose, filosofiche o morali) è un risultato naturale della sua cultura di
libere istituzioni. I cittadini comprendono che è impossibile raggiungere un accordo, o quanto meno
aprire la strada a una reciproca intesa, sulla base delle inconciliabili dottrine comprensive che essi
difendono. Ciò che dunque hanno bisogno di fare è esaminare quali tipi di ragioni possano
ragionevolmente offrirsi l’un l’altro quando sono in gioco questioni politiche fondamentali. La mia
tesi è che nella ragione pubblica le dottrine comprensive della verità e del giusto siano sostituite da
un’idea del politicamente ragionevole che possa essere rivolta ai cittadini in quanto cittadini.
Un aspetto centrale dell’idea di ragione pubblica è che essa non critica né attacca nessuna dottrina
comprensiva, sia essa religiosa o di altro tipo, a meno che tale dottrina non sia incompatibile con gli
elementi essenziali della ragione pubblica e delle società democratiche. La condizione di base
imposta alle dottrine ragionevoli è che accettino le forme di governo a democrazia costituzionale e
l’idea di diritto legittimo che le accompagna. Per quanto le società democratiche siano l’una diversa
dall’altra riguardo alle particolari dottrine che all’interno di ciascuna godono di autorevolezza o
sono attive — si pensi alle democrazie dell’Europa occidentale, agli Stati Uniti, a Israele o all’India
—, trovare un’idea appropriata di ragione pubblica è un compito che tutte devono affrontare.»
4.1. Prima introduzione: le contraddizioni e le sfide della società attuale
4.1.1. la contraddizione multiculturale: particolarismi e contaminazione (prima contraddizione).
«La società multiculturale, in quanto situazione di compresenza di gruppi culturali diversi
all’interno di uno stesso spazio sociale, chiama in causa il multiculturalismo quale possibile risposta
ai problemi generati dalla loro convivenza. Dalla considerazione di un dato oggettivo, si passa
pertanto all’elaborazione di un progetto di società all’interno del quale è necessario “stabilire regole
per la convivenza di tali gruppi su una base di assoluta parità e di reciproco riconoscimento” (Crespi
1996, p. 262). Espresso in questi termini, il concetto di multiculturalismo risulta essere meramente
descrittivo nei confronti della realtà, tacendo sulla natura dei rapporti che intercorrono fra le diverse
culture. Il problema legato all’affermazione della società multiculturale è infatti quello di conciliare
la tutela del particolarismo culturale con lo svolgimento di un graduale processo di contaminazione
tra culture diverse, quale garanzia di mutamento sociale e quale difesa nei confronti di possibili
degenerazioni integraliste. Da questo punto di vista, il multiculturalismo tradisce la sua natura
ideologica: incurante della natura processuale dei fenomeni sociali, i quali non di rado sfuggono a
ogni tentativo di razionalizzazione dell’agire che sia aprioristicamente determinato, esso affonda le
sue radici nella cultura moderna e nella frattura tra cultura e individuo da essa sancita. Le incognite
della società multiculturale sono pertanto riconducibili alle contraddizioni interne al progetto
multiculturalista, nonché alla nozione di cultura su cui esso si fonda.»
Maria Cristina Marchetti, La contraddizione multiculturale. Identità e identificazione (in Pompeo
o.c p. 203)
«È qui che entra in campo l’ideologia del multiculturalismo. Il diritto alla diversità, a qualunque
diversità culturale, viene giustificato in base al principio della uguaglianza di opportunità per tutte
le culture di esistere e di essere praticate senza un giudizio di valore su di esse. L’uguaglianza di
opportunità non è di fatto operante, ma si fa finta che lo sia. Si tratta di una ideologia perché
permette a culture parziali di difendere o promuovere degli interessi particolari come se potessero
16
diventare universali: una religione si chiude in se stessa pensando che prima o poi le altre
cederanno; si mantengono certi modelli culturali, come quello dell’inferiorità della donna, pensando
che gli altri sbaglino.
Il multiculturalismo si presenta come ideologia nel momento in cui consacra una forma di
coesistenza fra diversità culturali parziali che si pensano come universali mediante una concezione
della sfera pubblica secondo cui, per coesistere, occorre che tutte le culture siano relativizzate
(nessuna di esse può pretendere di dire la verità). Nella versione proposta da Gian Enrico Rusconi
(2000), a nessuno deve essere permesso di parlare di ‘verità’ quando parla in pubblico. Questa
posizione ha una sua giustificazione razionale? In apparenza sì, perché l’argomento di ragione che
viene avanzato è che ‘ciascuno ha la sua verità’. Ma questa ragione è ultimativa? Non si direbbe.
Essa ha un grado di riflessività zero. Infatti, è evidente che la verità — se intesa come effettivo stato
delle cose — non può essere diversa a seconda di chi la dica. La ragione addotta vale se si cambia il
senso del concetto di verità, cioè se ‘verità’ indica una opinione o un token, cioè un assunto, un
simbolo emblematico, che si ritiene dato per scontato. Ma questa definizione di verità non sarebbe,
con tutta evidenza, razionale, perché la razionalità implica una indagine che non dà nulla per
scontato (Antiseri, 1991).
Se lo spazio sociale pubblico diventa privo di valori comuni (perché l’unico valore comune è che
tutte le differenze abbiano uguale dignità), l’agire sociale deve essere ispirato al principio del
‘politicamente corretto’ imposto dal relativismo culturale. La lotta per il riconoscimento delle
diverse identità genera distanziamenti e fratture. È una nuova tragedia dei beni comuni.»
(Donati, Pierpaolo 2008 Oltre il multiculturalismo, Laterza, Roma-Bari, p. 21-22)
«Come ignorare il fatto che la difesa dei diritti culturali può ridursi in ossessione per l’identità,
l’omogeneità e la purezza del gruppo, dunque nel rigetto delle minoranze e delle differenze? In
nome dei diritti culturali si costruiscono comunitarismi che impongono le proprie leggi
mascherandole da diritti. In nome di una identità e di una tradizione, dirigenti autoritari cercano di
imporre principi e talora pratiche che negano la libertà di coscienza e le libere scelte culturali.
Touraine Alain 2004 La globalizzazione e la fine del sociale. Per comprendere il mondo
contemporaneo, il Saggiatore, Milano 2008, p.119-120
4.1.2. la contraddizione identitaria: soggettività e (è) relazione (riconoscimento, interazione)
(seconda contraddizione; di carattere dialettico)
«… non ci è stato possibile parlare di identità senza fare riferimento al rapporto con gli altri.
L’individuo non è una monade chiusa in se stessa e isolata nella sua autonomia, ma sin dalla sua
origine egli si trova in un rapporto costitutivo con altri individui. Si pone qui in evidenza la
dimensione dell’intersoggettività, intesa non come incontro di soggetti già formati, bensì come
l’essenziale relazionalità a partire dalla quale si rende possibile la stessa formazione della
soggettività. Nessuna coscienza di sé potrebbe infatti emergere, nessuna individualità potrebbe
costituirsi se non vi fosse all’origine una relazione con gli altri. …Per questa ragione, il problema
dell’autocoscienza e dell’identità va considerato in stretta connessione con quello del
riconoscimento, dal momento che sia l’identità personale sia l’identità sociale vengono costruendosi
solo attraverso l’interazione con gli altri. Come ricorda Lucio Cortella, è soprattutto Hegel ad avere
dimostrato la tesi fondamentale che «non si può dare un’unica autocoscienza, giacché il suo
costituirsi dipende dal sussistere di un’altra autocoscienza, o meglio dal suo essere riconosciuta da
parte di un’altra. La condizione della consapevolezza di sé è il riconoscimento da parte di un’altra
autocoscienza» [Cortella 2002, 257]. La richiesta di riconoscimento comporta anche
necessariamente la dimensione della reciprocità, infatti la validità del riconoscimento dell’altro ha
come condizione che l’autocoscienza dell’altro «nel mentre mi riconosce, sia da me riconosciuta
degna di riconoscermi» [ivi, 265]. (Crespi p. XII)
4.2. la dinamica del riconoscimento; una doppia morsa (la convergenza tra gli opposti)
4.2.1. l’incontro che annulla: « Siamo ancora una volta noi, dalla nostra posizione di forza, a
decidere che cosa è cultura per gli altri. Ci piacciono i ritmi africani, molto meno gli ambulanti
17
africani o certi atteggiamenti da loro tenuti. Nelle manifestazioni sull’Africa sembra non si possa
fare a meno di avere tamburi che suonano, perché è questo che ci piace maggiormente della cultura
nera ed è questo che vogliamo valorizzare. Si fa coincidere la cultura con le produzioni «artistiche»
delle diverse società, adottando una visione estetizzante della cultura stessa. Nel film di Alain
Goumis L’Afrance, il protagonista, un senegalese emigrato in Francia, dice a una ragazza francese:
“Cinquant’anni fa dicevano: i negri sono selvaggi, sanno solo suonare il tam tam. Oggi dicono: les
blacks sono formidabili, hanno il ritmo nel sangue”». Aime, o.c. p. 60
4.2.2. lo scontro che annulla: «Proprio perché le minoranze attive assumono strategicamente il
compito, in sé del tutto meritorio, di difendere coloro che sono più fortemente discriminati nella
società, esse finiscono spesso con il considerare i loro membri unicamente nei termini della
categoria che definisce la loro discriminazione: il genere, il colore della pelle, le preferenze sessuali
e via dicendo. Ne consegue che gli individui, pur così difesi, debbono conformarsi ai modelli propri
della minoranza che li rappresenta e ogni loro comportamento difforme a questo riguardo tende ad
essere considerato come un tradimento. Come ha giustamente rilevato Kwame A. Appiah, nato in
Ghana e professore di studi afro-americani e di filosofia all’Università di Harvard, ciascun
individuo dovrebbe poter rivendicare il diritto di essere nero o omosessuale senza per questo
doversi necessariamente adeguare a un modello particolare di appartenenza minoritaria che
definisca come debba comportarsi un nero o un omosessuale [cfr. Appiah 1994, 163].» (Crespi, 20)
4.3. Il carattere distruttivo delle identità assolutizzate
«Se i gruppi per la difesa dei diritti degli emarginati hanno certamente un’importante funzione
strategica contro le forme di discriminazione imperanti, tali gruppi rischiano di dimenticare il loro
carattere strumentale diventando, a loro volta, strutture di imposizione autoritaria sugli individui che
intendono difendere. Un autentico riconoscimento dell’autonomia individuale può essere ottenuto a
livello politico e sociale solo se l’individuo non è costretto a organizzare la sua vita sulla base di
criteri prefissati. Quando l’identità individuale viene ricondotta all’appartenenza di gruppo l’identità
di quest’ultimo viene ad assumere un carattere assolutizzato che compromette non solo la
possibilità di sviluppare un’identità personale, ma anche la prospettiva di integrazione dei diversi
soggetti nella società più ampia. Il fatto che l’identità particolaristica tenda ad essere posta al di
sopra dei valori universali dell’essere umano determina un’erosione dei diritti umani fondamentali
[cfr. Rockefeller 1994], con il rischio di accentuare le tensioni sociali, al limite fino a forme di
fanatismo terroristico, che pongono a repentaglio, non solo le forme democratiche della convivenza,
ma anche il mantenimento di un qualunque tipo di ordine sociale.
Come ha rilevato Richard Sennett, il fenomeno del multiculturalismo, nella forma distorta nella
quale è venuto diffondendosi soprattutto negli Stati Uniti, porta in pratica al fatto che «ogni gruppo
si trincera nelle proprie appartenenze identitarie e nei propri stili di vita ed è assolutamente
indifferente alle condizioni di vita degli altri. Così il multiculturalismo decreta la fine del discorso
pubblico» [Sennett 1998, 12].» (Crespi o.c. p. 20-21)
4.3.01. la componente ideologica del multiculturalismo
«La difesa a oltranza di una specificità culturale che non trovi più nei soggetti interessati quella
vitalità necessaria alle forme culturali per continuare a esistere, costituisce pertanto la componente
ideologica del multiculturalismo odierno, che lo rende facilmente assimilabile al fondamentalismo.
Da questo punto di vista, il fondamentalismo ha un’origine sociologica prima ancora che politica o
religiosa. Esso costituisce infatti la prova tangibile della scarsa vitalità interna di una determinata
cultura, costretta per ciò stesso a eliminare il confronto con le altre culture per sopravvivere. Ciò
che in questo caso viene a essere distrutto è la struttura latente delle relazioni individuali quale
componente attiva della produzione delle forme culturali.
La globalizzazione pertanto, al pari della società di massa, non produce cultura, in quanto annulla
ogni relazione tra gli individui fondata sul riconoscimento della diversità. È pertanto illusorio
pensare di poter trovare in questa tendenza, seppur dominante, un alleato per la realizzazione di una
società multiculturale nel senso pieno del termine. Al contrario essa favorisce la riaffermazione di
18
un particolarismo culturale esasperato e istintivo quale antidoto al processo di omologazione in atto
su scala planetaria.» (Marchetti, M.C. in Pompeo oc. p.213,214)
4.3.02. globalizzazione e frantumazione
«La recente accentuazione del processo di globalizzazione, conseguente alla fine della guerra fredda
e alla rottura dell’equilibrio rappresentato dalla divisione del mondo in due blocchi contrapposti, ha
ulteriormente aggravato il processo di deterritorializzazione e di frantumazione delle appartenenze
sociali. D’altra parte, la rivendicazione del diritto di tutti i popoli, di tutte le minoranze e di tutte le
culture a essere riconosciuti su un piano di parità hanno reso sempre più difficile la possibilità di
trovare valori universalmente condivisi quali basi della solidarietà sociale.
Anche qui, a effetti positivi di liberazione e di aumento delle possibilità di autorealizzazione sia
individuale che collettiva, fanno riscontro effetti negativi di sempre maggiore dipendenza degli
individui e delle collettività da un ordine globale che, dopo aver posto in crisi il concetto
tradizionale di sovranità, più nessuno sembra veramente in grado di controllare.
Quale reazione a questa situazione sono emerse soprattutto due tendenze entrambe di segno
contrario rispetto alla solidarietà generale: da un lato, l’affermazione di un individualismo
esasperato nel quale ciascuno, chiudendosi nella propria sfera privata, sembra perseguire soltanto la
soddisfazione dei propri interessi egoistici; dall’altro, l’assolutizzazione di nuove identità sociali di
tipo particolaristico, legate all’appartenenza etnica, alla religione, a nuove forme di integralismo
nazionale, a minoranze di ogni tipo. (Crespi, p. 90)
4.3.03. il carattere costruito, fittizio e strumentale delle identità assolutizzate
Come ho già accennato, tale assolutizzazione ha portato alla manipolazione strumentale del bisogno
identitario di grandi masse da parte di centri di interesse e di potere economico politico, con effetti
conflittuali devastanti in molte parti del mondo. (Crespi, p. 90)
Il filosofo della politica Jean François Bayart ha giustamente osservato che: «Niente minaccia
maggiormente, oggi, la “stabilità dell’ordine sociale” quanto lo scatenamento dell’illusione
identitaria. È diventato urgente oppone un ethos filosofico che distingua le rispettive parti del
contingente e dell’universale, dal momento che alcuni partiti politici, in Europa e altrove, hanno
preso l’iniziativa di ciò che essi chiamano il “conflitto identitario”» [Bayart 1996, 248]. Come
rileva Bayart, il presupposto che a un’identità culturale debba corrispondere necessariamente
un’identità politica è del tutto illusorio. Nei fatti, «ciascuna di queste identità è nel migliore dei casi
una costruzione culturale, una costruzione politica o ideologica, ovvero, in fine, una costruzione
storica» [ivi, 9-10]. Il carattere distruttivo delle identità assolutizzate e la lotta per il
riconoscimento…. Un primo aspetto da affrontare, lungo le linee che abbiamo prima indicato, è
indubbiamente quello del contenimento delle componenti distruttive derivanti dai processi reattivi
di assolutizzazione delle identità sociali. Occorre promuovere la coscienza del carattere riduttivo
inerente a ogni definizione identitaria e degli elementi illusori ad essa connessi (sublimazione) in
modo da contrastare l’utilizzazione strumentale delle diverse identificazioni sia in senso
individualista sia in quello di tipo collettivistico.» (Crespi, o.c. p. 92-93)
«Nel libro Contro l’identità, Franco Remotti, attraverso la sua analisi di alcune culture “primitive”,
tra le quali si trovano anche esempi di identità flessibili ed aperte, ha messo in evidenza il carattere
costruito e fittizio delle identità assolutizzate, ponendo il problema di come «uscire dalla logica
dell’identità.» […] Egli osserva che per uscire dalla logica dell’identità, per andare «oltre
l’identità», occorre riconoscere che l’identità è troppo riduttiva e selettiva e ciò che si perde in essa
è “l’apertura all’alterità, anzi il bisogno di alterità che, spesso in modo molto dialettico, si intreccia
quasi inestricabilmente con l’esigenza di identità”» (Crespi, o.c. p. 96-98)
«La possibilità di riferirsi in negativo al senso come dimensione irriducibile ai significati, e
all’esistenza come condizione comune caratterizzata dalla mancanza e dal non-sapere, permette di
sottolineare il limite di ogni forma di assolutizzazione dei significati stessi e, al tempo stesso, di
mostrare che, sul piano pratico, occorre sapere gestire le esigenze contraddittorie tra, da un lato, il
bisogno di forme di determinatezza, necessarie a definire, sul piano pratico, regole condivise
all’interno di prospettive contingenti atte a fondare la prevedibilità e l’ordine sociale, e, dall’altro,
19
quello altrettanto vitale di non restare rinchiusi in tali forme, assolutizzandole, per mantenersi aperti
a sempre nuove possibilità e capaci di costante adattamento al mutare delle condizioni materiali e
degli eventi storici.» (Crespi, o.c. p. 107-108)
«Sottolineando, infatti, l’esigenza di non essere identificati con nessuna determinazione, (Michael)
Walzer afferma: «Noi abbiamo bisogno di essere tollerati e protetti come cittadini dello Stato e
come membri di gruppi e anche come stranieri a entrambe le cose» [Walzer 1998, 125, corsivo
mio].» (Crespi, o.c. p. 111)
Far corrispondere una identità culturale con una identità politica è confondere comunità con società,
non riconoscere o non accettare il ruolo della politica, la sua laicità e la sua funzione in termini di
giustizia formale, non riconoscere quindi ad una società il diritto ad una politica di giustizia in
termini di equità, infine, non riconoscere il diritto della persona alla propria libertà.
4.3.1. un nuovo razzismo multiculturale ? («razzismo differenzialista»)
«Dopo la seconda guerra mondiale e la presa di coscienza degli orrori del nazismo … , secondo
Taguieff [1994; 1999], il razzismo ha assunto una nuova veste, prendendo a prestito una serie di
argomenti dell’antirazzismo. Diventa infatti centrale l’idea della differenza culturale, e allo
screditato termine «razza» si sostituisce quello di «etnia» o anche di «cultura». Taguieff parla
dunque di «razzismo differenzialista». In questa chiave, le popolazioni immigrate insediate nelle
società occidentali vengono così paventate soprattutto come una minaccia per l’identità culturale
delle maggioranze autoctone. Come nota Beck, «ci si appiglia strategicamente ad un ipotetico
essenzialismo della propria appartenenza etnica per ristabilire confini che stanno svanendo e
mescolandosi, tra dentro e fuori, tra noi e loro» [Beck 2003, 11].
Il razzismo differenzialista prende allora la forma di un’esaltazione delle differenze e di una
preoccupazione per la loro preservazione. Memorie, tradizioni, modi di vita peculiari possono
essere salvaguardati solo al prezzo della separazione da altri gruppi umani, concepiti come portatori
di culture diverse. Le identità culturali vengono dunque concepite come rigide, non modificabili,
mentre le possibilità di ibridazione o meticciato vengono respinte come inaccettabili (Taguieff parla
di «mixofobia», come «orrore della mescolanza tra gruppi umani»). Gli individui vengono poi
assegnati collettivamente ad una certa «cultura» sulla base del fattore ascrittivo della nascita in un
determinato paese o della discendenza da genitori rispettivamente autoctoni o immigrati.
La cultura viene quindi in un certo senso naturalizzata e serve a rinchiudere gli individui in identità
immutabili. L’ideale vagheggiato è quello di popoli (o culture) che rimangano nettamente distinti e
abitino territori separati (vivano «nel proprio paese») al fine di preservare la ricchezza delle
diversità.» Ambrosini, Maurizio 2008 Un’altra globalizzazione. La sfida delle migrazioni
transnazionali, il Mulino, Bologna, pp. 185-186
«Attualmente il pericolo maggiore è quello che l’idea di soggetto venga corrotta dall’ossessione per
l’identità. È un errore, in nome dell’idea di soggetto, difendere un diritto alla differenza. Questa
nozione, che porta in sé molti elementi positivi, è carica anche di conseguenze pericolose, poiché
implica per molti un diritto alla chiusura, all’omogeneità, dunque a quella pulizia etnica e religiosa
di cui molte parti del mondo hanno subìto gli effetti distruttivi. Il diritto di essere un soggetto è il
diritto per ognuno di unire la propria partecipazione all’attività economica, all’esercizio dei propri
diritti culturali, nel quadro di un riconoscimento degli altri come soggetti. … Allo stesso modo, gli
ex colonizzati, i nuovi immigrati, i musulmani vengono troppo spesso definiti in base a ciò che
subiscono, come se non potessero essere attori della propria storia.» Touraine Alain 2004 La
globalizzazione e la fine del sociale. Per comprendere il mondo contemporaneo, il Saggiatore,
Milano 2008, p. 129-130, 147
4.3.2. magliette o pelle (o i legami labili di una società complessa)?
«Anzitutto abbiamo visto come non esista una sola identità, e pertanto si possa tranquillamente
convivere con diverse «magliette», come sostiene Eric Hobshawm — al quale ci rifacciamo ancora
una volta — quando opera una colorita divisione delle identità collettive in «identità pelle» e
«identità maglietta». Le prime si fonderebbero su elementi oggettivamente condivisi dai membri di
una comunità (colore della pelle, genere biologico, ecc.); è difficile sfuggire da esse in quanto
20
fondate su elementi ascritti e facilmente riconoscibili, anche se non tutti i neri e neppure tutte le
donne si radunano sotto bandiere comuni. Però, afferma Hobsbawm, la maggior parte delle identità
collettive sono magliette più che pelle, cioè sono — almeno in teoria — opzionali, non ineludibili e
intercambiabili senza troppe difficoltà: si tratta insomma di fatti non inerenti all’oggetto stesso, ma
dipendenti dalle nostre decisioni.
Questa è la raffinata analisi degli studiosi. Ma nel nostro agire quotidiano siamo davvero coscienti
di quale sia la nostra pelle e quale invece l’abito indossato? Perché se scambiamo il secondo con la
prima (magari perché convinti dall’esterno o dall’alto) e agiamo di conseguenza ci ritroviamo a
combattere per una causa che reputiamo giusta e irrinunciabile. Il problema si pone infatti quando i
nostri cassetti sono pieni di queste magliette — quella dell’identità di classe, della nazionalità, della
fede politica, della passione calcistica — e siamo costretti a decidere quale di esse diventerà la
nostra pelle.
Come afferma Remotti, ogni tentativo di creare un’identità è un’azione duplice: da un lato si
include dall’altro si esclude; in nome di una particolarità si rinuncia, parzialmente o
temporaneamente, alla molteplicità. Poiché si tratta di una rinuncia parziale o temporanea, e non
necessariamente definitiva, si può dedurre che si tratta di una condizione non permanente (e
pertanto non innata) né pervasiva di tutti gli atti della nostra vita. I rapporti tra gruppi diversi
devono davvero passare per forza attraverso la cruna dell’identità? Ritengo più opportuno pensare,
come sostiene Luciano Li Causi, che due o più gruppi «possano intrattenere tra di loro ogni tipo di
relazione, l’etnicità può esservi presente come elemento tra gli altri, o può essere totalmente
assente; in questo senso i rapporti sono economici, matrimoniali, politici, ideologici, ecc., con o
senza componente etnica, a seconda delle situazioni.» (Aime, o.c. p. 125-126)
4.3.3. Multiculturalismo e libertà culturale
«Negli ultimi anni, il multiculturalismo si è guadagnato sempre più spazio in quanto valore
importante o, volendo essere più precisi, in quanto slogan efficace (dal momento che i valori che
esprime non sono del tutto chiari). La fioritura simultanea di diverse culture all’interno dello stesso
paese o della stessa regione può essere giudicata una cosa importante di per sé, ma molto spesso i
fautori del multiculturalismo lo difendono sostenendo che esso sia una condizione necessaria per la
libertà culturale. È un’affermazione che dev’essere esaminata in modo più approfondito.
L’importanza della libertà culturale dev’essere distinta dalla celebrazione di ogni forma di eredità
culturale, senza curarsi se le persone coinvolte sceglierebbero quelle particolari pratiche se fosse
data loro l’opportunità di sottoporle ad analisi critica e di conoscere adeguatamente altre opzioni e
altre scelte esistenti. Anche se si è discusso molto, negli ultimi anni, del ruolo importante e capillare
dei fattori culturali nella vita sociale e nello sviluppo umano, l’attenzione si è tendenzialmente
concentrata, esplicitamente o implicitamente, sull’esigenza della conservazione culturale (ad
esempio, il mantenimento di stili di vita conservatori da parte di individui che non sempre
accompagnano il proprio trasferimento geografico in Europa o in America con un adattamento
culturale). La libertà culturale può includere, fra le altre priorità, la libertà di contestate l’adesione
automatica alle tradizioni antiche, quando le persone — in particolare i giovani — vedono una
ragione per cambiare il proprio modo di vivere.» (Sen 2006 p.115)
«Perorare la diversità culturale perché è quello che gruppi diversi di persone hanno ereditato dai
loro predecessori non è palesemente un’argomentazione basata sulla libertà culturale (anche se a
volte viene presentata come se fosse una tesi «pro-libertà»). Nascere in una determinata cultura non
è ovviamente una manifestazione di libertà culturale, e preservare ciò che ti è stato appiccicato
addosso solo in virtù della nascita, difficilmente potrà essere, di per sé, un esercizio di libertà. Non
si può giustificare nulla in nome della libertà se non si dà effettivamente alle persone l’occasione di
esercitarla, questa libertà, o se quantomeno non si cerca di valutare attentamente in quale modo
sarebbe esercitata un’opportunità di scelta qualora essa fosse resa disponibile. La repressione
sociale può negare la libertà culturale, ma la violazione della libertà può venire anche dalla tirannia
del conformismo, che rende difficile ai membri di una comunità optare per altri stili di vita.» (Sen
2006 p. 118) «Come detto in precedenza, la popolazione mondiale non può essere vista
21
esclusivamente in funzione delle affiliazioni religiose, come una federazione di religioni. Per gli
stessi motivi, più o meno, una Gran Bretagna multietnica non può essere considerata un insieme di
comunità etniche. La visione «federativa», però, ha avuto un grande successo nella Gran Bretagna
contemporanea. Nonostante le implicazioni tiranniche insite nel collocare gli individui in rigidi
compartimenti ognuno corrispondente a una data «comunità», questa impostazione viene spesso
considerata, in maniera piuttosto sconcertante, come alleata della libertà individuale. Esiste perfino
una «visione», molto propagandata, del «futuro della Gran Bretagna multietnica» che vede il paese
come «una federazione elastica di culture tenute insieme da vincoli comuni di interessi e di affetti e
da un senso collettivo dell’essere».
Ma è indispensabile che il rapporto di un individuo con la Gran Bretagna venga mediato attraverso
la cultura in cui questo individuo è nato? Una persona può decidere di accostarsi a più di una di
queste culture predefinite, o, altrettanto plausibilmente, a nessuna. Un individuo può anche decidere
che la sua identità etnica o culturale è meno importante, per fare un esempio, delle sue convinzioni
politiche, o dei suoi impegni professionali o dei suoi convincimenti letterari. È una scelta che
dev’essere fatta da quell’individuo, a prescindere dalla casella che occupa in questa bizzarra
«federazione di culture».» (Sen 2006 p.160-161)
«L’illusione dell’identità unica, funzionale agli scopi violenti di chi orchestra questi scontri, è
abilmente coltivata e fomentata dai signori della persecuzione e del massacro. È più che naturale
che quelli che per mestiere fanno gli istigatori di violenza cerchino di creare l’illusione dell’identità
unica, da sfruttare per creare una contrapposizione, e non è un mistero che questo tipo di
riduzionismo sia un obiettivo perseguito. Quello che si fa fatica a capire, però, è perché questa
ricerca di unicità abbia tanto successo, considerando che si tratta di una tesi straordinariamente
ingenua in un mondo in cui la pluralità di affiliazioni è un fatto evidente. Considerare una persona
esclusivamente in base a una soltanto delle sue numerose identità è ovviamente un procedimento
intellettuale estremamente rozzo (come ho cercato di illustrare nei capitoli precedenti), eppure, a
giudicare dalla sua efficacia, l’illusione ricercata di un’unicità identitaria è facile da difendere e
facile da promuovere. Patrocinare un’identità unica per uno scopo violento assume la forma di
isolare un gruppo identitario — direttamente legato allo scopo violento in questione — dagli altri,
procedendo quindi a mettere in secondo piano la rilevanza delle altre associazioni e affiliazioni,
attraverso un ricorso selettivo all’enfasi e all’istigazione.» (Sen, Amartya 2006 Identità e violenza,
Laterza, Roma-Bari 178)
«Ma come l’ibridazione globalizzante non cancella le identità, pronte a risorgere e a reinventare se
stesse nelle guise più imprevedibili, così non le cancellano l’organizzazione postfordista della
produzione e l’estendersi e l’ingolfarsi della comunicazione fino alla completa cecità della
comunicazione stessa. Le diverse identità riappaiono, davanti allo sguardo critico, nel momento in
cui si consideri la comunicazione sotto l’aspetto di una speciale attribuzione che avviene al suo
interno: quella di potere. Attribuire potere a qualcuno o a qualcosa significa con ciò stesso istituire
un’asimmetria tra chi si trova in una posizione di vantaggio e chi si trova in una posizione di
svantaggio. Così le identità si ridefiniscono, e con esse i termini del conflitto potenziale. Il compito
della teoria critica in questo campo non è quello di riproporre le vecchie identità come motori
immobili della dinamica sociale, ma di portare alla luce ovunque nel movimento della
comunicazione attribuzioni di potere e asimmetrie. Quello dell’identità, infatti, è un terreno di
lotta.» Identità. Voce per un lessico (2001) in Genovese, Rino 2008 Gli attrezzi del filosofo. Difesa
del relativismo e altre incursioni. Manifestolibri, Roma p.175
4.4. Identità e differenze culturali, strade percorse per la comunicazione: un bilancio
«Esiste un aneddoto piuttosto noto sul principe Petar Potrovic Njegoš, che regnò in Montenegro
durante la prima metà del XIX secolo e di venne famoso sia per le battaglie contro i turchi sia per la
sua vena epica: quando un ospite inglese, profondamente impressionato da un rituale del luogo,
espresse il desiderio di prendervi parte, Njegoš ribatté rudemente: “Che bisogno c’è che anche lei
faccia l’idiota? Non bastiamo noi per questi giochi stupidi?”. Slavoj Žižek
22
«Per concludere, vorrei tornare su alcune questioni sollevate nell’introduzione a proposito del
dibattito sulla società multiculturale, richiamando brevemente quattro tipi di discorso,
apparentemente diversi, attorno a identità e differenze culturali.
Un primo tipo rinvia all’ideologia della political correctness, intesa come forma parossistica di
rispetto per le specificità culturali, riferite a gruppi sociali culturalmente definiti, che si traduce
nell’obbligo di astenersi dall’uso di espressioni e locuzioni poco riguardose nei confronti delle
identità — da intendersi come prerogative dei suddetti gruppi — in gioco nei processi di
interazione, e che genera, come conseguenza forse non intenzionale, separazione e irrigidimento dei
confini, ingessa la comunicazione e i traduce ogni problema di equità e giustizia sociali in una
questione di buone maniere.
Un secondo tipo coincide con una versione ingenua del discorso multiculturalista, riproposta di
sovente da politici e amministratori “sensibili” alla valorizzazione delle differenze culturali, oltre
che negli interventi di apertura dei convegni dedicati alla società multiculturale, alla comunicazione
o alla pedagogia interculturali, ai media multietnici ecc. Vi si ritrovano tre elementi ricorrenti:
1. L’idea che le società contemporanee si contraddistinguano per una complessità culturale inedita
rispetto al passato e che tale eterogeneità debba essere tutelata in quanto elemento di arricchimento
per tutti.
2. L’affermazione compiaciuta che un mondo ricco di diversità culturali (intese, di norma, come
culture specifiche di gruppi nazionali) sia più interessante di una società che tenda
all’omologazione: che Belleville sia più affascinante di Pontida e che la world music renda più
attraenti le nostre città, anche se i venditori abusivi di djembe ne mettono a repentaglio il decoro.
3. La convinzione che gli immigrati, organizzati in gruppi tendenzialmente nazionali (“magrebini”,
“sudamericani”, “africani dell’area subsahariana” permettendo) siano portatori di culture specifiche
che dovrebbero essere riconosciute e valorizzate insieme alle lingue che le veicolano.
La terza manifestazione del discorso sulle differenze, ben più truce e inquietante delle due viste
finora, è rappresentata dall’ideologia dello scontro di civiltà, ovvero dall’accettazione del mantra
per il quale, dalla fine della Guerra Fredda, le relazioni internazionali si starebbero strutturando
attorno a linee di conflitto, di matrice essenzialmente religiosa, tra civiltà fra loro inconciliabili
(occidentale, latinoamericana, islamica, sinica, indù, ortodossa, buddista e giapponese) e, cosa più
importante, tutte incompatibili (le altre) con quella “occidentale”. Secondo questa lettura,
l’influenza dell’Occidente starebbe scemando e, svanita qualsiasi possibilità di egemonia da parte di
pretese di carattere universalistico, l’unica via d’uscita per l’Europa e il Nord-America sarebbe
consolidare e difendere la “civiltà occidentale” all’interno dei suoi confini. Un discorso, questo,
sempre più al centro delle preoccupazioni di politici e intellettuali nostrani — oltre che di una parte
tutt’altro che minoritaria della Chiesa cattolica-romana — e che paventa un lugubre futuro di guerre
di religione.
Infine, abbiamo il discorso “differenzialista” (Taguieff, 1997), inteso come la versione
relativamente recente e “sofisticata” assunta dall’ideologia razzista, in cui il determinismo biologico
che prevede una stretta relazione tra corredo genetico, tratti somatici e tratti culturali e sulla cui base
venne istituita una gerarchia tra le razze che legittimò tanto il colonialismo, inteso come funzione
civilizzatrice dell’Occidente nei confronti del resto del mondo, quanto le persecuzioni razziali sulla
base dell’idea che si dovesse preservare la purezza della razza da ogni rischio di contaminazione
viene sostituito dall’idea che le razze, biologicamente indistinguibili, si differenzino per le loro
specifiche culture, che dovrebbero essere preservate dai rischi di omologazione e ibridazione. Se
l’espressione politica estrema, e più rara, di tale ideologia è costituita dall’apartheid, quella più
diffusa e socialmente accettata implica il rifiuto dell’immigrazione in quanto minaccia per l’identità
culturale dei singoli stati nazione.
Queste quattro “formazioni discorsive”, al di là delle evidenti differenze, poggiano su una comune
concezione della cultura, che, come è stato mostrato molto bene da Zoletto (2003, Gli equivoci del
multiculturalismo, in aut aut, 312, pp. 6-18), incorpora i seguenti elementi:
23
1. Un’idea essenzializzante e generalizzante delle culture, intese come sistemi simbolici statici con
confini definiti identificabili sulla base di un repertorio di elementi: valori, norme, usi. costumi,
manufatti, forme simboliche, credenze religiose ecc.
2. Un’assunzione di sovradeterminazione e monoculturalità, per cui le culture sarebbero entità
definite e internamente omogenee che circolano per il pianeta grazie a moltitudini di sherpa da esse
plasmati: i famosi “portatori di un bagaglio culturale”; qualunque elemento di differenziazione
interno ai gruppi culturali (classe, età, genere ecc.) risulterebbe inoltre irrilevante rispetto
all’importanza dei riferimenti culturali come elemento di identificazione.
3. Una concezione ctonia delle culture (Dal Lago, 2006) che, riproducendo coordinate di carattere
geopolitico, avrebbero confini geografici ben definiti (coincidenti, generalmente anche se non
necessariamente, con quelli di un qualche stato nazione [costruzione artificiale delle imprese
coloniali e retaggio di quella presenza ora definito nella forma di Stato nazionale]) e sarebbero
strettamente legate a una lingua e a un’etnia.
4. Una componente spiccatamente ideologica che porta a misconoscere l’esistenza di relazioni
asimmetriche di potere tra singoli e gruppi sociali, che vengono espunte dal dibattito e sostituite con
differenze e identità culturali.
5. Un gioco perverso di stigmatizzazione e autostigmatizzazione, connesso a processi di etero- e
autoidentificazione, ove il lessico multiculturale del gruppo sociale dominante (la società di
accoglienza, nel caso dei migranti) venga adottato dai gruppi subordinati e minoritari per
autodefinirsi (le “comunità etniche/nazionali”).
L’ultimo punto rinvia a uno degli esempi più eclatanti di discorso culturalista essenzializzante, che
trasforma i migranti in gruppi/minoranze etniche/culturali, ricollocando una figura contraddistinta,
per definizione, dalla fluidità entro un contenitore (un’identità) culturale rassicurante, proprio a
causa della sua diversità, e nonostante questa. Una trasformazione che cancella ciò che di più
importante i migranti simboleggiano, ovvero, come ricorda Dal Lago (ibidem), che il territorio e la
cultura possono non essere così importanti o indispensabili per la nostra esistenza. Considerare i
migranti come “magrebini”, “africani”, “cinesi”, “islamici”, “sudamericani” ecc. significa negare e
neutralizzare il carattere indeterminato, composito, variegato e sconcertante dei loro riferimenti
culturali. Significa riconsegnarli a patrie immaginarie che proprio per la loro diversità ci rassicurano
circa la nostra identità. La stessa idea soggiacente allo scontro di civiltà (“solo a partire da
un’identità forte possiamo confrontarci con popolazioni che mantengono riferimenti culturali
religiosi ben più solidi dei nostri”) può essere riletta, in questa chiave, come un invito a consolidare
i nostri riferimenti identitari e a riconnetterli a un territorio (al contempo geografico e simbolico).
Omogeneità culturale e disincentivazione della fluidità delle appartenenze e delle identità, peraltro,
hanno rappresentato da sempre, come ci ha ricordato Sayad (1999), la regola degli stati nazione.
L’emergere di minoranze etniche, in questo senso, non costituisce affatto un fallimento nella
costruzione degli stati nazione, poiché non ne mette in discussione le coordinate di fondo. Ciò che
risulta intollerabile per l’identità nazionale non è, infatti, l’esistenza di identità culturali alternative,
ma l’assenza di un’identità forte, la multiappartenenza e, quindi, il carattere molteplice,
rinegoziabile e rivedibile delle nostre lealtà. I migranti, per riprendere una formula di Sayad,
denaturalizzano, in quanto tali, l’ordine naturalizzato della nazione. Ma tale ordine viene ricreato
tramite naturalizzazioni subordinate: le minoranze etniche/culturali, appunto.
Se, dunque, ciò che ci sconcerta nei migranti è il carattere composito, opportunistico, negoziale,
deterritorializzato dei loro riferimenti culturali, la questione delle differenze, ove riguardi qualcosa
di diverso da un “diritto generico all’individuazione” e quindi all’affermazione della differenza in
quanto individui, diviene una faccenda complessa e scivolosa, che certo non può essere risolta con
un invito al rispetto e alla valorizzazione delle culture. Considerazioni analoghe potrebbero essere
fatte anche a proposito dei progetti sviluppati nella scuola per favorire il diffondersi di metodologie
di insegnamento basate sull’intercultura e sul mediatore culturale, una delle figure chiave
dell’“incontro tra culture” (Aime, 2004).
Il discorso essenzializzante incorpora comunque un’ulteriore assunzione, di particolare interesse per
24
le questioni che ho affrontato nel volume. Mi riferisco alla reificazione delle culture che deriva dal
disconoscimento sia del carattere processuale e contestuale del loro operare e manifestarsi (legato
dunque alle specifiche situazioni e alle strategie degli attori rilevanti in gioco) sia della relazione
indissolubile che esiste tra cultura e comunicazione. Qualunque cosa siano le culture — e
indipendentemente da come le si consideri sul piano epistemologico (essenza, processo, discorso)
— esse, infatti, possono esprimersi solo nella comunicazione e, ove quest’ultima abbia luogo
nell’ambito di interazioni sociali faccia a faccia, il loro manifestarsi dovrà “fare i conti” con i
vincoli specifici che caratterizzano tale dimensione della vita sociale.»
Quassoli, Fabio 2006 Riconoscersi. Differenze culturali e pratiche comunicative, ed. Raffaello
Cortina, Milano, pp. 201-215 (passim)
5. identità oltre il multiculturalismo: interculturalismo.
5.1. la situazione il problema e l’obiettivo
5.1.1.interculturalismo vs multiculturalismo (Rimbaud: «Je est un autre»). In sintesi e richiamo del
problema.
In sintesi e per passaggio. «‘Multiculturalismo’ è un termine che si è diffuso in Occidente a partire
dagli anni Sessanta per indicare il rispetto, la tolleranza e la difesa delle minoranze culturali. Il
concetto di multiculturalismo è diventato un immaginario collettivo («tutti differenti, tutti uguali»:
Young, 1996) che si presenta come l’ultima versione del concetto di laicità in senso modernizzante:
mettere ogni cultura sullo stesso piano ed evitare di parlare di ‘verità’ nella sfera pubblica, perché
ogni individuo è portatore di una sua verità e le diverse verità non sono confrontabili fra loro. Il
multiculturalismo così diventato una ideologia politica che propugna una cittadinanza inclusiva nei
confronti delle culture ‘diverse’.» (Donati, 2008, p.V)
«La dottrina del multiculturalismo è nata per promuovere la tolleranza e il reciproco rispetto fra
culture differenti, nell’assunto che esse siano inconciliabili. Apparentemente favorisce il
riconoscimento del diritto alla diversità culturale; ma in realtà fallisce nel suo intento. Perché?
La ragione fondamentale sta nel fatto che l’ideologia del multiculturalismo ha una teoria assai
riduttiva del riconoscimento delle diversità/differenze culturali, che comporta la cristallizzazione e
un trattamento assai limitativo delle potenzialità che ineriscono alle differenze culturali.
Per esempio, il multiculturalismo riconosce il diritto a parlare la propria lingua, perché ritiene che
parlare una lingua significhi appartenere a un mondo specifico, e che i mondi linguistici siano
‘intraducibili’; il che può essere vero per molti aspetti, ma in ogni caso produce due effetti negativi.
Primo, rinuncia a compiere uno sforzo per far accedere tutte le persone, quale che sia la loro lingua,
a quei servizi essenziali che richiedono solo un minimo di conoscenze linguistiche per essere fruiti;
secondo, sottovaluta il fatto che, quando si tratta di risolvere dei problemi nella vita pratica, esiste
una ragione prelinguistica che può mettere in sintonia le persone, come nei casi in cui si tratta di
darsi una mano per soccorrere una persona in difficoltà.» (Donati 2008, p.XIV)
«Sfortunatamente, dopo essere stato adottato come politica ufficiale in vari paesi, il
multiculturalismo ha generato effetti più negativi che positivi. Ha creato frammentazione della
società, separatezza delle minoranze, relativismo culturale nella sfera pubblica. Come dottrina
politica appare sempre più difficile da praticare. Al suo posto si parla oggi di interculturalità.
Tuttavia, anche questa espressione appare piuttosto vaga e incerta.
Il presente volume discute quali siano le possibili strade da percorrere per evitare i fallimenti del
multiculturalismo, e si chiede se la via della interculturalità sia una soluzione adeguata.
La mia tesi è che la teoria della interculturalità ha il vantaggio di mettere l’accento sull’inter, ossia
su ciò che sta fra le culture, e indubbiamente aiuta a costruire dei ponti, o più spesso dei cuscinetti,
fra le culture. Per esempio, può mettere in luce che certe azioni sono discriminatorie verso chi ha
particolari caratteristiche (il colore della pelle, l’etnia), e quindi fare in modo che coloro che sono
discriminati possano godere degli stessi diritti degli altri: si pensi a quei test per l’assunzione di
manodopera che strutturalmente discriminano le persone di colore o chi, provenendo da culture
25
orientali, non ha gli stessi modi di vivere degli autoctoni. L’interculturalità può aiutare ad
accomodare le culture fra loro, a trovare un modus vivendi fra di esse, in nome di un principio di
giustizia che riconosca il carattere ingiusto di una esclusione. Ma l’approccio interculturale,
genericamente inteso, non possiede ancora gli strumenti concettuali e operativi per comprendere e
gestire i problemi della sfera pubblica quando le diverse culture esprimano dei valori radicalmente
conflittuali fra loro: per esempio, nel caso di chi rifiuta la trasfusione di sangue anche se ciò porta
alla morte, o di chi vuole portare il burqa (l’indumento islamico che copre integralmente la donna),
o di chi segue l’usanza di procedere alle mutilazioni sessuali femminili in età infantile per motivi
rituali e/o religiosi: tutti casi in cui — per quanto riguarda l’Italia — si interviene di solito con il
divieto della legge.
Le difficoltà dell’interculturalità derivano da due carenze:
1) una insufficiente riflessività interna alle singole culture (esse sono costrette a mettersi in
discussione, ma reagiscono il più delle volte reiterando le proprie credenze, senza un’adeguata
capacità autoriflessiva);
2) la mancanza di un’interfaccia relazionale fra le culture (fra i soggetti che ne sono portatori), tale
da renderle capaci di gestire le differenze in modo da evitare la guerra reciproca o la separazione
senza dialogo.» (Donati 2008, p. V-VII )
5.1.2. il problema giuridico-politico delle identità collettive e una carenza giuridica, anche frutto
dell’impostazione tradizionale moderna del problema politico. Anche se, a livello politico, «sono
sempre attori collettivi quelli che si affrontano, disputando su scopi collettivi e sulla distribuzione di
beni collettivi» (Habermas, Jürgen (1996), Lotta di riconoscimento nello stato democratico di
diritto, in Taylor, C., Habermas, J, Multiculturalismo, Feltrinelli, Milano 2001, p. 62),
l’impostazione giuridica giusnaturalistica moderna, di tradizione liberal-democratica, pone al centro
il riconoscimento e la garanzia dei diritti individuali. «Sembra tuttavia – almeno all’apparenza – che
il problema debba porsi altrimenti quando ci troviamo di fronte a pretese di riconoscimento che
sono avanzate da identità collettive e mirano a equiparare forme di vita culturali diverse.»
(Habermas, ivi, 65) in altri termini, il problema «della parificazione giuridica e dell’eguale
riconoscimento di gruppi culturalmente definiti, cioè a dire di collettività che si differenziano tra
loro per tradizioni, forme di vita, discendenza etnica ecc., e i cui membri vogliono distinguersi dalle
altre collettività per conservare e sviluppare una propria identità specifica.» (Habermas, ivi, 80).
«Il multiculturalismo assoluto che implica un relativismo assoluto dei valori conduce
inevitabilmente a quello scontro di civiltà di cui ha tanto parlato Huntington. Il relativismo dei
valori dissolve le fondamenta dei diritti comuni. Perché ci sia comunicazione occorre sempre un
certo grado di universalismo, come ha spiegato Habermas, interrogandosi sulle condizioni della
comunicabilità. In questo senso, è importante ricordare che ogni essere umano o gruppo sociale è
comunque dotato di diritti di natura universale.» (Alain Touraine, intervista)
5.1.3. Le difficoltà o la dichiarata “fine” del multiculturalismo non può diventare contesto per
riprendere e rilanciare progetti politici di identità nazionale. Camuffati dai termini di cittadinanza e
di difesa dei valori compaiono progetti di identità nei quali lo Stato si attribuiscono un ruolo guida e
costituente; così nel proclami di alcuni capi (o ex) di Stato come Nicolas Sarkozy (Francia), Angela
Merkel (Germania), David Cameron (Inghilterra) (il tema in Todorov Tzvetan 2009 La paura dei
barbari. Oltre lo scontro delle civiltà, Garzanti Milano; e più di recente in Todorov Tzvetan 2012 I
nemici intimi della democrazia, Garzanti, Milano; in particolare il capitolo 9, Populismo e
xenofobia; qui preso in esame il caso tedesco, inglese e francese).
5.2. proposte per vie di uscita
5.2.1. alcuni postulati (due)
5.2.1.1. l’individuo si definisce nella comunità-società
«Le persone (quindi anche i soggetti giuridici) acquistano identità solo tramite socializzazione»
(Habermas, ivi, 70)
5.2.1.2. occorre restare nell’ambito della libertà personale – individuale
26
«… la convivenza giuridicamente equiparata dei diversi gruppi etnici, e delle loro forme di vita
culturali, non ha bisogno di essere tutelata da diritti collettivi (cioè da quel tipo di diritti che
finirebbero per “sovraccaricare” una teoria dei diritti modellata su soggetti giuridici individuali).
Anche se fosse effettivamente possibile concedere simili “diritti di gruppo”, nell’ambito di uno stato
democratico di diritto essi sarebbero non solo superflui ma anche normativamente discutibili.
Infatti, la tutela di tradizioni e forme-di-vita costitutive dell’identità deve, in ultima istanza, servire
unicamente al riconoscimento dei loro membri in quanto individui. Essa non può avere il senso di
una tutela biologica della specie compiuta per via amministrativa. Il punto di vista ecologico della
conservazione delle specie non può essere trasferito alle culture. Le tradizioni culturali, e le forme
di vita in esse articolate, si riproducono di regola per il fatto di convincere tutti coloro le cui
strutture della personalità ne risultano influenzate, motivandoli ad assimilarle e a svilupparle in una
maniera produttiva. Uno stato di diritto può soltanto rendere possibile questa prestazione
ermeneutica necessaria alla riproduzione culturale dei mondi di vita. Invece una “sopravvivenza
garantita” dovrebbe necessariamente sottrarre ai partecipanti proprio quella libertà del dire-sì e direno che è oggi preliminare a qualunque acquisizione, o presa in cura, di una data eredità culturale.
Nelle condizioni di una cultura fattasi riflessiva, possono mantenersi in vita soltanto le tradizioni e
le forme di vita che, pur legando a sé i propri membri, non si sottraggano al loro esame critico e
tengano sempre aperta ai discendenti l’opzione o di apprendere da tradizioni diverse o anche di
convertirsi e mettersi in marcia verso nuovi lidi. … Nelle società multiculturali, la convivenza
giuridicamente equiparata delle forme-di-vita significa garantire a ogni cittadino tutto un ventaglio
di possibilità. Per un verso c’è la possibilità d’invecchiare, senza subire umiliazioni, nel mondo
tradizionale della propria cultura e di allevare in essa i propri figli, il che significa la possibilità di
confrontarsi con questa cultura (così come con qualunque altra), di svilupparla in maniera
convenzionale oppure di trasformarla. Per un altro verso c’è la possibilità di dimenticare
tacitamente gli imperativi di questa cultura oppure di dichiarare loro guerra in maniera autocritica,
continuando a vivere con il rovello di aver rotto i ponti (o addirittura con una sorta d’identità
scissa). La trasformazione accelerata delle società moderne fa saltare tutte le forme di vita
stazionarie. Le culture restano in vita soltanto se traggono dalla critica e dalla secessione la forza
per autotrasformarsi. Tutte le garanzie di tipo giuridico devono sempre presupporre che nessuno sia
privato della possibilità di rigenerare questa forza nell’ambito del proprio contesto culturale. D’altro
canto questa forza si sviluppa non soltanto attraverso la contrapposizione e la difesa rispetto a
persone e a culture straniere, ma anche — almeno nella stessa misura — attraverso il mantenimento
di un rapporto di scambio con esse.» (Habermas, ivi, 89-91).
5.2.2. lo strumento per l’obiettivo è la ragione relazionale
5.2.2.1. cultura in contesto sociale; comunanza e riconoscimento
«La differenza fa problema quando non sia inquadrata o inquadrabile in modo significante, perché
manca un contesto relazionale di riconoscimento che fornisca una risposta alla dissonanza cognitiva
e alle sfide che essa pone. La ragione relazionale viene a dirci che l’aspetto espressivo (culturale) e
quello relazionale (la società) non sono separati, ma concretamente sempre interconnessi. La cultura
vive nella relazione sociale, non fuori di essa. Se la differenza percepita fa problema, è perché la
comunanza, che esiste nella relazione, non emerge prima del sentire la differenza, ma solo dopo di
essa. E allora ci si chiede: perché, nell’incontro fra persone di culture diverse, la differenza emerge
prima di ciò che è comune?
Se, per esempio, un italiano di classe media vedesse un individuo mangiare la carne cruda di un
cane, molto probabilmente la prima reazione (reattività istintiva) sarebbe di sentire quel gesto come
disgustoso, perché i suoi sensi risponderebbero attraverso un’identità simbolica per la quale quel
gesto esprime un atto barbaro. Solo con un atto di riflessività potrebbe arrivare a dire: ‘ma è un
uomo come me’ (comunanza attraverso una relazione di riconoscimento). Questa è quella che io
chiamerò la ragione relazionale. E la ragione relazionale che gli fa vedere la comunanza con l’Altro
27
come persona e lo induce a elaborare il perché della differenza, il suo significato, la sua
ammissibilità o meno, oppure ancora il rispetto o addirittura la condivisione. (Donati 2008, p. XI)
Abbiamo bisogno di un pensiero che, attraverso la riflessività, sia in grado di mostrarci la
comunanza, da cui nasce la differenza. Se vedo la comune umanità, allora potrò declinare la
differenza in modo tale da distinguere in essa ciò cui posso rinunciare, perché è un motivo
irrazionale (non stabilisce alcuna relazione significativa), e ciò che, invece, può costituire una utile
base per l’incontro e il dialogo su qualcosa di degno per entrambi, che può specificarsi in modi
diversi di essere — senza suscitare l’estraneazione, l’esclusione, il conflitto, lo scontro —
semplicemente perché sono ‘valori di scopo’ che rispondono diversamente a un comune ‘valore
della dignità’.» (Donati 2008, p. XII)
5.2.2.2. il contesto di metodo della ragione relazionale: le due semantiche della ragione occidentale,
quella dialettica (rapportata ad un valore, segnata dell’orientamento a uno scopo) e quella binaria
(ragione strumentale, rivolta ai mezzi), e, per contrasto e superamento, la logica del dono (cfr.
Marcel Mauss, Saggio sul dono).
Occorre « mettere in luce i limiti delle attuali semantiche del riconoscimento, attraverso cui
vengono definite e trattate le differenze culturali, per esplorare un’ipotesi: che stia emergendo una
nuova semantica, che chiamo relazionale, la quale definisce le identità e le differenze culturali
come relazioni sociali. […] Trattare le differenze culturali come relazioni sociali significa
affrontare il problema del riconoscimento in termini di circolazione di beni. Il riconoscimento sarà
tanto più pieno quanto più questi beni sono dati-ricevuti-contraccambiati come doni.» (Donati 2008,
p. XIV-XVI)
«L’approccio al riconoscimento dell’Altro come circolazione di doni reciproci porta a indagare il
tipo di razionalità che è inerente allo scambio dei doni. Ci si chiede: è razionale edificare la nostra
identità culturale attraverso il riconoscimento della nostra differenza (la differenza che ciascuno ha
non solo rispetto all’Altro, ma anche rispetto a se stesso) come prodotto di una circolazione di doni?
Oppure è irrazionale?
Per rispondere a questa domanda, dobbiamo introdurre il problema di come la ragione umana
intervenga nel processo di riflessività e lo configuri, ossia quale forma gli dia.
Da questo punto di vista si vede che le due semantiche tipiche della modernità occidentale, cioè
quella dialettica e quella binaria, hanno una visione assai limitata della ragione umana:
rispettivamente come volontà di realizzare un valore di per sé non-razionale (Wertrationalität —
razionalità rispetto al valore) e come razionalità strumentale (Zweckrationalität razionalità rispetto
allo scopo), secondo la nota distinzione di Max Weber (1968, Economia e società, pp. 21-22). La
razionalità che ha percorso il Novecento è stata una forma quanto mai riduttiva, che ha mutilato le
potenzialità della ragione umana. (Donati 2008, p. XVI)
È a questo punto che formulo la mia proposta: dobbiamo rivedere la teoria sociologica della
razionalità, introducendo il concetto di ragione relazionale. Con tale espressione intendo dire che la
ragione umana può e deve essere compresa come un complesso di quattro componenti: la
razionalità strumentale (che riguarda i mezzi più adatti per raggiungere uno scopo), la razionalità
dell’orientamento a uno scopo (in questo caso Wert è inteso come ‘valore di scopo’, laddove lo
scopo è una ‘buona ragione’ che può anche essere una semplice opinione o un’ipotesi di ricerca), la
razionalità normativa della relazione (ossia la logica regolativa che è inerente a ogni specifica
relazione la quale, se vogliamo ricorrere alla lingua di Weber, può essere chiamata
Beziehungsrationalität) e la razionalità del valore (intendendo per ‘valore’ il criterio di
valorizzazione della relazione in ciò che essa ha di degno, di ciò che la relazione preserva e
promuove come degno di essere perseguito, ossia la ‘razionalità della dignità’ che è in gioco nella
relazione: Würderationalität). (Donati 2008, p.XVII)
La ragione relazionale può essere definita come la modalità massimamente riflessiva per gestire le
differenze culturali nella misura in cui:
1) porta sulla scena le ragioni delle relazioni sociali (non solo le ragioni degli individui e la ragione
funzionale del sistema sociale);
28
2) connette fra loro le componenti della ragione umana;
3) le fa operare relazionalmente fra loro, sia all’interno del complesso stesso della ragione sia ai
suoi confini con il non-razionale (il mondo dei puri simboli ideativi).
Lo scontro fra identità culturali profondamente differenti può essere evitato non già facendo ricorso
a una ideologia o a un immaginario collettivo di tipo multiculturalista (sia esso comunitarista o
liberale), secondo il quale dovremmo essere ‘tutti differenti, tutti uguali’. Questa non è solo una
promessa illusoria; è anche una premessa errata per l’incontro fra culture diverse. La comprensione
delle differenze culturali o è relazionale o non è. Perciò dobbiamo ricorrere a quella forma di
razionalità che chiamo ragione relazionale. (Donati 2008, p. XVIII)
Nella prospettiva della sociologia relazionale, la riflessività — così come viene indagata e proposta
in questo volume — è un interrogarsi, da parte di un soggetto (osservatore individuale o
collettivo), nella propria conversazione interiore, sui propri convincimenti, dubbi, emozioni,
deliberazioni, ragionamenti, alla luce di come essi si formano nel relazionarsi all’Altro. È un
ritornare su se stessi (il soggetto che riflette su se stesso, dentro se stesso) per esaminare come il
proprio Io abbia elaborato la conoscenza (rappresentazione, emozione) di un oggetto o di una
qualità dell’Altro. Ossia è l’attivazione di un processo di conoscenza sulla nostra conoscenza,
tenendo conto di come il referente, l’Altro, influisca sul nostro modo di elaborare internamente la
conoscenza, rappresentazione o sentimento che abbiamo di esso.
Questo interrogarsi (interrogare se stessi sulla costruzione del proprio Self, del suo orizzonte e modo
di vita) è una relazione che è sorta e si è sviluppata con la modernità, ma che la modernità ha poi
sempre rimosso in qualche modo, da ultimo con la dottrina di quel multiculturalismo ideologico che
non vede la costituzione relazionale delle identità culturali.» (Donati 2008, p.XX)
5.2.3. il contesto e tema del bene comune
5.2.3.1. multiculturalismo: i rischi della sua deriva ideologica.
«Nella sua definizione originaria, il multiculturalismo è un «modo di incorporazione» degli
immigrati in una società in cui prevale un’altra cultura. È un modo diverso da altre soluzioni, quali:
assimilazione …ibridazione o meticciato …melting pot …interculturalità …( è una forma di
incorporazione che dà attenzione alle differenze culturali al fine di meglio integrare l’immigrato o
una minoranza nel sistema liberaldemocratico occidentale)»
(nota: Deriva ideologica = irrigidimento e universalizzazione potenziale-auspicabile o progettato di
una teoria, con solo momentanea tolleranza di altre teorie o di ragioni ‘comuni’ diverse dalla
propria cultura, identitaria, di riferimento)
Una conciliazione tra universalismo e particolarismo e un loro solido consolidamento in termini di
bene comune sulla base del diritto. L’incontro tra universalismo (globalizzazione societaria) e
particolarismo (comunitarismi identitari) è garantito, in termini di giustizia, sulla base del diritto e
solo così viene costruito e diventa disponibile un bene comune. Diritto nel quale si ritrovano le
forme astratte del diritto universale e le forme applicate del diritto positivo. « Il diritto positivo
diventa in Habermas la risorsa funzionale – fortunatamente disponibile nel corredo di acquisizioni
storiche della modernità – che ci consente di coniugare democraticamente solidarietà e giustizia,
particolarismo delle identità e universalismo della legge. […] Solo il momento universalistico della
validità giuridica consente di equiparare tra loro identità etiche e culturali diverse, garantendo coì la
tutale dell’altro nella sua diversità.» (Habermas Jürgen 1996, Solidarietà tra estranei, Guerini e
Associati, Napoli 1997, nota del curatore Leonardo Ceppa, 11,12); ma garantendo anche il bene
comune.
5.2.3.2. la necessità di edificare un mondo comune
«In quanto ideologia, il multiculturalismo non è una soluzione che possa esprimere un progetto di
società civile, per il semplice fatto che esclude in linea di principio la possibilità e la necessità di
edificare un mondo comune. Le alternative alle fratture della società possono essere cercate in un
programma di interculturalità in cui l’inter (ciò che sta fra le culture) deve essere letto, interpretato
e agito attraverso un paradigma relazionale. Il senso di tale paradigma è di espandere la ragione
29
dalla persona umana alle relazioni sociali, in modo tale che la ragione possa giocare il ruolo di
mediazione fra le culture. Chiamerò questa ragione la ‘ragione relazionale’.» (Donati 2008, p.19)
«… il multiculturalismo, laddove riduce la sfera pubblico-politica a neutralità, sia conoscitiva sia
morale, verso le differenze (ciò che è proprio dell’ideologia liberale della laicità, pur se con
differenze fra le diverse versioni del liberalismo), non promuove alcuna composizione fra le diverse
istanze che possa portare alla costruzione di un qualche bene comune: in breve, rinuncia a
perseguire un bene prodotto e fruito insieme, in cui tutti i soggetti multiculturali siano coinvolti, il
che significa che impone uno stato comune di cose che rimane implicito e latente. […] Come ha
osservato Amartya Sen (2006), a distanza di tre decadi la dottrina politica del multiculturalismo è
entrata in crisi quasi ovunque. Appare ormai evidente che, concepito come ideologia della
differenza, il multiculturalismo non è una risposta adeguata né sul piano etico né sul piano politico
al problema della convivenza fra culture diverse.
Tuttavia, se l’ideologia è facilmente criticabile, l’immaginario collettivo lo è assai meno, anche
perché è sostenuto dai mass media ed è culturalmente omogeneo ai processi comunicativi propri
della globalizzazione. È indubbio, infatti, che le società liberali aperte dell’Occidente non sono in
grado di curare le cause che hanno trasformato il multiculturalismo nell’immaginario collettivo per
cui ‘tutte le differenze sono uguali’, nel senso che devono avere le stesse opportunità di realizzarsi.
Le cause sociologiche che hanno generato il multiculturalismo risiedono nella desertificazione che
le società liberali (a regime lib-lab) hanno prodotto nel tessuto connettivo della società, per il fatto
che hanno tenacemente perseguito l’obiettivo di immunizzare gli individui dalle relazioni sociali
(più precisamente dalle dimensioni di appartenenza e di legame delle relazioni sociali). […]
La mia personale opinione è che in fondo, come dottrina politica, il multiculturalismo possa essere
letto quale nuova formula di quella che in sociologia è nota come «soluzione hobbesiana al
problema dell’ordine sociale» (Parsons, 1968, pp. 121-27), che ora viene applicata ai sistemi
culturali (le religioni sono considerate tali) anziché agli individui. Il principio di inclusione politica
del liberalismo individualistico accorda i diritti di cittadinanza alle minoranze sulla base di un
pluralismo che priva la sfera pubblica di una qualificazione etica. Pertanto è incapace di sviluppare
una cittadinanza «profonda» (Clarke, 1996), costruita su un’ampia partecipazione dei cittadini come
attori morali che forgiano una sfera pubblica, tale da essere veramente capace di riconoscere un
autentico pluralismo sociale, cioè un pluralismo che sia espressione delle libertà positive di incontro
interumano (Donati, 2000). A mio avviso, il limite intrinseco del multiculturalismo, sotto ogni
punto di vista (epistemologico, morale e politico), la mancanza di relazionalità fra le culture che
esso istituzionalizza. È semplicemente cieco (in senso affettivo, cognitivo e morale) di fronte alla
cultura come fatto relazionale. […] Il tentativo, così formulato, non può che essere destinato al
fallimento, perché la sfera pubblica viene sempre più svuotata di relazioni significative fra i
cittadini.» (Donati 2008, p.25- 32 )
Tre passaggi in sintesi parziale
1. «… la libertà personale, per essere assicurata, rimanda al riconoscimento del principio di
uguaglianza morale e giuridica delle persone come esseri umani e dei relativi diritti di cittadinanza.
La dottrina del multiculturalismo non risolve questi due problemi, perché considera la persona come
imbrigliata (embodied e embedded) nella sua cultura di appartenenza e non persegue alcun mondo
comune, ma solo il rispetto e la tolleranza ‘a distanza’ fra le culture. Entrambe queste carenze
rimandano al deficit di relazionalità proprio del multiculturalismo. In quale direzione cercare le
alternative al multiculturalismo?» (Donati 2008, p.50-51)
2. «Una possibile via di uscita ai fallimenti del multiculturalismo è oggi intravista nella
interculturalità. Con questo termine si intende, generalmente, una forma di convivenza che si basa
sul dialogo e sul confronto aperto fra culture diverse, che rinunciano sia alla dominanza dell’una
sull’altra (assimilazione o colonizzazione) sia alla separazione senza comunicazione reciproca
(balcanizzazione). Si invoca la comunicazione interculturale come mediazione fra universi culturali
differenti.» (Donati 2008, p.55)
30
3. »… l’ipotesi interculturale può essere una strada utile e significativa se riesce a risolvere in modo
soddisfacente il deficit di riflessività relazionale presente nel multiculturalismo. Per colmare questo
vuoto, la soluzione interculturale deve ricorrere a un paradigma di comprensione del fenomeno
culturale che possa farci vedere che cosa c’è di comune fra le singole culture.» (Donati 2008, p.6061) «La laicità guidata da una ‘ragione relazionale’ come alternativa al multiculturalismo e come
nuovo ‘mondo comune’.» (Donati 2008, p.68) «Lo Stato laico non può fare a meno di presupposti
di valore, che non tocca a lui proporre, ma che recepisce dai soggetti della società civile portatori di
cultura.» (Donati 2008, p.57)
Due note. La prima formale-linguistica: il termine valori è qui inteso in senso trascendentale,
weberiano; valori in senso kantiano, con riferimento alla natura formale degli imperativi categorici;
con riferimento alla natura delle norme base di giustizia ed equità così come sono ragionata da John
Rawls nei termini del liberalesimo politico).
La seconda sociologica e di costume: la connessione e lo scambio interculturale è già operativo nei
fatti concreti del vivere sociale, non tanto negli eventi programmati di incontri tra diversi gruppi
comunitari, quanto nella circolazione e nello scambio capillare di stili di vita e modalità di relazione
tra persone, per definizione astratta, appartenenti a diversi gruppi culturali.
«… lo Stato laico deve adottare «un nucleo duro di valori, di valori cioè irrinunciabili che, in
quanto tali, valgono per tutti gli uomini, quale che sia la loro appartenenza a una specifica cultura
(libertà, dignità umana, rispetto della vita, minimo vitale)» (Zamagni). «… si possono distinguere i
valori delle differenti culture secondo tre criteri di giudizio: la tolleranza, il rispetto, la
condivisione.» (Donati 2008, p.57) «La prospettiva interculturale può essere un’alternativa al
multiculturalismo se riesce ad adottare un punto di vista riflessivo che dia una risposta laica al
pluralismo culturale senza porre tutte le culture sullo stesso piano, ma definendo un terreno comune,
un minimo comune denominatore di regole e di valori.» (Donati 2008,p. 73)
«Non è più la compatibilità tra culture diverse a essere in questione, ma la capacità degli individui
di trasformare una serie di situazioni e di episodi vissuti in una storia e un progetto personali.
(Touraine, o.c. p. 125). I diritti culturali di ognuno, individuo o collettività, devono essere
riconosciuti perché bisogna proteggere tutte le forme e tutti i percorsi di modernizzazione. Ma
ognuno di noi deve lottare in se stesso e all’interno della propria società contro ciò che è contrario ai
princìpi generali della modernità. Bisogna scoprire, negli stranieri, forme nuove di
modernizzazione, e dunque la presenza di certi elementi di modernità, ma bisogna anche che loro
stessi siano in grado di giudicare criticamente la propria esperienza storica e le proprie pratiche
culturali. Non si tratta affatto di un puro rapporto di reciprocità, di un mutuo riconoscimento, ma
della capacità di esprimere un giudizio su di sé e sull’altro dal punto di vista di una modernità
rispetto alla quale alcuni risultano essere più prossimi di altri, ma che non appartiene a nessuno e
non si confonde con nessuna particolare realtà storica. Poiché la modernità si definisce tramite
princìpi di portata universale, il pensiero razionale e i diritti dell’individuo, poiché ogni
modernizzazione introduce l’idea della particolarità se non della singolarità di ogni società in via di
trasformazione e poiché le due nozioni non possono essere né confuse né separate, è impossibile
definire una società puramente universalista o, al contrario, parlarne in base alla sua pura
singolarità. È più utile precisare la complementarità delle due nozioni dopo aver eliminato le due
soluzioni estreme, quella liberista e quella comunitarista che fanno riferimento, rispettivamente,
solo all’una o all’altra dimensione dell’analisi… Non si può parlare di diritti culturali, lo ripeto, se
non quando i comportamenti culturali e sociali chiedono di essere riconosciuti in nome di princìpi
universali, ovvero in nome del diritto di ognuno di praticare la propria cultura, lingua, religione,
rapporti di parentela, costumi alimentari ecc. Ed è solo a partire dal momento in cui l’opposizione
nei confronti di una cultura centrale definita come universalista emana da culture minoritarie (o
legate a uno statuto di inferiorità), condannate da coloro che si identificano con l’universalismo, che
il conflitto diventa inevitabile.» (Touraine, o.c. p.213, 215)
Per proseguire il dibattito in forma di bilancio e di proposta: Baraldi Claudio, Ferrari Giuseppe (a
cura di) 2008 Il dialogo tra le culture. Diversità e conflitti come risorse di pace, Donzelli, Roma
31
In forma di verifica degli esiti del multiculturalismo – interculturalismo all’interno di culture
particolarmente sensibili al tema della propria identità, della sua evoluzione e dell’urgenza della sua
difesa: ebraismo: Yehoshua B. Abraham 2008 Il labirinto dell’identità. Scritti politici Einaudi,
Torino 2009; islamismo: Courbage Youssef, Todd Emmanuel 2007 L’incontro delle civiltà Marco
Tropea Editore, Milano 2009
5.3. una impostazione di teoria politica globale e di base: un modello. John Rawls.
Come bilancio e progetto, tratto da uno degli ultimi scritti di Rawls, ispirato all’obiettivo di avviare
una revisione dell’opera Liberalesimo politico. In una lettera del 1998 Rawls afferma di considerare
quest’articolo come “la migliore esposizione delle sue idee sulla ragione pubblica e sul liberalismo
politico, soprattutto rispetto alla compatibilità tra ragione pubblica e credenze religiose” Rawls John
2005 Liberalismo politico. Nuova edizione ampliata, Einaudi, Torino 2012, 403)
«L’idea di ragione pubblica appartiene, nella mia interpretazione, alla concezione di una società
costituzionale democratica bene ordinata. La forma e il contenuto di tale ragione — in che modo i
cittadini la intendano e come essa interpreti le loro relazioni politiche — sono elementi della stessa
idea di democrazia. Questo perché una caratteristica di base di ogni società democratica è il fatto
del pluralismo: che in una tale società esista una molteplicità di dottrine comprensive ragionevoli tra
loro in conflitto (siano esse religiose, filosofiche o morali) è un risultato naturale della sua cultura di
libere istituzioni. I cittadini comprendono che è impossibile raggiungere un accordo, o quanto meno
aprire la strada a una reciproca intesa, sulla base delle inconciliabili dottrine comprensive che essi
difendono. Ciò che dunque hanno bisogno di fare è esaminare quali tipi di ragioni possano
ragionevolmente offrirsi l’un l’altro quando sono in gioco questioni politiche fondamentali. La mia
tesi è che nella ragione pubblica le dottrine comprensive della verità e del giusto siano sostituite da
un’idea del politicamente ragionevole che possa essere rivolta ai cittadini in quanto cittadini.
Un aspetto centrale dell’idea di ragione pubblica è che essa non critica né attacca nessuna dottrina
comprensiva, sia essa religiosa o di altro tipo, a meno che tale dottrina non sia incompatibile con gli
elementi essenziali della ragione pubblica e delle società democratiche. La condizione di base
imposta alle dottrine ragionevoli è che accettino le forme di governo a democrazia costituzionale e
l’idea di diritto legittimo che le accompagna. Per quanto le società democratiche siano l’una diversa
dall’altra riguardo alle particolari dottrine che all’interno di ciascuna godono di autorevolezza o
sono attive — si pensi alle democrazie dell’Europa occidentale, agli Stati Uniti, a Israele o all’India
—, trovare un’idea appropriata di ragione pubblica è un compito che tutte devono affrontare.
§ 1. L’idea di ragione pubblica. 1. L’idea di ragione pubblica definisce al livello più profondo i
valori morali e politici di base che in una società democratico-costituzionale devono dare forma al
rapporto tra potere politico e cittadini, e tra un cittadino e l’altro. Si occupa, in breve, del modo in
cui devono essere intesi i rapporti politici.» (Rawls John 2005 Liberalismo politico. Nuova edizione
ampliata, Einaudi, Torino 2012, 406-407).
I passaggi essenziali della teoria per la costruzione del modello.
5.3.1. il pluralismo di dottrine comprensive (o complessive; religiose, politiche, di circoli…;
comprensive in quanto rivendicanti il diritto ad esprimere il proprio pensiero e le proprie tesi su
ogni aspetto della realtà) come: 1. espressione del libero pensiero in libere istituzioni; 2. nessuna di
loro può pretendere di diventare universale e unica; 3.non è possibile una conciliazione tra di loro.
5.3.2. un accordo sul concetto di giustizia definito in una ipotetica situazione originaria, intesa come
una procedura, caratterizzata da: 1. velo di ignoranza per togliere l’interferenza di posizioni di
privilegio; 2. uso della ragione; 3. giustizia come equità definita materialmente da beni primari,
formalmente dai due principi: di uguaglianza, di differenza.
5.3.3. la ragione pubblica è definita da un atteggiamento di ragionevolezza che porta le dottrine
comprensive ad aderire ad essa attraverso un consenso per intersezione, dedotto dalle sue posizione;
quindi le sue regole vengono sostenute con convinzione e non solo per obbligo.
32
5.3.4. la forza della politica si fonda sulla sua laicità: non definisce il bene, che è di competenza
della persona e delle associazioni, ma sostiene e regola la sua libera formulazione attraverso le
regole formali della giustizia politica.
5.3.5. In conclusione: il principio della differenza nella gestione del tema identità e
multiculturalismo. La tesi: l’accettazione (e gestione) del dato storico di una società pluralistica è
accettazione (e sostegno) della libertà di identità (del diritto alla “metamorfosi”, al “diritto di
uscita”).
5.3.5.1. La constatazione del moltiplicarsi di movimenti e gruppi diversi e spesso opposti nel
sociale, l’affermazione del valore delle differenze (non disuguaglianze), la politica attribuita alla
ragionevolezza e al conseguente contratto sociale espresso in termini di consenso per intersezione
permettono di impostare il problema attuale del multiculturalismo in uscita da visioni o proposte
identitarie di tipo essenzialistico, da “conventicole” (cfr. Locke, Lettera sulla tolleranza) segnate
dall’intolleranza e dalla contrapposizione. Le impostazioni identitarie di tipo comunitaristico
sembrano esaltare, difendere e salvare (imporre) visioni e forme culturali associative altrimenti
destinate alla scomparsa, in realtà finiscono per negare il potenziale civile universalistico che
posseggono. Infatti, l’opposizione tra esclusioni monoculturali e fanatismi multiculturalistici si
traduce nella costruzione di microunità sociali rigidamente monoculturali, comunità chiuse e
rivendicanti per sé diritti senza doveri in nome di una propria presunta, in realtà inventata e
enfatizzata ad hoc, specificità culturale; ne deriva l’assoluta intolleranza/ignoranza nei confronti
della società presente e dell’uomo o meglio dell’umanità.
L’indicazione che deriva dalle riflessioni di Rawls (e dai due principi della giustizia come equità
sociale e politica) formula il problema in termini di apertura e non di rinserramento essenzialistico:
come coniugare differenze e universalità delle molte dottrine (che non a caso si distinguono /
oppongono ma si presentano tutte come comprensive, depositarie di visioni globali / totali).
Un’osservazione e una posizione, sul tema, espresse da Patrick Savidan. «La questione che bisogna
quindi porsi è la seguente: come riconoscere le differenze senza ridursi a una dinamica che
porterebbe alla ri-essenzializzazione di queste ultime in termini di esclusione (dell’altro)? In altre
parole, si tratta di definire prima di tutto quale statuto conferire alla particolarità etnoculturale e di
determinare se questo statuto giustifica la possibilità di considerare tale particolarità da un punto di
vista istituzionale e politico, sapendo che questo riconoscimento — i teorici liberali del
multiculturalismo sono concordi su questo punto — non può comprometterne l’universalità (che si
esprime in particolare nelle diverse figure della solidarietà e dell’equità). I mutamenti che
intervengono nel modo in cui gli individui tendono a concepire la loro identità sollevano una
questione delicata, che è alla base di tutte le polemiche: il riconoscimento, e le politiche
dell’identità che cercano di dargli corpo, sono in grado di non contraddire l’ideale moderno di
uguaglianza morale e giuridica degli uomini e presentarsi come un modo (indispensabile?) per
realizzare meglio questo ideale?
In base alla tipologia proposta da Mesure e Renaut e nella prospettiva sostenuta da Michel
Wieviorka, ciò ci condurrebbe a quello che può essere considerato un nuovo modello, un modello
contemporaneo che si basa su un’esperienza dell’altro più complessa, in quanto si deve tenere conto
delle differenze senza provocare delle disuguaglianze, e questo per resistere a una tendenza forte
delle società democratiche «illuminate», nelle quali l’affermazione dell’universalità tende sempre a
farsi a scapito delle differenze (attraverso un loro svilimento o, più violentemente, attraverso la loro
pura e semplice eliminazione). In altre parole, «si tratta di inserire la differenza al centro
dell’identità», di «restituire all’uguale la sua differenza», sapendo che è la ricerca stessa
dell’uguaglianza, insita nella dinamica democratica, che trascende se stessa in una ricerca del
riconoscimento delle differenze. L’affermazione delle differenze non sarebbe quindi contraria ai
principi sui quali sono costruite le società democratiche, ma deriverebbe dalla dinamica
dell’uguaglianza e si presenterebbe sotto la forma inedita di un’uguaglianza nella differenza.»
Savidan Patrick 2009 Il multiculturalismo, il Mulino, Bologna 2010 p. 31-32
33
5.3.5.2. la rilevanza democratica del multiculturalismo sta nel “diritto di uscita”. «Questa tesi, che
permette di riaffermare il valore sociale della tolleranza, contribuisce a fondare l’idea di un primato
del concetto di ciò che è giusto sulle rappresentazioni concorrenti dell’idea di ciò che è bene in una
«società ben ordinata». Questo «diritto di uscita» è assolutamente determinante e costituisce uno
strumento importante di pressione sulle minoranze illiberali. Esso contribuisce in ogni caso a
definire la base a partire dalla quale risolvere un problema che l’opposizione fra diritti soggettivi e
diritti collettivi aveva la tendenza a esasperare. […] Quando non sono irrigidite dai conflitti e dal
disprezzo sociale, le culture non sono quelle potenze deificate, invincibili, impermeabili e refrattaria
a qualunque valutazione normativa.» (Savidan 2010, 97,99)
5.3.5.3. Multiculturalismo luogo di riflessione e rifondazione dei termini della democrazia e del
diritto. «Il multiculturalismo in quanto problematica illustra molto bene la necessità di pensare i
principi in un rapporto constante con i contesti della loro scoperta e della loro applicazione, John
Rawls, con il metodo dell’«equilibrio riflessivo» ha indicato un percorso possibile.» (Savidan 2010,
106)
6. globalizzazione e multiculturalismo / interculturalismo: bilanci, problemi,
proposte o come declinare l’identità in un’epoca di globalizzazione.
- Perché ha ambientato il film a Barcellona e non a Città del Messico, sua città di origine? E cosa
l’ha spinta a raccontare il mondo degli immigrati?
«Sono molti anni che osservo il fenomeno delle grandi migrazioni sociali. Barcellona è solamente
uno dei simboli di questo mostruoso processo di globalizzazione, che si è manifestato attraverso
grandi spostamenti di masse. A Città del Messico non esiste questo problema dell’immigrazione
multirazziale come nelle grandi città europee, Parigi, Roma, Londra o Barcellona. In queste città le
comunità di cinesi, africani e sudamericani vivono le une accanto alle altre, hanno gli stessi
problemi di sopravvivenza, sono invisibili a quella parte della città che vive nella legalità, tuttavia
non si incontrano e non si integrano. Sono cellule sociali autonome, che vivono realtà parallele,
delle quali noi veniamo a conoscenza soprattutto attraverso i media. Tutto ciò è una testimonianza
chiara del fatto che il fenomeno della globalizzazione è una pura illusione. Possiamo globalizzare
tutto, non l’essere umano».
- È messicano ma vive a Los Angeles. Si considera un immigrato?
«Certamente. Con Alfonso Cuaròn scherziamo dicendo: siamo degli immigrati di lusso, ma pur
sempre immigrati. Una condizione che amo molto perché, rispetto a quelli che hanno sempre
vissuto nel proprio Paese, la capacità di osservare di chi è straniero si amplifica, i punti di vista si
moltiplicano. È una condizione di continua scoperta e confronto».
Francesca Lombardo intervista a Alejandro Gonzàlez Iñàrritu (in Il Venerdì di Repubblica 4
febbraio 2011 122,123).
Il problema. «La diversità etnoculturale è storicamente un elemento fondamentale delle società
umane; non si può quindi parlare di una specificità delle società moderne. L’aspetto nuovo consiste
piuttosto nel fatto che si possa affermare, nel quadro di una politica del riconoscimento, l’idea di
una necessaria assunzione da parte dello stato della diversità culturale che caratterizza la sua
popolazione.
Tuttavia quest’idea non è un dato di fatto comunemente accettato, e ogni progresso realizzato su
questo fronte ha spesso dovuto misurarsi con forti resistenze. Tale reazione non deve però stupire,
poiché il multiculturalismo ambisce a promuovere un tipo di integrazione politica e sociale che
sotto molti aspetti va contro il modello sul quale sono stati costruiti gli stati-nazione.
Il governo democratico moderno si è infatti sviluppato assumendo per lo più una forma nazionale.
L’istituzione dell’autonomia politica ha richiesto non solo la costituzione di un corpo politico
organizzato sulla base di una volontà generale e comune che permettesse di ridefinire i termini della
34
cittadinanza — presupponendo che l’obbedienza alla legge significasse emancipazione — ma ha
anche incoraggiato l’affermazione di un principio di omogeneità sociale e politica. L’unità del
corpo politico e, fino a un certo punto, quella del corpo sociale si sono quindi imposte come
condizioni per una possibile cittadinanza democratica. Assumendo le concezioni e le pratiche
contemporanee della cittadinanza, il modello multiculturalista di integrazione rappresenta un vero e
proprio cambiamento di paradigma, di cui bisogna valutare il significato, la portata, il valore e i
rischi.
Il multiculturalismo, sostenuto da una rivalutazione delle differenze culturali, si è trovato in perfetta
sintonia — in un mondo globalizzato dove intervengono anche processi di integrazione regionale —
con l’esigenza di fornire una nuova descrizione del legame fra libertà individuale e cultura di
appartenenza. L’obiettivo di questa evoluzione è offrire a ogni individuo la possibilità di compiere
le proprie scelte di vita. Scelte che hanno un significato perché inserite nel determinato contesto
culturale al quale si è legati.
Il mondo moderno ci aveva insegnato a indossare i panni di qualcuno che non siamo: quelli
dell’altro sesso o dell’altro in senso culturale. Questo atteggiamento era a suo tempo indispensabile
per qualificare l’altro come uguale e di fatto consisteva in un atto di assimilazione volto a rendere
uguali. Il multiculturalismo prospetta un’altra concezione del «vivere insieme». L’atto del rendere
uguale attraverso l’assimilazione è solo una condizione preliminare, una tappa verso ciò che può
dare al processo verso l’uguaglianza il suo vero significato. Una delle sfide del multiculturalismo è
appunto quella di definire i dispositivi per restituire all’uguale la sua differenza culturale e questo,
paradossalmente, proprio allo scopo di andare ancora più lontano nell’instaurazione
dell’uguaglianza e per fare in modo che l’uguaglianza non nasconda più la negazione delle reali
differenze.» Savidan Patrick 2009 Il multiculturalismo, il Mulino, Bologna 2010, 7-8)
6.1. I molti aspetti (per richiamare la plurivalenza della globalizzazione)
«La globalizzazione abbraccia molti aspetti: il flusso internazionale di idee e conoscenze, la
condivisione delle culture, una società civile globale e il movimento ambientale. Questo libro,
tuttavia, si limita essenzialmente alla globalizzazione economica quella - cioè - che favorisce
l’integrazione dei paesi attraverso una circolazione più capillare di beni, servizi, capitali e
manodopera. La grande speranza della globalizzazione è quella di migliorare il tenore di vita in
tutto il mondo garantendo ai paesi poveri l’accesso ai mercati internazionali affinché possano
vendere i loro prodotti, consentire gli investimenti esteri che porteranno nuove merci a prezzi più
bassi e aprire le frontiere affinché i cittadini possano andare all’estero per studiare, lavorare, spedire
a casa parte dei loro guadagni per aiutare le famiglie e fondare nuove imprese.
A mio avviso, la globalizzazione ha le potenzialità per recare enormi vantaggi sia nei paesi in via di
sviluppo sia in quelli industrializzati. Questo libro dimostrerà che il problema non riguarda tanto la
globalizzazione in sé quanto il modo in cui e stata gestita. Il motore della globalizzazione è
l’economia, specie attraverso la riduzione dei costi delle comunicazioni e dei trasporti, ma è la
politica che l’ha plasmata. Le regole del gioco sono state fissate dai grandi paesi industrializzati in
funzione dei loro interessi particolari e non c’è da stupirsi che abbiano badato al loro tornaconto.
Non hanno cercato di creare modalità eque e condivise, e men che meno regole che favorissero la
diffusione del benessere nei paesi più poveri del mondo.» (Joseph E. Stiglitz 2006 La
globalizzazione che funziona, Einaudi, Torino 2006, p.4)
6.1.1. due volti della globalizzazione.
«Nei primi anni Novanta, la globalizzazione fu salutata con euforia. I flussi di capitali verso i paesi
in via di sviluppo erano sestuplicati in sei anni, dal 1991 al 1996. La costituzione, nel 1995,
dell’Omc — a cui si lavorava da cinquant’anni — si proponeva di introdurre un principio di legalità
nel commercio internazionale. Tutti dovevano trarne beneficio, sia nei paesi in via di sviluppo sia
nel mondo industrializzato. La globalizzazione doveva garantire a tutti una prosperità senza
precedenti.
Nessuno stupore, quindi, che la prima grande protesta moderna contro la globalizzazione —
35
avvenuta a Seattle nel dicembre i 1999 in occasione di quello che avrebbe dovuto essere l’inizio di
una nuova tornata di negoziati commerciali foriera di un’ulteriore liberalizzazione — abbia lasciato
di stucco i sostenitori dei mercati aperti. La globalizzazione era riuscita nell’intento di unire le
persone del mondo, ma proprio contro la globalizzazione. Gli operai delle fabbriche americane
hanno visto mettere in pericolo i loro posti di lavoro dalla concorrenza cinese. Il reddito agricolo nei
paesi in via di sviluppo è stato compromesso dal granturco e dalle altre colture fortemente
sovvenzionate provenienti dagli Stati Uniti. In nome della globalizzazione, i cittadini europei hanno
assistito a un progressivo indebolimento delle tutele dei lavoratori, per le quali tanto avevano
combattuto. Gli attivisti anti-Aids hanno visto i nuovi accordi commerciali aumentare il prezzo dei
medicinali a livelli insostenibili nella maggior parte dei paesi del mondo. Gli ambientalisti hanno
capito che la globalizzazione minacciava la loro lotta decennale a tutela dell’ambiente. Tutte queste
voci fuori dal coro non hanno sposato la tesi che, almeno dal punto di vista economico, la
globalizzazione avrebbe portato maggiore benessere a tutti. […] In breve, la globalizzazione può
aver aiutato alcuni paesi – il Pil, cioè il totale dei beni e dei servizi prodotti può essere aumentato -,
ma non ha fatto altrettanto per le persone, neppure dove i risultati dell’economia sono stati migliori
che altrove. Il timore era che la globalizzazione possa creare paesi ricchi con gente povera. (Stiglitz
2006, p.7, 8)
6.1.2. Riformare la globalizzazione
«Le cose da fare sono molte. Sei aree in cui la comunità internazionale ha preso atto che non tutto
funziona illustrano sia i progressi compiuti sia la strada ancora da percorrere
1. La diffusione della povertà
2. Gli aiuti internazionali e la cancellazione del debito
3. L’aspirazione a un commercio equo
4. I limiti della liberalizzazione
5. La tutela dell’ambiente
6. Un sistema di governo globale pieno di difetti. (Stiglitz 2006, pp. 13-19)
Su quest’ultimo tema: «Lo Stato-nazione, che per centocinquant’anni è stato al centro del potere
politico (e in larga parte) economico si trova oggi mutilato, da una parte dalle forze dell’economia
globale e dall’altra dalle esigenze politiche di devoluzione dei poteri. La globalizzazione — vale a
dire la maggiore integrazione dei paesi del mondo — ha creato l’esigenza di un’azione collettiva da
parte di popoli e paesi per risolvere i problemi comuni. Ci sono troppe questioni commercio,
circolazione di capitali, ambiente — che possono essere affrontate solo a livello globale. Ma se da
una parte lo Stato-nazione è indebolito, mancano ancora a livello internazionale degli organismi in
grado di affrontare concretamente i problemi creati dalla globalizzazione.
Di fatto, la globalizzazione economica si è sviluppata più rapidamente di quella politica. Abbiamo
un sistema caotico e scoordinato di governance globale senza governo globale che si riduce a una
serie di istituzioni e accordi che trattano di determinati problemi, dal riscaldamento del pianeta al
commercio internazionale, passando per i flussi di capitale.» (Stiglitz 2006, p. 21)
Joseph E. Stiglitz 2006 La globalizzazione che funziona, Einaudi, Torino 2006
6.2. “un’altra globalizzazione”: la sfida delle migrazioni transnazionali
«Sotto la coltre dei grandi processi strutturali sospinti da attori eminenti, che vanno dalle
organizzazioni economiche internazionali alle imprese multinazionali, dai grandi operatori
finanziari ai governi dei paesi più sviluppati, stanno dunque prendendo forma fenomeni
ufficialmente inattesi e indesiderati, e tuttavia in crescita, che possono essere definiti come
«globalizzazione dal basso»: la globalizzazione delle persone comuni, delle famiglie e delle loro reti
di relazione, che reagiscono ad una localizzazione imposta cercando altrove un futuro migliore.
Una diffusa vulgata che contrappone il radicamento forzato dei poveri alla mobilità globale dei
privilegiati del pianeta trova qui un’importante smentita: malgrado le disuguaglianze nel diritto alla
mobilità e le barriere erette dai paesi sviluppati, un numero sempre maggiore di abitanti del mondo
(anche se non i più poveri in assoluto) si sposta attraverso i confini nazionali, scombussolando le
36
corrispondenze tra territorio, popolazione e cittadinanza [Sassen 2008].
[6.2.1.] Certo, lo schema seducente dell’emigrazione come contestazione del nuovo ordine
mondiale, come risposta dei diseredati alla globalizzazione prepotente degli interessi dominanti, è
troppo semplice per poter essere interamente accettabile. I migranti non si limitano a rompere le
catene della fissità geografica per cercare scampo nel mondo ricco, trasformandosi in «rifugiati
economici». Arrivano anche perché sono richiesti dalle economie sviluppate, soprattutto per
colmare i vuoti che si sono aperti negli ambiti più sacrificati di un sistema occupazionale molto
segmentato e stratificato, ma in ogni caso incapace di abolire quelli che possono essere definiti i
lavori delle cinque «P»: precari, pesanti, pericolosi, poco pagati, penalizzati socialmente
[Ambrosini 2001; 2005a].
I mercati del lavoro, dunque, assorbono gli immigrati più facilmente dei sistemi politici. A volte,
proprio il loro arrivo consente di trasformare esigenze diffuse in domanda di lavoro
economicamente rilevante, come nel caso da manuale dell’assistenza delle persone anziane a
domicilio. I loro legami con chi è rimasto alimentano poi altri flussi economici, intercettati e gestiti
per una cospicua parte da istituzioni e operatori inseriti nei circuiti della globalizzazione dall’alto:
basti pensare al gigantesco fenomeno delle rimesse, che consentono altresì ai governi di molti paesi
di provenienza di rimettere in equilibrio la bilancia dei pagamenti e di chiedere prestiti ai grandi
investitori mondiali, come il Fondo monetario internazionale.
[6.2.2.] Contrapporre globalizzazione dal basso e globalizzazione dall’alto è quindi affascinante, ma
non del tutto veritiero. I fenomeni sono molto più interconnessi e ambivalenti. Anche per questa
ragione, non riguardano solo i migranti, ma l’assetto complessivo della società in cui viviamo.
La globalizzazione dal basso non solo cambia la composizione demografica della popolazione, delle
forze di lavoro come degli alunni delle scuole, ma ci obbliga a ridefinire il nostro sguardo, uscendo
da quel “nazionalismo metodologico” [Beck 2003] che sovrappone implicitamente lo Stato
nazionale alla società, “naturalizzando” confini, appartenenze e legami, plasmando le stesse scienze
sociali, che definiscono la società con concetti legati allo Stato nazionale, e sollecitando a pensare
l’integrazione come identificazione con esso. Lo Stato nazionale viene considerato così l’ovvio
punto di partenza sia delle analisi, sia delle aspettative riferite ai rapporti tra migranti e cittadini
«nazionali». Da questo punto di vista, le migrazioni internazionali appaiono come un’anomalia,
un’eccezione problematica alla regola del radicamento degli abitanti nella terra a cui appartengono,
ossia al loro Stato nazione [Wimmer e Glick Schiller 2003, 585]. A maggior ragione, i migranti che
intrattengono legami transnazionali e identificazioni simboliche con i luoghi di provenienza
rischiano di risultare sospetti e minacciosi, sotto l’accusa di “non volersi integrare” che sottintende
l’imperativo di allinearsi con lo Stato nazionale che li ospita, recidendo i vincoli con la madrepatria.
[6.2.3.] I migranti come attori. Si impone «una riflessione critica su questo schema cognitivo,
approfondendo le implicazioni della globalizzazione dal basso a partire da un punto di vista che
considera i migranti come attori, e non semplicemente come vittime dei processi di globalizzazione,
ed esplorando la dimensione dei legami che travalicano le frontiere politiche, coinvolgono i non
migranti, influenzano le società di provenienza, contribuiscono a definire e riconfigurare l’identità
dei migranti stessi.» (Ambrosini, Maurizio (2008) Un’altra globalizzazione. La sfida delle
migrazioni transnazionali, il Mulino, Bologna p. 8-9)
6.2.3.1. per il migrante: «Considerare gli immigrati come attori significa allora anche cercare di
comprendere come riorganizzino il loro mondo sociale una volta insediati: come dunque la
globalizzazione dal basso si prolunghi nella vita quotidiana, dando luogo a nuove esperienze
culturali e costruzioni identitarie. Il migrante è ben più che un homo oeconomicus; quando il suo
soggiorno si prolunga, sorge in lui il bisogno di ritrovare spazi di socialità e di produzione di
significati, ridando senso al mondo in cui si ritrova.» (Ambrosini o.c. p. 45)
6.2.3.2. per il paese di provenienza: «La sua vita sociale, inoltre, non si trasferisce interamente nel
paese di insediamento. Con intensità e forme diverse, molti migranti continuano a intrattenere
rapporti con chi è rimasto nei luoghi di provenienza. …contrariamente alle preoccupazioni
nazionaliste, i migranti che alimentano relazioni e attività che li connettono con i paesi di origine
37
sono solitamente anche i meglio integrati nelle società riceventi. (ivi p. 10-11) … il
transnazionalismo può essere definito come “il processo mediante il quale i migranti costruiscono
campi sociali che legano insieme il paese d’origine e quello di insediamento” [Glick Schiller, Basch
e Blanc-Szanton 1992]. L’attenzione rivolta alla partecipazione dei migranti ad attività collocate in
paesi diversi e inquadrate come una forma controcorrente di globalizzazione ha indotto le medesime
studiose, e vari altri al loro seguito, a teorizzare l’avvento di una nuova figura sociale, quella del
«trasmigrante», caratterizzata dalla partecipazione simultanea ad entrambi i poli del movimento
migratorio e dal frequente pendolarismo tra di essi.
Ragionare in termini di transnazionalismo significa dunque superare, o almeno fluidificare, le
tradizionali categorie di «emigrante» e «immigrato», e cessare di concepire la migrazione come un
processo che ha un luogo d’origine e un luogo di destinazione. In questa visione, i transmigranti
sono coloro che costruiscono nuovi rapporti tra le due sponde delle migrazioni, mantenendo
attraverso i confini un ampio arco di relazioni sociali.» (Ambrosini p. 45)
6.2.3.3. per il paese che “ospita”. L’Europa, e in particolare l’Italia, sta vivendo storicamente il
passaggio verso identità di tipo multiculturale. È una strada tutta aperta.
«Dopo la seconda guerra mondiale e la presa di coscienza degli orrori del nazismo … , secondo
Taguieff [1994; 1999], il razzismo ha assunto una nuova veste, prendendo a prestito una serie di
argomenti dell’antirazzismo. Diventa infatti centrale l’idea della differenza culturale, e allo
screditato termine «razza» si sostituisce quello di «etnia» o anche di «cultura». Taguieff parla
dunque di «razzismo differenzialista». In questa chiave, le popolazioni immigrate insediate nelle
società occidentali vengono così paventate soprattutto come una minaccia per l’identità culturale
delle maggioranze autoctone. Come nota Beck, «ci si appiglia strategicamente ad un ipotetico
essenzialismo della propria appartenenza etnica per ristabilire confini che stanno svanendo e
mescolandosi, tra dentro e fuori, tra noi e loro» [Beck 2003, 11]. (Ambrosini o.c. p. 185)
6.3. le identità nella globalizzazione (per tornare sul tema)
6.3.1. globalizzazione non omologazione?
Gesti e consuetudini quotidiane portano all’affermazione «siamo tutti “global players”» (utilizzo
della posta elettronica, navigare in Internet aderire alle proteste globali dei consumatori, prendere
posizioni su fatti mondiali, utilizzare cucine diversificate ….) «In questi contesti la vita delle
persone non è né disorganizzata né priva di senso. Al contrario: esse sono parte di un’intensa
struttura sociale da cui nascono attività connesse le una alle altre, che includono l’intero globo.
Abitano diverse sfere della vita sociale, che si incrociano nel loro momentaneo luogo di sosta, senza
danneggiarsi a vicenda. […] Ciò che dal punto di vista dell’egemonia nazionale appare come
declino e dissoluzione, nella prospettiva della società mondiale si rivela un cambio del sistema di
riferimento: via dalle rappresentazioni di blocchi culturali integrati, monolitici, territorialmente
vincolati (il “popolo”), verso rappresentazioni di una “cultura delle culture” come sistema di
riferimento globale per una pluralità non amministrabile…» (Beck Urlich 2003 La società
cosmopolita, il Mulino, Bologna 2003 p.111).
Globalizzazione non è omologazione: «con l’affermarsi della consapevolezza della società
mondiale non avviene un’unificazione sul piano linguistico, ma le lingue si moltiplicano. Il mondo
unico conosce e riconosce più lingue che mai. […] Qui diventa chiaro che il cuore babilonese della
società mondiale non batte nella tendenza all’uniformazione bensì al guazzabuglio delle identità»
(Beck Urlich 2003 La società cosmopolita, il Mulino, Bologna 2003 p.117)
6.3.2. complessità – moltiplicarsi delle possibilità.
«Inizio degli anni Ottanta. La costa dall’alto digradava a larghe terrazze sopra un mare che non si
stancava mai di infrangersi contro l’indifferente barriera di pietra e si potevano vedere due o tre
ragazzi che giocavano con un pallone sulla terrazza più bassa che si avventurava contro il mare dal
fianco della roccia. Passò qualche minuto e arrivarono altri ragazzi con un altro pallone. Si unirono
ai primi e giocarono insieme. Avevano due palloni. I ragazzi saranno stati in tutto sette o otto.
Giocavano tutti insieme, ma con due palloni. Un unico gruppo. I tiri si incrociavano, si ignoravano,
38
si collegavano, si sfioravano paralleli, opposti, laterali, centrali. Il rumore del mare sembrava mesto
e uguale fino a non farsi più distinguere di fronte alla inesauribile vivacità che quei ragazzi
comunicavano. Poco tempo ancora e sarebbero arrivati altri ragazzi con un altro pallone, si
sarebbero uniti a tutti gli altri e avrebbero giocato tutti insieme con tre palloni. C’era un ordine che
si produceva da sé; c’erano discussioni che ogni tiro successivo rendeva inutili o ignorava o
interpretava; voci che cercavano di attirare l’attenzione di chi aveva il pallone in quel momento, ma
i palloni erano sempre tre e i tiri erano simultanei e successivi insieme. Questione dell’osservatore.
Mentre, che i tentativi fossero andati a vuoto o fossero stati opportunamente intesi, era questione
che solo il tempo poteva affrontare, perché solo il futuro avrebbe potuto deciderla, ma il tempo del
gioco era il presente e il presente non è un tempo che abbia il tempo di controllare o di correggere
ciò che in futuro si fosse dimostrato «compreso» o «non compreso». Il tempo del gioco: un
paradosso che aveva già annullato le differenze tra i ragazzi che solo il tempo, in realtà, aveva
prodotto. Ora ciascuno, tirando il pallone, costruiva l’altro come compagno o avversario o
semplicemente come altro, mentre ciascuno, ricevendo il pallone e tirandolo a sua volta, ricostruiva
se stesso come compagno o avversario o come altro dell’altro e, allo stesso tempo, con il tiro
costruiva l’altro ancora come compagno o avversario o semplicemente come altro.
La sociologia tradizionale, mi disse Luhmann, dimostra la sua impotenza già di fronte a un modo di
produrre società elementare e semplice come questo: avrebbe bisogno di principi, di regole, di
schemi dell’agire, di forme della razionalità; avrebbe bisogno di un arbitro, di un contratto sociale,
ma soprattutto avrebbe bisogno di un unico pallone. Il suo riferimento sarebbe costituito da regole e
violazione delle regole, valori, sanzioni, controllo: insomma da ciò che tutti riconoscono come una
partita di calcio. Ai livelli elementari della produzione di senso la società opera come si può vedere
osservando questo gruppo di ragazzi che interagiscono. Nuove possibilità si producono ad ogni
evento, per il semplice fatto che qualcosa è accaduto. Qui, un semplice tiro. Ma ogni tiro effettuato
è già una possibilità che si realizza tra altre che avrebbero potuto prodursi e che sono state escluse, e
che restano tuttavia possibili, per il fatto che si è prodotto proprio quel tiro. Ad ogni evento segue
un altro che ad esso si raccorda. E ogni volta, cioè sempre, tutto ciò che accade, accade
simultaneamente. Come ci si può orientare? La complessità si produce per il semplice moltiplicarsi
delle possibilità e questo stesso moltiplicarsi scaturisce dalla impossibilità di relazionare uno ad uno
gli elementi della struttura che si costituisce con i singoli eventi che si producono, cioè si costituisce
da sé. Una cosiffatta struttura non solo si produce da sé, ma si trasforma continuamente da sé. E
poiché non sono prevedibili né calcolabili, i percorsi dall’autotrasformazione si sottraggono alla
razionalità del progetto che, anzi, interviene come fattore ulteriore dell’incremento di variabilità: la
società si rende instabile da sé, si sorprende, per così dire, da sé. Ma questa continua instabilità non
può essere tollerata e scaturisce da ciò la necessità di elaborare strategie selettive che rendano
possibile l’orientamento dell’azione.» (dalla Presentazione all’edizione italiana a cura di Raffele De
Giorgi dell’opera di Luhmann: Luhmann, Niklas (2000), La fiducia, il Mulino, Bologna 2002)
6.3.3. intolleranza xenofobica e i rischi di un’occasione mancata
Le nazioni europee, con intensità e in tempi diversificati, stanno vivendo storicamente una
trasformazione sociale che mette in crisi il concetto classico di nazionalità legato all’unità di lingua,
costumi, tradizioni e gestione politica: l’afflusso non programmato e “non programmabile”, nella
propria area nazionale, di un numero elevato di uomini portatori di altre lingue e culture alle quali
intendono restare comunque legati. Una reazione spaventata nei confronti del fenomeno, contenuta
nelle ipotesi affidate ai facili slogan della “tolleranza zero” o della assimilazione rieducativa,
impedisce la comprensione (sopra richiamata: Ambrosini) e la gestione del problema, si basa su
presupposti che definiscono con consapevole falsità il passato e il futuro.
6.3.3.1. Si dovrebbe infatti presupporre che sia il cittadino europeo sia l’immigrato posseggano
identità chiare e immodificabili. Definire secondo etnia, cultura, patria l’immigrato è costruire
semplificatori forzati, inutili e pericolosi. «Si tratta naturalmente di “patrie inventate”, che possono
fornire risorse di identificazione ai gruppi deterritorializzati, fino al punto di fornire materiali ai
conflitti etnici, in relazione all’idea secondo cui le biografie delle persone ordinarie sono costruzioni
39
in cui l’immaginazione svolge un ruolo saliente. Il rimando ad un ethnoscape, come lo definisce
Appadurai, un mondo di riferimenti “etnici” immaginato dalle popolazioni in movimento, avviene
peraltro in un contesto di pratiche di contaminazione e ibridazione tra culture diverse, consapevoli o
meno, tanto da indurre questo e altri autori a teorizzare un indebolimento delle identità nazionali e
la tendenziale formazione di un’economia culturale «globale». Due tesi in verità discusse e
discutibili: altri autori hanno insistito sul ritrovamento o la reinvenzione di pretese identità nazionali
nei paesi riceventi…» (Ambrosini, ivi, p 69)
6.3.3.2. Si dovrebbe inoltre presupporre, in parallelo, la ripresa e ridefinizione di identità nazionali
del paese che “ospita” rigide e immodificabili al di fuori di ogni attenuazione storicistica.
«Repertori culturali e pratiche sociali, sia della terra di origine sia del paese di accoglienza, vengono
rielaborati e mescolati per costruire nuove identità e stabilire confini di gruppo più o meno rigidi o
permeabili.» (Ambrosini, ivi, 70)
6.3.3.3. Non si include il confronto e l’incontro tra i fattori attivi che possono amplificare il campo
delle scelte personali all’insegna della libertà e del progetto. Il rischio è non comprendere quanto
accade, non vivere con attiva consapevolezza il mutamento che interessa sia le aree di arrivo dei
flussi migratori (le nazioni a produttività economico-capitalistica elevata), sia le aree di provenienza
con cui quei flussi conservano i propri legami, coinvolgendo i paesi di provenienza in processi di
“trasformazione dal basso” di portata sempre più ampia (segnando e avviando nuove forme di
globalizzazione).
6.3.4. identità nella globalizzazione o le opportunità antropologiche della globalizzazione
cosmopolita.
6.3.4.1. «deterritorializzazione», la fine della sindrome territorio-identità, del sangue e terra come
identificatori personali, la fine della territorial fallacy; la nazione diventa uno spazio delle garanzie
per cogliere l’intreccio delle opportunità.
«Uno spazio stratificato e multiforme. Lo spazio di riferimento dei soggetti individuali e dei gruppi
è dunque molteplice: ciascun attore si trova inserito, in altre parole, in più scale interdipendenti, che
contribuiscono a separare gli spazi dell’appartenenza cognitiva (di ciò che si conosce), affettiva (ciò
in cui ci s’identifica) e strumentale (degli interessi). Una molteplicità di scale spaziali che è anche
molteplicità di scale temporali, in un corto circuito tra prossimità e simultaneità.» (Bonomi 2010,
42)
«Sul piano culturale, inoltre, le diaspore contribuiscono alla deterritorializzazione delle identità
sociali, che rappresenta un aspetto tipico della globalizzazione. Se nel periodo vagamente definito
come «modernità» i governi degli Stati nazione cercavano di imporre agli individui una cittadinanza
esclusiva, volendo far coincidere l’identità sociale con l’identità nazionale, nel mondo
contemporaneo si sono aperti, come abbiamo visto, degli spazi per affiliazioni multiple, al di fuori e
oltre i confini degli Stati-nazione. I legami diasporici sono divenuti così più aperti più accettabili.»
(Ambrosini, ivi, p. 77)
«Queste rapide osservazioni ci consentono di enucleare le principali implicazioni culturali e sociali
della globalizzazione. La più manifesta di esse è la formazione di una società di massa nella quale
gli stessi prodotti materiali e culturali circolano in paesi molto diversi tra loro per tenore di vita e
tradizioni culturali. Ciò non significa affatto una standardizzazione generale dei consumi e
l’«americanizzazione» del mondo intero. Al contrario, stiamo assistendo alla compresenza e
mescolanza di realtà contrapposte. La prima è rappresentata dall’influenza culturale esercitata dalle
grandi imprese di consumo e di divertimento Hollywood è senza dubbio la fabbrica dei sogni del
mondo intero, ma non per questo le produzioni locali sono scomparse dalla faccia della terra. Nei
paesi più ricchi si nota inoltre una progressiva diversificazione dei consumi. A New York, Londra o
Parigi si trovano molti più ristoranti stranieri di un tempo ed è possibile vedere molti più film
provenienti da altri paesi del mondo. E infine si assiste a una rinascita di forme di vita sociale e
culturale tradizionali o sostenute dal desiderio di salvaguardare una cultura regionale o nazionale
minacciata. Ovunque, in ogni caso, e proprio per effetto di queste tendenze contrapposte, si accelera
il declino delle precedenti forme di vita sociale e politica e della gestione nazionale
40
dell’industrializzazione.» (Touraine Alain 2004 La globalizzazione e la fine del sociale, il
Saggiatore, Milano 2008 p. 35-36) E il fondamento: « La vita non si riduce a un dato, la vita è il
movimento tramite il quale gli attori, invece di identificarsi con un valore o uno scopo esteriori,
scoprono in se stessi, nella difesa della propria libertà, una capacità di agire in maniera
autoreferenziale, come faceva la «società» nella situazione precedente. È così che può emergere un
senso che resiste alla logica del potere e del mercato e allo stesso tempo a quella dell’integrazione
comunitaria. Ma è bene aggiungere, prima ancora di formulare in maniera approfondita tali ipotesi,
che questo soggetto consapevole di sé non si riduce affatto a un atteggiamento di meditazione
interiore, di ricerca di sé attraverso l’eliminazione degli influssi esercitati sull’io dal inondo esterno;
esso si afferma innanzitutto lottando contro ciò che lo aliena e gli impedisce di agire in funzione
della formazione di se stesso.» (Touraine 2004, 28-29)
«Attraverso la globalizzazione questo effetto di domesticità politico-culturale viene intaccato, con il
risultato che innumerevoli cittadini dei moderni Stati nazionali a casa non sentono più di coincidere
con la propria identità e nella propria identità non si sentono più a casa. […] Quel che certo
maggiormente si avvicina al primo estremo di tale dissoluzione sono gli ebrei della diaspora degli
ultimi duemila anni, dei quali è stato possibile dire, e non a torto, che fossero un popolo senza terra;
uno stato di cose che Heinrich Heine ha sottolineato magistralmente dicendo che gli ebrei non si
trovavano a casa propria in un paese, bensì in un libro, la Torah, che si portavano dietro ovunque
come una “patria portatile”. Questa considerazione così elegante e profonda getta di colpo luce su
una circostanza di validità generale che troppo spesso non viene notata: i gruppi “erranti” o
“deterritorializzati” non ricavano la loro immunità simbolica e la loro coerenza etnica in base a una
terra portante; sono molto di più le loro comunicazioni reciproche a fungere da «contenitore
autogeno» nel quale coloro che prendono parte alla comunicazione sono essi stessi contenuti e
restano “in forma” mentre il gruppo va alla deriva in paesi stranieri. Un popolo senza terra, dunque,
non può incorrere nella falsa conclusione che per tutta la storia dell’umanità si è imposta a quasi
tutti i popoli stanziali, e cioè quella di considerare il paese stesso come il contenitore del popolo e di
intendere la propria terra come l’a priori del senso della propria vita o della propria identità. Questa
territorial fallacy una delle eredità fino ad oggi più influenti e più problematiche dell’età
sedentaria del mondo, perché intorno ad essa si fissa il riflesso istintivo di ogni impiego politico, in
apparenza legittimo, della forza e cioè la cosiddetta “difesa nazionale”. Essa si basa sulla
parificazione ossessiva del luogo e del sé, sull’errore di ragionamento assiomatico commesso dalla
ragione territorializzata. Tale errore è stato portato sempre più allo scoperto da quando un’ondata
potentissima di mobilità transnazionale fa sì che in molti luoghi popoli e territori relativizzino il
legame che intercorre tra di loro. Il trend verso un sé multilocale, così come verso un luogo
multietnico o “denazionalizzato”, è caratteristico della modernità avanzata.
Su questo stato di cose, interessante anche dal punto di vista teoretico, ha richiamato recentemente
l’attenzione l’antropologo culturale indo-americano Arjun Appadurai [in Beck Perspektiven der
Weltgesellschaft, 1998] con l’elaborazione del concetto di ethnoscape. Sotto tale concetto vengono
presi in considerazione stati di cose quali la “deterritorializzazione” avanzante di relazioni etniche,
la formazione di “comunità immaginarie” al di fuori delle nazioni e l’aver parte, a livello
immaginario, di innumerevoli individui, nelle forme di vita di altre culture nazionali. Per quel che
riguarda gli ebrei durante il periodo dell’esilio, la loro provocazione era consistita nel fatto che essi
avevano ininterrottamente tenuto sotto gli occhi dei popoli dell’emisfero occidentale l’apparente
paradosso e l’effettivo scandalo di un sé che di fatto esisteva senza luogo.» Sloterdijk Peter 2001
L’ultima sfera. Breve storia filosofica della globalizzazione, Carocci, Roma 2002, 170-171
6.3.4.2. a tale scopo si presta il concetto di non-luogo (oggetto delle analisi di Marc Augé, qui in
diversa accezione e in estensione) come letture universale dello stile contemporaneo di territorialità;
e da qui le opportunità dell’individuo o nuove dimensioni per l’individuo, in uscita da rigidi
“container nazionali”.
«Questo vale per tutti i luoghi di transito, nel senso ristretto del termine e in senso lato, sia che si
tratti di località adibite al traffico, come le stazioni, i porti, gli aeroporti, le strade, le piazze e i
41
centri commerciali, sia che si tratti di complessi che sono stati concepiti per soggiorni limitati, come
i villaggi per vacanze o le città turistiche, le aree industriali o gli asili notturni. Tali luoghi possono
sì avere la loro atmosfera particolare, ma la loro esistenza non dipende dalla presenza di una
popolazione abituale o di un sé collettivo in essi radicati. La loro peculiarità è insita nel non
trattenere i visitatori e i passanti. Si tratta di quei luoghi di nessuno, ora affollati di gente, ora senza
un’anima viva, di quei deserti del transito che proliferano nei centri decentrati e nelle ibride
periferie delle società contemporanee. In queste società è possibile riconoscere, senza ulteriore
dispendio analitico, che quello che per esse ha rappresentato fino a oggi la normalità, e cioè una vita
racchiusa all’interno di condizioni—container etniche o nazionali (con tutti i loro rispettivi
fantasmi) e la licenza a confondere la terra e il sé senza correre alcun pericolo, è stato intaccato in
modo decisivo dalle tendenze globalizzanti. Infatti, da un lato queste società allentano il loro
legame con il luogo: grandi masse fanno propria una mobilità che non trova precedenti nella storia;
dall’altro, aumenta drammaticamente il numero dei luoghi di transito in relazione ai quali nessuna
relazione abitativa è possibile per le persone che li frequentano. In questo modo le società
globalizzanti e mobilizzanti si avvicinano sia al polo “errante”, a quello di un sé privo di luogo, sia
al polo desertico, un luogo privo del sé, su un fondale, che va sempre più rimpicciolendosi,
costituito da un’infinità di culture regionali e di sensazioni di soddisfazione derivanti dalla fedeltà a
un luogo.» (Sloterdijk 2001, 172)
6.3.4.3. dalla “natura” al “costruzionismo”: identità culturali multiple, sincretiche e fluide.
«Non per nulla, la formazione di identità culturali multiple, fluide, sincretiche, è un topos corrente
del postmodernismo. Come nota Enzo Colombo, “a partire da un’epistemologia costruzionista, si
mette in evidenza che differenze, identità e culture non sono date ma prodotte in un’opera
continua di mediazione, confronto, adeguamento e conflitto tra possibilità differenziate. Non
esistono come realtà pure, ma solo come processi intrinsecamente caratterizzati da contraddizione,
instabilità, mutamento miscelazione (Colombo 2005)». (Ambrosini, ivi, p. 73)
«Il riferimento ad un maestro buddhista, o la passione per la musica latinoamericana, o la ricerca di
cibi esotici non sono più classificabili come aspetti specifici del transnazionalismo culturale dei
migranti, ma possono essere condivisi, più o meno durevolmente e con valenze diverse, da persone
e gruppi che appartengono alla società ospitante. L’ibridazione culturale si diffonde, ma insieme si
confonde, in un vasto territorio intermedio tra identità individuali liberamente scelte e ridefinite a
piacimento e identità collettive originarie e «autentiche», o almeno esaltate come tali dai loro
propugnatori.» (Ambrosini, ivi, p. 74)
6.4. una sfida politica e un suo divenire.
6.4.1.Le nuove istanze del “collettivo” che raccoglie il sociale. Dalle analisi e dalle proposte di
Latour Bruno 1999 Politiche della natura. Per una democrazia delle scienze, Raffaello Cortina
editore, Milano 2000: «Finché il collettivo riesce a trarre insegnamenti da ciò che ha respinto fuori
di sé, lo si può definire civilizzato: può cambiare nemici, ma non ha il diritto di moltiplicarli a ogni
iterazione. Non appena si crederà circondato da entità insignificanti che lo minacciano di
distruzione, diverrà barbaro. Una società circondata da una natura da dominare, una società che si
crede libera da tutto ciò di cui non tiene conto, una società che si pensa d’acchito come universale,
una società che fa corpo con la natura — sono tutti esempi di collettivi barbari. Da questo punto di
vista, come si capirà, i moderni non si sono mai distinti per un livello particolarmente alto di civiltà,
perché si sono sempre pensati come coloro che erano sfuggiti alla barbarie passata, che resistevano
al ritorno dell’arcaismo, che dovevano portare il progresso a coloro che ne mancavano... Slittando
dal modernismo all’ecologia politica, si può dire che i moderni richiudono la parentesi che li aveva
per qualche tempo separati dagli altri, O piuttosto, dopo la prova di fuoco del modernismo, entriamo
in un’epoca nuova in cui nessun collettivo può, senz’altra forma di processo, utilizzare più
l’etichetta di “barbaro” per qualificare ciò che respinge. Non per questo ci si dovrà crogiolare nel
multiculturalismo astenendosi da ogni giudizio di valore, bensì riprendere la parola come all’inizio
delle grandi scoperte. Occorre che il collettivo reciti di nuovo la scena primitiva della
42
colonizzazione, ma colui che va incontro ai civilizzati che sbarcano è, questa volta, anch’egli un
civilizzato. Dopo secoli di malintesi, ecco che si riprendono i “primi contatti”. [in nota 26 cita
l’espressione di Appadurai Arjun a definire i tempi presenti: “globalizzazione delle differenze” p.
310] […] Con l’ecologia politica si entra veramente in un altro mondo, quello che non ha più come
ingredienti una natura e più culture, che non può quindi semplificare il problema del numero di
collettivi unificandolo attraverso la natura, né complicarla accettando una molteplicità inevitabile e
definitiva di culture incommensurabili. Entriamo in un mondo composto di realtà insistenti, in cui le
proposizioni dotate di abitudini non accettano più né di far tacere le istituzioni incaricate di
accoglierle né di essere accolte divenendo mute sulla realtà delle loro esigenze. L’esterno non è più
abbastanza forte da ridurre al silenzio il mondo sociale, né abbastanza debole da lasciarlo ricondurre
all’insignificanza. Nel senso nuovo che abbiamo ridato a questo termine, le entità escluse esigono
che il collettivo si presenti e si ripresenti al loro appello, cioè che rischi di nuovo la sorte di tutte le
sue istanze rappresentative.» (Latour 1999, 236, 238)
6.4.2. A conclusione e approfondimento le riflessioni di Appadurai sul tema delle interrelazioni tra
sfere pubbliche diasporiche in una globalizzazione fondata sulle migrazioni di massa e sulle
mediazione elettroniche dei mass media, che determinano il tramonto degli stati nazionali, tanto più
delle loro forme identitarie.
«Le sfere pubbliche diasporiche, tra loro diverse, sono i crogioli di un ordine politico
transnazionale. I motori del loro discorso sono i mass media (interattivi ed espressivi) e i movimenti
di profughi, attivisti, studiosi e lavoratori. Può darsi benissimo che l’ordine postnazionale
emergente si riveli non tanto un sistema di elementi omogenei (così com’è nell’attuale sistema degli
stati nazionali), quanto piuttosto un sistema basato su relazioni tra elementi eterogenei: movimenti
sociali, gruppi di pressione, corpi professionali, organizzazioni non governative, forze armate di
polizia, corpi giudiziari. Quest’ordine emergente dovrà rispondere a una difficile domanda: riuscirà
questa eterogeneità a combinarsi con alcune convenzioni minime sulle norme e sui valori, che non
richiedano una stretta adesione al contratto sociale liberale della modernità occidentale? Tale
questione decisiva non verrà risolta per decreto accademico, ma attraverso le negoziazioni
(pacifiche e violente) tra i mondi immaginati da questi differenti interessi e movimenti. Nel breve
periodo, come possiamo già vedere, sarà probabilmente un mondo caratterizzato da sempre maggior
barbarie e violenza. Sul lungo periodo, una volta liberate dalle costrizioni della forma nazionale,
potremo forse scoprire che la libertà culturale e la giustizia nel mondo non presuppongono
l’esistenza uniforme e generale dello stato nazionale. Questa eventualità perturbante potrebbe essere
il lascito più eccitante per aver vissuto nella modernità in polvere.» Appadurai Arjun 1996
Modernità in polvere. Dimensioni culturali della globalizzazione, Raffaello Cortina editore, Milano
2012, 35 (nota al titolo originale e alla sua traduzione italiana: Modernity at Large: Cultural
dimension of Globalization: at large= nel suo insieme, come affrontare un argomento nel suo
insieme; o = alla macchia, libero, senza permesso, come prigionieri alla macchia dopo l’evasione;
qui in polvere = frantumata ma anche perché intesa come materiale pronto per ricomposizioni [così
liberamente da nota 7 p. 257-8], oppure, o meglio: modernità diffusa, come indica Wikipedia o, si
potrebbe dire, in evasione, in fuga, in dilatazione, che ha preso il largo…).
Bibliografia di riferimento
Touraine Alain 1997 Libertà, uguaglianza, diversità. Si può vivere insieme?, il Saggiatore, Milano
1998
Bauman Zygmunt 2000 Modernità liquida, ed. Laterza, Roma-Bari 2002
Crespi Franco 2004 Identità e riconoscimento nella sociologia contemporanea, Laterza, Roma-Bari
Pompeo Francesco (a cura di) 2007 La società di tutti. Multiculturalismo e politiche dell’identità,
Meltemi, Roma
Aime Marco 2004 Eccessi di culture, Einaudi Torino
Donati Pierpaolo 2008 Oltre il multiculturalismo, Laterza, Roma-Bari
43
Ambrosini Maurizio 2008 Un’altra globalizzazione. La sfida delle migrazioni transnazionali, il
Mulino, Bologna
Sen Amartya 2006 Identità e violenza, Laterza, Roma-Bari
Quassoli Fabio 2006 Riconoscersi. Differenze culturali e pratiche comunicative, ed. Raffaello
Cortina, Milano
Savidan Patrick 2009 Il multiculturalismo, il Mulino, Bologna 2010
Cotesta Vittorio 2012 Sociologia dello straniero, Carocci editore, Roma
Rawls John 1971, 1999 Una teoria della giustizia, Milano Feltrinelli, 2008
Rawls John 2005 Liberalismo politico. Nuova edizione ampliata, Einaudi, Torino 2012
44