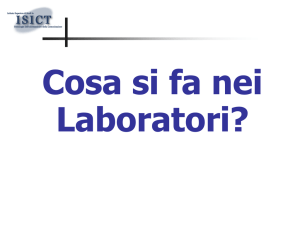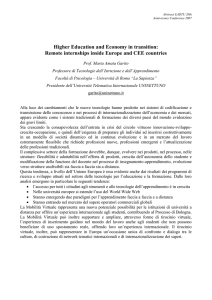Ufficio Nazionale
per le Comunicazioni Sociali
UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE
Convegno
Internet:
un nuovo forum per proclamare il Vangelo
Milano, 9 - 11 Maggio 2002
INTERVENTO ALLA TAVOLA ROTONDA:
INTERNET TRA TECNOLOGIZZAZIONE E
UMANIZZAZIONE
Prof. Francesco BOTTURI
Docente di Antropologia filosofica
Università Cattolica del Sacro
Cuore
I. LA QUESTIONE ANTROPOLOGICA AL CENTRO
L’ampiezza e la complessità dei problemi enucleati con vivace
intelligenza dal Convegno convergono verso la problematica
antropologica. Nella sua relazione il prof. A. Fabris ha affermato che
“la tecnologia comporta mutamenti antropologici” e che “Internet è
una questione antropologica”, intendendo dire che la tecnologia della
Rete ha a che fare con un nuovo modo di “fare esperienza” di sé, di
altri, del mondo. Anche le questioni etiche che l’uso di Internet
solleva sono dipendenti dal tipo di esperienza che la Rete fa fare e
quindi dalle nuove dimensioni antropologiche che mette in gioco.
Vi sono però due atteggiamenti contrapposti nell’affrontare la
questione, dipendenti dalla diversa interpretazione del rapporto tra
tecnologia e comportamento umano. In un suo intervento il prof. F.
Casetti ha affermato che la “tecnologia prefigura comportamenti”;
mentre, esponendo la sua ricca relazione, il prof. S. Martelli ha
sostenuto che la tecnologia non determina i comportamenti, ma è un
mezzo suscettibile di un uso buono o cattivo. Si tratta di due tesi
contrapposte che vale sottolineare, perché esprimono (entrambi con
fondate ragioni) le due valutazioni possibili dell’impatto
antropologico delle tecnologie. Il problema di fondo è il seguente: è
adeguato rappresentarsi - come è anche in uso nel linguaggio comune
sull’argomento - le tecnologie come strumenti a disposizione di un
soggetto concepito come autonomo da esse? Oppure bisogna prendere
atto di un coinvolgimento del soggetto umano nelle tecnologie più
globale e più potente delle sue stesse individuali intenzioni? Dalla
risposta a queste domande dipende - ovviamente - una diversità
rilevante nella valutazione del rapporto con le tecnologie e nella
progettazione operativa del loro impiego.
II. LA TECNOLOGIA COME “AMBIENTE”
Ritengo che abbia maggior verità la seconda posizione. Infatti,
la diversità della tecnologia contemporanea rispetto alla tecnica
tradizionale (componente permanente di tutta la vita storica
dell’uomo) consiste proprio nel fatto che la tecnologia solo
limitatamente è mezzo a disposizione dell’uomo secondo suoi fini
soggettivi e revocabili; essa è, invece, piuttosto ambiente, che precede
ed eccede il soggetto e le sue intenzioni.
Il soggetto certamente utilizza e innova le tecniche, ma ne
dispone limitatamente; molto più ne è disposto, perché la tecnologia è
un fatto sempre meno settoriale, ma è un amplissimo insieme di
dispositivi, che con la sua pervasività e capillarità dà forma a gran
parte del contesto vitale e dell’orientamento mentale dell’uomo
contemporaneo, cioè costituisce ambiente. Inoltre, la tecnologia, a
motivo della sua interna complessità tecnica, della sua impegnatività
finanziaria ed economica e della sua rilevanza sociale, tende a
costituire un articolato sistema “autotelico” - come dicono alcuni
studiosi del problema -, cioè che risponde sempre meno a bisogni
esterni e sempre più a fini interni di sviluppo secondo leggi di
permanenza e di evoluzione autonome rispetto a intenzioni di altra
natura (culturale, politica, ecc.), pur essendo in continua relazione
dialettica con queste.
Nella storia dell’uomo la tecnica ha un significato antropologico
fondamentale: quello di far rientrare in possesso dell’uomo le
condizioni materiali della sua esistenza, realizzando così il sogno
umano di signoria e di autonomia nei confronti della natura. Da questo
punto di vista, con la tecnologia avviene un fenomeno paradossale: da
una parte, essa realizza un dominio inedito sull’ambiente naturale, ma,
dall’altra, quanto più l’uomo le detta le sue condizioni, tanto più egli
costruisce con le sue mani (cioè con la sua mente) un nuovo ambiente
che condiziona sempre più globalmente la sua esistenza.
Questo non significa che l’uomo viene a trovarsi
necessariamente in balìa del suo prodotto tecnologico, ma che questo
stabilisce e struttura sempre più le condizioni artificiali della sua
esistenza, costituendo un ambiente sostitutivo di quello naturale, con
cui l’uomo deve fare i conti come qualcosa che, prodotto da lui, gli si
impone. In tal modo l’uomo tecnologico agendo interviene in qualcosa
che non gli sta semplicemente di fronte (come accade con un mezzo
strumentale), ma che lo ri-comprende e lo con-tiene
La tecnologia informatica approfondisce vertiginosamente
questo processo, perché, a motivo delle sue caratteristiche tecniche
stesse, l’ambiente tecnologico che essa viene a costituire è sempre più
internalizzato: il soggetto si sente e si concepisce in continuità stretta,
quasi in simbiosi con l’apparato tecnologico; tende addirittura a
vedere se stesso come una protesi dell’apparato tecnologico. In tal
modo, il medium è in realtà sempre meno tale, cioè mediazione tra il
soggetto e la realtà, intesa come ciò che può essere raggiunto anche
altrimenti, al di là del mezzo. Piuttosto, medium è ormai il nome di
una nuova realtà, sempre più sostitutiva di quella naturale; è appunto il
caso della realtà cd “virtuale”, che non è più tanto mediazione di una
realtà naturale, quanto - per l’alta componente tecnologica che la
costituisce - realtà nuova in se stessa.
III. IL SENSO DEL “FAR ESPERIENZA”
Di conseguenza, cambia in profondità il senso stesso dell’esperienza e
del fare esperienza. Nell’ambiente tecnologico c’è un modo diverso di
fare esperienza, perché - come si esprime S. Martelli - ha come sua
condizione la “derealizzazione” dell’esperienza nel senso tradizionale
del termine, come risulta evidente nella ricreazione e ricostituzione
virtuale della realtà.
La categoria dell’“esperienza” e la questione del “fare
esperienza” diventano dunque il problema centrale. Si tratta di sapere,
infatti, che senso abbia fare esperienza dotato di un’originalità che non
dipende dal suo ambiente tecnologico.
È ovvio che questo discorso non intende stabilire una
aprioristica conflittualità tra esperienza naturale ed esperienza
virtuale; vuole piuttosto segnalare una sfida che è nelle cose e che si
concentra sull’interrogativo sul significato del fare esperienza e se
questo abbia caratteristiche irriducibili e paradigmatiche rispetto
all’esperienza virtuale. L’uomo della semplice tecnica tradizionale,
pur riconoscendosi immerso nel suo ambiente naturale, si è sempre
concepito distinto dal suo ambiente e la consapevolezza critica di ciò è
stata una delle caratteristiche fondamentali dell’umanesimo
occidentale. Così ora è necessario interrogarsi se sia possibile che
l’uomo collocato nel nuovo ambiente tecnologico sia in grado di
affermare, di salvaguardare ed esprimere la sua “differenza
antropologica”.
Non si tratta dunque di guardare con sospetto le nuove
tecnologie, ma anche di evitare l’ingenuità di credere che esse siano
neutralmente a disposizione delle nostre buone intenzioni. Meglio
ancora, si tratta di rendersi conto che la nuova tecnologia costituisce
un evento che muta complessivamente le condizioni dell’esistenza e
quindi che per il soggetto umano si rinnova il compito di definire la
sua autocomprensione di soggetto umano in quanto tale; più in
concreto, il compito di ridefinire che cosa significa per l’uomo in
quanto tale “fare esperienza” umana.
Che questa insistenza non sia fuori luogo, è confermato dal
contesto culturale che accompagna l’affermarsi dell’“ambiente
tecnologico”. Si noti, ad esempio, la (apparentemente) contraddittoria
presenza del diffuso “naturalismo”, cioè di un riduzionismo di tipo
biologistico ed evoluzionistico, secondo cui l’uomo è identificato con
il suo apparato genetico, la sua mente con un epifenomeno del suo
cervello, la sua individualità con l’essere membro della sua specie, la
sua vita con una delle forme dell’ecosistema, ecc.). Si assiste, cioè,
all’insistita affermazione dell’omogeneità uomo con la natura (e
quindi
alla
negazione
della
differenza
antropologica).
Immediatamente questo appare come una linea culturale antitetica
all’esaltazione dell’uomo tecnologico. Ma se si osserva la cosa con
maggiore profondità, ci si accorge che si tratta di un’unica logica
culturale che si presenta in due versioni opposte: in un caso si assimila
l’uomo al suo ambiente naturale, nell’altro si assimila l’uomo al suo
ambiente tecnologico. In un caso e nell’altro si afferma l’essenziale
omogeneità dell’uomo con il suo ambiente. In realtà si tratta di due
forme della stessa cultura, che - di per sé - dà luogo ad una sinergia
negatrice della specificità dell’identità umana in quanto umana, della
sua libertà, della sua spiritualità, della sua dignità irriducibile. Non è
ovviamente secondario rendersi conto che l’esperienza umana della
tecnologia avviene in questo contesto culturale, che condiziona
profondamente l’autoconsiderazione e l’autostima dell’uomo
contemporaneo.
IV. L’ESPERIENZA “REALE” E DI FEDE
Non è qui possibile neppure tratteggiare il profilo antropologico
di che cosa significhi “fare esperienza”. È possibile solo alludervi, allo
scopo di riprendere consapevolezza dello spessore del “fare
esperienza” e della sua irriducibilità all’esperienza della tecnologia
virtuale.
Quando si parla di “esperienza”, evidentemente non si intende
parlarne nel senso di sperimentalismo, né in senso scientifico, né in
senso irrazionalistico, emotivistico; ma neppure di esperienza di tipo
virtuale, non perché questa non sia a suo modo reale (presenza
mediata, interattività, efficacia, ecc.), ma perché per sua natura il
virtuale è una protesi di potenziamento primariamente ed
essenzialmente del livello sensitivo-immaginativo-emozionale
dell’esperienza, che implica una strutturale selezione degli elementi
costitutivi dell’esperienza umana secondo una sua originaria e
paradigmatica integralità; implica cioè un’inevitabile riduzione e
scomposizione dell’esperienza tipicamente umana, che non è dannosa,
solo se è consapevolmente saputa come tale, ma che è devastante, se è
vissuta come rimozione e sostituto di quella
A quali condizioni, dunque, si dà esperienza in modo
antropologicamente sensato? Anzitutto non c’è esperienza, se non c’è
racconto del vissuto, ma come racconto di senso unitario del vissuto.
Ma non c’è racconto, se non come ripresa e interlocuzione con
l’essere già stati raccontati e quindi come appartenenza ad una
tradizione di racconto, cioè di “grande racconto” di senso
dell’esistenza, dal/nel quale il singolo riceve un fondamentale
riconoscimento di identità (in questo le tradizioni famigliari e
religiose e comunque culturali in senso forte hanno sempre avuto una
funzione fondamentale e insostituibile).
Ma l’appartenenza identitaria ad una tradizione di senso è
condizione e principio di esperienza, solo nella misura in cui attiva nel
soggetto la sua personale capacità di domanda e di dialogo; la sua
capacità di giudizio e di affermazione; cioè attiva la sua razionalità
non semplicemente calcolante e tecnico-funzionale, ma “realistica”,
cioè ontologica e veritativa. Ma l’appartenenza ad una tradizione
culturale non è solo esperienza cognitiva, ma anche attivazione di
personale libertà e quindi di razionalità pratica, non semplicemente
operativa, ma anzitutto assiologica, cioè morale.
In sintesi c’è esperienza, se il soggetto vive relazioni
significative e identificanti e giunge alla consapevole capacità di
discernimento tra il vero e il falso, tra il buono e il cattivo e, quindi, se
sviluppa un’affettività vissuta non come emozione egocentrica
reattiva, ma come risposta, adesione e vincolo. Infine, l’esperienza
umana di senso ha la sua sintesi vitale e culturale nella percezione
estetica della sua unità. Non è un caso infatti che tutte le grandi
tradizioni culturali, le grandi narrative della storia umana - che hanno
come protagoniste le grandi religioni e il cristianesimo in modo
particolare - abbiano dato al mondo la testimonianza di straordinarie
rappresentazioni estetiche dell’esistenza, siano sempre state il grembo
di una produzione artistica di straordinario valore, abbiano riempito il
mondo di bellezza.
Sono solo alcuni cenni per alludere a ciò che significa far
esperienza in un senso non preventivamente ridotto, ma che rispetti ed
esprima la ricchezza antropologica. È facile rendersi conto che,
benché contenutisticamente disponibile ad ognuna delle dimensioni
dell’esperienza ricordate, l’esperienza virtuale non solo non può
supplirne nessuna, ma soprattutto non è un luogo possibile di genesi e
di sintesi dell’esperienza stessa.
Se le cose stanno così, il soggetto sarà in grado di vivere il suo
nuovo ambiente virtuale - piuttosto che di esserne vissuto -, se potrà
attingere e sviluppare con consapevolezza, stabilità e intensità la
ricchezza potenziale della sua esperienza umana; vivendola come
paradigma del far esperienza e non accettando l’inganno di quel
rovesciamento di prospettiva che vorrebbe che l’artificiale diventasse
il paradigma del suo essere al mondo e con altri.
Risulta chiaro, a questo punto, che senza questa avvertenza
critica sullo statuto dell’umana esperienza anche la testimonianza e la
proposta dell’“esperienza della fede” può ricevere solo un’accoglienza
nominale (dico dal punto di vista del funzionamento culturale della
cosa, al di là della sincerità e della buona volontà del singolo). Se,
infatti, la fede non si innesta su un sentimento adeguato
dell’esperienza umana, inevitabilmente viene ricodificata entro i
limitati (antropologicamente parlando) schemi della comunicazione
virtuale, che significa in concreto la sua riduzione o a
moralismo/dottrinarismo oppure ad emozionalimo/spiritualismo.
Al contrario, l’esistenza ed il rinvio alla realtà per nulla virtuale
di una comunità viva di persone unite dal vincolo della fede e della
carità costituisce - per l’uomo d’oggi in particolare - un esempio ed
una risorsa di esperienza umana densa di senso e ricca di forme, che
offre un paradigma di esistenza reale dotata della capacità di
interagire “umanamente” con ogni ambiente.