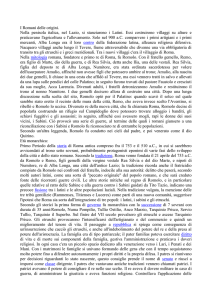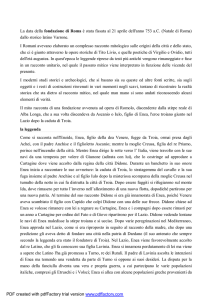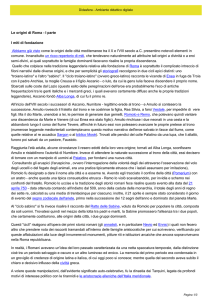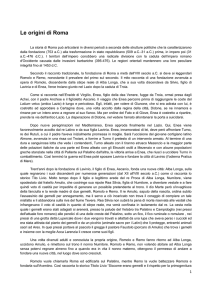Storia del
Diritto
Romano
1
Indice
La Genesi della Nuova Comunità Politica ........................................................................................... 3
La tradizione annalistica ........................................................................................................................................................ 3
Le condizioni materiali nel Lazio arcaico....................................................................................................................... 4
Villaggi, distretti rurali e leghe religiose ......................................................................................................................... 5
Romolo e le origini di Roma ................................................................................................................................................. 6
2
La Genesi della Nuova Comunità Politica
La tradizione annalistica
I Pontefici, sacerdoti romani e unici depositari dei mores, cioè del diritto arcaico, redigevano
dei documenti molto antichi. Risiedevano nella reggia, così chiamata perché, prima di
diventare la residenza dei Pontefici, era stata la residenza dei re.
Il Pontefice Massimo era loro rappresentante e aveva contatti anche con i privati. Perciò, fino
ad una certa epoca, coloro che dovevano risolvere un problema giuridico si rivolgevano in
segreto al pontefice.
Tutti i Pontefici redigevano due tipi di documenti, che stanno alla base di tutta la storiografia,
e li conservavano nella reggia:
Fasti, che si distinguevano in:
o Fasti diurni (da dies, “giorno”), che erano come dei calendari. A loro volta si
distinguevano in:
Fasti diurni urbani, redatti dai Pontefici.
Fasti diurni rustici, propri delle varie comunità al di fuori di Roma.
Si trattava di annuari, contenenti le date e le indicazioni di cerimonie religiose,
dei giorni fasti (in cui era consentito stare in giudizio), dei giorni nefasti, dei
giorni di mercato, dei giorni di comizi, e via dicendo. Venivano esposti nel Foro
all’inizio di ogni mese, giorno che, per questo motivo, era chiamato calendae (da
calare, ossia “chiamare, convocare”, proprio perché il popolo veniva convocato
per vedere cosa sarebbe successo nel corso del mese). Questi calendaria, come
erano ufficialmente chiamati, erano di esclusiva competenza dei Pontefici.
Nel 304 a.C., Gneo Flavio, liberto di Appio Claudio Cieco, introdusse l’usanza di
pubblicare nel Foro delle tavole scolpite nella pietra, di solito nelle quattro facce
di un solido rettangolare, con l’indicazione dei Fasti. Questa lista è stata
all’origine del calendarium scritto, il calendario romano, in cui ogni settimana
veniva suddivisa in otto giorni, ciascuno indicato con le lettere dalla A alla H.
Ogni giorno, poi, era caratterizzato da una certa lettera ad indicarne la natura.
Così la lettera “F.” stava per fastus, la “N.” per nefastus, “NP” per nefastus priore
(“illecito prima di mezzogiorno”), “FP” per fastus priore (“legittimo prima di
mezzogiorno”), e via dicendo. Questo calendario dei fasti permise di evitare che
il popolo fosse costretto ad interpellare i sacerdoti per conoscere quali fossero i
giorni fasti.
Di questi calendari abbiamo alcuni esempi. Il più antico di essi è della città di
Anzio e risale ad un periodo di tempo compreso tra l’84 e il 55 a.C.
La popolazione rurale celebrava meno feste, sacrifici, cerimonie e ferie della
popolazione della città, e per questo i fasti rustici contenevano meno indicazioni
rispetto ai fasti urbani.
o Cronache ufficiali, che si distinguevano in:
3
Fasti consolari, che erano cronache ufficiali nelle quali ogni anno era
indicato con il nome dei consoli e del loro padre, con l’aggiunta degli
eventi più importanti verificatisi nell’anno.
Fasti trionfali, che contenevano l’elenco dei generali vittoriosi, dalla
fondazione di Roma fino al principato di Augusto.
Annales, che erano una raccolta di testi contenenti succintamente la registrazione
degli avvenimenti più importanti nella vita della città (conquiste, trattati di guerra, di
pace o di altra sorta, elezioni di politici, trionfi generali, importanti fenomeni naturali, e
via dicendo), tenuta anno per anno dal Pontefice massimo. Tali documenti
consistevano in una serie di tavole dealbate, esposte dal Pontefice sopra l’ingresso
della reggia. Alla fine dell’anno questi Annali pontificali venivano portati nell’archivio.
Publio Mucio Scevola, console nel 133 a.C. e padre di quel Quinto Mucio che ha scritto
l’opera di ius civile, fu l’ultimo Pontefice ad aver redatto annales e, inoltre, raccolse
negli 80 libri degli Annales Maximi tutti gli annales precedenti.
La storiografia romana deve ai Greci l’invenzione di questo genere letterario. I Romani
ebbero grandi modelli su cui basare le loro opere, come Erodoto e Tucidide. I primi
annalisti romani scrissero in greco, probabilmente perché influenzati dalla raffinata
prosa letteraria ellenica. I pochi frammenti rimasti degli autori più importanti sono
insufficienti per esprimere un giudizio di merito.
Nel II secolo a.C., la storiografia polibiana si colloca storicamente in un periodo che
vede l’ascesa di Roma e un’accelerazione del processo di decadenza politico-culturale
della Grecia. Polibio, in questo senso, si inserisce come storico di origini greche, ma di
“adozione” romana: entra, infatti, a far parte del circolo degli Scipioni in seguito alla
sconfitta di Pidna, quando venne portato a Roma come schiavo.
Successivamente, Tito Livio, nato a Padova, fu uno storico romano conosciuto
soprattutto per la sua opera intitolata “Ab Urbe Condita” (Le origini di Roma), che è
una storia di Roma a partire dalla fondazione della città.
Durante il principato di Augusto, Dionigi d’Alicarnasso è stato uno storico greco, che
scrisse le “Antichità romane”, opera che abbraccia la storia romana dal periodo mitico
fino all’età della prima guerra punica.
Nel I secolo a.C., Diodoro Siculo fu un altro storico greco, autore di una monumentale
storia universale.
Appiano di Alessandria fu ancora un altro storico greco, che scrisse soprattutto sulle
guerre civili dell’età repubblicana.
Vissuto sotto l’Impero romano, anche Plutarco fu uno storico greco, la cui opera più
importante riguarda le biografie dei più famosi personaggi dell’antichità.
Dione Cassio fu un altro storico greco, che scrisse un’opera sulla storia di Roma dalle
origini al 229 d.C.
Sallustio fu, invece, uno storico romano, che scrisse dopo Cesare un’opera in cui narra
la congiura di Catilina e la guerra giugurtina.
Nel 390 a.C. tutti questi annales e fasti, che fino a quel momento dall’inizio della Repubblica i
pontefici avevano raccolto, sono andati perduti a causa dell’invasione gallica.
Le condizioni materiali nel Lazio arcaico
Il paesaggio fisico in cui si situavano gli insediamenti umani che, agli inizi dell’ultimo
millennio a.C., avrebbero dato origine a Roma e alle altre città del Latinum vetus, non doveva
4
essere molto diverso da quello odierno, solo più scosceso e segnato da maggiori e improvvisi
dislivelli. Soprattutto la presenza di aree boschive e di vasti acquitrini, negli avvallamenti,
contribuiva all’isolamento delle comunità umane ivi stanziate. Il territorio era limitato a Nord
dal Tevere, che divideva il Lazio dall’Etruria e ne rappresentava il confine (img. pag. 3).
Nella primitiva economia delle popolazioni laziali un ruolo importante era rappresentato
dall’allevamento. Era però già praticata anche una forma primitiva di agricoltura. Abbastanza
antico appare anche lo sfruttamento di certi alberi da frutto, come il fico e, molto
probabilmente, l’ulivo.
Sin dagli inizi dell’ultimo millennio a.C. vennero sviluppandosi, con l’incremento dei livelli
economici delle popolazioni laziali, forme di circolazione di uomini e di cose. Le principali
rotte commerciali, attraversando verticalmente la pianura laziale, univano l’Etruria alla
Campania: due aree di più precoce sviluppo economico. Uno dei pochi punti di passaggio dove
era più facile il guado del Tevere, è costituito dall’area su cui sorgerà Roma. Non meno
importanti erano anche le vie di comunicazione dal mare verso l’interno: allora, infatti, il
Tirreno era già coperto da una fitta rete di traffici marittimi che contribuiva all’intenso flusso
di beni tra la zona costiera degli scambi e l’entroterra. Ancora oggi il nome della Via Salaria, a
Roma, ricorda appunto uno di questi percorsi commerciali, relativo a un bene di fondamentale
importanza nell’alimentazione umana: il sale.
Tra i vari popoli d’Italia di quest’epoca (img. pag. 1), i più importanti, oltre i Sanniti, popolo
molto bellicoso, sono gli Etruschi, che, in un primo momento, occupano la zona dal Tevere
all’Arno, e, poi, si estendono fino in Campania. Avevano una cultura molto avanzata e rapporti
frequenti con i popoli greci. L’Etruria dominava anche i traffici commerciali, che andavano o
all’interno, attraverso la Via Salaria e la Via Campana, oppure verso il sud.
I Sanniti, invece, sono popolazioni meridionali, di lingua osca, che erano divisi in quattro stati
tribali dominanti; a capo di ciascuno vi era un’autorità. Tutti questi gruppi erano poi riuniti in
confederazioni.
Quest’area, sin dagli inizi dell’ultimo millennio a.C., era caratterizzata dalla presenza di
numerosi villaggi (pagi) vicini gli uni agli altri e costituiti da poche capanne, la cui struttura è
rappresentata in alcune urne cinerarie trovate nei sepolcreti arcaici della zona (img. pag. 17).
La loro aggregazione interna si fondava sulla presenza di forme familiari o pseudoparentali,
legate alla memoria di una più o meno leggendaria discendenza comune.
Villaggi, distretti rurali e leghe religiose
Non facile e non univoca è l’individuazione delle forme culturali che regolavano questi primi
arcaici insediamenti la cui conoscenza è possibile solo attraverso lo studio delle tracce
archeologiche che ne sono restate, soprattutto nei modesti sepolcreti che gli archeologi
vengono recuperando. Un aspetto importante è costituito dalla grande omogeneità di questi
ritrovamenti, a testimoniare una notevole uniformità di condizioni economiche.
Le elementari funzioni di guida del gruppo dovevano associarsi all’età e al ruolo militare.
Accanto agli anziani, ai patres, detentori della saggezza e della capacità di ben guidare la
comunità, dobbiamo comunque immaginare un ruolo permanente dell’assemblea degli
uomini in arme, che restava, insieme al parere degli “anziani”, dei patres del gruppo,
competente per le decisioni relative alla vita della comunità.
La grande quantità di questi piccoli villaggi, situati in un’area relativamente circoscritta,
sovente a poche centinaia di metri gli uni dagli altri, contribuiva ad accentuare un ininterrotto
e fitto sistema di relazioni tra di essi. Era un mondo magmatico caratterizzato da una “cultura”
comune, consistente anzitutto nella comunanza della lingua latina e nella partecipazione a
riti e culti.
5
Intorno agli anni in cui la tradizione colloca la “fondazione” di Roma, verso la metà dell’VIII
secolo, precisamente nel 753 a.C., profonde trasformazioni sembrerebbero verificarsi
nell’organizzazione economico-sociale del Lazio primitivo. Si tratta anzitutto di un
processo di differenziazione, documentato dalla presenza di tombe con arredi funerari di
crescente opulenza, nettamente distinte da quelle tuttora più diffuse, assai più modeste. Esse
attestano, con l’affermata egemonia dei gruppi economicamente e socialmente più forti, una
chiara ideologia aristocratica. Lo sfarzo anche funerario, nelle società primitive come, del
resto, in ogni società, si ricollega infatti all’affermazione di una gerarchia sociale e di una
distinzione di ruoli legata alla ricchezza.
Romolo e le origini di Roma
Nella proemio della sua “Storia” Livio afferma che desidera ritornare allo studio del passato
per poter allontanare lo sguardo dalla corruzione moderna. Accetta il declino morale della
società romana come una legge ineluttabile: l’impero romano soffre ormai per la sua stessa
grandezza, ed è, pertanto, una magra consolazione dover constatare che tale declino sia giunto
tardi ed in minore entità rispetto ad altri popoli. Sulla base di questo pessimistico pensiero, è
necessario rivolgersi al passato per poter recuperare gli antichi valori. Nel raccontare gli
avvenimenti storici, si rende conto che le antiche leggende sono idonee ai racconti poetici
piuttosto che ad un’opera storica, ma ciò non costituisce per lui alcun ostacolo nella
narrazione, poiché non gli interessa la critica storica, bensì la sostanza morale che tali
leggende tramandano e sono in grado di esprimere.
Dal I capitolo del Libro I incomincia la storia. Si tratta di una storia ovviamente mitica, perché
le origini di Roma si fanno risalire ad Enea e alla guerra di Troia.
Enea era stato lasciato uscire da Troia perché gli Achei avevano tenuto conto, in primo luogo,
di un antico vincolo di ospitalità e, in secondo luogo, del fatto che era sempre stato fautore
della pace e della restituzione di Elena.
Esule dalla patria, Enea arrivò in un primo tempo in Macedonia, quindi fu spinto verso la
Sicilia, sempre alla ricerca di una sede definitiva, e dalla Sicilia approdò con la flotta nel
territorio di Laurento, sulla costa vicino Roma.
Privi com’erano, dopo il loro interminabile peregrinare, di tutto tranne che di armi e di navi, i
Troiani si misero a fare razzie nelle campagne. Per questo motivo il re Latino e gli Aborigeni,
che allora regnavano su quelle terre, accorsero armati dalle città e dai campi per respingere
l’attacco degli stranieri. Del fatto si tramandano due versioni. Alcuni sostengono che Latino fu
vinto in battaglia dai Troiani. Altri, invece, raccontano che Latino incontrò Enea, quindi si
informò sulla loro provenienza, e chiese da dove o a seguito di quale evento fossero partiti dal
loro paese e cosa stessero cercando nel territorio di Laurento. Venne così a sapere che tutti
quegli uomini erano Troiani, con a capo Enea, esuli da una città finita nelle fiamme, e alla
ricerca di una sede stabile per fondarvi la loro città. Quindi, pieno di ammirazione per la
nobiltà d’animo di quel popolo e dell’uomo di fronte a lui, e per la loro disposizione tanto alla
guerra che alla pace, gli tese la mano destra e si impegnò per un’amicizia futura tra i due
popoli. Enea fu ospitato presso Latino. Lì questi aggiunse un patto privato a quello pubblico,
dando in moglie ad Enea sua figlia. I Troiani fondarono una città, che Enea chiamò Lavinio,
dal nome della moglie.
In seguito, Aborigeni e Troiani dovettero affrontare insieme una guerra. Il re dei Rutuli,
Turno, cui era stata promessa in sposa Lavinia prima dell’arrivo di Enea, poiché non accettava
di buon grado che lo straniero gli fosse stato preferito, entrò in guerra contemporaneamente
con Enea e con Latino. Turno e i Rutuli ricorsero alle floride risorse degli Etruschi e del loro
re Mesenzio, signore dell’allora ricca città di Cere. Enea, terrorizzato di fronte a una simile
guerra, per accattivarsi il favore degli Aborigeni e perché tutti risultassero uniti non solo sotto
6
la stessa autorità, ma anche sotto lo stesso nome, chiamò Latini l’uno e l’altro popolo. Nella
battaglia Enea vinse, ma perse la vita.
Ascanio, il figlio di Enea, non era ancora maturo per comandare; allora lo Stato latino e il
regno che il ragazzo aveva ereditato dal padre e dagli avi gli vennero conservati sotto la tutela
della madre (tali erano in Lavinia le qualità caratteriali). Dal momento che la popolazione di
Lavinio era in eccesso, Ascanio lasciò alla madre la città ricca e fiorente, e per conto suo ne
fondò sotto il monte Albano una nuova, che, dalla sua posizione allungata nel senso della
dorsale montana, fu chiamata Alba Longa. Tra i suoi successori, Silvio Latino fondò alcune
colonie, che furono chiamate dei Latini Prischi.
Si arriva così a Numitore e Amulio, ultimi discendenti di Ascanio. Numitore, che era il più
grande, ebbe in eredità l’antico regno. Ma Amulio, dopo aver estromesso il fratello, salì al
trono, commettendo un crimine dietro l’altro: fece uccidere i figli maschi del fratello, mentre a
Rea Silvia, la femmina, avendola nominata Vestale (cosa che egli fece passare come
un’onorificenza), tolse la speranza di diventare madre, condannandola a una verginità
perpetua.
Rea Silvia, vittima di uno stupro, diede alla luce due gemelli. Sia che fosse in buona fede, sia
che intendesse rendere meno turpe la propria colpa attribuendone la responsabilità a un dio,
dichiarò Marte padre della prole sospetta. Ma né gli dèi né gli uomini riuscirono a sottrarre lei
e i figli alla crudeltà del re: questi diede ordine di arrestare e incatenare la sacerdotessa e di
buttare i due neonati nella corrente del fiume. Per una qualche fortuita volontà divina, il
Tevere, straripato in masse d’acqua stagnante, non era praticabile in nessun punto del suo
letto normale, ma a chi li portava faceva sperare che i due neonati venissero ugualmente
sommersi dall’acqua, nonostante questa fosse poco impetuosa. Così, nella convinzione di aver
eseguito l’ordine del re, esposero i bambini nel punto più vicino dello straripamento, là dove
ora c’è il fico Ruminale. Una lupa assetata deviò la sua corsa in direzione del loro vagito e offrì
loro il suo latte con una tale dolcezza che il pastore-capo del gregge reale – pare si chiamasse
Faustolo – la trovò intenta a leccare i due neonati. Faustolo, poi, tornato alle stalle, li diede
alla moglie Larenzia affinché li allevasse. C’è anche chi crede che questa Larenzia i pastori la
chiamassero lupa perché si prostituiva: da ciò lo spunto di questo racconto prodigioso.
Così nati e cresciuti, non appena divennero grandi, cominciarono ad andare a caccia in giro
per i boschi, senza rammollirsi nelle stalle e dietro il gregge. Irrobustitisi così nel corpo e nello
spirito, non affrontavano soltanto più le bestie feroci, ma assalivano i banditi carichi di
bottino: dividevano tra i pastori il frutto delle rapine e condividevano con loro svaghi e lavoro.
Si dice che, già allora, sul Palatino si celebrasse il Lupercale, e che il monte fosse chiamato
Palatino (da Pallanteo, città dell’Arcadia). Là pare che vi fosse l’usanza che dei giovani
corressero nudi. Mentre erano intenti a questo spettacolo, – dato che la ricorrenza era ben
nota – si dice che i banditi, per la rabbia di aver perso il bottino, organizzarono un’imboscata.
Romolo si difese energicamente. Remo, invece, lo catturarono e lo consegnarono al re Amulio,
accusandolo di aver compiuto delle incursioni nelle terre di Numitore. Per questi motivi Remo
venne consegnato a Numitore, perché lo punisse.
Già sin dall’inizio, Faustolo aveva supposto che i bambini allevati in casa sua fossero di sangue
reale: infatti, sapeva che dei neonati erano stati abbandonati per volere del re e anche che il
periodo in cui li aveva presi con sé coincideva con quel fatto. Però, non aveva voluto che la
cosa si venisse a sapere quando ancora non era il momento giusto, a meno che non si fossero
presentate l’occasione propizia o una necessità urgente. Fu quest’ultima ipotesi a verificarsi
per prima: spinto dalla paura, rivelò la cosa a Romolo. Così venne architettato un complotto ai
danni del re. Per caso anche Numitore, mentre teneva prigioniero Remo e aveva saputo che
erano fratelli gemelli, considerando la loro età e il carattere per niente servile, era stato
toccato nell’intimo dal ricordo dei nipoti.
7
Numitore, convocata subito l’assemblea, rivelò i delitti commessi dal fratello nei suoi
confronti, la nobile origine dei nipoti, la loro nascita, il modo in cui erano stati allevati, il
sistema con cui erano stati riconosciuti, e, infine, l’uccisione del tiranno Amulio ad opera di
Romolo e dei suoi, della quale dichiarò di assumersi l’intera responsabilità. Dopo che i giovani,
entrati con le loro truppe nel mezzo dell’assemblea, ebbero acclamato re il nonno, l’intera
folla, con un grido unanime, confermò al re il titolo legittimo e l’autorità. Così, affidata Alba a
Numitore, Romolo e Remo furono presi dal desiderio di fondare una città in quei luoghi in cui
erano stati esposti e allevati. Siccome erano gemelli e il rispetto per la primogenitura non
poteva funzionare come criterio elettivo, toccava agli dèi, che proteggevano quei luoghi,
indicare, attraverso gli auspici, chi avessero scelto per dare il nome alla nuova città e chi vi
dovesse regnare dopo la fondazione. Così, per interpretare i segni augurali, Romolo scelse il
Palatino e Remo l’Aventino.
Il primo presagio, sei avvoltoi, si dice toccò a Remo. Dal momento che a Romolo ne erano
apparsi il doppio quando ormai il presagio era stato annunciato, i rispettivi gruppi avevano
proclamato re l’uno e l’altro contemporaneamente. Gli uni sostenevano di aver diritto al
potere in base alla priorità del tempo, gli altri in base al numero degli uccelli visti. Ne nacque
una discussione e, dal rabbioso scontro a parole, si passò al sangue: Remo, colpito nella
mischia cadde a terra. E’ più nota la versione secondo la quale Remo, per prendere in giro il
fratello, avrebbe scavalcato le mura appena erette e quindi Romolo, al colmo dell’ira, l’avrebbe
ammazzato aggiungendo queste parole di sfida: “Così, d’ora in poi, possa morire chiunque osi
scavalcare le mie mura”. In questo modo Romolo si impossessò da solo del potere e la città
appena fondata prese il nome del suo fondatore.
In primo luogo Romolo fortificò il Palatino e offrì sacrifici in onore degli altri dèi, secondo il
rito albano e secondo quello greco in onore di Ercole. Stando alla leggenda, proprio in questi
luoghi, Ercole con i suoi splendidi buoi, perché questi riprendessero fiato e pascolassero nella
quiete del verde e per riposarsi anche lui stremato dal cammino, si coricò in un prato vicino al
Tevere. Appesantito dal vino e dal cibo, si addormentò profondamente. Un pastore della zona,
un certo Caco, contando sulle proprie forze e colpito dalla bellezza dei buoi, pensò di portarsi
via quella preda. Ma, dato che spingendo l’armento nella sua grotta le orme avrebbero
condotto il padrone quando si fosse messo a cercarle, prese i buoi più belli per la coda e li
trascinò all’indietro nella sua grotta. Al sorgere del sole, Ercole, emerso dal sonno, dopo aver
esaminato attentamente il gregge ed essersi accorto che ne mancava una parte, si incamminò
verso la grotta più vicina, caso mai le orme portassero in quella direzione. Quando vide che
erano tutte rivolte verso l’esterno ed escludevano ogni altra direzione, cominciò a spingere
l’armento lontano da quel luogo ostile. Ma, poiché alcune tra quelle messe in movimento si
misero a muggire, come succede, per rimpianto di quelle rimaste indietro, il verso
proveniente dalle altre rimaste chiuse dentro la grotta fece girare Ercole. Caco cercò di
impedirgli con la forza l’ingresso nella grotta, ma, mentre tentava invano di far intervenire gli
altri pastori, stramazzò al suolo schiantato da un colpo di clava.
In quel tempo governava la zona Evandro, che, attirato dalla folla di pastori accorsi sbigottiti
intorno allo straniero colto in flagrante omicidio, dopo aver ascoltato il racconto del delitto e
delle sue cause, osservando attentamente le fattezze e la corporatura dell’individuo, più
maestose e imponenti del normale, gli domandò chi fosse. Quando venne a sapere il nome, chi
era suo padre e da dove veniva, disse: “Salute a te, Ercole, figlio di Giove. Mia madre,
interprete veritiera degli dèi, mi ha vaticinato che tu andrai ad accrescere il numero degli
immortali e qui ti verrà dedicato un altere che un giorno il popolo più potente della terra
chiamerà Altare Massimo e venererà secondo il tuo rito”.
Sistemata la sfera del divino in maniera conforme alle usanze religiose e convocato in
assemblea il popolo, poiché nulla, salvo il vincolo giuridico, poteva unire nel complesso di un
solo popolo, Romolo diede loro un sistema di leggi. Pensando che esso sarebbe stato
8
inviolabile per quei rozzi villici solo a patto di rendere se stesso degno di venerazione per i
segni distintivi dell'autorità, diventò più maestoso sia nel resto della persona sia soprattutto
grazie ai dodici littori di cui si circondò.
I dodici littori (img. pag. 22) erano delle guardie di cui il re e il magistrato si contornavano. Il
dittatore, invece, ne aveva, dato il suo imperium superiore, ventiquattro. Queste guardie
portavano i c.d. fasci littori (img. pag. 21 e 23), ossia delle fasce legate con una scure. Si tratta
di un simbolo etrusco.
Alcuni ritengono che Romolo adottò il numero di littori in base a quello degli uccelli che, col
loro augurio, gli avevano pronosticato il regno. Probabilmente furono importati dalla
confinante Etruria (donde furono introdotte la sedia curule e la toga pretesta) tanto questo
tipo di subalterni quanto il loro stesso numero. In Etruria infatti, una volta eletto il re
dall'insieme dei dodici popoli, ciascuno di essi forniva un littore a testa. La sella curule (img.
pag. 24) era un simbolo del potere. La toga pretesta si metteva a sedici anni ed era una toga
bordata di porpora.
Nel frattempo la città cresceva in fortificazioni che abbracciavano dentro la loro cerchia
sempre nuovi spazi. Le prime vere e proprie mura, in realtà, saranno costruite soltanto nel IV
secolo; in ogni caso, Romolo deve aver fatto delle mura attorno al Palatino. In seguito, perché
l'ampliamento della città non fosse fine a se stesso, creò un punto di raccolta là dove oggi c'è
un recinto tra due boschi. Lì, dalle popolazioni confinanti, andò a riparare una massa
eterogenea di individui – nessuna distinzione tra liberi e schiavi – avida di cose nuove: e
questo fu il primo energico passo in direzione del progetto di ampliamento. Ormai soddisfatto
di tali forze, provvide a dotarli di un'assemblea (il Senato). Elesse poi cento senatori, sia
perché questo numero era sufficiente, sia perché erano soltanto cento quelli che potevano
ambire a una carica del genere. In ogni caso, quest'onore gli valse il titolo di padri, mentre i
loro discendenti furono chiamati patrizi.
Roma era ormai così potente che poteva permettersi di competere militarmente con
qualunque popolo dei dintorni. Ma per la penuria di donne questa grandezza era destinata a
durare una sola generazione, perché essi non potevano sperare di avere figli in patria né di
sposarsi con donne della zona. Allora, su consiglio dei senatori, Romolo inviò ambasciatori alle
genti limitrofe per stipulare un trattato di alleanza col nuovo popolo e per favorire la
celebrazione di matrimoni. Essi dissero che anche le città, come il resto delle cose, nascono dal
nulla; in seguito, grazie al loro valore e all'assistenza degli dèi, acquistano grande potenza e
grande fama. Era un fatto assodato che alla nascita di Roma erano stati propizi gli dèi e che il
valore non le sarebbe venuto a mancare. Per questo, in un rapporto da uomo a uomo, non
dovevano disdegnare di mescolare il sangue e la stirpe. All'ambasceria non dette ascolto
nessuno: tanto da una parte provavano un aperto disprezzo, quanto dall'altra temevano per
sé e per i propri successori la crescita in mezzo a loro di una simile potenza. Nell'atto di
congedarli, la maggior parte dei popoli consultati chiedeva con sfregio se non avessero aperto
anche per le donne un qualche luogo di rifugio (quella infatti sarebbe stata una forma di
matrimonio alla pari). La gioventù romana non la prese di buon grado e la cosa cominciò a
scivolare inevitabilmente verso la soluzione di forza. Per conferire a essa tempi e luoghi
appropriati, Romolo, dissimulando il proprio risentimento, allestì apposta dei giochi solenni
in onore di Nettuno Equestre e li chiamò Consualia. Quindi ordinò di invitare allo spettacolo i
popoli vicini. Per caricarli di interesse e attese, i giochi vennero pubblicizzati con tutti i mezzi
disponibili all'epoca. Arrivò moltissima gente, anche per il desiderio di vedere la nuova città, e
soprattutto chi abitava più vicino, cioè Ceninensi, Crustumini e Antemnati. I Sabini, poi,
vennero al completo, con tanto di figli e consorti. Invitati ospitalmente nelle case, dopo aver
visto la posizione della città, le mura fortificate e la grande quantità di abitazioni, si
meravigliarono della rapidità con cui Roma era cresciuta. Quando arrivò il momento previsto
per lo spettacolo e tutti erano concentratissimi sui giochi, allora, come convenuto, scoppiò un
9