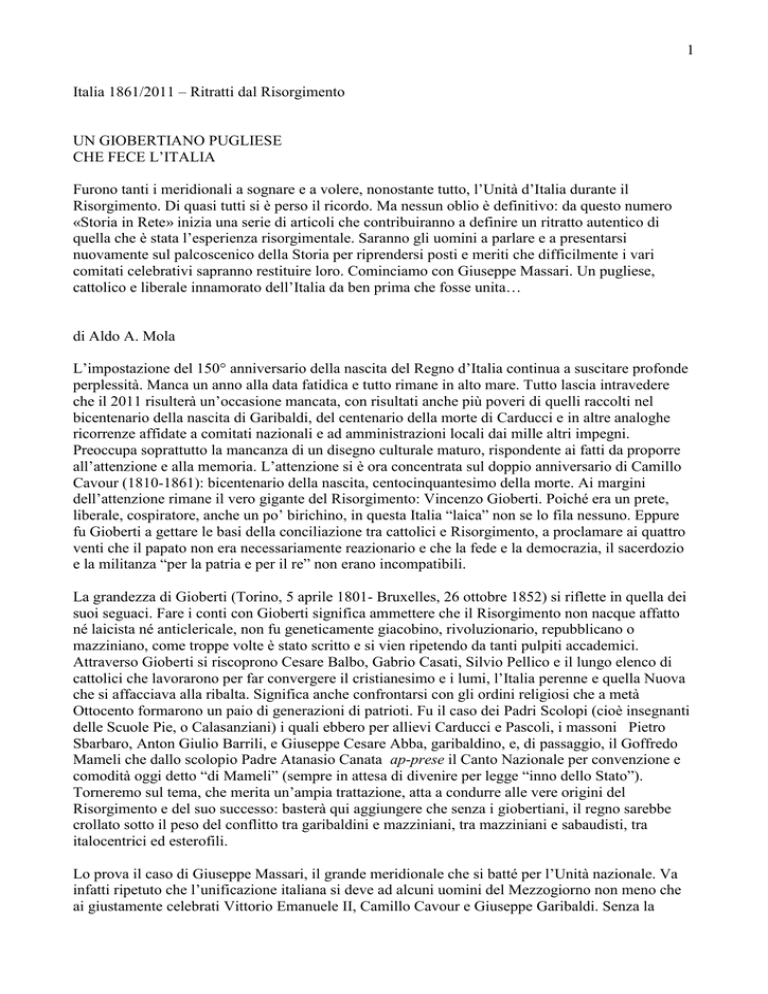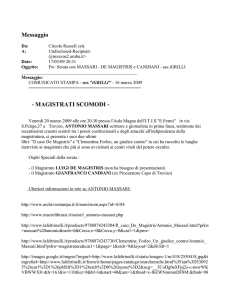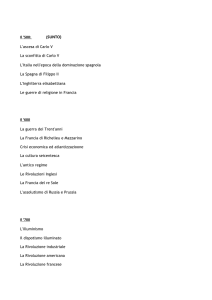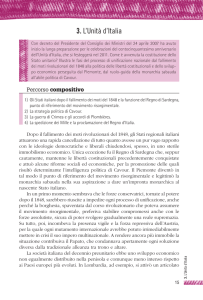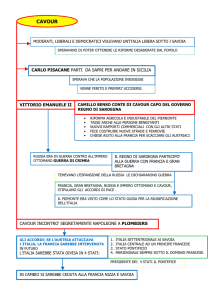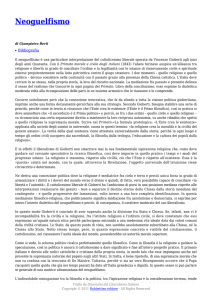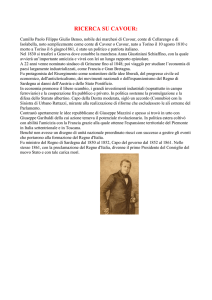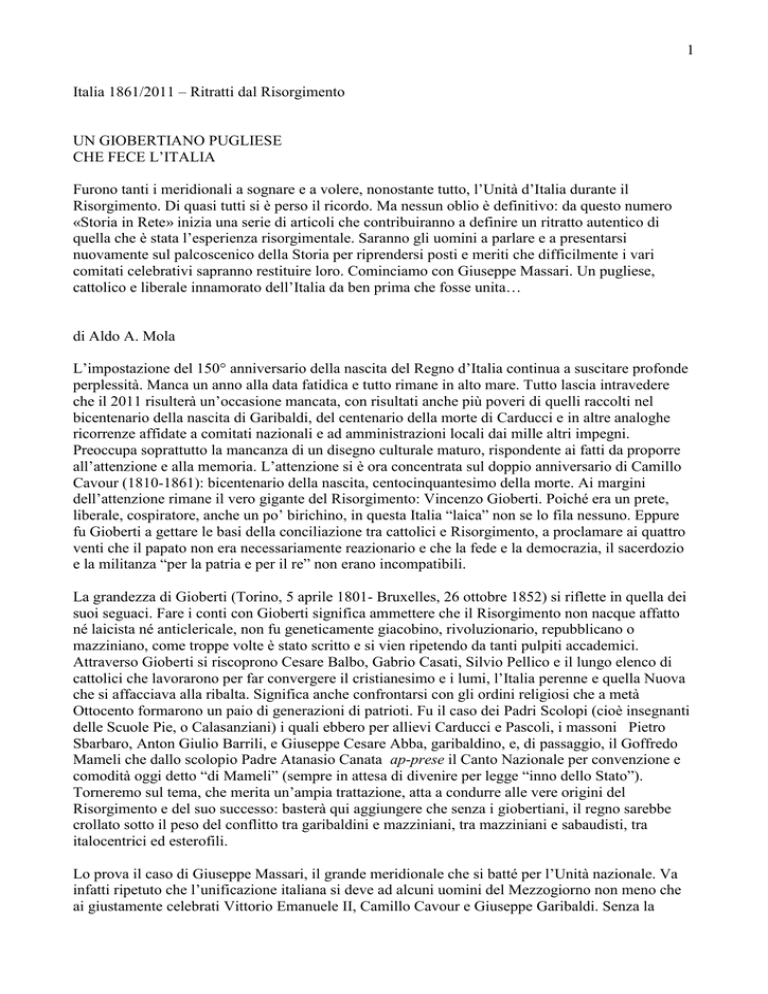
1
Italia 1861/2011 – Ritratti dal Risorgimento
UN GIOBERTIANO PUGLIESE
CHE FECE L’ITALIA
Furono tanti i meridionali a sognare e a volere, nonostante tutto, l’Unità d’Italia durante il
Risorgimento. Di quasi tutti si è perso il ricordo. Ma nessun oblio è definitivo: da questo numero
«Storia in Rete» inizia una serie di articoli che contribuiranno a definire un ritratto autentico di
quella che è stata l’esperienza risorgimentale. Saranno gli uomini a parlare e a presentarsi
nuovamente sul palcoscenico della Storia per riprendersi posti e meriti che difficilmente i vari
comitati celebrativi sapranno restituire loro. Cominciamo con Giuseppe Massari. Un pugliese,
cattolico e liberale innamorato dell’Italia da ben prima che fosse unita…
di Aldo A. Mola
L’impostazione del 150° anniversario della nascita del Regno d’Italia continua a suscitare profonde
perplessità. Manca un anno alla data fatidica e tutto rimane in alto mare. Tutto lascia intravedere
che il 2011 risulterà un’occasione mancata, con risultati anche più poveri di quelli raccolti nel
bicentenario della nascita di Garibaldi, del centenario della morte di Carducci e in altre analoghe
ricorrenze affidate a comitati nazionali e ad amministrazioni locali dai mille altri impegni.
Preoccupa soprattutto la mancanza di un disegno culturale maturo, rispondente ai fatti da proporre
all’attenzione e alla memoria. L’attenzione si è ora concentrata sul doppio anniversario di Camillo
Cavour (1810-1861): bicentenario della nascita, centocinquantesimo della morte. Ai margini
dell’attenzione rimane il vero gigante del Risorgimento: Vincenzo Gioberti. Poiché era un prete,
liberale, cospiratore, anche un po’ birichino, in questa Italia “laica” non se lo fila nessuno. Eppure
fu Gioberti a gettare le basi della conciliazione tra cattolici e Risorgimento, a proclamare ai quattro
venti che il papato non era necessariamente reazionario e che la fede e la democrazia, il sacerdozio
e la militanza “per la patria e per il re” non erano incompatibili.
La grandezza di Gioberti (Torino, 5 aprile 1801- Bruxelles, 26 ottobre 1852) si riflette in quella dei
suoi seguaci. Fare i conti con Gioberti significa ammettere che il Risorgimento non nacque affatto
né laicista né anticlericale, non fu geneticamente giacobino, rivoluzionario, repubblicano o
mazziniano, come troppe volte è stato scritto e si vien ripetendo da tanti pulpiti accademici.
Attraverso Gioberti si riscoprono Cesare Balbo, Gabrio Casati, Silvio Pellico e il lungo elenco di
cattolici che lavorarono per far convergere il cristianesimo e i lumi, l’Italia perenne e quella Nuova
che si affacciava alla ribalta. Significa anche confrontarsi con gli ordini religiosi che a metà
Ottocento formarono un paio di generazioni di patrioti. Fu il caso dei Padri Scolopi (cioè insegnanti
delle Scuole Pie, o Calasanziani) i quali ebbero per allievi Carducci e Pascoli, i massoni Pietro
Sbarbaro, Anton Giulio Barrili, e Giuseppe Cesare Abba, garibaldino, e, di passaggio, il Goffredo
Mameli che dallo scolopio Padre Atanasio Canata ap-prese il Canto Nazionale per convenzione e
comodità oggi detto “di Mameli” (sempre in attesa di divenire per legge “inno dello Stato”).
Torneremo sul tema, che merita un’ampia trattazione, atta a condurre alle vere origini del
Risorgimento e del suo successo: basterà qui aggiungere che senza i giobertiani, il regno sarebbe
crollato sotto il peso del conflitto tra garibaldini e mazziniani, tra mazziniani e sabaudisti, tra
italocentrici ed esterofili.
Lo prova il caso di Giuseppe Massari, il grande meridionale che si batté per l’Unità nazionale. Va
infatti ripetuto che l’unificazione italiana si deve ad alcuni uomini del Mezzogiorno non meno che
ai giustamente celebrati Vittorio Emanuele II, Camillo Cavour e Giuseppe Garibaldi. Senza la
2
Società Nazionale il Gran Conte si sarebbe fermato poco a sud del Po, come del resto era nei piani
da lui concordati con Napoleone III a Plombières (luglio 1858). I registi della rete cospirativa
furono il veneziano Daniele Manin, il milanese Giorgio Pallavicino Trivulzio e l’infaticabile
factotum, il messinese Giuseppe La Farina, che Cavour soleva ricevere da un ingresso secondario
alle cinque di mattina. Se il siciliano Francesco Crispi non si fosse fatto telegrafare che,
contrariamente al vero, gl’insorti liberali in Sicilia stavano vincendo, il 5 maggio 1860 Garibaldi
non sarebbe affatto salpato da Quarto. Niente “spedizione dei Mille”. Niente unità d’Italia. La
nascita del regno d’Italia corse sul filo dell’azzardo: che non è un gioco, ma un’arte; e richiede
secoli di apprendistato. Solo dopo lunga preparazione si mette a segno il colpo da maestro. La
semplificazione didattica ridusse il labirintico percorso dell’Italia verso l’unità all’iniziativa di
una manciata di primi attori. Così essa generò il semplicismo che conduce a gridare al “miracolo”
e svuota il processo storico della sua autenticità. Per comprendere la moralità dell’unificazione
nazionale occorre recuperarne la complessità e spostare i fari su figure collocate dalla manualistica
in seconda o terza fila o addirittura cancellate dalla memoria, anche se furono protagonisti di valore
assoluto. Alcune di esse, e di primissimo piano, furono pugliesi. A conferma basta scorrere il
repertorio dei deputati eletti alla Camera nazionale il 25 gennaio 1861, la prima del Regno d’Italia,
la IX del Parlamento istituito dallo Statuto promulgato il 4 marzo 1848 da Carlo Alberto nel Regno
di Sardegna. E’ il caso di Giuseppe Libertini, Cesare Braico, Giacomo Lacaita, Bonaventura
Mazzarella, Camillo Caracciolo di Bella, Luigi Minervini, Giovanni Vacca, Luigi Zuppetta...
ciascuno dei quali merita una biografia aggiornata. Accanto a esponenti del liberalismo non esente
da inflessioni anticlericali non mancarono gli ecclesiastici: l’arciprete Antonio Miele, eletto a
Lacedonia, e don Flaminio Valenti, deputato dal collegio di Monopoli: a conferma della coralità
dell’approdo all’unità nazionale.
Tra i molti, Giuseppe Massari merita di essere collocato a fianco degli artefici supremi
dell’unificazione nazionale. Senza di lui Risorgimento e avvento dell’unità si sarebbero ridotti a
prassi burocratica. Da meridionale ci mise invece una filosofia della storia elaborata nel corso di un
trentennio. Formato alla scuola dell’abate Monticelli nel seminario di Avellino, forse aderente alla
“Giovane Italia” di Benedetto Musolino, Luigi Settembrini e Nicola Nisco, a diciassette anni
Massari venne mandato in Francia dal padre, che intese sottrarlo alle pericolose tentazioni del
settarismo politico quando queste comportavano il patibolo. Vi entrò in dimestichezza con il
generale Guglielmo Pepe, l’uomo del moto liberal-costituzionale del 1820-21. Di amicizia in
amicizia entrò in corrispondenza con l’abate Vincenzo Gioberti, prima che questi pubblicasse il
“Primato” e le altre opere, prolisse e decisive per la legittimazione dell’idea d’Italia. Gioberti
riprese il cammino là dove erano giunti i napoletani Vincenzo Cuoco, autore del “Platone in Italia”,
e Pietro Colletta, il generale e storico che vegliò sui giorni dolenti di Giacomo Leopardi. Da Parigi
passato a Torino, Massari pubblicò quanto Gioberti dall’estero aveva difficoltà a farvi giungere.
Fallito un viaggio a Milano (la polizia asburgica era allenata a fiutare il nemico), nel 1846, quando
ancora il regno di Sardegna non poteva scoprire troppo il gioco, Massari assunse la direzione del
“Mondo Illustrato”, un faro per l’aristocrazia liberale e la borghesia delle professioni. Insegnò a
pensare in europeo, e non solo.
Il 15 aprile 1848 Massari fu eletto a Bari deputato all’Assemblea del regno delle Due Sicilie. Erano
settimane di grazia durante le quali Ferdinando II di Borbone concesse la Costituzione, inviò
un’armata a sostegno del Regno di Sardegna contro l’Impero asburgico e l’Italia era percorsa da
entusiasmi. Egli le visse a Milano, ove incontrò Gioberti, che accompagnò in una lunga
peregrinazione nell’Italia centrale. Ne condivise senza riserve il progetto di Federazione italiana.
Non era l’Italia indipendente, libera e una vagheggiata da Mazzini, ma molto più di quanto
all’epoca si proponessero Cavour e la cerchia del “Risorgimento”. Massari partecipò all’apertura
dell’Assemblea napoletana (30 giugno 1848) e a suoi accesi dibattiti. Nuovamente a Napoli nel
febbraio 1849, vigilia della seconda tragica fase della guerra austro-piemontese chiusa con la
3
sconfitta di Novara, scampò di misura all’arresto dei liberali meridionali, scattati a fine aprile 1849
quando Ferdinando II ebbe la certezza di poter arretrare a piacere le lancette della storia. Con la
tempestività di chi sapeva unire giudizio storico e proposta politica, pubblicò sul tamburo “I casi di
Napoli dal principio del 1848 al novembre 1849”, denuncia veridica del carattere intrinsecamente e
irrimediabilmente reazionario della monarchia borbonica. Due anni dopo tradusse l’opera destinata
a far da spartiacque: “Il signor Gladstone e il governo napoletano”, sintetizzato con la celebre
formula che bollò il governo borbonico come “negazione di Dio”. Cavour, che non aveva mai
nutrito simpatia per Gioberti e i giobertiani, colse la generosità di quel meridionale che rivendicava
la figura di Carlo Alberto e confermava che le fortune degli italiani erano riposte nell’iniziativa di
Casa Savoia. La vendetta borbonica non tardò. Nel 1852 la Gran Corte di Napoli lo condannò al
patibolo, pena commutata in venticinque anni di carcere duro, per il ruolo svolto nella camera dei
deputati. Nel 1856 Cavour affidò a Massari la direzione della “Gazzetta Ufficiale” del Regno di
Sardegna, che faceva da timone per l’ “opinione nazionale”, di concerto con la Società Nazionale
orchestrata dal siciliano Giuseppe La Farina.
L’annessione del regno delle Due Sicilie alla corona di Vittorio Emanuele II di Savoia, “re
costituzionale”, fu un trauma. Segnò la debellatio di uno Stato, ma non comportò l’avvento di uno
Stato nuovo. La consacrazione della monarchia unitaria venne celebrata da politici formati nello
studio della filosofia della storia. La loro impresa era più impegnativa delle vittorie dei
garibaldini al sud e dei piemontesi contro i papalini. Essi insegnarono che l’Italia non nasceva
dalla conquista militare o da intrighi diplomatici completi di imprese d’alcova ma da una storia
millenaria. Su quella trincea operò Giuseppe Massari, fedele a Cavour e alla monarchia e mai
dimentico del suo maestro Gioberti. Il 25 gennaio 1861 gli elettori di Bari lo vollero deputato.
Massari era ormai tra i massimi esponenti della Destra storica: apprezzato segretario delle Camera,
custode delle memorie del Risorgimento e autore di opere documentate e di alto sentire, dalla
Sinistra anticlericale era però considerato l’uomo da abbattere. Nel gennaio 1877 rimase
soccombente nel collegio di Bari, ancora in ballottaggio, a vantaggio di Giovanni Diana. Vi fu
rieletto un’ultima volta il 23 maggio 1880, ma optò per il collegio di Spoleto. Il seggio rimasto
vacante venne conquistato dal generale Bernardino Milon, ministro della Guerra, siciliano.
Tra le sue opere rimangono memorabili i “Ricordi biografici del conte di Cavour”, “La vita e il
regno di Vittorio Emanuele II” e un generoso profilo di Alfonso La Marmora. Massari le scrisse
intingendo il pennino nel calamaio del rimpianto di ciò che poteva essere e non fu. Gioberti era
morto quando le piaghe della sconfitta del regno di Sardegna erano ancora aperte. Lo seguirono
oltretomba tanti cattolici liberali e liberali cattolici. Cesare Balbo e Silvio Pellico e un centinaio di
“moderati” scomparsi nel quinquennio tra il 1854 e il 1859: una perdita irreparabile per l’Italia
nascente. Malgrado tutto, quando Massari morì (a Roma il 13 marzo 1884) gran parte del disegno
cui s’era votato settant’anni prima nel seminario di Avellino era giunta a compimento: il diritto di
voto era stato esteso a tre milioni di maschi adulti, era in corso di pubblicazione l’inchiesta sulle
condizioni delle classi agrarie, con la Triplice Alleanza l’Italia aveva aggiunto un bastione
diplomatico sul debolissimo confine con l’Impero d’Austria-Ungheria e contava sull’amicizia
schietta della Germania, mentre la Gran Bretagna ne chiedeva il concorso Oltremare. L’Italia
sognata da Massari non era solo un castello di leggi e decreti, di pratiche amministrative e di non
sempre facili rapporti fra istituzioni e cittadini. Dall’indomani dell’unificazione Massari aveva
guardato oltre l’approdo politico-militare, le annessioni, i plebisciti. Affrontò la questione
meridionale. Esortò a giocare la carta del decentramento, delle autonomie locali, del rispetto delle
tradizioni, contro la scorciatoia dello Stato centralistico, venato di giacobinismo. Avvertì per tempo
che il diffuso malcontento serpeggiante nel Mezzogiorno si sarebbe rovesciato contro il nuovo
ordine ancor più di quanto aveva potuto fare contro i Borbone. Espose alla Camera le sue
appassionate ricerche nella relazione su “Il brigantaggio e le province meridionali”.
4
In un’Italia che si stava lacerando (Aspromonte, Mentana, la tassa sulla macinazione delle farine, un
anticlericalismo d’importazione quale paravento per far cassa con la statizzazione e la vendita dei
beni ecclesiastici...) il 9 giugno 1866 Massari parlò alto e solenne alla Camera per chiedere “a nome
delle lettere, a nome della civiltà, a nome dell’Italia” di rispettare almeno l’Abbazia di
Montecassino. La Terza Italia era liberale perché colta: assecondò il monito di Massari. La sua
straordinaria personalità è consegnata alle pagine del suo “Diario delle cento voci”, una formula di
Adolfo Omodeo. La storia è successione di punti nei quali una sola tra le infinite possibilità diviene
realtà. Non è una linea, men che meno retta o addirittura ascensionale. Sono tanti puntini. Da
recuperare con pazienza...
Aldo A. Mola