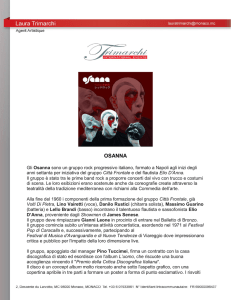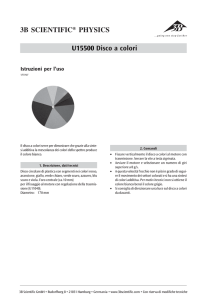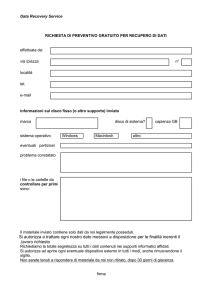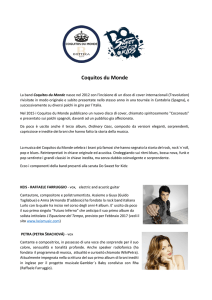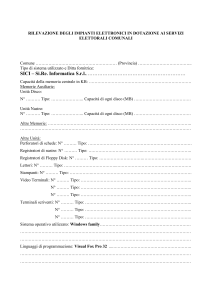digital magazine Luglio/agosto 2009
N.57/58
Mondo Nostalgia
le sette vite dell’exotica
ariel pink's
haunted graffiti
Toddla T - Antimagic - Bibio
Pupkulies&Rebecca - Miranda - Naomi Shelton
Anthony Buck - Fourm - Frigieri - Duo Alterno
hexlove
l’attimo della creazione
The Vaselines - Luigi Russolo
Transposonic
Primavera Sound 2009
Sentireascoltare n.57/58
Turn On
p. 4
Toddla T
5
Pupkulies & Rebecca
6
Antimagic
7
Bibio
10
Miranda
12
Naomi Shelton
14
Dark Night of the Soul
Rubriche
Tune In
126
Giant steps
12 Anthony Buck
127
Classic album
16
Giancarlo Frigieri
128
La sera della prima
20
FOURM
132
A night a the opera
26
Transposonic
134
I cosiddetti contemporanei
Drop Out
32
Mondo Nostalgia
38 Hexlove
46
Ariel Pink’s Haunted Graffiti
Recensioni
54
Bibio, Clark, Ghost, Graham Coxon, Moritz Von Oswald/Delay/Loderbauer
Rearview Mirror
106
The Vaselines, Russolo, Orbital...
Direttore: Edoardo Bridda
Ufficio Stampa: Teresa Greco
Staff: Gaspare Caliri, Nicolas Campagnari, Daniele Follero, Stefano Solventi, Antonello Comunale, Teresa Greco
Hanno
collaborato:
Leonardo Amico, Gianni Avella, Sara Bracco, Marco Braggion, Luca Collepiccolo,
Luca Colnaghi, Gabriele Marino, Francesca Marongiu, Andrea Napoli, Massimo Padalino, Giulio Pasquali,
Stefano Pifferi, Andrea Provinciali, Antonio Puglia, Costanza Salvi, Vincenzo Santarcangelo, Giancarlo Turra,
Fabrizio Zampighi.
Guida
spirituale:
Grafica
In
e
Adriano Trauber (1966-2004)
Impaginazione: Nicolas Campagnari
copertina:
hexlove
SentireAscoltare online music magazine
Registrazione Trib.BO N° 7590 del 28/10/05
Editore: Edoardo Bridda
Direttore responsabile: Antonello Comunale
Provider NGI S.p.A.
Copyright © 2009 Edoardo Bridda. Tutti i diritti riservati.La riproduzione totale o parziale, in qualsiasi forma, su qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo, è proibita senza
autorizzazione scritta di SentireAscoltare
Toddla T
Dancehall multietnico
Pupkulies & Rebecca
La nuova meteora del lazerstep da
Sheffield. Ancora ragga. Ancora in levare. E via.
L
a leggenda è questa: un giorno Roots Manuva
va a comprarsi un paio di trainers in un negozio qualsiasi di Sheffield e lì t’incontra uno strano
commesso. Il ragazzaccio gli propone un demo con
ritmi da inarcare il sopracciglio e dopo due giorni
i due hanno prodotto tre tracce che andranno direttamente nel primo long playing di lui, Skanky
Skanky, cioé la provincia fuori Londra imbevuta di
ricordi Northern Soul e, come al solito questa estate, dancehall. 4
/ Turn On
Tom Bell non è solo la new big thing
che esce dalla camera e prova lo stappo.
È qualcosa di più. Le connessioni con la
Giamaica dei 70, l’essenziale mesh-up a
base di M.I.A. e Missill, il background trita
wonky bass e strada, sono elementi di un
personaggio sunto del 09 brit.
Dopo la virata techno del dubstep e la
wonky in crogiolo sembra un momento
di godimento più che ti ricerca e di fatto
Tom gode proprio dell’equilibrio tra bass
culture e ritmi da party (banghrastep e
hip-hop, techno e fidgeting 90) e dell’indefinibile miscuglio di retrofuturismo e
lazer che si avvicina di brutto a Kingston
e ai vicoli di New York taggati dai Beastie
Boys.
Il suono basarà pur sempre sulle tastierine e sample del continuum ‘ardkore,
ma la particolarità è la continua mescolanza d’elementi alieni e non dimentichiamo che
Bell viene dalla Steel City (Cabaret Voltaire, Jarvis
Cocker, Human League e altri ‘innovators’).
Il curricula per lui s’è già mpennato - remix per
Roisín Murphy e Bashy e data al Fabric (assieme al
fido Skream) già fissate - e noi abbiamo quest’album: il perfetto compromesso per qualsiasi party.
Londra sta attenta, Sheffield bombarda ragga-bass... Marco Braggion
Dance Cabaret
Nell’affollata pista da ballo, un nome (semi) nuovo torna a farsi sentire. Ed è una sorpresa niente
male...
C
hissà che pensa Laurie Anderson dei figliocci
che metaforicamente ha messo al mondo tramite la sua fusione d’avanguardia umanista e respiro
pop. Fatto è che, da che la tecnologia divenne nei
’90 qualcosa di più accessibile, se ne sono sentite
di belle tra gli estremi di folkettari urbani e moderni cantautori, adoratori del silenzio e teorici del
glitch.
Tra gli indecisi se stare sulla pista da ballo o soggiornare nelle stanze più fresche dove ci si rilassa,
s’è infilata addirittura una frangia moderatamente
sperimentale, desiderosa di fare canzoni - folk o da
chanteuse, fa lo stesso: pensate ai Portishead - che
oggi vede un nuovo nome aggiungersi alla lista. Semi-nuovo, a dirla tutta, giacché i berlinesi Janosch
Blaul e Rebecca Gropp a.k.a. Pupkulies & Rebecca li
avevamo conosciuti nel 2007 con un album d’esordio sfocato ma capace di rivelare un certo talento.
Che perdeva di vista l’equilibrio tra un madrigale
modernista e l’altro, dunque davamo i Nostri per
archiviati, non fosse arrivato oggi Burning Boats
che, avvicinato con cautela, ha scompaginato a suo
modo le carte. Non sarà quel “disco lungamente atteso dal mondo della minimal house” che leggi in
giro, nondimeno spicca tra i dischi di settore (e non
solo…) con disinvoltura e fascino. Possiede la forza della tradizione alla base, sia che guardi al cuore
cyber-umano dei Kraftwerk o ipotizzi un non luogo
tra club intellettuale e cabaret anni ’20. Certo, una
sciantosa da locale notturno spargerebbe un po’ più
di sudore e lacrime di Rebecca, ma oggi suonerebbe
così. Lavorando di cesello strumentale e scalando
vette di gelo nello sforzo di emozionare, impiegando allo scopo un’interazione felice di corde e silicio,
contrabbassi e microchip.
è il tentativo che conta, perché alla fine il risultato giunge da solo e si chiama Paper, incanto di
violoncello e latinità sospesa - retaggio della fanciullezza di Janosch passata a Capo Verde - che cava, in
coda al disco nuovo, un prolungato brivido. Ritrovi
un’anima e la sua ricerca attraverso la canzone che
è il filo rosso di questi tempi odierni e confusi. Dice
però Blaul: Siamo lontanissimi dall’essere nerd musicali e nemmeno abbiamo radici in alcuna scena in
particolare. Non siamo obbligati a rientrare in canoni specifici, perciò la nostra musica va bene per
tutte le età.
Forse questa risoluzione nel farsi apprezzare da
tutti e nessuno può rappresentare un’incognita futura per la coppia. Facile non curarsene, alla luce di
un presente tutto da centellinare.
Giancarlo Turra
Turn On /
5
Bibio
Antimagic
Magic Powers
Rewarped folktronica
Da New York, l’ennesimo combo a metà tra dimensione arty e post-punk tribale e scurissimo. Dal giro
These Are Powers, un duo eclettico e dal suono personale
C
he New York sia una fucina in continua ebollizione è fuor di dubbio. La grande mela oltre a
non dormire mai non la smette neanche di produrre, da un trentennio buono, le musiche più rumorose e eccitanti del sottobosco americano. Riprova
ne è – se solo ce ne fosse bisogno – l’ennesimo
progetto collaterale scaturito da quell’ambiente in
perenne fermento in cui arte e musica si incontrano
e scontrano spesso e volentieri.
Antimagic nasce da una costola di These Are Powers, più esattamente da quello che era il batterista originario della band, Ted McGrath. Fuoriuscito
al termine delle sessions dell’esordio Terrific Seasons per proseguire la sua carriera di illustratore,
Ted forma Antimagic nel marzo del 2008 un po’ per
dare un nome alle sue sessioni private, un po’ per
quei casi fortuiti che possono accadere nell’intricato panorama art-musicale di NY. Cominciai a lavorare
da solo su una serie di canzoni scritte e registrate prima
di entrate nei TAP, armato solo di chitarre e drum machine… – ci racconta Ted – …Quando poi una coppia di
amici (Miracles e Lo Moda) mi invitarono a suonare uno
show alla Knitting Factory chiesi aiuto alla mia amica di
vecchia data Marcia Cahill.
La scintilla, si sarà capito, scatta subito. Le reazioni
positive pure. Così i due decidono di rinchiudersi
6
/ Turn On
in sala prove per dare una direzione più compiuta
alla collaborazione e forgiare il suono che oggi caratterizza Antimagic. Dapprima fissato nell’ep The
Sound Of Future Mold To Come, uscito sul finire dell’anno scorso; poi focalizzato nell’imminente full length Trash Symmetry. Un suono scarno negli arrangiamenti, teatrale nella vocalità della
Cahill, percussivamente spigoloso e piuttosto virato
al nero. Asimmetrico nonostante la simmetria delle
forze in ballo: due batterie, chitarra e basso, coi due
che si scambiano con facilità ruoli e strumenti. Giochetto che permette di toccare uno spettro sonoro
ampio e abbracciare un range di influenze piuttosto
vario: Questa formazione simmetrica – continua Ted
– ci da la possibilità di lavorare con un vasto spettro
di suoni e arrangiamenti sia nelle improvvisazioni che
nelle canzoni compiute. Ciò ci consente di continuare a
nutrire la nostra fascinazione per ritmo e ripetitività e di
connetterla con influenze più ampie come pre-war american gospel, i gruppi femminili e il doo-wop dei ’50/’60,
i Beach Boys più sperimentali, il Lee Perry più fuori, il
James Brown più aggressivo…. E, aggiungiamo noi, una
buona dose delle musiche targate NY degli ultimi
30 anni.
Stefano Pifferi
Il pargolo dei Boards of Canada riporta la folktronica in
casa Warp. Ed è di nuovo culto.
L
a folktronica di Bibio è un ripescaggio balearico
della happyness mista al melò da un po’ di tempo rispuntata pure sul versante electro house (vedi
Yacht e similia). Ma se là c’è il palco e la pantomima pop, qui si va di filtri che trasformano il suono in
un grande affresco sepia. Una fotografia ‘synthetica’
di un mondo che non c’è più e che oggi ricompare.
Sponsorizzato da Boards of Canada e da
Clark, il nostro si intrufola nella cricca Warp e,
dopo anni di indipendenza (3 album su Mush Records e qualche 12” a base di ambientronica registrata live), oggi si toglie lo sfizio di essere sulla bocca di tutte le electroheadz.
Stephen Wilkinson direttamente dalle West
Midlands, UK e la storia assomiglia a quella del buon
elettro gazer Nathan Fake, soltanto che al tempo avevamo un folletto in acido, e qui un secchione
delle scuole d’arte. Bibio è il nome di un moschino
usato come esca, quello che il ragazzo usava quando andava a pescare nei fiumi del Galles col papà e
che la sera guardava l’album di fotografie di famiglia
davanti al fuoco lasciandosi cullare dal crepitìo della
legna.
Tutto vero come la conferma di una proposta
che segue l’andazzo della seconda metà dell’anno:
un po’ stanchi di dubstep, di suoni cupi e speed,
l’etichetta di Sheffield pubblica nomi come Clark o
Grizzly Bear (ed evidentemente l’Ambivalence Avenue del buon Bibio) lasciandoci comprendere come certo surf-folk mescolato elettro sia una
possibilità concreta al sound di adesso.
Già l’avevamo capito grazie agli ibridi Werk Records: il ricordo è ancora una volta incarnato nelle
tracce un po’ nerdy e un po’ melanconiche, quasi a
sottolineare che la primavera è appena finita ed il
sampling preferito è pur sempre uguale a nostalgia.
Ovviamente non siamo diventati dei romanticoni:
il glitch è dietro l’angolo (come la techno dietro
a Fake) e pure in Bibio il tradimento è questione
d’istanti. Per ora l’ometto con la camicia a quadrettoni ci ricorda come si possa ancora fischiettare un
coro o scimmiottare nel backstage invece di farsi
solo di acidi. Chi se lo sarebbe aspettato dopo la
vampata neo-’ardkore? Attenzione: il contagio è
molto probabile. Il disco sembra una bagatella poppy, ma più lo ascolti più sale, col sorriso, direttamente in summer top 10.
Marco Braggion
Turn On /
7
Miranda
Elogio della circolarità
Cerchi che (non) si chiudono, quelli dei tre Miranda.
Al terzo disco lungo si completa quella metamorfosi
che, forse, era già accennata nei precedenti album.
P
ercorso ormai lungo e meritorio di attenzione, quello del trio fiorentino. Esordio nel lontano 2003
con Inside The Whale, culmine di almeno due o tre anni di prove sotterranee ed elaborazione
progettuale di un suono chitarristico mai banale; replica 3 anni dopo con l’ottimo concentrato di post(noise)-rock di Rectal Exploration a disegnare percorsi obliqui (e personali) a metà tra Louisville
e New York. Poi uno split-cd coi fantastici canadesi Creeping Nobodies in cui il senso malato del
8
/ Turn On
groove ben si sposa con ritmi (quasi) danzerecci
e vibranti sincopi basso/batteria. Ora quei tratti
ritornano in bella evidenza, anzi addirittura acuiti
nel nuovo Growing Heads Above The Roof,
rilasciato dall’etichetta di casa fromScratch proprio questo mese. Si lasciano in secondo piano le
chitarre e si procede di synth e samples, così che le
atmosfere si sfaldino ancor di più e i riferimenti più
prossimi si sfochino. Si aggiunge una drum machine alla batteria, così che ritmicamente il sound del
trio sia più acceso e insieme robotico e versatile.
Si asciugano ancora di più le strutture al fine di
lasciare spazio ad una matura essenzialità.
Il risultato è un’intrigante fusione di rock dissonante e pulsione ritmica primordiale. Fa muovere le
chiappe ma non perde nulla in potenza di fuoco; tritura il p-funk giocando di ossessività reiterata; aggira i cliché del genere iniettandovi pulsioni eterogenee non da poco, tanto che non è poi così assurdo
pensare ad un ibrido LCD Soundsystem meets
!!! suonato dagli Oneida in combutta coi Liars
del periodo di mezzo. La sensazione è quella – paradossale dato che si parla di circolarità groovey –
della quadratura di un cerchio che non sembra mai
tornare al punto di partenza. A questo proposito
abbiamo fatto due chiacchiere con Giuseppe Caputo, chitarrista nonché uno dei responsabili dietro
l’esperienza fromScratch.
Siamo giunti al termine di un percorso cominciato all’altezza di Rectal Exploration,
o sbaglio? Un pezzo come Monosexfiles
aveva quel senso del groove circolare che
ora esplode...
Sì, in Rectal Exploration c’era qualcosa di quello che poi è esploso in Growing Heads…, pezzi
come 3 American Bombs e Monosexfiles sono lì a dimostrarlo. Ma sono due dischi basati su attitudini
molto diverse. Rectal Exploration era legato
ad un’idea ancora rock, per quanto storto e rimasticato con una sensibilità noisy e un po’ deviata...
Growing Heads… è molto più omogeneo e “synthetico”, lo puoi ascoltare tutto d’un fiato e poi riascoltarlo, i suoni sono più scarni, gli arrangiamenti
essenziali, tutto il superfluo è stato tagliato. Non è
poi così circolare come sembra, quando percorri un
cerchio finisci per ritornare al punto di partenza, se
ascolti bene il disco ti rendi conto che difficilmente
ritorniamo indietro, via via che scorre c’è sempre
qualcosa che si aggiunge o si sottrae.
Lasciare più spazio ai synth che alle chi-
tarre che senso assume in questa nuova
via?
Il senso è che la chitarra mi aveva annoiato... Non
lo strumento in sé ma il fatto che ci caratterizzasse
troppo come una guitar-band. Poi c’era la curiosità di misurarsi con nuovo strumenti, più adatti alle
nuove idee che ci frullavano in testa. Non è stata
un’idea meditata troppo, nel giro di pochi mesi, abbiamo comprato synth, drum machine e campionatore e, senza saperli suonare, abbiamo fatto i pezzi
nuovi. È come aver acquisito una nuova verginità,
dimentichi quello che sai fare e ricominci con cose
semplici.
L’aver rielaborato alcuni pezzi precedenti significa rivestirli con le vesti attuali di
Miranda?
I pezzi rielaborati in realtà sono solo 3. Head Growing
che non è poi così diversa dalla versione precedente contenuta nello split con i Creeping Nobodies.
Furry Guys Looking For A Flat Girl invece era contenuta nello split, ma quella versione era il risultato di
un lavoro di editing e post-produzione, di fatto era
solo un groove suonato live e poi messo in loop al
PC con la voce sovraincisa in un secondo momento.
Per il disco invece volevamo suonarla per davvero,
come facciamo durante i concerti. Spesso rimontiamo le impro sul PC, poi impariamo a suonarle e alla
fine le registriamo. Invece I’m Your Guido è frutto di
un lavoro di editing e remix di una cosa che avevamo registrato nel 2006, su cui poi ho sovrainciso la
voce nel salotto di casa con una bottiglia di primitivo, dopo che una mia amica di Boston mi ha raccontato alcuni aneddoti sui Guidos italoamericani.
Dal vivo abbiamo imparato a suonarla esattamente
come la versione che è sul disco.
Sappiamo da dove venite (rock noise e
post), ma non dove state andando…suggerimenti?
è difficile immaginarlo, sicuramente verso la sempre maggiore contaminazione con apparecchiature elettroniche, utilizzabili live come qualsiasi altro
strumento. Detto questo non saprei cos’altro dire.
Siamo molto inquieti e ascoltiamo una gran varietà
di musiche diverse, gli sviluppi sono imprevedibili.
Stefano Pifferi
Turn On /
9
Naomi Shelton
Amazing Grace
Siamo alle solite: se non possiedi un’anima, non te
la puoi inventare e non puoi fingere di cantare soul
music. Naomi Shelton è qui per ricordarcelo con un
disco di debutto meraviglioso, ma non è stato facile
arrivarci.
H
ai un bel dire che se ne hanno già piene le scatole del supposto “ritorno del soul”, delle mediocrità e nullità che non lasceranno traccia. Cioè,
10
/ Turn On
indentiamoci: lo puoi anche fare e ne avresti tutto
il diritto, ma prima tieni ben presente che lo scorso anno una certa Mavis Staples ha pubblicato
un live da leccarsi i baffi e che oggi - Anno Domini
2009 - Naomi Shelton può finalmente esordire su
disco col sensazionale What Have You Done,
My Brother? a quasi settanta primavere. Roba da
non credersi e invocare davvero l’altissimo, che di
lei s’è infine ricordato. Deve averlo supplicato con
più forza del solito, questa signora cresciuta in Alabama cantando in chiesa e trasferitasi in seguito a
New York sfacchinando di giorno e cantando la sera
nei club di rhythm & blues. Poi ti dicono che fai le
cose “come una volta”: grazie tante, tu “una volta”
c’eri e hai rischiato di restare una delle mille talentuose che non hanno mai sfondato.
Te la immagini quasi, la Shelton, che a sei anni già
delizia gli astanti della Mt. Coney Baptist Church di
Midway e si forma sul Sam Cooke da acquasantiera accompagnato dai Soul Stirrers e insegue la
Grandezza dei Five Blind Boys Of Alabama:
“Quelli erano i miei mentori. Sono stata ispirata dalla loro
musica, dal tono spirituale che avevano nelle loro voci.
Non c’era hollering, cantavano e basta e a quell’epoca
non lo faceva praticamente nessuno.” Conseguito il
diploma, Naomi lascia il sud e si trasferisce con la
sorella a fare la cameriera in quel di Long Island.
Dura poco e sono momenti tristi, cui seguono un
ritorno a casa e la svolta a Miami Beach, dove sbarca
il lunario facendo la tata e affinando le corde vocali
sulla scorta di Wilson Pickett e Sam & Dave,
di Otis Redding e Lou Rawls. Manna che casca
dal cielo e le dona nuova ispirazione, quella mistura
di sacro e profano che è quintessenza di soul e la
spinge a esibirsi in alcuni “talent show” dove, pian
piano, inizia a vincere bei soldini mascherandosi col
trucco per nascondere la giovane età. È così che,
fattosi il 1963, torna a New York a menare la vita da
brava ragazza di giorno e sciantosa la sera. Com’è e
come non è, entra nel giro dei locali underground,
tre set a sera per sette giorni e sulle spalle un lavoro
normale come ogni buon cristo. è appunto in uno
di questi locali che incontra per la prima volta Cliff
Driver, organista provetto con un curriculum che
poterebbe via pagine e pagine e che resta colpito
da Naomi (“Mi piacque quel sua voce diversa dal solito, capace di raspare come Mavis Staples.”) ma nulla
si concretizza e le strade dei due si dividono per
alcuni anni ed entrambi tirano avanti tra un gruppo e l’altro, lontani dai riflettori e con nelle narici
la segatura dei locali di secondo ordine o l’incenso
della chiesa.
A raccontarla sembra un film, lo so, ma è tutto
vero: a farla breve, nell’80 Cliff meditava di ritirarsi
e piantare la scena dei club approdando al gospel.
Compie insomma il percorso inverso rispetto alla
Shelton e servirà: fino a fine Novanta sarà solo musica sacra, ed è dopo aver supportato per un certo
periodo il carneade Akim che prendono forma le
Queens, il trio vocale che fa bella mostra di sé in
What Have You Done, My Brother? Edna Johnson,
Lisa Poindexter e Judy Bennet vogliono trovare un nuovo cantante da accompagnare e spetta a Edna suggerire Naomi. La quale nel frattempo
aveva sempre frequentato chiesa e club e non se
lo fa chiedere due volte. Accetta al volo e s’è fatto
il 1999 allorché lei e Cliff entrano negli studi della
Desco Records di Gabriel Roth con la “house
band” Soul Providers per porre su nastro 41st
Street Breakdown. Esce su 45 come Naomi Davis
& The Knights Of 41st Street, diventa una
piccola ma solida leggenda alle feste funk e oggi passa di mano a prezzi da leasing. Quando sembra che
un po’ di successo stia arrivando, la Desco fallisce e
la Nostra torna sull’altare. Roth - sia benedetto! torna poco dopo alla carica con la nuova etichetta
Daptone, ma deve arrivare il 2005 perché si decida
di metter mano a un lp.
Occorreranno altre tre stagioni e altrettante
session di registrazione, ma alla fine ne sara valsa
la pena: il debutto di Naomi Shelton & The Gospel
Queens viene registrato in diretta (ed è cosa buona e giusta…) su un otto tracce in un terzetto di
occasioni lontane tra loro di dodici e sei mesi. Impossibile accorgersene, tanto What Have You Done,
My Brother? scintilla di una bellezza della quale rendiamo conto nello spazio recensioni e che attraversa in orizzontale la tradizione soul, mescolandosi al
country e guardando al blues, ricordando le radici
sacre e porgendosi carnale tra una cadenza shuffle e
le sonorità vintage, una vena Stax e un eco Motown.
L’umanità e la capacità di raccontarsi del disco spazzano via ogni residua accusa di revival, implausibile
perché questa è musica fatta da chi ne respira il senso ultimo e ancestrale in ogni momento della propria vita da che è al mondo, non vi s’accosta come a
un modello ammirato da lontano e non posseduto
oppure raccolto a posteriori. è nell’autenticità la sua
forza, ecco. Grazie della benedizione, Mrs. Naomi: ci
vediamo domenica prossima.
Giancarlo Turra
Turn On /
11
D
Dark Night Of The Soul
Viaggio al termine della notte
La cronaca di un album non-album che ha fatto molto discutere. Una fotografia con in primo piano nomi
prestigiosi e sullo sfondo, sfuocato, il caracollante incedere dell’industria discografica
12
/ Turn On
anger Mouse, Sparklehorse e David
Lynch, ma non solo. Iggy Pop, Flaming Lips,
Black Francis, Jason Lytle, Julian Casablancas, James
Mercer (The Shins), Gruff Rhys (Super Furry Animals), Nina Persson, Suzanne Vega e Vic Chesnutt.
Questi, tutti i nomi che hanno partecipato all’ambizioso progetto discografico Dark Night Of The
Soul. Se i primi due sono le menti dalle quali è scaturito il tutto e il terzo è colui che lo ha confezionato con tanto di corredo visuale – ogni brano possiede un vero e proprio film fotografico da sfogliare
–, i restanti dieci sono gli ospiti ai quali è affidato il
ruolo di interpretare vocalmente le canzoni.
Come se tutti questi artisti, protagonisti indiscussi del panorama indie e non solo, non fossero
bastati a far catalizzare attenzioni e aspettative, ci si
è messo addirittura un misterioso (major)boicottaggio della EMI a far salire un hype sproporzionato
intorno all’album in questione. E proprio quest’ultima bega legale rischia di far deragliare il giusto
approccio critico al progetto, facendo perdere appunto la criticità a favore di una presa di posizione
ideologica, seppur involontaria, legata comunque
all’attuale crisi dell’industria discografica. Non è un
caso, infatti, che sul Web le prime reazioni abbiano
avuto quasi tutte connotazioni estreme: o “album
del secolo” o “infima strategia di marketing”. Ecco,
noi il rischio ideologico non lo vogliamo correre,
però non per questo ci limiteremo a parlare esclusivamente dell’aspetto musicale dell’album. Anche
perché quest’ultimo, ufficialmente e concretamente,
non c’è. Ma andiamo per ordine.
Brian Joseph Burton, il talentuoso e fantasioso produttore noto come Danger Mouse, e Mark
Linkous, il malinconico e intimista Sparklehorse in
persona, pensano e decidono di scrivere e arrangiare a quattro mani tredici tracce appositamente per
un album corale e interdisciplinare: pedina fondamentale del progetto è proprio il regista visionario
David Lynch. La notizia inizia subito a girare in
Rete, curiosità e aspettative, visti anche i nomi degli ospiti coinvolti, salgono esponenzialmente, e non
potrebbe essere altrimenti. Ci sarebbe da aspettare
fino a estate inoltrata – così annuncia il sito ufficiale
del progetto www.dnots.com, messo in piedi per
l’occasione –, ma magicamente, o meglio ordinariamente, nei primi giorni dello scorso maggio gli mp3
dell’album sono già scaricabili un po’ ovunque sul
Web, con somma gioia dei fans. Ma è qui che sorgono le complicazioni: la EMI minaccia di muovere
un’azione legale contro Danger Mouse (già recidivo
per il suo geniale Grey Album), perché attualmente
sotto contratto con essa e quindi non autorizzato a
partecipare all’album in questione. La pubblicazione
quindi non s’ha da fare. Ma solo apparentemente. I
Nostri decidono ugualmente di dare alle stampe il
tutto – case, booklet, libro fotografico –, ma senza
musica. Infatti, il dischetto all’interno non è altro che
un cd-r vuoto. Nessuno dei titolari lo ha detto chiaramente, ma masterizzare su di esso gli mp3 freschi
di download è cosa più che logica. Il problema legale sembra aggirato, e l’industria discografica ancora
una volta sembra spiazzata e impreparata.
Delucidato ora l’aspetto formale, veniamo ora al
contenuto, alla musica, agli mp3. Di sicuro non si può
certo parlare di “album del secolo”, e neanche del
migliore album degli Sparklehorse o di Danger
Mouse. Però neanche ci troviamo dinnanzi a un
fallimento, anzi. Mark Linkous, già nelle sue ultime
uscite aveva fatto notare una lieve, forse naturale
carenza creativa, rispetto agli standard a cui ci aveva
abituato con i suoi primi due lavori. E le canzoni ora
proposte sembrano confermare questa tendenza:
niente di disastroso, ma quei picchi artistici restano purtroppo una spanna sopra. Indubbio, però, è
l’ottimo lavoro di arrangiamento e adattamento dei
brani che lui e Danger Mouse sono riusciti a fare.
La cosa che più colpisce è l’eterogeneità: si passa da
atmosfere umbratili e spettrali a sfarfallii pop, da ritmiche sostenute a passaggi fortemente psichedelici,
fino a ballad ora cupe ora leggiadre, toccando vari
generi musicali con una maestria unica. In più sono
riusciti letteralmente a cucire i brani addosso agli
interpreti: emblematici sono gli episodi con Julian
Casablancas e con James Mercer. L’ascolto
fila via senza cadute di tono, e per un album collettivo è un merito di non poco conto. Se si aggiungono
anche le immagini di Lynch…
Più che la notte buia dell’anima, chi sembra attraversare le tenebre è proprio l’industria discografica.
Chissà se il suo viaggio avrà veramente un termine…
Andrea Provinciali
Turn On /
13
Anthony (Tony) Buck
Drums Unlimited
- Luca Collepiccolo
Una volta trasferitosi in quel di Berlino - una delle
capitali europee più attive dal punto di vista artistico/
creativo - Tony Buck non ha certo smesso di indagare
la sua più consona dimensione musicale. Continuando a lavorare in parallelo negli ambienti del jazz di
ricerca e del sound design, il nostro decide di licenziare la sua prima opera propriamente ‘rock’
N
ascono nel 1987 a Sydney i The Necks, trio
australiano tra i più originali del modern
jazz, capace di incrociare gli stili in maniera
del tutto originale, alternando frasi di jazz elettrico
e spunti minimalisti, abbracciando un recondita idea
di musica ambient e adoperandosi in soffuse interpretazioni di ciò che un tempo fu il kraut rock. Il
quintetto storico di Davis (quello con il fenomenale Tony Williams alla batteria tanto per intenderci)
a braccetto con Philip Glass, i Can che osservano
estasiati le musiche discrete di Brian Eno. Ce ne
sarebbero di quadri da incorniciare con le mosse
mai scontate dei tre, possiamo peraltro dirvi che il
bassista Lloyd Swanton, il pianista Chris Abrahms ed
il batterista Tony Buck non amano particolarmente sedersi sugli allori, spingendosi spesso al di fuori
dei patri confini per collezionare collaborazioni dal
grande fascino. Il batterista Tony Buck in particolare
ha scelto la fervida Berlino come luogo operativo,
da diversi anni a questa parte, attraversando in lungo
e in largo gli scenari musicali locali. Alla sua seconda
prova in solo – per la solerte Staubgold – mette in
piedi un qualcosa di inedito, dando fondo alla sua
rinnovata passione per il rock chitarristico. [project]
Transmit è al debutto omonimo – ne riferiamo in
14
/ Tune In
altra parte del giornale – e l’uomo che siede dietro
ai tamburi fa praticamente tutto in solo, non fosse
per il basso elettrico di Dave Symes. Per un uomo
che ha collaborato praticamente con tutti i grandi dell’mprovvisazione (da Otomo Yoshihide a Ned
Rothenberg passando per John Zorn e Phil Minton)
concedendosi anche variazioni sul tema elettronico
con Fennesz, si tratta di stabilire nuovamente le regole del gioco. Cerchiamo di capire perchè
In che misura il trasferimento in quel di
Berlino ha influenzato le tue ultime pubblicazioni?
Penso che la prima volta che sono arrivato a Berlino,
circa 10 anni fa, ero molto influenzato dai musicisti
di estrazione impro e dalla natura e dal modo in
cui essi lavoravano. Posso riscontrare l’influenza di
diverse persone con cui ho suonato, soprattutto in
dischi come Aether dei Necks o l’ album di sola batteria e percussioni Self_Contained_Underwater_
Breathing_Apparatus. Naturalmente uscite come
quella in duo con Axel Dorner sono un prodotto
tipico della scena locale. Un’altra recente pubblicazione- Gold, un progetto in duo con la pianista berlinese Magda Mayas, pubblicato da Creative Sources
– è in qualche modo influenzato dalla stessa scena
di Berlino, ma non credo si possa dire lo stesso di
[Project] Transmit. Penso che queste registrazioni e
questo concetto hanno più che altro a che fare col
mio accresciuto interesse in alcuni aspetti del suonare la chitarra elettrica. Un lavoro che è in realtà
piuttosto vicino allo spirito di altri musicisti con cui
ho collaborato durante la mia carriera, Andy Moor
degli Ex (e dei Kletka Red) e Lee Ranaldo, con cui
ho suonato in un progetto di stanza a New York a
nome Glacial. Buona parte delle incisioni sono state
effettuate a Sydney, Australia e – davvero – non c’è
modo di ascoltare un qualsivoglia suono berlinese
all’interno di questi solchi.
Sei ancora un habituè dei circoli avant ed
improvvisativi, da dove nasce la volontà
di incidere un disco propriamente rock
nell’orientamento?
Come dicevo prima, nasce tutto dal mio interesse
rinnovato per la sei corde, l’ho sempre suonata ad
intervalli regolari, ma credo che solo 5 anni fa ho
realizzato quanto volessi approfondire in maniera
specifica le tecniche di esecuzione. Penso che l’approccio di suonare e scrivere musica rock - almeno alla maniera di gruppi come Shellac, Sonic Youth
o Swans – mi ha sempre interessato ed anche se
è difficile scorgerlo in superficie, è un aspetto che
ha influenzato alcuni elementi che sistematicamente trasporto all’interno dei Necks. Per molti versi [project] Transmit non è distante anni luce da
quanto proposto dai Necks, ovviamente questa mia
nuova avventura arriva da un concetto di formacanzone, non da una angolazione improvvisativa.
Pensi che questo disco abbia qualche tipo
di analogia con passate esperienze quali i
Peril ad esempio? Credi che sia la chiusura di un cerchio?
Penso che gli aspetti più heavy del disco possano
riportarmi indietro al tipo di energia e di intensità
che avevo esplorato all’interno del progetto Peril.
In una certa maniera credo che [project] Transmit
abbia in qualche modo riconciliato le differenze che
ho avvertito tra i Necks ed i Peril. Credo sia riscontrabile la potenza e l’energia nell’intensità tipicamente rock dei Peril, pur lavorando con figure
ripetitive ed aree di trance music che i Necks hanno
sempre esplorato.
Sei un così grande performer, capace
di muoverti in aree multiple e di unirti
a musicisti di diversa estrazione. Aldilà
dell’esperienza storica coi Necks, ho ap-
prezzato anche il tuo recente progetto
Regen Orchester ed ovviamente la coppia di album pubblicati a nome Kletka
Red. Qual’è il segreto nel cambiare destinazione così di frequente?
In realtà trovo estremamente facile cimentarmi in
diversi progetti, seguendo approcci differenti e focalizzandomi su estetiche spesso agli antipodi, proprio
perchè amo i più disparati modi di comporre musica. Ho sempre avuto l’impressione che l’essenza
di molti stili sia rintracciabile nelle intenzioni e nel
focus utilizzati in ogni specifico approccio. Non l’ho
mai visto come un problema, nel mio ruolo di batterista. C’è così tanta meraviglia nel suonare in una
maniera piuttosto forte e semplice come è fantastico trovare ricche tessiture e complessi contrappunti in una dinamica dai tratti più quieti. I differenti stili
musicali esplorano proprio queste specifiche caratteristiche e trovo che la vita di un musicista sia di
gran lunga più gratificante sotto questo aspetto.
C’è ancora qualche obiettivo che ti sei
prefisso di raggiungere come musicista?
Ci sono molti obiettivi da raggiungere.Vorrei che la
mia musica raggiungesse il maggior numero di persone e divenisse un mezzo di gran lunga più chiaro
ed espressivo. Mi auguro di poter esplorare maggiormente questo approccio chitarristico, renderlo
in qualche misura più articolato. Nella veste di batterista e compositore c’è sempre molto da fare per
incrementare le proprie conoscenze.
Ci sono piani per portare [project] Transmit ad esibirsi dal vivo o il tutto è inteso
come un esperimento rigorosamente da
studio?
Vorrei che questo progetto avesse anche uno sviluppo in termini di esperienza live. Abbiamo fatto
il lancio del cd nell’occasione di un concerto berlinese del quale mi posso ritenere assolutamente
soddisfatto. Ho suonato la chitarra con due batteristi, un bassista elettrico ed un tastierista/organista.
La musica era leggermente diversa da ciò che puoi
ascoltare su disco, specialmente nelle parti di organo, suonate originariamente dalla chitarra, ma il
tutto ha funzionato davvero bene, raggiungendo un
alto tasso di energia ed intensità...Sarebbe eccezionale poter portare in tour questa formazione. Ho
iniziato tra l’altro a lavorare ad una seconda pubblicazione ed il fatto di avere una buona band alle spalle mi ha permesso di concepire la musi ca seguendo
un approccio molto più espansivo.
Tune In /
15
G
Giancarlo
Frigieri
I giusti argomenti
Chiacchiere epistolari con Giancarlo Frigieri, ex frontman dei Joe Leaman. A proposito della sua solitudine per nulla solitaria. Di come si possa amare dischi ma
non comprarli né recensirli. Di certe pelose beatificazioni. Di una svolta ben meditata e inopinatamente fruttuosa. Di nomi sbagliati e strane ricerche sulla rete.
- Stefano Solventi
16
/ Tune In
iancarlo Frigieri da Sassuolo, classe ‘72, un
tempo suonava la chitarra nei Love Flower (dal 1989 al 1994), poi la batteria nei
Julie’s Haircut (dal ‘95 al ‘97), quindi è stato per
dieci anni (fino al 2006) la voce e la chitarra dei
Joe Leaman. Poi si è messo in proprio. Ha esordito in solitario col buon Close Your Eyes, Think
About Beauty (Black Candy, gennaio 2007), cui è
seguito un biennio operoso che ha dato vita a questo vivace 2009: a stretto giro sono usciti In Love
(Black Candy, Febbraio 2009), registrato nel settembre 2007 assieme ai Mosquitos, e Grand Theft
Auto/The Dead Children Song (Black Candy,
marzo 2009), split in formato vinile 7’’ assieme a
Chris Eckman dei Walkabouts.
A chiudere una sorprendente triangolazione,
ecco L’età della ragione, album che segna una
inattesa svolta in chiave rock cantautorale. In italiano. Attualmente però non c’è un’etichetta disposta
a distribuirlo. Contatto Giancarlo via mail e come
prima cosa gli chiedo spiegazioni. “La Black Candy mi
ha detto che avrei dovuto aspettare l’autunno a pubblicarlo. Ho scritto alla Tempesta se potevo spedirglielo
per farglielo ascoltare, non mi hanno risposto. So che di
solito si spedisce senza chiedere, ma io non voglio che
il mio cd finisca in una pila... E quindi lo distribuisco io.
A mano. Durante i concerti, per posta e nei negozi che
me lo chiedono. Anche perché tanto i dischi non si vendono assolutamente più, dal vivo ci sono persone che si
avvicinano al banchetto, scrivono il nome e il titolo su un
taccuino e poi probabilmente mi cercano su e-mule (visti con i miei occhi). Peccato perchè senza un’etichetta
spesso giornalisti, radio e locali non ti cagano nemmeno.
Peccato perché su questo sono (siete) rimasti indietro, al
vecchio e patetico trucco del marchio messo per finta...”
Peccato, sì, perché il disco è indubbiamente valido,
a partire dai testi. Ci sa fare, Giancarlo, coi testi in
italiano. “Ci ho pensato un paio d’anni. Mi mancava il
coraggio. L’inglese ti permette di non impegnarti a fare
testi che è il motivo principale per il quale viene usato in
tutto il mondo. America compresa, nel senso che comunque gli americani non si fanno problemi a cantare Tutti
Frutti e ascoltare solo il ritmo. Noi se ascoltiamo Stasera
mi butto la degradiamo a scemenza per via del testo. è
un nostro retaggio culturale, quello di voler fare cose che
abbiano un senso. Scusa, oggi sono in vena di battute.”
Altro che battute: giochi di parole che mandano i luoghi comuni in controsenso (come “E sarà
la tua indifferenza a farti credere differente”, oppure
“Professare amore e calda accoglienza/tenendovi bene
a distanza”). “Boh ! La prima frase che citi è proba-
bilmente la voglia di dire che L’età della ragione non è
detto che ti metta in condizione di capire esattamente
i tuoi simili ma forse è più un qualcosa di simile ad
un’utopia, a un qualcosa a cui tendere...La seconda, da
La stagione dell’odio, è dedicata a tutti coloro che parlano di accoglienza agli immigrati ma che se ne guardano
bene dal rivolger loro la parola. L’Italia è piena di questa
gente e non solo l’Italia. Siamo sempre alla distanza insormontabile tra il pensiero e l’azione.” Un senso però
sembra di intravederlo in questo disco, al punto che
potrebbe passare per un concept album. “In genere
con questo si intende un blocco narrativo unico quindi
non considero il mio un concept album. Però è vero che
c’è un filo conduttore, che penso sia una semplice analisi del tempo in cui viviamo attraverso vicende di vari
personaggi. Perché, ne approfitto per dirlo, non c’è molto
di autobiografico nel disco se non il punto di vista che
ovviamente è il mio.”
Ok, l’Italiano per forza ti impegna, te ne devi incaricare. Allo stesso tempo c’è la musica, curata ma
essenziale, talora ridotta all’osso. “Le due cose non
sono legate. è che in musica adoro il ruolo che ha il
silenzio. Trovo che tanti musicisti non capiscano l’importanza del NON suonare una nota. Specialmente i chitarristi e i batteristi spesso hanno fretta di dimostrare
che sono bravissimi e diventano come quelli che a scuola
sottolineavano tutto non capendo che in realtà non evidenziavano niente.” Lo avverto che nella recensione
mi toccherà citare De André. “Siamo sulla via della
beatificazione di De André e allo stesso tempo siamo
straordinariamente lontani dalla sua poetica. Questo
perché tra il dire e il fare ormai c’è un distacco incolmabile e viviamo in tempi nei quali la cosa più importante
di un libro è la copertina, magari ben in evidenza sullo
scaffale.” Rispondo al contropiede citando Il cane, il
pezzo che più di altri mi sembra scomodare la memoria del grande Faber.“è una canzone che parla proprio di un cane. Senza simbolismi. Mi sono immaginato
che magari tutte le frasi che i padroni dei cani dicono
dei propri cani siano perfettamente smontabili dai cani
stessi. Il coro finale è dei cani del canile di Arceto e nel
disco c’è anche il numero di telefono così se qualcuno
della zona ne vuole adottare uno sa dove andare. Succede la stessa cosa con i figli e d’altra parte le cose sono
collegate. Come disse una volta Giorgio Celli: dicono che
il gatto è un animale freddo e ti vuol bene solo perché
gli dai da mangiare. Provate a non dare da mangiare ai
vostri figli per tre o quattro giorni e poi vediamo cosa
pensano di voi e dove vanno ad abitare...”
Da Faber a Gaber, presenza palpabile in Alla fine
e Quando litighiamo, quest’ultima pure sbilanciata
Tune In /
17
Tenco. “Gaber è stato insieme a Sandro Luporini uno
dei più importanti uomini di cultura della seconda parte
del Novecento italiano. Il fatto che fosse un cantante
era probabilmente solo il vestito o la forma adatta al
proprio tempo. Trovo che, pur essendo anch’egli in via
di beatificazione, manchi molto ai nostri tempi. Più che
altro avrebbe secondo me capito dove saremo tra 10
anni visto che è stato sempre in anticipo. Come avrai
capito per Gaber ho una adorazione infinita da quando lo conobbi per la prima volta sentendo Io se fossi
Dio alla radio dove trasmettevo, intorno al 1991. Tenco
lo conosco poco, pur riconoscendogli un ruolo di primo
piano nell’Italia del suo tempo non mi è mai entrato
sottopelle.” Quello che rende davvero interessante
L’età della ragione è come tenti un equilibrio
tra mondi diversi, tipo il Paisley Underground come
lo rifarebbe Pierangelo Bertoli, o i Black Heart Procession pervasi Vecchioni e Branduardi. “L’accostamento a Bertoli mi inorgoglisce visto
che siamo concittadini. Onestamente non cerco nessun
equilibrio tra un mondo e l’altro, almeno non consapevolmente. Se una cosa suona bene per me, allora va
bene. Inoltre, per i suoni del disco devo ringraziare so-
18
/ Tune In
prattutto Andrea Rovacchi che da tanto tempo è colui
che sta dietro al mixer in sala di registrazione nei miei
album e che specialmente ne L’età della ragione
è stato determinante. Oramai l’intesa che c’è con lui mi
permette di entrare in studio senza idee troppo precise a livello di arrangiamento e di decidere velocemente
quali siano gli strumenti giusti da utilizzare. In ogni caso
anche Branduardi mi piace, così come Steve Wynn,
i Died Pretty, i Thin White Rope e tutto quel
suono americano degli anni 80 che la critica ha riunito
sotto il nome di Paisley Underground.”
E qui casca l’asino, ovvero la collaborazione con
Chris Eckman. “La Black Candy ha proposto a tutti
gli artisti del proprio roster di realizzare uno split single
in vinile 7 pollici in 100 copie numerate, dovevamo sceglierci noi con chi. Visto che non mi andava di fare una
cosa con qualche mio amico tanto per fare ho provato
a chiedere a Chris, visto che la sua musica mi è sempre
piaciuta dai tempi dei Walkabouts e che abitando
in Slovenia ci si sarebbe pure potuti incontrare. Gli ho
scritto e gli ho proposto la cosa, spedendogli il mio disco.
Lui ha risposto di si, chiedendomi di scambiarci una cover. Quindi io ho fatto Grand Theft Auto e lui The Dead
Children Song. Dopodichè ci siamo incontrati per fare un paio di concerti e pur senza
aver mai provato insieme abbiano suonato
magnificamente. Raramente mi sono trovato
così bene suonando con qualcuno, mia moglie diceva che sembravamo fratelli... Ripeteremo l’esperienza in autunno e Chris mi ha
pure chiesto di registrare il mio nuovo album
nel suo studio. Sto tentennando, la tentazione è forte.” Futuro e passato. Ad esempio,
l’ultimo lavoro dei Julie’s Haircut è
davvero buono, ma nulla di più lontano
dal Frigieri attuale. Quel Frigieri che ci
ha messo lo zampino. “Suonare con i Julie’s
è sempre bello, principalmente perché sono
una grande band. Fra l’altro il disco non l’ho
ancora sentito, ma Luca G. me ne ha tenuta
una copia in vinile che devo andare a prendere a casa sua. A dire la verità la collaborazione con i Julie’s non è che sia nata da
chissà quali esigenze o ragionamenti. Sono
passato a trovarli in studio, mi hanno detto
di suonare qualcosa e io l’ho fatto. Quanto
alla mia parte cantata ne La macchina universale, ero in
studio con Andrea che mi stava facendo sentire il pezzo
e gli ho detto: ma è strumentale? Perché ci starebbe
bene una voce che fa una parte ripetitiva... e lui mi ha
detto: valla a cantare tu. L’ho fatto, a loro è piaciuta e
l’hanno tenuta. Tutto molto spontaneo, insomma.”
Già, come calpestare il palco con Offlaga Disco Pax, Le luci della centrale elettrica, o
quei Modena City Ramblers che compaiono
anche nei credits de L’età della ragione. C’è pur
sempre una musica italiana che gira intorno. no? “I
Modena City Ramblers sono amici di lunga data. Massimo Ghiacci è l’unico che conosco che abbia un contrabbasso e poi mi piace come suona. è stata sua l’idea
dell’archetto all’inizio di Quando litighiamo. Quanto a
Elisabetta Vezzani, che dire ? Ha una voce come poche, un timbro straordinario che a me ricorda un poco
Suzanne Vega. è anche merito suo se Un cane è
la canzone che è. Per quanto concerne il rapporto con
la musica italiana di oggi è abbastanza vago, nel senso
che ascolto diverse cose ma che mi piacciono davvero
non ce ne sono poi tante. Cesare Basile mi piace.
Sono curioso di sentire il nuovo di Giorgio Canali.” Restano due dubbi. Il primo è legato alle foto
dell’artwork. “Il libretto, che è opera di mia moglie, non
è altro che una raccolta di foto di famiglia. Mio nonno
era un colone. Mio padre è nato a Mogadiscio nel 1942
e ci ha vissuto fino al 1959 quando è dovuto rientrare
in Italia per motivi famigliari. Gli è andata bene, visto che
nel 1960 la Somalia ha acquisito l’indipendenza e pian
piano sono cominciati i problemi...” Segue una appassionata analisi della triste condizione somala, che è
giusto rimanga fuori da questo contesto.
Ci sarebbe semmai l’ultimo dubbio, riguardo allo
strano nome del dominio web, l’astruso www.miomarito.it. “Tutti sbagliano a scrivere il mio nome. C’è
chi scrive Frigeri, chi scrive Friggeri, chi scrive Fergieri,
chi Frigierio, e così via... Se mettevo giancarlofrigieri.com
non lo trovava nessuno o comunque lo sbagliavano in
tanti. A quel punto ho pensato che ci voleva qualcosa
di semplice e visto che mia moglie quando parlava di
me (ovviamente) diceva sempre: mio marito. Ho guardato se fosse libero quello. Lo era, l’ho preso subito. La
cosa divertente è che ogni mese c’è gente che capita
sul sito cercando cose del tipo ‘problemi con la suocera’,
oppure, il mese scorso, ‘mio marito parla con un’altra
via internet’. Questo mese c’è già un ‘Mio marito ha un
cazzo formidabile’ che non è male...” Proprio niente
male. Prima di salutarmi mi informa che ha inciso
una cover di Cohen assieme alla moglie. Che sta registrando coi James River Incident, la band di
‘veterani esordienti’ già corresponsabili della galoppante title track L’età della ragione. Che se troverà
un buco probabilmente andrà a votare, visto che di
week end elettorale si tratta. In bocca al lupo.
Tune In /
19
Lo Spazio del Suono / 5
FOURM
- Sara Bracco e Vincenzo Santarcangelo
Archisonics come dire occhio e orecchio a lucchetto. Barry G. Nichols. Una vita dedicata
alle relazioni tra architettura e scienza del suono.
A
rchitettura e scienza del suono, seppure dotate di un certo rigore, si sono spesso dimostrate libere di interagire, tanto nella forma
di discipline o arti governate da regole e principi
(proporzione, ritmo ed equilibrio) costantemente
legati a doppio filo a questioni percettive che hanno finito per coinvolgere l’uomo e lo spazio da egli
abitato.
20
/ Tune In
Dall’architettura, intesa come scienza dell’abitare,
partiva la ricerca del sound-artist Tiziano Milani, impiegata all’interno di una camera riverberante e
legata alle proprietà fisiche dell’oggetto in Im Innersten (Afe, 2009), o intrappolata nelle registrazioni spaziali effettuate con Luca Sciarratta in
SIRR (Setola di Maiale, 2007).
Musica che Milani concepisce prima di tutto come
architettura dello spazio primordiale, o, per usare parole che Barry G. Nichols, artista dietro
FOURM, prende in prestito da Goethe, “un’architettura come musica congelata”, manifesto di esplorazioni per suono e forma della serie Archisonics.
Una ricerca per l’artista inglese che inizia con i
progetti firmati ECM 323 (1996-2003), di cui ricordiamo le preziose installazioni sonore, principi
successivamente approfonditi con i moniker SICOMM e Level (2003-2005) a cui concedere la
maggior parte dei suoi progetti solisti. Risalgono a
tempi più recenti, invece, i lavori firmati con la sigla
FOURM, progetto ideato inizialmente per la realizzazione di una serie di remix, e successivamente
concentratosi sulla fortunata serie Archisonics, il
tutto sotto l’egida dell’etichetta personale WHITE_LINE.
Un’esplorazione attenta alle relazioni tra suono e
forma costruita, collegate dalla matematica della
pura informazione, è qui che FOURM vede nel
personal computer “la chiave che lega le due cose”.
Indagini sonore al servizio prima di tutto di quello
che Nichols definisce il “vero minimalismo”, ridotte al minimo dei componenti e al servizio di strutture o particelle di forma, chiamate dall’artista “DNA
sonoro”.
Una serie primaria di suoni puri che si dispone combinandosi in una certa forma coerente, o meglio, in
una forma dotata di risonanza, fluidità e coerenza
linguistica.
Architettura e suono dipendono entrambi da una struttura, da fenomeni compositivi più o meno addizionali e distinti a
livello di ordine e proporzione che relazionano opera ed individuo. Partendo da
queste considerazioni preliminari, vorrei mi parlassi del progetto Archisonics
e della pubblicazione con Andy Graydon.
Come agisce su questi temi il tuo percorso di “lettura sonora” e “analisi del contesto” architettonico?
Forum: il procedimento per me è stato quello di
prendere una serie di regole o parametri e successivamente, tramite processi di sottrazione, contrazione, riduzione, deformare ciò che sarebbe stato una
sequenza o serie di suoni molto regolare. In questo
modo, introducendo un elemento frammentato nel
contesto di una disciplina che in gran parte è governata da regole e principi severi, ho agito come
l’avvocato del diavolo. Andy Graydon ha avuto un
approccio armonioso e più incline ai fenomeni at-
mosferici. La collaborazione tra noi due è vissuta
grazie a differenze significative, che tuttavia hanno
reso l’unione molto interessante. Archisonics, che
già di per sé unisce due parole, architettura e sonorità, è stato creato per incorniciare due diverse, ma
reciprocamente compatibili discipline, e il libro in
modo particolare si propone di analizzare gli aspetti
del suono e della forma costruita, tracciare paragoni e analogie e attivare un certo tipo di discorso
critico. La scrittura di Andy è stata particolarmente ispiratrice perché nasceva da una posizione del
tutto soggettiva. Alle sue istanze di tipo impressionista e sotto forma di diario segue la mia analisi, di
impianto più narrativo, scientifico-filosofica. Le due
forme sono tenute insieme da molte risorse oscure
e punti di riferimento comuni. Se esaminiamo meglio, architettura e scienza del suono sono discipline
che privilegiano l’occhio e l’orecchio rispettivamente, così Archisonics, come singola entità, funge da
ponte e da catalizzatore tra le due.
Analogie tra archiettura e suono che diventano manifesto, mi riferisco ai principi
del serialismo strettamente connessi ai
principi estetici del decostruttivismo architettonico. Principio del serialismo anticipato da Le Corbusier con il sistema di
misura basato sulle proporzioni umane,
approfondito grazie alla collaborazione
con Xenakis per il Padiglione Philips. In
che modo questi principi hanno influenzato i tuoi studi? Come vedi oggi mutata
la relazione tra I due elementi di questo
dualismo architettura/musica?
Ritengo che la relazione tra architettura e musica sia
diventata di fondamentale rilievo negli ultimi venti
anni, probabilmente parallelamente alla capillare diffusione dei personal computers. Di più, le discipline
creative hanno subito una serie di trasformazioni e
hanno iniziato a incrociarsi tra di loro, a partire da
collettivi artistici come Fluxus, e successivamente
dirigendosi verso l’esterno in direzione dei dipartimenti educativi dei musei, che iniziano finalmente
ad aprirsi all’influenza, o meglio alla confluenza, di
musica e architettura. Solo guardandosi attorno, si
può notare come edifici finiscano per assomigliare sempre più spesso a sculture, e viceversa; penso
che i computer siano i veicoli tramite cui questa
“fecondazione incrociata” viene attivata, e lo stesso
vale per i binomi musica/suono e musica/architettura. Questi trasferimenti di informazione attraverso i
sistemi digitali sono assimilabili ai sistemi in natura,
Tune In /
21
e il computer diventa il punto di convergenza di forme ibride che evolvono e mutano costantemente.
Il tuo riferimento al lavoro e al pensiero di Le Corbusier è davvero adeguato, poiché il suo Modulor
System si basava su tecniche e principi di proporzione, la cosiddetta Golden Ratio che hai menzionato e che governa anche la serie di Fibonacci. Il mio
lavoro è stato pensato specialmente per rompere
e frammentare in qualche modo la tradizione di
una Golden Ratio, o di una sezione aurea del suono, nonostante non nutra alcun dubbio sul fatto che
esista una parte del nostro subconscio e del nostro sistema cognitivo che si orienta naturalmente
verso proporzioni armoniose: altrimenti tutto ciò
che verrebbe fuori sarebbe cacofonico, o di sicuro
dissonante. Le relazioni tra suono e forma costruita
sono fondamentalmente collegate dalla matematica
della pura informazione, e ancora una volta, è qui
che io vedo nel personal computer la chiave che
lega le due cose. Non sto cercando di affermare
alcun tipo di primato intellettuale, poiché indagini
migliori sono già state condotte, e quello che è stato realizzato si trova nella sua forma migliore allo
stadio infantile. Immagino che se il mio lavoro fosse
governato unicamente da principi di proporzione
armoniosa, allora sarebbe molto più simile ad una
forma di minimal techno, qualcosa di decisamente
più rifinito e seriale. Forse per un progetto futuro...
Sempre in riferimento al Padiglione Philips, Le Corbusier diceva: “deve essere
una bottiglia e contenere il nettare dello
spettacolo e della musica”. Ad oggi, quale potrebbe essere un opera-luogo (o non
luogo) in grado di rappresentare questa
simbiosi tra Architettura e Musica?
È interessante il fatto che utilizziate il termine “simbiosi” perché fa parte di una terminologia che si rifà
alla biologia e alla natura, e che diventa effettivamente il punto d’origine di tutto il discorso. Ci sono
diversi posti a cui penso in cui questo senso di simbiosi sia consciamente o inconsciamente presente.
Questo è reso possibile dall’utilizzo dell’Architettura come strumento, o di strumenti come architettura. Forse i migliori esempi sono quelli che consapevolmente tengono unite le due istanze, il Geneva
Bypass è stato appositamente ideato come opera
di architettura che sfrutta come veicolo il suono
per esprimere il senso cinestetico del passaggio di
un autista in una galleria. Anche la SonoHouse di
Nox utilizza l’esperienza sonora come parte della
costruzione.
22
/ Tune In
Ci sono numerosi altri esempi di Archisononics che
vanno dagli antichi osservatori dei Maya alla turpe
Whispering gallery della St. Paul Cathedral a Londra,
all’architettura magnificamente brutale del Sound
Mirrors sempre in Gran Bretagna. Potrei citare anche il Memoriale del Negev Brigade in Israele, un
edificio meravigliosamente scultoreo e architettonico che fa uso dei suoni del vento, dei vari livelli
di costruzione e degli echi che intervengono nello
spazio del percorso fisico della memoria. La lista è
abbondante. Una delle mie maggiori ambizioni adesso è quella di riuscire a lavorare con un architetto
o con un team di architetti per creare un edificio/
scultura che sia archisonicamente prescrittiva.
Set.Neutral evidenzia la tua attenzione
alle atmosfere estremamente ridotte,
alle particelle in frammenti che penetrano il silenzio. Mi parli di Set.Neutral, le
regole e le influenze a questo lavoro?
Il suono inteso come una delle infinite declinazioni
del medium digitale è eccezionalmente malleabile a
infinite combinazioni. Mi sono sempre interessato
alle strutture e alle micro-strutture che manifestano se stesse più si va avanti a dilatare o espandere
un suono, o al contrario a ridurlo e compattarlo.
Le serie set (finora tre dischi: set.neutral, set.grey,
set.black) si concentra sull’esplorazione di strutture a partire da microscopici frammenti di suono,
estesi gradualmente in lunghe sequenze di forme.
Il metodo è quello della eviscerazione, un “recidere” o un “approfondire”, per creare suoni che siano
modificabili e in qualche modo simili a quelli della
teoria del caos. Ciò che cerco di fare qui è piuttosto
un’analisi delle strutture emergenti e non la replica
di qualcosa che è stato già realizzato.
Tutto il materiale è composto di particelle indivisibili: tutta la materia, una volta ridotta a sufficienza, diventa mera vibrazione (o moto browniano). Si
tratta, a mio modo di vedere di puro minimalismo:
ridurre e condensare ogni cosa ai propri elementi
costitutivi, cercando di creare strutture, forme dalle particelle, quello che io mi diverto a chiamare
“DNA sonoro”, una serie primaria di suoni puri che
si dispone combinandosi in una certa forma coerente, o meglio, in una forma dotata di risonanza,
fluidità e coerenza linguistica. Un momento chiave
del processo è stato quello di ridurre gli elementi
sonori il più possibile, pur mantenendo una tensione e un farsi-forma che risultasse interessante per
l’ascoltatore.
La materia che si sfalda in particelle di
Tune In /
23
frammenti sonori è, secondo Alva Noto
cristallizzata in nuclei che s’irradiano in
nuove direzioni mai programmate ma
inevitabilmente imprevedibile. Per usare sue parole, “I progetti possono essere
iniziati e terminati. L’Identità no”. Cosa
ne pensi?
Artisti come Noto, Ryoji Ikeda, Frank Bretschneider,
Plastikman e altri sono stati interessanti per la mia
formazione, ma il loro limite sta nel fatto che continuano ad operare all’interno di concetti come “musica” e “musicalità”. Utilizzano frammenti di suoni,
dati, campioni, e intrecciano complesse combinazioni che inevitabilmente finiscono per assomigliare
ancora a una forma di musica techno - per quanto
pura. Il loro lavoro è ancora marchiato a fuoco dal
tarlo del “musicale” ed è decisamente riconoscibile
in termini di formati musicale. Quello che cerco di
fare io, per converso, è di creare qualcosa di più
immediatamente categorizzabile e definibile come
arte, ed è per questo che cerco costantemente di
inventare nuovi modi per far fruttare il mio approccio; l’obiettivo a lungo termine (la mia missione è
ancora in atto e non ancora completata) sta nel riuscire a prescindere totalmente dai significanti dei
miei dischi, essendo essi componenti fondamentali
della musica.
Ci puoi dire com’è nata l’idea della White_Line, com’è strutturata? I progetti che
senti più rappresentativi, e quelli futuri?
Come molti degli artisti che operano al margine
dei canali convenzionali, volevo creare un tipo di
prodotti che io stesso avrei apprezzato, ponendo
attenzione alla buona qualità e al giusto design. Ho
cercato di creare una piattaforma che rappresentasse al meglio l’odierna comunità di artisti minimali, e
allo stesso tempo creare un mezzo col quale lanciare i miei esperimenti sotto il nome di FOURM.
‘White line’ è una struttura organizzata che tendenzialmente non ha nessun maestoso piano d’attacco
alle spalle. Semplicemente, rendo pubblico il lavoro
degli artisti che mi piacciono e che sento in qualche
modo estenderanno il linguaggio del minimalismo a
svariati approcci. Esistono diversi modi di approcciarsi al “minimalismo”. Penso che i progetti più rappresentativi dell’etichetta siano il libro di Archisonics e i quattro cd states con relativa installazione,
poiché non sono progetti basati esclusivamente sul
suono, ma coinvolgono il pubblico a vari livelli di
fruizione. I progetti futuri saranno ancora una volta
concentrati sul minimal sound: una sinergia di impe-
24
/ Tune In
gno e passione li renderà davvero attraenti!
F. L. Wright diceva che ”la musica non
sarà in grado di portare a compimento
la sua rivoluzione se, come l‘architettura, non rinnova i suoi materiali”. Cosa ne
pensi? Qual è il tuo rapporto con gli strumenti classici?
È un’affermazione che condivido. Suppongo che la
mia immaginazione sia ancora lo strumento più importante di cui io disponga. Certo, essa, così come
la mia arte, si esprime attraverso l’utilizzo di un personal computer. Il mio approccio alla strumentazione tradizionale è sempre consistito in un tentativo
continuo di frammentazione e riconfigurazione dei
suoi principi originari. Non penso di aver mai creato
o lavorato con uno strumento musicale nel modo
che era richiesto dalla sua storia...fa parte del mio
modo di essere, credo, prendere una posizione che
sia in grado di cambiare le regole. Ad essere sincero,
tutto questo in parte nasce dalla mia nota inettitudine con la musica, in parte è dovuto alla mia natura
ribelle e rivoluzionaria! Attualmente sto lavorando
a un importante progetto (ancora senza titolo), che
mi impone di distruggere letteralmente un pianoforte e registrare i risultati di questo processo.
Questa è la parte concettuale, in cui i suoni creati dal lento smantellamento di uno dei più potenti simboli della musicalità e la presenza fisica dello
strumento stesso vengono trasformati da un atto di
distruzione. Forse questa forma di distruzione creativa è la conseguenza diretta dell’odierna eccessiva
facilità di procurarsi mezzi per fare musica. Il progetto cambia simultaneamente la forma della musica e i
suoi strumenti e inoltre presenta una analogia quasi
fisica con i cicli naturali e dei processi di nascitamorte-rinascita intesi come atti di trasformazione
e trascendenza. Tutti i pezzi del piano saranno poi
inscatolati a casaccio e venduti in edizione limitata,
insieme con il cd dei suoni della loro stessa decostruzione, così in qualche modo il loro possessore
diventerà parte del processo.
Puoi parlarci del tuo percorso artistico a
partire dalle installazioni sonore siglate
ECM323. Qual è il tuo rapporto con questa forma d’arte?
Ho ideato il progetto ECM323 con Linden Hale:
miravamo essenzialmente alla realizzazione di idee
scientificamente fondate sulla forma del suono,
e a ricreare esperimenti condotti da esperti della (cymatics), Ernst Chladni e Hans Jenny, donando
loro maggiore fruibilità. Abbiamo esposto diversi
progetti, adesso ben documentati, e credo questo
sia stato il momento in cui si è deciso di dedicarci
a un corpo consistente di lavori che ci avrebbero
condotto al futuro. Gran parte di ciò che abbiamo
raggiunto con le installazioni lo si deve a Joe Banks
di Disinformation (Ash International), che ha coinvolto ECM323 nelle sue prime esposizioni in galleria.
Joe è stato un grande sostenitore dell’installazione
TRACE in particolare, e ci ha aiutati ad estendere il
progetto verso un più ampio pubblico. Dopodiché,
altre gallerie ci hanno fatto delle proposte e il progetto nella sua interezza è decollato raggiungendo
il suo apice con le installazioni di suoni in serie di
TEST SITES presso l’Installation Museum di Londra.
In seguito ha avuto la meglio il desiderio di famiglia
di Linden e così ho avviato il progetto in solitaria
Si_COMM, che si è poi trasformato in FORUM e
Level. I punti chiave che erano presenti in ECM323
sono ancora al centro della mia attenzione, e alcune
di quelle idee iniziali si sono sviluppate.
Quello di Feedback è stato un concetto ricorrente
sin dall’inizio del progetto, essendo esso implicato
tanto in processi biologici quanto per il funziona-
mento dei sistemi sintetici/digitali e i sistemi musicali elettronici. Il mio approccio all’installazione deve
necessariamente partire da un’idea che possa essere udita e visualizzata, che sia in grado di illustrare
un processo pensato, o una linea di pensiero, qualcosa che faccia parte della mia evoluzione personale
come artista, e non ultimo, qualcosa che sia finanziariamente praticabile. Il sistema britannico dei fondi
per l’arte è attualmente estremamente complicato,
sembra mirare subdolamente alla creazione di un
sistema di arte approvata dal governo che attirerà masse adulanti di spettatori del contemporaneo.
Quasi tutto quello che si vede nella gallerie inglesi
oggigiorno è fiacco, derivativo, scarsamente interessante...tutti vogliono diventare i nuovi Damien
Hirst. Per gli artisti più radicali ottenere fondi per la
realizzazione di progetti ambiziosi è diventato davvero difficile, almeno per quanto riguarda il Regno
Unito. Qualche offerta continua ad arrivare dall’Europa continentale e dal Canada...
Tune In /
25
S
ardegna. Terra madre di riti ancestrali e crocevia di tradizioni millenarie. Questo e molto
altro. L’isola che spunta rigogliosa in primavera
e brucia d’estate. La dea della fertilità il suo simbolo.
Se oggi questo patrimonio a noi continentali sembra così distante e antico, travolto dalla velocità di
download e dalle comunicazioni in fibra ottica, ci
sono degli avamposti che resistono all’oblio e alla
cancellazione della memoria.
Nel 1999 a Macomer, centro geografico dell’isola,
si respira aria di rivoluzione. Rivoluzione musicale. In
principio nasce tutto da un collettivo di performance teatral-musicale improvvisate. Gli 8 afrodisiaci fatti in casa. Deliri collettivi che si nutrivano
della neopsichedelia uscita dai 90. Teatro e performance più o meno regolari in un’esperienza che
dura poco ma che al suo interno ha un potenziale energetico che sprigiona DIY-ness da tutti i pori.
Così, dopo poco, con l’avvento del masterizzatore,
fare un disco è alla portata di tutti. Il medium non
viene però percepito come strumento per vendere. Anzi, il CD diventa diario per documentare
gli esperimenti. Mutati e salvati nei solchi digitali.
Dal teatro alla musica. Oggi il nome di punta è Hermetic Brotherhood Of Lux-Or. Con un moniker del genere hai già detto dove stai andando con la
visione. E se l’esperienza è difficilmente descrivibile,
Mirko Santoru aka Miroslaw - fondatore della
label transponsonica - ce ne parla come di una sorta
di scrittura musicale automatica che viene documentata
in presa diretta. Ci piace definirla post-world music mutante. Gli ingredienti sono avvicinabili al folk, ma non
quello americano di Devendra Banhart che ormai è
pura patina. Qui la folkitudine è un culto permeato
di terra e di sangue, cose che senti a contatto con le
radici delle sugheraie, le siepi di mirto che costeggiano le strade con i cartelli impallinati... Tutto il Carnevale della Sardegna non è altro che la rappresentazione
vivente di riti dionisiaci di carattere agricolo, funebre, di
uccisione e smembramento del Re sacro. In sardo si dice
“carrasecare”, letteralmente carne da fare a pezzi. Noi
facciamo a pezzi la materia sonora in veri e propri rituali
documentati, come fossero etnografia di una tribù in via
di estinzione che viene riplasmata in nuovi golem.
Non a caso anche il processo di registrazione/documentazione viene influenzato da questa estetica/
pratica. Non si va a noleggiare lo studio con gli ultimi
ritrovati della tecnica di sintesi, bensì si pensa a luoghi e a pratiche che si traducono in improvvisazione
sonora senza mediazioni, direttamente a contatto
con la terra. Più precisamente si registra in grotta.
26
/ Tune In
Abbiamo registrato sempre in posti chiusi, ristretti e senza finestre, con delay infiniti. Questo produce una sorta
di drone mentale che guida i nostri cervelli e si riflette
nella rappresentazione sonora. Ma non si tratta di un
tentativo di incasellazione sonora, si tratta più che altro
del fatto che l’essere nati in Sardegna - dove si respira un aria millenaria - ha influito positivamente sviluppando in noi un interesse fortissimo per l’archeologia, la
storia delle religioni e dei popoli e questo va ad aggiungersi alla nostra estetica musicale in maniera fondante.
Un’estetica che non bada - già dalla sua genesi - a
barriere artistiche. Oggi più che mai la multimedialità è d’obbligo: Abbiamo sempre avuto interessi disparati in campo artistico, quasi tutti noi si cimentano oltre
che alla musica nella fotografia, nella pittura e nella videoarte e a breve (spero) uscirà un film muto che abbiamo girato in questi anni e che naturalmente avrà la
nostra colonna sonora. Un atteggiamento aperto che
fa conoscere il collettivo anche fuori dall’Ichnusa.
Il personaggio che li lancia sulla scena internazionale
è Damo Suzuki. Dopo l’incontro con l’uomo-immagine dei Can esce il live degli HBOL Urano3, registrato a New York. Una fratellanza sonica che non
ha confini e che spinge la ricerca verso la stabilità. È
infatti uscito a giugno 09 il primo disco non autoprodotto. Dopo 10 anni finalmente il primo disco ufficiale. Si tratta del nuovo disco, finalmente con produzione
industriale, degli HBOL che si intitola Saint Lux. Un
lavoro che vede la partecipazione di tutti i componenti
del collettivo. È un disco molto intenso e pesante dedicato
ai tre aspetti della Luna, alla Dea Bianca, alla sua luce,
permeato di realtà industriale in decadenza, della fine del
mondo occidentale?
W ho ’ s W ho
Dei molti nomi coinvolti nel progetto Transponsonic non è facile selezionare un campione rappresentativo. I dischi usciti dai combo attivi nel 2008
sono solo una testimonianza parziale dei sentieri
di ricerca di questo gruppo di mistici post-folk, ma
forniscono comunque un’idea della varietà musicale
proposta. Le voci vengono da mondi diversi.A voi la
selecta dei più rappresentativi. Non sorprendetevi.
Loro ci fanno.
Transponsonic
L’oscura Transponsonic festeggia due lustri di
storia. Mirko Santoru ci racconta di un viaggio
psych totale dove teatro e performance fanno
un tutt’uno con droni, impro e un senso della
terra e del cosmo tutto da scoprire
- Marco Braggion
Ersilio Campostorto - L’eremita tossico
Lui è uno dei fondatori del suono transponsonico.
Insieme al capocchia Santoru fonda i Maqom, ma già
dal ‘99 esce con una pletora di progetti che vanno
dall’improvvisazione in acido (il progetto omonimo)
al pop (K17), dalla dark-wave (Magnetopho-
Tune In /
27
beeks) al rock (HameloH). Il perché di queste
mutazioni ce lo dice lui: verticalizzazione parossistica
e psicopatologia applicata. La sua proposta va al di là
del suono, in un gioco di strimpellature bruitistiche
di chitarre, pedaline violentate, tastiere da quattro
soldi e field sounds rubati qui e là.
Lui è un’isola di pietra che vive in un deserto roccioso
circondato dal mare, influenzato dal maestrale, dalle
rocce, dalla terra e dalle piante è la voce storica del
gruppo. Uno stronzo primigenio che si isola e che tiene i contatti con pochissimi amici fidati. Una delle
colonne dell’etichetta, la memoria isolata, il musicista primitivo. Senza peli sulla lingua contribuisce al
suono transponsonico con una lunghissima improvvisazione psichica, ai confini tra storia millenaria e
catarsi teatrale. Senza di lui non saremmo qui a parlare di questo piccolo mondo antico sardo.
Maqom - La definizione del suono T
Dopo le improvvisazioni/happening sui testi di Artaud, Miroslaw e Campostorto si legano ad Andrej
Porcu. Il trio riporta in musica le sperimentazioni
teatrali e nasce II-II-2002: uno studio musicalantropologico che registra la visione della terra sui
solchi del CD. Questa prima prova, registrata in un
ex caseificio abbandonato è il preludio a quella che
sarà una lista di diari sonori improvvisati in locazioni singolari, cose che pulsano sperimentazione.
Nel 2006 con Neurath e Der List si dà un nome a
questa tradizione e si registra il primo tassello della
serie Maqom: Tam-El, emblema e manifesto di
ricerca. Arriva poi Maqom II - Nasprias Cave
(è Miroslaw a parlarcene): uno sprofondamento psicochimico, ancora una volta una sintesi tra arcaico e ultracontemporaneo. Forme di sciamanesimo ancestrale
-ispirate dalla lettura dell’opera di Mircea Eliade- si fondono ancora una volta con il teatro della crudeltà artaudiano dando nuova linfa alla nostra ormai consolidata
forma di crudele rappresentazione sonora.
Registrato in sessione singola nella grotta di Nasprias, un
vecchio stazzo immerso nei vigneti del Marghine, è l’ennesimo lavoro di improvvisazione radicale targato Trasponsonic. Abissale. Nel maggio 2007 in un’altra sessione rituale si materializza Maqom IV - Utopos: un viaggio
nei meandri della storia dei popoli del Mediterraneo che
hanno popolato nei millenni la Sardegna e in particolare i
nostri villaggi. La mente viene catapultata nel mezzo di battaglie sanguinose e rituali di propiziazione e nelle musiche
che idealmente li accompagnavano. Free-jazz ed arcaismi
musicali in una devastante esperienza psichedelica tribale.
La strumentazione prevede oltre al solito set anche
strumenti (launeddas) e tecniche vocali derivate dalla
tradizione sarda ((canti gutturali, tenores) con un pizzico di elettronica vintage. La serie Maqom può essere
vista come una sorta di documentario a puntate circa
l’etnografia della Sardegna. Viviamo nel nostro territorio
circondati da monumenti megalitici millenari che stanno lì
corrosi dal tempo ma immutabili. L’asprezza e la bellezza
quasi terrficante del paesaggio, le nostre tradizioni che
rimandano a culti ancestrali anch’essi lavorati dal tempo
ma ancora prepotentemente presenti e vivi.
Andrej Porcu - Etnica avariata e psichedelia naturale
Il progetto solista per Andrej Porcu parte più o
meno dal ‘98. Si caratterizza per un uso del field recording marcio, un minestrone minimale arcaico-etnico
di rovine industriali. L’idea è quella di produrre suoni
nuovi, partendo con delle registrazioni molto rudimen-
28
/ Tune In
tali, eseguite con un registratorino a cassette, tracce di
improvvisazioni autistico-minimali di cavi, amplificatori e
collegamenti, ruderi di batteria e bidoni, chitarre scordate e da corde di materiali differenti e altre varie paccottiglie rumoristiche.
Nel ‘99 esce il primo disco: Disfunzioni tecniche.
Da qui in poi la strada è tutta in ascesa. Si fa presto
a dire discografia: Sfaceli umanistici (2000), Vol.
3 (2004) e Disturbi concreti nel disordine dei
sogni (2008). Dal primo all’ultimo vi sono enormi cambiamenti ed evoluzioni anche se mantengono sempre lo
stesso approcio istintivo: l’indole è sempre quella di cambiare situazioni e sonorità ad ogni brano, dal soffio dolce al rumore dissonante. Due chitarre autocostruite,
una cetra, una cornetta, flauti vari, benas (strumento
etnico sardo di canna comune), percussioni, microfoni e delay per creare un flusso continuo di suoni a
cascata libera.
India Von Halkein - Electro-industrial head
Un one-man project e un solo album all’attivo. La
new breed dell’etichetta. Dietro all’India sta la sintesi estetica ed elettronica: una commistione di elementi
variegati e differenti tradizioni musicali, una ‘contaminatio’ tra la dimensione industrial/wave e la dimensione,
apparentemente distante e aporetica, della musica etnica di matrice medio-orientale. Ciò determina l’utilizzo
velleitario tanto del synth, quanto dei flauti, di tamburi
e percussioni ‘esotici’ e dell’armonium; le chitarre emergono ora languide e minimali per affrescare contorni,
ora asettiche e sibilanti per determinare contrasti forti
ed ombreggiare sfondi apocalittici. Dal 2007 avanza
quindi la dimensione electro anche in casa Transponsonic. In collaborazione con Ethan Varrs, Miroslaw e Gabriel L.B., la proposta doveva rappresentare
un canale o medium espressivo in cui potessero essere
esplicitati adeguatamente i punti acerbi della riflessione
e del vissuto soggettivo sullo sfondo generale dell’alienazione e della destrutturazione esistenziale dell’individuo,
de-volutivamente assoggettato al monstrum simbolicum
dell’anomia tecno-gonica della civiltà contemporanea...
Il soggetto, dunque, e la sua deriva; ma anche il piano
inclinato dove il soggetto medesimo ansima e si disperde. Praticamente un trip tecnologico attaccato alle
radici dell’Ichnusa attraversato da misticismo, deliri
alterati e drones che richiamano il deserto: il deserto arde e nientifica, la musica lo rispecchia e lo riverbera. La Terra dell’appartenenza e, insieme, della non
appartenenza, dove il rituale richiede di essere officiato
in direzione della catarsi esistenziale e dove il ‘telos’ s’affaccia inesorablie: il fine dello smembramento bacchico
Tune In /
29
to dal suono dei pianeti ci va di improvvisazione:
con l’apporto di Antonov alle percussioni e sax e
di Solidea Surya al sampling si registra Urano1. Da
qui ha inizio l’esplorazione di altri mondi. La terra è
lontana e i nostri indagano l’atmosfera gassosa del
pianeta simbolo della Fratellanza Ermetica. Un vortice marziale di psichedelia cosmica, nera ed asfissiante. Nello stesso anno si vola a Brooklyn, New
York situata sul medesimo parallelo di Macomer.
L’esito della riunione di adepti è testimoniato da
Urano3, terzo capitolo, di cui già abbiamo detto. Nel maggio di quest’anno una nuova formazione ermetica composta da Miroslaw,Varss, Antonov, Campostorto, Porcu con l’aggiunta di Gabriel L.B. vede
riunite al completo le colonne portanti del suono
Trasponsonic. I nostri si rinchiudono in un “muristene”: una nicchia presso la chiesa campestre di San
Q uattro
India Von Halkein
all’interno della babele industriale, dove ogni appartenenza è frutto di un differimento organico, poetico e tribale, romantico e deietto... Nel deserto la connessione si
nullifica, il contatto è sottoposto ad evaporazione: le connessioni musicali sono rade, quasi autistiche, parossistiche, perpetuamente autoreferenziali... Ciò non significa
esclusione dal ‘cosmos’ musicale contemporaneo, bensì
idolatria della nullificazione e del differimento. Ben venga la comunanza, ma il deserto riverbera la sua propria
delirante irradiazione.
Last but not least:
Hermetic Brotherhood of Lux-Or
L’ultima creazione del collettivo è nata dall’incontro
con il produttore Ethan Varrs. Se Campostorto
segna le origini con Maqom, Varrs produce il nuovo suono per il sempreverde trio Miroslaw Cam-
30
/ Tune In
postorto Porcu. La visione del cosmo è abbagliante e
la sola terra comincia ad essere percepita come spazio
limitato. Le altre stelle sono più vicine di quanto appaiano. E allora ci andiamo di interstellar overdrive psichica: nel novembre 2007 viene registrato il primo
frutto di queste interazioni al di là del pianeta: in un
vero e proprio rituale micotico che vede protagonista
Ethan in compagnia di Miroslaw e Andrej Porcu. Un’unica session senza nessuna post-produzione o artifizio, un
viaggio attraverso la tribalità assoluta fino a giungere a
un tripudio sinfonico di cellulari realizzato con l’ausilio di
soli 3 microfoni filtrati da delay digitali e strumenti vari.
La tribalità acustica è digitalizzata. Si percorre il cammino dell’evoluzione sonora umana dall’analfabetismo
primordiale ad una piena consapevolezza tecnologica. È
Umungus Fungus: primo capitolo della saga HBOL.
La tecnologia entra nelle vene e il trio, galvanizza-
Lussorio, Borore (a 6 km da Macomer) dove i pellegrini sostavano a pregare. Da un’idea di Antonov,
originario del paese, nasce Saint Lux: la summa di
varie anime, di diversi modi di sentire accomunati dalle
stesse pulsioni astrali. Un nuova quanto arcaica divinità
mutante che fruga nella terrra, adora lo sbocciare della
primavera con i neuroni in fiamme come nella luminosità del Nuovo Messico circondata da insetti che disegnano sfere luminose. Un inno alla purezza femminile
e selvaggia della nostra terra, alla Dea Madre, alla luna.
Ai suoi tre aspetti di ninfa, fata e strega. Alla sua luce
che si specchia ancora nei pozzi sacri ma è stata ed è
continuamente profanata ed innervata di archeologia
industriale arcaica e contemporanea. Sopravvive nella
mutazione e forgia nuovi guerrieri pronti all’apocalisse,
rivelazione o distruzione esso sia.
dischi fondamentali
Maqom - Nasprias Cave
Il bruitismo derivato dal teatro di Artaud insonorizza le caverne sarde. Il passaggio dall’estemporaneità
dell’happening al documento sonoro. Questo disco, come le altre autoproduzioni d’esordio del gruppo,
è un post sul blog sonoro dell’etichetta, un tassello del mosaico in espansione che si chiama Transponsonic. Se il citazionismo ai padri della psichedelia progressiva è palese, ci sono però alcune soluzioni
che emergono e fanno scattare la scintilla dell’interesse: l’uso di strumenti tradizionali, i vocalizzi con
le tecniche estese (che ricordano il genio di Demetrio Stratos) e la manifestazione di un’indipendenza
sonora che si discosta dal mainstream e che getta le basi per il futuro. Seminale.
Hermetic Brotherhood of Lux-Or - Urano3
Un’ora di improvvisazione a cavallo tra la psichedelia pinkfloydiana, il rock sbilenco degli Ex e le krauterie dei Can. Chitarre cosmiche con riverberi lunghissimi, vocals che ululano un rituale a divinità ai confini
del sistema solare e intersezioni con suoni analog post-gioventù sonica. Registrato a New York e promosso dal joker Damo Suzuki è la prima prova autoprodotta dall’etichetta che varca i confini dell’isola.
Il segnale che la pazzia strutturata di questi ragazzi non è posa, bensì tradizione che si incarna nel suono
rock contemporaneo.
Andrej Porcu - Disturbi concreti nel disordine dei sogni
L’ultima visione dell’eremita. Flauti e altri strumenti dell’isola, noise, percussioni, voci in echi spastici e un
pieno di pazzia che confermano la visione Transponsonica. A cavallo tra avanguardia e tradizione. L’one
man band che esplora in solitudine i molteplici mondi della trance. Un punto di partenza che contiene in
sè tutte le anime del suono transponsonico, un’installazione perpetua in omaggio alle divinità ancestrali
sarde. Andrej disturba anche i nostri sogni.
India Von Halkein - Mnetha
La seconda generazione transponsonica. Dopo i fondatori che partono dal teatro per approdare al
drone rock,Von Halkein varca la soglia dell’elettronica e si viaggia sui territori del misticismo infarcito di
loop tribali. Cose che nei 90 avevamo sentito a Goa e nelle rielaborazioni degli O.R.B.. Qui si lascia da
parte il clubbismo e si punta sul rito. L’elettronica a servizio della terra. Un canto che scorre lento ma
inesorabile verso territori mentali à la Apocalypse Now. Pronti al trip?
(Un ringraziamento particolare a Roberta Pasella)
Tune In /
31
È
MONDO NOSTALGIA
LE SETTE VITE DELL’EXOTICA
Cosa c’è dietro quei dischi strani che, tre lustri fa, tornarono dall’anticamera
della memoria a reclamare il proprio valore?
A Walk On The Memory Side
fatta così, la memoria: un momento ti schiaffeggia e quello dopo ti commuove; alterna
una carezza alla lacrima facile ed è culla meravigliosa se non ne abusi. Lo sa fin
troppo bene chi traffica col pop e la sua seduzione, col senso di artificiale ed effimero che, invece,
nasconde un’attenzione creativa da lasciare senza
fiato. Per definizione faccenda sfuggente, è mistero che tutt’ora spinge critici e ascoltatori avvertiti
a pontificarvi sopra. Un gioco di maschere e reinvenzione del passato, costruisce in noi uno spazio
parallelo e da lì, incessantemente e talvolta in modo
subliminale, riadatta i cascami della cultura di cui è
parte integrante e, di rimando, contribuisce a plasmare. quanto legato a significativi immaginari retrò
- exotica, easy listening e tutte le musiche incredibilmente strane - funziona da coperta di Linus, adeguatamente confortevole e affettuosa con n valore
aggiunto di sperimentalismo istintivo. Il problema
è quando, grattando sotto la superficie, emergono
stridori e risacche inquietanti; quando ciò da cui
si cercava rifugio si ripresenta ineluttabile. Non un
caso, allora, che le musiche di cui parleremo siano
figlie di epoche complesse e socialmente instabili,
nelle quali i cambiamenti passavano sottoterra ed
erano, di conseguenza, vieppiù rischiosi. Gli anni ’50,
i medi/tardi Novanta e l’oggi infinitamente grande o
piccolo restituiscono, con differenti gradazioni, una
sorta di deformazione prospettica dove le cose non
sempre sono ciò che sembrano. Eccoci nuovamente
di fronte quella nostalgia fantasmatica - la ghostalgia
di cui parla Simon Reynolds - cui oggi non è possibile rinunciare e che si dimostra sempre più un fertile
terreno d’indagine sonora, propellente creativo per
musiche nuove ma vecchie. Non è una puntata di
The Twilight Zone, no. Soltanto la vostra facoltà di ricordare che si sta risvegliando. Tenetevi saldi.
The Revenge Of Easy Listening
- Giancarlo Turra
32
/ Drop Out
Più che dagli anni Cinquanta, che del fenomeno exotica furono culla e detonatore (per un approfondimento qui impossibile rimandiamo al volume Mondo
Exotica di Francesco Adinolfi edito da Einaudi nella
collana Stile Libero), è da un passo a noi relativamente più vicino che vorremmo partire, cercando i
motivi per cui, ad un certo punto, generi da sempre
considerati spazzatura divennero epitome della coolness. Ricordate? Verso la metà dei ’90 prese corpo
una sorta di riabilitazione della muzak, di suoni accessori - perciò strumentali al quadrato - confinati a
hall e ascensori di alberghi, oppure colonna della filodiffusione apparentemente innocua dei supermercati, che occulta(va) fini di persuasione subliminale.
Il fatto è che ne avevamo le scatole piene del rock
“indie” vero e di quello falso, degli avanzi del grunge
- ultimo rialzarsi di cresta del “rock come lo conoscevamo” chiusosi in mercimonio e tragedia - e ci
guardavamo intorno: jungle e drum ‘n’ bass erano
sugli scudi, i rocker non avevano ormai più ritrosie a danzare dopo aver consumato Screamadelica.
Mancava qualcosa, però, tra il brit-pop e la nuova
onda della nuova onda, tra un Chris Isaak intento a
fabbricare in vitro dei ’50 mai esistiti e altri ex duri e
puri che si rifacevano il trucco con ironia posticcia.
Avvertivamo un vuoto pneumatico, dentro e attorno, che il post-rock s’apprestava a colmare facendo
di necessità virtù, affidandosi a freddezza, distacco
emotivo e calcolo matematico applicato. La strada
rispondeva ricreando lo stile ruvido che fu ma dimostrando che si trattava per lo più di una messinscena, per quanto piacevole, giacché l’innocenza
nel rock - dopo Pussy Galore e Royal Trux - era
faccenda morta e sepolta.
Nel frattempo s’erano sbriciolati i muri che separavano il mondo sin dal secondo dopoguerra, cosicché la società prese a correre sempre più frenetica
e noi le tenevamo dietro mentre quel buco rimaneva aperto. Niente più ideologie credibili e come
allora riempirlo? Allargando ulteriormente le frontiere dell’accettabile in musica, ovviamente guardando avanti e indietro: dandosi al crossover totale
e pescando là dove non ci s’era mai spinti: verso
pionieri dell’elettronica (qui non citati per limiti di
spazio: ci torneremo su) e indagatori di mondi che
non esiteremmo a definire, con familiare aggettivo,
“alternativi”. Come spesso accade, la domanda stimolò l’offerta - si veda il debito del “post” verso il
rock d’ascendenza germanica - ed ecco volare sugli
scaffali dei negozi ristampe inaudite. Non senza esitazioni e diffidenza, ci convincemmo che non erano
Drop Out /
33
niente male, del loro trasudare la stessa passione da
devoti visionari di taluni classici capisaldi rock. Questione di reciproche influenze e alberi genealogici,
se vi va. Così la fascia di mercato giovane si appropriò delle sonorità bislacche appartenute ai genitori,
i Denny ed Esquivel - per tacer di Burt Bacharach,
il cui ritratto campeggia sulla copertina di Definitely
Maybe degli Oasis - degli anglosassoni, piuttosto che
i nostri Piccioni e Trovajoli. Da lì decollò un florilegio di raccolte, epifanie e nuovi gruppi a loro ispirati, taluni scarsi assai e altri viceversa di peso come
Combustible Edison o Cardigans (essendo i decostruzionisti pop Pizzicato Five attivi da molto prima;
allo stesso modo, la El Records di Mike Alway funse
nei secondi ’80 da anticipatrice e ponte). Fu tutto un
recuperare suoni e strumenti vintage - e riadattarli
ingegnosamente: benvenuti, Stereolab e Pram - per
capire cosa ci fosse dietro, in una reinvenzione con-
tinua che ora rinvieni nei gruppi “neo-ye ye” italici
e, soprattutto, abita i quartieri della Trunk Records.
Ci stava la memoria e nient’altro, a fare i conti con
la crisi del presente attraverso sonorità che, per la
loro natura ausiliaria, benissimo si prestavano - si
presteranno in eterno - a essere caricate di qualsiasi
significato. Oppure, a fungere da tornasole per l’assenza di quest’ultimo e l’azzeramento che ci tiene in
scacco. Da quelle brume mitiche riemerse l’ottimismo del dopoguerra, che a rifletterci scopri evidente esorcismo dell’atomica e della minaccia del comunismo, altrove sublimata negli alieni invasori delle
pellicole d’epoca. Non è un caso, ma l’ennesimo elemento unificatore, l’evidenza che la famosa “space
age” testimoniò un’esplosione tecnologica da restare a bocca aperta, simile a quella avvenuta dagli anni
’90 ad oggi e tuttora in evoluzione: che essa fosse
utilizzata a fini artistici è illuminante chiusura del
cerchio. Quanto stride, però, la bachelor pad music
figlia del crescente benessere e relativa alienazione,
trasmessa da luccicanti impianti stereo per scapoli
all’ultima moda (chiamarli “uomini soli” restituiva
troppa disperazione); il rifarsi a immaginari esotici posticci - perché l’esotico è in primis questione
prospettica - incarnava una fuga dalla quotidianità
dell’americano medio, dalle casette suburbane tutte
uguali e dalle famiglie felicemente disperate in modo
tipicamente puritano dipinte da un film commovente e arguto come Pleasantville.
34
/ Drop Out
From Ghosts To Heroes...
Da quelle inquietudini sommerse in surreali coloranti originano la genialità di Martin Denny, considerato un po’ da chiunque il padre dell’exotica, forgiata
a colpi di percussioni e classici trasfigurati, idoli Tiki
e ritmi latini appresi nella gavetta triennale in Sudamerica. Ne risultò la cosciente metamorfosi - forte
di un’attenzione profonda alla restituzione del suono, poggiata sulla nascente stereofonia - di qualcosa
di familiare in un escapismo di paradisi più artificiosi
che artificiali. Deceduto a 93 anni nell’amata Honolulu, ispirò persino la nascita del finto esotismo della
Yellow Magic Orchestra e non ne sfuggono le ragioni. Suo braccio destro il vibrafonista Arthur Lyman,
Drop Out /
35
presto imbarcatosi
in una carriera solista dallo stile ancor più sospeso e
sognante, apici le
Yellow Bird e Taboo
che
rivaleggiano
per successo con la
Quiet Village del Maestro. E Juan Garcia
Esquivel, che godette nei ’90 di un’incredibile
quanto
inattesa riscoperta
ed è, se si parla di
puro talento musicale, l’elemento di
spicco tra quelli qui
citati? Un Genio
che superò i confini tra lounge music,
sperimentazione
tecnica e avanguardia, fuse in dischi di gradevolezza
somma. Imprevedibili, tutt’ora scintillano e riportano in auge un pianista e arrangiatore superbo nato
in un paesino messicano e finito alla prestigiosa Juilliard School di New York. Che cavò una fortuna da
musiche adattissime al crescente mondo televisivo e
approfittò intelligentemente della moda “hi-fi”, piegando allo scopo le potenzialità di strumenti mutuati dalla contemporanea come theremin e ondioline,
inserendo nel tessuto orchestrale e ritmico i primi
pianoforti elettrici. Materiale, il suo, che riporta
alla mente soggiorni in
formica e feste a base di
Martini ed è, per le svolte
pericolose eppure garbate che l’attraversano,
nient’altro che innovazione resa di pubblico domino, ossia “pop music”
nell’accezione più vera
e profonda. Sirena che
richiamò anche Les Baxter, che lasciò la promettente carriera di pianista
da concerto per l’accessibile jazz di Mel Tormé
e Artie Shaw. Diventato
arrangiatore e direttore
36
/ Drop Out
d’orchestra per la
Capitol nel fatidico
1950, colse l’attimo per dedicarsi
a colonne sonore
e lp come Le Sacre
Du Sauvage e Brazil
Now, in cui l’educazione sinfonica
conferisce forme
inaudite a suadenti
esotismi. Non contento e mostrando
un’americanissima versatilità da
showbiz dirà la
sua sul folk-rock
e finirà alla corte
di Roger Corman,
altro arti-genio di
prim’ordine. Da
uno che intendeva
e proponeva dischi alla stregua di viaggi turistici sonori evocando suoni selvaggi e pagani non poteva
non raccogliere l’ammirazione di David Toop e che
ciò vi basti.
Altro nome da leggenda (in tutti i sensi…) è
Yma Sumac: circondata da un alone di mistero, la si
spacciava per discendente di regnanti Incas, mentre
era una casalinga di peruviani natali battezzata Zoila
Augusta Emperatriz Chavarri Del Castillo. Contava
poco o nulla, giacché la Nostra - passata a miglior
vita nel 2008 - possedeva un’ugola fenomenale
di cinque ottave, partita dall’orchestra del
marito e calamitata poi
dall’onnipresente
Capitol, pronta nei ’50 a
farne una stella di prima
grandezza con Les Baxter. Contando anche
su presenza scenica e
fascino non indifferenti,
arrivò persino a esibirsi
oltrecortina, senza mai
abbandonare le scene
e anzi godendo d’un ritorno di fiamma verso
fine ’80. Il segreto è da
cercarsi con tutta pro-
babilità in corde vocali che viaggiavano disinvolte da
123 a 2270 hertz, spaziando dal baritono al soprano
e utilizzando persino la “doppia voce” come nella
tradizione del canto di Tuva. Roba dell’altro mondo,
se non di un’altra era: che fosse effettivamente una
principessa precolombiana? Difficile dirlo, così come
difficile è catalogare Eden Ahbez, che vergò il superclassico Nature Boy e diede alle stampe nel 1960
Eden Island, lp che mischiava exotica e poesia beatnik in modo così spericolato da risultare credibile
oltre l’eccentricità dell’idea. Nato Alexander Aberle
a Brooklyn sul principio del XX secolo e trasferitosi
nel secondo dopoguerra in California, lo dici tranquillamente un proto-hippie in virtù del look della
vita misticheggiante da vegetariano all’aria aperta. Il
che non gli impedì di far incidere il successone di
cui sopra a Nat King Cole intascando bei soldoni,
registrare jazz-poetry e obliquo surf e rock & roll.
A mo’ di cerniera sul passaggio da quest’ultimo a
rock e basta, sappiate che una fotografia ritrae Ahbez in studio nel ‘66 con Brian Wilson.Vi sarà ormai
ben chiaro, quanto certe sonorità si siano riverberate per anni e come artisti eccelsi (farne la lista
porterebbe via pagine su pagine; e, a dire il vero, di
levarvi il gusto della ricerca non ce la sentiamo…)
e sovente tra loro diversissimi vi abbiamo attinto.
Un segreto ci dovrà pur essere ed è lo stordimento
dolcemente naif restituito da musiche che le parole
e l’analisi sociologica faticano a descrivere. L’incanto e la gioia indicibile della prima volta, quella che
veramente non si scorda mai. Del resto, lo scriveva già secoli fa un poeta spagnolo che la vita altro
non è che sogno. A noi, però, tocca acchiapparlo per
la coda e consegnarlo a una possibile realtà, anche
solo per il breve - incancellabile, però - spazio di una
canzone.
Drop Out /
37
Hexlove
L’attimo della creazione
Un marasma free-psych-weird. Questo l’humus, eppure
Hexlove germoglia fondendo stimoli e riferimenti diversi in un,
chiamiamolo, potenziale pop
- Stefano Pifferi
N
ello sterminato marasma delle uscite catalogabili, di volta in volta, come free-psych o come
weird, c’è un progetto recente che ci ha attirato particolarmente per una buona (se non ottima) media qualitativa, oltre che per una capacità, post-moderna diremmo, di fondere stimoli e
riferimenti in maniera non seriosa e sempre avvincente. Il nome in questione è Hexlove, ed è
il progetto in solitaria di un 27enne (cancer, aquarius rising, scorpio moon, ci tiene a sottolineare) originario
del Sud dell’Illinois e di stanza a Portland, non nuovo al proscenio dell’underground americano. Si chiama in
realtà Zachary Dain Nelson e nasce come batterista. Lo abbiamo sentito sia negli Who’s Your Favorite
Son, God? (trio prog-psych-metal in fissa coi Magma, con un album su Holy Mountain) sia nei Prints, duo
condiviso con Kenseth Thibideau (un paio di release su Temporary Residence), ma è con il nom de plume
38
/ Drop Out
Hexlove che il ragazzo s’esprime davvero.
Qui lo spettro di strumenti e riferimenti che può utilizzare è pressocché infinito perché Zak è uno eclettico, non solo nei
percorsi musicali ma anche in quelli umani.
Uno squattrinato cronico come potrete
già aver intuito. Il classico ragazzo che per
campà, ha svolto mille lavori.
…a volte sono riuscito a vivere della mia
musica, molto più spesso no…lavoro in una
scuola materna con bambini fino all’età prescolare, uno dei migliori lavori che abbia mai
avuto, non contando quello alla coltura idroponica di pomodori in serra!.
Nelson è un artista, un outsider. Uno
borderline. Propone un mix pressochè
impossibile da catalogare sotto un unico
filone e/o termine di paragone: Hexlove
attraversa, infatti, i generi musicali senza
remore né timori reverenziali, mescolandoli e fondendoli l’uno nell’altro fino a
configurare un suono iridescente e screziato assimilabile solo a quello dell’attimo
della creazione. Con in più una leggerezza
da fare invidia e un gusto pop (seppur virato in chiave experimental) decisamente
invidiabili.
Proprio come un altro personaggio –
italiano, questa volta – che abbiamo avuto
modo di incontrare tempo addietro: Valerio Cosi. Hexlove gli è molto legato sia
professionalmente, sia umanamente. Il trait
d’union tra di loro porta il nome di Dreamsheep Records, la altrettanto giovane
etichetta messa su da Cosi da un paio d’anni a questa parte e che nel seppur limitato
catalogo dimostra appieno la versatilità del
suo deus ex machina. Proprio targato Dreamsheep è stato pubblicato un paio di mesi
fa il doppio cd a titolo Pija Z Bogiem
che ha gettato ulteriore luce sul progetto
Hexlove (il disco è stato ottimamente recensito praticamente ovunque), tanto che a stretto giro di posta sono stati messi in circolazione – proprio
in questa tarda primavera/inizio estate – altri lavori di Nelson per importanti etichette americane come
Weird Forest e, soprattutto, Porter Records. Prima di proseguire oltre però, bisogna fermarsi, fare un bel
respiro e fare un passo indietro per mettere un po’ d’ordine nella carriera di Hexlove.
S top / rewind ;
stop / play
Per ripercorrere le tappe essenziali che hanno portato Nelson/Hexlove ad una tale, spaventosa crescita nel
giro di un paio di anni scarsi di attività – e bypassando il cd-r a uso personale rappresentato da Quit Acting Like An Indian – bisogna andare indietro non di molto. Siamo alla fine del 2008 quando col numero
Drop Out /
39
di catalogo 70182 esce per Holy Mountain Knew
Abloom (Life’s Hood). Un esordio sostanzialmente ben accolto sul web soprattutto da siti come
Dusted, sempre attenti alle evoluzioni bislacche e
stimolanti del suono genericamente definibile come
weird america. Knew Abloom è però – come
spesso accade a molti primi passi del (non)genere
frequentato da Nelson – non proprio ben focalizzato; se è nella sua natura quasi collagistica il vivere
sulla frantumazione, gli 11 pezzi tendono troppo alla
dispersione, quasi che a muovere il tutto fossero
inarrestabili forze centripete. O una incontrollabile
impazienza creativo/comunicativa. Un insieme difficile da descrivere, un blob sonoro che è ancora un
coacervo indistinto e poco malleato di bizzarre idee
incentrate su una forma di pop contorto e bislacco,
ritmicamente acceso come sarebbe lecito attendersi e giustamente equilibrato tra analogico (il suonato) e digitale (il processato al computer). Bricolage
ritmico, pastiche retro-futurista, cantilene spastiche,
bozzetti di elettro-ritmica demente, senso del pop
astruso e fuori fase. Questo è, molto genericamente, ciò che troverete in Knew Abloom. A distaccarsi in questo bailamme di caleidoscopici input è il
distico finale rappresentato dalle quasi gemelle Excepting Eternity In The Relationship e Excepting Eternity
In The Stretch. Qui il respiro si fa ampio e le strutture
si dilatano, tanto che non è un caso che i due pezzi
sommino un buon terzo dell’album. L’esser poste in
coda all’album, poi, è
un escamotage troppo
evidente per
non farcelo
notare. Lì, in
quegli ultimi
due pezzi,
la direzione musicale
di Hexlove
ha già preso
una svolta
decisiva.
Ad
emergere – nello
specifico nei
due pezzi finali, ma più
in generale
in tutto l’al-
40
/ Drop Out
bum – sono infatti almeno un paio di ottime costanti che segneranno trasversalmente i dischi a venire: innanzitutto la capacità di saper giostrare con
una tavolozza di colori molto ampia ed eterogenea,
priva di compromessi e incoscientemente (quasi
fanciullescamente) libera di muoversi tra pulsioni
diverse. E poi l’abilità nel saper ricercare l’ampio respiro necessario affinché quelle musiche stratificate,
aggrovigliate, intricate possano liberarsi in tutto il
proprio splendore. Tratti che, a ben vedere, sono il
cuore del suono “maturo” di Hexlove, per quanto
l’aggettivo possa suonare bizzarro per un progetto
relativamente così giovane. Quelli che erano semplici e brevi abbozzi di un sentire musicale a tutto
tondo esplodono letteralmente in dischi come Pija
Z Bogiem, Your Love Of Music Will Be An
Important Part Of Your Life e l’ultimo arrivato
Want To Be Nice accentuando ancora di più la
predisposizione free e open-minded di Nelson.
Il suono di Hexlove nelle sue releases “mature”, si
diceva, è infatti qualcosa che si avvicina terribilmente al suono primordiale, quello dell’attimo della creazione. Un florilegio di suoni impazziti e divergenti
che si scatenano uno dietro l’altro, ognuno dal precedente e verso il successivo, ignari e incoscienti
di questo processo di continua evoluzione/fusione
(meta)generica. La descrizione più prossima che ci
viene in mente è qualcosa di piuttosto banale nella
sua efficacia: il suono insieme stordente e caleido-
scopico di un’improvvisa fuga di centinaia di uccelli
colorati da un albero immenso nella foresta amazzonica. Un fluire insieme cacofonico, multiforme e
soavemente musicale di un qualcosa di totalmente
inafferrabile per noi umani. Eppure inconsciamente
conosciuto. Giri di parole, i nostri. Esercizi retorici
che possono solo suggerire sensazioni e – si spera
– indirizzare chi legge verso una esperienza da provare per tentare di capire ciò che è letteralmente
inspiegabile a parole.
Nell’economia della produzione a marchio Hexlove un ruolo decisivo – come si diceva sopra – lo
gioca una piccola ma attenta etichetta americana,
la Weird Forest, tanto parca di informazioni quanto
generosissima nell’eccellenza delle sue produzioni:
Can’t, Pocahaunted, Emeralds, i fantastici
Ganglians e molti altri si alternano in un catalogo
eterogeneo per suoni e formati e che passa agilmente da drone-noise a pop in modalità lo-fi, così
come dal digitale di cd e cd-r all’analogico di tutte
le misure del vinile. Come spesso accade in questi
ambiti da coda lunga, l’attenzione verso l’edizione
da artigianato dell’underground è il fiore all’occhiel-
lo dell’etichetta, soprattutto per quel che riguarda
la grafica di copertina. Proprio le cover dei dischi
che Hexlove ha pubblicato per l’etichetta americana – Free Jazz From Slavery, doppio vinile splittato col suo alter ego Faulouah, e l’appena uscito
Want To Be Nice – offrono una possibile chiave
interpretativa per i suoni in esse contenuti.
La mostruosa figura deformemente antropomorfa
(ma non minacciosa) che svetta sul doppio vinile
– opera dell’artista americano Zach Pangborn e intitolata Entder – è per metà una creatura da immaginario fantasy, per l’altra metà smokey, l’ignoto fumo
nero di Lost e nei suoi tratteggi infantili rievoca la
ambivalenza di fondo delle musiche di Hexlove: quella tra dimensione giocosa, quasi innocente di certi
momenti, e quella oscura, latentemente minacciosa,
fiabesca ma non rassicurante di altri. Nello stesso
modo l’interno della copertina gatefold – una foto
trattata di Jesse Vasquez in cui due figure umane
nude ballano intorno ad un ibrido metà uomo, metà
albero – rimanda ad una dimensione panica, naturale, ancestrale alla quale però sottostà sempre una
tensione latente e una ansietà sospesa.
Drop Out /
41
D ilatazioni
I 15 pezzi del doppio vinile colorato sono ancora
equamente divisi tra brevi singhiozzi (ritmici, vocali,
strumentali) e momenti di più ampio respiro, ma
sempre comunque all’insegna del pastiche sonoro
ad alto voltaggio pop. Ciò non deve meravigliare,
dato che ci troviamo ancora vicini all’esordio Knew
Abloom come periodo di registrazione. Così tra
claudicanti andamenti ritmici (They’re Bronze Rusts),
folate di drones come fossero flutti imbizzarriti
(Dew, Fields Feel), dissonanze arty (Grump Up The Volume), rarefatti passaggi ambientali (Rainy Road Worrier, i vuoti di Exits Very Damp) si srotola un album i
cui riferimenti rimandano a tutto ciò che è compreso tra l’Another Green World di Brian Eno e
certe aperture da experimental pop che dai Pere
Ubu arrivano ad Animal Collective. Sono però
di nuovo i pezzi più distesi – di nuovo, non a caso,
posti al termine dei due singoli vinili – a stuzzicare l’orecchio di chi ascolta. God Is Good, Goddess Is
Great, Let Us Thank Her For Our Moon – che sin dal
titolo evoca ambientazioni paniche – condensa in
12 minuti un intero microcosmo di suoni screziati e
trascendenti, che partendo da uno xilofono trattato
si trasfigurano in un fluire di drones fluttuanti fino
all’overdrive; Psychopomp, dal canto suo, conclude
il secondo disco procedendo sulla stessa linea con
20 minuti di stratificazioni tra ambient chiesastica e
attitudine spacey isolazionista veramente prossima
alla stasi cosmica.
42
/ Drop Out
e suoni ancestrali
Nei pochi mesi che separano Free Jazz From Slavery dall’altra uscita targata Weird Forest Want
To Be Nice, Hexlove non se ne sta affatto con le
mani in mano. La creatività di Nelson, invece, deborda, manifestandosi con altri due colossi in doppio cd entrambi, Pija Z Bogiem e Your Love Of
Music…, oltre che con un 3” in cui propone una
colonna sonora immaginaria, Music From The
Film Es Noonar Covencha. Del primo doppio
cd, uscito per Dreamsheep, si è già parlato in sede
di recensione (cfr. SA marzo 2009). A colpire fu soprattutto la trasversalità del suono di Hexlove, quel
suo vivere di tensioni e opposti senza preconcetti
né preclusioni. Schizzi e guazzabugli di psichedelia
krauta e french touch spastico, pop orchestrato e
tribalismo apolide, vocalità cangiante e elettronica
post-canterburyana, vaga ambient isolazionista e
droning introspettivo si alternano e fondono in un
unicum spiazzante e originale. Nelle rece lette in
giro ad essere tirati in ballo sono spesso e volentieri
i nomi di grandi outsiders come Dimthings, Wild
Man Fischer e Residents. E non a torto.
Il secondo doppio esce invece proprio in questi
giorni per Porter, importante etichetta che ci ha
già dato – per rimanere alle nostra latitudini – il
Collected Works di Valerio Cosi e si accinge
a pubblicare la collaborazione a tre Fabio Orsi/
Gianluca Becuzzi/(Etre). Your Love Of Music… è un album bipartito in cui convivono due
delle mille anime di Hexlove: quella ansiosamente ritmica e vocalmente accesa che si rifrange in
composizioni spigolose e angolari e quella spacey,
dilatata che allarga e sfuma i confini dei pezzi, trasfigurando i dettagli in una personale idea di ambient
music. È però col secondo disco per Weird Forest,
Want To Be Nice, che la metamorfosi di Hexlove – se di metamorfosi vogliamo parlare – giunge a
compimento. Ottimamente rappresentato in copertina da quello che sembrerebbe essere una sezione
di un albero, l’album consta di una sola, lunghissima
traccia strumentale di 40 minuti in cui l’universo in
continua espansione dell’a.k.a. di Nelson si dilata in
maniera ulteriore verso un concentrato organico a
metà tra Klaus Schulze e i Sunroof.Vera e propria fusione a caldo dei mille input sonori presenti
nell’universo Hexlove, Want To Be Nice è una
iridescente foresta metaforica senza soluzione di
continuità che – stando a quanto afferma Zac nella
intervista che segue – potrebbe essere il prologo a
releases manifestamente ambient. Psych, weirditu-
dini varie, svisate kosmische; ma anche pluriorchestralità cangiante, impressionismo haunted, looping
bucolico e frammentatamente melodico. Tutto si
fonde e confonde in un unicum stordente e debordante che rimanda, ancora, all’attimo della creazione.
E se ci si ripete è perché tutto il portato di Hexlove,
non solo la lunga suite in questione, sembra essere
una polaroid in salsa ambient-massimalista di quel
momento atavico.
Giunti, a questo punto, al termine di questa indagine
su Zac Nelson e sul suo a.k.a. più compiuto verrebbe facile per via di alcuni tratti evidenti (la dimensione panica, la tendenza free, l’ascendente psych
virato kraut, una neanche tanto latente freakitudine…) accostare se non accomunare l’esperienza
Hexlove al vasto e inclassificabile panorama weird
a stelle&strisce (e non solo). Le coordinate di partenza sono a volte simili, molto più spesso proprio
le stesse. E progetti recenti piuttosto interessanti
come Ducktails, Sun Araw, High Wolf – giusto per fare qualche nome da poco giunto alla pubblicazione di dischi lunghi – non sono così distanti dal clima rigoglioso e positivamente ridondante
evocato dalle aperte strutture di Hexlove, nonostante i mezzi interpretativi siano a volte piuttosto
diversi. C’è però uno scarto evidente con un simile
panorama; e risiede nel fatto che qui non si cerca il
primitivismo, ma si trova l’ancestrale, la primordiale brodaglia, l’ur prima dell’ur. Mai dimentichi però
del fatto che il tutto rifugge seriosità preconcette
per abbandonarsi ad un gusto (e a volte a modalità)
pop. Per quanto il termine possa suonare strano a
chi non è abituato ad associarlo solo a proposte
mainstream. Di seguito una breve e frammentata intervista con
Zac ci illumina su alcuni punti salienti del proprio
sentire musicale.
Sappiamo che suonavi con band come
Who’s Your Favourite Son, God? e Prints,
ma Hexlove è il tuo progetto personale…
quando è nata l’esigenza di suonare da
solo?
Ho cominciato a suonare la chitarra dal 1994, giocherellando e registrando divertenti quanto inutili
cassettine, ma poi sono entrato in possesso di un
programma per il sound editing e ho cominciato a
manipolare suoni e samples. Quando ho trovato un
programma per il multi-tracking ho iniziato a inserire voce e batteria e qualsiasi altro strumento sul
quale potevo mettere le mani, sovrapponendoli gli
Drop Out /
43
uni agli altri. Credo che la ragione dietro ogni forma
di espressione artistica per quel che mi riguarda sia
il piacere che ne traggo nel farla, oltre che sapere
che piace agli altri…questo mi rende felice! E se agli
altri la mia arte non piace, beh, è ok lo stesso…
Sei di base un batterista, ma le tue canzoni sono debordanti agglomerati di mille strumenti diversi…cosa usi quando
componi come Hexlove?
Voce, chitarra, basso, piano, synth, tastiere, percussioni, campane, cianfrusaglie varie e tutto ciò su cui
riesco a mettere le mani.
Come procedi nella creazione di un pezzo?
Parto sempre da first takes e semi improvvisazioni in solo, in cui utilizzo più strumenti possibili per
quanto posso essere in grado di fare suonando da
solo…anche se poi impiego molto tempo a manipolare ed editare i suoni…
La tua musica è un prisma iridescente
di sensazioni e input contrastanti, tanto
che sembra il suono del momento esatto
della creazione…cosa vuoi comunicare?
Credo che la musica possa comunicare qualsiasi
cosa l’essere umano o ogni singolo organismo vivente voglia…con Hexlove – o con qualsiasi altro
moniker io usi – cerco di rompere le barriere e le
regole, superare i preconcetti su ciò che la musica
(e la vita) può essere, mostrando a me stesso in
primis che esse sono illimitate e bellissime…
Nelle prime uscite a nome Hexlove (penso a Knew Abloom) le tue canzoni sembravano brevi abbozzi di pop post-moderno; nelle ultime, ogni singolo pezzo è
un microcosmo di suoni che collidono e si
scontrano/incontrano…c’è qualche differenza, un percorso?
Cerco di incasinarmi il cervello o costringere la
mia mente a sgobbare rielaborando tutto ciò che
è soggettivamente classificato “pop” per comodità.
Per molte persone sembra valere l’assioma catchy
= pop; per me vale invece in primo luogo chiedersi
cosa è catchy, quale è il suo significato, perché la
ritengo semplicemente una parola totalmente separata dall’esperienza dell’ascolto della musica, anche
se comprendo che abbiamo bisogno di parole per
comunicare…è come guardare l’oceano e chiedersi
“cosa sta succedendo laggiù?” e la nostra mente,
che vuole sentirsi a suo agio e sicura di se stessa,
decide di dire “oddio, è bellissimo” e quell’essere
“bellissimo” è anche più semplicemente un rito ar-
44
/ Drop Out
caico che sta lì di fronte a te e ti guarda senza bisogno di parole…
Il tuo ultimo lavoro (Want To Be Nice) è
una unica lunga suite di 40 minuti che
ricorda il fluire ondivago dell’oceano…
piuttosto lontano dai bozzetti degli inizi
(Knew Abloom o lo split Hexlove/Faulouah), vero?
Si, è molto più “disteso” rispetto alle altre uscite;
credo dia a chi ascolta, e anche a me, un sacco di
tempo per rilassarsi…
Una curiosità: sul web è possibile rintracciare una uscita (non ufficiale) chiamata
Quit Acting Like An Indian…cos’è?
Non pensavo girasse ancora. Il titolo esatto è Quit
Or Start Acting Like An Indian, così chiamato
in risposta ai giovani che cercano di atteggiarsi allo
stile di vita dei nativi. Che è un bel modo di approcciarsi alle cose, ma in questo caso credo che sia
più l’attrazione per quell’immaginario che una vera
passione…
Tornando a Hexlove la tua proposta è
piuttosto originale nel panorama contemporaneo…a chi ti senti vicino, anche
solo per affinità?
Mi piacciono praticamente tutti gli album dei The
Work (misconosciuta band inglese dei primi anni
‘80, nda) oltre alla musica dei miei amici, ma principalmente sono influenzato da un sacco di altre cose
che non sono prettamente progetti musicali human
oriented…
Beh, effettivamente The Work sono piuttosto vicini alla tua idea di musica, ma
adesso sarei curioso di sapere chi sono i
tuoi amici…
Ne ho molti…Zach Hill, Valerio Cosi, Carson
McWhirter, Trawler Bycatch, Daniel White, Scapulamanci, Stephanie Simek, Shane Skogberg, Steve Rodgers…ah, quasi dimenticavo, anche il mio grande
amico Kenseth Thibideau…
Cosa intendi quando parli di “not human
oriented music projects”? il suono della
natura?
Si, il suono della natura, ma anche tutto ciò che nella
natura ha luogo: i sogni, gli animali, la terra, lo spazio,
le emozioni, la lotta, le birre, i sorrisi, il cibo, i giardini, la famiglia…
Ducktails, Sun Araw, Magic Lantern, High
Wolf e moltissimi altri (tra cui la crew
dietro Not Not Fun e, perchè no?, gli
Animal Collective)…ti senti vicino a que-
ste band? Musicalmente, esteticamente,
filosoficamente?
L’unica band che conosco di quelle che citi è Animal
Collective, ma credo che la gente compari la mia
voce a AC solo perché è ciò che la loro collezione
di dischi permette loro…comunque mi piacciono
molto AC, ma è una conoscenza piuttosto recente
e credo siano piuttosto diversi da Hexlove…penso
inoltre che ci siano decisamente troppe band col
termine wolf nel proprio nome…
Sappiamo che ami suonare live? Che tipo
di show porti on stage? Voglio dire, un
solo-show o hai una band che ti accompagna?
Di solito preparo loop vocali e di tastiere e suono
la batteria mentre racconto barzellette; ma a volte
pre-registro una idea e invito amici a suonare con
me…
Cosa mi dici in merito al fake split Free
Jazz From Slavery…chi o cosa è l’alter ego
Faulouah?
Faulouah è stato il nome del mio solo-project
per anni, e ho voluto cambiarlo perché non volevo
passare tutto il tempo a dire alla gente come si pronunciava…prendilo come una sorta di addio a quel
nome…
Hai altri progetti oltre hexlove o collabori con qualche altro musicista?
Faccio attualmente parte della band Trawler Bycatch con ZDB (Zachariah Dellorto Blackwell dei
Danava) Russ (Zonder, Ali Akbar Khan) and Jonnie
(Fistfite); ho anche finito di registrare un disco col
moniker CHLL PLL con Zach Hill (Hella, etc...)
Hai in previsione delle uscite come hexlove o magari un tour europeo?
Si, uscirà un album ambient per Thor’s Rubber Hammer, un vinile su Porter l’anno prossimo e numerosi
split 7”…inoltre, come ti dicevo, usciranno dischi
con altri progetti come Chant Oh’s, Chll Pll,Trawler
Bycatch…mi piacerebbe molto fare un tour europeo se solo qualcuno mi aiutasse…ci penso veramente spesso…
Drop Out /
45
L’ultimo album l’ha registrato probabilmente nel 2002. I suoi lavori sono tutte ristampe. Eppure è tutto numerato. Sin dall’inizio. Sociologie e dietrologie di un ragazzo chiave del lo-fi ‘00.
D al
L
Ariel Pink’s Haunted
Graffiti
Retrologia di uno scombinacarte
- Gaspare Caliri ed Edoardo Bridda
46
/ Drop Out
vivo , per cominciare
’abbiamo visto a Barcellona, in un caldo pomeriggio. Il suo concerto, all’interno del Primavera Sound, era quasi separato dal resto
dell’elefantiaco cartellone. Segno che qui, in
Europa, il suo nome non muove, almeno secondo gli
organizzatori del festival, le grandi masse. Del resto,
si sa che Ariel Pink è da sempre connotato da un senso di oscurità, da una difficoltà a inquadrare il personaggio, innanzitutto nel bilanciamento tra furbizia
e talento. Si badi: non pensiamo che questo possa
essere stato il ragionamento dei ragazzi dell’Apolo,
locale da cui nasce la preparazione dell’evento del
Forum barcellonese. Né che la ragione sia la poca
notorietà di Pink, cosa che risulterebbe oltremodo assurda oltreoceano. Riteniamo piuttosto abbia
prevalso una sorta di incapacità di posizionamento, fatto molto più interessante e comprensibile
nell’ottica del frequente astigmatismo barcellonese.
Di conseguenza, tra il concerto di Ariel e il successivo c’è stato il tempo per un aperitivo e una cena.
Ariel Pink ci è apparso nella sua minuta e curiosissima figura, agghindata con un mini-vestito femminile (provvisto di spallina che cade) che subito
ha fatto pensare alla passione di Ariel per Madonna. Accanto a lui, quattro musicisti che sembrano
usciti dagli anni Settanta. E le macchine? E il lo-fi? Vi
raccontiamo dell’episodio perché ci pare una buona introduzione a quello che oggi è la ragione sociale Ariel Pink’s Haunted Graffiti. Gente che suona
tantissimo in America, al punto che si è instaurato
un meccanismo curioso: Ariel è ormai diventato un
personaggio al tempo stesso di culto e visibilissimo.
Da un paio d’anni, ormai, lo si può andare a vedere
nei suoi continui live act, e ne abbiamo avuto la testimonianza, finalmente, anche in Europa.
Non solo; sono sempre di più la band da noi intervistate che ci raccontano dell’emozione di fare da
spalla agli Haunted Graffiti; fra gli ultimi, i Cryptacize e, per tornare al Primavera, le Vivian Girls,
che scondinzolano quando il nostro le invita sul palco per un cammeo, fatto del suono di un tamburello
in un paio di canzoni. E non può essere l’emozione di
un momento fuggevole, dato che le Girls hanno condiviso con Pink una tournée intera negli Stati Uniti,
che ha avuto il suo picco nel concerto al Coachella.
Un altro palco enorme. Pink è insomma diventato
quasi un trampolino d’onore per chi si muove nella
nicchia. Eppure, spesso le band che suonano con lui
con il tempo escono da quella cerchia ristretta. Si
ha invece la percezione che la personalità pinkiana
non uscirà mai del tutto dal guscio di un criptico lofi. Epperò, come vedremo, non si tratta di fama o di
vendite, o di circuito underground; piuttosto di una
strategia di self-marketing che trattiene il Nostro in
un duplice limbo: l’oscurità dei dischi e la fortissima
(e spassosa) presenza scenica.
P er
nulla facile ?
Non sembra per nulla facile raccontare Ariel Pink.
Tutti si perdono nel farlo. I suoi dischi sono come un
muro di gomma. Si potrebbe iniziare così: nato a Los
Angeles il 24 giugno del 1978… e rassegnarsi alla
biografia. Non che sarebbe del tutto inutile menzionarne qualche rilievo. Per esempio, per dipingere
Marcus Rosenberg è opportuno citarne gli ascolti
giovanili: la wave gotica che ha affrontato dalla prima
adolescenza, che lo ha portato ad adorare Robert
Smith e i Cure, dunque quel pop scuro di tarda
derivazione dopo-punk con cui è cresciuto e che
ha accompagnato la scrittura dei primi brani, a suo
dire, già da poco più dei dieci anni di età. I risultati
avevano già a che fare con il lo-fi, genere rispetto al
quale convenzionalmente si affianca la figura di Pink
a quella di Daniel Johnston, o di Jandek, a tutti
questi soggetti che badano a registrare ciò che gli
capita in mente, senza fare caso – volutamente o
meno – a questioni di produzione o arrangiamento.
Tra la schiera di ipertrofici lo-fiers, c’è almeno
una figura chiave che ha segnato per partecipazione diretta parte della produzione di Ariel: è Stevie
Moore, caso da manuale della bassa fedeltà di confezionamento di un disco, e tanto azzeccato nel nostro
discorso, biograficamente parlando, dal momento
che ha iniziato a fare musica negli anni in cui Marcus
emetteva i primi vagiti dell’esistenza. In realtà, pur rimanendo nel contesto lo-fi, vorremmo spostare un
poco il tiro: se c’è qualcosa a cui la produzione di Ariel Pink – cioè il suo modo di mettere a punto i dischi
– ci fa pensare quella è una band geograficamente
poco distante da lui, e generalmente accolta come
l’iniziatrice dell’estetica lo-fi, almeno nelle implicazioni concettuali del genere. Una band californiana come
Pink, che fece uso di quelle tecniche di incisione che
appannano i suoni registrati, anziché avvicinarli e
schiarirli alla nostra percezione: i Residents.
Drop Out /
47
Ariel è innanzitutto colui che nei Duemila più
ha stressato il topic del missaggio scomposto, del
lo-fi non come necessità ma come effetto. Certo,
si dice che facesse la parte ritmica dei propri brani
registrando suoni fatti con la bocca e che usasse
espedienti di bassa fedeltà anche in altre occasioni;
è innegabile però che è la “post-produzione”, per
così dire, a emergere come lo-fi nel sound pinkiano.
Detto in modo semi-serio, senza spaventare, suggeriamo che l’ottica lo-fi di Ariel vada presa non in
senso “genetico” – cioè nell’effettiva mancanza di
sofisticazione nei vari momenti che vanno dalle prime note ai solchi del vinile – ma “generativo”: in un
senso dunque più concettuale, o ripercorribile solo
astraendo ex post un processo; in altre parole, in
un’acezione di lo-fi più relativa agli effetti prodotti nell’ascoltatore, più “simulacrale” che realmente
suonato tale. Da questo punto di vista è naturale
mettere il piccolo losangelino nella scia di quei maestri del sottobosco vestiti da occhio o da frigorifero.
Citiamo a evidente testimone l’unico album della
produzione di Ariel uscito a nome (anzi cognome)
Rosenberg, Ariel Rosenberg’s Thrash & Burn,
pubblicato da Human Ear Music nel 2006, ma registrato su cassetta nel 1998, quindi attribuibile ai
48
/ Drop Out
primi anni dell’Ariel bricoleur musicale (un’opzione, quella degli anni che si intrecciano e si disfano,
a cui ci dobbiamo abituare parlando di Pink). Un
disco di fruscii di synth e quasi di elettroacustica
psichedelica di quarta mano. Un Cut-up di macchine che ricorda quei filmati dadaisti dei Residents,
appunto - ma anche gli incubi dei primi Throbbing
Gristle, seppure virati dalla mente surreale di Ariel.
Certo, non appena menzioniamo il paragone Pink/
Residents vengono al pettine molte differenze: Ariel
per esempio non si è mai dissimulato; la rete è piena
di sue interviste e non è certo difficile leggerne le
opinioni.
Gli inventori della Ralph Records invece giocarono (e giocano) proprio sull’impossibilità di legare il
loro mondo musicale a identità umane, a persone.
A dirla tutta, è un’altra la sovrapposizione meglio
tentabile tra le due entità; specie nei primi dischi,
i Residents prendevano motivi noti e popolari e,
dopo averli coperti con una spessa coltre di fumo,
li rendevano inquietanti; la patina dei Residents agiva sull’universo del noto e popolare. Ariel Pink fa a
volte le stesse cose; Worn Copy, uno dei suoi tre
dischi su Paw Tracks, cita la top 100 degli album indie di Amazon; in generale Ariel è in grado di unire
psichedelia e para-folk con la passione per Throbbing, Cure, Metallica, l’ex-re del pop Michael Jackson
e il suo idolo (ironico o reale, non è dato saperlo)
Madonna.
Insomma gli è propria un’insolenza nel viaggiare
nei decenni e nel saltellare tra mainstream radiofonico (che il nostro dichiara di non disprezzare
affatto) e quella patina di polvere malata a bassa
definizione. Tutto ciò va sotto alla categoria “pop”,
direte. E qui passiamo e chiudiamo con l’ultimo elemento di confronto con gli spettri di Frisco. I temi
musicali di costoro erano (e rimangono, nella pallida e continua riproduzione di loro stessi) qualcosa
che smuove il riconoscibile, nell’ascoltatore; ma le
forme organizzative della musica dei Residents ha
trovato molti sbocchi, difficilmente ascrivibili alla
song popolare. Ariel ha invece sempre rivendicato
di essere uno scrittore di canzoni, cioè di qualcosa
che parte da un testo e una melodia: Quando avverto una buona melodia tendo a meditarla per circa un
mese per poi, una volta individuata, sedermi con chitarra, tastiera e base ritmica – frutto della mia voce – nella
speranza di darle corpo. Le tracce le aggiungo una alla
volta, ascoltandole anche dieci volte di seguito ipotizzando variazioni oppure per scovare eventuali errori, finché
non le raggruppo nel multipista. L’ultima fase consiste di
riversare il prodotto nel mio mangianastri e ascoltare,
ininterrottamente, l’esito per un periodo volubile a seconda della situazione
Ariel è responsabile di una musica con un profondo radicamento nello sballo tra Sessanta e Settanta, ma anche un modus operandi e una finalità
dell’approssimazione che non può che far pensare
alle conseguenze dilettantistiche esaltate nel periodo punk e post-punk. Non dimentichiamoci che fu
il dopo punk a riconoscere i meriti dei Residents; e
non a caso è la musica wave che Ariel ha ascoltato
da ragazzino che diventa poi la prima a riprodurre. Così come, insieme ai suoi amici del lo-fi, Ariel
tende a ricordare più volentieri le Shaggs (band
di incompetenza strumentistica proverbiale) piuttosto che qualsivoglia antenato intellettuale (Zappa su
tutti). E il dubbio con cui iniziamo finalmente a parlare di dischi è il seguente: Pink è inventore o eterno
dilettante? Le melodie che gli riconosciamo proprie
nascono da un bruitismo analfabeta o da raffinata
ricerca dello straniamento?
G uida
facile a un ascolto
difficile
All’inizio sembra ci voglia la lucina di Geologist per
indagare la discografia di Ariel. È come fare speleologia. Ti cali giù con la fune e, stando attento a non
farti male, dove ti giri trovi fiumi come particolari di
infinitesima bellezza. E naturalmente tutto al naturale, tutto grezzo come ci piace quando affrontiamo
l’indie con la I maiuscola; quella che chiamavano “underground”, espressione da cui, guarda caso, prende
il nome il primo lavoro di Pink, ristampato nel 2007
ma risalente agli anni carbonari ‘98 e ‘99.
Registrato sul Tascam 8 e sulla Yamaha MT8X a
Santa Clara, Underground 1 (Vinyl International)
è il primo esempio della tracotante vena dello smilzo
One Man Band. Ci si trova un approccio hard wave
che verrà abbandonato per un amore sixties senza
fine ma del resto è dal lo fi che tutto inizia - e “lo”
fa rima con Lou e con Barlow, con cui Ariel condivide senz’altro una spontaneità melodica sconfinata,
debordante. Di diverso però c’è l’anarchismo e la
precisa volontà di auto sabotarsi. Sempre.
In Ghost Town è presente la follia armonica di Jandek, così come tutto il nichilismo dei Suicide; quelli
che potrebbero anche non azzeccartene mai una di
canzone e quando ce l’hanno buttarla via. Ariel però
non butta nulla. Lavora tantissimo per qualche anno
– giusto la fine dei Novanta e l’inizio dei Duemila - e
poi aspetta il raccolto. Registra sapendo che l’indie
quando lo amerà metterà a coltura questi album.
Sono semi e non opere o lavori. Nuggets degenerati
e non parti di canzonieri. Se incidi musica come un
agricoltore e dimentichi di abbeverare le tue piante
quel che ti ritrovi è una selva intricata di rami e frutti. Molti marci. Forse tutti. Qualcuno quando si salva
ti coglie di sorpresa - come Shaven, la canzone con
Drop Out /
49
la quale il ragazzo inizia l’avventura. È vicina a certi Animal Collective gravi, soprattutto anticipa
l’impostazione vocale di My Awesome Mixtape e propaggini. Ed è un caso. Come sono casuali
le canzoni e la loro successioni. Le direttrici di base
sono ben visibili: pose da storyteller maledetto, e da
lì tutta la wave, si alternano a una California dei bei
tempi andati, e da lì invece le noccioline melodiche
(Ariel come zio pazzo delle Vivian Girls? Si, esatto).
Tractor Man è un classico raga-rock, l’ennesima
replica compressa della Sister Ray dei Velvet Underground. Crusades ha un uso surreale e alla Pere
Ubu delle invenzioni e dei modi di organizzare le
armonie degli Wire di 154. E Nana chiude il cerchio attorno a un simil-Beck melmoso da Mellow
50
/ Drop Out
Gold. Ma Underground, che dà il titolo all’album, è
piena di oppiacei all’imbrunire e si porta dietro lo
psych folk della baia mentre Auto Vanity e Damage
Done sono deliziosi sketch garage rock nei quali se
ti spingi poco più in là ci trovi ancora Residents e
Snakefinger. Chissà se quegli Haunted Graffitti sono
un omaggio all’amore per i B Movie degli occhiuti di
Frisco; ciò che è sicuro è che Ariel tardivamente si
butta nella coda della moda lo-fi dei Novanta esasperandone gli intenti.
Anzi. Ariel sta cercando qualcosa. Non sa cosa
ma quelle melodie e la facilità con la quale gli vengono lo fanno andare dritto, proprio come Anton
Newcombe, verso i Sixties e non senza qualche acido. Pink registra quello sarà il seguito di Undeground
nei primi duemila. è The Doldrums, ristampato,
come quasi tutti i suoi album, anni più tardi. Sì perché il giochino di stampe e ristampe è presto detto.
E mette in discussione la sbornia che il tentativo
di orientarsi nella discografia del nostro dovrebbe
comportare. Tutti i dischi usciti sotto il nome Ariel
Pink sono numerati da uno a otto; il primo di questi,
Underground appunto, è l’ultimo che ha visto la luce
in una stampa del 2007. Gli altri, a partire proprio
da The Doldrums, escono autoprodotti a partire dal
2000, anche se è nelle ristampe che trovano una
distribuzione accettabile.
Nel secondo disco della serie calano le voglie
freak, quelle Sixties sono messe da parte, i registri
iniziano a impennarsi; ma di diverso c’è il sound
e la voglia di ottenerne uno personale. Ariel ci va
con cautela: la pacatezza è la parola d’ordine e siamo lontani dal grottesco grandguignol che seguirà.
I prodromi di questo cambiamento ci sono già (la
stessa title track ne è un esempio) ma nell’album
è la wave a prevalere. Envelopes Another Day, The
Ballad Of Bobby Pyn e X richiamano antichi amori
goth, glam e neo-romantic; con la differenza che
Pink le suona con quel fare svagato, come se fosse
uno Zappa senza testosterone. La “migliore” traccia,
virgole obbligatorie, è Let’s Build A Campfire There, un
cut up di tre arrangiamenti messi assieme con lo
scotch. Un poppetino perfetto e al contempo guasto ai massimi livelli. Ultima chicca di quel disco la
traccia di chiusura: la sonnolenta ballata Young Pilot
Astray, già uscita come singolo, ovviamente autoprodotto, nel 1999. Da ultimo, nel disco c’è la traccia da
cui prenderà il nome esteso l’avventura Ariel Pink:
Haunted Graffiti.
Lo stesso album, qualche anno dopo, sarà il primo ristampato dalla Paw Tracks. La ragione arti-
stica Ariel Pink’s Haunted Graffiti, in quegli anni, sarà
l’unica non del collettivo animale a ritagliarsi uno
spazio nel catalogo della label. Ritrovarsi parte di
un’etichetta nel momento in cui i proprietari, Panda
Bear e compagni, sono sulla bocca di tutti permette,
a lui, di avvalersi della giusta visibilità, mentre consente a noi di soffermarci su quei dischi facilmente
reperibili che poi, non a caso, risultano essere forse
i migliori.
Nel 2002, mentre i preparativi per il contratto
con la neonata Paw Tracks procedono, Pink pubblica tramite la Ballbearings Pinatas, nata l’anno
prima, due volumi della sua serie Haunted Graffitti.
In più decide di auto prodursene altri due, anche
quelli incisi chissà quando, ma prima. Escono nell’ordine, poi pluri ristampati: Scared Famous 3, FF 4,
House Arrest 5 e Lover Boy 6.
Prima di affrontarli, proviamo a dare un senso
alla procedura con cui Ariel ha diffuso le uscite negli
anni. Di fatto la produzione “numerata” è tutta registrata tra il 1998 e il 2001, e fatta uscire poi in varie
sessioni. Fatto particolarissimo, per un personaggio
che comunque ha segnato tutti i Duemila, almeno
per il versante low-fidelity. Ma in realtà è una storia
semplice. O comunque una vicenda all’interno della quale non è impossibile districarsi, trovare delle
strade e dei percorsi di lettura. Uno, su tutti, ci è
suggerito dal walzer delle ristampe. Ariel ha cadenzato le proprie uscite a più riprese, tra autoproduzioni, etichette più o meno note; e, come abbiamo
visto, ha aspettato l’ultimo turno per pubblicare, su
un vinile colorato alla maniera delle maglie hippy,
l’ultimo (e primo) capitolo: Underground.
Ci sembra allora che la procedura in qualche
modo crei uno scollamento temporale tra momento di incisione e momento di diffusione. Qualcosa che ripristina e raddoppia quella vaghezza e
quell’oscurità residentsiana di cui sopra. Ecco una
chiave possibile: il modo con cui Ariel stesso ha rimescolato le carte della propria vicenda, per creare
confusione all’interno di una storia tutto sommato
comprensibile, è un’ulteriore strategia di straniamento a sostegno della musica. In un certo senso
Pink ha trovato un piano di traduzione nel mercato musicale dell’approccio lo-fi. Anche in questo è
figlio dei Residents (ricordate la presa in giro del
litigio e della separazione dalla Ralph, cioè da loro
stessi?). Ariel ha spalmato le pubblicazioni come le
canzoni nei dischi. E la ristampa è una lente che va
di pari passo con quel lo-fi, una retorica di allontanamento dalla comprensione. Un filtro che apre le
maglie temporali, per sbriciolare il tutto in un effetto psichedelico.
Le
maglie colorate
Ma dicevamo dei dischi. Scared Famous (del 2002,
poi uscito su Hall Of Records / Human Ear Music nel 2007) si fa subito notare per i nuovi vecchi
amori che Ariel non ha più paura di confessare. Madonna (a modo suo, con falsetti queer e svenevole
pop da girl group come lo vedrebbe un camionista
pedofilo) e Michael Jackson (sempre pedofilia droga
e tutta la storia indietro fino ai Jackson Five). Di
più; c’è il mentore Moore con il quale Pink incide
Express, Confess, Cover-Up e SteviePink. Come anticipato, Sir Robert Steven Moore, prime mover delle self release, ad oggi responsabile di oltre
400 produzioni disseminate tra cd-r e cassette, è in
qualche modo una guida spirituale per Rosenberg.
Un vate conosciuto da Ariel all’epoca di The Doldrums, e, come successo con gli Animal Collective,
conosciuto grazie a uno scambio di una di quelle
innumerevoli cassette.
Ai tempi conoscevo un solo album di Moore, Everything You Ever Wanted, ma tanto bastò per rapirmi.
Ne volevo sapere di più, quindi mandai una copia di
The Doldrums al diretto interessato chiedendo anche
qualche disco dal suo catalogo. Lui fu entusiasta del mio
lavoro tanto da scrivermi una mail, la prima ricevuta sul
mio account Hotmail, ricolma di complimenti ed atti di
stima”
Nel caso di Scared Famous, Moore è espressamente menzionato negli arrangiamenti di Birds In
Drop Out /
51
My Tree; mentre sua è Shedon’t Know-Whattodowithherself. È chiaro che dietro al trattamento di certa
strumentazione c’è Stevie. Tuttavia il kitch (o trash)
pop grandguignolesco all’ennesima potenza è tutta
farina di Ariel. Tra le pieghe, inoltre, si respira un’influenza più nera, sia in scrittura sia nelle idee prese
a prestito. E, con l’aumentare di esse, tenuta salda
la produzione, la pesantezza dell’ascolto si fa tosta.
La melma raggiunge picchi nei due sensi: nel fascino
e nella fatica di star dietro al folletto. Ariel è determinato, dirige le frequenze verso l’alto e ne viene
fuori un pastiche coloratissimo e dolce da devastare
i denti al primo boccone. Con pazienza, le gemme si
schiudono: sono Are You Gonna Look After My Boys?
(fate conto Jacko giovane missato da un dj tedesco di fine Settanta), la pastella psych Baby Comes
Around, e i richiami alle passioni glam di Scared Famous (Bowie-Pop a registrare nel bagno del bar) e
ai mai dimenticati Ottanta di Girl In A Tree.
A ruota, si diceva, arriva FF (del 2002), con Stevie
Moore che compare addirittura come co-autore. E
a questo punto pare di capire meglio i gusti e le idee
messe in gioco da entrambi. Nella naive Beefbud o
nel vaudeville pop di The Kitchen Club c’è Stevie, un
folk popper amante della bassa frequenza, mentre in
tutte le stramberie e nei richiami al pop britannico
c’è Pink. Sta qui la differenza tra i due, ma anche
la profonda unione che li lega. Da citare c’è infine
Talking All The Time tipica, fastidiosa e ruspante hard
52
/ Drop Out
glam song del ragazzo. Una formula che ripeterà
all’infinito fino ai giorni nostri.
Da un punto di vista di visibilità House Arrest e
Lover Boy (quest’ultimo originariamente uscito insieme al primo, nella sua versione a 2 cd, poi ristampato singolarmente con qualche brano in più) sono
gli album con i quali Pink si fa conoscere, prima al
pubblico losangelino e poi anche in Europa, con le
ristampe (chiaramente Paw Tracks, del 2006) . Dunque sono anche gli album più ascoltati del nostro e
quelli più tipicamente Sixties. Hardcore Pops Are Fun
ha dei richiami che potremmo pure dire tropical
punk, a osare; ma a colpire è quel cheese che ora si
compatta attorno al folk.
House Arrest è un tipico lavoro di cui si direbbe
che fosse stato registrato “bene” avrebbe drizzato
sopraccigli ai piani giusti della discografia. Ha delle
melodie appiccicose che difficilmente abbandonano l’ascoltatore. Pink è integerrimo e delle due la
produzione è ancora più ondivaga, con un richiamo
alle droghe prettamente fatto di produzione e non
di scrittura. Ancora quell’effetto psichedelico. Le
canzoni non hanno nulla di stravagante, anzi, sono
gemme pop, per giunta con il sapore genuino di una
volta. Ce se ne accorge soprattutto in episodi come
Every Night I Die at Miyagis, quando effetti della chitarra e altri fattori non le sovrastano. Poi 9Alisa-01,
che inizia Eighties e poi si rimangia tutto, forse è un
caso o forse no. Gli innumerevoli richiami Sixties
che gli anni reganiani promulgarono su larga scala
sono senza dubbio un portato con il quale Ariel non
può che fare i conti; questo nonostante si apra un
periodo centrato sull’idea di canzoni perdute, che si
prende tutto il portato ideologico del lavoro.
Ariel propone quelle canzoni che abbiamo ascoltato sempre inaspettatamente e distrattamente, ma
che abbiamo giudicato le migliori della nostra vita. O
meglio, le più vere. All’esistenza o all’illusoria verità
di quel momento, Ariel deve la sua carriera, pur con
duecento fuori onda che fanno la differenza. Prendete Almost Waiting, zappiana come soltanto Zappa
nei Sessanta poteva essere. Ariel non è così cinico.
Lo fa ogni tanto ma è troppo imbambolato da sé
stesso per fare del sarcasmo da Mothers. Il suo animo queer e glam prevale; ma forse è il processo di
spreco che lo interessa. Il che lo farebbe dannatamente Duemila, nel senso che il suo faro proietterebbe una scritta su cui riflettere non poco.
È su queste elucubrazioni che arriviamo ai giorni
nostri. Quasi: alle porte del 2008:Ariel Pink, assistito
da Julia Shammas Holter e dai Bubonic Plague
interpreta, nel tributo a Madonna Through The
Wilderness, una Everybody che la stessa Signora
Ciccone si dice abbia molto apprezzato. Forse è il
passo decisivo: non tanto per l’apprezzamento di
Madonna, ma perché abbandonando il proverbiale
solipsismo, il Nostro pone le basi per quella Haunted Graffiti Band - con gente di Beachwood Sparks, Lilys, White Magic e The Samps – con cui è in
tournée ormai da un numero di mesi che non si
contano. Fatto che ci non ci faceva pensare a nuove
registrazioni.
Il neonato taglio “a band” di Ariel – per cui recentemente ha chiesto a più riprese di non considerarlo più uno che lavora da solo – ha invece
comportato un nuovo ingresso nella sala di incisione. Non sappiamo ancora che cambiamenti possano
avvenire nelle sue tecniche di registrazione e nel
processo di allattamento di un brano. Però ora c’è
un gruppo che suona come un affiatato complesso
dei Settanta. Li abbiamo visti e non ci dimenticheremo della scissione percettiva tra loro e i dischi del
solo Ariel. Il messaggio per ora lo porta una compi-
lation e un EP di freschissima stampa. Anzi, la prima
notizia è la nascita della Cooler Cat Records,
l’etichetta con cui Ariel e la sua Haunted Graffiti
Band, a partire proprio dalla raccolta Grandes Exitos,
hanno iniziato a far uscire un nuovo ciclo di dischi.
Un’etichetta personale, quindi ancora a cavallo
dell’autoproduzione; ma un nome nuovo. E se Grandes Exitos è una raccolta che ancora rende conto
dell’ortodossia lo-fi del nostro, le quattro tracce del
nuovo EP, dal titolo Flashback, ci documentano i primi
esperimenti di un gruppo che quasi suona in chiaro,
con una batteria che non esce dagli schiocchi della
lingua di Ariel ma da tamburi veri, così come “sincroniche” suonano basso, chitarre e tastiere. Una
ventina di minuti che parlano un linguaggio rockista
tra metà Settanta e fine Ottanta, insomma. Per ora
attendiamo conferme e smentite dalla loro permanenza in studio. E probabilmente non ci aspettiamo
che le nuove mosse vengano ancora dilazionate in
un caleidoscopio di stampe e ristampe. Staremo ad
ascoltare.
Drop Out /
53
Recensioni::::luglio/agosto::::
►
A-Trak - FabricLive 45 (Fabric,
Aprile 2009)
G enere : house
C’è ancora spazio per il fidgeting derivato dai Daft?
Ascoltando questo Live 45 targato Fabric pare proprio di sì. E poi se qualcuno lo chiama retrofuturismo o o electro sono solo sinonimi. Il tagging di
queste compilation diventa necessario per la tweetgeneration, ma il suono che fa muovere il culo è
duro da farlo stare in piedi senza impaltanarsi nel
citazionismo regressivo. E A-Trak (al secolo Alain
Macklovitch) ci riesce con una cosa che velocissimmamente passa attraverso Boys Noize, suoni
afro (eccezionale i bbreakz del remix di Skepta),
svisate fidget soul (DJ Class), visioni p-funk melo
(Metronomy), acidissimi filtraggi dal sapore Kitsuné
(His Majesty André, Zombie Nation), Novanta in
pomap magna (Dance Area, Rob Threezy), l’utopia ibizenca del remix degli Aeroplane e altre
mascherate che riportano sul piatto quella che una
volta ascoltavamo sulla Los Quarenta quotidiana.
Un ritorno alle sirene house necessario prima durante e dopo le imminenti vacanze. Compilation
obbligatoria per chiunque batte il quattro con l’aperitivo in mano. Sarà anche poshy direte voi, ma il
Fabric ultimamente sta puntando sulla qualità, anche
se qui si viaggia su territori che confinano con lo
sputtanamento teeny. Ancora una volta, lunga vita
al clubbing.
(7/10)
Marco Braggion
And Also The Trees - When The
Rains Come (AATT, Giugno 2009)
G enere : goth folk
Il segnale definitivo del ritorno di un genere si ha
quando anche i più improbabili figuri finiscono per
cimentarvisi, con esiti non di rado discutibili. Se vi
diciamo che questa band d’oltremanica propone da
un quarto di secolo un goth rispettoso delle regole
- l’esordio una faccenda del 1984 prodotta da Lol
Tolhurst dei Cure - e nei ’90 ha aggiunto alla ricetta spezie lounge, salvo poi gettarsi nel blues prima del
54
/ recensioni
recente rimpatrio tra le tenebre, capirete che non di
Geni si tratta ma di mestieranti. Sulla cui onestà, tra
l’altro, non ci sentiamo di mettere la mano sul fuoco
a giudicare dalle “opportune” svolte di cui sopra.
Suscita ulteriori dubbi questo cd autoprodotto che
rilegge in chiave acustica una dozzina di brani del
loro repertorio, vestendoli d’atmosfere folk fine sixties e concedendosi qualche puntata in stanze abitate dai Sophia più raccolti o in un’ipotesi di Nick
Cave a spina staccata. Senza che sconfini nell’apocalittico, un esoterismo tipicamente “british” modella canzoni d’autore meditativa collocabile tra il
giovane Momus e Bill Fay, con la differenza che
Simon Jones e soci non possiedono brani tali da
lasciare il segno e la monotonia ha la meglio ovunque, tranne che in Candace e nelle tese The Street
Organ e Vincent Craine.Volere non basta in un’epoca
in cui escono cento dischi al giorno, no.
(6/10)
Giancarlo Turra
Andrea Polli - Sonic Antartica
(Gruenrekorder, Marzo 2009)
G enere : field recording
L’album raccoglie sessanta minuti di paesaggi neutrali dell’Antartide catturati dai microfoni di Andrea
Polli nelle sette settimane (2007-2008) che l’artista ha trascorso on site con una serie di scenziati
(biologi, climatologi e geologi) presso la sede della
National Science Foundation.
In pratica è la versione seria di Eskimo dei Residents con i droni a portarsi dietro i materiali più
differenti: dai dati scentifici estrapolati dalla stazione
meteo (Countdown) ai suoni naturali (chiacchere di
pinguini, sfrigolii del ghiaccio, passi sulla neve), dalle interviste (A Modelis a Cartoon) alle trasmissioni radio (Round Montain). Territori dalla natura così
ostile e distante ma che nelle mani di Andrea Polli
acquistano un palpabile ed emotivo senso di appartenenza.
Scultoree le componenti di Sonic Antartica vanno oltre quelle che possono sembrare solamente
trascrizioni sonoro-poetiche o sensibilità ambientali
highlight
Bibio - Ambivalence Avenue (Warp Records, Giugno 2009)
G enere : bbreakz folktronica
Ascolti Bibio e ti viene in mente l’abilità del Beck nel trasformarti l’hip-hop in qualcos’altro. Poi
pensi a Warp e riconduci la mutazione liquida di Ambivalnce Avenue al vero padre e se qualcuno
ti dice che dietro al ragazzo ci sia stata una buona parola da parte dei Boards of Canada (e
dall’amico Clark) fai spallucce. Il disco è un gioiello e a dirla tutta è più vicino ai Grizzly Bear
che alle teste elettroniche. Ci trovi l’effetto sepia-tone che filtra tutte le tracce e dietro la sensibilità retrò sporcata con (il solito) analogico. Di più, succulentissimo, ci
scopri da una parte l’amore per il folk intimista e dall’altra una crema
vintage soul in cut up che è, di fatto, l’hop più fresco che tu abbia sentito quest’anno ed è quello sublime al gusto di california, non quello
robo-comandato che ti aspetteresti. In pratica, quello che avevamo già
sentito dalle parti di Belbury Poly qui si consolida, in chiave hop
ovviamente. E veniamo al disco: folktronica e cori beachboysiani (All The Flowers e la
splendida Abrasion in odore Fleet Foxes), soul-break super cool dalle
parti di Shadow (Fire Ant) e poi, l’altra faccia della medaglia, la B del breakin’ che si radicalizza sul
glitch-hop a 8 bit (Dwrcan), il funk in lo-fi (Jealous Of Roses), l’acidità ambient (Sugarette) e la disco
melò che sembra una cosa ereditata dall’italo breaking di casa Riotmaker (S’Vive).
Il percorso dall’indipendente Mush Records alla Warp è meritato. Un sogno che si avvera per
Bibio e anche per noi che mai avremmo pensato di ritrovare il folk sound degli ultimi Boards in
così buone mani. Il ragazzo si inserisce nel nuovo corso dell’etichetta: dai Grizzly Bear (e prima
direte voi con i Boards) alla reinvenzione della “vecchia” folktronica di inizio Duemila.
(7.3/10)
Marco Braggion
merito di buone discipline elettroniche combinate
alle registrazioni di campo. Energie sonore capaci di
direzioni estetiche, attenzioni percettive e relazioni
spaziali. (6.8/10)
Sara Bracco
Antimagic - Trash Symmetry
(Autoprodotto, Agosto 2009)
G enere : ghost - rock
Si apre con una nenia di 8 minuti e mezzo in cui
riecheggiano i Sonic Youth haunted di I’m Insane
(Never Learn Not To Run). Prosegue con un istintivo
sabba tribaloide (Trash Nautilus) che passando per
i Liars stregoneschi del medio periodo, unisce i
Suicide più robotici alla New Tribal America (Aa
in primis). Stordisce con l’incessante battito cardiaco da periferia post-industriale in totale disarmo
(Fake Gravity) che si liquefa in una melodia vocale
dal retrogusto demodé.
Trash Symmetry è l’esordio autoprodotto di Antimagic, duo nato da una costola di These Are
recensioni /
55
Powers e coi quali condivide il gusto per percussività nervosamente post-punk e aliena vocalità ghostrock. Roba intrisa di nyc sound fino al midollo: nera,
slabbrata, asimmetrica, poliritmica, nervosa.
Da vertigine immediata. A fornire lo scarto principale con un suono ultimamente piuttosto comune
è, però, l’attenzione e il gusto per un senso della
melodia datata, ben rappresentato dalla presenza
vocale della Cahill: perfettamente in grado di bazzicare vari registri è la variabile intorno alla quale si
costruisce la costante di un suono spigoloso, oscuro, scheletrico e, soprattutto, già molto personale.
Roba da veri outsider.
E da palati fini.
(7/10)
Stefano Pifferi
Apostle Of Hustle - Eats Darkness
(Arts & Crafts, Maggio 2009)
G enere : P op , wave
Terzo album per Andrew Whiteman, lead guitarist
dei Broken Social Scene, Julian Brown (al basso
per Feist) e Dean Stone (batterista per Sarah Harmer, Amy Millan) e dopo le 25000 copie vendute dai
due precedenti, specie il fortunato National Anthem of Nowhere del 2006, ci si aspetta qualcosa
di più dell’experimental indie pop-rock con il quale
hanno sempre amato farsi riconoscere.
Per Eats Darkness, i tre rispondono concept senza comprendere l’importanza di suonare ed essere
una band, pensare come tale e scrivere canzoni potenti.
Questa avrebbe dovuto essere la base e poi, soltanto poi, l’inzuppo e la complicazione, altrimenti
perché questa intoccabilità del formato canzone?
Each track is like tapas at the banquet of conflict, ci
risponde idealmente il chitarrista.
E tanto di cappello, è una bella chiave di lettura dei
nuovi brani, come risulta innegabile la capacità del
trio di reinventare la wave Britannica attraverso una
coralità Broken Social Scene (e qualche tocco latino
à la Sea And The Cake).
Bravi gli apostoli di Ez Speaks (caraibi, bossa, samba,
i sapori attorno all’indie song). Bravi a farci dimenticare quel che conta, ma non così tanto da nasconderci per molto l’unica freccia nell’arco, la sola Xxerses. Il resto è un misto di trascurabili siparietti alla
Who (quelli di Sell Out) e qualche innocuo fuoco
pirotecnico formato ochestral pop canadese (l’inutile Regenerosity).
Anche questa volta hanno suonato divinamente e
anche questa volta non si sono fatti amare. Senz’altro la loro dimensione è quella live.
(5.5/10)
Edoardo Bridda
Attila Faravelli - Underneath the
Surface (Die Schachtel, Marzo
2009)
G enere : elettroacustica
Due nuove prove, una per la Die Schachtel di cui
conosciamo gli ambiziosi e lodevoli obbiettivi/cataloghi, l’altra per il chitarrista/compositore Attila Faravelli alla sua prima solista.
All’ascoltatore, Underneath the Surface chiede soltanto mezz’oretta d’attenzione per una serie
(sei in tutto) di snocciolate brillanti escursioni a cui
non è concessa distinzione di titolo ma differenza di
produzione.
Consistenti ma discreti i collage digitali di Faravelli,
velata l’architettura nonostante risuonino nitide le
sezioni d’elettroacustica
e microsuono a raccogliere e accompagnare
le sorgenti (percussioni
elettroniche, campi di
registrazioni, bozzetti in
corde, rintocchi di strumentazione, interferenze
e spaziosi turni in drones). L’obbiettivo è la superficie e il suono, indipendentemente dagli scritti che si trattino d’introduzione e sogni immaginati à la Sawako, dagli orizzonti
inquieti à la Fennezs, dai riscoperti tepori in glitch,
dalle lenti sgretolarsi à la Basinski, o dagli iniziati
avvicinamenti al ritmo più sottile (quello vestito a
nuovo dall’ulitmo Ielasi qui anche al mastering).
Intenso esordio. Sano eclettismo e garantita preparazione.
(7/10)
Sara Bracco
AutoKratz - Animal (Kitsuné Music,
Giugno 2009)
G enere : retrofuturismo fidget
David Cox e Russell Crank al debutto sulla
lunga distanza. Suoni già sentiti a migliaia di notti
passate sui dancefloor della generazione post-Crookers. I soliti filtri daftpunkiani, le solite casse taglienti e le tastierine che fanno tanto Ray Ban colorati, pantajazz e vodka Red Bull. Quello che piaceva
l’anno scorso sta mutando sempre più velocemente
innestandosi in meshin’ up furiosi o in lidi bbreakz.
Qui invece si sta fermi e si conferma che la buona
produzione non ha niente a che vedere con la creazione di nuove sonorità. Kitsuné ormai ribollita.
casione, fortunatamente (Banned Announcement) –
sottolinea. Nessuna fatica ad arrivare alla fine della
traccia quindici.
(6/10)
Gaspare Caliri
(4.7/10)
Marco Braggion
Benga - Buzzin / One Million
(Tempa, Giugno 2009)
G enere : dubstep
Il guerriero del dubstep sempre in prima linea.
Non si lascia sedurre dalle sirene techno e ci va
di ortodossia. Su Tempa, la casa madre del suono
della prima decade del nuovo millennio. Gli ingredienti sono selezionati con un’attitudine minimalista che lo riporta alle roots dub, senza step.
Sì c’è sempre quella gloominess di fondo, ma qui
si prende il binario dub. E non si pianta nessun
chiodo in 4 sulla cassa dritta. Buzzin superminimal con quella secchezza sporcata dagli echi ancestrali di Kingston, One Million il lato B da conservare per il prossimo full lenght con le vocal ragga.
Benga torna alle origini pur conservando la sua
identità. Un maestro di stile verso cui le nuove generazioni incasinate col mesh del lazer bass dovrebbero togliersi il cappello. Respect, Mr Benga.
(7/10)
Marco Braggion
Bill Wells/Maher Shalal Hash Baz GOK (Geographic, Maggio 2009)
G enere : easy - listening per ottoni
C’eravamo lamentati, ultimante, di Maher Shalal
Hash Baz. Temevamo che in GOK la sua sindrome forzatamente bruitistico-bandistica investisse
anche Bill Wells.
Ascoltando si scopre invece un disco di musica quasi esclusivamente strumentale, fatta di temi poco
pretenziosi – e a dirla tutta poco impegnativi, di una
dimensione che appare – senza offese per nessuno – di accompagnamento a qualcosa. Siano esse
avvenimenti collettivi (forse suggeriti dalla struttura bandistica dell’ensemble di musicisti che suona
nell’album), o attività quotidiane; questo è un disco
di easy-listening per ottoni.
Non che questi strumenti siano gli unici presenti.
Ma è il marchio del disco, che pur va a pescare in
facili motivetti e li sviluppa con una certa perizia
(Poxy) pur non mettendo mai quella al di sopra del
resto. Al di sopra di quella muzak soffice e lievemente grottesca che la voce di Maher - solo in un’oc-
Black Dog - Further Vexations
(Soma Records, Aprile 2009)
G enere : ambient technostep
Dopo il non troppo brillante Radio Scarecrow dello scorso anno, la terza incarnazione dei Black
Dog continua il percorso di coerenza e adattamento al presente. Dunque ancora ambient di oggi che
è l’ambient di ieri (Scuba, Ital Tek) con la novità
che i ritmi sono più dritti e il tunnel trance.
L’oscurità prende le mosse dalle progressioni cosmiche di 0093, affonda nella microtronica in You’re
Only SQL, ci va di sciabolate da acido in We Are Haunted e riporta in alto i vessilli della minimal nella bella
suite Northern Electronic Soul, eppure l’album non
esplode e probabilmente l’estetica di protesta che
lo circonda non lo veicola a dovere. Forse è meglio
lasciare queste cose ai giovani.
(6.8/10)
Marco Braggion
Boris Savoldelli/Elliott Sharp
- Protoplasmic (Moon In June,
Giugno 2009)
G enere : avant jazz noise
Corde che scoppiettano, sfrigolano, fremono di
acide frenesie e trafelati frames, sciorinano arpeggi
stoppati e improvvisi unghiati lirismi, sgomitano nei
loop cibernetici come demonietti ossessivi. A cura
di Elliot Sharp, chitarrista propenso all’avanguardia visionaria e selvatica,
già al lavoro con John
Zorn, Mike Watt e
Nels Cline tra gli altri.
Quanto alla voce, invece:
sbraita, plana, gorgheggia,
vaneggia, sbriglia melismi
e brulicanti deliri, sfodera
recitati stravolti (in italiano), fluttua come un fantasma angelicato irridente,
invasato, assorto.
Ne è artefice Boris Savoldelli, estroso vocalist e performer di cui l’anno scorso apprezzammo il buon
Insanology.
A quest’ultimo si devono anche le elettorniche, brodo di coltura che avvolge, aspira, fagocita, confonde,
recensioni /
57
trasfigura tra perturbazioni, guizzi, tic, reiterazioni e
rimbombi. Il risultato è che questo Protoplasmic
suona come uno scrollarsi di dosso la rigidità delle
sovrastrutture prima d’immergersi nell’intimità cosmica, tuffo free quindi libero, liberato e liberatorio
nel bagno nero dell’anima, verso l’origine profonda
e friabile, sbracciando a ritroso con spasmi patafisici
lungo fremiti kubrickiani e tarkovskiani (palesemente rievocato fin dal titolo dell’onirica Nostalghia),
cavalcando inquietanti fantasie nel vuoto galattico
e cellulare, tra derive ipnotiche e assalti fuzz-noise
(nella formidabile Prelude To Biocosmos Pt.Two).
Non sarà pane quotidiano, ma è uno spuntino di
alterità auspicabile per chiunque.
(7.1/10)
Stefano Solventi
Brian Jonestown Massacre Smoking Acid EP (A., Maggio 2009)
G enere : P sych shoegaze R ock
Pubblicato sull’amata A (come anarchia) records
(l’etichetta personale) e corollario del precedente
My Bloody, come lo chiama ancora lui, Undeground, Anton il bruciato dà alle stampe quest’eppì
nella più classica delle usanze del biz. Smoking Acid
EP serve come passpartout per aprire la torunée
americana dei nuovi
Brian Jonestown che
per la cronaca non sono
più totalmente stellestrisce ma un misto di sangue berlinese e islandese.
I nuovi 25 minuti nascono dalla collaborazione
tra Newcombe e l’artista
nordico Jon Saemundur Audarson. Niente di clamoroso , la produzione sarà anche un tantino più hi-fi
ma i contenuti dell’album del 2007 rimangono i medesimi, compresa la qualità.
The Serious Matter è un gran bel brano. Ti fa comprendere meglio quanto la produzione del primo
disco degli Oasis era influenzata dallo shoegaze.
Come suonasse bene quel sound. Inoltre, non stanca mai sentirci quei residui Stones che, a distanza di
anni, sono ancora il terreno comune tra i Jonestown
e gli odiati Dandy Warhols.
Non di meno, con due tracce (Tempo 116.7) a suonare esattamente come se fossero out-take di Loveless, fa piacere trovare nell’eppì metà scaletta in genuflessione Kevin Shields (quasi un secondo Jones,
per Anton, vien da pensare).
58
/ recensioni
Ultima traccia Super Fucked: il cuore Spacemen
3 messo in bella mostra e un altro santino: Sonic
Boom.
Devozione, intuito, melodia e immedesimazione
mitomaniacale sono da sempre le carte di Anton
Newcombe. Sono due anni che le usa tutte a dovere e continua a farlo. Il Rock è lui.
(7.1/10)
Edoardo Bridda
Buck 65/Bike For Three! - Bike For
Three! - More Heart Than Brains
(Anticon, Maggio 2009)
G enere : hip - hop electronica
Potere di myspace. Joëlle Phuong Minh Lê,
polistrumentista, artista vivisa e produttrice belga di
origini vietnamite (primo LP nel 2006, a nome Greetings From Tuskan, con un album che nei suoi
numeri migliori, e cioè quelli più trattenuti, esprimeva una buona downtempo), fan di Buck, lo contatta
via myspace e gli manda alcuni pezzi nella speranza
che... Va a finire che ne viene fuori questo disco,
tutto costruito a distanza e via web. Basi elettroniche, molto emotive, centrali le tastiere, campioni
quasi zero, tra ambient (vedi intro e outro, ma non
solo) e influenze techno-house. Buck è un torrente
ruvido, e se ha sotto una piuma mossa dal vento
o una mitragliatrice forse non gli cambia nulla. Le
basi sono la parte debole del tutto. Spesso appaiono, come dire, ingenue, impacciate (sia nel timbro,
molto meno elegante che nell’esordio di Joëlle, sia
nelle strutture) o semplicemente non centrate: seguendo la tracklist, fin da Nightdriving, ma vedi poi il
raddoppio in There Is Only One Of Us o certi effetti
sulla voce sparsi un po’ qui un po’ lì o ancora il pezzo “rappuso”(-electropop?), con base marcatissima,
MC Space, abbastanza fuori contesto. I pezzi migliori, e pezzi davvero buoni, sono il singolo, All There
Is to Say About Love, e Always I Will Miss You, picco
dell’emotività del disco. L’idea di Buck 65 che rappa su robe elettroniche è interessante: ma a pelle la
cosa qui non sembra proprio riuscitissima.
(5.95/10)
Gabriele Marino
Burial Hex/Zola Jesus - Split
(Aurora Borealis, Luglio 2009)
G enere : weird electronic s
La Aurora Borealis è nota ai più per le sue incursioni
negli ambiti estremi del weird black metal, del drone folk e dell’elettronica più alienante; con questa
produzione però la label inglese fa un passo in più,
portando su un’unica release due realtà che, se pur
provengono della medesima regione del Mid West
sperduto degli States (Wisconsin), sono state finora
appannaggio di due scene tendenzialmente diverse.
Burial Hex è infatti un ospite fisso di casa Aurora
Borealis, mentre Zola Jesus arriva dal rooster della
Sacred Bones e dal contiguo (neo)pubblico postpunk & wave; questo split si propone dunque di accorciare le distanze tra questi due sotto-mondi. Clay
Ruby (in arte Burial Hex) offre due pezzi: un primo,
di circa quattro minuti (Go Crystal Tears), in cui prosegue nell’esplorazione del nuovo sound intrapreso
con l’ultimo album Initiations; più claustrofobico
ed ipnotico, con synth che disegnano trame sonore da film horror e uno scream praticamente black
metal, risulta essere il più pregno ed interessante
della coppia. Nel secondo (Temple Of The Flood), assai più lungo e più in sintonia con le vecchie pubblicazioni, a lunghi passaggi ambientali seguono forti
distorsioni accompagnate da percussioni tribali, dai
suoni dilatati di un organo ed dalle insolite note di
un piano esotico. Zola Jesus, invece, in collaborazione con (l’ex-fidanzato?) Dead Luke, propone il
pezzo più lungo e sperimentale della sua breve carriera; Julius & Ethel è infatti un lungo mantra di quasi
venti minuti che ribolle e fermenta per metà della
sua durata, per poi esplodere in un picco sismico
di cacofonia no-wave e crollare nuovamente su se
stesso, trascinandosi tra i rantoli fino a scomparire. Un progetto sicuramente ambizioso che però fa
trasparire l’ancora relativa familiarità di Nika con i
brani di lunga durata.
(6.8/10)
Andrea Napoli
Caspa - Everybody’s Talking,
Nobody’s Listening (Fabric, Aprile
2009)
G enere : dubstep
Caspa (Gary McCann), da West London, cresciuto a
pane e jungle (oggi la chiamiamo drum’n’bass) e hiphop, maturato con la botta UK garage, ex-giocatore
di basket, nel giro electronica & environs dal 2003,
su disco dal 2005, prima come Quiet Storm, poi
assieme a Rusko (Chris Mercer). Fondatore della
costola Dub Police di Storming Production, ora dj e
compilatore per Fabric. Obiettivo: dubstep. E lui si
definisce un pioniere della scena. Produzioni metalliche, echi techno-industrial, senza fronzoli. Qui gli
strumentali sono ottimi, belli secchi, dall’iniziale Low-
Blow a Marmite (radar di tastiere e bubbles), fino
al dittico ultra-robotico, vedi i titoli, The Terminator
e I Beat My Robot. C’è posto anche per un affilato
jazzofilo trip-hop, Victoria’s Secret, e per un remake
ambient-techno Novanta, l’ariosa Back to ‘93. I cantati sono quattro (tra rappato e accenni ragga), e
sono la parte debole disco, abbassano la media, fino
al buco nero commerciale-a-tutti-i-costi di Lon-Don
City, con una melodia e un vocoder che: uno, sono
totalmente fuori contesto, due, sono davvero brutti.
L’intro è una presentazione stile lancio radiofonico
del dj, veterano reggae-dancehall, David Rodigan. Prossime cose, ancora più cupe o al contrario
superballabili, ma si spera solo strumentali.
(6.75/10)
Gabriele Marino
Church (The) - Untitled #23
(Second Motion Records, Maggio
2009)
G enere : I ndie pop
Per la serie “ancora esistono?”, i Church, come tanti
altri, hanno passato un momento di gloria (gli anni
‘80, durante i quali toccarono per un po’ di tempo anche il successo commerciale con Heyday
e soprattutto con Starfish e il singolo Under The
Milky Way) dopo il quale i loro eterei intrecci vocechitarra hanno ricevuto
un’attenzione limitata ai
fedelissimi.
Non per demeriti artistici: il successo o meno
raramente ha avuto un
rapporto diretto con la
qualità dei loro dischi e
negli anni il livello, nonostante le tensioni interne
al gruppo e i cambi di formazione (restaurata da un
po’ intorno ai tre fondatori), si è mantenuto generalmente buono.
Lo stile continua ad essere lo stesso: le chitarre di
Wilson-Piper e Koppes, la voce delicata di Kilbey
continuano a dare vita a dischi che arrivano, per citare il titolo del precedente, “inattesi come le nuvole” e fatti di una musica caratterizzata dalla stessa
aria errante (Destination, da Starfish, ben sintetizzava l’attitudine al viaggio, ribadita dalla copertina
di Untitled, le cui macchie sembrano una carta geografica). Uguali a sé stessi e perciò mai fuori moda,
visto che certo indie-pop somiglia loro da sempre.
Untitled #23 non fa eccezione: come i precedenti, le
recensioni /
59
varianti e le sperimentazioni (tocchi di synth in On
Angel Street e Lunar, distorsioni a rafforzare ritornelli) le mostra nei nei dettagli di una scrittura riconoscibile e comunque efficace (Deadman’s Hand),
alternando momenti dal piglio più deciso (l’apertura
in medias res di Cobalt Blue) ad altri in cui prevale
l’abituale rilassatezza (Happenstance).
E alla fine sì, esistono, sono in buona forma e fanno dischi che, tra relax e riflessione, definiscono
un’idea dell’estate diversa dai carnai chiassosi del
divertimentificio.
(6.8/10)
Giulio Pasquali
Claude Von Stroke - Fabric 46
(Fabric, Giugno 2009)
G enere : minimal deep house
Barclay Crenshaw è il prodotto di tre città: Cleveland dove è nato, Detroit dove è cresciuto assieme al patronato della Metroplex di Juan Atkins
e S. Francisco dove vive ora come boss della Ditybird/Mothership. Uno che merita l’inchino Fabric.
Serie di lusso per un asso storico: seconda generazione house contaminata con l’amore per il rap.
Oggi è come se avesse visto la madonna piangere
lacrime in un club. Von
Stroke si immola alle
divinità da dancefloor e
sceglie per noi la deep
più compatta e promettente: Martin Stimmin in salsa Villalobos,
Voodeux in clubbismo
puro F Communications,
il looping barocco degli
Italoboyz (Bla Bla Bla da panico), le variazioni ibizenco sudamericane di ICS, e per finire -come al
solito- l’inedito autotargato in esclusiva per la compila (Aundy è pura ambient deep crogiolata lounge).
Eterogeneità e ottimismo per la deep. Quando i
grandi si impegnano giunge l’ora di muovere il culo.
Grande Claude.
(7.1/10)
Marco Braggion
Cluster - Qua (Nepenthe Music,
Giugno 2009)
G enere : kraut rock
Il nuovo disco di Hans-Joachim Roedelius e Dieter
Moebius , il primo in studio da quattordici anni a
60
/ recensioni
questa parte, vede il duo teutonico in gran spolvero e in perfetta sintonia con i tempi, tanto che se
non avessimo letto l’effige Cluster sulla copertina
di Qua, limitandoci al solo ascolto, molto probabilmente l’avremmo intestato ad un nuovo progetto di
stanza Raster Noton. E certificato lo stato di grazia
della coppia, spicca la produzione asciutta di Tim
Story - “non ho fatto altro”, dice Story, “che lasciare
campo libero all’estro di Moebi e Achim. E registrare” altresì nota ai seguaci del Roedelius solista.
Dunque, giusto per essere chiari Qua sfoggia tra
le migliori composizioni dei Nostri; e in alcuni casi,
vedi la sinistra Xanesra, il funk spettrale di Na Ernel
e la meccanica Malturi Sa, il raffronto con la (loro)
storia è tutto salvo un eresia. E naturalmente, se di
storia si parla, epiche rimangono le melodie aliene
di Zuckerzeit e Sowiesoso. I Cluster del nuovo
millennio richiamano quelle atmosfere e le adattano, come mostrano le circolari trame di Flutful, il
motivo da cartoon in Albtrec Com e la world music
di Gissander (prossima nel mood ai Rechenzentrum di Director’s Cut), al presente. Un presente che li vede oltremodo protagonisti.
Lunga vita, sempre, Cluster.
(7/10)
Gianni Avella
David Last/Zulu [MC] - David Last
vs. Zulu - Musically Massive
(Staubgold, Giugno 2009)
G enere : electro - ragga / dancehall
Anticipato da un mini a fine 2008, ecco il long playing
per David Last, musicista e produttore di Brooklyn (all’attivo, tra le altre cose, un ottimo album
di electronica downtempo, The Push Pull, 2005,
Agricolture; anche artista visivo, collaborazioni importanti tipo MTV-Japan e il MOMA di NY), e Dominique Rowland aka Zulu, MC panamense di
stanza a Chicago, quotatissimo in ambiente ragga.
Produzione molto curata, quasi sempre asciutta
(secca, vedi la legnosità di License to Kill), se non proprio minimale (l’iniziale Ever Ready, charleston, clap
e due note di piano), poche sbracature (Necessary
Evils), piuttosto varia, esce fuori dal ghetto di genere
(dancehall), per addentrarsi in territori soprattutto
electro-funk, con strutture techno (l’uptempo Spanish Fly), ma anche reggae (Hit Parade, con le sue
aperture nel cantato), gospel (Monday Morning, coi
suoi cori), fino a lambire addirittura il latin (con i
sambeggiamenti della conclusiva Uptown Party Life),
il tutto ovviamente virato ragga dal cantato di Zulu
highlight
Clark - Totems Flare (Warp Records, Luglio 2009)
G enere : bbreaktronica
La Warp non perde colpi, anzi spinge sulle retrovie che ti rileggono la
storia. Il sesto disco di Clark conferma la rilettura dell’archivio della
label con lo sguardo all’oggi anche se qui siamo già al domani. E Clark
è uno che ne sa a pacchi. Pare seriamente intenzionato a disegnare
una traiettoria che dai Geogaddi dei Boards Of Canada (le tastierine
acide/aliene) ti porta ai migliori Two Lone Swordsmen. In pratica
una lama che taglia l’elettro britannica come il burro mettendoti, al di
qua, la psych e lo shoegaze e, al di là, la lirica cadaverica e il tastierismo
caciarone a base di circuiti 8bit.
Di più, in mezzo, c’è tutta questa voglia di overture che ti viene fuori come urgenza misurata
quando pensi che l’impasto è soltanto per giocare. Il ragazzo insomma i circuiti li fa sanguinare o li
sublima con ugual destrezza e a mezza strada li investe pure delle cosine che vanno tanto di moda
ora e che ritrovi nei bit poveri di Rainbow Voodoo e Future Daniel o nei breaks di Harmonic 313.
Poi, a proposito di pensare in grande, c’è del rave compresso in cameretta negli Orbital acidissimi
di Totem Crackerjack e c’è del Kid 606 con quel giusto truzzo che ci vuole. Infine gli spadaccini:
ascoltatevi il suo post punk in Growls Garden (è qui che si realizza il sogno Boards Of Canada +
Two Lone Swordsmen), Tails e Suns Of Temper per saggiare una versione decisamente più adult del
Tiga con il nero sotto gli occhi.
E’ l’album chiave per Clark. Perfetto completamento di una trilogia iniziata con Body Riddle nel
2006. C’è polpa nei suoi circuiti.
(7.1/10)
Marco Braggion
e con le pulsazioni di base funk di Last, alto potenziale (appunto) dancehall. Pezzi riusciti e contagiosi
anche per i non cultori (tipo chi scrive).
(6.9/10)
Gabriele Marino
Diaframma - Difficile da trovare
(Self Released, Aprile 2009)
G enere : R ock italiano
Dal “giorno ferito che impazzisce di luce” a dire in una
canzone d’amore “lo ha detto anche Prandelli/che i
risultati si ottengono col gioco” il passo è decisamente
lungo; ma è stato compiuto intorno all’inizio dei ‘90,
e Fiumani da tempo non è più il lirico impressionista che in due dischi e mezzo contribuì a fare la
storia della new wave italiana, bensì un cantastorie
che scartando dal dettaglio quotidiano alla riflessione generale, dal colloquiale al poetico, fa spesso
scintille.
Un cantastorie che, una volta preso completamen-
te in mano il gruppo e abbandonate “le mediazioni
necessarie per pubblicare un disco con le grosse
etichette”, va ad incidere “quando ho 10-15 canzoni
pronte”. E ha inciso tanto dal ‘90 ad oggi, sulle linee
di un rock melodico senza grossi cambiamenti stilistici, con coerenza e gli alti e bassi endemici nella
produzione di un autore, finché recentemente anche il pubblico è tornato ad accorgersi che Fiumani
era sempre stato lì.
Nell’ambito della sua seconda fase, Difficile da trovare fa eccezione solo in parte: nelle articolazioni
compositive di Dolce insonnia e Il sogno di te, dove
si accennano anche momenti strumentali (non
osiamo la parola assoli, si tratta più di abbandoni
trance), e in una sezione ritmica più aggressiva del
solito, a spingere la buona ispirazione di un Fiumani classico (Giovinezza, Perché piangi e Dura madre)
stavolta impegnato a raccontare più che l’amore (Io
sto con te - ma amo un’altra) l’erotismo - vedi, oltre
a quelle appena nominate, La bella e la bestia, nella
recensioni /
61
quale non manca un dettaglio impressionista come
“il mio umore cambiava di colpo/e sembrava l’arancio
in copertina di Low” (e che nel raccontare libido ed
età andrebbe fatta ascoltare ad un certo politico
italiano).
Non è solo il gruppo, stavolta lo sostiene anche
una buona ispirazione, e nella vasta produzione
post-1990 questo sicuramente è tra quelli che spiccano.
(7/10)
Giulio Pasquali
Dinosaur Jr - Farm (Jagjaguwar,
Giugno 2009)
G enere : indie rock
Una volta riavviato il motore, Jay, Lou e Murph non
hanno nessuna intenzione di scalare di marcia: inossidabili, immarcescibili, infaticabili, inarrestabili, immutabili, imperturbabili (continuate pure voi con gli
aggettivi), a due anni da Beyond - il migliore dei
ritorni possibili, ricordiamo - hanno già in saccoccia
dodici pezzi fiammanti e rocciosi che aspettano soltanto di essere portati in
giro per i palchi di mezzo
mondo, pronti a sfondare
le orecchie e rinfocolare
cuori e animi degli indie
rocker di ieri e di oggi.
Cavallo vincente non si
cambia, è chiaro: stessa impostazione, stessa
produzione (il fido John Agnello), stessi studios (il
canuto leader ha già tutto a casa sua, ad Amherst) cambia solo l’etichetta, Jagjaguwar.
La formula d’altronde è l’unica possibile, attendersi
qualcosa di diverso non avrebbe neppure senso: i
Dinosaur Jr. sono puro suono, espressione, essenza,
e le canzoni di Mascis (più le solite due di Barlow)
sono più che altro pretesti per incarnare tutte queste cose; nel caso di Over It, Friends, See You e Pieces
si tratta anche di manifestazioni piuttosto stuzzicanti, laddove però nel complesso annotiamo una certa pesantezza rispetto al predecessore (il fatto che
certi passaggi sembrino pericolosamente rimandare
ai Pearl Jam più che ai Crazy Horse, in effetti, dà
da pensare). Routine o meno - il cinismo resta, come
sempre, a vostra discrezione -, Farm è la definitiva
conferma che non trattavasi di sveltina, ma di nuovo
matrimonio dalle basi inaspettatamente solide. Se la
musica non è sufficiente a convincervi, forse lo saranno le parole dei diretti interessati, interpellati di
62
/ recensioni
recente da Pitchfork sulla ritrovata intesa: “We were
young and weird. Now we’re old… and weirder ”.
(6.8/10)
Antonio Puglia
Domenico Sciajno/Kim Cascone Hyaline (Bowindo, Aprile 2009)
G enere : elettronica / microsuoni
Se le giovanili collaborazioni di A Book Of Standard Equinoxes ci avevano entusiasmato per
continuità compositiva o coinvolto per dinamiche e
fluidità Hyaline vi sorprenderà per le sue imprevedibili architetture sonore.
Affinità di principi e solidità di stesure per gli scritti
di Domenico Sciajno e Kim Cascone a oggi consolidate nelle cinque tappe in scaletta di Hyaline,
materiale registrato a Palermo nel giugno del 2008
e direttamente pubblicato (dall’etichetta Bowindo
di Valerio Tricoli e dello stesso Sciajno) senza ulteriore manipolazione.
Un’inno alla forma rivolto alle dinamiche ambient
più astratte e ritratto nelle improvvisazioni elettroniche più dense e composte tra tecniche di stratificazioni (Satyrium), movimenti abrasivi (Selfing) e
sintesi dalla modulazione sottile (Glove Box).
Necessaria a svelare gli arcani per Hyaline è un’attenta rilettura. Un ascolto dai toni pacati ne evincerà le realtà confortevoli o gli oblii più profondi
(Cleistogamia), mentre i volumi più alti ne sottolineeranno le spigolosità e gli estremismi (Eulophia).
Che facciano uso di quiete o di pulsante movimento, l’architettura sonica di Sciajno&Cascone sembra
non lasciarsi scalfire ma sfoggia ancora una volta imprendibile ed ammaliante potenzialità.
(7.3/10)
Sara Bracco
Domenico Sciajno - Doves Days In
Palermo (Bowindo, Febbraio 2009)
G enere : J azz - elettroacustico / l aptop music
Distillati i duetti di Doves Days In Palermo da
alcune live-performace che nell’estate del 2008 si
sono tenute a Palermo in occasione della terza
edizione del “Doves Days”, materiale estrapolato
dall’artista Domenico Sciajno e successivamente ricombinato senza ulteriore processing.
L’elettronica qui microscopica e granulosa non gioca a veicolare o disporre il suono ma si racconta
interagendo (attraverso scelte di ritmo, tono e consistenza) e galleggiando negli intorni di quell’inalterata ed interattiva sensazione del live.
Si intende subito la matrice flessibile e l’orientata
avanguardia dei trattati dello Sciajno, che siano le
più convulse e ricercate micro-apparizioni di Gene
Coleman (Gloria), i laptop di Kim Cascone (Partocle),
gli smussati intorni di Robin Hayward tra le stasi
e le scroscianti chiusure di Colloidal o le solennità
impro di Gianni Gebbia (Eucariote).
Saranno ancora le suggestioni in lustrini di Hyaline
che catalizzano l’attenzione, rubandosi i meriti migliori, comunque sia lo Sciajno di Doves Days In
Palermo anche se leggermente minore, non perde
fascino e segna ancora un punto a favore per scritti
tanto complici quanto capaci di una certa dialettica
colta.
(6.5/10)
Sara Bracco
Dubblestandard - Return To Planet
Dub (Echo Beach, Giugno 2009)
G enere : dub
La domanda che pone questo disco è semplice: può
un Genio avere ancora qualcosa da dire dopo quaranta anni, specialmente da che ne sono trascorsi
pressoché venti dal suo ultimo autentico ruggito?
Sì, perché c’è Lee “Scratch” Perry a rendere
l’undicesima fatica dell’esperto combo austriaco
Dubblestandard (in carniere collaborazioni con
Dillinger, Mad Professor, Ken Boothe)
un avvenimento di rilievo e non l’ennesima uscita
senz’arte né parte. Non si fa schiacciare da una presenza che poteva rivelarsi ingombrante, il quintetto,
sfoggiando competenza strumentale adeguata alla
materia in bassi gommosi e nei fondali dub mutanti che ti aspetti, ancor più avendo cognizione della
presenza in tre pezzi - una minacciosa, modernista
Idiots Dub il più riuscito - di Ari Up delle Slits.
Finisce che l’album è più farina del sacco di Perry
per l’ovvia e immane influenza esercitata da costui
nell’ambito di riferimento e poi diffusasi ovunque,
dalla dance al rock.
Va benissimo, dacché ci troviamo tra le mani la sua
cosa migliore da chissà quanto e un disco che guarda al passato in modo autorevole, conscio che il suo
“qui e ora” tragga da esso la linfa vitale. L’upsetter
può così permettersi il lusso di tirare fuori dall’armadio i trucchi di sempre (Chase The Devil, Fungus
Rock) e omaggiarci di riletture dei classici Disco Devil
e Blackboard Jungle Dub; (auto)citare l’epocale Time
Boom For The Devil Dead nell’esotismo sarcastico di I Foo China e, chiudendo il cerchio, spargere
attorno a sé gli astrattismi On-U Sound tramite Let
‘em Take It e Give Thanx & Praises. Pagato lo scotto di
lievi sbavature e d’una Deadly Funny - costruita sulla
nefanda Oxygen Pt.4 di Jean-Michel Jarre! - tirata per le lunghe, accogli con piacere un secondo
cd colmo di ulteriori “versions” da dopobomba e
remix occhieggianti la techno. Ti scopri a tornarci
sopra spesso su Return To Planet Dub e - per
quanto sia difficile dire se possa rivelarsi un equivalente dello younghiano Ragged Glory - certo trattasi di zampata di classe sopraffina. Nel frattempo,
lei Mr. Perry, continui a toccare ferro, per favore.
(7.3/10)
Giancarlo Turra
Duo Alterno - La Voce
Contemporanea In Italia vol. 4
(Stradivarius, Gennaio 2009)
G enere : M usica vocale da camera
Progetto ambizioso, quello del Duo Alterno (ovvero
il soprano Tiziana Scandaletti e il pianista Riccardo
Piacentini) di dedicare un ciclo di composizioni alla
musica vocale dei compositori italiani del Novecento. Singoli volumi, pubblicati, a partire dal 2005, a cadenza più o meno annuale, che partono da un’idea
unificante, da un “leit-motiv”, come lo definisce la
Scandaletti. Il primo è costruito sul rapporto tra alcuni compositori italiani e grandi poeti a loro contemporanei
(basti ricordare, tra i tanti, i legami artistici tra Petrassi e Quasimodo
o tra Corghi e Ungaretti; il secondo (uscito
nel 2006) riflette sulla
“contaminazione”
tra
generi, lingue e linguaggi
(rappresentata da autori come Morricone,
Maderna e Sciarrino), mentre il terzo approfondisce il discorso linguistico concentrando l’attenzione su compositori
che hanno lavorato su testi in lingua tedesca (tra
cui Clementi, Manzoni e i più giovani Alberto
Cola e Luca Lombardi). Il nuovo anello della catena, che non sembra doversi
chiudere, a detta degli stessi musicisti (che abbiamo
intervistato nella rubrica I “Cosiddetti Contemporanei), raggruppa una serie di compositori che hanno tratto ispirazione, per alcune loro opere, ai classici del passato.
Tra questi si inserisce anche Piacentini stesso che,
insieme al Penderecki String Quartet, presenta la
recensioni /
63
sua An Mozart, una partitura concepita per quartetto d’archi e “foto-suoni” (un’interessante idea portata avanti dal Duo da molto tempo e che prevede
l’interazione tra suono e immagine fotografica) ed
elaborata a partire da due Lieder di Mozart.
Un posto di particolare riguardo spetta a Lachrimae
di Sylvano Busotti (“un capolavoro di ‘strutturalismo anarchico” la ha definita Riccardo) e alla bella
interpretazione della Scandaletti del testo-non testo di Cathy Berberian, Stripsody, una “partitura” che richiede capacità di recitazione e una libertà
interpretativa non indifferenti, oltre a far scattare
involontariamente, come una molla, lo scomodo paragone con la grandezza dell’autrice.
(7/10)
Daniele Follero
Ear&Now - Eclipse (Wallace
Records, Luglio 2009)
G enere : avant - rock
Una lametta a far da logo e una rappresentazione
del cono d’ombra proiettato su terra e luna ad arricchire cover e suggerire finalità ultime e/o ipotesi di interpretazione del progetto. Così si presenta
Eclipse, l’esordio lungo di Ear&Now, ennesimo
asteroide nella galassia dell’avant-rock nostrano.
Cantù, Morelli e Iriondo – loro i responsabili principali del progetto in combutta con molti ospiti (tra
cui Gianni Mimmo e Federico Cumar) – intessono
14 tracce di difficile catalogazione nel loro muoversi
dentro le musiche folk, jazz, colta, classica, rock, scavandovi a fondo un solco a volte difficile da seguire,
ma innegabilmente dotato di un fascino unico.
Musica che impasta riferimenti classici col piglio
dell’avant-rock, che (con)fonde frammenti di musiche passate e fuori moda per risemantizzarle all’attualità dei protagonisti. Un procedere ben sintetizzato dall’uso della voce (in modalità field recording
del 1927!) di Rosa Corn, ultima cantante tradizionale della Valle dei Mocheni, Trento, in Ai Möi Möi. Scavare nelle musiche non per il gusto fine a se stesso
di riesumare, bensì per ri-frequentare – in nome di
un sentire comune – tempi, suoni, spazi dell’uomo e
di uno dei suoi mezzi espressivi preferiti.
Vale per Eclipse ciò che si diceva per l’abbozzo omonimo su 3” che ne segnò il vero esordio:
quella di Ear&Now è musica di ricerca nella e sulla
musica, della sua interazione con la realtà circostante che con lo scandagliarne le potenzialità finisce con l’offrire – parole loro – l’altra faccia di
ognuno. Non un caso che l’album esca non solo
64
/ recensioni
per Wallace, Amirani e SoundMetak, ma per la prestigiosa ReR.
(7.2/10)
Stefano Pifferi
EARLabs 3 - Helix (Entr’acte,
Gennaio 2009)
G enere : elettroacustica
Un’altro trittico ma tutt’altra storia. Parliamo degli artisti Christopher McFall, Sascha Neudeck e Jos
Smolders occasionamente mascherati sotto il moniker EARLabs 3 e di Helix, progetto nato tra il
2006-2007 ad oggi pubblicato in un edizione limitata a 300 copie.
Sette mesi di gestazione e un assiduo interscambio digitale ha permesso agli artisti d’interagire con
continuità sulla materia sonora attraverso progressivi scritti d’elettroacustica.
Sebbene si respirino le più personali lezioni d’artista, l’aspetto predominante non è certamente la
singola scrittura bensì l’insieme. Esigenti ed attente
le dinamiche di struttura in stasi, le miniature atonali
(Sascha Neudeck), o l’approccio al dettaglio suggerito dalle densità in drones (Jos Smolders), dai territori in field recording e dalle combinate in texture.
Lo dicono a conti fatti le tenute di queste infinite scie
di suono che recitano rumorismi e granularità su una
liquida sezione di fondo (amplificati i brusii, i pulviscoli d’ambient o trasmesse le atmosfere più notturne e
i fondali dal fascino spiazzante e convulso).
Meccaniche del continuo per Helix, ex-suoni di cui
non è dato sapere l’origine o l’assegnazione e da cui
attendersi risposte di un certo magnetismo.
highlight
Ghost [Simon Williamson] - Freedom Of Thought (Breakin’ Bread,
Giugno 2009)
G enere : trip - hop emozionale
Produttore e dj nato a Glasgow, ora nel collettivo sud-londinese (con relativa etichetta) Breakin’ Bread, Ghost (Simon Williamson) aveva esordito su LP nel 2006 con Seldom Seen
Often Heard, buon disco indie hip-hop ben accolto dalla critica. Con questo suo secondo album, anticipato da un mini, si supera decisamente. Soprattutto, porta la sua poetica ad un livello
di maggiore intensità e maturità. “LISTENING TO THE MUSIC ON THIS PAGE IS LIKELY TO INDUCE
A WIDE RANGE OF FEELINGS”: così si legge sul suo myspace. E in effetti è chiaro da subito come
Ghost punti sul lato emozionale (nel senso più immediato, ed anche enfatico, molto “anni Novanta”, del termine) di musica e suono.
Solo cinque i pezzi rappati (feat di altri), quasi tutti ben gestiti (soprattutto l’acquosa Elevate), ma
l’hip-hop resta ancora una componente forte, e si sente poi come il
nostro sia fan di gente come Dj Shadow (mentre Move Strong, altro
ottimo rappato, sembra tanto guardare a Madvillain). Il disco però
dice davvero quello che deve dire con le strumentali: dove di hip-hop
c’è solo la tecnica cut & paste. Al cuore dei campioni, pianoforte e
chitarre acustiche, come a denunciare ascolti indie folk, indie rock o
similia, in pezzi di eccezionale efficacia come Feel Pain e Way You Feel.
Gli altri strumentali esplorano il pathos grandioso (l’iniziale, cinematografica, Return Journey, con tanto di raddoppio di tempo e assolo
acid-hard), ma soprattutto il sorriso agrodolce (The Day After, Daze, From the Beginning, altro picco). Esercizi su materiali lounge-jazz e atmosfere caraibiche i due pezzi di chiusura; spazio invece
per una caricaturina r’n’b in apertura, It’s All Love.
Meno astratto, più orientato alla forma-canzone, e meno visionario di gente come Four Tet o
Flying Lotus, ma comunque molto personale, e da tenere d’occhio. Non un capolavoro, e niente
di nuovissimo, ma un disco fatto bene, intenso e, banalmente, bello.
(7.5/10)
Gabriele Marino
(7/10)
Sara Bracco
Ebony Bones! - Bone Of My Bones
(Sunday Best Recordings, Giugno
2009)
G enere : M esh
Dalla copertina vengono in mente certi video Ottanta, specie uno dei New Order (Quello con gli
schiaffi o giù di li) e la cosa non è proprio esaltante.
T’immagini il solito prodotto confezionato per gli
altrettanto noti fighetti da passerella virati alt e non
pensi certo a quel misto di glamour sostanzioso firmato MIA e al meshing brit della più alta scuola.
Metti Miss Bones sul lettore è l’immaginario si capovolge: è veramente MIA a venire in mente e con delle differenze considerevoli, tutte racchiuse alla voce
personalità, in pratica, un altro personaggio neces-
sario nel panorama pop globale d’oggi. Bone Of My
Bones lo conferma immediatamente, ti stende con
ritmi fragranti al centro della scena e un punky pop
impattante. C’è l’energia primitiva di samba e afro,
sensualità e aggressività al canto che, diversamente
dalle pose para-politiche di MIA, muove verso una
più bitchy Siouxie al tempo dei Rapture (soprattutto
in The Muzik), dunque lontano dalle indie pacificanti
e vicino a un’energia tutta Slits.
è trasformista, produttrice e non di meno ambiziosa
Ebony, un’altra alla quale la parola grime sta stretta,
una che però non abbassa la guardia perché il manifesto è orgia black di nervi alienati white. Niente
Paper Planes in scaletta dunque, piuttosto una We
Know All About You che è già una specialità della ra-
gazza: samba guastata da una bella nube scura che
diresti di vecchia scuola Bristol ma che è tutta farina
degli illustri El Guapo, band troppo presto dimenticata che ritrovi pure nella conclusiva Don’t Fart
On My Heart , altro colpo al cuore e ritmi (eccoli)
voodoo, rime scorticate e forza d’insieme che dal
vivo non sembrano meno coinvolgenti di act assolutamente imperdibili come quelli dei Gang Gang
Dance (visti a Barcellona lo scorso maggio e wow).
Unico pericolo per Ebony: l’urgenza stessa che la
anima. Non vorrei si bruciasse come una candela.
Del resto ora come ora, non potete non aver voglia
di un’esperienza del genere…
(7.1/10)
Edoardo Bridda
recensioni /
65
Eels - Hombre Lobo (Vagrant,
Giugno 2009)
G enere : blues rock pop
Una pausa di riflessione così lunga non può passare
senza conseguenze. Deve avere un senso. Soprattutto per un artista che da sempre ha fatto della
fertilità - quel compulsivo scriversi canzoni addosso - una ragione poetica. Così, a quattro anni dal
buonissimo doppio Blinking Light And Other
Revelations, torna l’uomo dietro la maschera Eels
a dirci che si è avviata una fase nuova, fatta di dignitosa persistenza. Lo fa con un album ruvido e un po’
frettoloso. Tanto ruvido da prediligere l’impatto alla
scrittura (l’ordinaria poltiglia boogie di Prizefighter,
una Tremendous Dynamite che sgretola adenoidi
come dei Black Keys
sotto benzedrina), frettoloso sì eppure capace
d’infilare un paio di perle
nella collana, come quella The Longing che sembra una versione allibita
della beatlesiana Michelle e una That Look You Give
That Guy dal passo dolciastro e lunatico come una
nipotina sbrigliata di Here We Are In The Years (dall’album di debutto di un certo Neil Young).
Tema portante dichiarato è il desiderio, nucleo pulsante cui aggrapparsi diventando uomo, l’altro lato
in agguato capace di ribaltare il rapporto tra ragione e istinti (provocando quelle urla rugginose, tanto
adrenaliniche quanto balzane). Chiamatela se volete
licantropia, come una brezza che ti sfiora, ti affama
(Fresh Blood), lentamente ti divora finché non resti
col te stesso civile e irrequieto, insofferente ma in
fondo addomesticato, sorretto dalla speranza che
qualcuno possa cogliere la scintilla della tua diversità (Ordinary Man), e non mi riferisco a quel barbone
da unabomber talebano, per quanto si tratti di un
vezzo - diciamo così - emblematico.
Hombre Lobo è il disco gradevole di chi ormai
può permettersi di palleggiare con la propria calligrafia (una Lylac Breeze che strattona la giacchetta di
Tiger In My Tank, una All The Beautiful Things che guarda alle palpitazioni di Daisies Of The Galaxy) e
far riaffiorare antiche attitudini (il beat kinksiano di
What’s A Fella Gotta Do, i luccichii da La’s narcotizzati di In My Dreams) assecondando la tipica inerzia
di chi ha un grande futuro dietro le spalle.
(6.4/10)
Stefano Solventi
66
/ recensioni
Eildentroeilfuorieilbox84 - Ananab
(Autoprodotto, Giugno 2009)
G enere : art wave
Sono loro, sono tornati, i maniaci del titolo in reverse, i romani dal nome meno digitabile sui motori
di ricerca, gli scellerati, irascibili, carissimi Eildentroeilfuorieilbox84. Due anni dopo il breve folgorante
Omota’l, si ripropongono in lungo - ancora con
licenza Creative Commons via Sporco Impossibile
- con un concept sulla contaminazione di patrimoni
culturali e genetici, ferocemente e screanzatamente
antirazzista, intitolato Ananab (una banana invertita che diventa ananas ibrido: roba da incubo).
Nel quale ostentano veemente piglio wave, funkjazz, psych, drum’n’bass e dub, come uno scontro
frontale tra Flaming Lips, The Contortions e
Marta Sui Tubi (questi ultimi flagranti in Rivelarsi), come dei cuginastri trafelati di Runi e X-Mary
(pappatevi una acidissima Pescanoce, peraltro non
priva di additivi Stranglers), gustosamente scevri
di garbo come si conviene ad una band prodotta da
Fabio Recchia (già al lavoro per Zu, Ardecore e
Assalti Frontali tra gli altri), il cui tocco è evidente nell’impatto a muso duro de L’incontro.
Unico appunto, quei siparietti recitati, ancorché funzionali al concept, hanno il tono tra lo sbracato e il
dilettantesco che fa molto demenziale, campo minato da cui mi terrei a debita distanza.
(7/10)
Stefano Solventi
Electones (The) - If You’ll Null,
I’ll Be Void (Beatservice Records,
Maggio 2009)
G enere : P op -F olk -T ronica
Da non confondere con l’omonimo trio proveniente
dalla West Coast, gli scandinavi Electones affondano
le radici negli Xploding Plastix, pur perseguendo obiettivi e risultati molto diversi dall’electrofunk
del duo formato da Jens Petter Nilsen e Hallvard
Wennersberg Hagen. In questo nuovo progetto,
nato da una collaborazione tra i due e la cantante
Rita Augestad Knudsen, ma trasformatosi presto in
un open-project (che ha coinvolto anche altri cantanti e strumentisti), i musicisti virano decisamente
verso atmosfere distese e decisamente orecchiabili,
che ruotano attorno ad una miscela di folk ed elettronica, costruita su percussioni jazzy. Voci maschili e femminili si alternano senza mai rubare la scena ad una musica che, senza grandi sussulti,
ma con un’invidiabile leggerezza, sfugge agli sguardi
più penetranti: temi semplici e giocosi, arrangiamenti morbidi e una discreta varietà strumentale, che
accosta chitarra acustica, sintetizzatori, Theremin,
banjo e contrabasso. Peccato che non sempre gli
“ospiti” siano all’altezza della situazione, mancando
talvolta di personalità: il clone di Bjork che presta
la voce a Box Of Rain avrebbe potuto stare a casa.
Per fortuna, il simpatico country di The Non Sequitur
o le irresistibili idee melodiche di Electricity Wants
To Dance, una passeggiatina per i prati che finisce in
discoteca, sono lì a compensare le cadute di stile.
(6.6/10)
Daniele Follero
Eminem - Relapse (Interscope
Records, Maggio 2009)
G enere : hip - hop depres s ( iv ) o
Cinque anni, quelli passati da Encore, che sono un
secolo. Carriera sull’orlo del baratro perché vita
privata (?) sull’orlo del baratro: secondo matrimonio e secondo divorzio con la moglie, l’amico-sodale
Proof morto ammazzato, ovviamente la droga (la
ricaduta del titolo) con tanto di overdose. Le solite
americanate. Eminem sospetta ennesima gigantesca figurina di plastica, epocale ed effimera, alla deriva: vittima soprattutto di se stessa. Disco quindi attesissimo (eufemismo), anche solo come segnale di
presenza su questo pianeta. Ed Eminem c’è. Anche
troppo. Fin da segnali visivi chiarissimi, da territorio
marcato, stilemi portati al parossismo: un suo ritratto fatto con pasticche e pillole in copertina, il sito
dedicato al disco che pare il set di Hostel, un video
splatter con Slim Shady (che su Encore si era
suicidato...) serial killer scatenato e uno con la solita
grottesca teoria di sfottò a star del popdom USA.
Questo disco, dalla lavorazione lenta e macchinosa, ha un che di monumentale, ed è la sua cifra:
la claustrofobia. Le musiche: basi cristallizzate su
tastiere-archi-arpeggio enfatiche e ritmica strasecca. Le liriche: le solite eminemate, aspre come
agli esordi, qui ancora più macabre, e soprattutto automatiche. Con l’aggravante che adesso non
si ride (o ghigna) più. Su wikipedia e dintorni lo
chiamano “horror-pop” o una cosa del genere,
atmosfere comunque da grandguignol, e ci può
stare. Tavolozza patemica (di chi sente, non di chi
suona): oppressione, disperazione soffocata, stanchezza, soprattutto angoscia. Un’angoscia con un
retrogusto adolescenziale, di chi ascolta e mischia
Linkin Park e 50cent. Mamma mia che angoscia. Monumentale perché la sensazione che arri-
va è sì quella di una ripetizione di sé, ma portata
ad un livello superiore: autoclonazione fino alla
sublimazione.
Il disco risulta lunghissimo, settanta minuti che sembrano settecento, i pezzi lunghissimi, cinque minuti
che sembrano cinquanta, i testi lunghissimi. Un
oggetto contorto su se
stesso e involuto. La cosa
peggiore sono certi cantati, soprattutto quando distorti dal vocoder
o con accenni ragga (?)
(My Mom, Musta Be Da
Gangja). Le cose migliori, forse, a livello di rappato,
aprono e chiudono, 3 AM e Underground, la prima
come esempio di valanga di blocchi serrati, la seconda come esempio di flow.
Ultimo disco con atmosfere da disco ultimo, ma così
era già nel 2004, e infatti è già stato annunciato un
Relapse #2. Eminem sembra adesso un po’ come il
Fabri Fibra americano (per quanto il paragone sia
paradossale e perfettamente rovesciabile, e proprio
per questo anzi). Con tutto il carico di moralismoantimoralismo, simpatia-antipatia, sincerità-furberia,
(auto)analisi, sgradevolezza, incomprensione e morbosità che ne segue.
(5.5/10)
Gabriele Marino
Eric La Casa/Philip Samartzis/
Jean-Luc Guionnet - Soleil
D’Artifice (Swarming, Marzo 2009)
G enere : sculture sonore / elettronica minimale
Il progetto, iniziato nel luglio 2005 in occasione del
Liquid Architecture 6 (Austrialia) e successivamente ripreso tra l’aprile e il giugno del 2007 in una
serie di concerti in Francia, Germania e Repubblica
Ceca, si presta agli studi di fonetica e alle topografie sonore di Eric La Casa, alle indagini in texture
di Philip Samartzis e alle esperienze in opera tra
elettronica e suoni naturali dello scultore sonoro
Jean-Luc Guionnet.
Soleil D’Artifice rappresenta il punto d’arrivo
di tali indagini. I tre affrontano la forma sonora ottenuta grazie a strategie d’amplificazione, tecniche
d’improvvisazione o di scambio (elaborate in tempo
reale e alle specifiche del sito).
Le lunge soundscapes ruotano attorno a una poetica
di frammento di fonti articolate (registrazioni di campo, drones, laptop o grafie di un sassofono deconte-
recensioni /
67
highlight
Graham Coxon - The Spinning Top (Transgressive, Maggio 2009)
G enere : british folk , psych , rock
Che Graham Coxon dia alle stampe il lavoro più ambizioso e completo della sua carriera proprio
a ridosso della reunion dei Blur non può essere una coincidenza. Qualcosa dev’essersi aggiustato, decisamente: se tre anni fa – ai tempi di Love Travels At Illegal Speeds - lo avevamo
irrimediabilmente bollato come eterno teenager senza speranze, chiuso autisticamente nella sua
cameretta più o meno virtuale, ecco in risposta un torrenziale concept (quindici lunghe tracce
che raccontano l’arco della vita di un uomo, dall’alba – Look Into The
Light - al crepuscolo - November) che apre e spiega come non mai il suo
intero universo di chitarrista e autore, finalmente libero di sbocciare
dal punto di vista lirico ed espressivo. Maturità, la temuta (e spesso
abusata) parola che fino a ieri avresti esitato ad associare al suo nome,
è il paradigma di questo The Spinning Top, disco pesante e importante (non solo per durata e consistenza, praticamente un doppio), di
quelli che tracciano un esaustivo ritratto del personaggio e al tempo
stesso ne rivelano inedite sfaccettature.
Le recenti frequentazioni, in studio e su palco, di Paul Weller e Robyn
Hitchcock (qui peraltro presente in un paio di episodi) erano di per sé indicatrici della decisa virata stilistica e autoriale di Coxon verso la blasonata e gloriosa tradizione folk britannica, abbracciata con sentita deferenza e altrettanta naturalezza: i primi nomi che vengono prepotentemente
a galla sono infatti quelli di Davy Graham, John Martyn e Nick Drake, rievocati tanto nei
legnosi arabeschi della sei corde quanto nell’intimismo accorato e disarmante del tutto; la sola
presenza come ospite di un gigante del genere come Danny Thompson, d’altronde, varrebbe più
di ogni fredda e didascalica disamina track by track. è nondimeno un lavoro che va assaporato con
lentezza, The Spinning Top, per godere appieno dell’inaspettata ricchezza musicale di certi passaggi
(qua e là viene in mente il visionario Jim O’Rourke di Eureka), delle improvvise e idiosincratiche
deviazioni d’umore e di stile (lo spettro inquieto di Barrett aleggia e benedice più volte), delle
evoluzioni di arrangiamento, della bellezza cristallina di certe melodie; quelli che poi appaiono
come i suoi più grandi difetti – l’eccessiva lunghezza del programma e dei singoli episodi, nonché
la dispersività nei toni - sono in realtà piccoli pregi, una volta acquistata la corretta prospettiva e
individuata la chiave di lettura. Certo, i limiti di interpretazione (vocale, non certo strumentale)
restano i soliti, ma ciò che si è acquistato in termini di spessore e credibilità ha nel complesso un
valore sicuramente superiore; insomma, le promesse ventilate nel lontano ‘98 dall’esordio The
Sky Is Too High sono finalmente una realtà: pur con (o forse, proprio grazie a) tutte le increspature e imperfezioni del caso, la metamorfosi in songwriter può dirsi pienamente riuscita.
(7.7/10)
Antonio Puglia
stualizzato) sussurrate in enigmi e tensioni d’istanti
intorno alle fondamentali questioni di fondo da cui
attendersi esplosioni sonore più o meno atonali.Certo non spiacevole la pellicola di Soleil D’Artifice
per materia e suono in se ma difficile da metabolizzare per manierismo e mancanza di consequenzialità.
(6.1/10)
Sara Bracco
68
/ recensioni
Expo’70 - Night Flights (Fedora
Corpse, Luglio 2009)
G enere : guitar droning
Eccolo di nuovo Justin Wright aka Expo 70 pronto a rientrare nel cervello dei suoi ascoltatori col
suo flusso di droning spaziale nero pece. Non pago
di aver lasciato alla cassetta White Ohms il suo
personalissimo light side del magnificato album dello
scorso anno, Expo 70 torna sul luogo del delitto
con questo vinile colorato per Fedora.
Come al solito Wright, in perfetta solitudine e armato solo di pochi strumenti, disegna paesaggi sonori atavici, sculture di suono che rievocano il primo
ohm dell’universo sin dall’iniziale Trascending Energy
From Light: versione espansa di un 7” uscito tempo
addietro per Trensmat, il pezzo gioca di sottili equilibri tra arpeggi di chitarra in modalità hypnotic e
struggente droning da deep space, complice anche
il rumorio di sottofondo. Una strada, questa dell’interferenza da spazio profondo che prosegue anche
nelle altre tracce e caratterizza il suono di Night
Flights. Cognac Smoke, ad esempio, è il suono di un
buco nero e degli ultimi annaspanti s.o.s. lanciati da
chi vi sta precipitando, mentre Seismic Nuances si
inerpica da distanze siderali in un crescendo rotto
dal solo della chitarra. Vero e proprio suono di uno
spazio senza stelle che, nonostante l’apparente staticità, riserva sempre sorprese all’ascolto.
(7/10)
Stefano Pifferi
Falty Dl - Love Is A Liability &
Human Meadow EP (Planet Mu
Records, Giugno 2009)
G enere : IDM
Con Aphex Twin nelle orecchie, fresco di Primavera Sound, non fatico a comprendere cosa si
nasconda dietro alle tastierine analog infantili e
al chiacchiericcio angelico sui contrappunti bass
dell’iniziale Human Meadow. Falty Dl – giovane
produttore newyorchese - punta a On con il rispetto tipico dei brit: un colpo al cerchio (la scuola
Warp) e uno alla botte (wonky sound, e meglio, il
revival primi ’90 imperante).
L’intera tracklist di Love Is A Liability non farà
eccezione e nonostante ci piacciano i remember
minimal house altezza ’92 (Encompass, le balearic
Our Loss e Pink On The Inside) e il modo distante
con il quale il ragazzo approccia il dub-step (Winter
Sole Truth ecc), nulla lo nasconde dalla sudditanza eccessiva nei confronti dei modelli di riferimento più
prossimi (Mike Paradinas, D. James).
Dove è finito il funk del 12” To London? L’hip hop
dinoccolato di una Mother Beam? Rendetevi conto:
meglio attualmente il myspace che l’album. Da segnare, piuttosto, il 12” di Human Meadow con
i remixes di Vibert (versione futur kitch), Boxcutter (taglio hop) e del boss della casa Mu-Ziq (u
turn verso il dub step). A proposito, Falty, non è che
per compiacerlo devi suonare al di sotto delle tue
capacità, eh...
(6.5/10)
Edoardo Bridda
Federico De Biase - Pezzi Di Musica
(Improvvisatore Involontario,
Giugno 2009)
G enere : E lettroacustica
“Musica composta nelle e per le stanze di casa”,
come suggerisce l’autore sulle note al cdr scritte a
mano. E una riconsiderazione dell’oggetto-feticcio,
qui trasformato in confezioni artigianali e tutte diverse tra loro per copertina e sottotitoli. Uniche.
Relative. Come relativo si fa l’ascolto di questi “pezzi di musica”, (prodotti dall’autore in collaborazione
con il collettivo Improvvisatore Involontario) che
si appiccicano alle pareti, confondendosi e amalgamandosi con i suoni dell’ambiente circostante (nel
mio caso, fortunatamente, si tratta del cinguettio
degli uccellini, perenne paesaggio sonoro della mia
camera). Gli arpeggi di una chitarra emergono dallo sfondo,
costituito da field recordings, suoni glitch, effetti
sonori “ambientali” (la “mosca” protagonista dell’ultimo brano), dando vita ad un collage particolarissimo e affascinante di frammenti di vita domestica.
Una dimensione intima e personale, un contatto
“diretto” con l’ascoltatore cercato (e trovato) da
De Biase che, con disinvoltura e cognizione di causa,
mette in gioco un quarto d’ora della sua realtà.
(7/10)
Daniele Follero
Felix Da Housecat - He Was King
(Nettwerk Music Group, Agosto
2009)
G enere : retrofuturismo dance
Il titolo dice tutto. Il tempo di quel ‘Was’ ci conferma che qui si va sempre più indietro. E come la
sua amica Kitten, anche il gattone si iberna nel
suo suono e si trasforma nel fantasma di quello che era quasi 10 anni fa. Se con quel Kittenz
& The Glitz aveva scardinato l’electro del 2000,
oggi il giro di boa verso il pop suona un po’ facile per un drago come lui. L’uomo insomma sta
sempre dalla parte del dancefloor con il neon e
ci butta dentro i soliti trucchetti pop, ma a chi lo
ascolta da 10 album a questa parte e sa cosa è capace di fare, beh ci si aspettava qualcosina di più.
Quello che lo fa comunque rimanere a galla è que-
recensioni /
69
sta cazzo di ortodossia che con pochi amici riesce a mantenere in vita. Lo sapete di cosa stiamo
parlando: gli 80 delle tastierine midi, quelle voci
vocoderate che una volta chiamavamo minimal e
quei bassi in acido che oggi spopolano dalle parti di Oizo, Crookers e compagnia cantante.
Insomma, la corona l’ha ceduta, pur consapevole del
gesto. Abdica ma con classe il vecchio gatto. Perché ci sono ancora delle gemme nella sua corona:
la progressione di Elvi$ è da lacrime che Lindstrøm
si sogna, LA Ravers è l’acido con i filtri in espansione
Daft, Kickdrum è deep-trance da sballo E. Togliti di
dosso ‘sto pop e pensa a farci saltare, Felicietto. Alla
sezione moda mettici qualcun’altro.
(6/10)
Marco Braggion
Fiery Furnaces (The) - I’m Going
Away (Thrill Jockey, Luglio 2009)
G enere : avant - pop
Dopo tanti anni passati a incidere un disco più bello
dell’altro, un passo falso per i Fiery Furnaces è
quello che tanti s’aspettano per la consueta condanna a sangue freddo. Un rito che è anche un po’ la
moda americana: prima li
tiri su e poi li fai volare
giù, li schiacci a terra e
fai avanti e indietro con
la macchina (da scrivere), aspettando poi che
si rialzino e tornino a
fare esattamente quello
che tutti attendono. Anni
dopo s’intende, quando il sound si tinge vintage e la
vitalità ha bell’e lasciato il posto alla forma, e pure
a un bel tornaconto personale. Show biz direte e
biz diciamo; nel caso dei fratelli, la gente si è abituata a uno spettacolino eccentrico e mirabolante:
una cowgirl sexy e cinica e un omosessuale a gestir
tutte le quinte a suon d’ogni trucco che il rock, dagli inizi ad ora, abbia preso dal varietà (televisivo e
non). La critica ha sete di sangue. Il prodotto è sdoganato e, se la posta in gioco è uno switch pop, non
c’è miglior occasione.
Per I’m Going Away i due fratelli-quasi-non-piùindie, fanno l’unica mossa sensata da farsi: non percorrere la strada dell’ottovolante e incidere, assieme al bassista Jason Loewenstein dei Sebadoh,
una manciata di “semplici” canzoni, rinchiudendo i
vezzi avant in coda (al posto dei più canonici assoli) e costringendosi a una scrittura senza paraventi.
70
/ recensioni
L’importanza si sposta su Eleanor (suoi tutti i testi)
e il fratello si limita ai controcanti e al ruolo di, se
vogliamo, produttore. Non parliamo di canzoni canoniche però: il gioco prospettico è in sottrazione,
e se questo non è proprio il loro Sonic Nurse,
la macchina eccentrica è compressa con momenti
free improvvisi ma perfettamente al loro posto.
Il passo più importante dunque sono i testi e il banal
pop, quello da canticchiare e quello che s’appiccica,
e se questo non ci stupisce che riesca facile ai fratelli, neanche ci sorprendono le canzoncine démodé 100% Fiery ficcate in una serie di tragicomiche
ballate e mid tempo.
La misura del lavoro è data dalla riuscita dell’intreccio arrangiativo-lirico: in primis, il format che
conserva quel senso drammaturgico da rotocalco
precedentemente indagato amplificato però delle
componenti di tradite speranze e ideali, poi, l’ironia
costantemente sottopelle agli arrangiamenti, dopodiché, in ordine, l’isteria irresistibile con la quale
Eleanor affastella le rime quando tutto si corrompe,
le citazioni ai drammi sentimentali cinematografici
newyorchesi (Allen in primis) che sfociano nei citati
momenti liberatori del free e, non ultima, la varietà
con la quale queste situazioni s’intrecciano nella linearità autoimposta.
Tutti elementi di un lavoro che si vuole classico e lo
sarà per buona metà della scaletta. I’m Going Away
(cover di un traditional di Walter Hawkins),
Drive To Dallas, Cut The Cake e Even In The Rain (coi
già mitici anatemi “If I see you tomorrow I don’t what
I will do” e “When I Heard The News I Nearly Lost My
Beath… How Could It Be True”), The End Is Near (la
migliore naïf song), Charmaine Champagne (la marcetta country glam con momenti televisivi), sono
già i pezzi da antologia. Poi il livello scende, ma non
senza bei momenti. Non ce ne vogliamo. Non è il
momento di fare i baffi a manubrio.
(7/10)
Edoardo Bridda
Floating Action - Floating Action
(Park The Van, Giugno 2009)
G enere : soul , garage , dub
Progetto e moniker del produttore e musicista
Seth Kauffman, con all’attivo un paio di album
tra 2006 e 2007, Floating Action applica perfettamente il concetto di approccio D.I.Y., sia come scelta pratica che estetica. Il Nostro ha infatti registrato
interamente il disco da solo tranne pochissime eccezioni.
Floating Action riprende molte delle sonorità
della Park The Van, etichetta di New Orleans che
vede nel suo roster tra gli altri Dr Dog e Spinto
Band; una miscela di tropicalismo, dub, folk, blues,
garage-rock, soul, gospel e country ben tenuti insieme dalla mano sicura di Kauffman, novello Beck
odierno.
Abbondano allora ritmi in levare, linee di basso profonde e penetranti, soul gospel e garage a volontà,
ritmi caraibici, che oltre al già citato Beck Hansen
dei primi folgoranti anni, ci ha ricordato operazioni
simili anche in anni precedenti, come le riscoperte
in tal senso da parte di un Ry Cooder. Si aggiunga
anche una buona dose di psichedelica passata attraverso un folk obliquo, con un’attitudine pop a far da
collante all’intero disco.
Floating Action ha dalla sua un’attitudine che ci è
piaciuta molto.
(7/10)
Teresa Greco
Ganglians - Monster Head Room
(Woodsist, Giugno 2009)
G enere : psych - pop
Dopo il 12’’ di recentissima pubblicazione su Woodsist, torna il gruppo di Sacramento, che tanto sta
piacendo oltreoceano e non solo, con un full-length
pubblicato in Cd dalla stessa label newyorchese e in
versione LP + 7’’ dalla Weird Forest.
Rispetto al sopracitato mini-album, questa nuova
produzione segna alcuni punti di scarto; benché
infatti restino sporadici episodi che richiamano la
ruvida energia che ha caratterizzato l’uscita precedente (Valient Brave, 100 Years), il sound è qui decisamente più curato e, al contempo, più quieto. La fa
infatti da padrone un lungo elenco di pezzi acustici
dai toni trasognati ed onirici, ma non per questo
meno catchy, che ricordano al pari Brian Wilson
e Syd Barrett (Lost Words, The Void) o che, volendo scomodare nomi meno illustri, si avvicina ad
alcuni episodi l’ultimo album dei compatrioti Nothing People, anche se in versione smaccatamente più pop. A questi si affiancano tracce di frizzante
folk-rock (Try To Understand), quando non brani dal
sapore propriamente disco, come nel caso del secondo pezzo del lotto, Voodoo, che non può non far
tornare alla mente gli stessi Abba.
Rispetto all’omonimo mini-LP questo Monster
Head Room risulta un po’ più dispersivo, ma per
dovere di cronaca va detto che quello che abbiamo
di fronte è sicuramente un buon disco, con canzoni
fresche, ideali tanto per le giornate quanto per le
notti estive; resta solo il dubbio che qualcuno negli
USA non stia esagerando nel gridare al miracolo,
ma forse questa è solo un’impressione distorta dalla lontananza geografica e dovuta all’effettiva insondabilità del reale clima d’opinione dovuta al filtro
virtuale che Internet pone tra musicisti ed astanti.
(6.8/10)
Andrea Napoli
Giancarlo Frigieri - L’età della
ragione (Autoprodotto, Maggio
2009)
G enere : rock cantautorale
Se Giancarlo Frigieri passa al cantautorato folk rock
in italiano, non è certo per la (disperata) speranza
di raggranellare qualche passaggio nelle playlist con
quota tricolore. A sentire questo L’età della ragione - sua seconda prova solista dopo il buon Close Your Eyes, Think
About Beauty del 2007
e a seguire la recente
collaborazione coi Mosquitos - viene semmai
da chiedersi perché abbia
dovuto spengere trentasette candeline prima di
concedersi e concederci
canzoni tanto intense, dense, sconcertanti, trepide
e disincantate. Tra le quali aleggiano i noti influssi
Paisley Underground, però come li cavalcherebbe
un Bertoli trafelato (la title track, suonata assieme
agli amici James River Incident), mentre la fragranza indolenzita Black Heart Procession de
Il tempo si stempera di cantautorato Vecchioni e
Branduardi, così come nel dissesto sentimentale
de Il dubbio sospetti il Neil Young più trepido tra
delicate inquietudini Lauzi-Paoli.
I testi macinano amarezza fiera e ben meditata, covano apocalisse, tensione e disarmo abitando stanze
musicali asciutte, perlopiù acustiche, in cui ogni tanto s’accendono preziosismi come l’harmonium nella
cruda La stagione dell’odio o il flauto che sigilla Casa.
Nel programma, aperto dal post-medioevo austero
e arcigno di Promemoria (un po’ Cesare Basile
e un po’ Bachi da Pietra) e chiuso dalla beffa
agra di Alla fine (ascendenza Gaber ben più che in
filigrana), spicca quella Un cane capace di soggettiva
straniante, pietosa e spietata De André.
Pare insomma che il rock (in) italiano abbia guadagnato un nuovo ragguardevole autore. Pare che,
recensioni /
71
incredibilmente, non ci sia un’etichetta che lo distribuisca. Continuiamo a farci del male.
(7.2/10)
Stefano Solventi
Gina - Segreto (Il Popolo del Blues,
Aprile 2009)
G enere : songwriting
Premio Piero Ciampi 2008 come miglior opera prima, Segreto segna l’esordio della cantante ed autrice Gina Fabiani, insieme a Daniele Bazzani (chitarra e coautore) e Lorenzo Feliciati (contrabbasso).
La Fabiani e Bazzani vantano un passato decennale
come Kozmicblues sui palchi romani.
Ascendenze quelle del trio che fanno capo essenzialmente alla canzone d’autore italiana, con evidenti tributi anche a generi quali jazz, rock e blues.
Un amalgama che parte allora dalla voce decisa
dell’autrice, che ricorda sia la toscana Nada che
la romana Gabriella Ferri, per affinità stilistiche
e musicali, per poi svilupparsi decisamente intorno
alla musicalità del gruppo.
Detto che l’album al momento della premiazione
era ancora autoprodotto e che oggi esce grazie al
fiorentino Il Popolo del Blues e alla distribuzione
indipendente Materiali Sonori, Segreto passa agevolmente tra i generi, siano essi il songwriting d’autore (Luigi Tenco - Una piccola canzone d’amore,
Guardarti ridere; Vinicio Capossela – la jazzata
title track, Isola), le variazioni umorali tra le citate
Nada e Ferri (Le mie parole) mescolate a una spiccata teatralità che ci ha ricordato anche la Lina
Sastri cantante (la bossanova de Le onde, Parigi).
Atmosfere struggenti da jazz club sottolineano testi
acuti al femminile, tra amore, ironia e disincanto.
Da tenere decisamente d’occhio.
(7/10)
Teresa Greco
God Help The Girl - God Help The
Girl (Rough Trade, Giugno 2009)
G enere : chamber pop
Stuart Murdoch riforma i Belle & Sebastian
ma senza riformarli! Vale a dire che lo scozzese imbastisce un proprio nuovo progetto musicale che ha
però molto del gruppo di appartenenza. God Help
The Girl, questo il moniker scelto, comprende una
serie di cantanti femminili, un ospite d’eccezione
(Neil Hannon dei Divine Comedy al canto in un
pezzo), gli altri componenti dei Belle e un’orchestra
di ben 45 elementi.
72
/ recensioni
Il progetto nasce negli ultimi 5 anni, originato da
alcune canzoni scritte nel 2004 mentre il gruppo
era in tour con Dear Catastrophe Waitress. Il
Nostro ne spiega la genesi con la motivazione che
non sentiva fossero pezzi che potevano essere fatti
con la band. Il risultato lascia allora perplessi sugli
intenti, essendo essenzialmente né più né meno un
album dei primi B&S, ma non sui risultati. La varietà delle voci al femminile, soprattutto Catherine
Ireton in buona parte dell’album, non lo rende disomogeneo, anzi. C’è invece una certa freschezza
compositiva che mancava negli ultimi anni di loro
avvicinamento al pop, a favore di un respiro più orchestrale e bucolico in sintonia con lo spirito originario.
Detto che apprezziamo questa rigenerazione, il futuro di Murdoch, con o senza soci, potrebbe essere
allora votato al recupero delle sue radici.
(6.8/10)
Teresa Greco
Groupshow - The Martyrdom of
Groupshow (˜Scape DE, Giugno
2009)
G enere : E lettronica
Pare che dopo due anni di live act, il Kosmicher
Pitch, ovvero la performance live poi confluita nel
collettivo sotto il quale si presentano questi tre signori, spacchi veramente. Jelinek il minimale, Hanno
il casual drummer-popper e Pekler il feedbackarolo
hanno trovato una grande intesa e dei loro incendiari act – in Italia manco l’ombra – stanno parlando
in molti.
A piacere è soprattutto questa possanza psych rock
che viene fuori dal kraut. I loop inscatolati di Jan a
venir di volta in volta scompaginati dai compagni e
ripresi dal tedesco. Chi l’avrebbe mai detto che il più
démodé della cordata scape si potesse anche solo
avvicinare a un collettivo neo-freak Amon Duul.
Non solo è avvenuto, ma il trio - che ora è un collettivo di artisti tra audio, performance e video –
pare sia in pieno trip da comune sixties e garantisca
show al centro della sala (attorno il pubblico e attorno ad esso i panneli video) per sette ore filate
con un corredo di visual art altrettanto avvincenti.
Sul loro sito ufficiale troverete i nomi degli artisti
e performer, qui ci occupiamo di Martyrdom che
purtroppo paga fin da subito lo scotto della frustrata vena rock. Soltanto in Great Art Where You Least
Expect It nella quale sbuca l’omaggio a D.o.A. dei
Throbbing Gristle pare d’odorare il nerbo dei
highlight
Hexlove - Your Love Of Music Will Be An Important Part Of Your
Life (Porter, Luglio 2009)
G enere : free - psych
Zac Nelson, a.k.a. Hexlove, è un po’ fuori di testa. Se ne frega di riferimenti e scene, tendenze e hype. Procede nel suo viaggio – a dir
poco personale – poco attento a ciò che lo circonda. Your Love Of
Music… è l’ennesimo doppio cd zeppo all’inverosimile che il ragazzo
di Portland mette in circolo nell’ultimo anno. Segno di una creatività
debordante; ma anche, visto l’ampio spettro sul quale si muove in nonchalance, di una sensibilità musicale ed artistica fuori dal comune.
La proposta di Hexlove è ormai nota ai più attenti frequentatori del
sottobosco americano. Un ibrido umorale e sfaccettato, free & weird di kraut-rock liquido, psichedelia dolciastra e tribalismo non invadente che si coagula in una forma di pop astruso e
deforme, cangiante e imprevedibile. Your Love Of Music… non la cambia di una virgola, ma
mostra una maggiore coesione tra gli eterogenei input che ne formano il sostrato di partenza. Un
humus dal quale Nelson è in grado di far germogliare fiori sonori che assumono di volta in volta
sembianze mai simili a quelle precedenti e che stupiscono ogni volta per lucidità di intenti e perfezione di risultati. Quello che ne esce è un suono rigoglioso, difficilmente inquadrabile a parole,
stordente tanto quanto passeggiare – occhi spalancati, bocca aperta, orecchie ben tese – in una
foresta tropicale. Per pochi, ma potenzialmente per tutti.
(7.5/10)
Stefano Pifferi
live, il resto è Scape compliant: groove, attenzione
per la sete timbrica dell’elettronic listener e negazione della scuola Kranky, ovvero Peckler (e il suo
guitar noise) al guinzaglio. Rimane un buon prodotto della label, conforme ai suoi buoni standard. E sempre per la serie gossip - pare che i tre abbiamo
dozzine di nastri con improvvisazioni d’ogni tipo. Li
attendiamo.
(6.5/10)
Edoardo Bridda
Il paziente zero - Link (Olivia
Records, Giugno 2009)
G enere : cros sover
Fiatone e naftalina, in un esordio che mostra un
crossover grossolano e fuori tempo massimo. Non
basta mescolare i generi musicali per definirsi innovatori, non basta mettere in mostra buone doti
tecniche per fregiarsi dell’etichetta di artisti. è necessario avere buone idee e creatività. I Nostri si
accontentano invece di una concezione di musica
post-adolescenziale che mescola funk, elettroni-
ca, chitarre distorte, ritmiche in levare. Vengono in
mente certi Primus nei momenti meno sfortunati (Nuova Partita?), ma è davvero troppo poco per
aspirare alla piena la sufficienza. Peccato.
(5/10)
Fabrizio Zampighi
In The Country - Whiteout (Rune
Grammofon, Maggio 2009)
G enere : S candinavian J azz
Il pianista norvegese Morten Qvenild, è dotato di
una scrittura raffinatissima (che attinge allo stile
“colto” di jazzisti come Bill Evans e Keith Jarrett, così come alle pagine proto-ambient di Eric
Satie) oltre che di un “tocco” sensuale e preciso.
I suoi numerosi progetti e i riconoscimenti artistici ricevuti (tra cui il Musician Award del Kongsberg
Jazz Festival) danno un’idea della sua urgenza creativa e collocano senz’altro tra le figure più interessanti della scena avant-jazz scandinava. Il trio In The Country, messo in piedi nel 2003 insieme al contrabbassista Roger Arntzen ed al per-
recensioni /
73
cussionista Pål Hausken, rappresenta uno dei suoi
principali interessi e, probabilmente, anche dei suoi
risultati migliori. Il terzo album, pubblicato a tre
anni di distanza da Losing Stones, Collecting
Bones (a sua volta uscito dopo tre anni dall’esordio), che vide la partecipazione di Marc Ribot, si
presenta come un lavoro ambizioso e complesso.
Brani lunghi, che hanno tutto il tempo e lo spazio
per distendere le idee musicali del trio attraverso
una varietà stilistica che alterna atmosfere notturne
(From The Shore; Dead Water) a momenti più marcatamente jazzistici (Doves Dance), mostrando talvolta
anche un’anima progressive (Ursa Major), parente
non troppo lontana di gruppi “strumentali” come
Camel e Caravan.Talvolta la musica tende a spostarsi verso romanticherie che rischiano di sgonfiare le forti tensioni che animano l’album, ma si tratta,
per fortuna di episodi passeggeri e poco influenti.
(6.8/10)
Daniele Follero
Jack Peñate - Everything’s New (XL
Recordings, Giugno 2009)
G enere : C elestial P op
Lo si capisce dalla copertina. Nella precedente era
orrendo, ritratto in una foto in bianco e nero a
mo’ di rock’n’roll graffitti quando dentro ci trovavi
le classiche sonorità wave pop britanniche appena
sporcate di Northern Soul. In questa s’è fatto il portrait da ometto: bianco e nero ultra adult e posa da
annali di qualche università per ricchi (o sarebbe
forse meglio dire New Romantic?).
L’album va di conseguenza e non bada a spese. Rispetto quell’esordio (il deboluccio Matinée), il sound
sboccia in qualcosa di potente, ambizioso, emozionante. In pratica è un arioso wave pop in una girandola di colori, una versione post-moderna di Wish
dei Cure per capirci, e pure molto oltre.
Le influenze soul di Jack resistono, come pure quelle cooksiane, eppure queste iniezioni latine ribaltano le sorti dell’album: c’è samba e caraibi nei simulKlaxons di Be The One e nei Raputre tirati in
ballo in Everything is New e Tonight’s Today, poi però,
dalla smithsiana Every Glance, la scaletta prende strade ancora diverse e dalle agrodolci liriche del ragazzo l’intento del team che gli sta dietro (il produttore Paul Epworth e in consulenza Norman Cook
e il boss della XL Richard Russell) diventa chiaro e
invero interessante.
Il continuo cambio di scenografie trasforma il bel
Peñate dagli occhi blu in una mascherina dal re-
74
/ recensioni
trogusto amaro. Non è un caso che la traccia che
senti più sua è Let’s All Die, uno allegro scherzetto sulla morte cantato in uno schizzato amore per
la vita (Out Of The Womb And Into the Thumb, canta).
E pensare che l’album iniziava con le chitarre sulla
scogliera à la Charlie Burchill e la voce trovava un
padre ideale in quel Jim Kerr che nell’86, qui in Italia,
era più famoso di Bono Vox (Pull My Heart Away).
C’è da lavorare in personalità, eppure questa vena
da crooner alieno e alienato è già affascinante, a
prescindere dall’arma a doppio taglio Paul Epworth
e dal mito di Jack del primo disco, l’Housemartin
Norman Cook.
(6.5/10)
Edoardo Bridda
James Blackshaw - The Glass Bead
Game (Young God, Giugno 2009)
G enere : psych - folk , minimalism
Ad una manciata di anni dall’esordio (Sunshrine,
Digitalis 2005) James Blackshaw è accolto in casa
Young God. E come dare torto a Michael Gira,
che ha speso parole a dir poco entusiastiche per
questo ventottenne londinese che reinterpreta tanto John Fahey quanto Satie senza colpo ferire.
Poco interessato al dolce stil novo del finger picking,
Blackshaw lo rende più drammatico e selvaggio, imprigionando le rocce bianche dello Zabriskie Point
in una qualche nuova, originale, inquadratura.
La parte centrale del disco sembra governata da un
folk febbrile e psichedelico (Key, Bled), ma è niente
meno che l’ombra di Steve Reich ad aprire e chiudere il sipario. Il mood
malinconico dei vari Yann
Tiersen, Max Richter,
Goldmund e Sylvain
Chauveau è rievocato
quasi par coeur dal piano, ma l’orologio di gelo
di Litany Of Echoes (Tompkins Square 2008) si
è sciolto alle porte della primavera: The Glass Bead
Game è un disco caldo, solare, fors’anche salvifico.
La suite finale, poi, è un piccolo capolavoro: spennellate di violino rifrangono in un acquerello minimale
che scorre rapido ed etereo dal quarto minuto in
poi. I cameo vocali di Lavina Blackwall (Directing Hand) vanno ad intersecare un drone appeso a
un filo. E il Blackshaw pianista sembra addirittura superare il fanatico della dodici corde. Jolie Wood
(Current 93, violino, fiati) e John Contreas (Cur-
rent 93, Baby Dee, violoncello) contribuiscono qua
e là ad impreziosire l’intenso packaging sonoro.
Gli ultimi diciotto minuti alzano il voto di una delle
migliori uscite di questa prima metà dell’anno.
(7.6/10)
Francesca Marongiu
James Poyser/Rebel Yell (The) James Poyser presents The Rebel
Yell - Love & War (Rapster, Agosto
2009)
G enere : bl ack - macedonia
Peccato per questo progetto The Rebel Yell. James Poyser, del fu giro Soulquarians, e Khari
Mateen alla produzione. Il videomaker diventato
cantante Domini Quinn “SupaStar” lead vocalist. Feat dal giro new-Philly, come la brava Nikki
Jean e il Dice Raw sodale dei Roots, e l’altrocker PattyCrash. Si parte con due pezzi da 8
pieno, due cose juicy-black-ultraPOP da pasticceria.
Army of Misfits, primo singolo, e una Wanted che cita
in apertura gli archi di Strawberry Fields. Due canzoni
pop come dovrebbe essere il pop da classifica oggi.
Poi il livello si abbassa. Altri due pezzi molto buoni,
come Life, slow dall’incedere torbido, o il walkingpop della title track. Ma per il resto la macedonia
di electronica e strumenti analogici, di r’n’b, soul,
rock e funk, suona un po’ troppo confusionaria, sacrificando le buone idee contenute nei singoli pezzi.
Il tentativo di creare questo misfit r’n’b, come dice
Poyser, sembra riuscito solo in parte. E la sensazione è che avendo comunque dei pezzi buoni sotto
mano, li si sia straprodotti (vedi la brutta Denial,
punto più basso). Peccato.
(6.1/10)
Gabriele Marino
Japandroids - Post-Nothing
(Polyvinyl Records, Agosto 2009)
G enere : noise punk
Un altro duo chitarra e batteria. Si pensava che ne
avessimo abbastanza. E invece questi due imberbi
canadesi, entrambi alla voce, hanno fatto ricredere
in molti. Noi per primi. Nonostante che al primo,
al secondo, al terzo, fino al centesimo ascolto di
Post-Nothing continuassero a venire in mente i No
Age. L’originalità non è il loro forte, ma la follia,
l’ingenuità e la capacità di mischiare perfettamente
noise, punk, pop, e shoegaze sì, eccome.
E molto meglio dei No Age, per l’appunto. Otto
canzoni veloci, sbalestrate e grattugiate, ma ap-
piccicose, colorate e divertenti. Il teen spirit è più
che una sensazione, è ovunque: nel nichilismo del
titolo (post-niente), nei testi (adolescenziali scazzi
amorosi), nelle melodie
(urgenti ma sofferte) e
nell’approccio alla materia musica. Le prime
tre tracce contagiano
per immediatezza, dalla
quarta fino alla settima
le cose si fanno musicalmente un poco più complesse – cambi di tempo,
escrescenze post punk, inflessioni emocore, digressioni grunge e addirittura stoner -, ma il tutto sempre svolto con un’attitudine sfacciatamente punk.
L’ottava si ricolloca sui binari iniziali, mentre la nona,
la loro power ballad, satura l’atmosfera di opaca
malinconia, evocando addirittura i Seam. Difficile
prevedere il loro futuro, qua si raggiunge solo una
scarsa mezzora di musica, e dal vivo non abbiamo
idea di cosa possano combinare, ma il folle nome,
Japandroids, e questa loro vivacità a presa rapida infetteranno sicuramente anche “tua sorella”, come i
Nostri scrivono ovunque sul Myspace.
(7.4/10)
Andrea Provinciali
Jobi 4 - Sing Me Your Song
(Novunque, Maggio 2009)
G enere : pop jazz , songwriting
Progetto recentissimo nato telematicamente, Jobi 4
nel loro EP d’esordio tracciano le coordinate della
loro musica, un pop raffinato con influssi jazz e cantautorali ben delineati.
L’italo-tedesco Johannes Bickler autore, produttore, batterista da tempo nell’ambiente, con la voce
piena di Federica Caiozzo e la collaborazione di Fabio Visocchi e Cesare Pizzetti nei quattro pezzi qui
presenti spaziano dal songwriting d’autore infuso
d’elettronica discreta alle canzoni jazzate morbidamente arrangiate.
Un esordio che ben promette visto l’amalgama mostrato. In attesa di un seguito sulla lunga distanza.
(6.8/10)
Teresa Greco
Koji Saito - Beautiful (SEM, Aprile
2009)
G enere : ambient / drone / elettronic / abstract
Impressioni, quella che olio su tela danno il titolo al
recensioni /
75
highlight
Moritz Von Oswald/Vladislav Delay/Max Loderbauer - Moritz von
Oswald Trio - Vertical Ascent (Honest Jon’s Records, Luglio 2009)
G enere : live electronic s space dub
Il mezzo capocchia della Basic Channel (l’altra metà è Mark Ernestus) in trio da camera con
Vladislav Delay (aka Luomo) e Max Loderbauer degli nsi. Lui è il berlinese schivo che
molti conoscono come Maurizio. La sua aura misteriosa -grazie alla rivoluzione technodub con
l’etichetta che ha sede a Kreutzberg- è ormai diventata un piccolo must, un dato di fatto, una
certezza che influenza ad ogni uscita il suono elettronico, dub e non solo.
Dopo aver remixato Ravel e Mussorgsky con Carl Craig, e dopo aver fatto sospirare ad ottobre
scorso i fan per un malore (di cui soffre tuttora le conseguenze), oggi si mette a fare live electronics con gli altri due campioncini. Tutto europeo il suono dei 3. Cose da duri: Detroit e Giamaica
a Berlino. Ma stavolta c’è anche il palco.
Sì, perché se già i 3 avevano collaborato in studio alla fine degli 80, questa rivisitazione riprende
il meglio dei tour degli ultimi due anni e fa onore al mito di Miles Davis. Louderbauer ai synth,
Delay alle percussioni assortite (costruite dallo scultore newyorchese Pete Engelhart), von Oswald agli effetti e al banco mix. Momenti,
schianti, linee melodiche che viaggiano, suoni metallici e ritmi space
jazz fanno di queste 4 lunghe tracce un viaggio onirico lungo l’elettronica live che non sentivamo dai tempi di Bitches Brew.
Si parte con un pattern ritmico che ti sembra la solita cosa minimal,
e invece ti accorgi che va a finire sui territori progressivi cari alla mitteleuropa e alle spiagge nordiche, innesti che richiamano il kraut nella
motoricità dei ritmi e nella spazializzazione degli effetti (Pattern 1). Si
passa poi al rumorismo tagliato di fino (Pattern 2), percussioni ed echi che hanno l’essenza dub, qui
trasformata in contemplazione mistica verso ritmiche tribali che neanche Villalobos (Pattern 3).
In chiusura l’omaggio al dub puro, quello della Rhythm and Sound sporcato di organetti e synth
da altri mondi (eccezionale l’esplosione finale di Pattern 4).
Se volete ascoltare un solo disco di elettronica per questo 2009, andate sul sicuro. Questo è il
missile che vi porterà in orbita. Interstellar Oswaldrive.
(8/10)
Marco Braggion
Levar del sole di Claude Monet o quelle di un semplice melodico circuito in loop che Koji Saito demanda ai quarantatre minuti in ambient-drones di
Beautiful.
Prendiamo in prestito il celebre dipinto per dar
voce agli scritti di questo giovane artista giapponese
perchè le immagini qui avranno un peso, quelle che
chiusi gli occhi immancabilmente scivolano indotte
dalla memoria, tra le brevi ma precise pennellate
di elettronica, chitarra, pianoforte, effetti e stratificazioni, dalla giustappunta misura di colore, luce
ed ombra superata l’oggettività per le suggestioni
d’attimo.
76
/ recensioni
A Beautiful per tracciare le circolarità più ipnotiche basta un’unica semplice traiettoria e la lunga
distanza, in cui dileguare fonti e strumentazioni a
favore di fonetiche fangose che tendono all’infinito
celando tra le increspature gli animi più tranquilli
ma malinconici.
Koji Saito si addentra nel silenzio, dall’epica ambient del William Basinski di Disintegration
Loop alle fluttuanti ombre sonore e le soavità in
drones di Stephan Mathieu, attraverso le matrici più concrete che debordano le origini al suono
e collocandosi tra gli animi più romantici, quelli legati agli stralci melodici, alle meditazioni oniriche, ai
suoni stanchi,all’arte del rallentamento e ai detriti
sonori.
Non ci si può sottrarre, qualcosa di magnifico accade ed è intrappolato in questa rarefatta perdita di
senso del tempo.
(7.2/10)
Sara Bracco
Lee Fields & The Expressions - My
World (Truth & Soul, Giugno 2009)
G enere : vintage soul
Dicendo di taluni artisti rischi di cadere nella monotonia, ragion per cui sarebbe comodo risolvere
la questione indirizzando l’amante della “black”
all’articolo su Sharon Jones che trovate altrove in questo stesso numero. Perché la storia di Mr.
Lee è a grandi linee la stessa: nato e cresciuto in un
buco della North Carolina con altri tre fratelli, Lee
ha speso l’adolescenza tra la chiesa e i vinili di James Brown, Temptations e Otis Redding.
Hai detto niente, e ancor più significativo sarà il suo
calcare le scene dal crepuscolo dei Sessanta in poi,
finendo su una pletora di oscure gemme funk a 45
giri e in Let’s Talk It Over, raro lp conteso dai
collezionisti a cifre da leasing. Se aggiungiamo che il
Nostro ha - prima di approdare alla Truth And Soul:
un nome, una garanzia - soggiornato presso la Daptone, capirete che gli estremi per interessarsene
c’erano tutti, eccome. Sappiate allora che un solo
ascolto è bastato per zittire la cautela riservata agli
sconosciuti.
Vero che Fields riflette chiaramente la propria educazione sentimentale tra sensuosi ondeggiamenti
sudisti (Do You Love Me Like You Say You Do: splendidi
la tromba e il break melodico che la tagliano in due;
lo snodarsi in stile “Philly” di Ladies), pigro e morbido funk (il brano omonimo, Love Comes And Goes)
e qualche impennata (Money I$ King), nondimeno
la voce elargisce una personale grana, non di rado
avvolta da un’aura malinconica anche quando le atmosfere sono degne di uno “shouter” e figuratevi
allorché la ballata assume toni confidenziali (sublime
Honey Dove; latineggiante e corale My World Is Empty Without You). Disco a lento rilascio, My World
è inoltre impreziosito dalla sapienza esecutiva degli
Expressions - già con la Winehouse e Antibalas, costoro si guadagnano il proscenio con un pugno di discreti strumentali - e nel porgere ottoni
grassi e archi tondi senza appesantire la scrittura.
Una pratica che riconosci antica ma non “vecchia” e
che conforta come un amico fidato, giacché sai be-
nissimo che è così che s’ha da fare e cioè ripercorrere la memoria senza fermarsi a metà del guado.
Mica tutti possono lanciarsi nel futuro come Erykah Badu, insomma, tanto più se appartengono
alle generazioni che dell’oggi e del domani hanno
posto le basi. Con personaggi siffatti, ci vorrà molto
perché il ritorno del soul venga a noia. Non solo
perché - avrete inteso - la Musica dell’Anima non è
mai andata davvero via.
(7.5/10)
Giancarlo Turra
LTJ Bukem - Fabriclive 46 (Fabric,
Giugno 2009)
G enere : drum ’ n ’ bas s
Il campione del suono d’n’b si mette a mixare dal
vivo per il Fabric. Lui alla fine dei 90 insieme al
prode amico Fabio spacca il culo alla gente che
non sapeva ancora cosa stava ascoltando e scopre
personaggi del calibro di Photek. Ma già dagli 80
l’uomo è attivo. Infatti là getta le fondamenta per il
suo piccolo mondo: Good Looking. L’etichetta che
se non sei del mestiere non la vedi pubblicizzata.
E allora oggi giunge il momento di fare un opening in
gran stile sul variegato mondo della cassa più dritta
che mai. Danny Williamson ci seleziona delle cose
che vibrano 90 da tutti i pori, ma che per questo
non risultano minimamente stantìe. Più di un’ora a
cavallo fra ricordi in odore dub, atmosfere ambient,
voci in eco à la O.R.B. e qualche tocco ibizenco: il
tutto ovviamente sulla base che è ormai nota anche
alle nostre nonne. Niente di nuovo, ma ogni tanto fa
bene ripassare la lezione di uno dei pochi grandi del
genere. Consigliatissimo anche a chi storce il naso
all’aumentare frenetico dei bpm.
(7/10)
Marco Braggion
m2 - Global Pigeon (Danza Cosmica
Records, Maggio 2009)
G enere : electro wave
Da polli d’allevamento di gaberiana memoria a piccioni globali: l’evoluzione della specie secondo m2.
Uno è M alto, l’altro è M basso. In questo esordio discografico (se escludiamo i trascorsi come Neganeura) mettono in mostra una sbrigliata, ossessiva
e direi pure umoristica attitudine kraut-wave, guardando ai maestri Kraftwerk come se li avessero
contagiati quegli zuzzurelloni dei Devo, senza dimenticare le lezioni di asetticità febbrile e invasato
rigore fornite da Tortoise e Gastr Del Sol.
recensioni /
77
Ne esce un viaggio in sei tappe per altrettanti statinazione occidentali, ovviamente gli imperanti Usa
più cinque europei (Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda e - of course - Italia). Di ognuno viene
colto un intercalare, un tic verbale, un frammeto di
codice, dal cui loop germogliano altrettanti rituali
di quotidiana ossessione, che in qualche modo rappresentano la nostra unicità globale, l’ineffabile brodo di cultura della contemporaneità interconnessa.
Matematici intrecci chitarra-batteria, found sounds
riprocessati, elettroniche attonite, le voci che si alternano con flemma sordidella: questi i non molto
ingredienti utilizzati con sapienza dal duo fiorentino,
di cui va sottolineata la versatilità, testimoniata dai
disparati progetti avviati, tra cui la collaborazione
col molto onorevole transgender Vladimir Luxuria
di cui hanno musicato un reading teatrale.
(6.9/10)
Stefano Solventi
Magnolia Electric Co. - Josephine
(Secretly Canadian, Luglio 2009)
G enere : folk rock
Jason Molina più Steve Albini significa Magnolia Electric Co., ovvero l’ineludibilità sonora come rivalsa
anti-nostalgica del folk rock. Perché è impossibile
ignorare ciò che è vivo anche se da tempo lo hai
sepolto tra le cose che non hanno (più) voce in capitolo. Come, appunto, certo folk rock.
Questo nuovo disco - il quarto per la compagine
capitanata dal cantautore dell’Ohio - inizia nel segno di una triangolazione Al Stewart, E-Street
Band e Will Oldham, prosegue disimpegnandosi tra tepori country e soul, riesumando fatamorgane doo-wop, mestando la crema acida di una milonga da front porch (la
stupenda Shenandoah), e
ancora sgranando elettricità febbrile non distante
dal Neil Young altezza
Freedom. Con la gravità
generosa di chi ha speso
anni, cuore e dischi spellando il cadavere del folk
rock, finché non ne è rimasta che la polvere. Fu allora, nell’ormai lontano 2003, che incontrò Albini,
il cui turgore in flagranza di reato sembrò il modo
migliore - forse l’unico - per rimpolpare quelle trame minimali.
Jason ripartì come una fragorosa e obsoleta anomalia, le chitarre in resta, gli organi, gli ottoni, il pia-
78
/ recensioni
no. Forte di quel suono impetuoso e sconcertante
come un fantasma di carne, non si è ancora fermato.
Prosegue la sua patetica, appassionata e formidabile
scorreria on the road, cogliendo ballate dolciastre
e struggenti, solcando la spuma pastosa e sferzante
del malanimo, tratteggiando un’elegia assieme poderosa, vivida e affranta. In memoria di Evan Farrell, bassista e chitarrista, morto tragicamente nel
dicembre del 2007.
(7/10)
Stefano Solventi
Major Lazer - Guns Don’t Kill
People... Lazers Do (Downtown,
Giugno 2009)
G enere : mesh raggastep
Diplo + Switch = Major Lazer. L’equazione
sta tutta qui. E se già sapevamo che i due avevano bazzicato in studio per la produzione di alcune
tracce di M.I.A. (qualcuno dice che siano già lavorando al terzo disco insieme alla musa), non si
prevedeva il full leght in solitaria. Con la reginetta di cui sopra e le sue amiche Santigold e Missill
avevamo capito che il dancefloor chiama sempre
più i suoni banghra e mesh; con questo disco ne
abbiamo la prova definitiva. Tanto più che tra i collaboratori troviamo anche quei Crookers (Jump
Up) che probabilmente si son stancati di proporre il solito fidgeting-trash e stanno vedendo bene
di cavalcare la nuova onda. Ma il suono com’è?
Aspettatevi una cosa che -come la copertina- richiama il cartooning. Come i Gorillaz avevano fatto
con il rock, qui si fa il verso alla dance e la si pompa
di nuova energia inventandosi un personaggio che è
un misto di P.E. Barracus dell’A-Team e di Robocop e
che quindi fa 80. Che sia baile funk (Keep It Going Louder) o ragga (Can’t Stop Now), che sia lazer-hall (Lazer
Theme) o puro reggae (Cash Flow), che sia la musica
da banda (Mary Jane) o il suono Miami based (Bruk
Out) il mesh è sempre e comunque la parola d’ordine.
Questo (assieme a molti altri in questi mesi) è uno
dei punti di svolta per la musica da ballare. Ancora una volta Giamaica, ancora una volta ragga. Lunga vita a Kingston signori: il levare più famoso del
pianeta ci accompagni (almeno) per tutti i party
dell’estate.
(7.1/10)
Marco Braggion
Management del Dolore PostOperatorio - Mestruazioni
(Videoradio, Giugno 2009)
G enere : wave rock
Punk wave piuttosto cruda e abrasiva, ad alzo zero
e piglio intossicato come accadeva nei randagi anni
ottanta italiani, tipo il Vasco Rossi altezza Siamo
solo noi (1981) per intendersi. Aggiungete però la
delirante ossessione CCCP e il sarcasmo disincantato d’un Rino Gaetano, il tutto mutuato attraverso striscianti reminiscenze garage-psych, contagi
electro industrial e l’inevitabile imprinting del primo
grunge.
Gli abruzzesi Management del Dolore Post-Operatorio - egida opportunamente abbreviabile in Made
Dopo - colpiscono con la parte meno affilata della
lama, mirano alla ferita lacero contusa e ci riescono
perché riducono la distanza, sferrano il colpo e rigirano il coltello. A volte più a lungo (Prendendo a pugni l’aria, Nel giorno sacro), a volte più a fondo (Voglio
solo farmi male, la bellissima Panico), oppure limitandosi a “puncicate” tanto per sollecitare il nervolino
della ragion critica (gli sbrachi pseudo-Skiantos di
Il calendario e Cazzo che bello). Considerateli, se vi va,
i fratellastri cazzoni di Vasco Brondi AKA Le Luci
Della Centrale Elettrica, oppure i cuginetti irriducibili di Bugo, o ancora i nipoti scellerati - e
ripudiati - dei Marlene Kuntz.
In ogni caso, segnatevi il loro nome, perché malgrado tutto - a partire dal titolo di questo album
d’esordio - fanno parecchio sul serio.
(6.8/10)
Stefano Solventi
Master Musicians Of Bukkake Totem One (Conspiracy Records,
Giugno 2009)
G enere : psych rituale
Nonostante vincano la palma per il nome più improponibile del panorama musicale di tutti i tempi – cosa che fa venir voglia di cassarli dal novero
dei gruppi ascoltabili senza remore – questi MMOB
non sono affatto male.
Il nome a dirla tutta cita i Master Musicians Of
Jajouka è già questa di per sè è cosa buona e giusta. Se poi si aggiunge che punto fermo del settetto sono personaggi come Brad Nowan (Burning
Witch) e Don McGreevy (Earth) e che tra gli
ospiti troviamo il membro onorario Alan Bishop dei
Sun City Girls (la voce di People Of The Drifting
Houses è la sua), allora la cosa si fa seria.
Totem One è un viaggio cosmico lungo 40 minuti in cui la dimensione panteista dei protagonisti
prende il sopravvento sulle escursioni psych grazie
all’uso massimalista della strumentazione freak. In
aggiunta alla classica strumentazione rock c’è infatti
l’apparato d’ordinanza tutto: gamelan, tanpura, corde
indiane, flauti, ecc. L’asse delle lunghe composizioni
è perciò spostato verso
una psichedelia rituale
pregna di reminiscenze
orientali e dall’impatto
fortemente filmico, dilatata e visionaria ma insieme materica e desertica
come solo certo Jodorowsky ha saputo fare.
Su tutto, perennemente, aleggia un senso di cupezza
e di prossima sventura che però non appesantisce
mai le fluide strutture, ectoplasmiche a volte, del
combo.
Un vero e proprio viaggio, verrebbe da dire, nonostante l’oramai abusata metafora utilizzata per descrivere progetti simili possa non sorprendere più.
Ma la realtà dei fatti è che l’ascolto di Totem One
trascina verso luoghi lontani. Del mondo e perché
no? Dell’io.
(7.2/10)
Stefano Pifferi
Mattia Coletti - Pantagruele
(Wallace Records, Giugno 2009)
G enere : acoustic guitar
Dolce e delicata come un soffio di brezza marina
la musica di Pantagruele, ultima uscita a proprio
nome di Mattia Coletti. 6 piccoli haiku sonori in
cui messa a fuoco e attenzione al dettaglio fanno la
differenza anche rispetto agli eccellenti primi passi
Zeno e Zeno Submarine.
In Pantagruele si assiste ad uno spostamento
dell’asse interpretativo del lavoro di Coletti verso
una materia elegiaca e al tempo stesso introspettiva:
le composizioni si aggrumano ancor di più intorno
alla (sempre libera) forma canzone, il suono si fa
mano a mano più pulito, di un nitore encomiabile,
anche in fase di produzione mentre il caratteristico fingerpicking di Coletti è messo al servizio di
una struttura ottimamente definita e netta, in cui
trovano gradita ospitalità Paolo Cantù (clarinetto
e suoni), Alberto Morelli (piano) e Michele Grassi
(batteria).
Il bozzetto faheyiano di L’angolo Rosso Della Civetta, la
recensioni /
79
pastorale circolarità di The Bed Is Over The Rainbow,
l’ascesi introiettata di Nagano si muovono leggere
e sognanti e non sono che esempi delle atmosfere
sospese che le tratteggiano ammantando l’intero album di un senso di calma e di piacevole perfezione.
Cosa questa che dimostra come Coletti sia perfettamente calato nel suo percorso a ritroso verso le
musiche delle origini. Una pecca? Il fatto che il tutto
si risolva in soli 23 minuti.
(7/10)
Stefano Pifferi
Maya Mountains - Hash And
Pornography (Go Down Records,
Giugno 2009)
G enere : hard - psych stoner
L’amore per lo stoner primigenio dei Kyuss sprizza
da ogni poro di questo Hash And Pornography,
e non solo perché i Maya Mountains nascono come
cover band proprio del quadrunvirato californiano.
Già l’immagine di copertina aiuta nell’inquadrare il
raggio d’azione del trio veneto: volute psicotrope di
fumo e colori sgargianti da trip psych andato a male.
Quando poi attacca il riff circolare grasso e distorto
del pezzo che inaugura l’album (Spring) ecco che si
entra subito a gamba tesa dentro il sound del trio
veneto: psichedelia stonata dura e pura, hard-rock
granitico che viene dritto dritto dai seventies, saturazioni fuzz e incedere pachidermico a forti tinte
allucinogene e desertiche.
I 10 pezzi di questo esordio ottimamente prodotto
da Ragno Favero sono un monolite multisfaccettato
di musica heavy che oltre a rifrangersi in una tempesta di suoni riconoscibili e tipicamente di genere
– dai Black Sabbath ai citati Kyuss passando
per Blue Cheer e Motorhead – inserisce elementi altri come reminiscenze post-hardcore (Dead
Hurricane Saw), pesantezze melvinsiane, svisate metalliche e stop’n’go al fulmicotone.
Hash And Pornography è un disco possente per
compattezza e potenza che getta nuova luce sulla
scena hard-psych italiana.
(6.8/10)
Stefano Pifferi
Mercury Drops - Love Is The End
(Smoking Kills, Maggio 2009)
G enere : wave - psichedelia
Ci sbaglieremo, ma in questo esordio degli svizzeromessicano-serbo-italiani Mercury Drops leggiamo
una freschezza particolare. Merito dell’attenta fu-
80
/ recensioni
sione di stili alla base dell’opera, sunto di new wave
danzereccia, electro, ma anche attitudini melodiche
da college radio anni novanta. Per intenderci, The
Presidents Of The United States, ma anche, più di recente, Rogue Wave e The Shins.
Pop applicato all’accordo “storto”, psichedelia da
praticanti, backing vocals, wave-dance dispersiva e
imbastardita. Come rinnovare la tappezzeria senza
buttare via niente, insomma, e il risultato piace parecchio.
Le cose migliori escono dai brani più mutanti: i tempi in levare e i synth psych di A Girl, i Franz Ferdinand new romantic di 2 Drops, i controtempo
di Lemons Are Kisses, il pop espanso della title-track.
Per un’opera capace di riposizionare la linea della
contemporaneità a quindici anni fa senza per questo
perdere di vista un presente accessibile paradosso
di leggerezza e ricercatezza al tempo stesso.
(7/10)
Fabrizio Zampighi
Miranda - Growing Heads Around
The Roof (From Scratch, Luglio
2009)
G enere : funk - wave
Tornano e non deludono i tre Miranda. Partono
a cassa dritta e di synth. Si muovono di circolarità groovey. Acchiappano a base di coretti e fanno
muovere tremendamente le chiappe. Eppure fanno rumore, e con loro lo fa anche il terzo parto
Growing Heads….
Lo fa con quel suo rivoltare dal di dentro i canoni
del versante più funk del punk e di quello più negativo della wave. Che a ben vedere è un pregio mica
da poco. Significa sapere la materia da cui si viene,
maneggiarla, conoscerla a fondo. Masticarla per poi
risputarla fuori dopo averla metabolizzata. Non a
caso ci si sposta lievemente, dal punto di vista strumentale, verso la roboticità umanoide di synth e
drum machine. Così come non è un caso che si rielaborino, anzi sarebbe più corretto dire si ripensino,
pezzi nati in altri tempi, in altri contesti.
Mutanti in mutazione si dice in altre parti (cfr. Rated O degli Oneida) e lo stesso si potrebbe ripetere qui, perché le assonanze col procedere dei
newyorchesi non sono fuori luogo e la curiosità nel
muoversi verso territori non esplorati – da sempre
innegabile punto fermo degli Oneida – è la molla
dietro l’ottimo Growing Heads….
(7.2/10)
Stefano Pifferi
highlight
Oneida - Rated O (Jagjaguwar, Luglio 2009)
G enere : rock
Se la forza e il segreto degli Oneida risiedono nell’essere mutanti in mutazione, allora Rated O
può essere tranquillamente considerato come il punto d’arrivo più estremo nell’incontrollabile
percorso mutoide dei newyorchesi.
L’episodio mediano della trilogia Thank Your Parents riaccende maestosamente la fiamma
Each One… e vi butta ulteriore benzina, dilatando a dismisura le intuizioni di quel capolavoro.
Materialmente, dato che si tratta di un triplo cd per quasi due ore di
musica; ma soprattutto stilisticamente, visto che è un unicum stordente e onnicomprensivo, eclettico e sfaccettato che succhia, mastica e
risputa fuori tutto quello che era la linfa vitale di quel disco e tutto ciò
che da quel disco in poi è venuto.
Gli Oneida targati 2009 sono oltre quelli incensati nel 2002. Se lì riducevano in poltiglia le ceneri post-9/11 a forza di scossoni reiterati e
ossessività vertiginose, qui ricostruiscono dalle fondamenta le basi del
proprio sound utilizzando, a mo’ di Lego, i mattoncini distribuiti negli
ultimi album e finendo col racchiudere in un colosso portentoso tutta
l’insaziabilità e la creatività del proprio universo.
Poliritmie tribali africane, malati slanci minimal-techno, echi di dub(step) storto inzuppato in salsa
kraut-wave si incrociano e fondono nel primo cd in una ipotesi di mappatura sonora che dalle
bidonville di Lagos arriva fino ad un terzomondismo massiccio e depravatamente nyc, fatto di
muscolarità percussiva sciolta in un magma incontrollabile; roba che sgretola ogni convenzione e
annichilisce ogni tentativo di paragone. La natura di fondo degli Oneida però è sempre ossessivamente krauta, e così il secondo disco si riallaccia all’anima hard-rock a forti tinte motorik che ne
ha segnato la proposta, tanto che ossessività e reiterazione sono le parole d’ordine per decrittarlo e fuzz e seventies quelle per collocarlo nell’intricato puzzle sonoro oneidiano. La tendenza alla
dilatazione e alla jam folie peculiare del trio emerge in tutta la dirompente sapienza nell’ultimo cd
tra gli ipnotici umori orientali di O e le devastanti aperture dei 20 minuti finali di Folk Wisdom.
Insomma, in quell’inarrestabile e continuo cortocircuito tra organic e synthetic (parole di Fat
Bobby) che caratterizza il muoversi dei tre, Rated O rappresenta sicuramente uno dei picchi più
alti mai raggiunti. Si ha però la certezza che la terza parte della trilogia vanificherà queste nostre
parole, spostando ancora più in là i paletti.
(8/10)
Stefano Pifferi
Moby - Wait For Me (Little Idiot,
Giugno 2009)
G enere : spleen - pop
E la chiamano estate. A sorpresa, dopo il dancefloor
di Last Night, un disco intimista e fragile, l’immagine sonora di uno spleen praticamente autunnale.
L’antefatto: fan totale di David Lynch, Moby ne
interecetta un discorso alla British Academy of Film
and Television Arts, discorso che è un’esaltazione
appassionata (e un po’ naif) della “creatività senza
compromessi”. Si chiude così nel suo studio casalingo e registra, praticamente da solo, questo Wait
For Me, disco “per me e basta”, asciutto, bianco
come la sua copertina (ma il tutto è profondamente
blue), con pochi interventi esterni, soprattutto quelli
vocali dell’amica Amelia Zirin-Brown (che di
solito canta tutt’altro col suo duo burlesque), mixato
poi assieme al Kevin Thomas già fidato dei Sigur Rós, con un patina come di poco lavorato, quasi (quasi) lo-fi, soprattutto nell’assemblaggio delle
recensioni /
81
parti e nel trattamento delle voci. Il disco nella sua
totalità sembra un’emanazione dilatata del mood
di vecchi pezzi come Why Does My Heart Feel So
Bad? (la cosa è fin troppo palese in Study War, che ne
riprende quasi tutti gli elementi), con meno enfasi
sulle ritmiche e focus su piano e archi (riconoscibilissimi questi ultimi, in perfetto Moby-stile).
Sei cantati soltanto: Pale Horses, secondo singolo,
video con disegnini dello stesso Moby, organo da
chiesa, archi, coro, quasi
un canto gospel profano
(e anche un po’ macabro,
si veda il testo); Mistake,
cantato molto Lou Reed-Bowie (MOLTO); la
title track, costruita su
un ostinato arpeggio di
piano e con una voce fascinosamente languida. Le altre canzoni puntano su
una soffice e malinconica rarefazione. Le strumentali: la spaesata Shot In The Back Of The Head, primo
singolo, con tanto di video disegnato e diretto dallo
stesso Lynch nel suo classico stile rough, surrealista
e anti-simbolico, retta da accordi di chitarra elettrica mandati in loop al contrario; l’epica, quasi da
scena panoramica in un Indiana Jones, Seated Night;
e Isolate, la migliore del lotto, arpeggio di chitarra,
tocchi di piano e rimshot trattato molto Teardrop.
Le altre strumentali sempre electronica-pop agrodolce e dintorni. Canzoni fragili, disco fragile. E tutto
sommato, anche qui, ruffiano. Ma bello.
(7/10)
Gabriele Marino
Morgan - Italian Songbook
- Canzoniere Italiano Vol. 1
(Columbia Records, Aprile 2009)
G enere : M usica italiana
È bello ogni tanto vedere qualcuno che invece di scegliere la via facile decide di tirare la corda: Morgan
avrebbe potuto fare facilmente cassa dell’esposizione mediatica derivata da X-Factor pubblicando al
volo i primi dieci pezzi decenti nel cassetto purché
orecchiabili, o 10 cover tra quelle più acclamate in
trasmissione, e sarebbero andati via senza sforzo.
Invece resta fedele all’idea che “un conto è scrivere
musica, un conto è pubblicarla” e la ribadisce proponendo un’operazione di metamusica a forte rischio
di reazioni perplesse e nemmeno troppo adatta ad
un pubblico da reality, centrata com’è su classici degli anni tra ‘50 e ‘60.
82
/ recensioni
L’idea infatti è quella di analizzare i rapporti del nostro canzoniere nazionale con l’estero, ricordando
quando non erano solo Torna a Surriento e O sole
mio ad essere tradotte e reinterpretate da cantanti
stranieri ma -pur con minore risonanza- Il cielo in
una stanza, Resta con me, Lontano dagli occhi e Il mio
mondo. Morgan le canta sia in italiano che nella versione inglese e aggiunge Back Home Someday, che
Endrigo aveva scritto direttamente in inglese per
un film di Fulci, e la ciampiana Qualcuno tornerà, anche questa in due versioni, con quella inglese fatta
da Morgan stesso perché all’epoca la canzone non
ebbe versione estera ma, a detta del nostro, avrebbe
potuto averla con successo.
Come si vede, un’operazione un po’ cervellotica,
non proprio l’acquisto più probabile di un pubblico di giovani, anche perché gli arrangiamenti (non
realizzati da lui, che si limita a scegliere le canzoni e
a cantare) sono pienamente nello spirito dell’epoca, e la voce si adatta al repertorio fino a un certo
punto.
Poi, se uno ama il vintage e se si passa sopra alla
stranezza di un disco con le canzoni doppie non è
neanche male: Back Home Someday sembra Scott
Walker prodotto da Hazelwood, i due intermezzi orchestrali si inseriscono alla perfezione e
in generale l’effetto straniante è anche piacevole, benché resti qualche perplessità sulla necessità
dell’operazione.
Il secondo volume sarà dedicato a quelle canzoni
che avrebbero potuto diventare famose all’estero e
il terzo saranno originali di Morgan scritti come se
fossimo in quegli anni.
Vedremo: il progetto andrà valutato nell’insieme,
per ora, come detto, il giudizio oscilla tra approvazione e dubbi.
(6.8/10)
Giulio Pasquali
Mos Def - The Ecstatic (Downtown,
Giugno 2009)
G enere : ( melting pot ) hip - hop
Dopo l’esordio, dieci anni fa, col sorprendente
Black On Both Sides, un concentrato di classe,
intensità ed efficacia con pezzi magici come Umi
Says e Mathematics, Mos Def aveva spiazzato tutti
con un disco dalle forti inflessioni rock (nelle basi
con chitarroni) e ragga (nei cantati), non brutto, anzi
interessante, ma strano assai, e con un terzo capitolo invece piuttosto deludente, sottotono. Torna ora
dopo tre anni (nel frattempo ha sempre più intensi-
ficato l’attività di attore, fino al ruolo di protagonista per il Gondry di Be Kind Rewind), e siamo a metà
strada tra la seconda e la terza prova.
In media si tratta di pezzi carini, ma che scorrono
via un po’ così. Meno rock (Supermagic), restano i
cantati raggaggianti di cui sopra, spesso davvero fuori fuoco (Workers Comp.). Alcune sbracature nelle
basi, quando proprio non basi brutte, o comunque
inadeguate (Life In Marvelous Time di Mr. Flash). E poi
corpi estranei come No Hay Nada Mas, cantata in
spagnolo, più caricaturale che d’atmosfera: anche
qui, non brutta, ma perché. Le cose migliori sono i
pezzi con le basi di Madlib (tra cui un riciclaggio
da BK in India, pezzo ipnotico), bella History dai
beat tapes di Dilla (e che poteva benissimo stare
su Donuts), con un veloce feat di Talib Kweli che fa rivivere l’interplay dell’ormai vecchissimo
Black Star. Carine anche la solo percussiva Quite
Dog Bite Hard, con accenni samba, e la conclusiva, un
po’ pasticciata forse, ma divertente, Casa Bey, primo
singolo. Altro feat interessante quello con la Muldrow.
Testi come sempre piuttosto conscious, Def con
sprazzi della sua classe storica, ma che spesso e volentieri rovina tutto accennando il cantato o con
certi effettacci sulla voce. Soprattutto, mancano i
pezzoni. La sensazione insomma è quella di un grande talento un po’ trascurato.
(6.4/10)
Gabriele Marino
MRR-ADM - [EP 10’’ untitled]
(Autoprodotto, Marzo 2008)
G enere : funk - psych
Michael Raymond Russell e Adam Douglas Manella sono due giovani produttori californiani, basi nell’hip-hop-funk, che hanno pubblicato
piccole cose e fatto piccole collaborazioni sotto la
sigla MHE. A marzo 2008 mettono in circolazione un 10” autoprodotto, stavolta a nome MRRADM (ma senza indicazioni di sorta sul packaging),
1000 copie, vinile rosso, copertina psichedelica in
stile Heliocentrics (e infatti...), Malcolm Catto alla batteria: va a ruba. A marzo 2009 mettono in
vendita online gli ultimi 94 (!) esemplari della cosa,
allo scopo di finanziare il loro debutto su LP per
la stonesthrowniana Now-Again: esauriti in 3 giorni.
Adesso Manella pare stia dando fondo addirittura
alle sue scorte personali, tramite il sito della Stones
Throw: bisogna sborsare 30 dollari (!) per il vinile. 5
per la versione mp3, ma senza l’ultimo pezzo dell’EP.
Domanda: delirio collezionistico? Si. Esagerazione
hype? Non proprio. Sei pezzi senza titolo, meno di
venti minuti, file under FUNK. Funk scuramente psichedelico (notturno), suono corposo, tastiere synth
con effetti vari e la batteria legnosa (e centrale) di Catto. Nell’ordine:
funk esoterico-tribale,
blaxploitation-Settanta,
electro-funk con parossismo rave e coda latin, ancora blax, funk-noir-morriconiano, stilizzazione di
batteria funk con ghost-notes protagoniste. Aspettiamo allora, dopo questi ottimi appunti, il long per
la Now-Again, dovrebbe essere in dirittura d’arrivo,
titolo di lavorazione golosissimo: Dirty Drums.
(7/10)
Gabriele Marino
Murièl - Cosa decide? (A Buzz
Supreme, Giugno 2009)
G enere : electro - rock - pop
Nuovo disco dei Muriél. Rispetto al precedente Il
Movimento necessario, pregi e i difetti si mantengono gli stessi: ottimi arrangiamenti, suoni curatissimi, geometrie piuttosto variabili con un occhio di riguardo per una melodia a tratti evocativa.
Di contro, difficoltà a cogliere lo spessore dietro
a brani che mescolano, anche in maniera piuttosto
raffinata, elettronica, pop e qualche dettaglio jazz/
funk. In più, rispetto al passato, c’è una caratura decisamente superiore nelle soluzioni estetiche, curatissime e dettagliate fino all’inverosimile. Con una
conseguente perdita di immediatezza non sempre
sinonimo di scarsa fruibilità.
Ci si diverte, insomma, ma in modo moderato. Anche perché buone doti, creatività, coraggio non sopperiscono del tutto alla mancanza di quel pizzico di
carattere in più che sarebbe in grado di garantire ai
Muriél un impiego “sicuro” fino alla pensione.
(6.5/10)
Fabrizio Zampighi
New York Dolls - ‘Cause I Sez So
(Atco, Maggio 2009)
G enere : G l am stones
Todd Rundgren porta bene. Fu lui a produrre il loro
mitico omonimo ed ora patrocina un follow up inaspettato a firma New York Dolls. Stessa line up
del 2006 (con gli Hanoi Rocks) e probabilmente i
recensioni /
83
highlight
Pupkulies & Rebecca - Burning Boats (Normoton, Giugno 2009)
G enere : chanson - tronica
Alle volte basta concedere a chi fa dischi il tempo necessario per crescere. Si potrebbe sempre,
non fossero i tempi quelli che sono e cioè pieni di gente tradita dalla fretta, da questa e da quella
parte della barricata. Ad esempio i tedeschi Janosch Blaul (musicista) e Rebecca Gropp
(sciantosa), lasciati due anni e mezzo fa nelle secche di Beyond The Cage, debutto irrisolto
che inseguiva l’unione tra canzone folk ed elettronica; era - resta tuttora - uno dei tanti dischi
odierni interessanti zavorrati dal mancato compimento e dall’assenza di filtri oggettivi. Per quanto
scivoli lievemente anche qui in alcune evitabili prolissità (questione di un altro disco, speriamo…)
e in una Confused che cita gli Who di Tommy e sembra non finire mai,
il duo ora sfoggia un’armonia dove acusticherie di piano e chitarra si
fondono con tempi da chill out e tecnologia modernista.
Ne fanno fede la title track, distanza emotiva teutonica che si assottiglia pian piano come una confessione recalcitrante, una dolcemente
laconica Idiot dritta dalla New York del ‘79 e X–Hale, ovvero Laurie
Anderson che comunica alle nuove generazioni tramite la minimal
techno. Capisci che i ragazzi - da non dimenticare l’apporto del polistrumentista Seppi Singwald - hanno faticato con impegno su forma e struttura, cavando di tasca una lacca dance-pop che non induce carie (Hold It Tight, Sorry),
sperimentando con garbo (la melodica buffa dentro a From The Top, il jazz sereno ma dissonante
Black And Blue) e parafrasando credibilmente la “chanson” (Nouvelle Chance e Ton Chauffeur si
muovono rispettivamente sulle tracce di Lio e dei Kraftwerk paneuropeisti). Funziona, dacché
si umanizza uno stile a costante rischio di cerebralità e freddezza senza scadere nella cartolina.
Prova ne sia che il brano più memorabile, la conclusiva Paper, è ballata d’agrodolce intimismo che
svela capacità non comuni. E, quel che più conta, idee assai più chiare di prima.
(7.2/10)
Giancarlo Turra
tutto quel “già stato”, “già dato”. Già soggiaciuto
ai codici per non dire ai cliché, esausti per obsolescenza storica dacché il rock ha smesso d’indagarsi
il ruolo come in quei primi nineties affacciati sugli
zero. Questo praticare il post del post, dicevamo, è
pratica parecchio praticata, e a qualcosa - praticamente - si dovrà ricondurre. Vuoi perché gradevole
all’udito e comoda al suonante? Oppure vuoi perché in effetti (in pratica) alcune propaggini son rimaste in sospeso, abbadonate a se stesse prima delle
conseguenze estreme, tipo commistioni folktroniche e psych in un più vasto e inevitabile progetto di
rientro alla base formale.
Ecco, i Nicker Hill Orchestra, quartetto un po’ veneto e un po’ emiliano, con l’esordio su lunga distanza
decidono d’impegnarsi su questo fronte: esercitano un post-post-rock atmosferico, ovvero tornato
a percorrere il binario della melodia, propenso ad
accogliere l’asprigno noise-pop à la Yuppie Flu
e i fondali epici del sacro prog crimsoniano, allo
scopo di riarticolarne le morbidezze, i languori, la
solennità (dei cinque pezzi in scaletta si senta soprattutto Sailor), abbozzando pure qualche lineuzza
vocale come a suggellare il definitivo armistizio. Che
renda finalmente inutili i prefissi e sdoganate le inquietudini, per porre fine graziaddio al ghetto del
post, garanzia per troppi di una mediocritas neanche troppo aurea.
Potente, evocativa, soffice, generosa, atmosferica,
convinta: sembra non mancare nulla alla musica dei
NHO. Neanche l’eventualità - il rischio - di congelarsi in un presente senza sbocchi.
(6.4/10)
Stefano Solventi
fellas sono una band a tutti gli effetti, con la differenza non da poco che dall’r’n’b trademark di sempre
si passa a un misto di cose (Dictators, Aerosmith) che hanno molto a che fare con Johansen
interprete e autore.
‘Cause I Said So è un girotondo rock, ma soprattutto sui suoi dintorni. E molto a Sud. In una parola
caldo.Tra casa e buoni profumi. Ed è dunque un disco
lontano da New York, un qualcosa di leggero senza
conti in sospeso. A dimostrarlo Temptation To Exist,
brano che si spinge fino al confine coi Calexico
e, wow, Trash, rilettura del loro classico in versione
reggae (e funziona!), per non parlare dei Sixties da
balera pre ’65 a colpi di twang e rhythm’n’blues di
Lonely So Long.
Proprio come l’Iggy di Preliminaires, quel che
colpisce è la freschezza e la perfetta stagionatura
84
/ recensioni
delle canzoni: viaggiano come bere acqua dalla fonte
e la rinnovata verve è così convincente che song
alla vecchia come My World o Exorcism Of Despair
sembrano superflue.
La lezione è tutta in devozione, qualcosa di più easy
di quando la pensi a vent’anni. Ha probabilmente
a che fare con questo - dunque l’aver compreso il
proprio posto nella storia - la gran forma di Johansen e Sylvain. Classici.
(7/10)
Edoardo Bridda
Nicker Hill Orchestra - All The
Different Deaths....and Rebirths
(In The Bottle, Maggio 2009)
G enere : post post rock
Galleggiare sul futuro anteriore del post-rock, su
Nicolas Bernier/Jacques PoulinDenis - Sur Fond Blanc (Ekumen,
Maggio 2009)
G enere : elettroacustica
Nessun passaggio di testimone per il collettivo Nicolas Bernier&Jacques Poulin-Denis fedeli ai connubi in arte elettroacustica e danza intrapresi con
Etude no.3 pour cordes et poulies (Ekumen,
2007).
Per Sur Fond Blanc le premesse sono le medesime: si tratta di un supporto sonoro successivamente pubblicato su disco commissionato ai due artisti
dalla medesima compagnia, la O-Vertigo.
Il tema è lo spazio interiore, il vuoto e l’assenza
a cui far intervenire mutevoli interventi sonori. Il
suono, in questo caso, non si riduce all’essenza im-
prendibile del minimalismo ma contempla il movimento (trait d’union tra danza e suono) attraverso
l’intreccio di elementi - elettronica in textures, field
recording, contributi in prosa, frame e soundscapes
- a servizio di continuità e dinamismo.
Non mancano le sezioni più cupe e drammatiche, i
respiri e le fragilità, quelle testimoniate dagli scritti
ultimi del Bernier de Les Arbres (No Type-2008)
e neppure le atmosfere ambient o i rimandi all’inconscio.
Discreti i compendi e la materia come poco incisivo
il trasposto su disco. La sensazione è che alle dialogate trame d’elettroacustica manchi una seconda
voce - quella che originariamente spettava al visuale
e alle significative coreografie di Ginette Laurin - la
cui interazione sentiamo necessaria per una scrittura nata certamente con gli intenti più simbiotici.
(6/10)
Sara Bracco
Nneka - No Longer At Ease (Yo
Mama’s, Giugno 2009)
G enere : new world
Che il rapporto tra forma e contenuto sia ormai una
questione superata è, a dispetto dell’imperante relativismo culturale, una faccenda assai dibattibile. Offre
discreto contributo alla disputa questo nuovo lavoro
della nigeriana - trapiantata ad Amburgo - Nneka, che
per sostenere una lodevole denuncia sociale affida i
suoi brani a contaminazioni sonore oggi quasi scontate. Non un gran problema, in fondo. Semmai qualcuno potrà infastidirsi nell’apprendere che dietro la
Yo Mama’s c’è la Sony e che la ragazza non ha peli
sulla lingua nel denunciare le compagnie petrolifere
che da decenni depredano e avvelenano il suo paese.
Che facciamo, allora, smettiamo di ascoltare Clash
e Rage Against The Machine in nome di una
non meglio specificata “coerenza” e amen se il messaggio non arriva fuori della solita cerchia?
Che ognuno si regoli come meglio crede in tal senso, poiché quel che preme qui sottolineare è l’altalenante qualità del disco, indeciso se proporre una
Neneh Cherry circa Homebrew incazzata col
mondo (succede meglio che altrove nella bristoliana Running Away, nei nervosismi di Halfcast e in
una gustosa Streets Lack Love) o affidarsi al modello
Lauryn Hill senza trattenerne l’efficacia compositiva (l’acustica, vibrante Come With Me eccezione
che conferma la regola.) Altrove il gioco è condotto
dal solito DJ Farhot su interessanti sincopi drum
& bass e ricordi d’afro-pop, cartoline giamaicane col
recensioni /
85
pilota automatico e pessime copie dei Morcheeba. La sensazione diffusa è che, causa l’attenzione
rivolta alle parole, penna e arrangiamento abbiano
pagato pegno. L’equilibrio tra danza e militanza è
prerogativa dei Maestri ed ecco qualcosa su cui siamo tutti d’accordo.
(6.5/10)
Giancarlo Turra
Nouvelle Vague - 3 (Peacefrog,
Giugno 2009)
G enere : wavy - lounge
Furberia (pensando al sistema-mercato) e ruffianeria (pensando al sistema-pubblico) del progetto (rileggere classici new wave in chiave lounge). Bravura
nel confezionare il tutto (voci alla Giuppy Izzo, suoni
morbidi, arrangiamenti curati, selezioni azzeccate).
Un rischio che si affaccia: che il gioco stanchi presto.
Questi i dati “oggettivi” sui Nouvelle Vague. Al
di là poi del gusto personale o di una presa di posizione ideologica (che possono benissimo stuzzicare). Materie di discussione: vengono meno le specificità dei pezzi o queste specificità vengono anzi
esaltate dal trattamento NV? Esercizi di stile (gioco
di decostruzione PO-MO) e ossessione di genere
(di generi: quello “di entrata” e quello “di uscita”) o
semplice cover band a tema? (Ma valgono poi davvero queste dicotomie così nette?)
Più riuscito, perché più piacevole (ed essere piacevoli è sicuramente lo scopo dei NV) del secondo
capitolo, questo 3 accentua ulteriormente lo spostamento del progetto da atmosfere latin latu sensu
verso la ballad pop soffice e delicata (con un effetto
molto Carla Bruni), ora venata di folk & country,
ora di funky-reggae, ora jazzata (e ora rarefatta, quasi ambient, come in So Lonely). Idea carina quella di
ospitare Gore per Master & Servant, McCulloch
per All My Colours, Adamson (il cameo migliore) per Parade, Hall per Our Lips Are Sealed. Ma la
cosa non sposta di molto i risultati. Il vero colpo c’è
quando il pezzo è epocale e la rilettura lo trasfigura:
God Save The Queen fatta voce e arpeggio, agrodolce
come le riletture di Bowie fatte da Seu Jorge
per lo Steve Zissou di Wes Anderson.
(6.2/10)
Gabriele Marino
OMFO - Omnipresence (Essay
Recordings, Giugno 2009)
G enere : O riental D own T empo
Nei Novanta ce ne siamo fatti un’abbuffata. Dozzi-
86
/ recensioni
ne di album (mid)down tempo dal sapore etno nel
lettore e quei flare a imperversare nelle chill out
come, fuori di esse, band come Orbital e Chemical Brothers pronti a coglierne l’essenza rincorrendo quella che, a un certo punto, sembrava la
chimera chic per eccellenza.
Poi a memeoria arrivarono i Thievery Corporation (bossa), i Basement Jaxx (Bollywood), e
i Gotan Project (tango e milonga) e il definitivo
mix di loungeness ebbe un format e naturalmente
un business. Shakira e i buddha bar più sfigati chiusero l’epopea come da copione: un sound kitch, meglio, un sinonimo di brutta musica e basta (proprio
come accadde nei Settanta con la New Age).
Ora un russo emigrato ad Amsterdam di nome
Omfostan, amico di Sacha Baron / Borat - e
nel giro dell’arte multimediale - decide, dopo
(e attraverso) una vita in
giro per tutto l’Oriente,
d’affrontare di petto l’argomento. Per un terzo
album - che pare il definitivo - suona come un
misto dei Thievery più essenziali (il ritmo in levare)
e Gotan (l’aplombe) non senza dimenticare il rave
brit più evoluto (e un’ironia finissima). Per lui si scomoda addirittura Atom TM, il Senor Coconut dei
classici latini rivisti kraut. Le aspettative sembrano
essere quelle di un nuovo messia.
OMFO è uno esperto. Bravo nel prodursi e nel
suonare gli strumenti del Tajikistan, ma c’è qualche
luogo comune di troppo in Omnipresence. Nulla
gli toglie un premio per non aver stuccato con una
siffatta proposta, eppure, sentendo The Sorcerer (geniale mix di reggae, spizzichi di fanfara russa, pianola
jazz e field recording di risate e cornacchie) sembra
d’aver per le mani un capolavoro mancato. Avesse
avuto almeno metà tracce a questo livello e ci saremmo esaltati. Occorre accontentarci invece.
(6.8/10)
Edoardo Bridda
Outrageous Cherry - Universal
Malcontents (Alive Naturalsound
Records, Giugno 2009)
G enere : psych - pop
Universal Malcontents, ennesimo album del
quartetto Outrageous Cherry, parte da un bluesaccio del sud bello tirato e pieno di coretti (I Recogni-
sed Her), passa attraverso una melodia pop malinconicamente inglese (Anymore) e approda sulle spiagge
preferite, quelle targate VU altezza Nico (It’s Not
Rock’n’Roll...And I Don’t Like It).
Si riassume nei tre pezzi iniziali la parabola ultradecennale della band detroitiana. Sean Elwood (basso),
Samantha Linn (batteria) e i due fondatori Larry Ray
(chitarra) e Matthew Smith (voce, chitarra, organo)
– stabilizzatisi in questa formazione dopo la consueta girandola di bassisti e batteristi – sono l’ennesima band di onesti lavoratori del pop più sixties
oriented ad essere destinati all’oblio o al massimo
ad un culto iper-sotterraneo. Eppure, come succede
spesso in questi casi, di grosso peccato si tratta, perché Universal Malcontents contiene 10 pezzi
godibilissimi nella loro mistura in parti diseguali di
Velvet Underground (diciamo 6 parti), Beatles (almeno un paio di parti), psychedelic pop dei
tempi andati (i 60s, nello specifico) e passione sballona per suoni fuzz e attitudine garage (le restanti
parti). Zero innovazione, personalità a sprazzi, passione come se piovesse. In definitiva un buon disco
di genere.
(6.5/10)
Stefano Pifferi
Papercuts - You Can Have What You
Want (Memphis Industries, Giugno
2009)
G enere : cosmic dream pop
Con il terzo album, il progetto di Jason Quever
(guest member di band quali Vetiver, Beach
House e Skygreen Leopards) si sposta verso
coordinate decisamente più allargate.
Mantenendo una sua base folk e rock sixties (Beach Boys, Dylan, Zombies, Phil Spector, VU), immette nel songwriting ora diventato piuttosto epico,
suonato analogicamente, elementi preponderanti di
dream pop Ottanta/Novanta (Creation e 4AD),
riverberi a volontà, French pop dei Sessanta, persino ritmiche kraut dalle parti dei Can e psichedelia,
tutti elementi che ci permettono un accostamento
non troppo peregrino non a caso con gli amici Beach House (Alex Scally ha contribuito ad alcuni
arrangiamenti del disco) e Grizzly Bear.
Un decostruzionismo pop anche in questo caso per lui allora, per pezzi sognanti e lievi ricolmi di visioni
inconsce, oscuri e dilatati. Una decisa virata in positivo.
(7.1/10)
Teresa Greco
Pinch - Attack Of The Giant
Killer Robot Spiders! (Planet Mu
Records, Maggio 2009)
G enere : D ub S tep
Guardare avanti dopo il classico dub step Underwater Dancehall senza perdere in coerenza per Pinch
significa ascugare il battito. Nell’attacco dei killer
robot la ricetta è una tribal affasellata ma ridotta
all’osso come pure nella seconda traccia Teleportation la stessa sorte toccherà alla drum’n’bass. Il ragazzo non riuncia alle fondamenta (nubi scure sullo
sfondo, radici dub, seconde e quarte battute tolte
dal 4/4), ma lavorando sodo sulle basi apre una via
concreta senza copiare niente e nessuno. (7/10)
Edoardo Bridda
Pissed Jeans - King Of Jeans (Sub
Pop, Agosto 2009)
G enere : punk - noise
Sono sempre più luridi e sboccati i Pissed Jeans, e
male accettano il passaggio alla maturità. Questo è
ciò che risulta dall’ascolto di King Of Jeans, nuovo capitolo della saga del quartetto from Pennsylvania in uscita per Sub Pop. Nulla che si discosti
dai precedenti incendiari album, ma sembra essere
l’acquisizione di una “maturità compositiva” il segno
di questo terzo passo.
L’attacco è al solito di una brutalità indefessa: False
Jesii Part 2 (punk-noise pachidermico e scartavetrato
che si sviluppa su un giro ossessivo di chitarra), Half
Idiot (basso caterpillar
alla Melvins + sproloquio da primi Oxbow +
senso melodico à la Bleach), Dream Smotherer
(hard-punk straight in
your face, senza sconti
né compromessi e dal
peso specifico altissimo)
sono le gemme dirompenti e sfatte che inaugurano
un album che, peggio dei precedenti, ignora il senso
del termine riflessione e/o pausa consolatoria.
Nella musica dei Pissed Jeans è sempre tutto tirato
allo spasimo: le chitarre vanno di grattugia a grana
grossa, la sezione ritmica procede di clava e randello, ma è soprattutto la voce di Matt Korvette, un
Pink Eyes dei Fucked Up forse lievemente (e dico
lievemente per usare un eufemismo) più aggraziato
e melodico, a segnare in lungo e in largo i 12 pezzi
dell’album. Una voce che incendia ogni singolo pez-
recensioni /
87
highlight
Toddla T - Skanky Skanky (1965 Records, Maggio 2009)
G enere : banghrastani l azer - step
Il dopo M.I.A./Missill passa attraverso il dubstep e ne viene fuori Toddla T. L’innesto dei colori
cupi del grime con i confini dell’impero ce lo avevano già proposto Dusk + Blackdown, solo
che là era antropologia urbana seriosa. Qui ci si sfonda invece di skank, percussioni tribali e si va
dritti in cerca del movimento pelvico.
Toddla è quindi la nuova creatura sfornata dalla Sheffield sempre più multimeltin’, il dj che svela di
nuovo il gioco semplice ma raffinato della mescolanza: il ragga sparato
d’n’b di Manabadman, la lazer jungle di Safe (M.I.A. trema), il bbreakin’
di Sound Tape (con gli inserti di synth 90 ormai obbligatori), la techno
sporcata con i ritmi sudamericani di Road Trip, i sample chimici di Shake
It e i laseroni (con il featuring di Roots Manuva) in Sunny Money.
Oltre a tutte queste cosucce in questo disco si respira un’aria internazionale che riassume il suono della capitale del dancehall. Ma badate
bene: non siamo in un club per pochi nerd isolati e brufolosi. Qui si
estende il tutto al pianeta e per un momento ci sentiamo anche noi
fatti di skank e pronti a muovere il culo. Senza aver mai sentito Burial, Benga o gli altri numi tutelari della cricca. Toddla estende il suono a qualsiasi dancefloor ed evade gli schemi che intrappolavano il genere ad essere ‘genere’. E scusate se è poco.
(7.5/10)
Marco Braggion
zo, roca, ubriaca, ferina, ferocemente aggressiva e
urlata allo stremo; nello stesso, identico modo in cui
i restanti tre stuprano un noise-rock che non proviene dall’asse NY/Minneapolis degli anni ’90, bensì
dal sottobosco punk e post-punk americano (con
Stickmen With Rayguns e Flipper - veri e
propri passioni dei quattro - su tutti): convulso, stranito, sgraziato e deforme. E iconoclasta, of course.
Si chiamano Pissed Jeans e se si pisciano nei pantaloni, potete star sicuri che non è per timidezza.
(7/10)
Stefano Pifferi
Placebo - Battle for the Sun
(Dream Brother, Giugno 2009)
G enere : F orever young hard gl am
Con i Placebo ci eravamo lasciati tre anni fa azzardando un destino: esattamente come da copione
del perfetto Peter Pan del rock, Molko non avrebbe mai smesso di cantare la stessa canzone. Battle
For The Sun è, sin dal titolo e dalle press kit, la
conferma dell’assunto: un prodotto teenager fatto
da quarantenni forte della solita e imperterrita formula e forma mentis.
88
/ recensioni
Non è bastata la dipartita dello storico batterista
Steve Hewitt, sostituito dal ventenne Steve Forrest, e neanche la fine del contratto con Virgin (ora
camminano in pienezza di diritti con la loro Dream Brother); il nuovo lavoro è una pallida copia di
Meds, con il quale sicuramente sono stato un po’
troppo severo, o forse semplicemente quel disco
risulta migliore di converso.
Aspetto interessante è dunque il lato tecnico: non
pensate a un suono chissà che pomposo pensando
al nuovo produttore Dave Bottrill (già al lavoro
con Tool). Buono il lavoro in The Never-Ending Why,
tuttavia a sentirsi maggiormente è il mixing di Alan
Moulder, in linea con certi richiami My Bloody
Valentine (Kevin Shields, Reznor e Corgan in curricula) e dunque dagli espliciti richiami shoegazey.
Non ci salverà dai mitici tormentoni di Molko
(“cuore di portacenere”, “Slow motion suicide” oppure la già famosa “voglio un cambio di pelle”, per
non parlare di “fratello dei sogni, mio amante mio
assassino”) ma aiuta. E se vogliamo novità positive
troviamo le tastiere casio utilizzate un po’ a prezzemolo (ascoltatevi pure il recente Depeche Mode
per le tastierine retrò) e, perché no, l’ottimismo
che pervade quasi tutti i testi, aspetto dichiarato
dal cantante in più di un’occasione in questi mesi.
“Abbiamo fatto un disco che parla di scelte di vita, di
scegliere di vivere, di uscire dall’oscurità e andare verso
la luce”. E aggiunge: “Sono in un momento positivo per
la mia mente, quello che vedo è eccitante”.
Di contro alle belle parole, abbiamo un videoclip
anni ’90 super abusato con una debole canzone
a fargli il paio, For What It’s Worth, e una valanga di
luoghi comuni ai quali i fan sono abituati. Con ciò
che vale, salverei proprio il brano più gaze del lotto,
Bright Lights: brutto il ritornello ma la leggerezza è
quella che manca in tre quarti del disco. Infine non
dimentichiamo la rima “A heart that hurts it’s a heart
that works”, me la segno sul diario delle superiori. E,
vi prego, togliete quegli archi.
(5/10)
Edoardo Bridda
li “vissuti” di fianco ad un amplificatore Fender e
che come titolo dell’ultima “fatica” in studio sceglie
l’inequivocabile The Hardest Town? No, non si tratta
di una parodia zappiana del southern rock, come
avrebbe pensato qualche mente aguzza. Anche se a
volte la realtà si presenta più esilarante di una satira. Chi conosce i Rhino Bucket, gruppo losangelino attivo, a fasi alterne, sin dal 1987 e noto per essere
uno dei cloni più riusciti degli AC/DC, sa di cosa
stiamo parlando. Appare un’impresa trovare anche
solo un riff, una linea vocale o un assolo di chitarra,
in almeno una delle 10 canzoni (anzi, 11, c’è anche la
bonus track!), che non faccia riferimento ai classici
di Angus Young e soci. E poco importa se dietro
alla batteria c’è Simon Wright in persona a fare
da garante.
(3.8/10)
Daniele Follero
Poison Pen - The Money Shot (Gold
Dust, Agosto 2009)
G enere : hip - hop cazzone
Secondo long per Poison Pen, newyorkese di
Brooklyn, sulla scena dal ‘96, membro degli Stronghold, autore di un paio di 12 pollici e di un primo
album-fantasma nel 2007, rapper che conoscevamo
di striscio per il suo feat su un vecchio pezzo di
Doom, Bloody Chain. Disco senza picchi di tecnica
ma scorrevole, tra inni alcolici (con tanto di rutti), spacconate varie, cameratismo street e tentazioni conscious (The 2nd Ammendament, sull’abuso
di armi negli USA), il tutto presentato con molta
autoironia. Basi midtempo, larghe per calzare la prosodia marcata e rilassata di Pen (eccezione WTP),
funzionali, con inflessioni soul sparse (ma produttore non accreditato e irrintracciabile anche sul
web: autoprodotto?). Un quattro-cinque pezzi sono
molto riusciti, qualcuno anche con buon potenziale
commerciale, vedi il singolo BK’s Fat Boy. Citazione
della sirena di Kill Bill (a sua volta ripresa dal serial
Ironside) nella titletrack.
Scuba - Klinik / Hundreds &
Thousands (Hotflush Recordings,
Aprile 2009)
G enere : T ech -S tep
Dopo il botto 08 (con A Mutual Antipathy) la
direzione del nuovo Scuba in questo 12” è sempre
più verso il battito techno. E quindi la cassa in quattro la fa da padrona. Dimenticate per un momento
le atmosfere ambient e haunting di quel capolavoro.
Come Nathan Fake, anche qui si cambia sui binari macchinici del proverbiale sound detroitiano.
Paul Rose si discosta dallo step e ci va di tech.
Quella da digrignare i denti e lasciarsi trapassare dagli stati di agitazione trance senza inibizioni. Quella
che parte dall’anima e ti spezza senza compromessi.
Hundreds & Thousands è pura progressione in 4 con
gli inserti di chitarra sporca che fanno l’occhiolino
ai Prodigy e a quel mitico ‘92. Klinik è il lato B, importante ricordo dub del passato. Ma ragazzi, è solo
un ricordo. Ora il sentiero è segnato. Il trend è di
nuovo lì: techno come non mai.
(5.95/10)
(7/10)
Gabriele Marino
Marco Braggion
Rhino Bucket - The Hardest Town
(Acetate, Giugno 2009)
G enere : H ard R ock
A volte le copertine riescono a descrivere un album
molto meglio di quanto riesca a fare la musica. Cosa
immaginate di aspettarvi da una band che schiaffa
in copertina le gambe di un uomo in jeans e stiva-
Scum from the sun - Scum from
the sun (Afe records, Giugno 2009)
G enere : doom / electronic s
Negli ultimi anni tra Isis, Old Man Gloom, Jesu e
compagnia bella si è mosso parecchio nell’ambito
doomshoegaze-e-contaminazionivarie; una prima
“risposta italiana” era già arrivata con i Vanessa Van
recensioni /
89
Basten, ora gli Scum from the Sun provano a spostare l’asse verso lidi più elettronici e sperimentali. E lo
fanno con un concept album - omonimo - che non
ha paura di addentrarsi in territori che lambiscono
l’ebm pur privandolo della sua essenza danzerecchia ed edonista. Il ritmo lento - che potrebbe provenire dai remix
dei Godflesh - si interseca con drones di synth eterei e da soundtrack: li vedrei bene come colonna
sonora di un film di Carpenter (La caduta prima del
distacco). Non dimenticano nemmeno la lezione dei
Mogwai sul come costruire quiete tracce strumentali che vanno a braccetto con una drum machine
(Caput corvi). Convince appieno l’isolazionismo di
Eris con i suoi saliscendi di feedback e drones che
si danno appuntamento su una navicella a gravità
zero.
Un disco che si fa apprezzare anche per la sua confezione simil “metal box” - in cd ovviamente - molto
curata come del resto è abitudine Afe.
(7/10)
Nicolas Campagnari
Sébastien Schuller - Evenfall
(Green United Music, Maggio 2009)
G enere : I ntimismi pop
Sia Sébastien sia la sua label - Green United - non
sembrano amare particolarmente i meccanismi
di mercato: il sito dell’artista è work in progress,
l’etichetta possiede soltanto un My Space, la distribuzione è un affare di passa parola. Di fatto hanno
lavorato così male che, a tre anni dal buon Happiness, a maggio usciva Evenfall e non è voltata
una mosca. Tutti zitti fino alla pubblicazione della
recensione sul blog più
famoso della rete, Bolachas Grátis, a cui ha fatto
eco Rate Your Music.
Un riscatto necessario
- e grazieaddio - perché
il nuovo lavoro, se risulta da subito più autonomo rispetto ai suoi proverbiali riferimenti di prossimità, è anche un gran
bell’album avvolto in una maliconia intensa e spoglia
d’ogni trucchetto copia incolla indie.
Schuller era già bravo ma è maturato: il lavoro volta
acustico e per buona parte è pop astratto per il quale possiamo spendere i paragoni più pertinenti con i
Buckley, i Sigur Ros e la magia delle Deserter
Songs mercuriane senza troppo stringere il campo
90
/ recensioni
al solo Yorke e alle tante Pyramid Song. E non dimentichiamo neanche gli episodi diciamo convenzionali
dove, tra drum machine e crescendo, il trasporto è
ammaliante e il colpo al cuore a effetto istantaneo.
Ma veniamo alla sfiga - e quasi ce l’aspettiamo viste
le premesse - il lavoro di produzione: in certi passaggi, l’assenza di un produttore è pesante quanto
la cura con la quale Sébastien ha confezionato le
tracce. Sébastien non è il DM Stith che va d’incisi
e pennellate in libertà e riesce nel contempo a calibrarti bottoni e levette. Eppure... una misura per
arrivare al celeste è stata tracciata.
(7/10)
Edoardo Bridda
Simak Dialog - Demi Masa (Moon In
June, Giugno 2009)
G enere : psych jazz
Prendete un tastierista, un chitarrista e un bassista,
aggiungete due estrosi percussionisti e metteteli
all’opera su una fregola fusion con l’esotica fiammella etno sempre accesa e refoli bossa a scompigliare
la mistura. Mettiamo che riescano ad azzeccare il
dosaggio e ne esca un elisir dolce e acidulo, fluido e
frizzantino, coi retrogusti che s’inseguono esoterici
e accomodanti lasciandoti sulla soglia di un suadente mistero. Sono i Simak Dialog, quintetto da Jakarta
fondato nel 1993 da Riza Arshad (il tastierista) e da
Tohpati Ario Hutomo (il chitarrista).
Demi Masa è il loro quinto album, strutturato
in quattro sezioni dove le singole tracce - durata
media vicina agli otto minuti, dai due e mezzo di
Trah Lor Laras al quarto d’ora di Salilana Pertama - si
sviluppano sbrigliate come jam, evocative come suite e ipnotiche come raga. Il Fender Rhodes s’impadronisce spesso della scena, guizzando con arguzia
speziata più Chick Corea che Zawinul, mentre
gli assolo e i ricami della chitarra possiedono un’affilatura scabra e saettante di stampo Scofield. A
stupire è però la leggerezza dell’insieme, che ne fa
un pregevole manufatto anche in ottica chill out.
Provare per credere.
(6.9/10)
Stefano Solventi
Simple Minds - Graffiti Soul
(Universal, Maggio 2009)
G enere : N ew wave - pop
Capita che in periodi di revival e reunions si riaccenda la luce anche su coloro i quali invece non
avevano mai smesso, magari riportando loro anche
un po’ di ispirazione. Non è il caso dei Simple Minds,
i quali escono con un altro disco spento. Qualche
segnale di vita nell’iniziale Moscow Underground, vecchio stile ma con la giusta tensione, e poco altro: il
singolo Rockets può dare sollievo nella orrida programmazione delle radio e Stars Will Lead The Way
anche, se sarà il prossimo estratto, ma in generale
non si va oltre la loro maniera wave-pop un po’
epica un po’ eterea, riconoscibile ma allo stesso
tempo anonima in quanto animata solo raramente
dalla trovata di un suono, di un passaggio diverso, da
accenni di idea. Nonostante i risultati opinabili ottenuti qualche
anno fa con un’operazione simile, poi, c’è anche un
bonus disc di covers, nel quale funzionano Shadows
& Light e Teardrop, (più per la solidità della scrittura
originale che per il rifacimento) mentre il resto va
da una Rockin’ In The Free World che riescono quasi a
fare male (e ce ne voleva), a classici new wave divertenti e non altro, a parte forse Christine.
Più noioso e strasentito che davvero sgradevole,
ciononostante:
Sinclair - Electric Black Sheep
(Big Dada Recordings, Giugno 2009)
G enere : E lettro
Sappiamo da mo’ che gli 80 son tornati: Ray Ban,
spalline, colori accesi e facciata uberbarocca. La ‘musica da bere’ poi ha già segnato il passo e i cloni di
quegli anni li senti ovunque. Gli ingredienti sono le
solite tastiere, le voci pulite, un immaginario sognante party, VIP areas (come diceva la vecchia gattina
belga) e cotillon innaffiati da champagne.
Il disco dei Sinclair si situa in questa galassia di suono: i riferimenti vanno ovviamente a quegli anni, ai
primi Depeche Mode, alla voce distillata di Valerie Dore e alla progressività moroderiana. Il tutto
aggiornato con il migliore software per ‘far finta’
di essere ancora là. Buona produzione e motivetti
catchy che alla lunga stancheranno però anche gli
aficionados
si sono voluti concedere come regalo di nozze nel
2003. Hanno iniziato come trio assieme ad un amico, ma per fare sul serio hanno dovuto imbarcare
il batterista Þormóður Dagsson e il bassista Örn
Ingi Ágústsson. L’esordio Lab of Love (Bad Taste,
ottobre 2006) stuzzicò complimenti e una certa
eccitazione nell’ambiente, che il qui presente sophomore All Over The Face dovrebbe ribadire
e amplificare. Prodotto da Orri Jónsson - autore
di numerose soundtrack e già al lavoro coi Gus
Gus - è un lavoro fragrante, assieme impetuoso
e lieve, impudente e accorto, come poteva confezionare solo chi ha elaborato la propria versatilità
senza pressioni culturali e ambientali, ovvero senza
preclusioni stilistiche.
Capita così di ascoltarli mentre si preparano l’insalata con misticanza Belle And Sebastian e
Prefab Sprout più
una spolverata di Yo La
Tengo
(nell’incedere
teso e trepido di Costa
Bravo), abbozzare scontrosa freschezza da nipotini neoromantici dei
Sonic Youth (Now Or
Never) oppure ricavare
un mid tempo arguto come dei Cars inturgiditi Pavement o se preferite dei Cock Robyn
strattonati Modern Lovers (Like You Did). Per non
dire di quando ci rendono partecipi della devozione Dylan con trasporto stropicciato da Arcade
Fire fanciulli in Smell You Later, coadiuvati dall’armonica di Örvar Þóreyjarson Smárason dei Mùm.
Ma è con Good Times che davvero ci sconcertano:
percussioni sincopate e arrembanti, il piglio noise delle chitarre, riff sghembo di synth, il canto da
Byrne anfetaminico e ritornello che squaderna
Flaming Lips, My Bloody Valentine e PIL
come un gomitolo di fili avanzati da rocchetti di diverso colore.
Piacevoli le pur minimali melodie. Disinvolte le interpretazioni, con quella verve trafelata e le malinconie scontrose. L’evoluzione della specie lo-fi.
(5/10)
(7.1/10)
(5/10)
Giulio Pasquali
Marco Braggion
Stefano Solventi
Skakkamanage - All Over The Face
(Morr Music, Giugno 2009)
G enere : lo - fi folk wave
Shakkamanage è la band indie rock che gli islandesi
Svavar (voce e chitarra) e Berglind (tastiere e voce)
Skepta - Microphone Champion
(Boy Better Know, Giugno 2009)
G enere : hip - hop / grime
Rapper e poi produttore e discografico, giovane
stella della scena grime basata nel nord di Londra,
recensioni /
91
Skepta, al secolo Joseph Adenuga Junior, è una
personalità forte, uno che dichiara di essere il re del
genere e il principale responsabile del suo sdoganamente commerciale (di hit in effetti ne ha infilati).
Basta poi guardare titolo e copertina del disco. Che,
anche se per buona metà auto-prodotto, è inteso
soprattutto come showcase delle sue capacità di
mc. E il rapping in effetti ci sarebbe anche, e pure
come basi non si parte malissimo.
Ma malissimo presto si va a finire, in un tripudio dei
peggiori stilemi di hip-hop generalista, grime e dancehall senza peli sullo stomaco, con effettacci assortiti e una ripetitività che non diventa mai ipnoticità.
Soprattutto, con la parte musicale che non acquista
mai profondità di suono. Che è ‘sto piattume. Già
a metà si comincia a guardare l’orologio. Apice del
bruttume, roba che parrebbe quasi un’autoparodia,
traccia undici, Disguise: sentire il trattamento delle
voci. La sensazione più che altro è quella di un grande, furbacchione, ma raffazzonato, riciclo.
(4.4/10)
Gabriele Marino
Sonic Youth - The Eternal
(Matador, Giugno 2009)
G enere : indie rock
Il tanto sbandierato ritorno a casa dei Sonici, di
nuovo sotto le ali di una indie dopo tempo immemore, non è poi una notizia così clamorosa: a onor
del vero, in quasi due decenni di Geffen non avevano
rinunciato neppure a un mignolino della propria essenza, mantenendo salda quell’esclusiva visione pop
- si è sempre trattato di canzoni, dopo tutto - con
tutte le derive di volta in volta concessesi (del resto,
per le amabili astrusità c’è sempre stata la serie SYR
e l’infinita ragnatela di collaborazioni).
Ora, la maturità dei protagonisti è abbondantemente assodata: chi per passione, voglia o pervicacia
ne avesse seguito le mosse recenti (soprattutto il
precedente Rather Ripped e il Moore solista di
Trees Outside The Academy, 2007) avrà avuto
modo di prenderne atto; nel caso di The Eternal quindi, come del resto dei lavori che lo hanno
preceduto, interessi allora annotare eventuali divagazioni – o perché no, variazioni - sulla ben cognita
mappa.
Per cominciare, non si possono non registrare pesanti tracce di Goo e Dirty (ironia! i loro esordi su
major), una recuperata freschezza bubblegum che
esplode nei due-minuti-due dell’iniziale Sacred Trixter e spande i suoi aromi sul resto del programma
92
/ recensioni
(Leaky Lifeboat e i suoi la-la-la, Poison Arrow e i suoi
sentori quasi Sugar Kane), alimentando sulle prime
più che debiti sospetti di nostalgia degli irripetibili
(?) ’90. In apparente controtendenza con la succitata maturità, i quattro appaiono in effetti svecchiati
e più agili che mai, snocciolando una dietro l’altra
canzoni veloci e dirette come una serie di 45 giri;
sorprende poi vederli alle prese con armonie vocali
(una rarità del loro repertorio), e in un paio d’occasioni – What We Know, Calming The Snake - lasciar
guidare il groove al basso di Mark Ibold, recentemente promosso da
ex-Pavement a sonico
ausiliario.
Insomma, ce ne sarebbe
abbastanza per osannarne la resurrezione o, in
alternativa, storcere il
naso di fronte all’ennesimo disco-riciclo; questo
se siete in cerca di facili conferme ai vostri – anche legittimi, per carità - (pre)giudizi. Se invece vi
va di grattare la superficie, prestate bene orecchio
ad Antenna (Thurston Moore in versione poeta metropolitano à la Tom Verlaine, in una ballata rock dai
toni quasi Creedence) o Massage The History (dieci minuti semiacustici e onirici con una Gordon da
manuale, che riesuma perfino il verso “all the money’s gone” direttamente da I Dreamed I Dream): è
lì che sono i Sonic Youth del 2009, e probabilmente
continueranno a restarci – fino al prossimo disco,
ovviamente.
(7/10)
Antonio Puglia
Suburban Kids With Biblical Names
- # 4 (Labrador, Febbraio 2009)
G enere : elettropop
Prodotto volutamente leggero... con piccole sofisticazioni interne. Il capitolo #4 degli svedesi Suburban Kids With Biblical Names è un EP che
non fa altro che citare ciò che fa effetto, senza elucubrazioni e con una tecnica d’assemblaggio tutto
sommato buona.
è così che Studenter På Flak si butta a pesce su melodie smithsiane, e 1999, in apertura, intreccia un’impressione di collage settembrino che di fatto rivela
un perfetto stile synth-pop Ottanta (a proposito, è
un cut-up del TRL italiano quello che sentiamo?)
Nella pillola indorata di quegli anni sta la chiave per
leggere questa musica: superficiale e funzionale a
un’opulenza produttiva che, lo ribadiamo, è sopra la
media. A cercare altro, viene da dire “peccato”, ma
probabilmente non c’è nessun motivo per farlo.
(6/10)
Gaspare Caliri
Suffocation - Blood Oath (Nuclear
Blast, Luglio 2009)
G enere : brutal
Dopo l’omimo sorprendente del 2006 (non roba
nuova, certo, ma il loro suono e la loro musica al
massimo della potenza), tornano i Suffocation,
stavolta su Nuclear Blast. Si può postulare che più
estreme sono le propaggini di genere lambite, e più
innovativa è stata storicamente la formula brevettata, meno saranno gli elementi espressivi a disposizione, meno gli spazi di libertà e di novità: più difficile insomma rinnovarsi. I Suffocation non sfuggono al
postulato: estremi(ssimi), decisivi, monodici. Messa
in conto quindi la fissità stilistica, si cercano altrove
i motivi di interesse.
Ma il disco è molto meno incisivo di come ci si
poteva-voleva aspettare. A partire dalla produzione, non efficacissima, soprattutto se paragonata a
quella scintillante del 2006, con la voce a coprire
troppo, da sentire in cuffia per non perdere il filo
dei contortissimi riff, catrame geometrizzato. Si
nota forse una maggiore compattezza (e una certa
vena thrash), dovuta anche alla maggiore quadratura, a un minor sbizzarrimento, della batteria del
mito Mike Smith. La voce di Mullen si è fatta
ormai quasi del tutto intelleggibile, con un cantato
meno continuo e più a blocchi, certamente più dei
grugniti sordi degli esordi (ma che si facevano preferire). Manca soprattutto l’impatto a servire dei pezzi anche studiati ma comunque non eccezionali. La
conclusiva Marital Decimation continua l’operazione
di ri-registrazione programmatica dei pezzi del vecchio Breeding the Spawn. Edizioni con versioni
strumentali di due brani dalla tracklist, diverse a seconda del paese.
(6/10)
Gabriele Marino
Sunset Rubdown - Dragonslayer
(Jagjaguwar, Luglio 2009)
G enere : indie pop
La scena indie pop rock di Montreal degli ultimi anni
ha in Spencer Krug uno dei suoi protagonisti,
coinvolto come è noto in innumerevoli progetti paralleli (Swan Lake,Wolf Parade…). Sunset Rubdown
si è trasformato via via, da esperimento solista, in
gruppo vero e proprio, arrivando ora al quarto album.
Con Dragonslayer si riparte non dal penultimo
Random Spirit Lover (2007), che aveva rappresentato un mezzo passo falso con il suo psych pop
costruito, dilatato oltremisura e piuttosto dispersivo, bensì dai primi due dischi.
Riappare allora l’obliquità che tanto ci era piaciuta
allora, un misto di pop e
glam, barocco e melodie
sghembissime, stratificato e dissonante il giusto.
Con una destrutturazione meno accentuata che
in passato ma ancora
presente. L’imprevedibilità degli Sparks (Idiot
Hearts), Bowie e Roxy che incontrano i soliti
Arcade Fire (Silver Moons), qualche traccia appena d’acidità ereditata dagli esperimenti del penultimo (Black Swan, la lunga finale Dragon’s Lair in odore
di Neil Young), il solito gusto netto per la melodia, accenni Broken Sociale Scene e Tv On
The Radio (Paper Lace).
Il tutto è più diretto e senza fronzoli, con una bella
urgenza, e arriva direttamente questa volta.
(7.1/10)
Teresa Greco
Surfing Machos - History Files
Vol. I - the theatre of Mejerhol’d
and Majakovskij (Geoduck & Koala
Records, Giugno 2009)
G enere : electro avant
Found voices, found sounds, accorti arpeggi di
chitarra e piano, elettroniche allibite. Più la voce
narrante - come un ectoplasma spaziotemporale dell’attrice teatrale russa Natalia Teplysheva. Questo
il materiale con cui i Surfing Machos (ovvero Alessio
Budetta - già negli Orange targati Snowdonia - e
quel d.m. che abbiamo intercettato negli Eveline)
danno vita alle meditazioni attorno alla scena culturale russa dello scorso inizio secolo (tirando in
ballo nomi come Majakovskij, Blok e Stanislavskij).
Il risultato è straniante e fascinoso, una copula eterea
e lenta tra astrazioni Brian Eno e spersi struggimenti GY!BE, tra impalpabili spiritelli minimal-ambient, palpiti di concreta, brumosi margini industrial.
Il loro è un esotismo culturale prima che geografico,
ciò che ti obbliga a inclinare lo sguardo, i sensi, i pen-
recensioni /
93
sieri. A regolare il timer della percezione.
Questo History Files... parrebbe, oltre che il loro
esordio, il primo volume di una serie. Siano lodati.
dei classici dell’hip-hop 2000, Mathematics di DJ
Premiere-Mos Def.
(7.4/10)
Gabriele Marino
(7/10)
Stefano Solventi
Themselves - theFREEhoudini
(Anticon, Marzo 2009)
G enere : electro - hip - hop
Pilastri dell’hip-hop escapista Anticon, due grandi album alle spalle, il primo, dieci anni fa spaccati, asciuttissimo e intenso, il secondo più prodotto e più
sperimentale, in qualche modo sulla scia cLOUDDEAD. Poi gli spin-off 13&God, coi Notwist,
e Subtle, interessanti, soprattutto il secondo (che
sembrava averli assorbiti completamente), con strumenti suonati accanto a campioni ed electronica,
cantati accando al rapping. Tornano un po’ a sorpresa allora Doseone (che dei cLOUDDEAD era
la voce) e Jel a nome Themselves, con un disco tanto infarcito di feat
(Aesop Rock e Buck
65 i nomi più noti anche ai non followers)
da sembrare quasi un
crew-album. Inizialmente
pubblicato online come
mixtape (mix by Odd
Nosdam) di 39 minuti
da scaricare gratis, poi disponibile anche in forma
fisica con qualche pezzo in più e le tracce splittate.
La base è la solita elettronica&dintorni maltrattata e
sporcata, rumorista, in stile Them-Anticon appunto,
ma con una grinta più rock e contemporaneamente
più “danzereccia”.
Dose in formissima, sempre nasale al limite della
caricatura e sempre capace di maratone hi-speed
da fiatone, si veda il primo pezzo. Tutti i feat sono
riuscitissimi, da Sole a Lionesque a Serengeti a ThePedestrian, con quest’ultimo che firma la traccia più desolata, industrial-pauperistica,
del lotto. Ancora sorprese: reunion (oneshot?) dei
cLOUDDEAD su Rapping4Money, dato che oltre a
Odd compare anche Why?, pezzo molto rappuso
nella forma e, ovviamente, molto anti-rappuso nelle
liriche. Pare che alcune tracce di questo mix appariranno sull’annunciato vero e proprio terzo album
dei Them, titolo Crowns Down. Vedremo. In ogni
caso, un ottimo ritorno, ma soprattutto un ottimo
disco punto e basta, sorprendentemente fresco. Curiosità: Long Time Coming campiona in coda uno
94
/ recensioni
Tiny Vipers - Life On Earth (Sub Pop,
Luglio 2009)
G enere : folk psych
Dopo due anni pressoché esatti, torna sul luogo del
primo ineffabile delitto Tiny Vipers, al secolo Jesy
Fortino da Seattle, fino a poco tempo fa esile cameriera da bistro e oggi speranza del folk alternativo a
stelle e strisce targata Sub Pop. Rispetto all’esordio,
la scrittura e l’interpretazione guadagnano in intensità, si corroborano a vicenda anzi si compenetrano,
al punto che non t’immagini la spersa solennità di
queste melodie separate dalla trepidazione essenziale di voce e chitarra acustica, prodigiosamente in
grado di ricavarsi una dimensione psych.
Ballate su ballate, crepuscoli masticati con irrequieta saggezza, uno spleen deliziosamente tedioso e
soavemente ipnotico che la ragazza propone con
l’appassionata austerità di un Jason Molina e la
generosa alterigia della Nico più frugale. Non possiamo che apprezzarla, augurandole un futuro sempre più luminoso. In tutti i sensi.
(6.9/10)
Stefano Solventi
Tribuna Ludu - In Etere (Danza
Cosmica Records, Giugno 2009)
G enere : post - punk - funk
Gioca tutto di incoscienza giovanile ed impeto iconoclasta, l’esordio di Tribuna Ludu. Dopotutto, di
questi tempi scegliersi un nome del genere e gettare nella mischia una cover di Io Sto Bene di cccpiana
memoria è una dichiarazione d’intenti che si presta
a aspettative al di sopra della media.
Quello di TL è un post-punk da nevrosi iper-ritmica
posto esattamente al guado tra follia da calembour
linguistico post-surrealista e isteria strumentale,
(auto)ironia caustica e gridata e schizofrenica tendenza alla frantumazione stilistica, sguardo lucido/
ludico sull’attualità e passione per sonorità (ria)
dat(t)ate. La tripletta iniziale Cardiopalma/Stato Di
Grazia/Il Passo Dell’Oca è ottimo esempio di questo
procedere citazionista e muscolare, ma è la citata
cover dei CCCP a divenirne paradigma: filologica il
giusto, inserisce il turbo a livello di ritmica in (quasi)
4/4 tunz tunz alimentando fantasmi da disco mitteleuropea post-Berlusconi ter e giocando di meta-
highlight
Ultimo Attuale Corpo Sonoro - Memorie e violenze di Sant’
Isabella (Manzanilla, Aprile 2009)
G enere : post - rock narrativo
Memorie e violenze di Sant’Isabella ha l’impeto rivoluzionario del libero pensiero, la nobiltà d’animo dell’atto politico disinteressato, la commozione gracile di un amore sconfinato, lo
spessore dell’opera letteraria, l’intensità catartica di un manifesto programmatico. Se i CCCP
rappresentano la militanza, gli Offlaga Disco Pax si identificano
nel ricordo nostalgico, i Massimo Volume definiscono la narrativa esistenziale, questi Ultimo Attuale Corpo Sonoro sono l’Italia che
non c’è mai stata. Quella ferita a morte dalla politica stragista, messa
a tacere da quarant’anni di governo democristiano, sterminata dalle
trame piduiste e dai servizi segreti. La voce contro, insomma. Ma anche l’intellettuale senza legacci. Che è punto di osservazione, più che
figura statica e personificata. In un processo di identificazione in cui
Pier Paolo Pasolini (Empirismo eretico, Ultima lettera al 1975, Le ceneri
dell’idroscalo) diventa il poeta turco Nazim Hikmet (L’esilio del canto, I
fantasmi del Bosforo, Impossibile dormire a Varna, amore) che diventa Arthur Rimbaud (Memorie e
violenze di Sant’Isabella). Ognuno simbolo di libertà d’espressione e di critica contro il controllo
sociale violento, metafora di indipendenza e analisi arguta del quotidiano orrore. Oltre i confini di
una nazione, di una divisa politica, di un genere. Spoken word e musica. Quest’ultima, a grandi linee,
un post-rock etereo e immaginifico con qualche puntata verso autorialità solenni à la Giovanni
Lindo Ferretti. Anche se l’aspetto meramente tecnico passa in secondo piano perché fondamentale è il continuum di musica e parole, il messaggio, l’interpretazione, non i dettagli sparsi. Un
fascio di verità e poesia che non vuole essere razionalizzato. Non deve. E che rapisce.
Toccante, Memorie e violenze di Sant’Isabella. Ma anche lucido, necessario. In un momento
in cui revisionismo e scarsa memoria storica sono la regola. A tal proposito scrive Gianmarco
Mercati, voce e testi del gruppo: “Per tutto questo e in nome della scandalosa forza rivoluzionaria
del passato, alzate i vostri canti ora. Perché dobbiamo trovare la forza di imparare tutto. Di nuovo”.
(7.4/10)
Fabrizio Zampighi
linguaggio con l’inserimento di un campione della
voce del Ferretti intento ad analizzare il portato
punk della sua band.
Post-punk(funk?) del terzo millennio che si fonde
con la wave storica del granducato fiorentino? Una
versione 2.0 di Camerini votato al dadaismo e virato al nero tribalismo del Pop Group? I Neon
in fissa con le aritmie del funk bianco e a ruota di
intreccio vocale? Ipotesi più o meno plausibili. I tre
fiorentini d’adozione Federico Fragasso (voce, chitarra, synth), Cristiano Bianchi (basso, voce, synth)
e Simone Vassallo (batteria, voce), le aspettative di
chi ascolta le appagano, nonostante In Etere perda
un po’ dell’impatto iniziale mano a mano che si procede nell’ascolto. Non una bocciatura, quanto piut-
tosto un consiglio: riuscire a concentrare al meglio
le ammirevoli intuizioni distribuite in questo buon
esordio.
(6.7/10)
Stefano Pifferi
Valerio Cosi/Fabio Orsi - Thoughts
Melt In The Air (Preservation,
Giugno 2009)
G enere : drone elettroacustico
Thoughts Melt In The Air è la seconda collaborazione tra Valerio Cosi e Fabio Orsi delle tre
previste per la trilogia pugliese, e sottolinea ancora
una volta, se ce ne fosse bisogno, lo stato di grazia dei protagonisti sia in solitaria che nel percor-
recensioni /
95
so condiviso. Le quattro lunghe composizioni sono
come al solito tracciate lungo coordinate astrali di
matrice krauta e sognante, in modalità free ed elettroacustica, capaci di ridisegnare e risemantizzare le
esperienze e il background dei due.
Ciò che più colpisce, però, non è tanto la novità di
queste quattro istantanee in divenire di un suono
quanto mai corposo nella astrattezza del suo sviluppo, quanto notare come la ricerca (etnomusicale
si potrebbe dire a ragione) messa in atto dai due
giovani musicisti viva di un equilibrio invidiabile,
frutto evidente di una comunanza di prospettive e
retroterra e di un sentire condiviso. E se la terra – la
loro terra – sembrava essere termine di riferimento in occasione del primo volume We Could For
Hours, qui (opinione personale e perciò opinabile)
sembrerebbe essere l’aria, il cielo, lo spazio sconfinato al di sopra di quelle loro terre d’origine ad essere omaggiato. Nella dilatazione libera e fluttuante
del suono; nel pulsare vasto e destrutturato delle
ritmiche; nello struggente potere evocativo dei drones a grana grossa, granulosa e materica (come certe terre di Puglia), veri e propri respiri di un afflato
atavico.
Mancherebbe ancora un elemento di quelle terre
da omaggiare, il mare. Ma dopotutto resta ancora
un volume per completare la trilogia, no?
(7.5/10)
Stefano Pifferi
Warlocks (The) - The Mirror
Explodes (Tee Pee, Maggio 2009)
G enere : P sichedelia S ixties
Il gruppo di Los Angeles torna a due anni di distanza
dal precedente Heay Deavy Skull Lover con un
disco che prosegue sulla stessa linea di dilatazione
lisergica dei pezzi: le lunghe cavalcate psichedeliche
le hanno sempre fatte (una addirittura apriva l’esordio del 2001 di Rise and Fall), ma negli ultimi due
album hanno preso il sopravvento al punto di farli
sembrare due lunghissime jam più che raccolte di
canzoni autonome.
La band perciò, da sempre passatista come poche altre, abbandona i momenti che ricordavano i VU più
r’n’r per approdare ad un suono allo stesso tempo
pesante ed etereo, un po’ come dei Loop che aggiungessero al cantato un po’ di ansia-Clinic (un’altra maniera di fare revival 80s, se vogliamo), sotto la
guida del cantante Bobby Hecksher, unico superstite dai tempi degli esordi, a garantire continuità tra
cambi di formazione e gli spostamenti stilistici già
96
/ recensioni
detti. Non lo fanno neanche male, grazie anche alla
produzione centrata, è per un’estate of love rilassata
il disco va benissimo; basta non scambiarlo neanche
per un momento per un disco del 2009.
(6/10)
Giulio Pasquali
Wilco - Wilco (The Album)
(Nonesuch, Giugno 2009)
G enere : folk rock
Tweedy e soci tornano con un album omonimo, il
loro settimo titolo (tolti lavori in condominio con
Billy Bragg), al cui ascolto ti attraversa il sospetto
che si siano ficcati in una specie di gabbia dorata.
Smaltita la verve no-depressionista iniziale, le madreperlacee derive pop e l’ansia sperimentale, assieme al predecessore Sky Blue Sky (Nonesuch,
maggio 2007) siamo difatti al secondo lavoro consecutivo che potremmo tranquillamente definire
folk-rock, nel senso tradizionale del termine e pur
covando residui tremori avant-pop.
Tuttavia, giusto di un sospetto si tratta. Poi passa.
Perché è un disco che
ha senso e sostanza, che
non teme il presente.
Registrato nei Roundhead studios di Neil Finn
ad Auckland, Nuova Zelanda, annovera fantasmi
elettrici nati tra la cenere delle bandiere (la stordente Bull Black Nova), ballate dolcemente indolenzite (la stupenda One Wing, la delicata semplicità di
You And I cantata assieme all’amabile Feist, quella
Everlasting Everything concepita per strapparti - as
usual - il cuore dal petto), certa sbrigliatezza agile e
irrequieta à la Being There (in I’ll Fight, nella baldanzosa title track), retaggi power pop impolverati
come vecchie scarpe battagliere (You Never Know,
Sonny Feeling).
Titoli, quelli appena citati, capaci di non sfigurare
rispetto a - e in certi casi anche di insidiare - gli
antichi cavalli di battaglia, frutto di un’ispirazione
ancora nel pieno della fioritura, impegnata a rifinire
quanto già edificato, irrobustendone e sfaccettandone la magia (vedi con quale disinvoltura ordiscono preziosismi sixties nell’impasto di clavicembalo,
archi, slide, organo, campanellini e chissà cos’altro
in Deeper Down). Con tutto ciò, forse il loro miglior
pregio è la marcatura implacabile di ogni consuetudine con un vezzo inquieto, un’intuizione obliqua,
Wolf Eyes - Always Wrong
(Hospital Productions, Giugno
2009)
G enere : noise
Preparate le orecchie, sono tornati i tre dagli occhi
di lupo. In verità non se ne sono mai andati, anzi,
hanno continuato in tranquillità a sfornare vinili, nastri e cd-r in quantità industriale insozzando l’etere
di violenza e cacofonica brutalità.
L’effetto sorpresa, dopo lo sdoganamento subpoppiano, è ormai svanito e non resta che la solita, acida e imbastardita profusione di suoni disturbanti e
fastidiosi distribuiti in 7 pezzi per mezzora di claustrofobia noise a doppia anima. Incompromissoria e
brutale nei momenti più selvaggiamente white noise
(Broken Order, la title track) in cui clangori reminiscenti i TG e la grey area più rumorosa sono letteralmente lasciati a imputridire in una fogna a cielo
aperto di brutture sonore. Altrettanto radicale ma
spostata verso una sorta di ritualistica ambient devastata e caustica in momenti come Living Stone, We
All Hate You, Pretending Alive (ipotesi di convergenza
tra free-jazz e noise puro memore della collaborazione con Braxton) o i 6 macilenti minuti droning
post-industriale della conclusiva Droll Cut The Dog,
incubo horror da day after in cui forse l’essenza disturbante di Wolf Eyes trova la sua più completa
sublimazione.
Always Wrong non è un capolavoro e solo accostare il termine a Wolf Eyes fa sorridere. Se però ci
si chiede dove andrà a parare il noise a stelle&strisce
di questi anni 00, non ci si potrà esimere dal fare i
conti con l’affascinante etica/estetica del trio del Michigan, capace di far convivere estremismo nichilista
e carne allo sbando, asperità del quotidiano vivere
post-industriale e paranoia sub-umana.
Years - Self Titled (Arts & Crafts,
Maggio 2009)
G enere : F olktronica
Il termine con cui viene da definire The Years è di
quelli che un paio di anni fa avrebbe fatto preoccupare, data la sbornia allora ancora in corso: folktronica. Nell’album d’esordio, omonimo alla band, ci
sono infatti dei suoni che richiamano all’orecchio gli
ultimi Books (Binary Blues); eppure non ne daremmo una connotazione derivativa, e non solo perché
questa sorpresa chiamata Years sembra, insieme a
Bibio, sempre in questi giorni, aver compreso al meglio la lezione della meraviglia in salsa cut e glitch.
Per l’appunto qui c’è dell’altro, e quest’altro è meno
definibile e quindi più interessante.
Innanzitutto c’è la chitarra, protagonista indiscussa,
che, al di là della frammentazione a cui viene sottoposta dal trattamento tronico, si ritaglia spazi di fingerpicking direttamente riconducibili a John Fahey
(Don’t Let The Blind Go Deaf,The Assassination Of Dow
Jones); o forse, meglio, a quei Gastr Del Sol che di
Fahey fecero rinascere la mitologia, ultimando i
due dischi finali della loro produzione con espliciti omaggi al maestro. Ci stiamo allontanando dalla
folktronica ma anche avvicinando alla poliedricità
dell’album in questione. In effetti non si sentono
davvero i Gastr, ma si avverte un approccio forse
non troppo lontano da loro (September 5. October
21. 2007). Merito forse del fatto che dietro al moniker Years c’è Ohad Benchetrit, del giro Broken
Social Scene, ma principalmente ex post-rocker
coi Do May Say Think.
Lo spirito canadese d’altra parte è onnipresente,
e si manifesta – con varianti che sanno anche di
Nord-Europa – negli arrangiamenti per archi come
nell’enfasi dei brani, sempre a un passo dall’eccesso di emotività, ma mirabilmente misurati (a partire dalla prima traccia, Kids Toy Love Affair). Basta un
attimo e l’inizio pastorale di Hey Cancer... Fuck You!
esplode in una percussività quasi rumorista. Basterebbe un attimo e tutto ciò sarebbe troppo. Ma, a
conclusione di tutto, se di folktronica abbiamo parlato, è perché tra tutti i modi operandi usati da The
Years, tale genere è quello più cristallizzato in un
codice, e quindi riconoscibile. Convince il fatto che
rimanga una cornice dove dipingere – si era parlato
di action painting per i Books, ricordate? – le montagne di Cézanne tra le lande attorno a Toronto.
(7/10)
(7.2/10)
uno scarto straniante. Metteteci anche quel delirio
di copertina, con le sue (parecchio) dissimulate allusioni (pare) alla situazione mediorientale... Il punto
è: farne comunque una questione contemporanea.
Viva di vita che s’incarica della meravigliosa rogna
di vivere.
Sia come sia, trattasi di un altro bel disco per la
band di Chicago. La maturità è una trappola, ma i
Wilco sembrano aver intrappolato la maturità.
(7.2/10)
Stefano Solventi
Stefano Pifferi
Gaspare Caliri
recensioni /
97
Akron / Family
C lub : H ana B i , R avenna (1 giugno )
Gli Akron/Family non sono materia da lettore cd.
Tanto meno da iPod. Sono, invece, entità da palco:
solide, coinvolgenti, stratificate. Un suono ricco che
trova la propria ragion d’essere nell’estemporaneità
dell’umore, nell’inesattezza del momento, nel feeling
dell’improvvisazione, oltre che nella caratura tecnica. Fuori da ogni facile catalogazione. Anche se l’immaginario che questi freaks richiamano è sempre
quello: America anni sessanta o giù di lì, con tutto il
suo carico di folk, soul, blues, psichedelia, artigianato
etnico. Un salto a piè pari in un’epoca irripetibile
sulle ali di un tribalismo urbano contemporaneo.
Con il batterista/santone che picchia come un ossesso, il cantante/hippie che pare una replica indie di
Björn Borg ai tempi d’oro e il bassista/Carl Wilson
che comanda la sezione ritmica. All’appello manca il
quarto, quel Ryan Vanderhoof fuoriuscito dalla
formazione qualche tempo fa, ma il suono rimane
comunque corale, potente, ramificato. Come potente si dimostra il sentimento di identificazione di chi
ascolta. Un meccanismo perverso che a fine concerto spinge i più coraggiosi ad accaparrarsi, oltre
ai dischi e alle magliette di rigore, anche una replica
della fascia di spugna per capelli indossata da Seth
Olinsky. Semplicemente inguardabile.
All’ Are you Experienced? della band, comunque, rispondiamo senza remore, in un concerto che risveglia la Woodstock messa in soffitta. I Nostri giocano
con la voglia di interagire del pubblico, vendono una
98
/ recensioni
concezione di musica prima della musica stessa, fissano le regole della comunicazione in funzione del
feedback. Sommando livelli a livelli come neanche
Photoshop e inventandosi una cacofonia stordente
ma meravigliosamente viva fatta di chitarre elettriche, batteria, basso, tamburi, effetti vintage, flauto,
synth, armonica, maracas. Finisce per comporsi così
quel complesso mosaico di richiami che è il suono
del gruppo americano. In maniera naturale. Senza
forzature.
Gente seria, gli Akron/Family. Di altro genere rispetto a The Pains Of Being Pure At Heart o Vivian
Girls visti il giorno prima sempre all’Hana-Bi. Questi ultimi bravi a intrattenere, immediatamente riconoscibili, ma tutto sommato negli standards di un
rock impacchettato e pronto all’uso. Dana Jansenn, Seth Olinsky e Miles Seaton suonano
invece senza rete di sicurezza, giocano a memoria.
Divertono, insomma, tra brani dalla potenza lirica
sconsiderata – citerei a onor di cronaca una Ed Is A
Portal da brividi - e intermezzi strumentali feedback/
rumorismi talvolta perfino eccessivi. Con gli applausi rimandati all’unico momento di pausa del set. La
fine.
Fabrizio Zampighi
PRIMAVERA SOUND
C lub : P arc del F orum , B arcellona (28-30
maggio )
PS2009 suona tanto come play station e invece è
Primavera Sound, il festival indie, ora possiamo dirlo,
©ScannerFM
live report
Primavera sound
più famoso e popoloso d’Europa. Tre giorni, cento
concerti e colpo d’occhio di una massa di gente in
ogni palco. Secondo forse a quello americano dove
solo i più danarosi e convinti possono accedere. Primo sicuramente per il mix tra indie e vecchie glorie
che ce l’ha fatto piacere da subito e primo pure
per capacità di cogliere le innovazioni tecnologiche
e funzionali al business.
PS è la sala giochi della musica anzi il luna park di
un certo tipo di musica che o è storicizzata e quindi
costa cara oppure ha un cachet medio basso. Due o
tre miti e mettere d’accordo, due o tre generazioni
e un’ottantina di altre realtà a contorno, il tutto con
il beneplacito di tutti, giovani e vecchi. Un prodotto
vincente di quelli che una volta avrebbero scatenato
scontri verbali e ideologici. Ma anche un prodotto
più autenticamente 2.0. Più complicato da additare
che non per le politiche più terra terra del costo
della birra - o della prenotazione per entrare all’auditori che costa un eurino in più (totale 2). I fatti
parlano da sé: il PS ha superato concettualmente il
format classico del festival che da sempre ti propina quattro cinque bolliti di dieci anni prima (prendi
Oasis, Metallica, Tool, Blur) come la cosa hype da
far fare alla cosiddetta massa, con una realtà che ha
il coraggio di metterti Deerhunter, Oneida e
mettiamoci pure i Bloc Party prime time assieme
all’indubbio gusto di proporti tutta la teppaglia post
punk in reunion mirate che di anno in anno hanno mosso centinaia di addetti ai lavori. Quest’anno
il ciclo si è compiuto con gli A Certain Ratio,
poca roba, ma gli storici nomi anche quest’anno
sono stati intoccabili: Neil Young e Michael
Nyman per la serie sempre più dinosaur. Prima di
loro c’erano stati Lou Reed, Iggy Pop e Patty Smith.
Roba di lusso che non puoi dire quello che diresti
se ti chiamassero gli Stones o peggio gli U2. Infine ricordiamoceli per un attimo i festival nostrani
e l’italietta che siamo quando la vediamo da lì. Da
Barcellona. Il contenitore più grande del già grande
PS. La città dei balocchi come la Bologna di qualche
anno fa al cubo.
Rigira il festival come vuoi e vince, perché centra i
propri risultati. Salvo la fu proverbiale resa acustica
degli impianti, quest’anno meno attenta (o addirittura scadente nel caso del palco Pitchfork). Salvo,
e tutti lo sappiamo, perderci di anno in anno sotto l’aspetto logistico e di sovrapposizioni di palco.
Il risultato quest’anno sono state intere mezz’ore
senza sapere cosa fare, tra un concerto e l’altro di
recensioni /
99
pensato bene di spremere fino alla fine il revival dei
mitici occhiali di plastica. Tra gli ottantamila presenti
almeno 2 o 3 mila li hanno già da giovedì, ma vuoi
vedere che ci sono almeno altrettanti consumatori? Invogliarli significa allestire dei concerti acustici
nello stand espositivo e regalare gli stessi occhiali
alle band che suonano. Magari farglieli pure mettere
dietro compenso. Gli Horrors canteranno pure
come nell’Ottantatre ma tante storie non le fanno,
ci fumano su. In Spagna il monopolio tabacchi può
pubblicizzare il proprio brand. è accattivante: giallo
con scritta blu che sono anche i colori di un’area
relax perfettamente situata all’incrocio tra i vari stage.
Dentro un container di quelli da nave ci sono altre belle macchinette. Ti ci puoi comprare le tue
sigarette preferite. Bevi + fuma. Chi ascolta questa
musica è vestito di queste cose capito?
Ci domandiamo se l’unica vera ribellione al confort
e alla droga legale; a tutto il sedativo che non toglie
la capacità di sentire il consiglio per l’acquisto; ai
tappi per le orecchie forniti all’ingresso tarati 20 db;
©ScannerFM
un minimo interesse. Oppure, peggio, un Ariel Pink
con band e stravaganza quasi lo-glam alle cinque e
mezza di pomeriggio. Con dopo due ore di buco.
Del resto, la complessità dello scegliere e scremare,
lo scarabocchiare i flyer con linee e numeri, scalette,
il fantasticare sulle asimmetrie e anomalie di suoni
sono invero sempre il suo autentico bello e quindi
anche il difetto è in verità un grande pregio.
Chi sa cosa vuole in ogni caso ha degli spettacoli garantiti e sempre a sua scelta può razionalizzare l’acquisto delle vivande per la sopravvivenza.
Quest’anno – sempre per trentenni ex disoccupati e teenager danarosi – c’era una machine touch
screen tipo i-Phone dove prenotare per gli spettacoli dell’auditorium e comprare un ampio range di
bevande. Potevi pagare con la carta e contanti senza
perderci un euro con un resto garantito al cent; e se
ti scocciava fare la fila c’era l’omino sandwich. Con
loro l’Estrella o il redivivo Jack D’n’Coke formato
lattina non sono mai mancati. E a soli un euro di più.
Dimenticavamo il look. Quest’anno tra una quantità sorprendente di under 18 e nerd, la Rayban ha
deerhunter @ primavera
100
/ recensioni
©ScannerFM
sonic youth @ Primavera
non sia il dannosissimo – sia per gli occhi che per le
orecchie – spettacolo dei My Bloody Valentine. Due gli show per loro, uno fuori e uno – paura
– dentro l’auditorium delle meraviglie. Che quando il reattore parte la turbina si sente anche fuori
dall’acusticamente isolatissima sala. Shields, come lo
scorso anno Mr Dinosaur Jr, è quel classico nerd
con l’orecchio inevitabilmente leso. Alzare i volume
è un’esigenza e non una libidine. Quando non senti più, la musica è solo vibrazione. Uno sballo che,
come una malattia, ti impedisce di pensare ma è anche l’unica cosa non-mediata che respiri quaddentro. Lo capisci solo a certi livelli - quando il denaro in
gioco è capitale - quanto l’udito non sia scambiabile.
Quando lo sarà avranno ragione i Portishead che
lo scorso anno avevano un’immagine di Essi Vivono
come logo del loro My Space.
Ma ora questa musica celestiale e idilliaca che ti
fa un male cane per volumi e immani feedback è il
migliore paradosso/spiegazione del frame in cui ti
hanno cacciato e dal quale non puoi più sfuggire. Alzare il volume talmente tanto da far sparire Tabaco,
Estrella, Jack D, Rayban e tutte e mode e tutti i vizi è
come ricreare il contatto diretto tra te e la musica.
Senza mediazioni. Privarti dei sensi per accedere a
una nuova vita. Ascetismo spiritual-shoegaze contro chi oramai non capisce più e ti mette i Liars
all’ATP perché sono sperimentali. A chi ti chiama i
Mahjongg un anno dopo perché tutti hanno detto
(dissero) che sono un prodotto promettente. Kevin
Shields icona contro tutti gli Wavvves consumisti
wow illegali ma tanto non lo capite che – a certi
livelli - è uguale. Fatti della musica. Fatti dell’introno
di musica. Siete disposti a farvi saltare le orecchie
per ascoltare musica? Se avessimo il video faremmo
apparire la sigla di Lost.
Edoardo Bridda
Zu
C lub : H ana B i , R avenna (9 giugno )
Bassa Romagna poco generosa con chi non si riconosce nel tradizionale divertimento asfittico e massificato della riviera? All’ Hana-bi rispondono con
un tutto esaurito per il concerto degli Zu. Un happening inaspettato quanto esaltante. Perché mostra
il dito a chi da queste parti ha sempre considerato il
rock roba da “sfigatelli”. E perché ci fa credere, almeno per una sera, di vivere in un paese culturalmente
recensioni /
101
ricettivo. Dai sedici ai trent’anni passati il target di
riferimento del live. Come dire, il campione perfetto per una ricerca sociologica sul cambiamento dei
gusti giovanili. Nello specifico, fuori dalle discoteche
e dentro all’indie-rock nostrano più illustre: quello
della band di Luca Mai, Massimo Pupillo e Jacopo Battaglia in tour con l’ultimo – splendido
– Carboniferous.Viene naturale, allora, chiedersi i
motivi alla base di una tale risposta di pubblico per
un concerto “di nicchia” in una serata infrasettimanale. Ne troviamo tre. Il gesto tecnico: vedere gli Zu
dal vivo è sempre uno spettacolo di prim’ordine, con
un batterista perso in una ragnatela di piatti e rullanti dispari, un sassofonista perennemente a rischio
embolia, un bassista che scava fraseggi impossibili su
automatismi cerebrali. La musica: ricercata, tellurica, sperimentale, riconoscibile, adatta a palati free/
progressive/jazz-core come a nostalgici del metallo.
La coolness che la band si porta appresso: contratto
discografico con l’Ipecac, collaborazioni con Mike
Patton e King Buzzo, buone vendite oltreoceano, recensioni positive pressoché unanimi. In più,
la riscoperta di certe cadenze. Crossover di nuova
generazione, molto spesso strumentale, fissato coi
suoni energici e i tecnicismi esasperati. Roba in cui
si cimentano anche, con le dovute differenze di stile,
gli stessi Zeus! - basso e batteria schizofrenici con
velleità hardcore – chiamati ad aprire il set.
Appuntamento importante, insomma, e attesa spasmodica tra il pubblico. Tanto che quando la band
romana si presenta sul palco scatta quasi un’ovazione. Applausi che i tre si meriteranno ampiamente
con un’esibizione impeccabile e sudatissima, tutta
impostata, come d’abitudine, sul pattern ritmico.
Quest’ultimo suddiviso, ripetuto, accelerato, portato alle estreme conseguenze da scambi paranoici,
grazie a un’attitudine progressiva che è free-jazz
post industriale, math, metal e a musicisti bravi nel
trasfigurare il suono degli strumenti in un magma
triangolare e tiratissimo. Il pubblico, quasi intimidito
da una tale potenza di fuoco, ritroverà la parola soltanto in chiusura. In tempo utile per “assaltare” un
povero Giulio Ragno Favero de Il teatro degli
orrori temporaneamente “retrocesso” da uomomixer a commesso del banchetto cd.
Fabrizio Zampighi
Hjaltalín
C lub : T eatro D al V erme , M il ano (30 maggio )
Ci troviamo stasera al Dal Verme principalmente
per ascoltare gli islandesi Hjaltalín, ci perdonino gli
102
/ recensioni
altri partecipanti alla seconda serata della rassegna
di fine maggio milanese Liveacross (29/30). Che
si apre con uno dei momenti migliori della serata,
la sonorizzazione, da parte dei Giardini di Mirò,
del film muto Il fuoco (di Giovanni Pastrone, 1916),
appena restaurato dal Museo Nazionale del Cinema.
Post rock e shoegaze dosati con maestria e grande
effetto creano una atmosfera palpabile. Neil Halstead (Slowdive e Mojave 3) appare invece a
tratti soporifero e un tantino prolisso. Ma prima di
lui ci pensano a scaldare l’atmosfera gli islandesi.
Detto che il pubblico non era numeroso ed era
piuttosto tipico delle rassegne festivaliere cinematografico-musicali, gli Hjaltalín hanno goduto, per
tutto il tempo dell’esibizione - un’ora scarsa - del
sostegno da parte di un rumoroso seguito - piccolo ma compatto - di loro connazionali, magari in
trasferta concerto, chissà. Che hanno fatto il tifo,
applaudito, cantato e urlato, riscaldando l’atmosfera
non troppo rovente a dire la verità.
La formazione, che abbiamo conosciuto nei mesi
scorsi con il bell’esordio Sleepdrunk Seasons,
(prodotto da Benni Hemm Hemm con Gunnar Tynes dei Múm) propone prima timidamente poi con
più convinzione il proprio chamber pop impetuoso e lirico, molto vicino ai primi Arcade Fire, ma
non eccessivamente barocco,compreso di fagotto e
violino, ricco di cambi, variazioni in tempi e mood
e stratificazioni assortite. Si aggiunga a tutto questo una naturale facilità alla melodia e una più che
buona alchimia di gruppo. Il leader Hogni Egilsson (voce e chitarra), un mix vocalmente tra Jónsi
dei Sigur Ros, Antony e Jens Lekman è doppiato al
canto dal lato femminile di Sigga (Sigríður Thorlacius), da cui ci si aspettava magari una maggiore
presenza scenica a fargli da contraltare e non una
figura piuttosto intimidita e in disparte. Comunque il loro tratto distintivo armonico evidente su disco
c’è tutto e questo basta.
Viene suonato quasi tutto l’album, alternando
estratti cantati sia in inglese che in islandese, mini
suite orchestrali, pop song e tutto l’armamentario
che abbiamo imparato a conoscere, un misto di
Bacharach o Hazelwood, musica colta e folk
inglese dei Settanta, Sufjan Stevens e Belle &
Sebastian, tutto con piglio molto easy e con discrezione.
La sostanza c’è, a livello di esibizione live servirebbe
una maggiore coesione e presenza scenica di gruppo, insieme a un po’ più di sicurezza nelle loro capacità e a una consapevolezza che ancora non hanno
del tutto acquisito. Ma si faranno, da questo punto
di vista, c’è da scommetterci.
Teresa Greco
Sunn O)))
C lub : L okomotiv , B ologna (1 giugno )
Torna in Italia il duo che a suo modo ha segnato
un’epoca – la nostra – in fatto di musica “estrema” e lo fa per celebrare i dieci anni dell’uscita di
The Grimm Robe Demos, il primo parto musicale fuoriuscito dalle chitarre di O’Malley e Anderson. È chiaro che tutto ciò è solo un pretesto per
scaricare sul pubblico – numerosissimo – 1 ora e
venti di drones a basse frequenze senza soluzione
di continuità.L’atmosfera è da lande norvergesi ma
il clima è da inferno dantesto. Le reazioni in questo caso sono svariate: chi grida alla pura epifania
sonora, chi si annoia – perché poi alla fin fine di
variazioni manco a parlarne - , chi si bulla con l’amico per averlo portato a vedere un concerto che
difficilmente rivedrà presto. Tutti atteggiamenti per
altro condivisibili.
Poi a mente fredda emerge un pensiero: tolto il
fumo, tolti i vestiti di scena, tolte le pose tenebrose
e tutto il paratesto che rimanda al metal estremo,
siamo sicuri che definiremmo questa “roba”, metal?
Avreste dato del metallaro a Dylan Carlson che
sotto il moniker Earth nei primi anni ’90 trafficava
con drones e feedback in mezzo alla bolgia grunge
– quella si popolata di metallari - ? In ogni caso le
tutte raffinatezze e paraculaggini – dal risultato divino, s’intende…. – dell’ultimo Monoliths rimangono
a casa, questa sera, segnale che il percorso/strada
del gruppo americano avanza ma, in direzioni multiformi e diversificate.
Nicolas Campagnari
sunn O)))
recensioni /
103
WE ARE DEMO
#38
I migliori demo giunti nelle nostre cassette postali. Assaggiati, soppesati, vagliati, giudicati
dai vostri devoluti redattori di S&A.Testo: Stefano Solventi, Fabrizio Zampighi.
Alba di Morrigan (L’) - Circle
(Autoprodotto, Febbraio 2009)
G enere : post prog
Stanno quasi per concludersi questi stranissimi anni
zero, che chissà quanto ci metteremo a capire cosa
resterà e non resterà, e capita d’imbattersi in dischi
come The Circle che sembrano piovere da un’increspatura spazio-tempo rimasta inceppata sul finire
dello scorso millennio. Ne sono autori tre ragazzi
di Torino assieme dal 2004 che nel 2008 decidono
di chiamarsi L’Alba di Morrigan, optando per una
formula sonora che si culla di palpiti, tremori e irrequietezze folk e post-rock strattonate metal e mesmerizzate prog.
Ecco quindi apprensioni Metallica foderate di retaggi Genesis, turgori crimsoniani tra ossessioni
desertiche e puntigliose inquietudini 90 Day Men.
Non è un gioco credibile, scorgi una data di scadenza parecchio stagionata dietro quei riff e nel caracollare delle melodie, però c’è coerenza e convinzione, non è escluso che progredisca verso qualcosa
di altro e interessante. (6.2/10)
Stefano Solventi
Allison Flower - Naked To Nothing
(Autoprodotto, Luglio 2009)
G enere : hard
Spingono sull’acceleratore, gli Allison Flower, mescolando metal, basi dispari, ballate elettriche e
grunge/crossover. Il genere musicale imporrebbe da
parte del recensore una severità esemplare, visto e
considerato le banalità che si ascoltano talvolta in
questi frangenti, ma non possiamo non ammettere
come le otto stazioni in scaletta meritino ben più
di una frequentazione distratta. In virtù di soluzioni
tecniche capaci di rinnovare un contesto musicale
ormai ampiamente saccheggiato, pur senza stravolgerlo. (6.7/10)
Fabrizio Zampighi
104
/ recensioni
Black Box Nation - Promo 2009
(Autoprodotto, Maggio 2009)
G enere : wave rock
Quintetto nato a Roma nel 2005 dalle ceneri dei
Davincisdrama, i Black Box Nation fanno una wave
piuttosto tesa, incentrata ora su allarme drammaturgico di stampo Stranglers e impeto algido da
New Order anfetaminici (Here It Comes, The Great
Addiction), ora sulla stordente inquietudine colta al
crocicchio tra Interpol e OMD (la tiratissima Just
Crash), altrove sul trasporto emo che chiama in causa i primi Radiohead e gli Elbow (Saturday Night
Is Wrong), mentre più vicina alle ultime palpitazioni
di Yorke e compagni suona la conclusiva Futurista.
Mi piacciono perché ci aggiungono quel pizzico di
melodramma vagamente Benvegnù (ascoltatevi
Hell’s Crying) che rende l’impasto turgido, obbligandoti sul chi vive. Restiamo sintonizzati. (6.8/10)
Stefano Solventi
Crabway - Five Songs, Two Kids
(Autoprodotto, Gennaio 2009)
G enere : wave pop
Vecchia conoscenza, i Crabway, quintetto allestito
ormai quasi tre lustri fa sulla scorta di una fregola
wave pop di stampo eighties disposto ad accogliere evoluzioni prog senza con ciò mai venire meno
all’imperativo categorico dell’affabilità. Accade
anche in questo nuovo EP: per quanto le cose si
complichino sanno essere atmosferiche, avvolgenti
come potrebbe un ibrido tra gli ultimi Yes e certi
Ultravox (Calling), strattonate da tentazioni arty
che conducono in territori funk-jazz stranamente
esotici (New Foundation), oppure più quietamente
impegnate con fogge folk-rock che stiepidiscono i
Fairport tra emulsioni di synth e chitarra trepida
(la notevole Two Kids).
Sono meno efficaci quando mollano le briglie cercando scioltezza Steely Dan e garrule angolosità
Nadiè - Questo giorno il prossimo anno
(Autoprodotto, Aprile 2009)
G enere : indie rock
Trio da Misterbianco attivo lungo tutti i novanta e si sente, vista la
fibra da indie rockers con i ranghi stretti attorno al piglio psichedelico
che affiora costantemente, però portati a ciondolare dalle parti di un
cantautorato (in italiano) che procede per allusioni, per intimi sussulti,
rovelli e trasalimenti ora rabbiosi, ora poetici, ora vagamente sciroccati e pure scomodi, insomma ben lontani dalle consuete retoriche e
dalla posticcia emotività post-radioheddiana (à la Negramaro per
intenderci). In questo senso tanto la voce chioccia di Giovanni quanto la strutturata efficacia degli
arrangiamenti (al bisogno si ricorre ad archi, mandolini, clarinetti, pianoforte, e-bow...) fanno buon
gioco, definendo una tesa profondità che non perde tempo a specchiarsi.
Mi piace collocarli da qualche parte tra Afterhours (si senta Glicine) e Perturbazione (Laurea
in lettere e filosofia, Franti), così come mi piace che giochino a fare i nipotini di Simon & Garfunkel con la fregola cameristica ma non l’irriverenza d’un Morgan (Roman Polanski). Trovo altresì
stuzzicanti i retaggi Celentano (Il valzer del non amore) e Tenco (stemperato in un accorato
romanticismo Black Heart Procession nella stupenda title track). Insomma, è un bel disco di
una band capace e matura. Attualmente, incredibilmente, senza contratto. (7.2/10)
Stefano Solventi
Kajagoogoo, ma se non altro non sembrano mai
smettere di crederci. (6.2/10)
Stefano Solventi
Delsaceleste - Io come...la voce
delle stagioni (Autoprodotto,
Luglio 2009)
G enere : rock
L’attitudine potremmo ricondurla a un rock progressivo estremamente melodico, tra batterie in divenire e tastiere, chitarre elettriche e archi. Con in
più il ricorso a certe sonorità etniche dal gusto quasi mediorientale. Il pregio maggiore di questo one
man project di Marco del Santo è la semplicità
di espressione, una scrittura che pur frequentando
sonorità lontane da tutto ciò che è essenzialità e
rigore, è capace di mantenersi coerente e in qualche maniera razionale. Senza, nel frattempo, sentire
il bisogno di voler farsi passare per quello che non è.
Ovvero qualcosa di imprescindibile. (6.3/10)
Fabrizio Zampighi
Il Garage Ermetico - Pinpilinpauxa
(Autoprodotto, Luglio 2009)
G enere : rock
Copertina collage che nasconde un duo scoordinato ma affascinante. Coerente, quest’ultima, con la
musica che Il garage ermetico propone, visto che in
Pinpilinpauxa si parla di certi Sparklehorse
slabbrati anni novanta (Via Madre di Dio e dintorni)
come di folk acustico chitarra e fisarmonica (Ades
Dorma), di post-rock ingabbiato in forme canzoni
riconoscibili (Cacciavite) come di improvvise accelerazioni (Vico della Croce Bianca). Tutto è estremamente lo-fi e in alcuni frangenti un tantino confuso,
ma lo spessore che la formazione lascia intravedere
sembra notevole. Attendiamo sviluppi. (6.8/10)
Fabrizio Zampighi
Michele Nucciotti - Risposte
multiple (Autoprodotto, Luglio
2009)
G enere : rock d ’ autore
Nella media anche questo Risposte multiple di
Michele Nucciotti. Nel senso che nei trentanove minuti del cd si scivola via in maniera abbastanza
agevole tra basi elettroniche e canzone evocativa,
aspirazioni autoriali e arrangiamenti patinati. Da un
lato si pensa a Carboni, dall’altro vengono in mente i Subsonica, anche se del primo manca lo spessore e dei secondi l’irrequietezza ritmica. Per un disco che comunque mantiene fino alla fine un livello
dignitoso di serietà artistica e di inventiva, rivelando
un autore dalle buone potenzialità. (6.2/10)
Fabrizio Zampighi
recensioni /
105
1909-2009. E il Futurismo compie cent’anni. Oltre le celebrazioni, un’ottima occasione
per avvicinare meno superficialmente questi nostri interpreti, che dobbiamo ancora
sforzarci di capire davvero.
«Sogno strumenti che obbediscano al mio pensiero
e che con il loro intero mondo di suoni sorprendenti
possano piegarsi alle esigenze del mio ritmo interiore»
– Edgard Varèse, dall’articolo New Instruments, New
Music, in «391» [rivista diretta da Francis Picabia]
n.5, giugno 1917
«Dovunque ci troviamo, ciò che sentiamo è principalmente rumore. Quando lo ignoriamo, ci disturba.
Quando lo ascoltiamo, lo troviamo affascinante» – John
Cage, da una conversazione del 1937, riportata nel
saggio The Future of Music: Credo, in Silence: Lectures
& Writings by John Cage, Wesleyan University Press,
1973; p. 3
Luigi
Russolo
Il
Frammenti di un
discorso rumoroso
Luigi Russolo e la rivoluzione
musicale futurista
106
/ Rearview Mirror
- Gabriele Marino
futuro rincorso
Prima avanguardia in senso stretto del Novecento, e tutta italiana, a lungo incompresa, volgarizzata,
sottostimata, ghettizzata quando non deliberatamente rimossa. Allo stesso tempo, punto di riferimento fondamentale, spesso occulto, anche solo
come totem da demolire, di tutte le più importanti
esperienze di sperimentazione artistica del Novecento. La portata del Futurismo, a livello ideologico,
estetico, teorico, è difficilmente calcolabile, tantomeno riassumibile in poche parole: basta però leggere alcuni dei sorprendenti manifesti prodotti da
Marinetti e compagni, forse il loro lascito di maggiore originalità e il più importante, per acciuffarne
il senso. Che a ben vedere sta già tutto nel nome
scelto per designare il movimento: “Futurismo”.
Futuro obiettivo unico e vera ossessione, sognato
e rincorso febbrilmente in tutti i campi del fare e
del pensare artistico, con un gusto irresistibile per
la provocazione e l’iconoclastia, tra intuizioni geniali
che precorrono i tempi di decenni e contraddizioni
insanabili: un pensiero realmente visionario, rigoroso e incoerente, utopisticamente olistico, soprattutto, sorprendentemente attuale, pur con tutti i suoi
limiti (e forse proprio in virtù di questi), le sue ingenuità, le sue storture. Eccole comunque le parole
chiave del lascito futurista, ombra lunga che arriva
fino ai nostri giorni: necessità della riflessione teorica nella prassi artistica, esaltazione della libertà
espressiva al di là della tradizione e delle istituzioni, intermedialità e multimedialità, accostamento di
materiali “alti” e “bassi”, concezione dell’arte come
azione, dialettica elastica programmazione-improv-
visazione. Cento anni fa. Cento anni di Futurismo, e
qui, nel nostro piccolo, il nostro piccolo contributo,
su uno degli ambiti in cui il Futurismo, per quanto
frustrato nei risultati, ha espresso forse al meglio le
proprie potenzialità.
Il
contesto : verso l ’A rte dei
rumori
Una serie di tappe nella storia della musica occidentale tra Ottocento e Novecento ci aiutano a
inserire l’esperienza della musica futurista, e in particolare la “scoperta del rumore” da parte di Luigi
Russolo, nel quadro del definitivo superamento
degli stilemi romantici, e più in generale, della diffusa esigenza di sperimentazione e rinnovamento che
apre alla cosiddetta “musica contemporanea”.
Wagner (Tristano e Isotta, 1857) impiega il cromatismo [l’introduzione di semitoni estranei alla
scala diatonica, procedimento che rende meno netta la percezione della “fondamentale”] in maniera
sistematica ed esasperata: è il primo segnale forte
del progressivo superamento della tonalità tradizionale. Debussy (Preludio al pomeriggio di un fauno,
1892) fa un uso personalissimo, si dirà “impressionista”, del timbro e delle strutture armoniche tradizionali, rendendole fluide e nebulose, allentandone
il valore strutturale. Schönberg (Quartetto Op. 10,
1907) porta al parossismo il cromatismo di derivazione wagneriana fino a raggiungere una vera e
propria atonalità (termine cui però preferisce «pantonalità»): è la rottura definitiva con le convenzioni
del sistema tonale, vero punto di non ritorno. Idea
poi (Walzer dei Cinque pezzi per pianoforte, 1923)
un metodo compositivo basato sull’uso delle dodici note della scala cromatica, lo chiamerà appunto
«dodecafonia», inteso come «sistema di organizzazione dell’atonalità»: si realizza definitivamente
l’«emancipazione della dissonanza» come strumento di espressione musicale. Anche Stravinskij (La
sagra della primavera, 1913) propone politonalità e
uso libero della dissonanza, ma soprattutto un’inventiva timbrica e ritmica senza precedenti.
Thaddeus Cahill, americano, inventa nel 1897
il telarmonio (o dinamofono), il primo strumento
elettronico della storia, una grande (36 note per ottava) e pesante (quasi duecento tonnellate) tastiera
alimentata da 145 dinamo a corrente alternata, pen-
Rearview Mirror /
107
Umberto Boccioni, “Serata futurista” (caricatura; 1911)
sata per la diffusione della musica attraverso i cavi
telefonici. Ferruccio Busoni, grandissimo pianista e musicologo, intuisce le potenzialità euristiche
di questo strumento avveniristico e nel suo Appunti
per una nuova estetica della musica (1907), testo influentissimo e che Russolo certamente conosceva, auspica una ricerca musicale orientata proprio
all’esplorazione delle più piccole frazioni di tono,
della microtonalità. Leon Theremin (nome francesizzato di Lev Termen), fisico al servizio dell’esercito russo, inventa nel 1919 il theremin (o eterofono), un apparecchio che attraverso la manipolazione
di un campo elettromagnetico consente di produrre un fischio caratteristico, modulabile in altezza e
intensità.
Carol Bérard, francese naturalizzato americano, compone una Sinfonia di forze meccaniche
(1908-10?) di cui oggi non resta nulla, ma che pare
anticipasse l’estetica rumorista, e in parte esoticoprimitivista, di Russolo attraverso l’uso di rumori
prodotti da motori a scoppio e sirene industriali.
Nel 1929 scriverà sulla rivista «Modern Music» un
articolo dal titolo Recorded Noises: Tomorrow’s Instrumentation, in cui, forse ignorando l’esperienza futurista, auspica un uso del rumore come elemento
musicale strutturale.
108
/ Rearview Mirror
La
musica futurista : prima
dell ’A rte dei rumori
è Francesco Balilla Pratella (1880-1955)
ad essere considerato dagli stessi futuristi l’iniziatore e il massimo esponente del Futurismo musicale:
lo stesso Russolo dichiara di dovere le sue intuizioni alle teorizzazioni di Pratella e all’ascolto delle sue
composizioni. Il suo pensiero musicale è consegnato ai tre manifesti Il manifesto dei musicisti futuristi
(1910), La musica futurista – Manifesto tecnico (1911)
e La distruzione della quadratura (1912), raccolti poi,
assieme ad altri scritti e agli spartiti di alcune sue
composizioni, nel volume Musica Futurista (1912).
Il primo manifesto ha un carattere essenzialmente
“politico”, e contiene un’impietosa analisi della “società musicale” italiana dell’epoca, con tanto di nomi
e cognomi, ancora intrappolata negli schemi stantii
del melodramma. Pratella propone uno studio della musica “liberato”, fuori dalla lobby conservatoricritici-premi-editori, catene al piede della creatività
dei musicisti e del gusto di un pubblico destinato
altrimenti a restare eternamente “passatista”.
Il secondo manifesto, il più importante per quel
che ci riguarda, entra nel vivo della questione musicale. Pratella vi espone i punti chiave della sua
“rivoluzione”: enarmonia (il suo modo di chiamare
l’esplorazione della microtonalità), uso libero e sistematico della dissonanza, polifonia (intesa come
fusione di armonia e contrappunto), concezione
armonica della melodia, poliritmo (il suo modo di
chiamare un uso libero e irregolare del ritmo). Fonte di ispirazione per il compositore dovranno essere non più la tradizione ma, secondo una sorta di
panteismo sonoro, la natura e il mondo meccanico
creato dall’uomo: la natura umanizzata-meccanizzata. Entra così in scena la contemporaneità industriale tanta cara all’immaginario futurista, ancora ad un
livello soltanto tematico, coi suoi emblemi: la città,
la macchina (la locomotiva, l’aereo, la nave), la guerra. Le sue maggiori opere futuriste, oltre al manifesto programmatico Inno alla vita – Musica futurista
(1913), saranno infatti ispirate alla guerra (l’omonimo trittico per pianoforte, sempre del ‘13) e alla
guerra “vista dall’aeroplano” (l’opera lirica L’Aviatore
Dro, composta a partire dal ’13 e rappresentata per
la prima volta nel 1920; lo spartito prevedeva l’impiego degli intonarumori di Russolo, ma negli allestimenti scenici questi verranno sempre sostituiti da
semplici motori a scoppio e sirene).
Il terzo manifesto di Pratella approfondisce esclusivamente le questioni del ritmo e dell’accentazione, mirando alla distruzione della quadratura, e cioè
del ritmo “quadrato”, regolare, tipico della musica
istituzionale e della musica da ballo.
Pratella è una figura interessante perché intimamente contraddittoria. Allievo di Pietro Mascagni e perfettamente inserito nel sistema della
musica ufficiale-accademica, durante tutta la vita
mostrerà un forte interesse per la musica tradizionale e popolare (si veda già l’opera dialettale, in
romagnolo, La Sina’d Vargöun, 1909), tanto da collaborare con D’Annunzio alla compilazione della
Raccolta Nazionale di Musica Italiana (incompiuta per
la morte dello scrittore nel 1938). I suoi manifesti si
presentano come provocatori e iconoclasti (e forse
lo furono davvero, se rapportati al provincialissimo
contesto italiano), ma a ben vedere si limitano a
tradurre in parole quanto già messo in musica da
alcuni grandi compositori dell’epoca, da Wagner in
poi. Soprattutto, non si può non registrare un profondo iato tra il suo slancio teorico e la sua produzione come compositore, unanimemente giudicata
un contributo marginale nella storia della musica (la
critica si è accanita soprattutto sul suo Aviatore). Pur
presentando tracce di atonalità e un’interessante vivacità ritmica (si vedano i già citati pezzi per piano
La Guerra), la sua è una musica ancora sostanzialmente legata al linguaggio tradizionale. Soprattutto,
eccessivamente debitrice delle sue fonti di ispirazione, affetta com’è da un colorismo effettistico che le
deriva dal maestro Mascagni e dalle prime musiche
da cinematografo, e da tentativi di imitazione dei
modi delle avanguardie musicali dell’epoca, su tutti Debussy (proprio in La Guerra, Pratella rielabora
un brano tradizionale già rivisitato proprio dal maestro francese). Lo stesso Marinetti, come a sancire
inconsapevolmente questa distanza incolmabile tra
impeto ideologico e realizzazioni concrete, lo definirà «il solo futurista che unisce genio e serenità».
Struttura interna di un intonarumore
Rearview Mirror /
109
Spartito enarmonico delle prime 7 battute di “Risveglio di una città” (1914)
L’A rte
dei rumori
Un musica veramente futurista, la grande rivoluzione musicale (con Pratella, sostanzialmente una
bomba inesplosa), si dà solo con Luigi Russolo
(1885-1947). Una figura inquieta, di instancabile ricercatore e sperimentatore. La musica di Russolo è
futurista non solo nei temi, come già parzialmente
in Pratella, ma nella sua sostanza formale, nei suoni, nella sua carne: con Russolo, mcluhanianamente,
il medium diventa messaggio; saussurianamente, la
forma diventa contenuto. I futuristi, e il mondo tutto, prima di lui concepivano il rumore come onomatopea, effetto coloristico, con valore connotativo:
con lui il rumore diventa invece valido ad un livello
strettamente denotativo, assume valore strutturale,
autonomo, pienamente musicale. La rivoluzione di
Pratella, quantitativa (con l’enfasi posta sull’uso degli
intervalli microtonali propri dell’enarmonia), si inserisce ancora perfettamente in un discorso musicale
tradizionale, e impiega strumenti e modi compositivi tradizionali. La rivoluzione di Russolo è invece
una rivoluzione qualitativa, che comporta l’invenzione di suoni e strumenti musicali del tutto inediti,
l’apertura di un orizzonte fino a poco tempo prima
impensabile. Il rumore, fino ad allora considerato
come scoria, accidente e disturbo, diventa musica,
diventa arte.
110
/ Rearview Mirror
Russolo nasce immerso nella musica, con il padre
Domenico organista della cattedrale di Portogruaro (sua città natale, sopra Venezia) e direttore della
Schola Cantorum di Latisana, e i due fratelli maggiori, Antonio e Giovanni, musicisti di conservatorio.
Ma si avvia alla pittura: inizia come molti futuristi
come divisionista, vicino a Previati, assorbe influenze cubiste, per orientarsi poi ad una pittura più propriamente futurista sulla scia delle esperienze del
fotodinamismo e della cronofotografia; negli ultimi
anni si dedicherà poi ad una pittura più tradizionale, con uno stile da lui stesso definito «classicomoderno».
Musicista autodidatta quindi, e orgoglioso di questa sua formazione autonoma e antiaccademica, nel
1913 teorizza, inventa e realizza (assieme all’amico
pittore Ugo Piatti) gli intonarumori; inventerà
poi, sulla scia di questi primi strumenti, anche un
arco enarmonico, un piano enarmonico e un rumorarmonio. Avverso al fascismo, e quindi avversato
dal fascismo, Russolo sarà a Parigi quasi ininterrottamente dal 1927 al 1932. Qui si occuperà anche
della sonorizzazione di alcuni corti sperimentali, di
cui non resta alcuna traccia, prodotti dallo Studio 28
(lo stesso attorno a cui gravita il primo Buñuel),
che vedono per protagonisti lo stesso Russolo, Marinetti e altri futuristi. L’avvento del sonoro scorag-
gia però profondamente le sue ricerche, che sperava
di orientare proprio in ambito cinematografico: nel
1929, amareggiato per il mancato riconoscimento
del suo lavoro di musicista e inventore, tiene a Parigi
il suo ultimo concerto. Si trasferisce così in Spagna,
dove si interessa sempre più all’esoterismo, all’occulto, alle filosofie orientali, alla pratica dello yoga, e
nel 1938 pubblica un saggio dal titolo indicativo di
Al di là della materia.
Il pensiero musicale di Russolo si ritrova nel suo
manifesto L’Arte dei rumori (13 marzo 1913) e nel
volume dallo stesso titolo (1916) che raccoglie il
manifesto e gli interventi successivi apparsi sul mensile Lacerba.
Russolo presenta le proprie riflessioni come
conseguenza delle innovazioni proposte da Pratella:
l’obiettivo è unico, ampliare la libertà del compositore, fornirgli sempre nuovi strumenti espressivi,
consentirgli un pieno controllo della materia sonora. Forte di una concezione evolutiva-progressiva
della storia della musica, come campo in continuo
rinnovamento, propone l’impiego musicale del suono-rumore: ultimo “stadio evolutivo”, passo necessario già di fatto anticipato dall’utilizzo della dissonanza, che del rumore è una sorta di “grado zero”.
L’arte dei rumori è così presentata come semplice e
doveroso adeguamento alla vita e alla realtà: siamo
circondati dal rumore e non possiamo non tenere
conto di questo immenso bacino di possibilità sonore. I suoni musicali che si utilizzano per tradizione sono per Russolo astratti, “falsi”, ma soprattutto
limitati: rappresentano soltanto una minima parte
dello spettro possibile dei suoni che la natura, e la
natura umanizzata-meccanizzata, ci offrono. L’utilizzo dei suoni musicali puri è paragonato da Russolo
all’utilizzo in pittura dei soli colori primari, o comunque di una gamma di sfumature ridotta, a fronte di tutte delle possibilità cromatiche esistenti. I
suoni naturali sono indefiniti, non procedono per
salti discreti, ma secondo una gradualità continua,
secondo un sistema enarmonico (simboleggiato dagli strumenti capaci di glissando, come il violino). Il
tradizionale sistema temperato (simboleggiato invece dal pianoforte), coi suoi salti discreti di tono,
elimina quindi tutto un intero mondo di possibilità,
dato che il nostro orecchio è sensibile a variazioni
dell’ordine dell’1/8 di tono.
Il rumore, massima espressione di questa concezione enarmonica del suono, ci circonda, ci disturba,
ma soprattutto ci affascina: non riusciamo a padroneggiarne l’essenza, è un terreno ancora vergine,
tutto da esplorare. Gli intonarumori (termine questo che non compare nel manifesto del 1913, ma è
successivo), strumenti che consentono appunto di
intonare e regolare armonicamente e ritmicamente i rumori, permettono un’applicazione libera dei
principi enarmonici e un’esplorazione totale delle
componenti del suono. Con l’impiego del rumore, non si arricchisce soltanto la tavolozza tonale
(numero di note), ma anche quella squisitamente
timbrica (tipi diversi di suono), a rivestire un ruolo
fondamentale nel rinnovare i “colori” dell’orchestra:
Russolo propone infatti un’integrazione tra orchestra tradizionale e un’orchestra di intonarumori.
L’uso del rumore non ha dunque finalità meramente imitative dei suoni della natura (saremmo ancora
alla semplice onomatopea), né mira a creare una cacofonia insensata e fine a se stessa (saremmo nella più sprovveduta iconoclastia, pura provocazione
ideologica): il rumore nell’ottica futurista di Russolo
è uno strumento di espressione artistica a tutti gli
effetti. Siamo nel 1913.
G li
intonarumori
Un intonarumore si presentava come una grossa
scatola di legno dipinta con colori sgargianti. Al suo
interno, lastre e fili metallici collegati tra loro da
ingranaggi: il principio che permetteva di produrre il
rumore era analogo a quello che regola gli strumenti a corda. Una manovella (o un bottone collegato
ad un circuito elettrico) permetteva di azionare la
macchina, controllando le dinamiche del suono-rumore a seconda della velocità impiegata. Una leva
permetteva la modulazione del tono. Una tromba
simile a quella di un grammofono fungeva da amplificatore. Per alcuni modelli di intonarumore erano
poi previste leve aggiuntive per modificare leggermente il timbro del suono-rumore.
Russolo individuò sei famiglie timbriche di rumori: «rombi, tuoni, scoppi scrosci, tonfi, boati; fischi, sibili,
sbuffi; bisbigli, mormorii, borbottii, brusii, gorgoglii; stridori, scricchiolii, fruscii, ronzii, crepitii, stropiccii; rumori
ottenuti a percussione su metalli, legni, pietre, terrecotte,
ecc.; voci di animali e di uomini: gridi, strilli, gemiti, urla,
ululati, risate, rantoli, singhiozzi». A queste dovevano
corrispondere altrettante famiglie di intonarumori,
dai nomi auto-esplicativi: «ululatori e rombatori, crepitatori e stropicciatori, scoppiatori, gorgogliatori, ronzatori, sibilatori». Ciascuna famiglia timbrica era poi
articolata in quattro possibili varianti di estensione,
sul modello della voce umana: contralto, soprano,
tenore, basso. Russolo e Piatti realizzarono il primo
Rearview Mirror /
111
intonarumore nel 1913, e arrivarono a costruirne
un numero massimo di ventinove nel 1921.
Nel 1914 Russolo scrisse una trilogia per orchestra di intonarumori, intitolata Spirali di rumori, e
comprendente Risveglio di una città, Si pranza sulla terrazza dell’Hotel e Convegno d’automobili e d’aeroplani.
Con molta probabilità, le composizioni prevedevano
anche momenti di improvvisazione etero-diretta, e
cioè di improvvisazione guidata: con un direttore,
Russolo o chi per lui, a indicare le dinamiche secondo cui si dovevano svolgere e dovevano interagire
tra di loro le improvvisazioni dei singoli esecutori
(una pratica resa poi celebre dai tour de force live
di Miles Davis, Zappa e Zorn). Di tutti questi
spartiti restano oggi solo sette battute da Risveglio
di una città. La “grafia enarmonica” sperimentata da
Russolo per la notazione del rumore è ancora oggi
per larga parte impiegata dai compositori di musica
elettronica.
Oltre ai più celebri intonarumori, Russolo in-
ventò anche l’arco enarmonico (una sorta di
sega meccanica che consentiva di ottenere rumori
metallici da normali strumenti a corda) e il piano
enarmonico (una sorta di piano meccanico paragonabile al piano preparato che sarà poi di Cage; ne
resta un modello di una sola ottava, unico superstite
delle sue invenzioni). Ma, soprattutto, il rumorarmonio o russolofono, una tastiera con pedali
che consentiva di utilizzare i suoni provenienti da
diversi intonarumori: in pratica, un antenato del moderno campionatore a suoni presettati. Siamo nel
1921.
L a musica futurista :
l ’A rte dei rumori
dopo
Marinetti fu sempre un fervido sostenitore e
propagandista della musica futurista, promuovendone la commistione con le altre arti (gli intonarumori vengono utilizzati per sonorizzare spettacoli ed
eventi futuristi) e l’infiltrazione nella vita quotidiana
(già nel 1911 un gruppo di futuristi “minori” aveva
pubblicato il Manifesto futurista per la città musicale,
dove si proponeva la filodiffusione per le strade di
musica «ottimista, allegra e tonificante»). Pratella ricorda come il teorico e boss del movimento non
mancasse di intervenire in prima persona nella stesura dei manifesti musicali: a lui vanno forse attribuite proprio le frasi più provocatorie.
Ma Marinetti sarà anche, e soprattutto, autore
di interessanti esperimenti musicali: collage sonori
che miravano a sfruttare al massimo il potenziale
acusmatico del mezzo radiofonico (inventato da
Marconi nel 1894), alternando musica strumentale, rumori presi dalla quotidianità, rumori di guerra,
parole in libertà, momenti lasciati alla libera improvvisazione, silenzio con funzione strutturale.
A partire dagli anni Venti, tutta una serie di giovani musicisti si pone in continuità con le teorizzazioni
di Pratella e Russolo, dedicandosi però prevalentemente a sperimentazioni pianistiche (non a musiche orchestrali né ad opere liriche né a musiche
per intonarumori): Luigi Grandi, Aldo Giuntini, Virgilio Mortari, Daniele Napoletano, Luigi Gral, Nuccio Fiorda. Silvio Mix
(1900-1927) e Franco Casavola (1891-1955)
sono probabilmente i maggiori esponenti di questa
seconda generazione: compositori, pianisti e teorici
dell’improvvisazione. Casavola si interesserà addirittura pioneristicamente al jazz, genere completamente ignorato dai compositori e dai musicologi
dell’epoca; censurato per questo dal regime, nel
1927 si vedrà costretto a distruggere tutti gli spartiti delle sue opere propriamente futuriste. Antonio Russolo non aderisce al movimento ma vi
graviterà sempre attorno, sfruttando all’occorrenza
la celebrità di scandalo del fratello minore Luigi.
Nel 1921, Mario Bartoccini e Aldo Mantia
danno alle stampe L’improvvisazione musicale, manifesto in cui viene ribadita la centralità di questo principio nell’estetica futurista (propongono addirittura
una «libera improvvisazione per orchestra»), principio largamente impiegato nelle imprevedibili serate
futuriste, praticato da Russolo (ma in dialettica con
una rigida “etica del controllo”) e oggetto particolare delle riflessioni di Mix e Casavola: l’esecutore
come componente attiva del processo di composizione.
U n ’ arte
Russolo al rumorarmonio-russolofono (Parigi, 1930)
112
/ Rearview Mirror
dissolta
Ricostruire la storia della ricezione e della fortuna dell’arte dei rumori è un’operazione comples-
sa e dagli esiti contraddittori. John Cage, uno dei
primi a riscoprire la musica futurista, fa giustamente
notare come tutti i suoi esponenti, al di là del merito specifico, siano stati storicamente sottovalutati
e per questo a lungo misconosciuti, se non presso
piccole gelose nicchie d’avanguardia.
I musicisti futuristi ebbero vita difficile. Poco rassicuranti e consolatori, con loro esasperato sperimentalismo e il loro ostentato disprezzo per la tradizione, furono generalmente invisi al fascismo (Russolo
ad esempio non vi aderirà mai), e già la cosiddetta
“Generazione dell’Ottanta”, Alfredo Casella e
Gian Francesco Malipiero in testa, pesantemente compromessa invece col regime, pur attingendo proprio ad alcune intuizioni del Futurismo
musicale, cercò di cancellarne ogni traccia, attraverso la fondazione, nel 1923, della Corporazione delle
Nuove Musiche: in realtà, un istituto volto ad operare
una vera e propria “restaurazione musicale”.
Gli intonarumori costruiti da Russolo andarono
distrutti durante un bombardamento della seconda
guerra mondiale. Minime, e quasi del tutto trascurabili, le loro testimonianze registrate: due sole composizioni del fratello maggiore di Russolo, Antonio,
Corale e Serenata, consegnate alla storia da un gracchiante 78 giri registrato nel 1924, in cui sono presenti interventi di intonarumori, ma con funzione
per lo più coloristica, diremmo oggi “commerciale”,
sovrapposti a materiali musicali convenzionali. Lo
stesso Antonio pare abbia perduto (se non addirittura distrutto) le partiture del fratello, di cui restano
solo le sette battute di Risveglio di una città affidate
ad una tavola del volume L’Arte dei rumori (volume peraltro tradotto in inglese soltanto nel 1967).
Quella di Russolo, insomma, che pure rappresenta il
maggiore lascito in musica del Futurismo, è un’arte
praticamente dissolta, alla quale appare oggi impossibile restituire il giusto peso.
Nel 1977 Daniele Lombardi, compositore e
pianista toscano trapiantato a Milano, forse il massimo esperto italiano di Futurismo musicale (e di
conseguenza, nostro Virgilio), ha curato per conto
della Biennale di Venezia l’esecuzione del frammento superstite, 25 secondi in tutto, di Risveglio di una
città, utilizzando degli intonarumori appositamente
ricostruiti dallo studioso Pietro Verardo. Lombardi ha commentato la prima esecuzione parlando
di un «impatto sonoro paragonabile a quello della Sagra della Primavera». è quasi certo insomma come il
corso degli eventi ci abbia negato opere di interesse
assoluto.
Rearview Mirror /
113
I contemporanei : S travinskij ,
V arèse e gli intonarumori
Nel 1914 Stravinskij, Diaghilev (il direttore
del balletto russo) e il loro entourage sono a Milano. Marinetti organizza per i prestigiosi ospiti alcune serate futuriste nel salotto di casa sua: in una di
queste compaiono anche alcuni intonarumori. Non
appena vengono messi in funzione, Stravinskij fa letteralmente un balzo dalla poltrona su cui è seduto,
Diaghilev comincia a ridere a crepapelle, uno dei
loro ballerini cerca dei passi di danza adatti al rumore. Pare invece che Balilla Pratella dorma rumorosamente per tutto il tempo dell’esibizione. Russolo si gratta il pizzetto insoddisfatto: ancora non
ci siamo (la scena viene descritta nel memoriale Le
serate futuriste, 1930, di Francesco Cangiullo).
Stravinskij si dichiara comunque entusiasta e promette che si adopererà per fare debuttare quelle
eccezionali diavolerie in Europa.
Non si sa quanto per intercessione del grande
compositore russo, ma così accade. Dopo le burrascose première italiane e una lunga (e altalenante negli esiti) trasferta londinese, i concerti parigini
degli intonarumori, siamo nel 1921, sono un vero
evento. Al Théatre des Champs Elysées è presente la crema dell’avanguardia musicale (e non solo)
dell’epoca: de Falla, Kahan, Honegger e Milhaud del “Gruppo dei sei”, Claudel, Casella, lo
stesso Stravinskij, Ravel, il pittore Piet Mondrian (quest’ultimo scriverà un lungo e lusinghiero
articolo sulla sua «De Stijl»). Presenti anche Tristan Tzara e altri Dada, da sempre nemici giurati dell’estetica bellicista dei futuristi: intenzionati
a sabotare l’esibizione, finiscono però con l’essere
cacciati via in malo modo.
Sarà poi un ancora poco conosciuto Edgard
Varèse, uno dei pionieri della musica contemporanea, assieme a Stravinskij probabilmente l’unico
vero grande ammiratore delle ricerche sugli intonarumori, a presentare, sempre a Parigi, nel 1929, l’ultimo concerto (per rumorarmonio) della carriera
di Russolo. Cala il sipario.
D opo l ’A rte dei rumori : dai
“ futurismi musicali ” alla
musica elettronica
Ancora oggi molta critica “generalista” tende a
liquidare l’esperienza di Russolo e compagni con
poche parole, relegandola ai margini delle avanguardie di primo Novecento. Ma la sua opera (e lui sorta
di Buddy Bolden non del jazz ma della “musica
114
/ Rearview Mirror
rumorista”, personaggio capitale ma, come visto, dissolto) è stata un’influenza fondamentale su tutta una
generazione di sperimentatori musicali.
Lombardi parla di «futurismi musicali» proprio
per riferirsi alle tracce della concezione futurista
nella poetica di alcuni autori immediatamente successivi a Pratella e Russolo. George Antheil, ad
esempio, pur non avendo avuto contatti diretti coi
futuristi, dimostra di averne assimilato la lezione in
Ballet Mecanique (1924, pensato per l’omonimo film
di Fernand Léger) e Jazz Symphony (1925), dove
fa uso di poliritmia, collage sonoro e rumore con
funzione strutturale.Tracce dell’influenza futurista si
ritrovano in altre opere famose come La crèation du
mond (1923) di Darius Milhaud, nel Boléro (1928)
di Ravel, in Pacific 231 (1923) di Arthur Honegger, in Tides of Manaunaun (1917) di Cowell,
e poi in opere più o meno “minori” di Alberto
Savinio, Chesimò (Mario Monachesi), Alfredo
Casella (si veda il suo delizioso Pupazzetti, composto per sonorizzare i Balli Plastici di Depero, 1918),
Germaine Albert-Birot, Alexander Mossolov, Arthur Lourié, Leo Ornstein, perfino
dell’insospettabile Giacinto Scelsi, o dello stesso
Stravinskij, fino a Harry Partch.
Le intuizioni dell’estetica musicale futurista (le
teorizzazioni di Pratella, i collage di Marinetti, gli
intonarumori di Russolo) e cioè l’idea di una musica in qualche modo “meccanica”, la ricerca timbrico-tonale-ritmica legata alla scoperta del rumore
come possibilità, l’uso del silenzio strutturale, l’improvvisazione, la simultaneità, l’interdisciplinarità,
rappresentano un’anticipazione e un precedente
fondamentale per tutta una serie di esperienze musicali che arrivano dalle avanguardie storiche fino
ai giorni nostri: il collage Dada; il bruitismo sonoro
e la poetica del «suono organizzato» di Varèse; la
musica concreta (il suono inteso non nell’astrattezza del suo essere musica, e cioè composizione e
spartito, ma nella concretezza materiale che gli deriva dall’esistenza di un oggetto tangibile che ne è
la fonte) di Pierre Schaffer; quella acusmatica (il
suono possibile solo in quanto “allucinazione acustica”, materia sonora la cui fonte prima non ci è
dato di vedere e che possiamo fruire solo in quanto
riprodotta) di François Boyle; l’arte dei suoni fissati (il suono possibile solo in quanto registrato su
un supporto) di Michel Chion; l’alea, la dialettica
rumore-silenzio e il piano preparato di John Cage;
Fluxus e tutte le poetiche dell’happening e della
performance; le esperienze di “non-musicisti” come
Brian Eno e di inventori dei propri strumenti
come i già citati Partch e Cowell; l’industrial music
teorizzata da Monte Cazazza negli anni Ottanta;
il noise di matrice extra-colta (fino a Merzbow);
la musica elettronica da Stockhausen in poi; la
musica sintetica-campionata; la computer music. E
siamo ad oggi. Anzi, a domani.
Vista la diversità di campi che l’eredità di Russolo & Co. pare in qualche misura lambire, bisogna
sottolineare la doppia anima della musica futurista,
perfettamente sintetizzabile con le parole di Jacques Attali tratte dal suo saggio Rumori (1977):
«Quando diventa suono, il rumore è fonte di potere
[…]. È al tempo stesso cuore della progressiva razionalizzazione dell’estetica musicale e il rifugio per una
residua irrazionalità». Dall’intuizione futurista infatti
si dipartono due strade, due concezioni estetiche,
opposte e complementari, che spesso si sono incrociate: “etica del controllo” e “anarchismo sonoro”. La prima, appunto, orientata ad un
controllo razionale e totale della materia sonora e
al raggiungimento di un preciso risultato prefissato
(da Varèse in poi); la seconda orientata all’utilizzo
irrazionale-liberatorio della stessa e concentrata
assai più sui procedimenti che sui risultati (da Dada
in poi).
Fonti: i manifesti del Futurismo musicale
Francesco Balilla Pratella, Il manifesto dei musicisti futuristi, 1910; La musica futurista – Manifesto tecnico,
1911; La distruzione della quadratura, 1912, http://posso.dm.unipi.it/users/traverso/futurismo/futurismo.html
Luigi Russolo, L’Arte dei rumori – Manifesto futurista, 1913, http://www.eclectic.it/russolo/artofnoises.pdf [intero facsimile in pdf del volume del 1916].
Mario Bartoccini e Aldo Mantia, L’improvvisazione musicale, 1921, http://apicesv3.noto.unimi.it/site/reggi/0003-0466.htm .
AA VV, Manifesto futurista per la città musicale, 1911, http://apicesv3.noto.unimi.it/site/reggi/0003-0520.htm .
Spunti critici di base
Andrea Prevignano, Noise – Guida pratica al rumore, Ed. Apache, 2008 (volume allegato al mensile Rumore
#198-199, luglio-agosto 2008) [per ricostruire il filo rosso che lega le “musiche rumoriste”]
Daniele Lombardi, Futurism and Musical Notes, 1981, http://www.ubu.com/papers/lombardi.html [sul valore e
sull’eredità della musica futurista]
Daniele Lombardi, Futurismo musicale in Toscana – Alcune voci per un dizionarietto di veloce consultazione,
http://www.danielelombardi.it/writings/by/Writings_By5.html [sintetiche ma preziose notizie biografiche sui
musicisti Futuristi]
Per approfondire
Daniele Lombardi, Il suono veloce: Futurismo e futurismi in musica, Ricordi-Lim, 1996
Stefano Bianchi, La musica futurista – Ricerche e documenti, Lim, 1995
Dischi
AA VV / Daniele Lombardi [musiche di Marinetti, Pratella, L. Russolo, A. Russolo, Giuntini, Grandi, Mix, Casavola, Casella], Musica futurista, Cramps (2 LP), 1980; rist. con mod., Salon (CD), 2004
AA VV / Daniele Lombardi [musiche di Casavola, Savinio, Casella, Scelsi, Mortari, Giuntini, Chesimò, Napoletano, Malipiero, Birot, Stravinskij], FuturisMusic – Piano Anthology 1, Col Legno, 2000
Rearview Mirror /
115
The Vaselines
You Think You Are A Cult Band
Sono una band di fine Ottanta fondamentale; non hanno però mai
raggiunto - quasi inspiegabilmente - il successo commerciale. E se il
loro pubblico più generoso fosse quello odierno?
- Gaspare Caliri
116
/ Rearview Mirror
G lasgow O ttanta
T
utta la scena indie glasgowiana di fine Ottanta si portava appresso un gusto street,
naif e cartoon tutto newyorchese. Il bello
era la capacità di miscelare quei sapori al
milieu campestre che tanto aveva contraddistinto,
all’inizio del decennio (o qualche anno prima), la
breve storia del giovane gigante di marmo.
La polarizzazione era già Novanta, assieme convivevano brandelli di Paisley, culti Velvet e tutta la
mania Fifties e Sixties che, almeno dalla fine della
decade precedente, aveva investito l’underground
(vedi Simon Reynolds alla voce Jesus And Mary
Chain), eppure, la cosa buffa e peculiare della Scozia indie era lo spirito.
Osservandolo con la lente fumettosa e deforme
dei Ramones, tutto il marcio della strada si tingeva
di verde e le ragazze, invece d’essere lasciate nei
camper, entravano nella band a pari titolo con tutta
la frittata del vecchio rock (secondo il primo verbo
r’n’r) a prenderci una consapevolezza per forza di
cose post punk, a trovandoci in mezzo il divertimento clean (e non come facevano a Londra) e non
di meno a far saltar fuori, all’orecchio e al tatto, una
scuola. O meglio un atteggiamento démodé che se
ne fregava delle mode. E The Vaselines in siffatto
scacchiere Nord Brit erano la punta di diamante.
Coloro che ne avevano veramente convertito la
polarità mantenendo negli anni pure una considerevole identità e autonomia. Per questo oggi sono un
nume tutelare e sono citatissimi nonostante allora,
anzi, qualche anno dopo, fossero stati protagonisti
di una serie di eventi che li portò probabilmente ad
essere malintesi.
La spremuta della cosiddetta scena Creation –
Pastels, Shop Assistants, Bmx Bandits - e
dintorni era il portale per l’indie dei Novanta, la
scheggia apparentemente superficiale che guarda al
sempiterno Barrett invece dei soliti miti dissoluti
(Reed e Pop). I Vaselines erano decisamente imparentati con tali band, eppure vi si affiancarono solo
parzialmente: erano un passo indietro in quanto a
coerenza e una spanna sopra per qualità, freschezza e efficacia. Come si dice nel marketing, ciò che
faceva (fortunatamente) difetto nei Vaselines era
una mancanza di posizionamento chiaro con autopromozione e investimento su se stessi pari a zero.
Dall’inizio come alla fine, si occuparono di divertirsi
scrivendo e suonando canzoni. Quando il gioco non
fu più lo stesso, Cobain o meno, scazzi o meno, si
sciolsero con una grande naturalezza, quella stessa
caratteristica che li portà alla mitica Molly’s Lips: la
canzone che ogni vero fan dei Vaselines esalta. Niente a che vedere con Jesus Wants Me For A Sumbeam,
brano che tutti dopo un concerto “ad ampli staccati” avrebbero conosciuto molto bene. Quella canzonetta infantile con i campanellini delle BMX, cantata
da Frances Mc Kee con un’intonazione improbabile (almeno fuori da una di quelle chiese dove il
parroco accetta l’innovazione della chitarra), è il più
fulgido esempio di lo-fi sgangherato e forse uno dei
più puri esercizi di eredità della Bike di barrettiana
memoria. Molly’s Lips è un witz puerile, ma è anche
La Storia vaselinesiana, il prototipo; anche se di storie – biografiche – i Vaselines ne hanno almeno altre
due da raccontare. Quella di Cobain è inevitabile.
Come con altri gruppi (Flipper e Meat Puppets), fu
il loro più grande fan (cosa che lo portò a chiamare la propria figlia Frances, come la metà femminile
del duo). Senza di lui la band avrebbe avuto (e ha)
peso e identità autonomi, ma i fatti occorsi rendono doveroso il collegamento. È curioso che per farlo si debba partire dalla fine: a quell’inizio Novanta
nel quale i Vaselines erano già ufficialmente sciolti;
in cui Eugene Kelly (l’altro membro insieme a
Frances, che a sua volta avrebbe avviato l’esperienza
Suckle) stava per fondare i Captain America,
moniker poi cambiato in Eugenius per via di una
causa minacciata dalla Marvel.
Dicevamo di Cobain. La passione del biondo per
i Vaselines si palesa a libro concluso anche se forse
il romanzo deve a tutt’oggi trovare una fine appropriata. Tutto si giocò in quattro anni; l’avventura era
iniziata nel 1986 e divenne subito entusiasmante
quando, l’anno dopo, la produzione vaseliniana si
avviò con l’EP Son Of A Gun (53rd & 3rd) e il
fratello Dying For It (53rd & 3rd). Suoni che oggi
chiameremmo indie-pop, screziati di accenni giocosi
di noise; una bolla di sapone di purezza Velvet virata al pop Sessanta: evanescente rivelatrice di una
naturalezza in scrittura fuori dal comune. La loro
messa a punto dei brani è disarmante per semplicità
(vedi ancora il campanello di Molly’s Lips, confluita in
Dying For It) e ha un che spensierato e casuale.
Canzoni, perché no, come pic-nic nelle quali abitava pure una certa dose di sarcastico anti-romanticismo ormonale che troveremo pure nell’unico
vero LP licenziato dal duo, Dum-Dum, uscito per
l’attenta Rough Trade (come per quei tipi uscì Colossal Youth) nel 1989. E lì fu punto e a capo, se si
pensa che nella stessa settimana della pubblicazione
dell’album Eugene e Frances decisero di scioglier-
Rearview Mirror /
117
si. C’è chi dice che i due fossero delusi dal poco
successo dei due EP pubblicati. Frottole. Dalle voci
degli stessi protagonisti, non esistevano né cause
insormontabili né malumori insopprimibili per uno
split, semplicemente, come suonare una delle loro
canzoni, the band disbanded, le cose accaddero.
I ndie novanta ,
D uemila
ritorno
Qualche anno dopo, il cantante dei Nirvana invita i
Vaselines a suonare come gruppo spalla a Edinburgo. Iniziò così un’associazione con Cobain corroborata da cover (Jesus… suonata nell’Unplugged In
NY, più altri due brani - Molly’s Lips e Son Of A Gun
– inseriti in Intesticide) e sperticate dichiarazioni
di affetto verso gli scozzesi. L’operazione sarebbe
dovuta culminare con l’uscita dell’opera omnia di
Kelly e Mc Kee, In The Way of the Vaselines:
A Complete History, compilation pubblicata nel
1992 da quella Sub Pop che allora – grazie alle vendite di Bleach - era il gigante indie. Ma l’insuccesso
si replicò calando il secondo sipario sulla vicenda e
mettendoci il sigillo grunge. Tramite Cobain passò
infatti un’immagine distorta dei Vaselines; l’unplugged esaltò una componente nichilista che i Vaselines
non avevano o meglio, non cavalcavano. In Frances
ed Eugene dominava un certo humour nord britannico condito con una stralunatezza lontana dalla
triade maledetta del rock. Erano dei ragazzi belli e
sereni, adorati dalla “scena” per quel perfetto mix
di estetica e onestà. In più, avevano almeno quattro
pezzi dall’hook memorabile. Niente roba da rock
mainstream, piuttosto hit indie filiate di chitarrismo
e aplomb garage, lontane il giusto dalle pose pseudo
fedeli dei compagni di cordata perché in direzioni
puramente infantili. Ed erano loro stessi tanto che
Sun Of A Gun porta i Velvet in una dimensione anti-nichilista fatta di campagna, famiglia e amici. Nella
loro testa c’è quel che i Novanta saranno. Ci sono i
Lemonheads di Dando. La nerditudine Barlow.
L’approccio home made. Dalla strada alla cameretta e dalla cameretta al pic nic con la band - pardon – con gli amici. Roll Roll. Spin Spin. Around Around.
Nei testi dei Vaselines c’è questa testa che gira, non
troppo velocemente, non tanto per sballarsi e poi
sfracellarsi a terra. è quel che gli inglesi chiamano
tipsy: giusto quel tanto che sale e che poi non fa
sentire l’effetto collaterale.
E poi nel repertorio dei Vaselines c’è You Think
You’re A Man, un wave pop sentito mille volte ma
sconcertante per semplicità, ed esperimento para118
/ Rearview Mirror
elettronico unico nella manciata di canzoni del duo.
Il ritornello fa “you think you’re a man but you’re only
a boy” e sotto c’è una batteria sintetica con un pizzico di chitarra acida e synth riverberati. Il dialogo
minimo. L’interplay tra boy/man è ridotto all’osso:
essenziale e naif come l’essenza stessa della cosa,
ma l’aspetto più interessante è l’unicità dell’esperimento. In realtà, il brano è una cover di Divine,
aka Harris Glenn Milstead, attore travestito che negli anni Ottanta ebbe successo in America con un
pessimo mix di dance pop sintetico per gay club. E
la canzone venne apprezzata perlopiù in Inghilterra, arrivando alla posizione n° 16 nella hitlist, non
troppi mesi prima che i Vaselines la coverizzassero. Una piccola stravaganza che tramite il viatico
dei due scozzesi fu poi rifatta anche dai Belle &
Sebastian, altra band dalle radici nell’humus di
Frances ed Eugene. Un humus culturale lontano dai
grunge-ismi sul quale pare naturale aggiungere una
considerazione importante: il deragliamento operato dall’ingombrante Cobain portò i Vaselines alle
orecchie – di massa – sbagliate e oggi tutto questo
ritorna a casa, nelle mani – più corrette – dell’indie.
Anche se l’indie attuale, pur sempre atomizzato, ma
su scala globale non è l’indie provinciale di allora. È
tuttavia quanto basta per ricollocare una reunion
nata per caso nel 2006 e che oggi è tutt’ora operativa. La nuova storia, aperta questa volta, parte dalla
sorella di Frances. è stata lei a chiederle di suonare a un concerto di beneficienza e per l’occasione
Eugene ha pensato di riproporre un set di canzoni
dei Vaselines. A tre anni di distanza da allora la band
trionfa al Primavera Sound davanti a un pubblico dagli occhiali Ray-Ban più evidentemente indie. Forse
– a dire di Kelly – quella ragione sociale che sfornò
un gruzzolo di canzoni indie perfette a fine Ottanta
potrebbe oggi riprovarci. Senza nomi tutelari, per
cogliere i risultati della fama che presso i musicisti
degli ultimi vent’anni i due hanno accumulato. E che
probabilmente adesso darebbe i suoi frutti.
Rearview Mirror /
119
Ristampe
AA. VV. - Ze 30 Ze Records 1979-2009
(Strut Records, Agosto 2009)
G enere : mutant disco wave
Esistono delle “scene” che - per quanto storicizzate e/o influenti - ancora non hanno ricevuto la
collocazione che meritavano: tra queste vi è senza
dubbio la New York che, tra la fine dei ’70 e il decollo del Reaganismo, rispondeva alla crisi con le
due wave, una disco music ormai assurta a classico
e soprattutto la reciproca impollinazione, testimoni influenze funk, latine e
caraibiche lascito di una
metropoli che è cento
universi in uno. Perfetto
laboratorio sonoro in
anticipo sull’oggi, anche,
nel quale giocò un ruolo
rilevante la ZE, etichetta
fondata dall’anglo-libanese Michael Zilkha e dal punk parigino in trasferta Michel Esteban. Senza porsi limiti di genere e
avvalendosi della distribuzione Island, il duo rivelò ai
soliti quattro gatti un sottobosco dove gli sfregi del
CBGB’s e le carezze del Paradise Garage rappresentavano facce della medesima moneta.
Splendore che durerà fino alla chiusura della label
nell’86, divenendo materia di culto fino alla ricomparsa del solo Esteban nel 2002, in parte causata
dal rinnovato interesse delle giovani leve verso tali
sonorità. Ed è proprio per celebrare il trentennale
del marchio che la Strut pubblica questa raccolta di
brani per lo più editi ma col pregio di restituire, del
ventaglio stilistico di cui sopra, tutta l’ampiezza e
porsi così come adeguata presentazione al neofita.
Non manca nessuno alla festa: un Kid Creole 120
/ Rearview Mirror
remixato da Larry Levan - in anticipo sul Byrne solista e il funk in candeggina dei Was (Not
Was); i Suicide con la struggente Dream Baby
Dream e Alan Vega che ostenta radici rockabilly
in Jukebox Babe; la tenera, sfortunata Lizzy Mercer Descloux che suona già post-chill out e Cristina a dipanare oscurità sulla pista da ballo. La satira Devo-luta Re Bop Electronic allestita da Marie
Et Les Garcons e il pop che prefigura i Pizzicato Five della favolosa Maladie D’Amour a firma
Aural Exciters contrappuntano gli otto minuti di
Bustin’ Out (mostro disco-funk spaccaossa partorito
dai Material più Nona Hendryx) e gli schiaffi
colemaniani di James White e relativi Contortions. Un’ora e rotti di gustoso bignami da mandare a memoria e collocare sullo scaffale accanto
alla serie Mutant Disco. Approfondire, dopo, sarà
soltanto una logica conseguenza.
(7.2/10)
Giancarlo Turra
Beck - One Foot In The Grave (Iliad
Records, Aprile 2009)
G enere : sl acker - folk
Ristampa (con bonus, 12 inediti e 4 alt take) di uno
dei primissimi dischi di Beck, dalla sua discografia
out-major. Si parte e si pensa: ma sembra Skip James. E infatti è Skip James, la cover di He’s a Mighty
Good Leader. Riferimento programmatico e cartina
del mood dell’album: l’america rurale suonata però
in qualche garage dei suburbs. Disco pesantemente
folkie, a esplicitare una delle radici musicali più importanti per il nostro, disco scarno, quasi tutto voce
(quella nasale e più annoiata di Beck) e chitarra acustica, pochissima batteria, basso inesistente. E gli in-
terventi baritonali di Calvin Johnson, che produce il tutto. Quadretti (appesi storti, evidentemente)
di cantautorato slacker-folk, acerbi ma con un loro
fascino, e comunque riusciti, anche nell’esposizione della loro dichiarata
imperfezione, e poi un
paio di puntate più decise verso il country (I’ve
Seen The Land Before) e il
blues (il cameo d’apetura,
Fourteen Rivers Fourteen
Floods). Suggestioni sparse dei tardi Velvet (o di
quelli delle primissime demo), di Elliott Smith,
e una (bellissima) See Water tanto rarefatta da far
pensare alla forma canzone filtrata da certi gruppi
post. Due corpi estranei (in questo disco, non nel
mondo-Beck), Burnt Orange Peel e Ziplock Bag, riffone sporco alla God Save The Queen il primo, melmosa
cacofonia blues il secondo. Beck qui si fa chiamare
“coglione”, ma esploderà, più o meno nello stesso
periodo, e con un altro disco, dichiarandosi più generazionalmente un “perdente”.
(6.8/10)
Gabriele Marino
Benni Hemm Hemm - Murta St.
Calunga (Kimi Records, Giugno
2009)
G enere : string & bras s pop rock
Immaginate una parodia involontaria di Atom Heart Mother, ma davvero molto meno pretenziosa, e
quindi involontaria solo perché in alcuni passaggi lo
ricorda, come un umore di fondo che ci sarebbe
potuto essere nella suite di allora, ma che non fu.
Quindi diciamo impianto easy-listening pop-rock
con tanti fiati a sostenere melodie e contrappunti,
comprese voci suadenti che sono facilone quanto
memori di un certo gatto sornione, Kevin Ayers
(Whaling In The North Atlantic).
Il bello, anzi bello è dire troppo, ciò che incuriosisce
di Murta St. Calunga – come degli altri dischi che
già abbiamo affrontato di Benni Hemm Hemm
- è proprio che ci porta a compiere un’oscillazione. Come dire che dal popolare e il colpo di sicuro
effetto, soprattutto nei crescendo epici e negli arrangiamenti bandistici, si annusa una consapevolezza che fa l’occhiolino a un passato molto onorato.
L’islandese Benni Hemm Hemm d’altronde ha confezionato queste undici tracce con l’intento di farne
romantiche ballate, e ammiriamo la sua bravura nel
sembrare onesto e semplicemente orecchiabile e
invece nel colpire con scienza e coscienza (e usciere) l’ascoltatore che subisce il fascino di una melodia ben concepita per essere un po’ struggente,
un po’ appiccicosa, un po’ serenamente indulgente;
ma anche la coralità tonda degli ottoni. Più entriamo in questo disco facile, più gli riconosciamo uno
sguardo calcolatore. Chissà se ce l’hanno visto anche quelli della Kimirecords, che oggi ristampano
l’opera per coloro – cioè l’Europa - che se la sono
persa un anno fa, quando uscì per la prima volta.
(6.6/10)
Gaspare Caliri
Birigwa - self titled (Porter,
Gennaio 2007)
G enere : freak etno
Tutta colpa del “solito” destino: Birigwa era uno
studente ugandese in trasferta al New England
Conservatory, dove si fece notare da Mait Edey
della minuscola Seeds, il quale nel 1972 lo persuase
a mettere su nastro questa mezz’ora di musica. Difficile dire con quali prospettive se non fermare un
particolare momento, poiché l’ascolto restituisce
un folk d’arpeggi acustici intinto nel jazz - come potevano magari intenderlo Terry Callier o Nick
Drake - ovviamente acceso da momentanee bramosie terzomondiste. Il ragazzo ci mette del suo
mostrando corde di velluto (Kanemu-Kanabili) e
sfiorando le intenzioni di Tim Buckley, soprattutto decollando sulle ali dell’istinto non addomesticato per abbandonarsi a sé stesso.
Più delle scale pentatoniche, dei brani ripresi dalla tradizione del proprio paese e di qualche passo
in 6/8 colpisce soprattutto la performance canora,
stravagante ed eccentrica da far (quasi) chiudere gli
occhi su una libertà a tratti eccessiva e apprezzare
una penna di buon livello, certificata da Okusosola
Mukuleke e Uganda. C’è sovrabbondanza di stramberia, certo, ma del tipo che non si morde la coda
e induce a pensare che si entrò in studio persi dietro chissà quale visione. Non uno dei troppi vinili
che certuni godono a raccontare come culti solo
perché rari a trovarsi e/o “strambi”. Poiché anche a
quello abbiamo fatto il callo, sappiamo riconoscere
quando freak non rima con chic; questo, pur coi suoi
umanissimi limiti, non è fortunatamente uno di quei
casi.
(6.8/10)
Giancarlo Turra
Rearview Mirror /
121
Cluster - Grosses Wasser
(Bureau-b, Giugno 2009)
G enere : kraut rock
Alla luce delle collaborazioni con Michael Rother
prima e Brian Eno poi, i Cluster di fine ’70 erano,
per così dire, alla terza giovinezza.
Grosses Wasser, il settimo disco della sigla se si
includono le due uscite con Eno, vedeva Peter
Baumann - transfuga dai Tangerine Dream - alla
produzione. Un lavoro nello stile di Moebius e Roedelius, fatto cioè di quella melodia stranita figlia
delle delicatezze di Zuckerzeit e Sowiesoso
(il sinistro vaudeville di
Isodea, la melmosa e ambientale Breitengrad 20,
la ninna nanna di Manchmal) e dell’esperienza
assieme l’ex Roxy Music
(Avanti). Si era nel 1979, tempi in cui la creatura Cluster, navigata e titolare di uno stile definito, veniva di
pari passo alle sortite in proprio sia di Roedelius, che
esordì come solista l’anno prima, sia di Moebius, che
nel mentre pianificava Rastakraut Pasta con Plank.
Tuttavia, per chi pensasse ad un dispiego di energie
riversato altrove, la coppia era affiatata nonché capace, in Protese, di aperture mutant disco da intimorire
qualsivoglia giovincello di stanza Ze Records. La title
track - un blob contenente ambient, gamelan e scorie
dell’esperienza Kluster - sanciva l’epilogo.
La ristampa, che rientra nel progetto della Bureau B
di riproporre buona parte del vecchio catalogo Sky,
non ha bonus track.
(7/10)
Gianni Avella
Frank Zappa - Lumpy/Money (Zappa
Records, Gennaio 2009)
G enere : ragù di suoni + parodia flower
power
Celebrazione tardiva del dittico sessantottino Lumpy Gravy-We Are Only In It for the Money (il
disco più scopertamente sperimentale di Zappa, e il
suo preferito, il primo; la sua satira in presa diretta del flower power e della psichedelia il secondo)
con un audio-documentario in 3 cd che scava nelle
session dei due album, sul modello di quanto già
fatto nel 2006 per il quarantennale di Freak Out!
(con quel MOFO pubblicato inopinatamente in due
versioni, doppio e quadruplo cd, tra loro comple122
/ Rearview Mirror
mentari). Il primo disco contiene allora l’Ur-Lumpy,
ovvero la primissima versione solo orchestrale senza i mitici “dialoghi del pianoforte”, prodotta per la
Capitol nel ‘67 e poi rifiutata (reperibile prima d’ora
solo su bootleg), più la versione mono di We Are.
Il secondo i remix 1984 di Lumpy, inedito, e di We
Are, usato invece per la prima stampa su cd (1986) e
oggi introvabile. Si tratta di un remix terribile, voluto e fatto da FZ in persona, criticatissimo dagli zappofili, e giustamente, perché mette in scena un disco
del tutto falsificato, se non massacrato, con le linee
di basso e batteria risuonate ex-novo, alcuni pezzi
accelerati, un timbro generalmente più acido, come
solarizzato. Oggi che la versione definitiva dell’album su compact restituisce il mix originale, questo
qui resta come documento, interessante, strano, ma
soprattutto inoffensivo: specchio di certe fisime zappiane anni Ottanta.
Il terzo disco contiene gli inediti veri e propri, come
già da MOFO: prove e dialoghi di studio, versioni
alternative e frammenti di interviste. Interessante
soprattutto la lunga macedonia di How Did That Get
In?, dalle session di Lumpy Gravy, che passa in rassegna, senza soluzioni di continuità, parti strumentali
e orchestrali non editate, due soli di chitarra blues
e sezioni impro free-rumoristiche.
(7/10)
Gabriele Marino
Kevin Saunderson - History Elevate
(KMS, Giugno 2009)
G enere : ristampa techno house
Parla tech il mito Saunderson. Lo spirito (santo?) che contrasta e incarna le altre due divinità di Belleville (May e Atkins) ritorna con un
doppio obbligatorio. Nel primo CD i suoi mix da
vent’anni a questa parte distillato di tecnica impegno anima targati Motor City. Nel secondo disco
la progenie contemporanea che tenta di rileggere il maestro ma che soccombe (a parte nel caso
di Luciano e di Craig) di fronte alla sua statura.
E allora vediamo se è ancora giusto parlare di mito.
La rilettura di The Bottle dei Christians è soul puro,
una cosa che ha dei flauti che parlano direttamente
con il divino e dei backing da panico. C’è poi il culto
progressive Cerrone riletto in chiave uberfunk, la
versione definitiva di Supernature in slow-mo, High è
il suo territorio techno, quei synth che hanno creato
l’uomo, la sua specialità a nome Inner City, e per
avvicinarci a noi ecco la gemma per Hercules And
His Love Affair, una You Belong in trance da brivido
highlight
Orbital - 20 (Rhino, Giugno 2009)
G enere : B ig R ave
La loro recente reunion non promette niente di nuovo. Troppo freschi i pessimi risultati ottenuti
dai fratelli nei Duemila, sia con le ultime cose come Orbital sia come solisti. Fortuna che per
festeggiare e rimediare c’è questa bella compila.Tanto bella quanto definitiva: due cd che ripercorrono il meglio di una carriera e almeno un remix (su tre) di lusso, Halcyon di Tom Middleton.
Soprattutto un tomo che ricolloca correttamente nella storia il duo come il fiore all’occhiello di
quella crema di raver/produttori che fecero il salto proponendosi come rock (meglio wave) band
per il millennio a venire (questo) e non più come dj.
Il nostro futuro presente è andato diversamente eppure meglio non poteva andare, il ricordo live
che conservo dai tempi d’oro ritorna fedele e i due con gli occhialini a doppio led laterale rubati
dai Residents - che oggi li puoi vedere soltanto addosso a Geologist (Animal Collective) – sono
ancora quella botta pinkfloydiana che culminò, quella sera, a Ibiza, nell’esecuzione del loro brano
d’esordio. Era Chime e il suono primi Novanta dance brit festeggiava la sua Wish You Were Here
sette anni dopo la prima pubblicazione.
Gli Orbital esistono veramente dall’inizio del movimento, o perlomeno, dal picco della prima
ondata e nell’89, 20 anni fa, quel brano già spopolava. I fratelli lo presentarono al Top Of The Pops.
Premettero il tasto play e rimasero immobili. Bastava la musica perché
il simbolo della così nominata Second Summer of Love britannica era
distillato e poco importava se veniva etichettato con un indistinto
house/techno, ora abbiamo tutto il tempo per comprenderne il fascino della leggenda.
Chime, e il gemello cattivo Satan (acid distillata con un cucchiaino di
Beltram), resistevano a tante delle tentazioni bleep e ultra acide del
periodo opponendo un equilibrio e una sublimazione invidiabili e invidiati. Quei suoni erano figli della stessa famiglia, fatti con le stesse
primordiali macchine, eppure erano autorevoli. Si giocavano la carta del super-io. In Chime, specialmente, il climax era perfetto e proprio su quello standard gli Orbital si misurarno in spazi ritagliati
ad hoc: le tracce di chiusura.
In scaletta troviamo una sempre magnifica Belfast (Green Album) e Halcyon (Brown Album), nella
take housey di Middleton. Con Lush il cerchio balearico si chiude sia in omaggio al revival attuale
sia in senso filologico chiudendo la (allora) moda dell’ambient per la vera fase adulta della, chiamiamola, band.
E la storia andò così: se Snivilisation fu la premessa, la storia la scrisse Insides e il picco di popolarità la colonna sonora del Santo. La compila gli oppone un interesse per i brani chiave del primo
periodo (ben due versioni di Lush e Impact) e per alcuni singoli (uno su tutti The Box, il sommo
brano orbitale).
Minimo comun denominatore: la voglia di lasciare un segno autorevole quanto classico con un
suono in grande e totale da bravi brit che non sanno fare a meno di misurarsi con le storie antiche e moderne. Ne esce un lavoro imprescindibile, specie nel primo cd. E non dimentichiamoci
che Goldfrapp viene da qui (è qui).
(7.5/10)
Edoardo Bridda
Rearview Mirror /
123
deep che sbatacchia i neuroni, e poi il remix di Hustler
che eclissa la versione originale dei Simian Mobile Disco. In chiusa il gioiello acieeed in Money di Cameo.
Impossibile non inchinarsi di fronte alla storia. Necessario quando troppi DJ durano il tempo di qualche singolo. Lui è un classico. E resiste(rà) sempre
contro i mulini a vento del tempo. Da avere possedere e ballare.
(8/10)
Marco Braggion
Madlib - The Last Electro-Acoustic
Space Jazz & Percussion Ensemble
- Summer Suite (Stones Throw,
Giugno 2009)
G enere : space - l atin - lounge
Finalmente. Stones Throw decide di rendere giustizia
a questa lunga suite, quaranta minuti circa, ispirata
all’estate, e ovviamente parte di una programmata
tetralogia sulle stagioni, originariamente accoppiata al vinile di Yesterdays Universe, luglio 2007
(stordente compendio delle ultime - in tutti i sensi
- produzioni di Madlib come Yesterdays New
Quintet & derivati), e destinata quindi ad una circolazione limitata. Summer Suite meritava invece
una collocazione a sé, perché rappresenta uno dei
parti jazz&dintorni di Mad non solo più rappresentativi (del suo modus operandi e del suo mood tra
free, latin e funk), ma anche più riusciti (Mad più
maturo come strumentista, meno dispersivo del
solito, più controllato). Il risultato è un sottofondo
di lusso a base di percussioni, piano, tastiere e fiati,
una lounge ideale per coconut-bar su spiagge dorate,
tipo copertina di Bitches Brew. Aspettiamo adesso il più volte annunciato-rinviato tributo a Davis di
Miles Away e una Fall Suite, opportunamente,
verso settembre-ottobre.
(7/10)
Gabriele Marino
Natural Food - self titled (Porter,
Gennaio 2007)
G enere : jazz - rock
Con un certo ritardo sulle uscite in madrepatria
giunge anche nel nostro paese il programma di ristampe dell’etichetta americana Porter. Gestita
da uno stuolo di sinceri appassionati, la label della
Florida ha in carniere dischi contemporanei di Jewelled Antler Collective, Henry Grimes e
del nostro Valerio Cosi; di conseguenza, la loro
riscoperta di materiali rari si carica di una trasver124
/ Rearview Mirror
salità lontana dal rock, che siede più comodamente
nell’ambito della sperimentazione. Cosa che, tanto per smentirci, Natural Food fa poco o punto:
stampa privata risalente
al ’72, il disco del nutrito ensemble di Boston
- raccolto attorno al
pianista elettrico Mait
Edey, capoccia di quella
Seeds che stampò l’album in origine - ammannisce al contrario soul e
blues-rock scolastici, tutt’al più si rifugia in un jazz
innocuo sia fedele alla linea che figlio delle contaminazioni di Davis e Hancock. I quali avevano
tracciato il solco in notevole vantaggio cronologico
forti di un’ispirazione superiore, dunque senza soccombere a eccessi di gradevolezza e vuoti strumentali. Qui la perizia esecutiva appartiene viceversa alla
media dei “dilettanti” - nell’accezione negativa di chi
arriva in ritardo e s’adegua come può - e la personalità latita, eccezion fatta per un’apprezzabile Siren
Song da Jefferson Airplane alle prese col soul.
Troppo poco per giustificare non soltanto il culto,
ma finanche la briga di una riedizione.
(6/10)
Giancarlo Turra
Neon - Rituals (Expanded Edition)
(Spittle, Maggio 2009)
G enere : synth wave italiana
La prima ristampa dei fiorentini Neon uscita per la
rinata (oramai da un pezzo) Spittle Records ci aveva
davvero stupito: un infinito mantra di synth tenebrosi e catramosi, una fotografia live di un gruppo
del tutto paragonabile alla fase più ostica (e forse
migliore) dei Cabaret Voltaire ma più capaci altresì di creare ambienti di tensione bianca e nervosa. Un trionfo di macchine e di fumo.
Ma i Neon sono soprattutto quelli che trovate in Rituals, disco oggi ripubblicato dalla etichetta di cui
sopra nella sua versione estesa. Un disco di quella
che in Italia chiamavano dark-wave, senza picchi ne
infamie di rilievo; ma indiscutibilmente uno dei migliori prodotti della synth-wave nazionale. E appunto,
nel panorama italiano, e soprattutto in un periodo
(la prima stampa fu del 1985, per la Kinder Garten)
di parziale restaurazione nella wave nostrana, Rituals
rappresentava un momento di tenuta e di qualità sostanziale. Un appiglio per l’underground italiano, visto
anche la longevità della band, l’unica forse presente
sia nei primordi sia nei tardi Ottanta, senza eccessive concessioni mainstream. Di più: arrivava come
primo album effettivo della band di Marcello Michelotti, dopo singoli ed EP, e la Spittle come al solito è
brava a restituirci le opinioni di allora in un booklet
ricco di interviste e articoli d’antan. Epperò, qui non
ci si può fare nulla, il tempo passa, e passa meglio a
quella melma di cui i Neon si resero capaci in quei
dissotterrati live fiorentini fatti di circuiti analogici e
di inquietudine gotica, rispetto a questo valido ma
collocabilissimo post-punk sintetico.
(6.7/10)
lie Parker. Ma soprattutto, per l’appunto, c’è un processo colto e restituito, un processo nelle cui note
si percepisce la grana della prova, e per nemmeno
un istante l’ansia da prestazione. Una sicumera e un
sorriso di stare davanti a tante piste da mettere insieme. “Solo in seguito mi sono accorto che certi
frammenti erano legati tra loro da una certa coerenza”, dice Wyatt. Tanto basta per riprendere questo coacervo di “procedure” e darlo alle stampe,
per la prima volta, ventotto anni dopo, nella collana
Tracce di Rai Trade. Esperimento riuscito.
(7.2/10)
Gaspare Caliri
Gaspare Caliri
Robert Wyatt - Radio Experiment
Rome, February 1981 (Rai Trade,
Giugno 2009)
G enere : texture - rock
Preferiamo ormai guardare a essi come un rumore
di fondo; tutto pur di evitare di prestarvi attenzione
e di rimanere costantemente delusi e schifati. Ma
il nostro moralismo nei
confronti dei mezzi di
comunicazioni di massa subisce una messa in
discussione quando parliamo di radio pubblica.
Intro enfatica per una
recensione che non parla solo di autore e titolo, ma anche di circostanze e pratiche. Era il 1981
quando Radio 3 Rai chiamò Robert Wyatt nei
suoi studi; volevano osservare e registrare il suo
“reale processo creativo”, e quindi lo invitarono a
stare una settimana a Roma ma a fare quello che era
abituato a fare: partire da idee musicali e svilupparle.
“Non erano interessati a ottenere un prodotto finito”, quanto a “mostrare il processo”.
Robert decise di non arrivare là con materiale già
pronto, non assunse il contesto come ambiente
dove inscenare qualcosa di già disposto e pianificato, come spesso avviene in una dimostrazione
di laboratorio. Arrivò con la testa note e voce e si
mise a sviluppare le texture di incastri e di livelli che
universalmente già gli si riconosceva come tratto
distintivo. E in questo esperimento radiofonico ne
abbiamo mirabolanti esempi. Il laboratorio di Wyatt
è un sistema di maglie che prendono vita nell’incredibile equilibrio di suoni e cose, improvvisazioni e
melodie, effetti e voci. C’è il tema dell’Albero degli
zoccoli come il rifacimento di Billie’s Bouncie di Char-
XTC - The Dukes Of Stratosphear
- 25 O’ Clock + Psonic Psunspot
(Ape House, Aprile 2009)
G enere : P sych -( lolli ) pop
Ristampe rispettivamente dell’EP uscito il primo aprile ‘85 e dell’LP uscito nell’agosto ‘87 per Virgin a nome
The Dukes of Stratosphear. E cioè gli XTC in
trip da gas esilarante concentrati a parodiare-omaggiare-ricreare, in una parola, giocare con le loro radici Sixties: pop psichedelico, con la testa alle armonie
vocali dei Beach Boys, al primissimo Bowie, a
Byrds, Pink Floyd, Kinks, Pretty Things, ma
soprattutto ai Beatles del Sgt. Pepper’s. Divertentissimo giocare ad orecchiare la citazione, il riferimento, la strizzatina d’occhio. Con il sorriso stampato in faccia, tanto ironico, quanto nostalgico.
Operazione piacevolissima, leggera nel senso migliore, deliziosa fin dal nome pomposissimo scelto per
il gruppo (e ripescato dai primordi in cantina degli
XTC), agli pseudonimi ancora più pomposi adottati
dai musicisti (Dave Gregory su tutti, col bellissimo
Lord Cornelius Plum), agli artwork, ai testi (ad un tempo ingenui e maliziosi). Operazione quindi anche
studiatissima, si direbbe di filologia non pedante, di
ricostruzione di un suono e di un immaginario, quello appunto soft-psych di fine anni Sessanta, tanto
basilare per i nostri (e un po’ per tutti). Materiali
frizzanti e speziati in perfetta continuità con la carriera XTC, come dimostra quella Big Day pensata
per 25 O’Clock ma finita poi su Skylarking.
Tutti i pezzi hanno il loro perché, e alcuni sono gioielli assoluti. Ristampe con versioni demo, qualche
inedito (pezzi registrati ma mai pubblicati), rarità
(come la Open a Can già su una compilation del
2003) e un video ciascuna.
(8/10)
Gabriele Marino
Rearview Mirror /
125
(GI)Ant Steps #29
classic album rev
Dizzy Gillespie
The Pretty Things
The Complete RCA-Victor Recordings (RCA,
Gennaio 1995)
s.f. sorrow (Columbia records, dicembre 1968)
Se nel rock il termine “raccolta” sottintende spesso
quell’operazione commerciale mascherata da esigenza artistica che sono i “best of”, nel jazz la cosa
funziona diversamente. Tanto che tra i dischi imprescindibili per una discografia di base rientrano anche
alcune opere sostanzialmente compilative. Alla base
del discorso, un’esigenza storiografica: documentare l’evoluzione artistica di musicista in un mondo il
cui lo “stile” non è solo cornice ma anche linguaggio.
Più una strettamente pratica: entrare in possesso
di materiale pubblicato in un periodo – soprattutto anni venti, trenta e quaranta - in cui il supporto
discografico era agli esordi e aveva una natura decisamente dispersiva. Nasce con questi intenti anche
The Complete RCA-Victor Recordings. Due
CD per 43 brani che raccolgono gli esordi e la prima maturità di quel virtuoso della tromba che era
John Birks Gillespie, in arte Dizzy.
I classici Manteca e Anthropology inaugurano la
prima parte dell’opera ma è una falsa partenza, dal
momento che i due brani risalgono al 1946 mentre
il resto del programma procede rispettando l’ordine cronologico delle registrazioni. Partendo dal
1937, quando ritroviamo un giovanissimo Gillespie
nel libro paga della Teddy Hill Orchestra sostituire il
suo idolo Roy Eldridge in King Porter Stomp,Yours
And Mine, Blue Rhythm Fantasy. Questo e il successivo musicista che nel ‘39 incide Hot Mallets col vibrafonista Lionel Hampton più una parata di all
stars del periodo - tra cui Coleman Hawkins e
Ben Webster – non corrisponde ancora al Dizzy
della maturità. Lo stile esplosivo, il riff incontenibile,
le note “tirate” che segneranno il bebop del trombettista sono ancora in fase germinale e verranno di
lì a poco. Più precisamente nel 1945, con 52th Street
Theme, Night in Tunisia, Anthropology, Ol’ Man Rebop,
Ow!. Standards suonati grazie a una formazione agile
sax tenore, vibrafono, piano, chitarra, basso e batteria, più la tromba acrobatica del padrone di casa.
Nati a Kent, in Inghilterra, agli albori della British Invasion, i Pretty Things rappresentano uno degli aspetti
più creativi e pionieristici di quella scena, ma anche
uno dei meno fortunati. I loro esordi sono legati ad
un rythm and blues dal sound crudo e più duro rispetto agli Stones, dal quale trarranno ispirazione
molti gruppi garage, a partire dagli MC5. Nonostante
le attenzioni del pubblico inglese e in controtendenza
rispetto all’”invasione britannica”, Phil May e compagni passano praticamente inosservati negli U.S.A.
Con l’esplosione della psichedelia, il gruppo cambia pelle e aderisce alla controcultura, mescolando
il proprio sound R&B con le nuove sperimentazioni
in studio, ormai consolidate dopo il giro di boa del
decennio dei ’60. Nel 1968 la band si chiude negli studi di Abbey Road, dove i Beatles stavano registrando
Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, per dare vita
alla loro personale rivoluzione: S.F. Sorrow. Nato da
un’idea di May, il nuovo album proponeva una novità assoluta: partendo da una storia, il cantante aveva
composto una serie di canzoni attraverso le quali
raccontare la vita di un personaggio, dalla culla alla
bara.
Cronologicamente, si tratta della prima rock opera
mai pubblicata, pur precedendo di pochi mesi il capolavoro degli Who, Tommy, divenuto presto emblema
del genere. Lo stesso Pete Townsend ha dichiarato
di esserne stato ispirato, anche se le due opere hanno un carattere notevolmente diverso. Composto di
singoli brani, uniti tra loro nel mixaggio, ma pur sempre delimitati da una forma chiusa, S.F. Sorrow non
contiene né il dialogo diretto dei vari personaggi, né
le riprese dei temi, caratteristiche che hanno conferito a Tommy la sua particolare e definita struttura
drammatica, ripresa abbastanza fedelmente anche
nella traduzione cinematografica.
Musicalmente, S.F. Sorrow segna un importante punto di contatto tra le esperienze post-beat e la nascita della psichedelia, facendo emergere due dati
126
/ Rearview Mirror
Quest’ultima virata verso un bop che è virtuosismo,
narcisismo e, per alcuni, vera e propria esagerazione. Come ne ebbe a dire un Louis Armstrong evidentemente in ritardo sui tempi, che senza mezzi
termini accusò Gillespie di infarcire il proprio jazz
di note “sbagliate”.
Corsi e ricorsi storici. Per uno stile che muore,
un altro ne nasce. Tanto che due anni dopo il classicismo spericolato Parker/Gillespie sembra già un
ricordo lontano. C’è l’America latina alle porte e
ha un nome e cognome: Chano Pozo. Percussionista cubano oltre che autore di valore, il Nostro
si dimostra capace di traghettare il jazz di Dizzy
verso il Golfo del Messico e poi ancora più a Sud,
dando il la a una commistione tra bebop e ritmi
latini che segnerà tutta la produzione successiva del
musicista. La già citata Manteca, lo scat-blues di OppPop-A-Da, il Sud America di Algo Bueno, Cubana Be
e Cubana Bop mostrano un sound “eccitato” dalle
ritmiche sincopate e prodotto da una formazione
che è una big band a tutti gli effetti, pur in chiave
“etnica”: tromba, trombone, sax alto, sax tenore, sax
baritono, pianoforte, basso , batteria, percussioni.
Inizia così a concretizzarsi quello che sarà il nuovo Gillespie: arrangiatore, direttore d’orchestra, innovatore di linguaggi, capace di una visione d’insieme che armonizza le bizzarrie del bebop, il fascino
dello swing, la disciplina della grandi formazioni e i
particolari latini.A lui è dedicato quasi tutto il secondo CD dell’opera, con brani come Guarrachi Guaro,
Duff Capers, I’m Boppin’Too, Swedish Suite, Dizzier And
Dizzier. Per arrivare poi a una chiusura di scaletta
affidata a due versioni di Victory Ball e Overtime suonate nel 1949 con quei Metronome All Stars in cui
militavano, tra gli altri, Charlie Parker, Lennie
Tristano, J. J. Johnson, Miles Davis. Ma questa è un’altra storia.
Fabrizio Zampighi
di fatto storicamente importanti: prima di tutto, il
collegamento diretto tra la British invasion e la scena psichedelica; secondo, la stretta relazione tra le
esperienze controculturali e i primi passi del rock
progressivo (non a caso tutti generi che nascono in
Inghilterra, così come sarà per il punk nel decennio
successivo). In quest’album, il rythm and blues e il
folk rock vengono osservati al caleidoscopio, con un
orecchio a Sgt. Pepper’s dei Beatles e un altro all’acid
rock dei Grateful Dead.
La corrispondenza tra i brani e i testi, fondamentale
per rendere musicalmente concreta l’idea della rock
opera, è un elemento cruciale di S.F. Sorrow: il contrasto tra il rock teso e acre di Balloon Burning, che
presagisce la tragedia della morte della moglie di Sebastian, trova la sua logica conseguenza nella lenta
e cupa Death, in cui sta ad una chitarra “piangente”
e al sitar condurre la melodia discendente del triste riff, che descrive la sensazione di abbandono del
protagonista. L’esperienza del “viaggio” introspettivo
di Sorrow dentro se stesso è quella che mette in
luce il carattere più psichedelico della band. Sembra
quasi di sentire i Pink Floyd di barrettiana memoria
quando l’andamento tranquillo di The Journey si trasforma in un incubo ossessivo dal quale fuoriescono,
sovraincisi e manipolati, pezzi di brani precedenti (e
della vita stessa di Sebastian) e che culmina nei deliri
allucinogeni di Well Of Destiny. La chiusura è affidata
significativamente ad una malinconica ballad acustica
(Loneliest Person), che rafforza l’idea di solitudine e
trascina malinconicamente il protagonista verso l’inevitabile fine.
daniele follero
Rearview Mirror /
127
Cadillac Records
di D arnell M artin (USA, 2009)
Feeling good was easy, Lord, when we sang the blues,
you know, feeling good was good enough for me, good
enough for me and my Bobby McGee… cantava Janis
Joplin qualche decennio fa per ricordare il potere
incredibile che il ritmo del blues ha sulla mente e sul
corpo umano. Una musica che nasce come reazione
viscerale ai soprusi e alle fatiche, come ritmo della
vita libera contro il duro lavoro: musica che riscatta
dalla realtà del quotidiano e spinge altrove. In fondo
Cadillac Records vuole soprattutto raccontare
quest’idea di redenzione che le radici afroamericane si portano dentro dai secoli in cui la barriera
del colore sembrava insormontabile. Un’intenzione
nobile ma che non riesce del tutto.
Il fatto è che, diversamente da ciò che accade con
la musica in questione, il film non avvince, non conquista. Il blues, come si sa, è musica che sale su dal
basso. You can sqeeze my lemon till juice run down my
leg… cantava Robert Johnson nel 1937. Negli
anni 40 Anaïs Nin nauseata dalla smortissima vita
letteraria americana saliva nottetempo verso Harlem insieme ai suoi amici haitiani a sentire la musica
nera, i ritmi indiavolati e le danze selvagge che si
facevano negli scantinati. Nel film la scena del primo
grande concerto di Muddy Waters con il pezzo I’m
your Hoochie Coochie Man ci dà l’idea di quello di
cui Anaïs parlava: riprese ristrette di corpi sudati,
luci soffuse e sfondo rosso. Darnell Martin sceglie
spesso di stare addosso ai personaggi come se volesse trovare la giusta immagine per il calore emanato dalla musica: inquadrarli in primo o primissimo
piano, indagarli, far parlare i volti. Fortunatamente
può contare su volti (e voci) davvero fenomenali.
Pendant di questo calore è il rapporto d’amore che
lega i musicisti alle loro donne, tutte devote, passionali, votate completamente al loro uomo. Geneva,
la futura moglie di Muddy Waters, gli offre la possibilità di smorzare il casino della città infilando il
jack della sua chitarra nell’amplificatore. Sittin’ here
thinkin’ of your kiss and your warm embrace…I’d rather
be blind then to see you walk away from me… canta
Etta James di fronte a Leonard Chess che se ne sta
andando. I maschi, in sostanza, lottano per affermarsi, le donne, invece, per amare.
Come molte altre cose anche il senso del ritmo, il
soul, è una cosa con cui si nasce: o ce l’hai oppure no. E infatti, è proprio questa sua caratteristica
fatale (nel senso dell’ineluttabilità del destino) che
contribuisce ad alimentare quelle leggende di cui si
128
/ La Sera della Prima
che comprende sette film di Charles Burnett, Clint
Eastwood, Mike Figgis, Marc Levin, Richard Pearce,
Wim Wenders e lo stesso Scorsese). La coralità, poi,
è una cosa difficile da gestire per un regista quasi
alle prime armi. Ci servirebbe un Altman o uno
Scorsese appunto.
Per un ipotetico confronto il film che salta alla mente per primo, oltre a Ray, vero e proprio biopic, è
Dreamgirls del 2006 che condivide con questo la
stessa attrice. A questo punto, però, saremmo costretti ad intavolare un discorso diverso. Come mai,
è stato detto (Aldo Fittante, ‘Film tv’, anno 17, n.
22), Cadillac Records è un film non personale (è
vero) e soprattutto fatto al risparmio (altrettanto
vero)? Dreamgirls criticava con gran dispendio di
energie, talenti e denaro il cinismo dello star system. In fondo, in quel film le questioni razziali, seppur legate a black artists, non erano il centro del
discorso. Qui, invece, il centro sembra essere proprio quello. Ovviamente con molto meno dispendio
di risorse. A renderci un po’ più chiare le cose è la
storia stessa della sua regista (e anche sceneggiatrice) Darnell Martin. Dopo aver vinto nel 1994 il
premio del “New York Film Critics Circle” per Così
mi piace la Martin è stata incasellata come un “Spike
Lee al femminile”. A lei, che deve avere un caratterino non proprio facile, la cosa non è piaciuta e
ritiene di essere stata ostracizzata da questo meccanismo. È proprio la condanna più controversa del
black cinema; il fatto, cioè, di essere incasellato a vita
dentro un meccanismo di nicchia (fare film di neri
per i neri) che non permette di bucare la barriera
del mercato. Eppure proprio Spike Lee con Lola
Darling nel 1984 aveva proprio fatto questo… La
lotta per i diritti civili di cui si accennava all’inizio è
parte integrante di questo percorso di identità, differenze e diaspore (le origini africane) che si complica ulteriormente a causa delle contraddizioni del
mercato e della distribuzione.
(Ringrazio Alberto Rancan per le preziose indicazioni sul blues. Feeling good is easy, Lord, when you play
the blues)
Costanza Salvi
accenna nel film: Muddy Waters che ruba il chitarrista ad Howlin’ Wolf, Little Walter che spara ad un
tizio colpevole di portare il suo nome, la taccagneria
di Chuck Berry e la sua bravata con la ragazzina, la
dipendenza dalla droga di Etta James, la dipendenza
di tutti dalle donne, Leonard Chess colpito da un
infarto subito dopo aver lasciato la sua casa discografica… Il film accenna, come in un patchwork, a
tutti questi episodi ma lo fa freddamente. L’intento
di fare un biopic collettivo è interessante ma si rischia di perdere l’affezione per il personaggio. Peraltro la regista è stata anche criticata in America
per aver reso in maniera edulcorata e “hollywoodiana” la verità letterale: che dire per esempio del
fratello di Leonard, Phil Chess con cui venne lanciata l’omonima casa discografica? Ma, in fondo, questo
realismo ad oltranza al cinema non fa un po’ ridere?
Non penso che i vizi del film siano questi. Forse il
suo più grande difetto è quello di non aver scelto
nessuna posizione o attaccamento per ciò che racconta. L’aneddoto non basta a rendere accattivante
una storia, l’appeal del blues nemmeno, a meno che
non si abbia una piena intenzione documentaristica. (A questo proposito è da vedere assolutamente
il ciclo sul blues voluto da Scorsese, The Blues
La Sera della Prima /
129
Martyrs
di P ascal L augier (F rancia / C anada , 2009)
Pascal Laugier è il nuovo campioncino dell’horror,
esponente di quella generazione cresciuta sfogliando Starfix e alimentando i nuovi moti parigini da
jeune cinèphile, quelli combattuti per la rivalutazione
di cineasti come Fulci, Carpenter e Argento,
per intenderci. Dopo Saint Ange (2004), il regista
sembra aver raggiunto la maturità con il disturbante
quanto disturbato Martyrs (2008), frullato di carne e ketchup al retrogusto di acqua santa. Nel 2008
al Film Festival di Roma si è presentato mostrando
come curriculum: un verboso dibattito sulla censura che ha scosso l’esagono, il massimo del divieto
come particella nobiliare, la mancata professione di
coscienza del produttore Richard Grandpierre
che aveva inizialmente rifiutato la sceneggiatura per
poi fare mea culpa all’altare del dio denaro (in alcune religioni chiamato libertà d’espressione).
Oggi si ripropone in 62 sale italiane accompagnato
dal biglietto da visita che millanta lo status di film
più crudo di sempre
e il record di ko tecnici da parte degli
spettatori d’oltralpe.
Le credenziali sono
ottime per un film
che si ama o si odia.
Per alcuni film di denuncia, per altri ennesimo clone del più
becero scannatoio
impacchettato per
irritare e disgustare
gratuitamente. Non
un semplice torture
movie e, nonostante
il fascino delle due
vergini di Laugier,
ben poco che riconduca al torture porn
oggi tanto in voga.
Qualche pelo adolescenziale e un bacio saffico, ma niente più. Non ci sono
gatti che leccano
colli mozzati a mo’
di prosciutto crudo
come in Hostel.
Non si ride. Comun130
/ La Sera della Prima
que, diaframma e muscoli contratti assicurati, offre
Laugier. Perché il ritmo serrato, l’inizio in medias res
ed un montaggio a spigoli vivi non lasciano davvero
un attimo di tregua. Immagini sgranate da Le déjeuner sur l’herbe familiare per l’inizio del film, se non
fosse per il fatto che Lucie (Mylène Jampanoï) è
appena scappata da un inferno post-industriale brevettato Dottor Mengele e come Lola corre, ma non
per salvar il proprio ragazzo, ma la pelle. Metafora
affascinante visto l’esito del film. Due protagoniste,
due storie e due anime. Attrazione degli opposti. La
vendetta di Lucie, che trova dopo anni i propri carnefici e decide di farne carne trita, pare costruita sul
più tipico trattato di esoterismo che ripiega sullo
psicologico: storia splatter di fantasmi (della mente)
che guarda all’horror asiatico di Hideo Nakata e Takashi Shimizu, dei loro The Ring e Ju-On. Quindi
carnival orfico di mostri antropomorfi e bambine in
decomposizione dalle pose disumane. La passione di
Anna (Morjana Alaoui), novella Giovanna d’Arco, dramma psicologico – benché a patirne sia direttamente il corpo – con
virata misticheggiante
finale. Kammerspiel da
Grand-Guignol in cui
ambienti claustrofobici
e claustici diventano la
Tiffany di parure di celle, catene e altri gingilli
agghiaccianti che divertirebbero tanto Eli Roth
e amiconi. Dopo Saw,
ogni volume solido –
non me ne voglia Boyle
– pare potersi dilatare
all’infinito mostrando
al proprio interno un
alveare di appartamenti,
stanze, segrete, celle. Il
sogno delle immobiliari
di Delhi.
Le cose paradossali a
questo punto sono tre:
Laugier insiste nel dire
che ha fatto il film per
studiare l’essenza del
Male; il film anche nella
sua eccessiva tracotanza mantiene una certa
logicità, senza dover
ricorrere allo spiegone
finale come molti horror contemporanei, vedi Visions (Luigi Cecinelli, 2009); si tratta di un ottimo
film di genere. In un’epoca in cui le
donne hanno raggiunto le quote
rosa anche per categorie sindacali
come killer, presidenti, ministri, eroine, vendicatrici, Laugier le iscrive di
forza all’albo del martirio. Il regista
sa perfettamente rapportarsi con il
senso di colpa femminile, il rancore,
la vendetta fredda e meditata. Sono
tutti arredi notevoli nell’ambiente
asettico ritagliato da una fotografia
dai colori freddi. Quando il tutto
diviene troppo artificioso stempera i toni con una
bella spruzzata di sangue, perché diamine si tratta
pur sempre di un horror e le emoglobine qui non
sono mai superflue. Rilettura europea del male che
valica i confini manichei, per approdare ad una lucida follia. Non c’è la vena politica di Frontieres, né
la giustificazione a suo modo classista di Hostel
per cui un gruppo di ricchi borghesi può comprare
la vita degli ultimi boyscout con il tarlo del tacco 12.
Nulla a che vedere con il Salò pasoliniano. Il fascino
discreto della borghesia qui rasenta la stupidità del
suicidio lemming: una setta – tengono a precisare
laica - di vecchi facoltosi martirizza giovani fanciulle
per sapere cosa c’è dopo la morte.
Un tempo per esorcizzare la morte
bastava un lifting, nei casi più drastici un patto col diavolo di turno.
Poco importa se questo può portar
via diciassette anni e che per alcuni
di loro l’esperienza nel frattempo
sia diretta e non mediata. Ossessione per gli occhi, thanatografia
escatologica sulla scia del Girolamo
Fumagalli di Imago Mortis (Stefano Bressoni, 2008) con dubbio
finale. Anche perché stavolta la malcapitata di turno è sopravvissuta e
a mollo in una vasca di formaldeide.
Ma l’ultima cosa da fare in un film horror con pretese trascendentali è porsi domande e farsi irretire
nella facile trappola della spiegazione multipla. Finale un po’ compiaciuto nella sua catarsi escatologica
che rasenta follia ed imbarazzante demenza, ma del
resto dopo il fallimentare quanto millantato avvento
millenaristico ci si riprova con l’Era dell’Acquario.
Le sette sono il piatto forte e Borderland (Zev
Berman, 2007) è la portata (fredda, visto l’anno
d’uscita) successiva.
Luca Colnaghi
La Sera della Prima /
131
a night
at the opera
Il “papi” di Donizetti e
l’amarezza dell’amore
senile
Convince l’allestimento del Don Pasquale, che riattualizza la storia in chiave contemporanea, dimostrando che i rapporti tra potere e piacere non sono cambiati molto, nei
secoli.
Don Pasquale di Gaetano Donizetti –
Teatro Comunale di Bologna (10 – 17
Giugno 2009)
L’amore senile per una giovane donna è sempre stato un tema molto caro all’opera buffa. Viene subito in mente la Serva Padrona di Pergolesi, maestro
nel dipingere sulla scena con sbeffeggiante ironia, la
sconfitta dell’uomo vecchio e potente dominato e
ridicolizzato dalla bella e scaltra serva. O l’umiliazione di Bartolo nel vedersi sfuggire la bella Rosina
nel Barbiere di Siviglia di Rossini. Nel tempo, questo
quadretto, diventato presto uno stereotipo, si è arricchito di drammaticità, salvandosi dalla piattezza
dello stereotipo e il Don Pasquale di Donizetti rappresenta un ottimo esempio di questa evoluzione.
Da situazione comica, l’attrazione per una donna da
parte di un anziano signore, si trasforma in una tragicommedia in cui i personaggi soffrono le situazioni
che procurano ilarità. La delusione, il rimpianto di
Don Pasquale quando, dopo il matrimonio, prende
coscienza di essere un “povero sciocco” che è “tradito, beffeggiato”, si tingono di tristezza, rendendo
amara la dolce e cinica risata. All’epoca dei “papi” e delle escort d’alto bordo, il
“dramma buffo” del compositore bergamasco sembra sia stato scritto l’altro ieri, tanti sono i parallelismi che richiama alla mente. Nell’allestimento
presentato a chiusura della stagione d’opera del
Comunale di Bologna, la regia di Alfonso Antoniozzi,
attualizza la messa in scena, rendendo ancora più
evidenti le similitudini. Il vecchio possidente si trasforma in un potente alto borghese vicino al Vaticano (con tanto di bandiera bianco-gialla esposta in
casa), mentre il nipote Ernesto diventa un giovane
immaturo appiccicato al suo Nintendo portatile, innamorato di Norina, una prostituta che accetta il
gioco del matrimonio-beffa propostole dal Dottor
Malatesta, che qui veste l’abito clericale. L’intreccio tra potere e piacere si concretizza nel
decisionismo di Don Pasquale, consapevole delle
possibilità che offre la sua appetibile ricchezza, ma
anche nel cinismo di Norina-Sofronia, pronta a rivendicare i diritti acquisiti appena celebrato il matrimonio. Una scena vista e rivista sui magazine di gossip che fotografano la vita dei potenti, immortalata,
soprattutto grazie alla musica di Donizetti, in tutto
il suo carattere grottesco. Antoniozzi è un cantante prestato alla regia, allievo di Sesto Bruscantini e
volto noto dell’opera buffa, dunque perfettamente
a suo agio con il capolavoro di Donizetti, cui dona
una brillantezza coinvolgente (anche se non sempre supportata dall’orchestra, diretta dal giovane
triestino Leonardo Vordoni) che esalta la presenza
scenica di Michele Pertusi, apprezzabilissimo nel saper conciliare un’ottima mimica da attore comico
ad una voce di basso piena ed espressiva.
Una voce che sovrasta quelle degli altri personaggi,
quasi tutti giovani pescati dalla Scuola dell’Opera,
bravi ma ancora un po’ acerbi per donare il giusto
spessore ai personaggi donizettiani. La scenografia,
povera ed essenziale, è costruita su due grandi cubi
che, trascinati da una servitù che entra ed esce dalla
storia, svolgendo anche il compito di “facchinaggio”
(bello il contrasto tra i loro abiti da cortigiani settecenteschi e l’ambientazione evidentemente attuale
dell’opera), costituiscono le diverse ambientazioni
delle scene. Scene che in alcuni casi trasbordano
dai luoghi chiusi (escono dai cubi), come all’inizio
dell’atto terzo, quando una Norina ormai all’apice
della sua foga consumista, occupa tutto il proscenio
con modelli di abiti e diamanti acquistati con i soldi
dello sconsolato e rassegnato Don Pasquale. Un pubblico non molto numeroso (complice il caldo o le scelte del cartellone di quest’anno?) ha di-
mostrato di gradire. Qualcuno avrà pensato, mentre
si chiudeva il sipario :”e anche questa è fatta!”. La
stagione di quest’anno, particolarmente minata dai
problemi interni ed esterni al Comunale, dagli scio-
peri e dai tagli, è riuscita ad arrivare al capolinea,
seppure con prospettive future ancora da definire.
Daniele Follero
a night at the opera /
133
i cosiddetti
contemporanei
Duo Alterno
Contemporaneamente alterni
Esplorare tutti i meandri della musica dei compositori italiani del Novecento: il Duo
Alterno ha un obiettivo molto chiaro, che affonda le sue radici in uno studio filologico
dell’opera d’arte
Molti compositori viventi (tra cui Ennio Morricone e Giacomo Manzoni) hanno scritto per
il loro Duo Alterno, una formazione da camera che
si impone nel panorama della musica d’arte italiana
con progetti sempre più ambiziosi. Come La Voce
Contemporanea In Italia, ciclo di registrazioni (giunto al quarto volume) dedicato al repertorio vocal-cameristico nostrano. O come l’ideazione
della “foto-musica”, un procedimento compositivo
che riflette, da un’angolatura inedita, il rapportro tra
suono e immagine. Tiziana Scandaletti e Riccardo
Piacentini sono personaggi interessantissimi e
molto competenti, con i
quali è stato affascinante
e costruttivo conversare
dei più svariati temi legati al mondo della musica
“cosiddetta contemporanea”. Immagino siate partiti da studi classici.
Qual è stato, invece,
il vostro primo approccio alla musica
cosiddetta “contemporanea”? E come
mai avete scelto di
specializzarvi in questi repertori? Tiziana: Certo, studi
classici, liceo e università compresi. Alla musica
contemporanea mi sono
avvicinata a Venezia negli anni ’80, collaborando
con amici compositori… Riccardo: … mentre nel mio caso i primi contatti sono avvenuti tra la fine degli anni ’70 e i primi
’80, quando intercettai i corsi estivi di Sylvano
Bussotti (a Sargiano) e di Franco Donatoni
(all’Accademia Chigiana di Siena). Con quest’ultimo
ho frequentato quattro anni no stop di corsi e gli
devo moltissimo. Tiziana: Insieme, come Duo Alterno, la scelta di
specializzarci nel repertorio contemporaneo è stata
quasi d’obbligo. Io provenivo da studi universitari di
Filologia, oltre che da quelli di Canto, e Riccardo
aveva studiato pianoforte e composizione. Risultato:
se volevamo collaborare insieme, non rimaneva che
mettere insieme le nostre rispettive forze e competenze. L’atteggiamento del filologo che lavora sui
manoscritti, calza alla perfezione con i nuovi segni
della musica contemporanea e con la passione e il
rigore che questa musica richiede. Sono ormai 12 anni che suonate insieme. In
che modo è cominciato questo vostro rapporto artistico? Riccardo: In parte la risposta sembrerebbe già
contenuta nella precedente, ma in realtà, prima di
formare il Duo Alterno, la nostra collaborazione era
già piuttosto solida, in quanto Tiziana eseguiva spesso mie musiche. Anzi io, a partire dal 1992, componevo le mie musiche quasi esclusivamente per la sua
voce! Tiziana: Sì, erano pezzi per voce sola (come Fugitives.Tre Frammenti da Baudelaire) o per voce e nastro
magnetico (come 7x7+7. Otto Filastrocche Per Voce
Di Mamma) o per voce e ensemble o ancora per
voce e orchestra (come L’Aura per soprano, flauto e
orchestra). Questo tipo di collaborazione continua
tuttora, e infatti spesso io eseguo brani di Riccardo… Riccardo: … ma dal 1997 abbiamo deciso di aggiungere qualcosa di importante alla nostra collaborazione, costituendo il Duo Alterno e dando il
via a una certa “irrequietudine geografica” che ci
accomuna: abbiamo cominciato a viaggiare, praticamente in tutti i continenti, Australia compresa, proponendo un repertorio insolito, ma anche straordinariamente affascinante, di musiche italiane del ‘900
e contemporanee… Tutti conosciamo le difficoltà che si incontrano (in qualsiasi ambito musicale) nel riuscire ad intraprendere una carriera professionale. Come riescono musicisti come
voi a vivere di musica pur avendo scelto un
repertorio affascinante quanto “impopolare”? Riccardo: L’insegnamento in Conservatorio è una
base economica, oltre che formativa, da cui noi non
possiamo prescindere. Ma i concerti non sono certo un puro divertimento, e trovarli comporta a sua
volta un grande lavoro che
richiede tempo, coerenza,
stabilità emotiva ed anche
una buona predisposizione a livello organizzativo
e manageriale. Per “coerenza” intendo la volontà,
l’energia di proporre un
repertorio in cui si crede
fortemente, per il quale
ci si sente preparati e di
cui si è sicuri che non deluderà le aspettative del
pubblico più sensibile e
della critica. Noi non crediamo che fare cultura sia
una cosa “comoda” e necessariamente “popolare”
(nel senso di non impopolare). Quali sono le principali differenze che
si possono notare,
a distanza di tanto
tempo, nel suonare
insieme? Sotto quali
aspetti siete principalmente cresciuti,
i cosiddetti contemporanei /
135
musicalmente? Tiziana: Tantissimi. La voce e il pianoforte, il canto e la composizione… sono binomi già di per sé
problematici e ti obbligano a crescere, modularti,
coabitare in modo non sempre facile e immediato.
Così, studiando ore e ore insieme, con un repertorio in costante espansione, non puoi che cambiare
nel corso del tempo. Quando ascoltiamo le nostre
prime registrazioni fatte come Duo Alterno (parliamo del 1998) e poi quelle più recenti scopriamo che
abbiamo maturato, ad esempio, una dimensione più
gestuale e teatrale del far musica. La nostra passione
filologica rivolta ai repertori del ‘900 è un’avventura sempre più imprevedibile e creativa (la creatività
è imprevedibile!), perché studiare a fondo qualcosa
vuol dire saperla reinterpretare. Riccardo: Sì, ci piace l’idea del “performer ermeneuta”, una specie di esploratore che scava nei meccanismi più nascosti della composizione e lo fa fedelmente e , insieme, con trasgressione. È possibile,
anzi irrinunciabile. È una sorta di sano “pregiudizio”,
come direbbe Gadamer, che sta alla base di ogni
lettura, per quanto seria e filologicamente fondata.
Se no, come si farebbe ad essere creativi? Ci sono dei compositori con le cui musiche
vi sentite maggiormente a vostro agio? Tiziana: Direi i compositori con cui abbiamo un
feeling e una frequentazione costanti, compositori
vivi e operanti (“viventi e scriventi”, come diceva di
essere Morricone quando, ottantenne, vinse l’Oscar
alla carriera) con cui possiamo direttamente confrontarci. Sarebbe lungo fare un elenco di quelli
che in questi anni ci hanno dedicato loro lavori, o
quanto meno ne hanno seguito o curato una versione per il nostro Duo. Faccio in primo luogo i
nomi di Giacomo Manzoni, Ennio Morricone, Sylvano Bussotti, ma abbiamo anche avuto la possibilità
di confrontarci con Luciano Berio, Goffredo
Petrassi… e tutta una nutrita serie di generazioni successive, da Solbiati a Vacchi, Cifariello
Ciardi, Gentile, Bosco, ecc. E poi c’è il repertorio italiano da camera del primo ‘900: parliamo
di Ghedini, Casella, Alfano, Malipiero… Dei
primi due abbiamo eseguito decine e decine di volte
brani come i Quattro Canti Su Antichi Testi Napoletani
o le Deux Chansons Anciennes, che traggono ispirazione dal folclore popolare rivisitato in chiave colta.
Un po’ come le successive Quattro Canzoni Popolari
di Berio, un nostro cavallo di battaglia che eseguiamo con le diverse cadenze dialettali richieste dai
testi di ciascuna canzone. Ecco, questo repertorio
”misto” ci piace moltissimo e, fra l’altro, piace anche
moltissimo al pubblico, incluso quello che sulle prime si dimostra prevenuto. Eseguire la musica di altri è una pratica di
per sé creativa, che presuppone uno studio,
un metodo di lavoro ed una successiva interpretazione. Come approcciate (tecnicamente, ma anche cognitivamente) ad una
nuova partitura? Riccardo: Ottima domanda che al suo interno
contiene già alcune affermazioni che condividiamo
in pieno. La creatività sul piano performativo non è
mai qualcosa di capriccioso, né una cosa da star hollywoodiane permalose e scostanti. Al contrario, richiede una grande disciplina e una strategia di azione
molto attenta, anche se spesso nascosta, tutt’altro
che esibita. È la parte del performer che non fa
spettacolo, l’arte di far sembrare facili cose che non
lo sono affatto, di portare alla luce ciò che alla luce
può arrivare solo in seguito a una lunga operazione
di scavo. Qualunque atto creativo, nella composizione come nella sua interpretazione, comporta ore e
ore, giornate intere di metodico lavoro. Un esempio
recente è stato per noi lo studio di due partiture
esemplari della vocalità da camera degli ultimi decenni: Lachrimae di Sylvano Bussotti e …Ed Insieme
Bussarono di Franco Donatoni. Il primo richiede una
totale ricomposizione, a partire però da una pletora
di elementi che vanno letti-intesi-fraintesi in modo
logico e conseguente, e quelli devono essere, non
altri. Il secondo, il brano di Donatoni, è un capolavoro di “strutturalismo anarchico”, ossimoro che
significa: la composizione nasce idealmente secondo
una concezione strutturalistica, ma l’esito finale – e
l’interpretazione non può non tenerne conto – ha
un sapore fortemente anarchico. “Anything goes”,
ma solo con quelle note, quelle durate, quelle dinamiche, quelle precise richieste espressive… per
un’apologia della libera anarchia. Un capolavoro che
sfida non certo solo il buon senso, ma addirittura il
senso. Per capire questo, bisogna respirarlo a pieni
polmoni e in modo continuativo: ne esci trasformato. Compositori del calibro di Giacomo Manzoni ed Ennio Morricone hanno scritto appositamente per voi. Da cosa è nato questo
interesse? Come si è svolta la collaborazione? Avete partecipato in qualche modo, al
processo compositivo? Tiziana: Nel caso di Giacomo Manzoni, è stata una
bella collaborazione con le Edizioni Curci a favorire
questa circostanza. Riccardo contribuiva, e contribuisce tuttora, alla Rassegna Musicale Curci e pubblicava e pubblica anche sue musiche per questa casa
editrice; così, quando Manzoni nel ’98 fu richiesto
di pubblicare per la Curci e noi eravamo in stretto contatto con lui per una comune partecipazione
al Festival di Musica Contemporanea di Vancouver
(dove il Duo Alterno fece il suo primo concerto),
nacque Du Dunkelheit a noi dedicato. Riccardo: Con Morricone, invece, dopo la prima
esecuzione di Grido per voce e orchestra, in cui
Tiziana era la voce solista, ci furono diverse esecuzioni parziali dei suoi Epitaffi sparsi nella versione
per voce e pianoforte. In un’occasione, che peraltro
non trovò sbocco immediato, la celebre coreografa
Lucinda Childs chiese a Morricone l’aggiunta di
alcuni piccoli preludi e postludi nel corso della composizione che avremmo dovuto eseguire a Losanna,
Parigi e altre sedi. Morricone scrisse per noi una
decina di micropreludi e postludi e noi, da allora,
eseguiamo gli Epitaffi sparsi in questa versione modificata per noi. La Voce Contemporanea In Italia contiene un progetto ambizioso: raccogliere i differenti stili vocali della musica italiana del
Novecento. Approcci diversi alla vocalità
che immagino abbiano richiesto una notevole disponibilità di adattamento a cotanta
i cosiddetti contemporanei /
137
varietà. Come avete affrontato, dal punto
di vista esecutivo, queste difficoltà? Riccardo: L’obiettivo era proprio quello, di dimostrare quanta varietà ci fosse nella produzione vocale-cameristica italiana d’oggi, ma anche rintracciare alcune linee-guida, perlopiù ignorate finora dalla
stessa musicologia, che permettessero una mappatura per così dire “più comprensibile”. Comprensiva
e comprensibile, insomma… Tiziana: … e così in ogni disco abbiamo lavorato intorno a un leit motiv, sostenuti non solo dalla
nostra ricerca ma anche dal contributo di musicologi come Quirino Principe, Paolo Petazzi, Carmelo
Di Gennaro, Stefano Leoni e Sandro Cappelletto. Il
primo CD indaga i rapporti tra compositori italiani
e grandi poeti loro contemporanei (tipo Petrassi-
Quasimodo, CorghiUngaretti, Scelsi-Aleramo, ecc.); il secondo
approfondisce il discorso
delle “contaminazioni”
tra generi e lingue; il terzo riunisce compositori
che hanno lavorato su
testi in lingua tedesca; il
quarto, compositori che
traggono ispirazione nei
loro brani da grandi autori del passato.
L’aggettivo “contemporaneo” associato
alla musica, contiene in sé molte contraddizioni,
anche
se, spesso, è venuto a
coincidere con l’arte
dei compositori del
Novecento.
Come
definireste voi il significato di questo
aggettivo? Che cos’è,
per voi, “contemporaneo”? Riccardo: “Contemporaneo” è un attributo
doppiamente relativo: va
riferito a due sostantivi che ne modificano di
volta in volta il senso.
Per esempio “la musica
contemporanea a Schumann” non era meno contemporanea di quella riferita all’oggi. Nel primo caso i due sostantivi di riferimento sono “musica” e “Schumann”. Noi sappiamo
che Schumann era un compositore non meno
avanguardista per i suoi tempi di quanto lo fosse
Stravinskij con il Sacre del 1913, ma in entrambi i casi non si può dare una valutazione assoluta.
Contemporaneo è ciò che accade qui, adesso, e che
non sarebbe potuto accadere prima semplicemente
perché non c’erano ancora le convergenze storiche,
culturali e sociali che oggi ci sono. Tiziana: Considerare la contemporaneità una prerogativa della musica d’oggi vuol dire assolutizzare
un termine che nella lingua italiana ha sempre valore relativo. Il che cambia totalmente la prospettiva e,
come minimo, disinnesca certi rigidi pregiudizi che
sono principalmente dovuti a non conoscenza. In cosa consiste il progetto “foto-musica”,
che vi ha visti protagonisti alla Biennale
Internazionale di Fotografia di Torino? In
cosa consistono i “foto-suoni”? Riccardo: Progetto è la parola giusta, perché si
tratta di un’operazione di ampio respiro che utilizza
reportage acustici da me registrati durante i viaggi
all’estero e spesso in situazioni anomale (i cosiddetti “foto-suoni”, intesi come fotografie acustiche
di mercati popolari, metropolitane, strade, mari e
oceani, fiumi, pioggia, vento, autobus, ecc.). Questi
oggetti sonori vengono trattati nella foto-musica
alla stregua dei fotogrammi di una pellicola cinematografica o, se si preferisce, di fotografie di un album
musicalmente organizzato. L’idea che sta a monte è
che qualsiasi suono, e dico qualsiasi, può farsi musica
purché ci sia dietro il pensiero di un compositore.
In questa avventura la voce di Tiziana ha un ruolo
insostituibile. Se non ci fosse lei, la foto-musica non
sarebbe mai nata. Quanto è importante, secondo voi, definire
dei confini in musica? Tiziana: Se si tratta di inscatolare i generi, non credo bisogni essere troppo rigidi. È necessario, però,
sapere che formazioni diverse comportano diverse
modalità di approccio all’arte e questo è una ricchezza le cui varie connotazioni vanno esaltate… Riccardo: come dice un filosofo a noi caro, Paul
Feyerabend: “conquistare l’abbondanza, non
semplificarla o ridurla a un preteso uno”, in altri
termini, evitare di omologarla per fini di strumentalizzazione. Ciò permette di valorizzare il molteplice,
ma anche di riconoscervi dei confini interni, non assoluti ma relativi, non dogmatici ma “liberi”, aperti,
modificabili. I confini ci sono, vanno riconosciuti e
studiati, ma a nostro avviso non devono servire per
costruire dei recinti o peggio dei ghetti, ma piuttosto per delimitare pragmaticamente i diversi ambiti
e poter agire in modo più efficace. Dopo La Voce Contemporanea In Italia
avete in programma altri progetti tematici
come questo? Riccardo: La Voce Contemporanea In Italia è giunta al quarto volume e non abbiamo intenzione di fermarci. Rimangono ancora molti autori che ci hanno
dedicato pezzi che non abbiamo ancora registrato e
il volume quinto sarà l’occasione per proseguire la
nostra perlustrazione… Tiziana: per il prossimo anno, vorremmo tornare
a esplorare il primo ‘900 prendendo spunto dalle
celebrazioni del Futurismo, per esplorare il movimento di segno contrario ad esso contemporaneo
(ecco che la parola contemporaneo ritorna con tutta la sua forza “relativa”). Mi riferisco al crepuscolarismo… Riccardo: … il nostro prossimo disco si chiamerà
proprio La voce Crepuscolare. Notturni E Serenate Del
‘900 e sarà un omaggio a Malipiero, Tosti, il Casella della dannunziana Sera Fiesolana, il Ghedini delle
Liriche di Pascoli, ecc. Un inno alla musica più poetica del primo ‘900, giusto per non dimenticare che,
accanto all’aggressiva propositività del Futurismo,
conviveva una dimensione diversa e non per questo
meno vera e rappresentativa. C’è qualche composizione o qualche autore
che non avete ancora eseguito, ma che vi
affascina particolarmente? Tiziana: Se la cosa andrà in porto come sembra,
studieremo presto un intero programma di Lieder
di Alban Berg, e la cosa ci fa un grande piacere.
Ma aspettiamo anche lavori da compositori italiani
come Luca Francesconi, Ivan Fedele, Nicola
Sani e altri ancora, perché vogliamo coinvolgere il
meglio della contemporaneità in Italia oggi. Un duo
per voce e pianoforte fa meno gola a un compositore rispetto a un grande apparato orchestrale, ma in
compenso è molto più agile e ha maggiori possibilità, secondo il nostro modo alternativo di vedere, di
infiltrarsi nel tessuto culturale e sociale odierno. Esiste un rapporto artisticamente privilegiato con qualcuno dei compositori con cui
avete collaborato?
Riccardo: Noi cerchiamo sempre di collaborare
con compositori “viventi e scriventi”. Poi, se come
nel caso di Ennio Morricone, è possibile instaurare
un rapporto continuativo, utile e costruttivo, è allora che nascono le situazioni “privilegiate”. Non le
scegliamo noi, ma nascono da una sintonia a tre: il
Duo Alterno e il compositore.
daniele follero
i cosiddetti contemporanei /
139
www.sentireascoltare.com