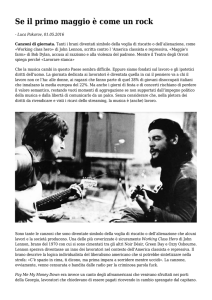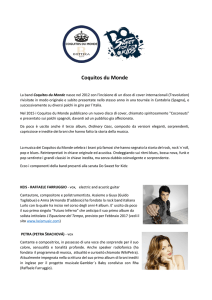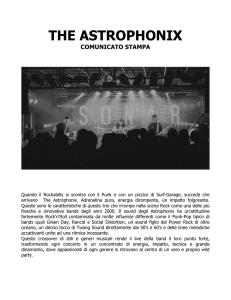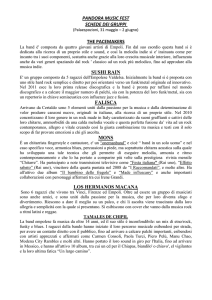digital magazine maggio 2010
La Questione Morale
Amor
Fou
N.67
UK d.i.y.
Goth Wave
Summertime
Hits
*Pixies*
Drunkdriver // Gayngs // Locrian // Evelyn Evelyn // John Grant // Audio Bullys
67
Sentireascoltare n.
Turn On
p. 4
Drunkdriver
5
Gayngs
6
Locrian
7
Evelyn Evelyn
8
John Grant
10
Audio Bullys
Drop Out
12
Amor Fou
20
Goth Wave Summertime Hits
28
UK DIY
Recensioni
36
Dirtmusic, Erikah Badu, Land Of Kush, Flyng Lotus, New Pornographers...
Rearview Mirror
92
The Afrosound of Colombia, Pixies, Jon Spencer...
Rubriche
88
Gimme Some Inches
90
Re-boot
104
Giant Steps
105
Classic Album
106
La Sera della Prima
SentireAscoltare online music magazine
Registrazione Trib.BO N° 7590 del 28/10/05
Editore: Edoardo Bridda
Direttore responsabile: Antonello Comunale
Provider NGI S.p.A.
Copyright © 2009 Edoardo Bridda.
Tutti i diritti riservati.La riproduzione totale o parziale,
in qualsiasi forma, su qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo,
è proibita senza autorizzazione scritta di SentireAscoltare
Direttore: Edoardo Bridda
Direttore Responsabile: Antonello Comunale
Ufficio Stampa: Teresa Greco
Coordinamento: Gaspare Caliri
Progetto Grafico
e
Impaginazione: Nicolas Campagnari
Redazione: Antonello Comunale, Edoardo Bridda, Gaspare Caliri, Nicolas Campagnari, Stefano Solventi, Teresa Greco.
Hanno
collaborato:
Giancarlo Turra, Marco Braggion, Gabriele Marino, Leonardo Amico, Fabrizio Zampighi,
Luca Barachetti, Stefano Pifferi, Andrea Napoli, Filippo Bordignon, Luca Barachetti, Salvatore Borrelli.
Guida
In
2
spirituale:
copertina:
Adriano Trauber (1966-2004)
Amor Fou
A
New York non ci sono soltanto opache sonorità
wave, eppure da tempo sulle strade della grande
mela non aleggiava una funesta aria di violenza sonora
come quella che sta montando recentemente. Oltre a
Blank Dogs, Vivian Girls e tutto il codazzo di band
indie/wave, per i vicoli della città che non dorme mai
scorrono fiumi di collera targati Twin Stumps, White Suns e appunto Drunkdriver. Gruppi che hanno in
comune, oltre ad un approccio noise e no wave al punkhardcore più viscerale, anche storie personali spesso
altrettanto violente: come quella di Michael Yaniro dei
Twin Stumps, selvaggiamente aggredito nel Queens per
pochi spiccioli, o quella, di natura opposta, del batterista dei Drunkdriver, recentemente citato in giudizio per
stupro. Un’accusa infamante che ha portato la band allo
scioglimento prematuro, proprio a ridosso dell’uscita del
secondo disco.
Nati sul finire del 2007 nel cuore della city, i Drunkdriver si fanno subito notare grazie all’album Born Pregnant in cui mettono a fuoco la ricetta di veemenza che
li caratterizza: registrazioni a bassa fedeltà, le urla scomposte di Mike Berdan, chitarre ultra-sature che veicolano
riff blues menomati dal muro di feedback, una sezione
ritmica brutale ed elementare che passa dal down-tem4
Gayngs
Turn On
Turn On
Drunkdriver
—Apocalypse Now in
NYC—
—Passati futuri—
Poco prima dell'usicta del
secondo album, si scioglie uno dei
gruppi più irruenti dell'hardcore
a stelle&strisce.
Il Glo-Fi ancora sugli scudi? Su
Jajaguwar l'esordio di un esercito
di innamorati.
po alle corse efferate dell’hardcore senza soluzione di
continuità. Otto brani in venti minuti, prima che arrivi
la scure finale di Cure For The Common Cold che estende la cifra a dieci caustici minuti di tortura sonora. Un
paio di singoli assassini (tra cui l’eccellente Firesale) ed
è tempo per una collaborazione al vetriolo con un altro
protagonista indiscusso del rumore più efferato: Mattin,
chitarrista del famigerato combo noise basco Billy Bao,
altro vorace propulsore di mondezza sonica.
List of Profound Insecurities è il risultato di quell’incontro furibondo, nonché una malevola creatura bifronte che elargisce massicce dosi di ansia ed angoscia senza
ritegno. È quindi comprensibile perché una label come
Load, da anni paladina del sound del trambusto urbano, li
abbia avvicinati per pubblicare il loro secondo full-lenght,
salvo poi ritirarsi di fronte ai vergognosi capi imputati al
batterista.
Ad oggi pare che sarà Parts Unknown a farsi carico
della release che già circola per la rete, ma nulla è dato
per certo, se non il mesto velo che ammanta il nome
del gruppo il quale, per liberarsene, non ha potuto fare
altro che seppellire le proprie spoglie, sicuro però che la
guerra del rumore sia ancora tutta da combattere.
Andrea napoli
P
oco importa se i kid meno pratici di blog specializzati e social network non faranno in tempo ad
accorgersene. Probabile che il glo-fi sia già moribondo,
se non addirittura già morto, dato che voci insistenti
parlano di palchi minori di festival stelle e strisce zeppe
di emuli di dubbia qualità dei vari Neon Indian, ma soprattutto di Memory Tapes e Tori Y Moi. Attenzione
dunque a scambiare i monitorati Gayngs su Jagjaguwar
con i vari campioncini in bassa fedeltà, loro che con le
cassettine smagnetizzate di proposito non hanno nulla a
che vedere e che dalle mode rifuggono, tenendosi però
una comune voglia d’effimero e di vacanza, costellate
dalle classiche pulsioni carnali da canicola isterica, travestite da inni all'amore universale.
Di differente inoltre c’è che questi ragazzi sono una
comune di quelle moderne come lo erano i Bran Van
3000 pur con intenti diversi: sono tutti dopolavoristi di
varia estrazione a cui piace utilizzare qualche moderna
tecnica pubblicitaria per farsi largo tra i media, come il
logo rivisitato dal simbolo della pace e la sua divulgazione attraverso tecniche di viral marketing con Vimeo.
Assieme formano un’internazionale della svagatezza vacanziera, in parte fregandosene della coerenza a tutti i
costi, mescolando tutto lo scibile per stilemi affini dai
Settanta ai Novanta inoltrati. L’esordio Relayted infatti,
è un coacervo di situazioni rilassate che vanno dal down
tempo alla new age, da timide fiammate soul a scampoli
free jazz, passando per l’inevitabile fascinazione psych e
addirittura qualche tendenza da boy band sfatta decorata da lustrini argentati e stille di trip hop piacione.
Ognuno ci mette del suo sotto l’egidia del capobranco Ryan Olson, un non-leader attorniato da metà dei
Solid Gold, un’insospettabile Bon Iver, quei mattacchioni dei Megafaun, i Leisure Birds e, tra gli altri,
pure un collettivo hip hop al completo (Dumtree)
all’insegna di una colonna sonora pronta a ricongiungersi
con tre generazioni di viaggiatori chimici. Il trip è di quelli
dove non sai mai bene quel che succederà: lascive linee
vocali, francesismi electro-pop (Faded High), stille di dub
impregnate di gustosissima melassa (Crystal Rope o The
Beatdown), esplosioni soul e gospel a detonazione ritardata, beat rotondi e dal groove appiccicaticcio, scopano
armoniosamente ad ogni angolo e il fumo del migliore
joint sul mercato si trasforma in nuvolette a forma di
cuoricino. Quanto basta per certificare Relayted come
un Peace & Love da veri material boy.
Giampaolo Cristofaro, Edoardo Bridda
5
—Quello stesso nero
pesto mondo—
Quando accogliere blastbeats e voci in scream nel
proprio droning è l'inevitabile
conseguenza di un tragico sentire
comune.
C
ontaminazioni tra metal e rumore se ne sono viste a centinaia negli ultimi 10 anni e lasciando da
parte Stephen O'Malley e tutti i suoi progetti, tra i vari
fenomeni di musica brutta significativo è un manipolo
di musicisti diversi per provenienza ma che con il truce universo nordico hanno finito per condividere una
visione del mondo, fino a trasformare la convergenza in
una fusione inevitabile. Dominique Fernow è stato (ed è)
uno di questi. Se propriamente black è la sua band Ash
Pool, Prurient rappresenta il moniker di una personale interpretazione dello spirito profondamente tragico
che è l'eredità più sigificativa di gente come Burzum o
Abruptum. Un'oscura genealogia che va oltre i paletti
di genere, la stessa di cui Locrian, ovvero Terence Hannum alle chitarre e André Foisy ai synth/voce, rappresentano oggi un passo successivo.
Provenienti dalla Florida il primo e Buffalo il secondo,
trovano a Chicago un terreno di sussistenza (lavorano
come assistenti al Columbia College) e una pianta stabile per suonare. Inizialmente l'intero mondo sonicoimmaginativo è necessariamente limitato dal ristretto
set-up: attraverso grevi drones e urticanti reiterazioni,
i due descrivono paesaggi urbani in rovina, architetture
abbandonate da un umanità in estinzione della cui scomparsa non nascondono lucide rassegnazioni. Le visioni,
6
spesso un'intensità stordente, raggiungono la massima
espressione nel nastro Drenched Lands, un album difficilmente inquarabile in una qualsivoglia mazzo e proprio
per questo destinatario di consensi e attestati di stima.
E' più per quella che per ragioni meramente soniche
che i ragazzi si ritrovano a suonare con i chicagoani Bloodyminded, furioso act Power Electronics di Mark Solotroff per l'etichetta del quale - la Bloodlust! - finiscono
per incidere e ricongiungersi in quello che è chiaramente
un percorso verso l'estremo. Territories è la risposta: ai
due s'aggiunge, oltre allo stesso Solotroff, Bruce Lamond
(sax della band avant-metal Yazuka), Andrew Scherer
(già batterista nei Velnias) e Blake Judd (chitarrista dei
Nachtmystium), quest'ultimi due provenienti dalle più
influenti band del USBM.
Ne viene un fluido droning con sfuriate grind e voci
in screaming, eterogeneo ma coerente e soprattutto il
primo passo per realizzare l'ambizione di sintetizzare
un sound che scavalca, inglobandoli, gli stilemi di genere
restituendoci uno squarcio di quello stesso nero, pesto
mondo.
Leonardo Amico
Evelyn
Evelyn
Turn On
Turn On
Locrian
—L'Imaginarium di
miss Palmer—
Sospesa momentaneamente
l’attività con i Dresden Dolls,
l’artista bostoniana si imbarca in
un nuovo e bizzarro progetto artpunk cabaret.
C
hi sono Eve e Lyn Neville? Secondo Amanda
Palmer, si tratterebbe di una coppia di sorelle siamesi, le cui vicende incrociano crudeli temi di formazione dickensiani con uno spiccato gusto surrealista. La loro
sensibilità musicale, temprata da un passato fatto di abusi
e una carriera da fenomeni da circo, frutta oggi un album
che è l’equivalente sonoro di un film di Terry Gilliam
virato al gotico.
La somiglianza di una delle due sorelle con la stessa
Palmer tradisce, se ce ne fosse bisogno, la vera natura del progetto. La bella bostoniana, dismessi il ruolo di
Dresden Doll, dà nuova foggia al teatrino dell’assurdo
allestendo un concept che avrebbe fatto la felicità del
Tod Browing di Freaks. Ad accompagnarla c’è l’amico e
folk busker Jason Webley, unito alla ragazza in un connubio che dal vivo non sarà meramente artistico: “Lo
show presenta le due sorelle unite per un fianco. – ha
affermato la Palmer – Sono incredibilmente talentuose e
sono in grado di suonare di tutto: piano, ukulele, chitarra
e batteria”. Il che, considerando che a esibirsi saranno i
due artisti costretti in un costume che permetterà loro
di usare una mano a testa, lascia immaginare qualcosa più
vicina a un’esibizione circense che a un vero e proprio
concerto.
A trionfare è soprattutto la grottesca teatralità del
duo.“il rock ha bisogno del teatro, perché il rock è teatro.
Quando formammo i Dresden Dolls, ai tempi dell’esplosione di Strokes e White Stripes, la gente guardava a noi
come ad un gruppo di poveri disadattati. Fortuna che col
tempo, e con la crescente popolarità di act come Arcade Fire, Patrick Wolf e Cocorosie, i freaks travestiti
sono passati al contrattacco”, sottolinea Amanda.
In questo senso la partecipazione al progetto di alcuni
dei più curiosi personaggi del pantheon pop suona quasi
come una chiamata alle armi. L’elenco degli ospiti, infatti,
costituisce uno dei più bizzarri namedropping della recente discografia: fra gli altri spiccano il nome di Tegan &
Sarah, “Weird Al” Yankovic, Andrew WK, lo scrittore e
fumettista, nonché fidanzato della Palmer, Neil Gaiman e
una certa Frances Bean Cobain, meglio conosciuta come
la figlia di Kurt. La loro è chiramente una sponsorizzazione: tutti cantano un verso della canzone MySpace.
“Tutti hanno voluto legare il proprio nome a quello del
progetto – ha spiegato la Palmer – Dopotutto si tratta
di una cosa talmente folle che ha bisogno di tutto l’aiuto
possibile per funzionare”.
Diego Ballani
7
Turn On
John Grant
—Ossessione e
redenzione—
Cantautorato settanta, ironia e
leggerezza per l'ottimo esordio
dall'ex cantante degli Czars. Con
il fondamentale aiuto dei Midlake.
8
U
n’ossessione è alla base di Queen Of Denmark,
l’esordio di John Grant, ex cantante degli americani Czars, cult band denveriana di fine ’90. L’ossessione
è quella del boss della Bella Union, Simon Raymonde,
che scopre il gruppo del quale Grant è cantante e leader, e lo mette sotto contratto principalmente per lui, e
quella dei Midlake, che lo scelgono nel 2006 quale supporto del loro tour USA che promuove The Trails Of
Van Occupanther. Entrambi ne restano colpiti, giudicando un peccato che il songwriting essenziale di Grant
rimanga appannaggio di pochi intimi. Proprio i compagni
di etichetta Midlake si fanno carico dell’esordio, suonandolo, producendolo e coarrrangiandolo, e ritardano
per questo le registrazioni dell'ultimo The Courage Of
Others uscito pochi mesi fa. “Abbiamo sentito The Czars
durante il nostro primo tour a Londra - ricorda il bassista
dei Midlake Paul Alexander – e la voce baritonale di John è
stata la prima cosa che mi ha colpito. Ma siamo veramente
rimasti affascinati quando l’abbiamo visto live tempo dopo e
voluto come opening act in patria, fino a portarlo con noi a
Denton per realizzare il disco”.
Dopo la vicenda altalenante con gli Czars, conclusasi
nel 2004 alla fine di un sodalizio durato quasi 15 anni,
il Nostro medita addirittura di abbandonare la musica.
Si trasferisce quindi armi e bagagli a New York, dove
prosegue e termina gli studi di russo (parla correntemente anche il tedesco e lo spagnolo). E’ un po’ dopo
che riprende sporadicamente a far musica, e proprio
suonando di spalla a gruppi come Flaming Lips viene
notato dai Midlake, e il resto è noto.
E’ un songwriting piuttosto classico quello dell'americano, che in Queen Of Denmark accentua ulteriormente la matrice Settanta: siamo dalle parti di Harry
Nilsson e Carpenters, con un versante anche soft
pop alla Supertramp e E.L.O., (via Beatles) lambendo qua e là gli amici Midlake, e smarcandosene anche
grazie a un intelligente jazz rock (Steely Dan) e al
country primo amore sempre presente in sottotesto, si
veda la passione per Patsy Cline (“ai tempi della scuola
non mi vergognavo di amare la Cline, per anni ho cantato
dietro alle sue canzoni”) e le sonorità alt-country dell’ex
gruppo. Si aggiungano arrangiamenti raffinati, realizzati
con la “backing band” di lusso, un gusto pop alto e una
scrittura varia, fatta di canzoni per piano, arricchite da
synth settanta e archi, in cui predomina la ballata ma
non solo e un gusto lievemente barocco che fa pensare
al prog e a Flaming Lips e affini.
Del resto, a proposito di ossessioni, John Grant è
perfettamente in argomento, sia quando si tratta di tormenti amorosi, sia quando queste derivano da postumi
da dipendenze, come quelle per alcol e cocaina consu-
mate nel corso dell’ultimo decennio, quando è anche arrivato sull’orlo del suicidio, come ha rivelato di recente
a Mojo. Queste esperienze sono presenti e trasfigurate
nelle canzoni, attraverso una meditata impronta ironicosarcastica e su tutto una leggerezza di fondo, da sempre
la chiave di lettura del suo songwriting, che lo distingue
dalla drammaticità di alcuni e lo avvicina a personaggi
quali Morrissey e Scott Matthew.
La scrittura sincera riflette tutto il disagio di crescere in provincia, in questo caso un piccolo centro del
Michigan fino alla preadolescenza, e poi Denver in Colorado – dove si era trasferito con la famiglia -, con le difficoltà e le esperienze del caso, di cui tratta senza mezzi
termini nel disco. Così i temi portanti sono le difficoltà
di crescere essendo gay in un ambiente familiare religioso (JC Hates Faggots) e in un soffocante piccolo centro,
gli incontri e le esperienze successive sin dal trasloco in
Colorado. “Ai tempi della scuola, poco dopo il trasferimento
a Denver ero un pesce fuor d’acqua, mi sentivo come Sigourney Weaver che si batteva contro gli alieni, come se fossi
perciò su un altro pianeta. Mi piace lo sci-fi e film come La
mosca e Alien mi fanno assaporare l’idea della metamorfosi”
(Sigourney Weaver).
Come racconta, con il supporto di Paul Alexander
e compagni si è sentito completamente libero di esprimersi. “Non c’è niente di superfluo o inutile nel disco, ho
rivelato chiaramente dal mio punto di vista dove sono arrivato e chi sono come persona, e sono fiero di esserci riuscito
al meglio. Almeno mi è stata data l’occasione di affrontare
il dolore, invece di esserne spaventato e non riuscire a farvi
fronte”. Ecco che allora tutto assume un sapore di sublimazione e insieme di redenzione, una battaglia contro i
propri fantasmi interiori, su tutti la depressione e la dipendenza (“l’intero album è sulla dipendenza”) e l’essere
riuscito a tenervi testa. E non è poco.
Teresa Greco
9
Turn On
Audio
Bullys
—London Dreamers
Back Again—
Più in alto della Torre Eiffel: la
nuova fatica di Simon Franks e
Tom Dinsdale riporta il meshrock nell’house.
A
udio Bullys il ritorno. E non poteva esserci un
tassello più nobile per continuare la tradizione
UK degli inserti rock nei tessuti dance. Il nuovo lavoro
Higher Than The Eiffel, pari per freschezza e realness
all'esordio di sette anni fa, sembra culminare una nouvelle vague che dai Crookers in poi non conosce soste.
Le commistioni di base rimangono le stesse che
animarono i Chemical Brothers, i primi Basement
Jaxx, gli Orbital e tanti altri: hip-hop, r'n'b, rock, punk e
pop in dialogo con house e techno, ma il mix è senz'altro differente. La seconda generazione di rocker postrave ha ritrovato nei laser verdi e nei synth marci un
fascino di guerriglia retrò che è anche il punto d'unione
e di riconoscibilità di tutto il non-movimento. Le hit del
dopo sono Future Belongs To Us, Only Man (dal taglio in
10
acido-Justice), Shotgun (la motordeep di periferia) e
una traccia come Kiss The Sky dove il french touch si
schianta contro una prosopopea che gli U2 oggi si scordano.
Eppure al menù acido, il duo londinese preferisce
attingere con mano sedata dacché c'è tutta una tradizione alla quale, da buoni inglesi, si deve attingere. Simon Franks, al telefono da Londra, ce lo confessa a
mò di preambolo "qualche cambiamento ci sarà anche
stato ma il suono sta seguendo la stessa formula". E se alchimia dev'essere, una delle costanti nell’equazione ci
porta dritti a parlare di un'altra grande rock band on
E: i Prodigy, capostipiti del rave da palco dei Novanta,
padri putativi pure per dei Bullys che proprio da adolescenti nei Novanta sentirono l'ebbrezza di quel periodo
sonico nel quale mescolare qualsiasi suono senza barriere,
sembrò la cosa più eccitante e inaudita del mondo.
"I Prodigy ci hanno portato dentro la musica", e non il big
beat e tutta la stagione mainstream di fine millennio che
trasformò l'affare dance in un fumetto post-modernista.
Di Fat Boy Slim, che di quell'ondata fu il capostipite, i
Bullys non hanno preso molto e la cosa non ci soprende.
C'è stato pure un incontro dal vivo ("in un party in Sud
Africa, abbiamo preso un drink") senza che questo abbia
prodotto null'altro che stima e consapevolezza di appartenere a modi diversi d'intendere l'impasto sonico.
Più vicini ai londoners dunque, due tamarri come i Crookers. Vicini per attitudine mesh e mattanza dancefloor
ma, anche lì c'è un distinguo, l'hip hop. A Franks piace
come si atteggiano, il loro nome, quello che fanno; dice che
sono proprio bravi ma crede pure che ci sia un forte link
con l’hip-hop che i Bullys non hanno.
Loro vengono dall'house, i Crookers da quell'altra grande famiglia black questo è il punto, e inoltre, non dimentichiamo che c'è tutto l'amore per l'Haçienda e la
Madchester drogata degli Happy Mondays che viene
fuori forte e chiara nell'album. Se c'è un'altro contatto black, condito magari di chitarre indie, è quello con
l'r'n'b slavato e imbottito di E di Shawn Phillips le cui
movenze e slaking sembrano aggirarsi come uno spettro in quasi tutte le song. Certo, non è il solo: ospiti del
disco, e questa volta in carne ed ossa ci sono addirittura
componenti dei Madness, il cui cantante Suggs, collaboratore assieme al tastierista Mike Barson in quasi tutto
l'album, sembra aver messo più di uno zampino in brani
dagli andamenti ska come Daisy Chains e Goodbye. Franks minimizza ("in quelle canzoni Suggs non ci ha messo direttamente le mani"), ma è anche un ottimo diplomatico
("la sua influenza indiretta c'è comunque stata"), nonché
un grande estimatore della band di Camden Town e con
lui, più che continuare con i paragoni con altre formazioni, è meglio fare un salto temporale e tracciare delle
prospettive.
Dall'esordio Ego War del 2003, cos'è cambiato e in
cosa sono cresciuti gli Audio Bullys? Cresciuta in produzione, abilità nel dosare il mix, sono le prime cose che
vengono al microfono ma è dal un punto di vista della
scrittura, della capacità di scrivere canzoni, che Franks è
moderatamente fiero: "Ho cercato di spingermi oltre con
i testi, ammette e Daisy Chains è una delle canzoni che
preferisco da questo punto di vista. Con Higher Than The
Eiffel siamo tornati a scrivere canzoni con il cuore per farci
rispettare dalla gente che vogliamo che ci rispetti".
E naturalmente su quel "tornare" c'è tutto il lascito
di una polemica oggi ricomposta che risale ai tempi di
Generation, album che successe al remix di Shot You
Down della Nancy Sinatra, che freddò molti degli entusiasmi che si erano creati attorno al loro suono. All'epoca i Bullys polemizzarono con Virgin dichiarando che fu
in parte loro la causa del fallimento di quel disco. Non
sapevano come promuoverci e così ci dissero che dovevamo
rallentare il ritmo. Noi accettammo e quel compromesso deluse tutti, dichiararno allora a cose fatte. Oggi i toni sono
completamente differenti, segno che i due vogliono lasciarsi la sconfitta alle spalle senza addossare la colpa a
nessuno ("E’ stata una cosa che ho detto così, poi tutti ne
hanno iniziato a parlare. In effetti non è stato poi un così
grosso problema"), ma anche che del nuovo sforzo sono
convinti e non vedono l'ora di portarlo on stage.
Niente inutili orpelli sintetici, ci anticipa Frank riguardo alla tournée, non useremo molti synth. Specie quelli
di moda oggi e neppure quella robaccia synth pop e auto
tune. Non mi piace usare effetti, soprattutto li toglierò dalle
vocals. Sarà mix tra suonato e consolle. Il tour partirà da
Londra e girerà il mondo toccando l'italia in un'unica
tappa, a Milano, unendo in una proposta fresca bangers
in acido e rockers da pogo sporco. Eppure il collante
che sorprende all’ennesimo ascolto di Higher Than
The Eiffel è la sapiente arte del maneggiare la malinconia british (quella dei Verve per intenderci), e l'ultra
sincerità confessionale di The Streets come si ascolta
nella bella Drained Out (“I miss my girl / I miss my family
/ Too much cocaine too much brandy”) tra scazzo urban,
funk, jazz e groove house.
Al telefono Simon lo senti che ha la giusta dose di
tamarraggine: 10mila “fuck, man, cool” al secondo e lo
yeah yeah che interrompe le domande. Sono questi gli
ingredienti che vanno oltre la scena e recuperano cose
distanti dalla normalità da Billboard. Il loro mesh è l’ennesima conferma di come la disco brit sia ancora una
volta Great, ha saputo guardare oltre le influenze transoceaniche lasciano ai giovani skunkers le fascinazioni
del wonky o del banghra riprendosi, in un arrocco poderoso, le armi della realness di gente come Beastie
Boys (Feel Alright) o Wu Tang Clan (London Dreamer).
Maximum Respect quindi per chi non si ferma un attimo
e ha già in testa la scaletta per il prossimo disco. I bulli
son tornati più in forma che mai.
Marco Braggion, edoardo bridda
11
Amor Fou
—La questione morale
Q
Drop Out
A volte può anche capitare che
le cose vadano per il verso giusto
dopo un inizio non così promettente come ci si attendeva. Magari
proprio mentre tutto intorno sta
crollando senza freno.
Testo: Luca Barachetti
12
uella degli Amor Fou è la più classica delle vicende nata con potenzialità
enormi ma sviluppatasi a rilento, con
esiti all'inizio semplicemente buoni e
solo in seguito – passando attraverso esperienze e
cambiamenti – splendidi, per non dire definitivi.
Anno 2007: Alessandro Raina, dopo il transito
nei Giardini di Mirò quale vocalist e un doppio parto
solista in inglese, si ritrova per la prima volta alle prese
con la scrittura in italiano. Insieme a lui il polistrumentista Leziero Rescigno, il bassista Luca Saporiti
e soprattutto Cesare Malfatti dei La Crus/The
Dining Rooms. Un disco, La stagione del cannibale, che su traiettorie Blonde Redhead-Notwist
sceglie la via del concept-album per narrare di una
storia d'amore in disfacimento durante i giorni della
strage di piazza Fontana, e dunque della disgregazione
socio-politica di un Paese che da quel momento in poi
andrà incontro a un qualcosa di molto più triste del
morire democristiani. Canzoni dotate di un'eleganza
traslucida eppure consistente, che recuperano Tenco, Paoli e Bindi tra gocciolamenti glitch, pianoforti
soffusi e liriche che raccontano con parola piane e cinematografiche (Pasolini, Petri, Truffault) l'amore
come fine e la fine come scarto antropologico di un
popolo nuovo e dai costumi nuovi ma sempre più in
decadenza. Un esordio certamente bello, in particolare per la sua carica progettuale non così tipica dalle
13
nostre parti, eppure mancante di quel
quid (di scrittura, arrangiamento e interpretazione) che dai nomi coinvolti
si sarebbe preteso. Quel quid che invece già si trova nell'ep Filemone e
Bauci (2009), una cover e due brani
autografi (tra cui una title-track da
brividi) come preannuncio di ciò che
sono oggi gli Amor Fou dopo un doppio e difficile cambio di formazione
– fuori Saporiti e Rescigno, dentro in
pianta stabile il cantautore e chitarrista Giuliano Dottori e il bassista
Paolo Perego (Nuovi Orizzonti
Artificiali, Fiamma Fiumana).
I Moralisti, che esce per EMI
dopo un primo annuncio su La Tempesta, è la pietra preziosa che si incastona nell'oro pop-rock-cantautorale
degli anni zero (Baustelle, Paolo
Benvegnù, Non Voglio Che Clara, Virginiana Miller). Uno sguardo lucido e reattivo, popolare eppure
intellettualmente fecondo, sui mala
tempora in corso, ovvero il richiamo
a una moralità che è prima di tutto
senso dell'esistere e ritorno a un
vivere civile e a una quotidianità responsabilizzata. Ma anche e più semplicemente una risposta – la migliore
fino ad oggi – alla crisi di una canzone
d'autore, la nostra d'italiani immobili,
in affannosa ricerca di un linguaggio
nuovo e rivitalizzante. Ne parliamo
con Alessandro Raina.
Dopo La stagione del cannibale la vostra line-up è cambiata. Ci vuoi spiegare in breve
cosa è accaduto e come ciò ha
influenzato la realizzazione de I
Moralisti?
Ci siamo semplicemente resi
conto che non era fisiologicamente
più possibile e nemmeno coerente
continuare un percorso vissuto con
presupposti, attitudine, entusiasmi
e obbiettivi completamente diversi.
Sicuramente con il cambiamento di
formazione si è imposta in modo definitivo un’attitudine artigianale lega14
ta a un certo modo di vivere la musica, la scrittura e la produzione. Io vengo
da due anni in cui ho suonato ininterrottamente anche da solo, un periodo in
cui ho potuto finalmente lavorare con calma sui miei limiti e sugli elementi da
valorizzare meglio. Giuliano ha portato in pianta stabile un elemento chitarristico che prima era poco presente. Leziero ha avuto la possibilità di creare
gli arrangiamenti in assoluta libertà espressiva, Paolo ci ha portato un enorme
entusiasmo e tanto supporto logistico. Siamo insomma diventati una band.
Il primo disco venne per tre quarti realizzato a tavolino. I nuovi brani sono
stati scritti, arrangiati, suonati dal vivo e successivamente registrati: la novità
fondamentale è questa.
Tra l'altro ad un certo punto avevate addirittura pensato di cambiare nome.
La questione si è posta per un'assurda richiesta dei due ex componenti,
ovviamente subito ritirata. La scritta Amor Fou ce l'ho tatuata su un braccio
da anni prima che il gruppo esistesse, penso basti a risponderti.
Inizialmente il disco doveva uscite con La Tempesta, poi la sorpresa Emi. Come state vivendo il passaggio scena indie-major, sempre che oggi abbia ancora senso presupporre delle differenze fra i
due mondi...
Non credo che in Italia esista una causa o una scena indipendente, e credo
sia anche un bene. Esistono persone con una bella attitudine che portano
avanti i loro progetti con coerenza e ricerca della qualità, penso sia questa la
cosa che conta. L'unica causa che questo progetto sposa è quella delle canzoni e dei contenuti che cerchiamo di affrontare, quindi davanti a tutto abbiamo
sempre messo la possibilità di portare la nostra musica al maggior numero
di orecchie possibili. Non è che dal mondo indipendente avessimo ricevuto
chissà quante proposte. La Emi ci ha chiesto di ascoltare il disco e, cosa sicuramente molto rara, dopo una settimana ci ha proposto un contratto, che
per altro ci lascia ampi margini di autonomia. Sul piano umano l'impressione
è stata ottima e non credo ci sia più tutta questa differenza fra la struttura di
un progetto “indipendente” affermato e quello che una major può metterci
a disposizione. Alla fine crediamo sia comunque sempre la gente a poter
scoprire quello che gli piace e decidere cosa meriti attenzione e supporto,
internet ha completamente cambiato le carte in tavola.
Fin dai primi ascolti mi è sembrato che il disco sia la medesima risultante di ciò che Benjamin Biolay ha fatto oltralpe con la
tradizione cantautorale francese. Un tentativo eccelso, svolto con
compattezza e disinvoltura, di rinnovamento di un linguaggio ormai frustro. Per quanto vi riguarda mi riferisco ai soliti Tenco, De
Gregori, Guccini, Battisti-Mogol ma innestati con Blonde Redhead,
Wilco, Interpol, National. E' così?
Personalmente ho una stima immensa di Benjamin Biolay e il paragone
ovviamente ci lusinga. Di sicuro abbiamo sempre cercato di mettere a frutto
la nostra esperienza di musicisti che hanno vissuto anche situazioni all'estero
e vivono la musica cercando di rifarsi ad un'attitudine che fuori dall'Italia si è
sviluppata meglio ed ha resistito all'avvento della rete continuando a puntare
sulla ricerca della qualità complessiva. Per questo non abbiamo avuto fretta di
adeguarci alla frenesia che sembra aver contagiato un po' tutti spesso abbassando radicalmente la qualità dei dischi e dei live proposti, e abbiamo atteso
che le canzoni prendessero forma, scegliendo sempre di lavorare nelle migliori condizioni possibili, investendo moltissimo di nostro per non sacrificare
la qualità del suono sia sul disco che dal vivo. Sicuramente questa nuova dimensione discografica ci aiuterà a concretizzarei progetti con più agilità ma ci
porrà anche l'obbiettivo stimolante di una maggiore periodicità nelle uscite.
Insomma ravvisi anche tu una certa crisi del songwriting nostrano...
Questo è un punto su cui ho riflettuto moltissimo scrivendo il disco ed
ho cercato di rendere più manifesto possibile. In una società italiana sempre
più abbruttita, diseducata e politicamente compromessa, mi piacerebbe che
la canzone d'autore tornasse ad essere una chiave di lettura della quotidianità
e non solo una forma di intrattenimento. Il cantautore dovrebbe riabituarsi
a guardare anche al di fuori del proprio mondo interiore cinico, sognante o
fragilone che sia. Apprezzo molto alcuni cantautori della mia generazione, ma
mi sono un po' stancato di non sentirli andare mai oltre la prima persona o
il diarismo sistematico, una tendenza che ha segnato gli anni '90, anche nel cinema italiano, e che bisognerebbe decidersi ad accantonare per prendersi un
po' più di responsabilità. Un cantautore è in primis un cittadino, una persona
che racconta ciò che vive ma pensare che tutto possa esaurirsi nell'autoreferenzialismo mi sembra stucchevole. E sicuramente non è l'approccio che
ha reso De André, Mogol, De Gregori, Tenco, Paoli e gli altri dei grandi
autori ma anche dei divulgatori nazionalpopolari.
I Moralisti sono persone che innanzitutto hanno compiuto una
scelta di vita, non necessariamente positiva. Voi li contrapponete
all'immobilismo delle nuove generazioni. Da cosa è dovuto a tuo
parere tale congelamento di volontà e quindi di senso dell'esistenza?
15
Il periodo storico in cui viviamo è caratterizzato da una grandissima rimozione e dalla mancanza di un “osservatorio” a cui rifarsi per analizzare
noi stessi e la realtà che ci circonda. Tutto è fagocitato e metabolizzato ad
altissima velocità, anche a causa della comunicazione digitale. Un tempo questo osservatorio era rappresentato dall’educazione ma anche dalla cultura
popolare, attraverso la musica, il cinema e la letteratura. Sono venuti meno i
punti di riferimento, a furia di metterli in discussione non si è stati capaci di
sostituirli con valori di civilizzazione alternativi e innovativi, come accaduto
in altre società. Vedo nella crisi della famiglia e nelle carenze educative della
scuola la principale causa di questa decadenza, ma ovviamente non è l'unica.
Diventare grandi in una società in cui tutti, a partire dagli adulti compiono
un'abiura delle responsabilità non aiuta certo a sviluppare un'identità forte o
a trovare veri stimoli di evasione. I giovani italiani viaggiano anche molto poco,
essendo perennemente in rete, dunque non hanno nemmeno tutte queste
chance di incontrare fisicamente persone che possano indirizzarli.
E dai Moralisti che tratteggiate si possono anche ricavare alcune
delle più grosse contraddizioni del nostro Paese. L'ambiguità dei
rapporti con la Chiesa in De Pedis, l'atteggiamento individualistico
e adolescenziale di quei giovani strati sociali che necessitano la rivendicazione di alcuni sacrosanti diritti in Anita... c'è anche questo
intento nel disco?
In realtà no, anzi, ho proprio cercato di circoscrivere la dimensione della
responsabilità individuale “a dispetto” delle sovrastrutture che spesso tendiamo a idealizzare un po' troppo per identificare le responsabilità in una serie
di strutture organizzate. In questo ci siamo rifatti molto anche al neorealismo
che si concentrava totalmente sui personaggi e lasciava le sovrastrutture sullo
sfondo, di cui venivano al limite descritti gli effetti sulla società. Pensando alla
Chiesa ho pensato alla comunità dei credenti – di cui io stesso sono parte – e
mi sono concentrato su alcuni suoi esponenti e sul loro modo, a mio avviso
toccante, di vivere la propria condizione esistenziale. Idem con un criminale di
borgata diviso fra megalomania e sensi di colpa. Non ho voluto accennare alla
iper-celebrata banda della Magliana o ricercare un mood didascalico da personaggio noir, ma pensare a De Pedis come a un uomo qualunque, un personaggio
pasoliniano, l'ennesimo prodotto di un'Italia popolare illusa e sregolata.
Ma andare a scovare le vite di persone normali però escluse dalla
pseudo-realtà catodica rimane l'unico gesto politico, “d'impegno”,
che si può permettere oggi la canzone d'autore?
Pensiamo che questo paese vada raccontato, a partire dalle storie che
racconta e che ci toccano, e che vada raccontato anche nei suoi lati am16
bigui, drammatici piuttosto che bizzarri. Niente di nuovo, ma crediamo
sia un dovere e un privilegio farlo. Il
nostro primo ministro attacca i libri
inchiesta sulla mafia dicendo che fanno una cattiva pubblicità al paese, un
po' come Andreotti criticò “Umberto D.” di De Sica perché mostrava
un'Italia troppo spietata con gli anziani e gli esclusi dal boom economico.
E' nostro dovere cercare di portare
il nostro piccolissimo apporto visto
che abbiamo la fortuna di confrontarci con un patrimonio come quello
italiano e la responsabilità di vivere in
un periodo così complicato.
Ti faccio questa domanda
perché le canzoni che avete
scritto mi sembrano pure una
sorta di inno alla complessità
del mondo. Non esistono il bianco e il nero, i guelfi e i ghibellini,
il “chi non è con me se ne vada”,
ma realtà sfumate, contraddittorie, dove i moralisti non sono
17
eroi ma persone qualsiasi, che hanno fatto una scelta di vita e ne
prendono le conseguenze, il susseguirsi di gioia e pena, come dicono i versi di Sandro Penna che chiudono la tracklist. E' anche questa
una volontà politica, di contrapposizione alla realtà unica, non solo
nell'informazione ma proprio nei costumi, che è poi a mio avviso la
vera "questione morale" dei nostri tempi?
Probabilmente sì, c'è un elemento politico nell'atto stesso di proporre certe
tipologie umane. Forse più che politico in senso stretto c'è una sorta di senso
civico nell'occuparsi di questi argomenti e divulgarli attraverso delle canzoni
che lascino la libertà all'ascoltatore di approfondire o meno i contenuti. Non
dimentichiamo che stiamo pur sempre parlando di un disco, non di un trattato
sociologico o di un film inchiesta. Ma le canzoni hanno una grandissima forza divulgativa, anche in chiave pop e non solo cantautorale. Gli unici personaggi noti
li abbiamo inseriti perché estremamente rappresentativi dell'Italia che descriviamo, ma anch'essi sono visti come uomini qualunque, e non sono celebrati,
nemmeno in negativo. E in ogni caso non volevamo sostituirci alla cronaca a cui
spetta il compito di occuparsi di personaggi pubblici. Noi ci occupiamo di quelli
che piano piano stano sparendo dall'immaginario collettivo.
Come accennavo prima il disco si chiude con alcuni versi di Sandro Penna recitati da una bambina. Dite nelle note stampa che è
una chiusura all'insegna della speranza e, attraverso i versi di Penna, un atto di realismo verso la vita, che appunto è prima di tutto
un susseguirsi di gioia e pena. Ma ci rimangono solo speranza e
realismo o è possibile fare altro?
Non solo è possibile, è doveroso. Ma senza sogni e coesione non si va
da nessuna parte ed è per questo che, non come artista ma come cittadino,
18
sono molto pessimista in merito al futuro dell'Italia in quanto tale, che probabilmente è un'esperienza culturale e
storica ormai conclusa, che vive la sua definitiva decadenza arroccata su concezioni politiche (indipendentemente dal
versante) antistoriche, di pura retroguardia, E' la vecchia storia del mondo, come capitò a Roma ai tempi di Eliogabalo
e della caduta dell'impero, emergeranno sullo sfondo nuove realtà etniche e culturali che mi auguro sappiano infondere nuova linfa alla società del domani tutelando quello che troveranno ancora intatto di questo Paese bellissimo e
frammentato.
Le
canzoni
De Pedis
Il Renatino della Banda della Magliana visto come figura ambigua ma dalla polarità negativa, ben lontana dal Dandi di
“Romanzo Criminale”, in un dialogo con il proprio padre spirituale e l'amata. Crimine e tentativi di redenzione (il boss donò
molto denaro in beneficenza), Baustelle e Blonde Redhead, sullo sfondo la Roma neorealista e una “Trastevere di brutte
cose”.
Anita
L'impossibilità di una decisione vera diventa moralità imbrigliata e desiderio represso da convenzioni o utopie ancora
lontane. Anita è una ragazza che scopre insieme alla propria omosessualità la delusione di una società intollerante cui non sa
opporre altro che scelte adolescenziali e dunque impossibili. Come nella traccia precedente drumming corposamente wave
e trascinanti frange pianistiche. Bellissimo il testo.
Le promesse
“Oggi mi dedicherò a un pensiero unico / che ti liberi da tutto il male e ti renda onore”: le preoccupazioni di una madre incerta
sull'educazione impartita alla figlia. Una ballad commuovente e malinconicamente ariosa, tra i momenti migliori di tutto il
disco. Puro pop italiano con il brit bluriano come referenza intellettuale prima che musicale.
Peccatori in blue jeans
Cadenza beat alla Rokes ma senza calchi scontati che sorregge la parodia di due cinquantenni idealisti ancora convinti
di essere giovani. E dei giovani un ritratto non meno beffardo, come se Petri scrivesse oggi una canzone su di loro. La classe
indie-kid va in paradiso.
Il mondo non esiste
Una filatrocca folk-pop su Mario Morotti, pensionato di Benevento morto suicida nell'indifferenza generale di cui si scoprirà un mondo fatto di visioni sognanti e primordiali. A raccontarlo la moglie, con la stessa pietà dolceamara del Fossati de
L'uomo coi capelli da ragazzo, in un brano che De Gregori non scrive più da un pezzo.
Filemone e Bauci
Il mito narrato da Ovidio nelle Metamorfosi per un'altra splendida canzone sul rapporto genitori-figli, questa volta però
dal punto di vista di questi ultimi. Sinceramente battistiana la prima parte, post-rock senza vendere l'anima la seconda, sorta
di bolero morriconiano che fa da notevole giro di boa dell'intero disco.
Cocaina di domenica
L'apocalisse italiana è nei bar col videopoker della provincia cronica. L'immaginario di un tipico uomo della Lega in una
serie di frame grotteschi alla Sorrentino. “Amo la mia terra e la foresta sonorizzo col fucile”. In filigrana qui come altrove Wilco
e National.
Un ragazzo come tanti
Di questi tempi una canzone su una storia d'amore tra un prete e un ragazzo può essere facilmente travisata. Ma qui si
parla soprattutto di scelte, coerenza, integrità. Come spazi di senso e libertà individuale.
a.t.t.e.n.u.r.B.
Il ministro Brunetta, altro moralista negativo dell'album, e il suo discorso contro gli intellettuali inserito in reverse in un
frammento pop-wave strumentale. La colonna sonora di una moderna invasione barbarica, nella quale tutto (vedasi anche il
titolo) si sta capovolgendo.
Il sesso degli angeli
Un innamorato si pente di aver lasciato scorrere una relazione in modo troppo libero. L'unico passaggio interlocutorio
di tutto il disco dimostra una qualità di scrittura comunque sopra la media.
Dolmen
“Ah! Se noi fossimo almeno noi”. Un amore irrealizzabile per troppo individualismo che diventa nella frammentazione della
nostra società l'impossibilità disperata di un qualsiasi tipo di legame. Scritta pensando agli Altro, arrangiata come degli Interpol
rabbiosi. Fino ad ora, una delle canzoni più emozionanti del 2010.
I moralisti
La chiusura è affidata ad un breve strumentale più recording dove una bambina recita due versi da “Una strana gioia di
vivere” di Sandro Penna. Un omaggio al poeta e ai “Comizi d'amore” di Pasolini, ma anche un lancio di speranza e realismo
che fa da sigillo programmatico all'intero lavoro. “Dacci la gioia di conoscer bene / le nostre gioie, con le nostre pene”. La vita per
quello che è, prima di tutto.
19
Goth wave
summertime hits
High Places
—High Places, Pit Er Pat,
The Hundred In The Hands
A ssociazioni
Drop Out
Pit Er Pat
Tre band lungo il continuum di una
categoria: gradienti di estetica ’80 e
di pratica ’00. Opinioni a confronto
nell’intervista parallela e doverosa
introduzione
Testo: Gaspare Caliri
The Hundred In The Hands
20
successive
Fare critica musicale vuol dire fare ipotesi. Ascoltando The Flexible Entertainer dei
Pit Er Pat, qualche mese fa, ci siamo resi conto di essere davanti a una possibilità di discorso
trasversale. L’idea è stata allora di avere un po’
di pazienza e di ragionare sulla natura del combo e della musica dei chicagoiani. Nati come
tre e ridotti a duo, ci sembrava avessero reso
la propria offerta musicale meno ingombrante,
sia in termini di effetti semantici, sia rispetto
all’eseguibilità live. Ci sembrava avessero traghettato il meta-pop in un nuovo pop, pieno
di riscontri in altre band. In altre parole, abbiamo ravvisato in Pit Er Pat il possibile punto di
partenza verso un approfondimento trasversale. Eppure non abbiamo semplicemente aggregato, attorno a una band, una serie di altre
realtà in qualche modo gravitanti attorno allo
stesso pianeta, come degli insetti che volano e
si incaponiscono attorno all’unica luce accesa.
Il gioco delle righe che leggerete è piuttosto
di associazioni successive. Anziché mantenere
i Pit Er Pat come lume solitario e unico polo
della categoria attorno alla quale organizzare il
ragionamento, si è preferito cercare qualcosa di
simile su cui articolare le affinità e divergenze, e
anche una categoria più complessa.
Abbiamo lavorato anzitutto sul roster di
21
The Hundred In The Hands
provenienza di Pit Er Pat, l’etichetta Thrill Jockey of course, un piccolo mondo e cartina al tornasole affidabile di questi anni di indie-pop eterodosso. Un
universo che va dalle meditazioni profetiche di Daniel Higgs al cosmic-hard
di Trans AM, dai poliritmi Mi Ami ai Tunng, solo per fare qualche esempio
recentissimo. Gente di Chicago, nella label nata per iniziativa privata di Bettina Richards: Tortoise, Chicago Underground Duo, gli stessi Pit, ma la
strada non è questa. Devia e ci porta inizialmente a Brooklyn, luogo che ha
dato i natali agli High Places, e poi a Los Angeles, dove il duo di Rob Barber
e Mary Pearson ora ha sede.
In High Places abbiamo ritrovato la struttura delle “songs” di Pit Er Pat, lo
spirito per così dire, e una tendenza a spolverare un mondo e dargli un’altra
forgia: i primi Ottanta e lo spirito del post-punk, sicuramente, unito ancora
una volta a quella portabilità di cui sopra. Altro duo, altro polistrumentista,
altra voce femminile.
N uove
leve
La ricerca non si è conclusa qui. High Places sposta di qualche metro il
fuoco dell’osservazione, ma in realtà non fa che creare tensione nel primo
polo della categoria. Per così dire, lo sbilancia verso un altro, ancora tutto da
trovare. A questo punto, però, ci è stato chiaro dove cercare. Ed è stato semplice riconoscere quello che stavamo cercando, una volta imbattutici.
Si chiamano The Hundred In The Hands e sono anch’essi un duo, proveniente ancora una volta da Brooklyn, e ivi ancora ubicato. Un duo appena
nato, da qualche mese salito alla ribalta e subito precettato da un’etichetta
sempre più attenta, nonostante l’età, a quello che può avere dono di sintesi
di processi in corso in altre band. Parliamo della solita Warp, ottima capita22
lizzatrice di tendenze musicali. Partiamo dalla fine, dunque. L’anno scorso
Jason Friedman e Eleanore Everdell,
i due nomi che stanno dietro al moniker Hundred In The Hands, fanno
uscire per Pure Groove Dressed In
Dresden, singolone che subito attira
l’attenzione di nomi importanti: fondamentale è la potenza trascinatrice
del giro D.F.A., messa in moto dal
remix presente sul lato B, un remix
ad opera proprio di Jacques Renault.
La Warp si accorge dei primi passi
della band e la accompagna a fare le
prime esplorazioni successive, che si
materializzano in un remix 12” sempre di Dressed In Dresden, in uscita
ad aprile, e soprattutto in This Desert EP, punto di congiuntura tra
avant Pit Er Pat-iano, synth-pop e atmosfere da messthethics redux.
Il nome della band viene da una
battaglia vinta dai nativi americani –
tra cui Crazy Horse – a metà Ottocento. Per derivazione diretta o per
accidentale sovrapposizione, Hundred In The Hand è anche il titolo di
un best-seller di qualche anno fa di
Joseph Marshall, autore di western –
ma niente di più lontano è la musica
prodotta. Aura inglese e spirito gotico che riemergono insistentemente
su una disinvoltura synth-portatile
sicuramente figlia dei Duemila: di
quei ’00 che in qualche modo sono
stati alimentati da esperienze quali
Pit Er Pat e High Places. Il giudizio
complessivo sui nascenti Hundred lo
daremo in autunno, momento in cui
vedrà la luce, a quanto pare, il primo
album della band, sempre per Warp.
Per adesso limitiamoci ad affrontare
la pratica musicale del duo. Eleanore,
come Fay Davis-Jeffers di Pit Er Pat e
Mary Pearson di High Places, canta e
dà un taglio forte alle armonie proposte dal gruppo, di cui è la principale
responsabile. Accanto a lei, che suona
anche i synth (come Mary), Jason è il
polistrumentista della ragione sociale,
che si occupa di ritmo, soprattutto,
programming, chitarre. In lui si rifrangono e si specchiano, con monti di esperienza in più – e si sente -, le figure di Rob Barber (High Places) e dell’ormai
mitico Butchy Fuego (Pit Er Pat). Menti delle rispettive band e protagonisti
assoluti, come polistrumentisti, della stratificazione degli strumenti.
La pratica di Hundred In The Hands è figlia poi dell’ambiente in cui il duo è
sorto: una grossa mano la sta dando il già citato Jacues Renault, e il suo studio,
nello specifico. Friedman è anche stato coinquilino di Mattie dei Ruptures
periodo DFA. Naturalmente, anche le passioni musicali sono vicine. Tutta la
messthetics, a partire da Young Marble Giants, e in generale il post-punk
inglese, su tutti i primi Wire. C’è invece tutta NYC nei riferimenti odierni
dei due, da Crystal Stilts a The Pains Of Being Pure At Heart. Tutto secondo programma. Ma è ora di risalire il gradiente temporale del decennio e
affrontare, dal loro inizio, le origini di queste riflessioni: la vicenda Pit Er Pat.
G radienti
temporali : decennio
P it E r Pat
Se Hundred In The Hands sono neonati, al polo estremo sta la biografia
di Pit Er Pat. L’esperienza del duo di Chicago, oggi per metà di stanza a Los
Angeles, – e comunque nato e diventato noto come trio – inizia grazie all’iniziativa di Butchy Fuego. Batterista ossessionato dal ritmo e dalle sfaccettature
che esso cela, soprattutto nelle vesti percussive del Brasile e latine in senso
lato, produttore a cui è possibile far risalire il marchio di fabbrica piterpatesco, si impegna nel mestiere di musico già prima di iniziare la vicenda PEP.
È il 2001 quando licenzia un primo album solista a nome Butchy Fuego.
Il trio per cui lo conosceremo meglio si sta per formare ma non produrrà
nulla fino al 2004, anno in cui escono, in un crescendo temporale di formati, il
primo 12” (The Babies Are Tired/Lullaby), il primo EP (Emergency EP) e il primo album (Emergency anch’esso, come l’EP). Le label variano e si attestano
l’anno dopo – con Shakey - su quella che rimarrà l’etichetta da tutti associata
ai Pit Er Pat, la Thrill Jockey. I Pit Er Pat non sono però emanazione del solo
Fuego ma provengono dalla convergenza di tre persone: ci sono anche Fay
Davis-Jeffers, alle tastiere e alla voce, e Rob Doran al basso. Quest’ultimo,
oltre ad avere una formazione di arti visive, veniva in realtà già da un lustro
abbondante con gli Alkaline Trio, quando ha deciso di dedicarsi alla mission
patesca. Fay, dal canto suo, cuce sulla band un’individualità vocale femminile
che farà il gioco di associazioni diverse, come quella in corso ma anche con i
Fiery Furnaces (teorici della portatilità tastieristica), con i quali i Pit Er Pat
dividono il palco nell’autunno del 2007.
La storia di PEP, in un certo senso, è costellata di eventi salienti degli ’00.
Il batterista Fuego viene invitato dal compagno di label Eye dei Boredoms
per l’ormai arcinota esibizione di 77 batteristi a Brooklyn, di tre anni fa. Il 77
Boadrum fu un evento fondamentale per sancire l’attenzione del decennio
verso il cortocircuito ancestrale-tecnologico e verso il primitivismo tribalista dei tamburi. Qualche anno prima, in un altro momento passato poi alle
cronache, chi scrive sentiva parlare per la prima volta di Pit Er Pat seguendo
il secondo episodio delle saga Burn To Shine, serie di DVD che ritraggono
concerti svoltisi in case prossime a essere abbattute. Il n° 2 veniva registrata
proprio a Chicago, e accanto a Ponys, Shellac, Tortoise e Wilco suonavano
un set convincente anche i Pit Er Pat. Ciò che emergeva già da quell’esperienza – datata 2004 – era un innesto molto promettente tra retaggi Novanta
– peraltro ottimamente rappresentati dai personaggi che animavano quelle
stanze – e un germe ludico targa Ottanta che iniziava a farsi notare, nei Pit
23
Pit Er Pat
dal vivo. È tutto incentrato sull’MPC, la drum machine più usata anche nell’hip hop. Siamo senza un bassista ora, e la macchina supplisce all’assenza. Ci sono un paio di tracce dove suono la drum machine con le dita, come un piano, e mi diverte
moltissimo. Usare i sampler ha comportato per noi un’ecletticità maggiore. Ci hanno detto che la nostra musica oggi è molto
più spensierata…”.
Tranne forse per la spensieratezza, diremmo che i Pit Er Pat si stanno avvicinando, con questa operazione di portabilità, a High Places. Il duo di Brooklyn, oggi losangelino, sempre legato alla Thrill Jockey, ha esordito, con un fare
immaginifico e un pop rarefatto e pienamente figlio delle atmosfere Ottanta, già nel debutto sulla lunga durata del
2008, omonimo alla band. Di appena un paio di anni prima era il cd-r con cui Mary Pearson e Rob Barber hanno fatto
le prime mosse, mentre è il 2007 quando stampano il primo EP (omonimo anch’esso) e iniziano una tournèe pressoché infinita, e praticamente ancora oggi in corso. I due sono musicisti e come tali si sono conosciuti. L’esigenza della
riproduzione live delle creazioni in studio ha segnato fin dall’inizio l’approccio di composizione e di scrittura della
band. All’interno di tale costante, le variabili dipingono, come ci si aspettava, una via di mezzo tra Pit e Hundred.
The Most Beautiful Name, da High Places vs. Mankind, è legata a doppio filo agli esperimenti Slits-iani condotti
anche in The Flexible Entertainer, come in un certo senso alle annate chiamate in causa da This Desert EP. C’è un
dono di sintesi e di commistione che fa parlare insieme il proprio passato prossimo (il primo album, del 2008) come
il meta-pop di Fuego e soci. When It Comes è motivo Ottanta con tutti i crismi, e dà una bava di colla alle affinità e
divergenze di cui stiamo parlando in queste righe. Le note vocali di Mary prendono la parola anche per una parte
di quell’elettropop di cui tanto s’è discusso negli ultimi anni, spesso con ugole femminili come portavoce. L’accompagnamento è The Cure fino all’osso, e tutta la song lo sarebbe, se non fosse evidente il tratto distintivo di High
Places, che preserva – al contrario di quanto accade a Hundred In The Hand – dal trasformare il brano in una specie
di goth-wave-pop 2.0.
G radienti
musicali :
H igh P laces
High Places
come nella massa di altre band di metà Duemila.
Oggi Fay vive a Los Angeles, questione su cui, come vedremo, la diretta
interessata nicchia. Eppure la fucina Chicago ha avuto conseguenze sulla vita
della band, oltre che per Burn To Shine. A Chicago, Butchy ha vissuto cinque
anni in uno studio chiamato Shape Shoppe, dove è entrato in contatto con
altri musicisti, come collega e produttore, tra cui Dylan Ryan degli Icy Demons, che collaborerà a High Time, Griffin Rodriguez a.k.a. Blue Hawaii,
tutti i gruppi licenziati dalla label Obey Your Brain. In quegli anni la ricerca
del trio – prima che diventi duo – si direziona su un genere molto vago ma
esplicito: l’avant-pop degli inizi già in Pyramids vira verso la ricerca della canzone pop, e in High Time trova un compromesso in una sorta di meta-pop
che parla un linguaggio che oggi non facciamo fatica a individuare come il Pit
Er Pat sound.
In quel “meta” si annidano gli Ottanta nascosti dietro ai Novanta dell’“avant”.
Su questo filo del rasoio si svolge la carriera dei Nostri, fino al nuovo disco,
che taglia secondo direttive finalmente messthetics, come si diceva anche per
Hundred, scoperchiando influenze persino Slits, in qualche occasione, e fumi
giamaicani dietro all’Inghilterra di fine Settanta / inizio Ottanta.
di mezzo
Su The Flexible Entertainer Butchy Fuego si esprime come segue: “Il
nuovo disco è per così dire “spogliato”, con l’obiettivo di essere facilmente suonabile
24
25
I nterviste
parallele
Riassumendo le tante parole spese, in un caso come quello presente
la trasversalità agognata vale come
attraversamento di un continuum, di
una stratificazione di pratiche, tempi,
risposte, atteggiamenti, stili musicali.
L’idea è stata allora di confrontare
i diretti interessati in un’intervista
uguale per tutti e tre le band. Non a
caso il continuum si è riprodotto anche nelle risposte. Gli ultimi arrivati
sono i più prolissi, i primi quelli più
sintetici. Il gioco delle etichette, dei
suoni e dei tempi si riscopre anche
nelle risposte. Vi lasciamo a quelle,
per non dilungarci oltre e per lasciare a voi l’andirivieni ludico delle opinioni.
Quanto è importante il contesto dove vivete per la vostra
musica?
F (PEP): Non credo che la città in
cui vivo abbia un riflesso nella mia musica, che non è così site-specific…
M (HP): Molto importante. Un
26
The Hundred In The Hands
Gli High Places hanno uno sguardo a volo d’uccello. Il nome della band
sta a significare la passione comune ai
due componenti per i paesaggi montani e in genere per le viste dall’alto.
Gli High Places sono questo, paesaggio e quindi distacco, ricerca di una
tipicità, focalizzata o detenuta nelle
carceri dell’astigmatismo, portabilità
capace di mettere a fuoco e scattare.
Le foto del loro blog vivono di grandangoli. La loro musica "distante" è
perfetta per complessificare una categoria, scioglierla, darle colore e percorrerla in lungo e in largo. Il sound
High Places sembra quasi euforico, a
tratti. Altre volte un po’ scazzato. In
realtà è quasi anti-emozionale. Il che
la rende interessante e efficace messa a distanza di due mondi – i Novanta filtrati di Pit Er Pat e i novelli
Ottanta di HITH – che oggi non ha
più bisogno di ricorrere agli esotismi
di High Places (album).
sacco della nostra ispirazione viene dal tempo e dalla natura, e quindi la situazione è drasticamente cambiata quando ci siamo trasferiti da New York a
Los Angeles.
R (HP): E’ un tira e molla per me. Traggo ispirazione dal posto in cui sto,
però ogni tanto sono tentato di reagire e scappare, o di pensare a come
starei da un’altra parte. Non che non mi piaccia LA, mi immagino solo di
essere a Berlino e di divertirmi, mentre guido verso casa dalla spiaggia. HITH:
Probabilmente il posto in cui viviamo dà forma a tutte le cose che facciamo.
Soprattutto perché ci sono moltissime band di amici che ci danno ispirazione.
New York è un luogo pieno di competizione, in questo senso. In senso buono,
ci sfida a essere al meglio delle nostre possibilità.
Conoscete l’uno il lavoro dell’altro? Cosa apprezzate maggiormente? Cosa vi invidiate musicalmente di più?
Butchy (PEP): Sono sempre stato un fan degli High Places! La cosa che mi
attira di più della loro musica è quel modo di suonare sia aereo che terreno.
È un sound familiare e inedito insieme. Ma non parlerei di invidia.
M (HP): Siamo amici di Pit Er Pat. Sono una delle ragioni per cui siamo nel
roster Thrill Jockey. R (HP): Pit Er Pat sono una delle band più avventurose che conosca. Si
reinventano in ogni album. È una cosa che mi spaventerebbe, ma loro ce la
fanno ogni volta. Li sento come parte del mio mondo e della mia stessa specie.
HITH sono invece una novità per noi…
HITH: Abbiamo preso l’ultimo High Places solo settimana scorsa. Ci piace
un sacco il singolo, The Longest Shadow. Gran video. Quanto sono importanti gli
Ottanta per voi? Specialmente
per quanto riguarda le produzioni 4AD e Creation…
B (PEP): ho inziato ad ascoltare
quel tipo di musica nei ’90 e hanno sicuramente avuto un’importanza decisiva nella mia visione musicale. Allo
stesso tempo sono stato influenzato
da ogni cosa abbia ascoltato. Mi è rimasta però ben fissa in mente quella
sorta di bellezza caotica (messethetics? Ndr) del periodo. Oltre tutto,
credo ci sia un collegamento tra la
nostra musica e band come Jesus
And Mary Chain, My Bloody Valentine, Pixies, Bauhaus, ecc. Ma non è
un’influenza conscia.
R (HP): Alla fine degli ’80, ero un
punk, un hardcore kid, che pensava
solo a salire sul palco e fare stagediving… Musica come quella della
Creation è stata poi un paradiso e
una salvezza per il mio cervello, mi ha
permesso di focalizzare il mio lavoro
e di mettere a punto un’idea di bellezza, insomma è stata fondamentale
per la musica che faccio ora.
HITH: Ci sono tante cose che ci
piacciono degli Eighties, cose molto
diverse tra loro. New Order, Italo
disco, Minimal Wave, ma anche band
come Stone Roses, Happy Mondays, Cure, oppure ancora ascolti di
fine decennio come De La Soul, Ultra
Magnetic MC’s, Eric B. & Rakim, ecc.
poi ci sono i classici: Thriller, su tutti,
e la roba più dura, da Dinosaur Jr. a
Sonic Youth. Negli anni Novanta c'era un
mood, spesso legato alla solitudine della propria stanza. C'è un
mood degli ’00?
F (PEP): Noto un sacco di gente
che si sforza di avere un mood positivo. È importante il senso dell’umorismo.
M (HP): Internazionalismo? R (HP): Wishy washy-ness senza
genere?
HITH: i Novanta erano noiosi.
All’epoca ascoltavo per tirarmi su soul-punk e mod anni Sessanta. C’erano
un sacco di feste a tema a NYC. Il risultato sono band di inizio ’00 che volevano solo divertirsi.
Mondi Terzi. Esistono buove geografie dove il ritmo è fondamentale, giungle e savane che ci affascinano?
F (PEP): se c’è un mondo altro che mi affascina o suggestiona, non è africano, brasiliano o tedesco. È nell’immaginazione. Qualsiasi cosa aliena è interessante, ma spero che la nostra musica sia compresa dagli umani.
M (HP): le persone che ascoltano gli High Places ci sentono cose molto
diverse tra loro. Alcuni sono convinti del fatto che ci riferiamo alla musica
carnatica o al drumming africano. Quando suoniamo in Giappone, ci dicono
che sembriamo citare la musica folk nipponica. Credo che queste associazioni nascano dall’associare strumenti non provenienti dallo standard del rock.
Comunque sia, oggigiorno suoniamo le chitarre in un modo molto più tradizionale rispetto a prima.
Questione live set. Hundred In The Hand sono un duo. Pir er
Pat lo sono diventati, e per farlo hanno dovuto rendere i propri arrangiamenti più “portatili”. La stessa cosa probabilmente accade a
High Places…
F (PEP): In effetti abbiamo considerato come decisiva la semplicità di trasporto della strumentazione. Ma non credo che il nostro sound abbia perso
in complessità…
B (PEP): Penso che il nuovo formato a due ci apra delle nuove possibilità.
Nonostante sia necessario considerare quello che ci possiamo portare appresso, il suono in qualche modo si è espanso. E in realtà credo sia un processo già in corso da anni in seno alla band.
M (HP): Essere un duo è una gran cosa. È molto conveniente. Abbiamo iniziato fin da subito con l’obiettivo di essere più “portatili” possibile, e questo
ci consente di viaggiare molto e piuttosto facilmente. Ma è importante non
sovra-semplificare il proprio live secondo questo criterio.
HITH: La cosa migliore di lavorare in due è non fermarsi mai, nel migliorare e nel fare pratica. Entrambi vogliamo fare più concerti possibile, ed essere
“portatili” al massimo. Nei live mettiamo al centro chitarre e voce, per esprimere l’importanza dell’elemento umano; eppure usiamo molte macchine, che
sono il terzo componente della band. Per esempio, stasera voleremo per l’Europa, e ho passato 40 minuti al telefono per cercare di convincere Airfrance
a farci portare in stiva tutto il nostro equipaggiamento…
Band preferite di oggi e di ieri?
F (PEP): Oggi: Bizimun,Yesterday, J Dilla e Missy Elliott. B (PEP): Oggi: Buraka Som Sistema, Boredoms, Javelin, Frente Cumbiero, jj,
Lil Wayne, Maluca Mala, Lucky Dragons, R. Kelly, Dan Higgs, ecc. Ieri: Charles Mingus, Need New Body, Grace Jones, Allen Toussaint, Betty Davis, Eno,
Eddie Kendricks, J Dilla, Led Zeppelin, Lord Kitchner…
M (HP): Oggi: Portishead. Ieri: Led Zeppelin.
R (HP): Oggi: Thee Oh Sees. Ieri: Celtic Frost.
HITH: Oggi: Rupture, Holy Ghost (nostri vicini di casa), Flying Lotus,...
Ieri: il primo hip-hop e ska, il post-punk, la prima synth music, il pop classico,
il French pop,Young Marble Giants,Tom Tom Club, Neneh Cherry… Per concludere gli Hot Chip: abbiamo suonato con loro e abbiamo realizzato come
sappiano sintetizzare tutti quei generi insieme...
27
UK DIY
—Pens, Male Bonding,
Graffiti Island, Fair Ohs,
Veronica Falls, Cold Pumas
Male Bonding
Drop Out
In un mercato discografico allo
sfascio, il DIY garagista americano
sbarca negli UK and it is here to
stay
Testo: Diego Ballani
28
È
passato parecchio tempo da quando
mister Alan McGee veniva considerato il discografico più lungimirante e
illuminato del Regno Unito. Erano gli
anni in cui la sua Creation poteva vantare una
scuderia da fare impallidire quella di Diva Futura nel porno.
Oggi il vecchio Alan è un signore di mezza
età che tiene un piccolo blog sul sito del Guardian. I suoi post hanno titoli perentori e un pò
altisonanti, e vengono spesso accolti dai suoi
lettori, per lo più indie rocker britannici con
gusti molto prosaici, con la benevola ironia che
si riserva ad un vecchio zio un pò rincoglionito. Lo scorso febbraio, però, il buon McGee,
recuperata temporaneamente quella lucidità
che in passato gli permise di scoprire gruppi
che fecero fischiare le orecchie della gioventù
sonica inglese, si ritrovò a commentare i Brit
Awards 2010 con una buona dose di amarezza.
Secondo colui che scoprì gli Oasis, le major ci
hanno servito un altro anno di vacuo pop da
reality show. In tale aspetto e nelle difficoltà
fiscali ed economiche che affliggono ormai da
tempo questi colossi dai piedi d’argilla, è facile
intravedere, in tempi relativamente brevi, la fine
dell'industria musicale (per come la conosciamo, aggiungiamo noi).
Assodato questo, però, la questione diven29
P rime movers : PENS,
G raffiti I sland
Facciamo per un attimo un passo
indietro e spostiamoci dall'altra parte dell'oceano. DIY all’alba dei 10s è
sinonimo di etichette come Woodsist, HoZac e Capture Tracks (ma non
dimentichiamoci di Make A Mess,
Zoo Records e decine di altre ragioni sociali di natura semiamatoriale),
ovvero la punta di un iceberg le cui
reali dimensioni sono ancora tutte
da scoprire. Si tratta di label guidate
per lo più da artisti decisi a pubblicare musica in proprio, che hanno
avviato una rete fittissima di contatti,
hanno riportato alla luce un’estetica
fatta di suoni approssimativi, spesso
registrati in studi casalinghi, la cui
unica ragion d’essere è unicamente
l’urgenza espressiva. Il tutto, unito ad
una sorta di feticismo per vinile, cassette, copertine disegnate a mano, ha
delineato le coordinate di una scena
agguerritissima e compatta.
La comparsa di artisti come Dum
Dum Girls, Psychedelic Horseshit, Blank Dogs ha fatto da battistrada a decine di minuscole entità
passate dalla sala prove al vinile senza
soluzione di continuità, all’insegna di
30
sonorità in bilico fra pop acido, garage deviante e wave minimale. Il bello è
che la loro influenza sull’immaginario indipendente si sta dimostrando più
pervasiva di quanto non dicano i numeri. A metà del 2009, una di queste
etichette, la Art Fag di San Diego, pubblicava uno split con quattro band, due
statunitensi e due londinesi. In quel momento fu chiaro che la pianta selvatica
del lo-fi aveva iniziato a germogliare anche nella vecchia Albione.
Le PENS, terzetto londinese al femminile, erano una di quelle band. Oggi
possono vantare lo status di prime mover del scena DIY britannica, più che
altro per la velocità con cui sono riuscite ad arrivare al traguardo dell’album. Hey Friend, What You Doing? è stato inciso dopo appena sei mesi
dalla loro formazione ed è stato pubblicato sul finire dello scorso anno per
la De Stijl. La qualità della registrazione è pari solo all’imperizia tecnica del
gruppo. Eppure, se la parola punk ha ancora un significato all’alba del 2010, è
da rintracciarsi proprio in questi solchi. Immaginate una versione minimale e
sgangherata delle Slits, impegnate a registrare nel tinello di casa filastrocche
garage dai testi inintelligibili, (oppure slogan programmatici come “we got no
money and we’re gonna break in”): un mix di cantilene infantili e urla belluine,
in cui l’immediatezza ha la meglio su tutto. E’ Il recupero dell’innocenza che
stava dietro alle produzioni targate Flying Nun, la magia del pop servita col
ghigno beffardo dell'ennesima “rock’n’roll swindle”.
Certo, chiunque affermasse che tutta questa storia del DIY non è altro
che una scusa per celare l’incapacità tecnica sotto un’asfissiante cappa di
hype, avrebbe gioco facile. Dal canto loro, però, le ragazze non si scompongono: “È buffo che la gente pensi che cerchiamo di essere cool – controbattono – in
realtà facciamo solo quello che ci diverte. Il nostro problema è che non possiamo
permetterci strumenti o sale di registrazione costose. Inoltre non siamo granché
Pens
ta un’altra: la marginalizzazione delle
major comporterà anche la fine della
musica che amiamo? “Of course not!
– è la risposta di McGee – la testimonianza del fatto che ci sia vita oltre
le major, sta nella pubblicazione della
compilation della Paradise Vendors
Inc, etichetta dei giovani noise makers
Male Bonding: un ottimo esempio di
tutto quello che c’è di buono nella musica indipendente odierna. Un manifesto
di brutale DIY fuzz pop nella tradizione
di label storiche come la SST”.
E fu così che i giovani lettori del
Guardian, per lo più abituati a confrontarsi con personaggi come Lady
Gaga e Lily Allen, scoprirono i Male
Bonding e il nuovo e intricatissimo
universo DIY britannico. come musiciste. High In The Cinema,
ad esempio, è stata incisa una camera
puzzolente dell’East London, tanto che
se ascolti bene puoi sentire persino il rumore della muffa. La verità è che vogliamo solo divertirci senza preoccuparci di
rappresentare nulla per nessuno.” Ecco,
più chiaro di così!
A suggello del connubio artistico
fra le due sponde dell’oceano, c’è stato poi il tour con Dum Dum Girls,
Crocodiles e i londinesi Graffiti
Island, nome quest’ultimo che sembra legarsi indissolubilmente a quello
delle PENS.
Più pop e indolenti rispetto alle
tre concittadine, quello dei Graffiti
Island è una sorta di 60s garage suonato da cavernicoli, visto il riverbero
che ricopre voce e chitarre e la foga
con cui tormentano gli strumenti.
Uniscono testi in cui si parla di lupi
mannari e amenità varie ad un approccio slacker che nell’ultimo singolo, Demonic Cat, finisce per farli assomigliare ad una versione zombificata
dei Beat Happening.
Neanche un album al loro attivo e
già da mesi si parla di loro come della
band più cool di Londra. Vedendoli, e
leggendo interviste in cui si divertono a parlare invasioni aliene e horror b-movie, ci se li figura piuttosto
come un circolo di nerds reduci da
una lunga sessione di D&D: “E’ corretto dire che sono i vecchi VHS degli anni
80 ad ispirarci – spiega il cantante Conan Roberts – quelli bizzarri che trovi
nei banchetti dell’usato dalle incredibili
e coloratissime cover.” Insomma, il tipo
di immaginario che ci si aspetterebbe
far presa su qualche sfigatissima garage band americana, più che su un
terzetto di occhialuti borghesi londinesi.
Curioso che per un gioco di influenze incrociate, il teen rock americano dei 60s e dei primi 90s sia
tanto importante per la nuova scena
indipendente d’Albione quanto lo è
il C86 lo è per lo shitgaze d’oltreo-
ceano.
In tal senso si deve leggere il tributo alla figura del figlio più degenere
della junk culture a stelle e strisce da
parte della Italian Beach Babes,
micro label inaugurata lo scorso anno
dallo stesso Roberts. Nata principalmente con l’intento di distribuire in Europa materiale targato HoZac, Capture Tracks e
Zoo Records, l’etichetta, la cui prima
issue in catalogo è una split-cassete
con brani di PENS, Male Bonding e
degli stessi Graffiti Island, ha dato alle
stampe un 7’’ tributo allo scum rocker GG Allin.
Cosa abbiano in comune gli efebici
componenti dei gruppi in questione
con uno dei personaggi più controversi di tutta la storia del rock, è un
argomento che sarebbe interessante
approfondire. “Sono sempre stato affascinato da GG Allin, dalla sua vita e da
come divenne il personaggio che conosciamo – afferma Roberts – di sicuro si
trattava di una persona disturbata, con
idee controverse su diversi temi, ma non
bisogna dimenticare le grandi canzoni
che scrisse.”
John Arthur Webb dei Male Bonding è sulla stesa lunghezza d’onda:
“Chiaramente non condivido molte delle
affermazioni fatte da Allin – uno che
fra le altre cose affermava l’utilità dello stupro ai fini della crescita personale – tuttavia mi interessa il percorso
psicologico che lo ha portato a scrivere
canzoni come Shove That Warrant. Di
certo era uno che viveva al cento per
cento la propria musica.”
Risultato: le 300 copie stampate
di Violent And Obscene: A Tribute
To GG Allin sono andate sold out in
men che non si dica. Dopodiché Roberts e Webb hanno iniziato pianificare un’uscita ancora più ambiziosa
che prevedeva una collaborazione
fra le rispettive label. Il che ci porta
direttamente nel ventre della balena
del nuovo fermento underground. D on ' t go back to
D alston : M ale B onding
Lo scorso anno il solito Guardian
pubblicava sulle colonne del suo sito
un curioso articolo, il cui titolo suonava più o meno così: “Benvenuti a
Dalston, il luogo più cool della Gran Bretagna”. Immaginatevi le risate di tutti
coloro che conoscevano il sobborgo
londinese per i caotici mercatini, le
file interminabili di ristoranti turchi e
gli insanabili problemi igienici.
Il fatto è che, al di là dei facili entusiasmi, in vero piuttosto comuni
nell'ambito della stampa britannica, il
codice postale E8 si stava trasformando in uno dei poli di attrazione della
vita notturna londinese. La presenza
di numerosi capannoni sfitti e i massicci investimenti nell’ambito dell’edilizia, avevano creato le premesse per
l’arrivo di sostanziose iniezioni di capitale umano e artistico. I club nascevano e un numero crescente di musicisti (due a caso? Lightning Speed
e Jack Penate) iniziava a considerare il quartiere come il proprio avamposto strategico.
Se un anno fa gli psycho poppers
Big Pink rappresentavano il nome
di punta a Dalston, oggi al top del
Who’s Who c’è un insospettabile trio
di slackers. John Arthur Webb (chitarra e voce), Kevin Hendrick (basso) e Robin Silas Christian (batteria)
rappresentano il frutto apocrifo di
due delle maggiori tendenze d’oltre
oceano: quella art rock & noisy, che
negli USA prolifica intorno al locale
di culto The Smell, e quella no-fi di
HoZac, Capture Tracks e Art Fag, a
cui il combo dalstoniano si è da subito affiliato.
Sono autori di un noise pop spigoloso, scosso da violenti fremiti punk,
anfetaminico e tribale, che si è subito
guadagnato paragoni con quello dei
californiani Abe Vigoda, tanto per
citare una della band più hyped del
giro dello Smell. Loro non fanno mistero di provare un naturale richia31
Male Bonding
mo per la scena losangelena:“Ci piace
l’estetica di quello che sta avvenendo
da quelle parti. - è il chitarrista John
Webb a parlare - Ci siamo stati solo un
paio di volte ed è stato incredibile, carico
di ispirazione. Adoriamo il sound di band
come i Mika Miko, gli Abe Vigoda e i
nostri nuovi compagni di etichetta, i No
Age.”
Già perché nonostante i Male
Bonding abbiano fino ad ora veicolato la propria musica attraverso una
messe di materiale a tiratura limitata,
pubblicata sulle più disparate label
del giro DIY, è stata la Sub Pop ad
aggiudicarsi la possibilità di pubblicare, a maggio, il loro disco d'esordio:
“C’è gente che è convinta che siamo 'arrivati' solo per il fatto di aver firmato per
Sub Pop – spiega Webb – e che questo
sia avvenuto senza reali meriti da parte
nostra.”
In realtà, sin dal momento della
loro formazione, avvenuta nel 2008,
tutti e tre i componenti della band
si sono resi protagonisti di un'attività
frenetica, organizzando e partecipato
a concerti di band come HEALTH
e Fucked Up, tenutisi in piccole venues della zona diventate il punto di
riferimento per gli indie junkies londinesi. In breve il gruppo ha iniziato
a catalizzare l'attenzione delle realtà
32
artistiche più oblique presenti sul
territorio. Tutto questo non poteva
che sfociare nella nascita della Paradise Vendors Inc., micro label dedita a
produzioni dalla tiratura limitatissima
(per lo più in cassetta o 7’’), tramutatasi da subito nel vettore privilegiato
di band dal comune sentire. E’ grazie
ad una di queste uscite che la Sub Pop
si è accorta di loro. L’etichetta americana è quella che più di ogni altra sta
ricalibrando il proprio rooster sugli
urticanti suoni del nuovo lo-fi. No
Age e Dum Dum Girls sono già della
partita, con i Male Bonding, i discografici di Seattle possono tranquillamente affermare dire di aver messo
le mani sulla band più significativa fra
quelle sorte al di qua dell'Atlantico.
Se poi qualcuno nutrisse dubbi di
natura etica sul percorso che ha condotto il trio a compiere la suddetta
scelta,Webb ha già pronta la risposta:
“Guarda, è tutto molto relativo. Se non
avessimo avuto contatti con Sub Pop
non avremmo mai prodotto un album. Ci
vogliono troppi soldi per farlo, in questo
modo avremo la possbilità di raggiungere un numero infinitamente maggiore di
persone. Il punto è che non c’è una formula univoca per queste cose, è giusto
che ogni band trovi la sua strada.”
Una cosa sembra chiara a que-
sto punto: il DIY targato 2010 è innanzitutto un'esigenza dettata dalla
necessità, tutt'al più da una scelta
estetica, lontano in questo senso dal
fenomeno apparentemente analogo
che seguì l'esplosione del punk. Tanto
meno c'è traccia del rigore etico che
stava dietro alla cultura dell'autoproduzione che negli anni 80 proliferava
intorno ai centri sociali. Registrare
musica e produrre dischi in proprio
oggi è un modo come un altro di far
conoscere il proprio lavoro, di solito
complementare alla creazione di una
paginetta su MySpace, alla gestione di
un blog o all'aggiornamento del proprio account su Facebook e Twitter.
E' un'esigenza dettata dall’urgenza
espressiva e dal vecchio principio del
“be here now”, resa efficace dall’abbattimento dei costi di produzione
e di promozione legati allo sviluppo
della Rete. Paradossalmente è proprio questo approccio low profile a
renderla così popolare. Creare un
network di artisti e un'infrastruttura
capace di diffondere il frutto del proprio ingegno, oggi è la cosa più naturale del mondo, ed è questo che la
rende così pericolosa per il mercato
tradizionale.
E' per questo che i Male Bonding
continueranno a produrre materiale
su minuscole etichette (così come
dall’altra parte dell’oceano le Dum
Dum Girls faranno uscire la versione
vinilica del loro album per HoZac),
“prestando” in questo modo la loro
notorietà a gruppi con cui condividere i progetti più disparati. Allo stesso
modo la Paradise Vendors Inc continuerà a produrre materiale sfruttando la nube di hype addensatasi
attorno alla band. “Una cosa deve essere chiara: con la PVI abbiamo sempre
pubblicato dischi di gruppi che consideriamo amici. Band che amiamo e che
vogliamo supportare.”
Ora però la cosa si fa seria. C’è
un universo di band e sonorità da
scoprire, e se i mezzi per farlo non
bastano, è arrivato il momento di unire le forze. N ew gangs in town : Fair O hs , M azes , Cold P umas ,
L a L a Vasquez
"E’ rincuorante sapere che i Male Bonding continueranno a produrre materiale
con la propria etichetta. In questo modo saranno d'esempio per tutte quelle realtà
acid pop e lo-fi punk d'Albione che vogliano intraprendere il loro stesso percorso."
Sono sempre le parole dello zio Alan McGee, che avevamo lasciato con l’increscioso compito di presentare ad un mondo in bilico fra mainstream ed
indie di maniera, la compilation che sancisce ufficialmente la nascita della
“cosa”.
Su questo punto John Arthur Webb è chiaro: “preferisco parlare di ‘community’ piuttosto che di una vera e propria ‘scena’. Le band che ne rappresentano il
cuore pulsante, sono costituite per lo più da persone che si conoscono molto bene, si
frequentano e si stimano, di conseguenza cercano di aiutarsi in ogni modo. Questo è
il senso dell’operazione che ha portato Paradise Vendors Inc e Italian Beach Babes
a programmare l'uscita del disco.”
Dieci band stipate in un 12’’ che ha per titolo il numero di catalogo congiunto delle due label: PVI006 / IBB004, stampato in appena 500 copie, probabilmente sarà già sold out nel momento in cui leggerete queste righe. Fra
blogs e webzines è un susseguirsi di consensi, a cui non poteva che aggiungersi quello di Pitchfork.
Vediamole dunque le band più significative di questa community.
Fra tutti i Fair Ohs sono quelli che possono vantare la discografia più
cospicua, costituita principalmente da materiale pubblicato in modo semi
amatoriale. Sono autori di un'emozionante commistione di sonorità abrasive
e ritmi calypso, che richiama da vicino l’afro pop dei Vampire Weekend.
Attenzione però, perchè il loro sound è in costante evoluzione. Basti pensare
che solo pochi mesi fa il terzetto, che si dichiara fan dei Black Flag, era dedito ad un furibondo hardcore in bassissima fedeltà: “E' stato Eddy (il chitarrista)
- spiegano - a portare nella nostra musica influenze afro. Lui è appassionato di
musica Benga (un genere popolare, diffusosi in Kenya intorno agli anni 60). Quando
abbiamo iniziato a provare ci siamo resi conto che era un tipo di sound con cui
ci trovavamo perfettamente a nostro agio. La nostra idea, sin dall’inizio, era quella
di trasmettere vibrazioni positive: è esattamente quello che fanno queste nuove
canzoni.”
Naturalmente gestiscono la loro piccola label: si chiama Suplex Cassetes
e, come è facile intendere, produce solo nastri, dalle curatissime confezioni
handmade. Fra le numerose uscite si possono contare le più interessanti realtà lo-fi garage locali, mentre per il 2010 sono già schedulate le prime realease
di gruppi esteri, nonché una compilation surf a cui parteciperanno, fra gli altri,
gli stessi Fair Ohs e i più noti Lovvers.
Spectrals è un altro moniker su cui si concentrano le attenzioni degli
appassionati. Dietro allo pseudonimo si cela Luis Jones, una sorta di oneman-wall-of-sound-band, innamorato di Diana Ross e del doo woop, autore
di una versione deforme della teen music dei primi sixties. Il suo è un sound
distorto e grottesco: quello che succederebbe se Phil Spector avesse deciso di produrre la colonna sonora di un film horror. Di recente, si è dato da
fare aprendo concerti per Big Pink, Crocodiles e Eat Skull, fino a che Mike
Sniper della Capture Tracks non si è letteralmente innamorato del suo sound
33
'spettrale'. Al loner britannico è stato offerto di pubblicare un 7’’ ed un
album che vedranno a breve la luce
grazie all'etichetta di San Diego, nel
solco di solo project come Blank
Dogs, Dum Dum Girls e Wavves.
Bowie Knives e Painting of Tupac
Shakur sono i titoli che i Mazes, sorta di joint venture fra londra e Manchester, hanno scelto come biglietto
da visita. Negli ultimi mesi sono rimbalzati per siti e blog come molecole
impazzite, raccogliendo unanimi consensi. Nel primo sembra di ascoltare
un meraviglioso out take dei primissimi Dinosaur Jr, mentre il secondo
consiste in un alternarsi di riverberi
atmosferici e chitarre sfrigolanti che
finiscono per coagularsi in una liberatoria cantilena pop punk. Sono bastati questi due pezzi, a fronte di una
vasta produzione casalinga, a fare dei
loro autori uno dei nomi più monitorati della Rete.
John Cooper, il leader della band,
cura un blog grazie al quale tiene
contatti con labels e gruppi affini, documenta ogni tipo di attività che lo
vede impegnato in prima persona o
con la band (come nel caso del recente tour con gli shitgazers Box
Elders) e diffonde la propria musica con ogni mezzo. Lo scorso anno
dopo aver atteso che la minuscola
Sex Is Disgusting (altra etichetta del
giro DIY) pubblicasse cinque brani
appena incisi dai Mazes, ha deciso di
mixarli in un'unica traccia e lasciarli
liberi di navigare in Internet. Questo aspetto, unito a dichiarazioni pittoresche tipo quella rilasciata recentemente al NME (“i talent
scout delle majors dovrebbero uccidersi
a vicenda”), ne fanno uno dei portavoce del nuovo modo di intendere il
Veronica Falls
rapporto fra musica e business. Nel
suo caso il lo-fi diventa una scelta di
campo: “Credo che ci fosse qualcosa di
veramente eccitante nel modo in cui la
Fliyng Nun realizzava i propri dischi agli
inizia degli anni 80. Non avevano soldi
34
ne tempo da spendere e di certo non
potevano permettersi di passare settimane in uno studio. Tuttavia in quelle
registrazioni c’era una spontaneità che
vorremmo trasmettere nelle nostre canzoni.”
Per questo motivo il passaggio
dalla composizione dei pezzi alla registrazione avviene senza soluzione di
continuità: “Siamo molto veloci, possiamo perfino registrare quattro o cinque
canzoni in una giornata, non importa
come”.
La prima intervista rilasciata alla
webzine Loud & Quiet portava come
titolo “Non puoi dirti lo-fi finchè non
mixi la tua musica con televisore Sony”,
sembra infatti che, almeno nei primi
tempi, Cooper e compagni fossero
soliti registrare i brani con un Tascam
Portastudio e mixarli usando un televisore Sony. “Il fatto è che non avevamo speakers, così abbiamo provato a
far passare la musica dalle casse del televisore e sembrava che suonasse molto
bene”. Dichiarazioni queste che hanno mandato in brodo di giuggiole tutti i fanatici del DIY più intransigente.
Sogni per il futuro? Fare da backing
band per Mark E. Smith e suonare
insieme a Jonathan Richman. Il solito Cooper ha già diffuso un appello
in Rete, chiedendo a chiunque ne abbia la possibilità di far sì che il loro
sogno si realizzi.
Brighton fa da sponda alla scena
sfornando due delle realtà più interessanti. I Cold Pumas, pur avendo
percorso gli inevitabili “sette passi”
del artista lo-fi, sembrano essere solo
di passaggio nel mondo dell’autoproduzione. Il loro è un cervellotico
noise pop in Abe Vigoda style, stralunato e ultra riverberato, articolato in
rigide strutture kraut rock e ritmiche
ossessive. Nel loro caso il termometro dell’hype si alza a livelli di guardia,
anche se, alla luce del primo singolo
Jela, in cui sembra di ascoltare una
versione lo-tech degli HEALTH, tanto clamore sembra essere, per una
volta, ben riposto. Per promuovere il
brano è stato girato anche un video,
realizzato dal regista indipendente
Dan Nixon, che vede la band immortalata come un'agguerrita macchina
da guerra, durante la partecipazione
dello scorso anno all’Offset Festival.
Le La La Vasquez prendono il
loro nome da una nota vj americana
e sono l’ennesimo trio al femminile
nato, al pari delle PENS, quasi per
scherzo. Sfoggiano schegge di sgangherato garage pop, memore delle
scorribande pop punk di Shop Assistants e Talulah Gosh, anche
se, dal canto loro, si dichiarano fan
di L7 e di tutto il punk al femminile.
Hanno capito che le cose si stavano
facendo serie quando gli è stato offerto di aprire il concerto di Dum
Dum Girls in occasione del tour britannico. La loro comunanza al sound
istintivo delle Vivian Girls, ha spinto
la solita Captured Tracks a pubblicare
il loro primo singolo Mexican Ghost
(On a Boat), in uscita proprio in questi
giorni. Ci sono, o meglio c’erano, anche
i Teen Sheiks, fantastica band sotto
la stretta osservazione delle etichette
dell’area californiana. Purtroppo quella che sembrava essere la più promettente delle realtà di Brighton, ispirata
dai Wipers di Greg Sage, nonché
autrice di schegge di crepitante punk
wave, ha posto fine alla sua corsa al
termine del 2009, dopo nemmeno un
anno di attività. Un peccato, certo, a
testimonianza, però, di come la scena
sia in continua evoluzione. Le band si
sostengono vicendevolmente, condividono palchi, studi e musicisti, come
nel caso di quella che potremmo definire la band più attesa nel preciso
momento in cui mi trovo a scrivere
queste righe.
un ora, quando ricevettero la mail in cui Mike Sniper chiedeva loro di incidere
un pezzo su Captured Tracks. Ok, direte voi, ormai è chiaro che mister Blank
Dogs considera la scena britannica come il discount con il miglior rapporto
qualità/prezzo. Nel caso del combo in questione però la sua scelta è avvalorata dall’attenzione che la band sta suscitando al di là dei confini della discografia indipendente. La leggenda vuole che si siano conosciuti ad un concerto
dei Comet Gain e che, in quanto membri di bands piuttosto hyped come
Your Twenties, Royal We e Sexy Kids, si possano considerare una sorta
di supergruppo dei recessi underground. Una cosa sembra certa: in questo
momento sono loro l’oggetto del desiderio. I ricostituiti Pastels se li sono
portati in giro come band di supporto nel loro recente tour e l’impressione
è che si cerchi di farne la versione britannica dei Pains Of Being Pure At
Heart.
Con loro inizia il processo di riappropriazione del pop britannico degli 80s
da parte delle lo-fi band d’Albione. Loro si dichiarano fans del romanticismo
di Chills e House Of Love, delle liriche malate di Rocky Erickson, tribalismo di Mo Tucker e della new wave in bianco e nero targata Postcard:
“Band come Orange Juice, Josef K e Aztec Camera avevano una visione
originale e multidimensionale del suono – sono le loro parole – I primi, in particolare, hanno fornito alle band del C86 la loro ragion d’essere, suggerendo l’importanza di preservare anche in età adultà l’innocenza dell’adolescenza”. Parole che di
per sé suonano come un manifesto dell’ala più pop’n’dreamy della nuova scena. Ascoltando il primo singolo I Found My Love In The Graveyard, perla jangle
pop carica di brezze shoegaze, sembra di essere tornati in dietro di un quarto
di secolo: la naiveté, la grana melodica, perfino il candido timbro di Roxanne
Clifford ricordano quello di band come Primitives e Darling Buds.
Con ogni probabilità saranno loro, più degli spigolosi Male Bonding, a fungere da cerniera fra la nebulosa delle micro label e l’agonizzante industria
discografica, già pronta a normalizzare l’onda anarchica del lo-fi.
E poi? Sicuramente indietro non si torna. È facile prevedere che un loro
possibile successo possa spingere un numero crescente di artisti a intraprendere un simile percorso, innescando un meccanismo virtuoso che farà del
DIY, e in generale della creatività veicolata dal basso, il fenomeno principale
con cui imparare a confrontarsi a partire da ora.
L o - fi hipsters : Veronica
Falls
Dei Veronica Falls si dice che il
loro MySpace fosse on line appena da
35
Recensioni
65daysofstatic - We Were
Exploding Anyway (Hassle
Records, Aprile 2010)
G enere : post - rock
Colpi come palpitazioni di un cuore robotico aprono il
comeback del combo inglese e sembrano ridisegnarne
una nuova vita: Mountainhead parte infatti sotto i migliori
auspici grazie a un'ottima alternanza tra ritmi digitali e
chitarre emotivamente in crescendo, prive però di prolissità o dell'epica da eroi senza macchia del post-rock.
Il timore dopotutto era dietro l'angolo, visto che da The
Destruction Of Small Ideas la parabola dei 65dos sembrava
miseramente quanto inesorabilmente discendente. E invece We Were Exploding Anyway riaccende il sacro
fuoco della passione per il quartetto di Sheffield: le belle
fiammate di Weak4 - anche primo singolo del disco - fanno muovere il culo oltre che il cervello, l'electro afasia
ossessiva di Go Complex rinverdisce i fasti del passato
prossimo, la lunga Debutante alterna la dicotomia vuoto/
pieno impastandola di una sognante melodia, Crash Tactics tira fuori chitarre aggressive e piglio sfacciato mentre
la successiva Dance Dance Dance va di cafonaggine postTrainspotting, ovvero come far collidere dancefloor pestone e chitarre heavy.
Lontano dalla catastrofe che temevamo, We Were Exploding Anyway risolleva le sorti di un quartetto il cui effetto
sorpresa sarà anche svanito da tempo, eppure per una
buona metà riesce a vivere di begli equilibri, dinamiche
mobili e sonorità coinvolgenti.(6.5/10)
Stefano Pifferi
@C - Music for empty spaces
(Baskaru, Marzo 2010)
G enere : P ost -G litch
Pedro Tudela e Miguel Carvalhais, ovvero gli @c,
sono l'unica promessa portoghese mantenuta del dopoglitch in ambito europeo, e tra i pochi e rari musicisti di
quella generazione a dare un valore affettivo alla musica
frammentata che compongono. Passati su Sirr, Crònica,
Grain of Sound, approdano ora sulla francese Baskaru.
Music for empty spaces è un diario di bordo, vertiginosamente allucinatorio, registrato tra Lisbona, Nagoya,
Glasgow, Parigi. Un taccuino dove sono annotati scam36
— cd&lp
poli di luoghi, registrati così bene da sostituirsi alle tracce, partizioni di collassi sonori e gente, nature plastiche
che involvono in conflitti e contesti trasposti.
Si tratta di un lavoro non troppo dissimile da quello di
un reporter di guerra, contemporaneamente frapposto
sul corpo della terra (da qui la sua particolare ascultazione, dove a filtrare sono oggetti, pareti, rivestimenti,
membrane) ed insieme sull'interno delle cose (il processing più che modificare amplifica millimetricamente
tutte le istanze, come quella di un orologio, di un porto,
di una campana). Sbalordisce e riesce in sostanza l'equilibrio perfettamente bilanciato tra microsuoni e dettagli
e corpi più frattali e pesanti che donano al materiale
un'istanza tattile così veritiera e sacrale che si fa fatica a
chiamarla solo-musica.
Come nell'ultimo Marc Behrens, si parla di geografie, luoghi che respirano ed esplodono, di nature molto
poco da cartolina e molto spesso mortali e devastanti.(7.5/10)
Salvatore Borrelli
AA. VV./Dompteur Mooner - Elaste
Vol. 3 - Super Motion Disco
(Compost Records, Marzo 2010)
G enere : C osmic , I talo , D isco
Torna a scegliere i brani della Elaste il buon Dompteur
Mooner, conosciuto ai più per far parte del combo
Zombie Nation. Per il terzo volume della serie su
Compost, il DJ viaggia su coordinate cosmic disco e
funky, che in questi tempi sono entrate di nuovo a far
parte del ritmo à la page (vedi le uscite di Prins Thomas e Lindstrøm e la fascinazione per gli ‛80
dei Minimal Wave Tapes).
La selezione di tracce non mixate si rifà alle cassettine
che Daniele Baldelli e Beppe Loda erano soliti assemblare per le festine degli yuppies rampanti in giacca e cravatta, pronti per l'ennesima puntata del Drive In. Ricordiamo quindi ancora una volta le spalline e le paillettes,
ma siamo consci che in queste 14 tracce c'è quella patina
di archeologia che ci trasmette l'amore per il remember
d'effetto: si va dall'uberpop di Riccardo Cioni (Fog) alla
cosmic disco primigenia di Moebius (Urth), dal trashfunk di Maccaroni Radio al ricordo dei Depeche Mode
highlight
Amor Fou - I Moralisti (EMI, Maggio 2010)
G enere : canzone d ' autore
E alla fine lo si dovrà pur trovare il disco. Quello che racconti questi anni con la precisione necessaria,
con l'urgenza indomita propria di chi vede crollare ogni cosa nell'indifferente tutti contro tutti odierno.
Quello che, al di là di ogni blockbuster feltrinelliano e di ogni istinto apparentemente generazionale, cerchi una via (felicemente) intellettuale dentro ma contro lo zeitgeist contemporaneo, prima della caduta
o forse durante essa, chissà. E sono gli Amor Fou questa volta a provarci, andando a scovare quelle vite
lontane dalla pseudorealtà televisiva dove permane e si svela una morale,
intesa come capacità di compiere una scelta di vita, non necessariamente
positiva ma capace a sua volta di svelare molto di un Paese sempre più privo
di stimoli e sempre più atomizzato nel suo essere ancora massa e per giunta
di individui.
I Moralisti, appunto. Ovvero ciò che hanno già fatto in tanti qui da noi, ma
nessuno con gli stessi risultati eccellenti di un Benjamin Biolay in Francia.
Prendere una tradizione, quella cantautorale tanto nobile quanto infeltrita
sia di qua che di là dalle Alpi, e instillarle una botta di vita, quindi di bellezza
come apertura al nuovo, per aggiornare chi ascolta e aggiornarsi, con efficacia e grazia. In altre parole
i Blonde Redhead dentro De Gregori, gli Wilco infiltrati in Guccini, i National tra le costole di
Venditti. Per fare il disco che costoro, dinosauri se non proprio pinocchi coi pianoforti a tracolla, non
faranno più.
Ecco dunque dopo un cambio di formazione (via Malfatti e Saporiti, dentro Giuliano Dottori e Paolo
Perego) e una sterzata anti-Morr verso l'analogico, quella manciata di canzoni che potrebbero mettere
il punto e a capo ai tanti discorsi sullo stato di salute della nostra canzone d'autore, costruite con versi
rapidi e incisivi come i frame cinematografici di Petri o Sorrentino. Le rotondissime frange di piano e
drumming vigoroso delle splendide De Pedis e Anita, il Paolo Benvegnù sciolto da ogni laccio lessicale
di una ballad a dir poco commuovente qual è Le promesse, il beat lampeggiante come un'insegna sixties
di Peccatori in blues jeans, la dolceamara filastrocca degregoriana de Il mondo non esiste, il già sentito ma
apprezzato prestito Battisti di Filemone e Bauci. E su tutte il megalite sonico di Dolmen, come gli Altro
se scrivessero tre righe tre per gli Interpol e ne venisse fuori non solo una canzone d'amore spaccaossa,
ma proprio il mausoleo funerario, sociale poiché esistenziale, di una collettività che, frammentata in tanti
«io» e «tu», lamenta un rabbioso e disperato «fossimo almeno noi».
Alessandro Raina, finalmente all'altezza anche nell'interpretazione, non ha mai scritto così bene, con così
tanta precisione e imprevedibilità, come qui. A proposito: fate l'elenco dei personaggi narrati e diteci se li
avreste mai immaginati per un titolo come I Moralisti. Un motivo in più per augurare un ruolo di opera
definitiva ad un disco che per ora è sicuramente un bellissimo capolavoro.(8/10)
Luca Barachetti
37
in The Shark Eats Ice. Se non resistete, andate a vedervelo
a Monaco: Dompteur suona una volta al mese nel club
Die Registratur. Il prodotto è buono, ma resta comunque
da segnalare solo agli aficionados.(6.1/10)
Marco Braggion
AA. VV./Juan MacLean (The) - DJ
Kicks (!K7, Aprile 2010)
G enere : disco house
Nuova grafica e nuovo corso per la longeva serie di compilation della berlinese !K7. Confidando nella mano fatata
di VIP del panorama ritmo mondiale, i guru della capitale
tedesca scelgono come primo alfiere della seconda repubblica Kicks l'amico di James Murphy (mente degli
LCD Soundsystem). DFA in testa e personalità sui fader
della consolle. Istinto in purezza, Maclean fa lo spot a un
modo di sentire house di pancia che non si intestardisce
su inutili intellettualismi o su scioccanti sfarfallii 80.
Pesta senza strafare, si lascia ascoltare come i vecchi cugini dell'ondata french più affine al jazz (St. Germain
un nome per tutti) e replica il clubbismo più sano e
soul che nella grande mela ha il suo olimpo. Un viaggio
attraverso recenti progressività disco (Spaghetti Circus e
la versione di Todd Terje di Simple Things), tech-house (i
cuts di Florian Meindl e Alex Niggemann), il classico acid
(l'edit di Thomos su Armando) e l'inedito per la compila
(Feel So Good con il featuring chic di Nancy Whang).
Mixato in analogico, con due giradischi, pochi filtri e un
delay a nastro: "Volevo fare qualcosa che fosse rappresentativo sia del mio background sia dello stato della
house music contemporanea". Obiettivo riuscito Juan.
Divertimento assicurato targato NY.(7/10)
Marco Braggion
Alessandro Fiori - Attento a me
stesso (Urtovox, Marzo 2010)
G enere : A vant -F olk
Alessandro Fiori è un cantautore fuori posto. Un esistenzialista da osteria. Uno che andrebbe bene per il
Big Lebowski dei fratelli Coen - recuperate il video Se io
avessi un cane sul suo sito ufficiale e capirete il perché non fosse un musicista. E invece si dà il caso che sia un
fine compositore, titolare di una discografia sparpagliata in progetti paralleli, numerose collaborazioni (Marco
Parente, Andrea Chimenti, Paolo Benvegnù) e un'ispirazione lucidissima. Quel quid che lo fa assomigliare a un
Lucio Dalla surreale o un John De Leo spogliato dai
tecnicismi della voce ma perso allo stesso modo in un
universo scollegato dall'attualità.
L'immaginario del suo primo disco solista è un po' quello
dei Mariposa e non potrebbe essere altrimenti visto che
38
il Nostro è da dieci anni il front-man della formazione bolognese. Anche se dal progetto in solitaria di Fiori
emerge ancor più forte quello che è il tratto distintivo
della sua poetica, ovvero
la capacità di unire serietà
nella scrittura e approccio
ironico, disillusione e leggerezza, testi impegnati e delicatezza nelle melodie. Un
bypassare i luoghi comuni
del genere affidandosi a una
parte musicale malinconica
che mescola spartiti à la Tim Hardin (Senza le dita) e
Love (Catino Blu), Weill/Brecht (La Vasca) e pre-war
folk all'italiana (Trenino a cherosene), musica da camera
mista a cabaret (Fiaba contemporanea) e Paolo Conte
in salsa rock (2 cowboy per un parcheggio).
Fiori impacchetta la realtà in una quotidianità autobiografica e sopra le righe leggendola come si potrebbero
leggere le istruzioni di montaggio di un mobile Ikea: con
qualche dubbio e la curiosità di vedere come va a finire.
Anche se in generale si parla comunque di un'operazione raffinata che privilegia l'arrangiamento e l'estrema
professionalità dei musicisti coinvolti nel progetto. Nello
specifico, Alessandro Stefana, Marco Parente, Zeno
De Rossi, Danilo Gallo e Enrico Gabrielli.(7.4/10)
Computer in aurea celestiale di L'idea di te, eppure sono
colpi di reni sempre incastrati in un certo periodo, che
non riescono a distogliere l'attenzione dell'ascoltatore
da evocazioni già ampiamente vissute - in sintesi: il poprock di qualità che dai primi novanta ci ha portato agli
anni zero, vedi l'accento Jeff Buckley de Il principio di
conservazione. Forse è proprio venuto il momento di
buttare in aria il tavolo e ricominciare da zero. Che lungo
queste vie non si andrà mai oltre una sufficienza meritata
ma assai imbrigliata dalle prerogative di partenza.(6/10)
Fabrizio Zampighi
Giampaolo Cristofaro
Luca Barachetti
Allo Darlin' - Allo Darlin' (Fortuna
Pop!, Aprile 2010)
G enere : S unshine P op
Un volto sfocato che guarda lontano con le mani a mo'
di binocolo e alle spalle il cielo velato da nubi. Sul retro:
gambe nude in primo piano e mare limpido sullo sfondo.
Dalla copertina si capisce già tutto: Allo Darlin' è Elizabeth Moss, novella portatrice del vessillo del sunshine/
twee pop di matrice Sarah Records o di band come Belle & Sebastian e The Orchids.
Pezzi sbarazzini, coretti e chitarrine lanciate in leggiadri
arpeggi, mandolini scintillanti, melodie in chiaroscuro (o
chiarogrigio, in effetti) e quella sostenibile pesantezza
dell'essere che può rendere la vita migliore.(6/10)
Alibia - Manuale apocrifo delle
giovani marmotte (EMI, Marzo
2010)
G enere : pop - rock
Apples In Stereo - Travellers In
Space And Time (Yep Roc, Aprile
2010)
G enere : P sycho pop
Viene difficile negare che gli Alibia abbiano ascoltato
molto gli Scisma, quelli di Rosemary Plexiglas soprattutto, e che ne abbiano interiorizzato le dinamiche
e le suggestioni. L'incrocio non troppo netto fra voce
maschile e femminile in primis; poi un certo spleen chitarristico vigoroso ma smussato verso il pop, cui fanno
da cesello le melodie non troppo pronunciate di due pianoforti; infine un approccio lirico che cerca via diverse
grazie ad accostamenti lessicali imprevisti o citazioni fra
le più disparate (qui Baudelaire, Mogol, ma anche lo slogan di una nota marca telefonica). Ed è proprio da questa
(gravosa) derivazione che il gruppo salernitano, arrivato
ormai al terzo disco, dovrebbe svicolarsi. Perché gli Alibia
il loro compito di songwriters tipicamente novantiani lo
fanno alla perfezione, ma negli undici brani di Manuale
apocrifo delle giovani marmotte urgerebbe una pur
minima zampata che tolga il disco dalla moltitudine dei
lavori buoni ma già sentiti.
I tentativi non mancano, come nei Radiohead post Ok
Travellers In Space And Time è l'album in cui Robert Schneider abbandona ogni indugio e invita i suoi
fan a ballare.
Ricalibra lo psycho pop della sua creatura su un tappeto ritmico che costringe a battere il piedino dalla prima
all'ultima traccia e ci regala il suo disco più immediato di
sempre, quello che fa tesoro di un songwriting perfezionato nell'arco di una carriera pressoché impeccabile.
In un certo senso non ci poteva essere momento più
propizio. A tutti coloro che hanno apprezzato le ultime
evoluzioni sintetiche degli
Of Montreal, i coloratissimi pastiche retrofuturisti
dei MGMT, questi brani
suoneranno come dei marchingegni di perfezione algebrica.
Il dancefloor immaginato
dagli Apples In Stereo è
di quelli in cui il funky e i falsetti della disco si sposano
con vocoder ed elettronica vintage.
Dance Floor, il primo singolo, è lì pronto a deflagrare grazie al ritornello killer e un appeal glam che strappa il
sorriso al primo ascolto.
I fan della prima ora troveranno familiarità con le melodie beatlesiane di It's All Right o con lo squadratissimo
power pop di Dignified Dignitary, il cui riff whoiano sembra tagliato con l'accetta, ma sono i groove gommosi di
brani come Told You Once e le cromature sintetiche sparse un po' ovunque, a restituire lucentezza all'astronave
Apples In Stereo.
Con l'invidiabile risultato di rinfrescare una formula che
rischiava di stagnare e consegnarci il miglior disco della
band da molto tempo a questa parte.(6.9/10)
Diego Ballani
Ash - A-Z Series Vol.1 (Atomic Heart
Records, Aprile 2010)
G enere : I ndie rock
Onestamente, li davo per persi gli Ash. Da troppo tempo il loro pop rock teenageriale aveva perso smalto e il
gruppo sembrava indirizzato inesorabilmente verso un
prematuro (e alquanto triste) finale di carriera.
Vederli, appena trentenni, prendersela con le incomprensibili dinamiche del mercato discografico, all'indomani dell'ultimo e bruttino Twilight Of Innocents, era
una cosa che stringeva il cuore, soprattutto se li si aveva
amati al tempo dei loro fulminanti primi singoli.
Quello che sembrava un estremo gesto di disperazione
(la volontà di bypassare i canonici e obsoleti formati discografici, pubblicando un nuovo singolo ogni due settimane, per un anno intero) si è rivelata invece una mossa
vincente. E' come se la perentoria scadenza dei quindici
giorni avesse funto da pungolo per gruppo e gli avesse
fatto recuperare l'urgenza degli esordi.
Ora, con un ripensamento tipicamente radioheadiano, la
prima parte del progetto si è materializzata in un cd vero
e proprio: si intitola Vol.1 e fotografa il lavoro svolto dalla
band nel corso dei primi sei mesi delle A-Z series.
Si tratta di 13 brani che sono, senza mezzi termini, la
miglior sequenza inanellata dal combo irlandese dai tempi di 1977. Attenzione, non è che Tim Wheeler, sia diventato improvvisamente un songwriter maturo e compassato. Tantomeno ha imparato a interpretare i pruriti
degli odierni adolescenti. Piuttosto è accaduto che, vuoi
per mestiere, vuoi perché essendo ritornato a essere
un trio, il gruppo ha riacquisito quell'agilità che ne aveva
contraddistinto gli esordi, gli Ash abbiano ricominciato a
divertirsi.
39
Ecco così spiegato l'entusiasmante pop punk di Arcadia, i
Kinks a 78 giri di Ichiban, le cromature electro di Space
Shot, il brit rock leggero come una piuma di True Love
1980: piccole cose che non ti cambiano la vita, ma ti fanno ricordare di quando la musica la vivevi con la pancia,
più che con la testa.(6.7/10)
Diego Ballani
Aucan - DNA (Africantape, Aprile
2010)
G enere : post - math - rock
DNA è un ep, almeno ufficialmente, anche se per durata e soprattutto suggestioni è un album a pieno diritto.
Nello stesso modo in cui l'omonimo esordio prometteva, sin dalla foto di copertina, la frantumazione di un
retroterra musicale di matrice dopo-rock, DNA fa un
passo ancor più profondo, ponendo sin dal titolo al centro dell'ep la riflessione sul codice genetico del gruppo
bresciano.
L'ossatura ritmica, innanzitutto, vero pilone portante del
suono della band e che qui sottende ad almeno 4/5 del
disco: inasprita verso un ossessivo pulsare (quasi)techno
(Rooko) o in un dancehall para-industriale alla Blade Runner (Crisis); o ancora, aprendosi a melodie black trasfigurate in DNA o palesandosi in trasversali rimandi battlesiani in Urano 2, complice anche il raddoppio percussivo
di Jacopo Zu Battaglia. È però l'insieme virato al nero,
plasmato su atmosfere sinistre e immmaginario da droga
andata a male, come di capannoni industriali in disuso
o disgregarsi di materia (una volta) vivente - perdetevi
nel lungo, straniante, droning da giorno del giudizio di
The Darkest Light - a dare un senso al tutto. Un nuovo
senso di intendere la propria natura musicale, il proprio
DNA.(7/10)
Stefano Pifferi
Benni Hemm Hemm - Retaliate EP
(Kimi Records, Marzo 2010)
G enere : indiepop - songwriting
Gli islandesi Benni Hemm Hemm ci consegnano un
nuovo EP e la voglia di citare i classici, da Leonard Cohen
e Nick Drake in avanti: è da lì che si parte per leggere
Retaliate EP. Church Loft si fa molto interessante nel momento in cui questo cantautorato si fa corale, per effetti
di sovrapposizione tra voci che si fanno il controcanto e
accompagnamento di chitarra che sembra moltiplicarsi,
in una lentissima processione collettiva, che finisce proprio con una sorta di canto del cigno di una banda. Shipcracks è sicuramente più enfatica, più tradizionale, con
però un delicato tempo dispari che rende questa marcia
dolce.
40
In generale, di questi Benn Hemm Hemm convince quindi ciò che normalmente convince di un cantautore: la
capacità di scrittura e di arrangiamento. In questo caso
- principalmente in Blood On Lady Lawson - il metodo
utilizzato crea dei crescendo con effetto corale che si
basano su una melodia trascinante. Riuscendo a creare
l'equilibrio ottimale, non passando né per mielosi né per
calibratori. Un EP che ce li farà riascoltare.(7/10)
Gaspare Caliri
Black Eagle Child - Poland
(Sturmundrugs, Gennaio 2010)
G enere : F olk
Delle scorribande psych di Michael Jantz abbiamo già
detto recensendo lo split con il russo Sergey Kozlov,
uscito sempre sulla vitale etichetta Sturmundrugs.
Con Poland, il musicista meglio conosciuto come Black
Eagle Child (nome ispirato a un romanzo dello scrittore nativo americano Ray Young Bear) svela, come è tipico
di artisti che operano a queste latitudini, la propria vena
intimista, e con essa una manciata di canzoni tenute nel
cassetto di una cameretta nella quale si sono le spoglie
di un folk di cui è rimasta solo l'ossatura - o l'idea: voiceless, Jantz imbraccia una chitarra acustica e si serve,
all'occorrenza, di una fisarmonica, una melodica, qualche
effetto, voci registrate, laddove il richiamo di altri mondi
si fa sentire appena (White Fly).
Talvolta ci è parso di essere dalle parti di un Josè Gonzalez afono (Days Before), talaltra abbiamo gioito di
un'epifania che ci ha fatto ricordare per un momento il
progetto solista di Bruno Duplant (aman&aguitar).
Mezz'ora di quiete prima di rituffarsi anima e corpo in
quel magma di psichedelia freeform del cui verbo sturmundrugs si sta rivelando sempre più credibile alfiere.(6.5/10)
Vincenzo Santarcangelo
Black Keys - Brothers (V2 Music,
Maggio 2010)
G enere : blues rock
Non si fermano più Dan Auerbach e Patrick Carney:
dopo un 2009 che li ha visti dediti a progetti solisti
(Dan), band parallele (Patrick) e progetti alternativi (il
controverso Blakroc), neanche il tempo di riprendere
fiato ed ecco Brothers, sesto album a firma The Black
Keys. Probabilmente il loro lavoro più soul, a partire dal
suono, caldo e sfrangiato, distorto come certi sentimenti
quando la temperatura si fa troppo elevata. Un suono,
consentitemi, vintage che più vintage difficilmente si può,
pur con tutta la voglia di lanciare sfide alla contemporaneità con quei fuzz che si spampanano e confondono
highlight
Audio Bullys - Higher Than The Eiffel (Cooking Vinyl UK, Marzo
2010)
G enere : UK, house , mesh
Dopo quattro anni tornano Simon Franks e Tom Dinsdale. E se da Londra ultimamente ci arrivano
solo novità dubstep o di rock visionario, sappiate che l'house non è morta. I
due lo confermano e, come dei nuovi Crookers (Smiling Faces), sponsorizzano una tamarritudine che pesca tra i migliori riferimenti now: Riva Starr
e Noze in The Future Belongs To Us, la generazione post-Prodigy nel singolo
Only Man, il ricordo Happy Mondays con delle bordate da panico 90 in
Feel Alright, l'hip-pop dei migliori Gorillaz in Daisy Chains. In più c'è il richiamo al mesh del Robbie Williams più truzzo (London Dreamer), il fidgeting
tagliato rock à la Justice in Shotgun e per chiudere pure lo ska à la Manu
Chao di Goodbye.
L'accozzaglia di derive e tagli non sborda però in un inutile citazionismo, bensì riporta il savoir faire di
una old school house UK che non demorde e riscopre il miscuglio rock-dance che da un po' ci eravamo
dimenticati (vedi le distorsioni cosmiche di Kiss The Sky). Due che non perdono il colpo e che riescono
in tempi non sospetti a costruire un prodotto che - pur restando fedele ad un'indipendenza storica - si
trasforma piacevolmente in pop. Orgoglio da hooligans isolani con le facce da Trainspotters. Thumbs up
for Audio Bullys!(7.4/10)
Marco Braggion
tra le tastiere, grattando la pancia antica ma viva della
bestiolina blues-rock.
Il risultato è una psych melmosa e vibratile (Black Mud),
i piedi comunque ben piantati tra magagne terrene anzi
viscerali (She's Long Gone, Too Afraid To Love You). C'è Mike
Neill a dirigere la sala d'incisione, che già aveva ben lavorato nel buon Keep It Hid (il suddetto esordio solista di
Auerbach), anche se a Danger Mouse viene concesso
di salutare l'auditorio producendo il singolo Tighten Up,
non a caso una delle tracce più disinvolte della scaletta.
I cui pezzi pregiati sono appunto quelli che azzeccano la
miscela più stordente tra rigurgiti sixties e spasmi acidi
di varia natura, come quella Go Getter che centrifuga soul,
psichedelia funkadelica e hip-hop, o quella The Only One
che spalma fregole Marvin Gaye su un tapis roulant
non indenne da perturbazioni wave.
Se poi vogliamo parlare di scrittura, i ragazzi se la cavano
piuttosto bene, sono lontani dall'aver esaurito la vena,
trovandosi a loro agio soprattutto con le ballate (Ten
Cent Pistol, I'm Not The One, la stupenda These Days) ma
regalandoci anche un paio di graffi niente male (Howlin'
For You, Next Girl), per poi tornare a concedersi l'antico
vezzo della cover con Never Gonna Give You Up del soulman Jerry Butler. Ben fatto, Pat & Dan.(7.3/10)
Stefano Solventi
Blank Dogs - Phrases EP (Captured
Tracks, Marzo 2010)
G enere : S ynth W ave
A detta di molti the busiest man in Brooklyn, Mr Blank
Dogs Sniper torna con una nuova uscita a quasi un anno
di distanza dal doppio Under And Under e lo fa con
un sound maggiormente pulito ed elettronico.
Heat & Depression e il gaze pop classe C86 di Blurred Tonight strizzano l'occhio alla melodie sfuocate dei glofiers,
mentre le tracce del B side apparecchiano una darkwave
di buona compagnia senza scossoni.
Pare che siano molti in questi giorni a tentare delle virate sulle brevi distanze (Zola Jesus, Fresh & Onlys), ma
quando la messa a fuoco non è precisa a rimanere è un
incompiuto senso di vaghezza.(6.6/10)
Andrea Napoli
Bonnie "Prince" Billy/Cairo Gang
- The Wonder Show Of The World
(Domino, Aprile 2010)
G enere : indie folk
Niente pare poter arrestare la creatività di Will Oldham e il suo fluire incurante di tutto. Delle logiche
di mercato in primis, considerando che sono trascorsi
pochi mesi dal carbonaro Funtown Comedown, lavoro edito solo in vinile per la piccola Sea Note. Della pazienza
41
di ascoltatori e appassionati poi, sommersi da decine
di uscite quotidiane di natura fin troppo spesso "usa e
getta". Questioni che l'uomo del Kentucky giustamente
ignora, appartenendo a ben altra e più solida categoria. Il
suo metro non è Ryan Adams, semmai Leonard Cohen: come lui e i suoi pari,Will asseconda cuore e umori
al momento di compiere delle scelte. In ciò ha origine la
difficoltà (che trovi anche in Bob Dylan
) a farsi mettere in una teca e accumulare polvere.
Come puoi "fermare" l'identità che mette in mostra, se
solo lui (forse) sa cosa accadrà di qui alla prossima raccolta di canzoni? Per ora, queste ultime sono più asciutte
che nel recente passato, acusticherie romantiche ridotte
al minimo ma cosparse di dettagli importanti (su tutti
certi impasti di voci che ondeggiano e portano via); ogni
tanto solcate da elettricità lieve (esemplare Teach Me
To Bear You) e che indubbiamente richiedono tempo per
essere afferrate. Emett Kelly maneggia la chitarra e la
Cairo Gang esegue come il gruppo di amici che è, per
lo più rinunciando alla batteria poiché intima è la chiave
di lettura.
Ascolti da dietro una porta semiaperta e la sobrietà del
mezzo aiuta il messaggio ad arrivare. Lo dimostrano le
sfoglie di classicità Something Coming Through (David
Crosby in rivoli di purezza), Troublesome Houses (una
scheggia da After The Gold Rush) e Merciless And Great
(cinque minuti di lame senza ruggine), bilanciando i rari
momenti in cui si gira attorno a un vibrante già detto.
In mano ad altri, infatti, la California seventies di That's
What Our Love Is sarebbe pura pantomima. Qui si trasforma nell'ennesima trasfigurazione cui non puoi rinunciare.(7.3/10)
Giancarlo Turra
tastiere Novanta (Teenage Spaceman), il featuring degli
Yello in tardoprogressività ambience (Divine) e il ripescaggio dell'amico Chelonis R. Jones (che guardacaso
milita su Get Physical) nel pezzo stranamente più Ottanta dell'intera tracklist (Bad Love).
Un disco che si distingue per il perfezionismo del suono,
privo però dei singoli bomba che fin qui li hanno contraddistinti ed elevati sul trono tech-house mondiale. La
prossima volta dateci more soul.(6.4/10)
Dirtmusic - BKO (Glitterhouse, Aprile 2010)
G enere : etno - rock - blues
Il passato in musica può essere un fardello bello tosto
da portarsi dietro. Probabile però che di questo a Brant
Bjork importi poco, ma è arduo non confrontare la
produzione solista e ciò che ha contribuito a realizzare
quando era colonna portante di Kyuss e Fu Manchu.
Imprenscindibile addirittura, dato che Brant ha deciso di
continuare a sguazzare nel mare dello stoner/noise nutrito con robuste dosi di fuzz. Gods & Goddesses sa però
rendersi più simpatico del solito - The Future Rock (We
Got It) è programmatica in tal senso - e meno "monolitico" dei suoi predecessori. Appare infatti più rilassato
e dotato di una piacevole e inedita letargia blues. Ovviamente siamo lontani dalla spinta innovativa portata
al genere dai Pontiak o anche solo dai muri di suono
eretti da Mr. Julian Cope quando è in forma, ma Brant
sa come portare a casa il risultato e rendere ancora più
adoranti i fan irriducibili.(6/10)
Di come i Dirtmusic siano finiti ai Bogolan Studios di Bamako a registrare il loro secondo disco dopo
l'omonimo esordio di tre anni fa raccontiamo nella recensione di Adagh dei Tamikrest. I quali fanno da
backing band a questo BKO, convergenza fra il rock-blues del trio formato da Chris Eckman (Walkabouts), Hugo Race (True Spirit, Bad Seeds) e Chris Brokaw e alcune fra le tante espressioni sonore che negli ultimi anni hanno fatto del Mali una delle zone musicalmente
più interessanti dell'Africa.
Non ci sono infatti solo i Tamikrest in questo disco, ma anche Fadimata Walet Oumar dei Tartit (altro gruppo tishoumaren da tenere d'occhio) che
incrocia la sua voce extratempo con quella saturnale di Race in Ready for the
sign e Desert wind, e poi Lassana Diabaté e Issa Kone della Symmetric
Orchestra di Toumani Diabaté (n'goni e balafon nella profluvio di corde
e legni di Niger Sundown: strumentale dall'immensa malinconia crepuscolare)
e infine un figliastro di Ali Farka Touré quale Lobi Traoré, che mette quelle quattro note rinfrancanti su una ballad di chiusura un po' scialba come Bring It Home.

I Dirtmusic in pratica vanno a ricercare le radici del loro classicismo rock-blues facendosi sporcare da
alcune delle migliori realtà musicali maliane e il risultato è di quelli da avere assolutamente, anche se non
si è proprio degli adepti di ciò che si suona nelle zone del delta del Niger - anzi, questo disco potrebbe
essere un ottimo inizio per farsi un'esplorazione discografica di ciò che succede là.
I tre si spartiscono in solitaria i dieci brani in scaletta e tirate le somme sono i tipici blues metropolitani
di Race ad accogliere ed amalgamarsi meglio con la psichedelìa desertica della chitarra di Ousmane Ag
Mossa e del basso liquido e groovoso di Cheikhe Ag Tigly, ma anche Eckman mette a segno una Black
Gravity scura e sinuosa che ospita il cantato quantomai suggestivo di Mossa e Brokaw trova la sortita folk
definitiva infilando un banjo fra chitarre tuareg, wha wha wha e calabash in Unknowable.
Difficile immaginare un incontro meglio riuscito di così: trepidazione e curiosità per l'approdo congiunto
dal vivo (Dirtmusic e Tamikrest insieme), anche alla luce del dvd allegato al disco che in vari spezzoni video
e audio acuisce la nostra fame di musica trans-africana.(7.7/10)
Giampaolo Cristofaro
Luca Barachetti
Marco Braggion
Brant Bjork - Gods & Goddesses
(Cargo, Aprile 2010)
G enere : S toner ril as sato
Booka Shade - More! (Get Physical,
Maggio 2010)
G enere : tech - house
Broken Social Scene - Forgiveness
Rock Record (Arts & Crafts,
Maggio 2010)
G enere : indie - epic
Arno Kammermeier e Walter Merziger dichiarano che il quarto album della loro pluripremiata carriera
ha tre più: la produzione raffinata, le atmosfere in sovrapposizione multi-layer e l'emozione. La tech house
dei due draghi da palco si riflette sul nuovo disco giocato
in casa Get Physical (di cui i due sono co-fondatori dal
2002) con un'ottima tecnica di produzione di cui i due
sono maestri da Movements. Gli ingredienti si basano su
"grooves strong che seguono la tipica uscita notturna: l'excitement del pre-serata, il party, le ore piccole, un po' di paranoia
e infine l'alba di un nuovo giorno".
Il concept è questo e gli ingredienti ci sono tutti. Il 4
pulsante infarcito di nuances deep à la Claro Intelecto
(Regenerate), gli FX 303 old school (The Door), visioni e
Ci sono momenti in cui, avendo osservato la parabola di
un gruppo sin dall'inizio, avverti il momento di crisi. Che
può essere risolto facendo quadrato e spremendo il nucleo della propria arte uscendosene con un capolavoro,
oppure separarsi tra sguardi in cagnesco e male parole.
Esiste però una "terza via" che nel caso dei Broken Social Scene non ci sentiamo di chiamare opportunismo
o proroga. Non si può pretendere che la gente faccia
sempre grandi dischi e, se è evidente che questo lavoro è
lontano da You Forgot It In People e il lavoro omonimo che
seguì, è altrettanto vero che non ne svilisce la formula. Il
rischio era smarrire un'epica intelligentemente rinvigorita da sperimentazione e approccio indie; oppure insistere sul pop per scalare le classifiche e perdere la faccia.
42
highlight
Forgiveness Rock Record si colloca al bivio, indeciso sul da
farsi: sposta l'asse su poco convincenti visioni eighties ma
si rifugia anche in una multiforme maturità.
Che nei momenti più alti assume l'aspetto di una tristallegria Flaming Lips (World Sick un'iniziale meraviglia
con cui il resto fa i conti) o figlia dei Radiohead (Sweetest Kill), di possenti cavalcate kraute (tesa alla Talking
Heads Chase Scene; retro-pop alla Stereolab Sentimental X's) e autentici colpi di genio (i Pavement metà glam
e metà roots di Water In Hell, la sfoglia femminile All To
All). Aggiungete discreti ammiccamenti ai Cure più scodinzolanti (Texico Bitches), morbidezze Primal Scream
annata '97 (Highway Slipper Jam ricorda molto Star) e
omaggi sparsi ai James, sapendo che sull'altro piatto della bilancia stanno però tortuosità e lungaggini - co-pro-
duce John McEntire: considerate le recenti uscite dei
suoi Tortoise, sarebbe stato saggio rivolgersi altrove - e
per la prima volta l'emotività dei canadesi vi soccombe.
Un Giano bifronte di disco, in sostanza, che offre alcune
canzoni fantastiche, qualche scivolone e più di ogni altra
cosa l'umanità dei propri dubbi. In attesa del futuro, può
bastare a guadagnare l'assoluzione.(6.9/10)
Giancarlo Turra
Cccandy - Lonesome Berlin (Avant!,
Aprile 2010)
G enere : synth - wave
Il primo vinile lungo della Avant! è appannaggio di un solo-project made in Deutschland che si muove su coordinate molto in voga ultimamente. Una sorta di synth-wa43
ve spastica in modalità minimal che cortocircuita spesso
con la cosiddetta cold-wave che tanti cuori (ehm) scaldò
negli 80s.
Metronomica e marziale nell'assetto ritmico (just a
drum-machine, dopotutto), meccanica e robotica nelle
vocals effettate, la musica di Stefan, ventenne tedesco
che si nascondo dietro il moniker Cccandy, è esattamente ciò che vi potete aspettare come colonna sonora di un immaginario in b/n privo di qualsiasi sfumatura
intermedia. L'etichetta segnala come punti di contatto
The Normal e Dark Day, ma potremmo tranquillamente aggiungere alcuni progetti minori targati Sacred
Bones come Nice Face o, più per suggestioni che per
veri e propri legami musicali, tutto il giro portato avanti
dalla Dais/Heartworm (pensiamo a Cold Cave, tanto
per fare un nome sulla bocca di tutti) o dall'olandese
Enfant Terrible (gli ottimi Agent Side Grinder).
Etichette e gruppi in fissa col sostrato dark-wave e/o
minimal-synth dei mitizzati anni '80, ma da cui Cccandy si
distacca (di poco) per un distinguo e un dettaglio a margine. Il primo è che qui sembra esserci, seppur sempre
virato al nero, qualche sprazzo di luce (She Lied, Teacher
Of Lust, l'autoreferenziale I'm A Punk), tanto che si sfiorano lande synth-pop. Il secondo è più un paradosso, dato
che pur evocando i terribili anni Ottanta, il pischello dietro Cccandy a quell'epoca non era ancora nato. Della
serie, altro che immaginario ipnagogico.(6.9/10)
Stefano Pifferi
Chap (The) - Well Done Europe (Lo
Recordings, Maggio 2010)
G enere : elettropop
Mega Breakfast era stato un album discusso, ben discusso, uno di quei dischi che anima reazioni positive anche
se non concordi nel grado di entusiasmo. C'era un buon
lavoro sull'elettropop e sugli antenati sintetici dei vari
Blow, così come un discorso sul cut-up direzione Fiery Furnaces. Well Done Europe prova a capitalizzare i
buoni risultati degli esperimenti precedenti e a virare
definitivamente verso l'elettropop e anche la spendibilità
commerciale, seppure sofisticata e mai banale.
Well Done Europe assume però un piglio decisamente più
citazionista. E tentando il salto verso i patres più impegnativi. La scomposizione del funk nel synthpop è mirabile e riuscita, a tratti (come nel primo brano, We'll See
To Your Breakdown, che non a caso è posizionato come
punto di ingresso all'album), ma più spesso si nota una
smania di eccellere, più che un'urgenza espressiva. Il
combo non è più solo londinese, ma divide il proprio
quotidiano tra l'Inghilterra e Berlino, e il suono diventa
inevitabilmente più mittel-europeo, come si diceva nella
44
prima metà degli anni Ottanta. We Work In Bars usa il
dialetto degli Ultravox che
più vanno a braccetto con
Eno. E Brian Eno è la chiave con cui aprire e smontare quasi tutti i brani del
quarto album di The Chap.
Sia il Brian autore, sia l'uomo produttore, sia il musicista
dei Roxy Music.
La ricerca dell'hit intelligente comporta, e ciò può essere
un problema, tic di dizione e di arrangiamento (il controcanto di Obviously è piacevole ma evitabile - avremmo
preferito che la canzone proseguisse senza i soliti retaggi robotici Ottanta). È quel decennio per tanto tempo
bistrattato che parla sempre di più tramite i presenti
che attraverso i ricordi. Eccellenze come The Chap sono
esempio e sintomo. Appena si lasciano andare e scendono dalle spalle dei padri estraggono un'imprendibilità senza dubbio più efficace (Gimme Legs, o Maroccan
Nights, personalissima cavalcata elettropop, che da sola
alza il voto di due decimi). Ma i conti con venticinque
anni fa non sono evidentemente ancora finiti.(6.9/10)
Gaspare Caliri
Clipd Beaks - To Realize (Lovepump
Records, Marzo 2010)
G enere : noise - rock
Un paio di anni fa li avevamo lasciati intenti a trafficare
con verve post-punk 2.0 e percussività da New Tribal
America; ora ce li ritroviamo, sempre su Lovepump, persi nell'esplorare orizzonti molto più ampi. Non nel senso dei riferimenti e delle influenze, ma proprio a livello
strutturale. I tre californiani d'adozione dilatano spazi e
tensioni in una sorta di noise-rock ceruleo e macilento,
al ralenti, ossessivo come una nenia pre-morte. Come
dei Liars epoca Drums Not Dead (Blood è paradigmatica) o, per chi se la ricorda, come i Sonic Youth di
I Love Her All The Time da Bad Moon Rising: riuscire,
cioè, ad essere rumorosi, fastidiosi, disturbanti senza fare
necessariamente rumore.
La componente ritmica che più ci aveva colpito in precedenza, sembra qui trattenuta, resa liquida e scivolosa
senza però mai perdere il senso del groove. Si tratta di
un groove malato, inacidito da bagni di sole e lsd nel
deserto del Mojave, rattrappito su una sorta di stoner
trascinato, smostrato, completamente decontestualizzato. Buon gioco hanno le vocals-nenia di Neil Barbeln,
tono dimesso e incedere ipnotico, in grado di segnare
una via portante lungo tutto l'album con quel procedere
su melodie sempre stranite. È la generazione dello Smell,
quella dei Clipd Beaks di To Realize. Quella in grado di
trasfigurare la lezione rumorosa a stelle & strisce in forme di volta in volta diverse, ma sempre dall'alto potenziale evocativo e disturbante.(7/10)
Stefano Pifferi
Coconuts - Coconuts (No Quarter,
Aprile 2010)
G enere : tribal post punk
Tim Evans e Jordan Redaelli. Austrialiani di origine, newyorkesi d'adozione, loser per destino. I due arrivano nella Grande Mela, incontrano Daniel Mitha, mettono su i
Coconuts, iniziano a fare musica brutta. Difficile definirla diversamente. Del resto anche alla No Quarter mettono le mani avanti e usano tre parole come altrettante
stelle polari per coordinare i giudizi: 'ugliness', 'despair',
un-marketability'.
Ugliness. C'è qualcosa di dolente, di spastico, di demente
nella musica dei tre. Il drumming risente evidentemente
degli Animal Collective, ma il generale mid-tempo in
cui vivono tutti i brani, non aiuta a gioire, piuttosto fissa tutto in una dimensione intorpidita e asfissiata, che a
tratti sembra prodotta da una versione zombi dei Devo. Il basso distorto gioca un'economia fondamentale nel
sound e fa rima, per evidenti assonanze oltre che per
origini geografiche, con quello cavernicolo che fu dei
Birthday Party. Poi ci sono voce e chitarra. Un rantolo
elettrificato e ispido quello della sei corde, un filo spinato post-punk che arriva da No New York, dai Mars, dai
Teenage Jesus and the Jerks, dai Minimal Man, dai
Band Of Susans, in un modo che come meglio non si
può dire "is like an opiated Ritchie Valens slow dancing the
Dead C", nell'immortale definizione di Daniel Lopatin
(Oneohtrix Point Never).
Despair. Qui non c'è molta voglia di vivere. Le canzoni
hanno titoli come Dark World, Lost Bitches, Dean's Blues.
La voce vive in una perenne eco che arriva diluita nel
contiuum spazio-tempo come il rantolo di un milione di
depressi che si lamentano da generazioni e generazioni.
Qualcuno pensa ai Loop di Robert Hampson è alla loro
maniacalità ossessivo-lisergica. Quel qualcuno ha ragione. Il panorama è desolato, l'orizzonte è chiuso, la malia
del riverbero è velenosa.
Un-marketability. Il disco d'esordio consta di cinque brani con 7 minuti di durata media. I Coconuts però non
hanno l'aria impegnata della band "che sperimenta". Ai
tre, non sembra importare nulla di sperimentare. Di fare
pop-music poi non ne parliamo proprio. L'unica traccia
che sembra avere una qualche forma pop è When She
Smiles, ma più che una popsong, sembra un immaginario brano saltato fuori dalla
collaborazione tra Brian
Wilson e tutta la Family di
Charles Manson sotto acidi. I Coconuts rischiano di non piacere a nessuno. Troppo poco avant per allettare gli sperimentatori, troppo
brutali e gotici per attrarre gli indie kids, troppo poco
formalisti e radio friendly per un qualche minimo appeal
commerciale. Sono come un vecchio slasher flick di serie B edito in vhs, quando ora abbiamo i super-cinema
IMAX 3D.
I Coconuts fanno semplimente musica brutta e non andranno molto lontano da qui. Che il Dio del Rock ce li
conservi proprio così, quindi.(7.5/10)
Antonello Comunale
Cocorosie - Grey Oceans (Sub Pop,
Maggio 2010)
G enere : M istic etno pop
A tre anni di distanza dalla transizione adulta di The Adventures Of Ghosthorse & Stillborn, Sierra e Bianca
di professione ora fanno le freak globali. Sono scafate artiste maudit piuttosto lontane dalle timide performance
a piedi nudi di cui Devendra Banhart e l'intellighenzia
avant-folk si innamorarono a inizio Duemila, e un tour
mondiale, che le ha viste abili performer nel miscelare
non solo world music, opera, hip hop, folk, soul (ma anche vestiario e teatro), ha dato il segnale definitivo sul
formato da intraprendere.
Il baule dei ricordi della nonna (pre-war folk, tape giocattolo) già ampiamente ribaltato da produttori e ingegneri (Valgeir Sigurðsson prima e Nicolas Kalwill ora), è
lo smalto per unghie di un mondo sonico che fa consapevolmente i conti con un destino da performer alternative ben settate dentro il mainstream e una formula
addomesticata per il grande pubblico (che peraltro aveva
precorso quella tendenza musical culminata quest'anno
con Here Lies Love di Slim e Byrne). Tutto sacrosanto,
eppure al recupero classico/lirico perfezionato ai tempi
della collaborazione con Antony, le abbondanti partiture per piano di un terzo elemento normalizzante, Gael
Rakotondrabe, e al canovaccio a ruoli delimitati che le
sorelle ora perseguono, non si è contrapposto lo scarto
necessario in scrittura, disinvoltura e urgenza espressiva.
Come dimostrato dalla scorsa tournée, sono le tracce
più marcatamente hip hop a dare le stoccatate che ser45
vono (R.i.p. burn Face, The Moon Asked The Crow), eppure
l'album è zeppo di ballad ingessate come se si vendesse
l'anima al diavolo in cambio dell'infanzia perpetua subendo il contraccolpo di una Wonderland incartapecorita.
E proprio come per l'Alice di plastica di Tim Burton,
come nei corsi e ricorsi dei chronicles Hippy di Ibiza,
gli arrangiamenti in cassa techno (Fairy Paradise, come
una Bjork fuori tempo massimo) e qualche cosina di
drum'n'bass (Hopcotch con il bel giochino ragtime però)
non che fa aggiungere pericolosi - e perdenti - paralleli
con Björk, peraltro con espedienti fuori tempo massimo.
L'ironia del finale Here I Come (con la voce abbassata di
Bianca e l'effetto minimalista à la Laurie Anderson), e
l'afflato di Grey Oceans, unica vera ballad all'altezza, fanno
capire che la stoffa c'è ancora ma forse non l'impegno e
la maturità necessari.(5/10)
Edoardo Bridda
Crystal Castles - Crystal Castles
(Pias, Aprile 2010)
G enere : noise lo - fi disco
Nel sophomore del duo canadese i suoni dell'esordio
rimangono gli stessi, a mancare è invece la sorpesa mesh,
convertita oggi a noioso rumorismo electropunk (Doe
Deer).
Le facce col cerone e con la decadente matita nera sugli
occhi non fanno guadagnare punti, tantomeno l'ostinata
nostalgia microhouse di Miss Kittin & The Hacker
(Suffocation, Celestica e il singolone Baptism), per la cricca
di Mr. Oizo (Year Of Silence) e la partecipata incursione
nei territori ambient-tech à la Kate Bush (Violent Dreams). Il ricorso alle solite cavalcate prog (Vietnam, Not In
Love) e alla fascinazione per le colonne sonore di video
games a 8 bit è l'ennesimo già detto e se non fosse per
qualche droghina che si intravvede sullo sfondo, il castello di cristallo sarebbe probabilmente già crepato in più
punti.
Li avevamo aspettati, ma dopo due anni Ethan Kath e
Alice Glass hanno già perso la carica. Peccato.(5.5/10)
Marco Braggion
Curumin - JapanPopShow
(Makasound, Marzo 2010)
G enere : bl ack
Quando dici melting pot e non è degli Stati Uniti che
parli, ti basta scendere qualche centinaio di chilometri a
Sud. Cioè in Brasile, da dove proviene Curumin (paulista con sangue spagnolo e giapponese), polistrumentista
chiamato a persuadere che l'idea di musica black a 360°
mostrata nell'esordio del 2005 Achados E Perdidos fosse
46
sorretta da continuità d'ispirazione e brillantezza. Così
è e in misura vieppiù maggiore, poiché alla mescolanza di soul, hip-hop, reggae e tradizione locale il ragazzo
aggiunge un'immediatezza "pop" non banale (si vedano
Compacto, Magrela Fever e Sambito) e ospiti efficaci (su
tutti Blackalicious e Lateef The Truthspeaker nella
collagistica Kyoto); alla luce del risultato non sorprende
perciò che il lavoro - risalente a due anni or sono, tuttavia giunto solo ora da noi - abbia raccolto elogi e premi
di là dall'Atlantico.
Suona infatti egregio figlio di un globalismo positivo, di
tecnologie moderne che permettono incroci smaliziati se usate con chiarezza d'idee e voglia di trasmettere
emozioni. Su quanto già citato e un livello medio assai
elevato, spiccano la metropolitana e inquieta Dançando
No Escuro, il funk verdeoro Mal Estar Card, quel respiro
romanticamente oppiaceo che sale da Misterio Stereo e
dalla sensazionale In The Hot Sun Of Christmas Day. Apice che, collocato in chiusura, esorta a ripartire daccapo.(7/10)
Giancarlo Turra
Daedelus - Righteous Fists Of
Harmony (Brainfeeder, Marzo
2010)
G enere : chamber l aptop
Daedelus (Alfred Darlington) è bravissimo e ci sta anche molto simpatico (vedere Secondhand Sureshots).
Ma come produttore non ci ha mai fatto impazzire: colpa
di quelle melodie luccicanti e pomposamente romantiche, di quel barocco sinfonismo con cui accumula suoni
su suoni, tutti sempre troppo "puliti".
Ritroviamo puntualmente gli ingredienti della ricetta in
quest'eppì ispirato alla rivolta dei Boxer in Cina, un
lavoro che ci pare stucchevole e ripetitivo come mai finora: chitarre acustiche con mandolinismi e bucolicismi,
lenti incedere trip hop (su Ninja Tune ha pubblicato ed
è Ninja Tune che distribuisce), spleen quasi-fado con la
voce della moglie Laura Darlington (guest vocalist di
fiducia anche di Flying Lotus), archi cinematograficienfatici.Vedere alla voce: oleografico.(5/10)
Gabriele Marino
Daniel Higgs - Say God (Thrill
Jockey, Maggio 2010)
G enere : mistic - slow
Vive il paradosso del predicatore mistico, Daniel Higgs.
È aedo solitario, un menestrello con banjo e harmonium
che non si è mai negato la soddisfazione di prendersi
tutto il tempo possibile per esporre la propria cosmogonia. In Say God - titolo che già dice molte cose del
highlight
Erykah Badu - New Amerykah, Part Two: Return of the Ankh
(Universal Motown, Marzo 2010)
G enere : funk - soul
Il primo volume della saga della Nuova Amerykah era senza mezzi termini un capolavoro. Normale che
questa Part Two fosse uno dei dischi più attesi del 2010. L'anteprima mesi fa, con la traccia esclusiva per
iTunes Jump In The Air, aveva un po' messo in allarme, produzione efficace
dei due curatori baduiani RC Williams e Jah Born ma feat inopinati: quella
mezza tacca di Lil Wayne e un Bilal (compagno della Badu nello storico
collettivo Soulquarians) abbastanza incolore. Per fortuna, il disco è tutt'altra
cosa e - come da programma - si propone come rovescio del precedente
(sperimentale, elettronico, barocco, schierato), e quindi quadrato, suonato,
asciutto, intimista.
Il solito cast stellare affianca la Badu per un lavoro lineare e di immediata
godibilità in cui si bilanciano perfettamente classe, mestiere e ispirazione.
Lei miagola come sempre e i tappeti che le stendono sotto sono funk-soul vellutato (Window Seat, con
Questlove alla batteria), sensuale (You Loving Me), pulsante (Fall In Love), gommoso (Turn Me Away, al basso
Stephen "Thundercat" Bruner), con aperture alla fischiettabilità più pop (Gone Baby, con un campione
dai Wings di Paul McCartney). Il tocco di Dilla - è davvero incredibile - si riconosce già dall'attacco;
Shafiq Husayn ritaglia un delizioso inciso jazzprog di piano e batteria; Madlib si ricollega alle produzioni
che aveva realizzato per il primo volume con un pezzo di molle psichedelia (complice l'arpa di Kirsten
Agresta); James Poyser produce un paio di brani e suona buona parte delle tastiere, con un feel jazzy
che trova però la sua massima espressione nella suite conclusiva, dove si ricongiungono ancora una volta
allieva (Georgia Anne Muldrow) e maestra.
Erykah è sempre inquieta: lo si capisce stavolta - più che da segnali specificamente musicali o testuali - da
indizi contestuali. La copertina dell'album, sottilmente disturbante, pensata dallo psicomago Alejandro
Jodorowsky, e il video del primo singolo, Window Seat, con nudo integrale e allusione al passato buio
dell'America: l'uccisione di JFK.(7.3/10)
Gabriele Marino
contenuto dell'album - diluisce in un doppio CD / LP i
gospel, le declamazioni e le riflessioni fisiche e metafisiche che compongono il proprio eremitaggio. Per l'occasione Andrew Sitek (TV On The Radio) si occupa di
preparare e di cucire attorno al santone barbuto il setting - d'ambiente e di produzione - perché il solipsismo
abbia libero sfogo.
Eppure tutto ciò presuppone un ascoltatore, e in questo sta il paradosso. Un moto così radicato e nascosto
nell'anima che vuole trovare una pubblicazione, e quindi
un riscontro di pubblico, per definizione. Higgs oscilla
tra l'essere l'eremita e il profeta. E la musica va di conseguenza. Daniel asciuga il più possibile l'espressione di
cotanto contenuto, finendo con il ridurla alla sola voce
(Tumble Down, con appena dei grilli notturni in un sottofondo quasi impercettibile). In un caso (Root & Bough),
dopo sei minuti di predica, si materializza un'esplosione,
un fragoroso viaggio new-age. Niente però - tranne l'at-
mosfera d'insieme - parla il inguaggio proprio del raga,
a cui Daniel ci aveva abituati. Le armonie, le inflessioni
della voce, coerentissimi espedienti estetici per veicolare
il messaggio, viaggiano nel passato essenziale del folk anglosassone, in una forma ancestrale e monolitica.
L'effetto è profondamente ipnotico. Unica via per risolvere il paradosso è trascinare l'ascoltatore nel solipsismo. Non importa convincerlo del tema religioso, del
percorso mistico. L'importante è coinvolgerlo. Altrimenti, ascoltare la rarefazione di questo doppio e infinito
album sarebbe impossibile.(6.6/10)
Gaspare Caliri
Darkthrone - Circle the Wagons
(Peaceville, Aprile 2010)
G enere : H eavy M etal P unk
Continua il nuovo corso della saga dei Darkthrone e
il relativo processo di rilettura della radici hard rock e
47
punk-hc del metal. Già da alcuni anni il famigerato duo di
Oslo, artefice di uno dei sound più emblematici - e difatti
copiato - della musica estrema, ha smesso le nere vestigia del black, optando per un heavy più classico, pesantemente influenzato dal punk e guidato da un'attitudine
esplicitamente DIY. Alla base la volontà di far riscoprire,
a giovani in primis, le sonorità che caratterizzano il mondo metallico dagli albori fino alla metà dei '90, quando,
a parere di Fenriz (batterista e consacrato leader spirituale), ha preso piede un rinnegamento delle radici brutali del genere, indirizzatosi
verso produzioni plastiche
ed insulsamente pulite.
Ci pensano dunque i nostri a riportare ordine nel
caos, facendosi largo a colpi di machete e senza fare
prigionieri. L'hard anni '70
di Black Mountain Totem e
Eyes Burst At Dawn è territorio di caccia di Nocturno Culto, mentre I Am The Grave Of The 80's e I Am The Working Class viaggiano a vele
spiegate sospinte dal soffio (alcolico) di un Fenriz che
più triviale non si può. E se questo è già noto a chi ha ancora nelle orecchie i ruggiti di F.O.A.D. (2007) e Dark
Thrones And Black Flags (2008), c'è spazio anche per
inaspettate deviazioni. Come Those Treasures Will Never
Befall You e la title-track che spolverano vecchi rottami di
metal epico con la grazia di un bisonte ferito, sempre in
bilico tra provocazione e sincero tributo.
Che la nuova veste della band abbia diviso i fan non è
una novità, ma ostinarsi a ritenere che i veri Darkthrone siano solo quelli di Transilvanian Hunger significare
negare alla base il tentativo di rinnovamento che i due
oscuri signori stanno tenacemente portando avanti per
rifugiarsi nelle certezze di un passato che ormai è sempre più tale.(7.7/10)
Andrea Napoli
Daughters - Daughters (Hydra
Head, Marzo 2010)
G enere : P ost HC
Tornano i Daughters per quello che sembra essere l'ultimo lavoro della band. Ancora una volta sotto
la Hydrahead di Aaron Turner, l'album è interamente in
streaming nel sito della rivista Revolver e niente (o quasi) rimane delle abrasive schegge grind degli esordi di
Hell Songs, né del successivo - e già più imbrigliato - Canada Songs.
All'inizio erano gli ultimi arrivati di un manipolo di gruppi
come Converge, Botch, Coalesce che negli USA
48
cercavano di trovare delle nuove direzioni all'HC, ora
sembrano una costola di Interpol, Editors e Rapture
(la disco punk di The Hit). Come è accaduto per i Dillinger Escape Plan di Ire Works, la band di Providence
prova a cimentarsi in HC da classifiche. Non cadrà nei
refrain imbarazzanti di quest'ultimi, eppure il suono, debitamente ammorbidito, levigato da ogni asperità e rallentato un po', non sa né di carne né di pesce. Birthday
Party e Jesus Lizard covano ancora sotto le partiture
(nei brani The Dead Singer, Sweet Georgia Brom su tutti)
ma è tutto art-punk per emo-kids quello che si ascolta e
niente più.(5.5/10)
Leonardo Amico
Deaf Wish - Reality & Visions (Exo,
Marzo 2010)
G enere : P sych P ostpunk
L'Australia non smette mai di elargire piccole perle di
malessere in musica e di rumore in quattro quarti. Se
degli Uv Race abbiamo già parlato, è ora il turno dei
Deaf Wish che, dopo un primo album uscito solo in
Cd-r ed un piccolo aggiustamento di line-up, arrivano
alla seconda fatica su lunga distanza (nonché ad un'effettiva pubblicazione).
Rispetto al precedente omonimo, le tracce che affollano
Reality & Visions sono più slegate, frammentarie, volutamente inorganiche: Man/Manbeast inizia con campioni
random di trasmissioni radio, subito troncati dalla corsa
fulminea di Smash; due strofe e siamo già catapultati nello stomp folle di Bad Water. La risacca di Gentle Mental
Illness concede una tregua e prepara il terreno per i successivi blitz di Backwards e Slow Me Down.
Da buoni australiani, i ragazzi di Melbourne metabolizzano la lezione delle glorie punk autoctone (X e Saints
in primis), rivisitata alla luce delle eruzioni espressive degli '80 (dagli Hüsker Dü agli Urinals, dai Black Flag ai
Wipers) e dei '90 (il catalogo Skin Graft e AmRep), dando vita ad un insano canovaccio di idee deviate dall'alto
potenziale eversivo.(6.9/10)
Andrea Napoli
Delorean - Subiza (True Panther,
Giugno 2010)
G enere : balearic , post - glo
Debutto sulla lunga distanza per il quartetto di Barcelona. Dopo aver innestato nella glo fashion il moto dance
con la fascinazione del buon Ayrton Senna EP, Subiza si
sposta sulla costruzione del suono e sulla produzione.
Coinvolgendo Chris Coady, ingegnere del suono di !!! e
TV On The Radio, ci si impunta sul perfezionismo, e
come ci hanno ricordato da poco i MGMT, la tendenza
torna indietro non solo per quanto riguarda l'estetica
compositiva della lacrimuccia, bensì anche per l'analogico che qui non è per niente lo-fi. Anzi.
Per arrivare a quella patina intrisa di ricordi, si parte dai
soliti programmi di editing che mimano le Korg e le altre
tastierine d'epoca nello studio casalingo di Barcelona e
ci si fa meshare dai guru della consolle in fase di mixing.
Come a dire che è ora di fare sul serio, di puntare a un
prodotto che resista alla schiuma dei giorni. I quattro
ragazzi si muovono sul ricordo degli anni ‛80 già
egregiamente esplorato da Memory Tapes e innestano
la lezione degli Animal Collective (Stay Close) con dei
riverberi che starebbero bene nei memorabilia targati
My Bloody Valentine, speziando il tutto con un sole
balearico che riflette una positività acida in odore Primal Scream (Grow, Simple Graces) o dei più vicini Kings
Of Convenience (Infinite Desert).
Uno dei primi gruppi che si staccano dal Big Bang glo
con uno pop consapevole e maturo. Salite sulla Delorean, attivate il flusso canalizzatore e impostate l'anno.
Back to the future, again.(7.3/10)
Marco Braggion
Denseland - Chunk (Mosz, Aprile
2010)
G enere : jazz / postrock
Denseland è il progetto nato nel 2008 dall'unione tra
David Moss, Hannes Strobl, Hanno Leichtmann.
Per chi conosce gli ambienti berlinesi, ma anche per chi
fa una rapida ricerca sul trio, si tratta di un supergruppo.
David è performer con la voce, di mestiere, generalmente piuttosto estremo. Hannes compone e suona il basso,
nelle varie forme in cui lo strumento può manifestarsi.
Hanno è famoso per essere stato la mente degli Static,
quindi ambito indietronica, ma viene dal free jazz.
Chunk è la summa delle tre esperienze, con i tre a venirsi incontro per trovare uno scenario comune. In particolare Moss, che qui sussurra, mormora, sinistro come
sempre (Cumulus Crowds), ma non di certo dionisiaco. Il
core del disco è il particolare composito, il tessuto di
elementi minimi e quasi silenti, fragorosi solo nella loro
solitudine. Le percussioni sopra a tutto il resto. Battiti
frammentati, che però qui, anziché fare da tappeto come
nel genere succede spesso, fanno particolarmente sentire la propria materia. Sembrano ossicini, piccole ossa,
non si capisce bene se provenienti da una polverizzazione di uno scheletro o minuscole in partenza.
Raramente il tutto trova un ritmo costante - una struttura riconoscibile - a cui appigliarsi (e quando lo trova, lo fa sempre con l'accumulazione - sentire Scrape It
(Up) o Obsidian per credere). Più spesso è l'ardore del
buio a parlare nell'album. Metafora spicciola per parlare
di un innesto piuttosto riuscito tra analogico e digitale.
Chunk non fa la differenza in senso assoluto, ma quanto
serve per farsi notare rispetto ad altre produzioni simili.(6.7/10)
Gaspare Caliri
Dimlite - Prismic Tops (Now Again,
Maggio 2010)
G enere : glitch hop
Prima uscita su Now-Again (costola Stones Throw) per
il produttore svizzero Dimitri Grimm. Vicino agli ambienti Brainfeeder (Flying Lotus & Co.), ha esordito
nel 2005 sulla lunga distanza con il bellissimo Runbox
Weathers (Sonar Kollektiv). Il 2009 lo ha visto centellinare le uscite, in pratica solo due pezzi, ma due perle:
il sette pollici Quiz Tears e
quella Ravemond's Young
Problems, su compila, alla
base del fake split tra Lotus
e Burial. Pezzone.
Questo EP è chiaramente
un lavoro di riscaldamento,
ma presenta una serie di
numeri glitch-hop da incorniciare: miniature agrodolci e giocose, compostissime e
sbilenche, con un uso molto interessante della voce - tra
il sinistro e il romantico - e una timbrica scelta con la
massima cura, ricca di suggestioni tattili.
Dimlite è uno da tenere d'occhio. Aspettiamo l'album.(7.1/10)
Gabriele Marino
DIN A Testbild - Programm 6
Collage (Bureau-b, Marzo 2010)
G enere : industrial -EBM
DIN A Testbild sono un leggendario combo tedesco
nato a fine Settanta in piena era post-punk. Attivissimi
e molto influenti per tanti settori artistici, sono riusciti a sopravvivere e ritornano riproponendo una miscela
d'antan tra EBM e industrial tradizionale.
Ci sono dei presupposti che rendono Program 6 - Collage interessante. C'è un uso dell'elettronica down tempo e poi ballabile evidentemente datato, retrofuturibile,
codificato, e così un'estetica vetero-cyberpunk, sintetica
ormai storicizzata e quasi vintage. Eppure tutto questo
è realizzato con cesellature di suono molto certosine,
attente al particolare, nella logica del flusso continuo.
È quindi un peccato ritrovarsi nelle condizioni di scagliarsi violentemente contro una scelta pervasiva che dà
l'immagine al disco e lo fa ricordare per quello. Il filo con49
highlight
John Grant - Queen Of Denmark (Bella Union, Aprile 2010)
G enere : songwriting
I Midlake fanno da backing band e producono l'esordio di John Grant, cantante dei defunti Czars, cult
band denveriana fine '90 titolare di tre album su Bella Union; il loro incontro risale al 2006 quando il gruppo lo aveva voluto come supporto di un tour in America ai tempi di The Trials Of Van Occupanther
e il sodalizio è poi proseguito, concretizzandosi in Queen Of Denmark.
Personaggio dalla spiccata personalità musicale il Nostro, con influenze anni
'70, dalle parti del songwriting sublime di un Harry Nilsson ma anche Carpenters, Supertramp e E.L.O., per quel gusto rock soffice e sufficientemente barocco alla Peter Hammill che oggi accosteremmo a nomi quali
Mercury Rev e Flaming Lips. Una scrittura varia la sua, che risente non
poco dei mentori Midlake, ma se ne smarca intelligentemente, proponendo
sonorità che lambiscono, oltre ai già citati, anche territori jazz rock colti
(Steely Dan per fare un nome), country (uno dei suoi idoli è Patsy Cline)
e in generale un cantautorato adulto.
Canzoni per piano, con synth ma anche archi a volontà, arrangiamenti raffinati, con il gusto per l'ironia
e il sarcasmo feroce, che rimanda alla scrittura di un Morrissey e di un Rufus Wainwright, e con
tematiche borderline alla Scott Matthew e Antony And The Johnsons, sia pur trattate con più levità
e leggerezza, ma per questo meno drammatiche. Un ottimo esordio allora e ancora una conferma che
proviene dalla Bella Union di Simon Raymonde.(7.3/10)
Teresa Greco
duttore dei brani di Program 6 è infatti l'ugola-vocalist
declamata e pseudo-cool che scandisce le "parole chiave"
dei brani, con tanto di eco e un tono che tutt'al più può
appena scimmiottare il mood di Genesis P-Orridge
epoca passaggio Throbbing Gristle / Psychic TV. Un
filo rosso imbarazzante e davvero fastidioso, che rende
intollerabili le tracce, finendo per esaurire l'ascoltatore e
distogliere l'attenzione dai pur meritevoli inserti cosmici
e particolari che fanno la tela dell'album (si notano bene
nel passaggio tra Factory e Industrial).
Musica industriale che così diventa caricatura di se stessa (se si parla addosso con parole isolate come "Energy",
"sinergy", "666"). Seguiremo forse una visione un po' ideologica, ma se questo tipo di musica ha bisogno di parole
che ne comunichino i temi probabilmente non funziona,
non ha raggiunto l'obiettivo, o comunque manifesta un
obiettivo che è al di là delle sue possibilità.(5/10)
Gaspare Caliri
Dominique Bassal - Ubiquité
(Enprientes Digitales, Marzo 2010)
G enere : A vant -A ccademica
Il nome di Dominique Bassal non è noto ai più trattandosi di un accademico formatosi a corte senza passare
per grossi consensi pubblici nè per prove discografiche
50
proprie. Ce lo ritroviamo come ingegnere sonoro al mastering di numerosi dischi di elettroacustica canadese e
non, ma mai niente di suo, fino a questo primo Ubiquitè.
Che Bassal abbia lavorato attorno ad una serie di materiali disparati, lo si sente dalla variegata sfaccettatura delle
sue composizioni, che forniscono una sorta di compendio universale-elettronico che va dai minimal-textures
dei Microstoria, alla musica concreta di Pierre Henry.
Si passa dai buffer-sinfonici, a paradigmi tastieristici, fino
a moduli sonori di autogenerazione sintetica. Eppure la
dimensione massiva delle stratificazioni non corrisponde
pienamente ad una chiarezza formale che faccia di questi
suoni qualcosa di unico.
Nei 4 lunghi movimenti che caratterizzano il dvd-soloaudio 5.1 (e traccia stereo) c'è troppa carne a fuoco, in
particolare l'uso alla propedeutica d'ascolto che si presenta sotto forma di compendio scritto-teorico dalle
descrizioni eclatanti. Ad esempio in L'inénarrable Nout, si
legge che il musicista si è richiamato alla mitologia del
cielo, ai viaggi astrali e che i materiali sono stati realizzati
da un synth in max/msp di ri-sintesi assai faticoso da costruire; eppure la corrispondenza col cielo e con i suoni,
o i viaggi intergalattici, rimane solo una dichiarazione per
convincere probabili commissioni universitarie (e sarebbe meglio che ognuno ci vedesse quello che sente da
queste musiche, senza la ridondante retorica che sta a
monte).
(5/10)
Salvatore Borrelli
Dosh - Tommy (Anticon, Aprile
2010)
G enere : G roovey coll age
Sempre su Anticon il nuovo lavoro di Martin Dosh,
collaboratore stretto di Andrew Bird (anche ospite
alla voce in Number 41 e coautore di Nevermet) e polistrumentista moderno. Come per i precedenti, benché
il groove e le dinamiche ritmiche rimangano al centro
della cifra stilistica, niente a che vedere con l'hip hop.
E neppure con il post-rock con il quale il ragazzo di Minneapolis chiama un sound che sostanzialmente, come la
maggiorparte delle produzioni anticon, è un collage di
campionamenti, batterie elettroniche e tastiere sempre
più vintage. Anche Tommy segue questa strada incanalandola verso soundscape capaci di toccare generi anche
antitetici e sta qui il bello: Number 41 e Nevermet sono
indie rock (con Bird ad infondere una certa sensibilità
pop) Subtractions possiede sapori africani mentre Town
Mouse è un'istantanea sfocata dall'impianto jazzy e Yer
Face innesta interessanti elementi di drum'n bass. Lavoro
senz'altro frammentario nondimeno fascinoso.(6.8/10)
Giampaolo Cristofaro
E42 - Uomini celesti (Cantoberon,
Febbraio 2010)
G enere : pop - rock
Gli ex Elettrojoyce arrivano alla terza uscita con Andrea Salvati alla voce al posto del fuoriuscito Filippo
Gatti. Uomini celesti svela l'adagiarsi di un percorso
che dall'incoraggiante TheAlbumPart1 del 2003 si assesta oggi su rispettosissime calibrature pop-new wave,
laddove gli Interpol paiono rivisitare i fasti di culto del
passato - e sono i momenti migliori (La strage delle illusioni con citazione C.C.C.P., Ricordami) - o scegliere strade
sulle quali solo l'ispirazione delle singole tracce potrebbe affrancarli da una stanchezza altrimenti latente.
Così non accade, e sentori pasoliniani a parte (che emergono qua e là in modo un po' didascalico: dalla copertina fino alle lucciole di Vuoi perderti? passando per Una
vita violenta) gli E42 azzardano anche dinamismi Afghan
Wigs (ancora Vuoi perderti?) e ricalchi Coldplay preEno di ballad piano-voce e crescendo di chitarra (Per
davvero). Purtroppo però non servono a far rimpiangere
il gruppo originario, o almeno gli inizi sotto questa sigla.(5.8/10)
Luca Barachetti
Elephant9 - Walk The Nile (Rune
Grammofon, Maggio 2010)
G enere : jazz rock
L'impatto è pari al debutto, così come tutto il resto. In
definitiva, gli Elephant9 non cambiano di una virgola
quanto detto in Dodovoodoo, fregandosene di tutto e
tutti. Una musica che sintetizzata, evitando la sequela di
soliti nomi, si pone giusto nel mezzo tra i Deep Purple e
Tony Williams epoca Lifetime. Le tastiere di Ståle Storløkken (Supersilent), il basso di Nikolai Hængsle Eilertsen
(Big Bang) e la batteria di Torstein Lofthus (Shining)
pestano da power trio che si rispetti, suonando tellurici
(Fugl Fonix) e cagneschi (John Tinnick sembra uno strumentale dei Motorhead con Jon Lord all'organo) senza
dare un attimo di respiro se non - a modo loro, sia chiaro - nelle jam Aviation, Walk The Nile e Habanera Rocket
dove tra una sfuriata e l'altra si alternano brevi anfratti
psichedelici.
Per il prossimo disco, che crediamo sulla stessa lunghezza d'onda, sarebbe ideale un dvd live a mostrarceli in
tutta la loro carica, visto che la sola musica dopo poco
mostra la corda. Ad ogni modo, meglio loro che 1000
Mars Volta.(6.5/10)
Gianni Avella
Ellen Allien - Dust (BPitch
Control, Aprile 2010)
G enere : M inimal
A scanso del titolo e dei suoi riferimenti espliciti, dalle
collaborazioni con AGF nell'ultimo Sool ad Apparat
nell'oramai classico Orchestra Of Bubbles, Ellen Allien è sempre più con un piede fuori piuttosto che dentro lo scacchiere della pista da ballo.
La cornice di acciaio e ghiaccio auf Berlin resta il marchio
di fabbrica, ma era fin troppo chiaro che il nuovo lavoro
sarebbe stato diverso e così è stato. Fin dall'apertura in
odor di wave (Ourutopie) ai sussurri ebm di Flashy Flash,
il ruolo degli strumenti, campionati e suonati (chitarre,
xilofoni, bassi e piano) è stato incisivo tanto quanto il
dialogo con i generi pre-techno e pre-E.
La cassa in quattro è dunque arginata e tracce come My
Tree e Should We Go Home si addentrano addirittura nella
classica (per strumenti a fiato) e nella piece elettronica per teatro. Non sono novità assolute per Ellen ma
senz'altro le pop song spiazziano il fan: Sun In The Rain e
You, sono canzoni vere e proprie, persino più dream-troniche di quanto il più avvezzo Apparat abbia mai fatto.
Il lato più propiamente dance torna infine nell'orchestra
di bollicine che tutti abbiamo apprezzato nel 2006 (Ever),
oppure in una versione deep-house (Schlum!), mentre il
passo oltre l'IDM (Dream) avviene nel segno dei migliori
51
highlight
Land Of Kush - Monogamy (Constellation Records, Maggio 2010)
G enere : world avant
Sam Shalabi chiude il cerchio. Le sue ipotesi di una psichedelia globale, oltre le culture, arrivano a conclusione di un ciclo lungo ed appassionante. Come dire che il suo karma d'artista s'è compiuto, allestendo un
affresco in cui si trascende oriente e occidente. Un terreno molto scivoloso, che ha sulla propria coscienza
un numero imprecisato di sconfitti. Shalabi c'è riuscito con la sua Land Of
Kush Orchestra, lavorando ai margini del suo stesso stile e mettendo a frutto
il concetto di ensemble orchestrale. Non a caso questo disco viene firmato
dalla Land Of Kush's Egyptian Light Orchestra, su cui forte si avverte l'influenza dell'Arkestra di Sun Ra con relativa suggestione di un Egitto mitico,
al di là dei secoli e dei popoli.
Li dove il precedente Against The Day prendeva confidenza con il mezzo
e le dimensioni di un gruppo folto di musicisti, il nuovo Monogamy arriva
subito dritto al centro della questione, immaginando un ibrido costante di stili e scenari. Numeri ancora
più grandi, sia sul fronte tecnico (più di 20 i musicisti che si alternano), sia sul fronte del crossover stilistico
con inserimenti avventurosi di jazz orchestrale, psichedelia folk, elettronica cosmica, canzonieri d'epoca.
Una voce processata ritorna, ricorrente, lungo le trame del disco a mo' di contrappunto poetico e narrativo, parlando un vocabolario mitico e ancorando il lato concettuale del disco al contenuto più arcaico delle
cose: "frustrazione / liberazione, castità / carnalità, innocenza / vergogna, purezza / impurità". Il filo conduttore
di un disco, che invece sul piano formale non potrebbe essere più vario ed eterogeneo: vertiginosi arabeschi psych-folk (The 1st And The Last, Tunnel Visions, Like The Thread Of A Spider); free jazz e arie d'orchestra
di una terra immaginaria tra Arabia e Persia (Scars, Boo, Fisherman); groove cosmici per uno Stargate vero
l'infinito (Monogamy).
In un dedalo di voci che affollano il disco, il canto femminile regna sovrano. Tra le varie ugole, quella delle
fidate collaboratrici di sempre, Molly Sweeney e Elizabeth Anka Vajagic, che contribuiscono ai momenti
più alti, mentre l'elettronica è affidata al vecchio compagno di armi Alexandre St-Onge. Chiusura etnica,
che dopo il viaggio stordente dei minuti precedenti è come tornare con i piedi per terra, in un fumoso e
speziato villaggio siriano: Like The Thread Of A Spider.
Quello dei Land Of Kush è un linguaggio universale, tanto denso e complesso, quanto immediatamente
comprensibile. Se non bastasse la qualità assoluta e transculturale della musica, nel testo di Monogamy,
Moly Sweeney si prende la briga anche di declinarne l'alfabeto: "A is for the apple tree / B is for Beelzebub and
he's the snake / C is for the curse of Ham / D is for the drugs that you're now forced to take / E is for eternity / F is for the fucking that you did outside / G is for the Giving Tree / H is for the Holy Spirit's bride / And all of this
comes out / In little birdlike trills / You'll reach for paper towels / To clean up all your spills"(7.8/10)
Antonello Comunale
Black Dog.
Ellen ha sostituito la ketamina con le proteine e la nuova dieta non può che averle giovato. L'alternanza delle
diverse specialità risponde sempre a una buona fattura
e forse per la prima volta in una sua recensione la parola minimal non comparirà nelle prime trenta battute.
Nondimeno per quanto solido è un lavoro di transizione.
Aspettiamo la prossima mossa.(7/10)
Edoardo Bridda
52
Eternal Tapestry - The Invisible
Landscape (Not Not Fun, Gennaio
2010)
G enere : psych - kraut
Mentre si prepara l'offensiva primaverile targata NNF
con molti dei grossi calibri pronti a dispiegare il potenziale freak-psych specialità della casa, recuperiamo un disco uscito da qualche mese come succoso antipasto.
Gli Eternal Tapestry sono di Portland e sono dei fricchettoni in fissa col rock che più krauto non si può, almeno
a giudicare dall'oceanica opener Cathedral Of Radiance,
oltre 11 minuti di magmatico flusso montante di deliqui
psichedelici che si gonfiano in heavyness krauta reiterata
e incessante.
Quello di Nick Bindeman (chitarra e voce), Dewey Mahood (chitarra) e Jed Bindeman (batteria), è uno strambo immaginario space-primitivista: come se per perdersi lungo i crinali della psych più dilatata e kosmische si
avesse bisogno di clava e randello. Tra furia ossessiva e
brutalità strumentale, urla belluine e trionfi di wah-wah,
è un senso di straniamento quello che colpisce nel marasma post-hawkwindiano di Cosmic Dream o al momento
di salire a bordo della navicella spaziale fatta di stracci e
erbacce nel lungo trip Temporal Starshine Voyage.
A materializzarsi è un immaginario bucolico e primigenio che ben si accosta a sfuriate degne di Can e Neu, un
bel modo di mostrare il lato più muscolare della musica
cosmica.(6.9/10)
Stefano Pifferi
Fall (The) - Your Future Our
Clutter (Domino, Aprile 2010)
G enere : the fall
Dopo l'apparizione al Primavera Sound del 2004, che
proprio quell'anno sancì il proprio status di festival musicale di culto, la rapida ascesa nello stardom alternative
dei Fall è stata inarrestabile. E così, successivamente alla
firma per la major indie Domino Records e alle diverse
collaborazioni musicali (Von Sudenfed) e televisive (la
sitcom Ideal), oggi la (one man) band di Salford Docks è
più famosa che mai.
Trent'anni di incoerenze da sempre spesi fuori dalla mischia punk e da tutti i suoi cliché hanno ripagato, tanto
che Your Future Our Clutter sembra infliggere un
colpo ancor più preciso rispetto alle prove precedenti
con una formula country 'n' northern iniettata di spezie
sintetiche, qualche ritocco in bassa fedeltà e alcuni retrogusti krauti.
Mark E. Smith, leader maximo, è ancora lì a rantolare il
consueto rosario d'abrasioni, forse più consapevole che
mai della propria immortalità e riconosciuto carisma, e
ciò che più conta è una riconfermata band - la stessa di
Imperial Wax Solvent - pronta al salto del grande palco. E' la migliore che abbia mai avuto, dice Smith, un grande r'n'r act in grado farsi all'occorrenza potente lama
garage'n'roll o tellurgica tappezzeria di basso, batteria e
synth; un combo che trova nei vezzi lo-fi dell'uomo un
suo spessore e nelle tastiere e effetti della moglie Elena
Poulou un'ottima sinuosità.
La riprova? I tre movimenti di Bury con il caracollare
della carrozzella in cui Mark fu costretto lo scorso anno
e le aperture cow punk della seconda e terza parte; la
solida Mexico Wax Solvent (sempre suono americano rivisto però a suon di crudezze e krauti) e i sette e passa
minuti di Y.F.O.C. / Slippy Floor (tipico basso metallico à la
SST di Dave Spurr per una passeggiata hardcore a passo
d'uomo); le pose Pere Ubu e Cop Shoot Cop in Chino
(rispettivamente su theremin e chitarra); la ballad - se
così si può chiamare - di Weather Report 2. Quest'ultima chiusa di un album splendido, dedicato agli amanti
del garage come a chi non cede alle mode di ieri e di
oggi. (7.3/10)
Edoardo Bridda
Flying Lotus - Cosmogramma (Warp
Records, Maggio 2010)
G enere : prog glitch hop
Il secondo album su Warp di FlyLo, dopo il capolavoro
Los Angeles, era atteso come uno dei dischi del 2010.
E per molti lo sarà. Sicuramente si tratta di un lavoro
importante, che segna una svolta nel percorso artistico
dell'uomo e si candida a possibile cartina al tornasole
di tutta una scena e un suono. Steven sogna big band
live che mischino elettrico ed elettronico ed è in questo
senso che si muove, attraverso l'integrazione forte di
elementi suonati accanto a sample e suoni di sintesi: il
basso di Stephen "Thundercat" Bruner, gli archi arrangiati da Miguel Atwood-Ferguson, il sax del cugino
Ravi Coltrane e l'arpa di Rebekah Raff (simulacro
musicale e spirituale della madrina silenziosa del disco
sotto il segno cosmic, la prozia Alice Coltrane).
Cosmogramma sconta però la pressione che vi si è
creata intorno, Steven ansioso di sperimentare a tutti
i costi suoni e soluzioni nuove. Abbandonato il mood
fumoso, intimista e bluesy di Los Angeles, la psichedelia
lotusiana prende ora una
piega progressiva, con tutto
quello che questo significa
sotto il profilo della sperimentazione, del collagismo
e dell'onanismo. Abbandona il focus sul glitch e sul
wonky e si fa influenzare
dagli amici produttori (il
barocchismo di Daedelus; l'enfasi su una ritmica aggressiva e il clash di elementi di Hudson Mohawke),
allargando i riferimenti e presentando una tavolozza così
ricca che rischia di sembrare a tratti pasticciata. Il lavoro
è disomogeneo e manca di una direzionalità forte, in
tensione tra una manciata di pezzi eccellenti (quelli più
tradizionalmente lotusiani e quelli dove la matrice progressiva-accumulativa trova il giusto dosaggio) e numeri
53
invece eccessivamente lavorati, sovraccarichi di elementi,
superprodotti.
Da incorniciare: la siderale Zodiac Shit; la dilliana Computer Face; una And The World Laughs With You che fotografa la convergenza di rock e hip hop verso i territori
dell'elettronica (col cameo, ectoplasmico, del più calzante dei padrini possibili, Thom Yorke); Do The Astral
Plane è la take house che spacca; Satelllliiiiiteee unisce
ad arte wonky, tribal, latin e Quasimoto; Dance Of The
Pseudo Nymph è il compiuto aggiornamento di quello
che suonavano i Soft Machine su Third. Il resto sono
esercizi piacevoli (il controtempo sospeso di Mmmhmm;
il delizioso intermezzo lounge, con una mutazione degli
accordi di Fall In Love, di German Haircut) e prove tecniche di prog glitch hop (orge di suoni esagerate, macedonie ricoperte di gelatina sampledelica/laptopistiaca;
ingredienti in ordine sparso: breakbeat, superscale di
basso slappato e cascate di arpa, archi cinematici e superenfatici, pseudo freejazz peggio del Madlib di Young
Jazz Rebels, Laura Darlington). Hype kills? Al cinquanta per cento.(7.1/10)
Gabriele Marino
Frank Black - Black Francis Non
Stop Erotik (Cooking Vinyl UK,
Aprile 2010)
G enere : songwriting
L'ultraprolifico Frank Black o Black Francis di Pixies-iana memoria sembra essere inarrestabile, anche
dopo la reunion del gruppo nel 2004, sfornando l'ennesimo album solista, il diciottesimo, mentre prepara anche
la seconda puntata del progetto Grand Duchy, insieme
alla moglie Violet Clark.
Non Stop Erotik viene pubblicato in concomitanza
con l'uscita di un film di Judy Jacobs - che ha realizzato i background visuals per il tour del ventesimo anniversario di Doolittle -,
pellicola parallela all'album
e che si suppone, dopo le
proiezioni di rito, destinata
ad uscire in DVD. Il disco è
stato realizzato con il vecchio collaboratore ed ex
tastierista dei Pere Ubu,
Eric Drew Feldman, e si
attesta sul suo songwriting
più recente, tra molto lontani echi Pixies e variazioni
assortite, in particolare, come si poteva immaginare, vicine a quel country soul a nome Frank Black dei dischi
precedenti. Non mancano accenni blues e rock (Dead
Man's Curve), una cover dei Flying Burrito Brothers
54
(Wheels), persino qualche richiamo AOR.
Più melodico del solito, Non Stop Erotik si concede,
a dispetto del titolo, a tutta una serie di simbologie religiose, e tra dediche d'amore e esaltazione del sesso
orale, non brilla particolarmente. Tutto già sentito molto
meglio da lui, del resto.(6/10)
Teresa Greco
Funki Porcini - On (Ninja Tune,
Maggio 2010)
G enere : D owntempo bbreakz
Quinto album per James Braddell in sosta da quasi un
decennio (l'ultimo Fast Asleep è infatti del 2002). L'uomo torna in gran spolvero e accende ancora una volta
il baraccone Ninja. Il suo è lo show di un eremita che
sembra spuntato fuori da un'epoca lontanissima, come
se l'isolamento fisico (vive infatti nella campagna ingelse
lontano da mondi londinesi à la page) lo avesse costretto
a ripensare al suono e alle radici.
Non c'è niente di più facile che tornare al buon vecchio
jazz live con strumenti analogici, il moog che rifà lo standard (in Moog River appunto), la classicità del mistero instrumental hop in This Ain't The Way To Live o il trip postSt Germain in fungo che è Belisha Beacon, le atmosfere
piene di rumore smooth con le trombe in sordina di DJ
Krush, l'ambient con un pianoforte magico e nostalgico
(On An Inconnsequential Afternoon) e via così per tre quarti d'ora lisergici strafatti di blues (da sballo gli sweep di
Bright Little Things).
La riconferma che il bbreaking è anima blues, e che nella
scuderia dei padroni di casa Coldcut c'è posto sia per
giovani rockettari smanettoni che per vecchi draghi rodati che hanno ancora il sangue nell'anima. Funki Porcini
è uno di questi. Uno che provoca ancora dopo vent'anni:
abbassa il metronomo e convince con pochi mezzi essenziali, un controcanto chill alle rivisitazioni bbreakz di
Harmonic 313. Lunga vita, James. Il re del downtempo
non è ancora morto.Viva il re.(7.1/10)
Marco Braggion
Future Islands - In Evening Air
(Thrill Jockey, Maggio 2010)
G enere : S ynth pop
A portarceli alla Thrill Jockey già dal 2007 è quel misto
di basso manchesteriano e tiepida emotività sintetica, e
certamente, l'estetica che dal varo New Order è arrivata sino al fatidico 1984, anno spartiacque, e bilico, sul
quale poggia il cuore arrangiativo della "post wave"; genere autoproclamato e professato da questo trio appena trasferitosi a Baltimore e terreno sulla quale la label
statunitense sta indagando anche con gli High Places.
Nella città degli eccentrici, questi ragazzi giunti al secondo disco non cercano clamori né riflettori puntati.
Piuttosto, la loro è una missione per conto di un'urgenza
narrativa, un passionalità sottotraccia (e perciò ancor più
cocente) che in In Evening Air li porta a tracciare percorsi di passione e incomprensione, dolore e struggimenti
dove è soprattutto l'amore catartico a regnare sovrano.
Niente epica Echo & The Bunnymen dunque, c'è piuttosto tutto quell'addentrarsi nel lato più romantico di
certi Psychedelic Furs (con un tocco pure di O.M.D.).
Una mossa in dialogo a distanza, se vogliamo, con la formula lo-fi di Blank Dogs e Blessure Grave alla quale i
Future Islands oppongono un bel crooning in chiaro con
un Samuel T. Herring che ha tutte le carte in regola per
arrivare da qualche parte. Il suo canto è il trademark di una proposta derivativa,
raucedinoso dalle mille sigarette, ha quella fiamma dentro che brucia e l'acquasanta è un David Bowie più
volte e degnamente chiamato in causa. Segnali di carisma
di una formula comunque in rodaggio, ma promettente e
già di sicuro culto per taluni.(6.8/10)
Edoardo Bridda
Ganglians - Monster Head Room
(Souterrain Transmissions,
Maggio 2010)
G enere : psych - pop
Logiche mercantili e distributive stanno dietro alla ristampa dell'esordio lungo dei Ganglians. La band californiana di nascita ma newyorchese per elezione (vedi
alla voce "suoni e affinità"), è in procinto di partire per
un lungo tour europeo che per un paio di mesi li vedrà
calcare i palchi del vecchio continente con la ciliegina
sulla torta della partecipazione al Primavera Sound. Molto probabilmente è per questa occasione che Monster
Head Room viene riproposto, con l'aggiunta di un paio
di bonus tracks in coda, Blood On The Sand e Make It Up,
che in realtà nulla aggiungono al suono della band ma che
invogliano all'acquisto quanti non avessero provveduto
per tempo.
Melodie alla codeina, bagni di sole all'lsd, psych-pop pieno
di coretti estivi e bubblegum pop appiccicoso e zuccheroso; roba in modalità bignami che farebbe però la fortuna di tantissimi gruppi alla ricerca della melodia perfetta.
Alchimia che più segreta e sfuggente non si può, ma che i
pischelli americani sembrano aver individuato.(6.8/10)
Stefano Pifferi
Gayngs - Relayted (Jagjaguwar,
Maggio 2010)
G enere : S ynthofreakerie
Della genesi e degli obiettivi dei Gayngs se ne parla altrove su queste pagine. Il collettivo di Minneapolis dà vita
ad un congegno ad orologeria di sfacciata e algida sessualità, dai forti richiami eighities e dalle pulsioni tra glofi e chill out. E messa così
non suona granchè bene,
ma per infettare a dovere
i nostri cuoricini pulsanti,
bastano il crescendo emotivo di Cry, i Talk Talk versione 2.0 di The Walker, la
celestiale convivenza tra hammond civettuoli, chitarrine
hawaiane, sassofoni strappamutande e intrecci vocali da
brivido di No Sweat o il cinematico intreccio simil noise
(!) di sfasato appeal pop di marca Animal Collective
di False Bottom. A giusto coronamento dell'operazione
poi, l'infuocata glacialità dell'apripista The Gaudy Side Of
Town e la splendida sovversiva intimità della conclusiva
The Last Prom On The Earth.
Piacione Relayted, un disco rilassato, un sorso d'aranciata per combattere la canicola estiva, uno stormo di
rondini con le camice hawaiane e gli occhiali scuri, assiepate dietro sintetizzatori e tastieroni eigthies. Un po'
puttane, un po' santoni, i Gayngs si tuffano nella loro
tinozza ricolma di cocktail analcolico al kiwi; che altri li
seguano pare non essere fondamentale, che ciò avvenga
è molto probabile.(7.3/10)
Giampaolo Cristofaro
Georgia Anne Muldrow - Kings
Ballad (Ubiquity, Febbraio 2010)
G enere : funk soul
Quest'album era stato annunciato come la prova più pop
mai realizzata da Georgia. E se in effetti qualche numero
tenta una via più normalizzata e catchy, la ragazza non
rinuncia alle proprie specifiche di base. E ai temi preferiti: i figli, la mamma Africa, l'armonia con la natura (e i
rischi della tecnologia), lo sfottò a certi stilemi dell'HH
commerciale.
L'impressione è quella di un disco scollato e un po' distratto, nel rimbalzo tra canzoni di impronta r'n'b-soul
(dove domina un piano jazzato e la voce della nostra
leggermente sfalsata sui due canali stereo) e brani più
freaky e psichedelici, tra frammenti elettronici, cazzeggio (Room Punk!, punkpop greendayano), un pizzico di
rapping (ospite ovviamente Declaime), l'ennesimo R.I.P.
dedicato a Dilla e una chiusa exotic-latin. Il brano mi55
gliore è l'iniziale Indeed, mentre la pianistica Kings Ballad è
un commosso omaggio a "Jacko" che girava in rete già da
tempo: non male musicalmente, presenta un testo forse
fin troppo urgente e sincero, tanto da passare in un batter d'occhio dal naif al ridicolo (People try to moonkwalk,
but nobody's like the king / We love you Michael...).
Spunti interessanti ma scostanti. E la cosa pare anche
inevitabile, visti l'eclettismo e i ritmi produttivi di Georgia.(6.3/10)
Gabriele Marino
Georgia Anne Muldrow/Declaime Someothaship (Mello Music Group,
Febbraio 2010)
G enere : hip hop funk
Serpeggiante la sensazione dell'assemblaggio e dell'altalena qualitativa nel nuovo disco rappuso della coppia, ormai assestata su ritmi produttivi di madlibiana memoria.
Georgia, qui soprattutto in veste di produttore, canta
poco, colora giusto qua e là, e lascia ampio spazio al rapping zoppo di Declaime e agli ottimi feat di gente come
Kazi (del giro Lootpack) e M.E.D.. Al bancone la affiancano, tra gli altri, Black Milk, Prince Po e un Flying
Lotus discretissimo, tutto al servizio di una grande
performance di Dudley (Mages Sages 2; i due avevano
già collaborato in Whole Wide World, EP cointestato
uscito nel 2009). Per il resto, un bel tormentone (Boogie)
e un bel remix by Oh No in coda. Buon mestiere althop.(6.4/10)
Gabriele Marino
Giuseppi Logan - The Giuseppi
Logan Quintet (Tompkins Square,
Febbraio 2010)
G enere : free jazz
Giuseppi Logan il drop out. Nato a Philadelphia nel
'35, polistrumentista autodidatta, si sposta a New York e
si inserisce nella scena free, suonando con gente come
Archie Shepp e Pharoah Sanders.Tra il '64 e il '65 la
mitica ESP gli stampa due album, di ristretto ma assoluto
culto, con Milford Graves alla batteria e Don Pullen
al piano. Ma Giuseppi, che non è mai stato un tipo dritto,
si perde nella droga e finisce per diventare un vagabondo. Lascia New York e di lui si perdono le tracce. Negli
anni Novanta gira addirittura la voce che sia morto. Nel
2008 lo ripescano a New York, dignitosissimo barbone
abbracciato al suo sax, in quel Tompkins Park su cui si
affaccia l'appartamento che fu di Charlie Parker. La ruota
riprende a girare.
The Giuseppi Logan Quintet esce a febbraio di
quest'anno. Dentro gente fidata come Dave Burrell
56
(piano), Francois Grillot
(contrabasso), Matt Lavelle (tromba e clarinetto)
e Warren Smith (batteria). E se dopo quarantacinque anni la maniera di
Giuseppi non fa più sensazione e la visione si è fatta
meno urgente e - paradossalmente? - meno disperata,
la musica è ancora orgogliosamente sfilacciata: un free
jazz dalle pause esoteriche, scollato e zoppicante ma mai
casinista, intriso di ricordi be bop, dominato dal suo sax
ubriaco - e sheppiano - e dal piano storto di Burrell. Tre
cover (Over The Rainbow, Blue Moon, Freddie Freeloader;
più l'omaggio a Coltrane di Steppin') e nuovi pezzi autografi, tutti condotti bilanciando spigoli e lirismo sincero,
con la sorpresa del cantato alla Wild Man Fischer di
Giuseppi nella conclusiva Love Me Tonight.
La retorica ha spesso le sue ragioni: un ritorno inatteso
e gradito.(6.9/10)
Gabriele Marino
Golden Triangle - Double Jointer
(Hardly Art, Marzo 2010)
G enere : I ndie
Continua a pieno regime l'invasione dei gruppi neo-indie
di Brooklyn e zone limitrofe. Un'onda fatta di band che
nel giro di pochi mesi passano dall'essere totalmente
sconosciute a firmare per label come Captured Tracks,
Mexican Summer e su fino a Matador e Sub Pop.
Proprio di quest'ultima è sussidiaria la Hardly Art di Seattle che oggi licenzia il primo full-lenght del sestetto newyorkese Golden Triangle. Il quale, pur suonando in più
di un passaggio come delle Vivian Girls più energiche
(il che già di per sé pone a suo favore), ha anche qualche
carta in più da giocarsi. Prova ne sono gli echi à la Siouxsie Sioux di Jellyroll e Arson Wells e le corse forsennate
di Rollercoaster e Eyes To See. Sempre pop dunque, ma di
ruvida ed esperta fattura, spigoloso e irruento quanto
basta per farsi ascoltare senza storcere il naso - come
avviene ascoltando molte delle band colleghe.(6.8/10)
Andrea Napoli
Gotan Project - Tango 3.0 (Ya
Basta!, Aprile 2010)
G enere : tango , chill - out
Nuova fatica per la fabbrica poshy della tangotronica.
Marchio ormai riconoscibilissimo e per questo ubervendibile, il gruppo di Philippe Cohen Solal sforna l'ennesima
variazione sul tema tangueiro che coniuga elettronica e
pseudotradizione: sempre con un occhio alla tradizione
di St Germain e F-Comm, i ragazzi rimestano le solite
tiritere da Buddha Bar, con la voce di Cristina Villalonga,
l'hammond di Dr. John e addirittura, in una tamarrata senza precedenti, il commentatore argentino Victor
Hugo Morales.
Risultato: cadono sulla propria ombra con una sequela
di no-hit da chill-out finto sinistroide con la revoluccion
nel portafoglio. Niente di più che una raccolta industriale da lasciare in sottofondo, pure se Gilles Peterson si
esalta. Per chi cerca l'autenticità, consigliamo di ripartire
da altri maestri, tipo Piazzolla. Quelli cattivi, lasciamoli
perdere.(3/10)
Marco Braggion
Gli Hank sono titolari di un fresco pop rock wave che
non disdegna le puntate in territori synth e dance, il tutto cantato in italiano e con una spiccata verve ironicodissacrante, che fa dell'osservazione della realtà il suo
punto di forza. I riferimenti sono la canzone d'autore italiana, anche degli ultimi anni (Samuele Bersani, Bugo
ma anche Rino Gaetano) rivista alla luce di un nonsense acuto che tiene tutto. Bravi.(7.1/10)
Teresa Greco
Harper Simon - Harper Simon
(Tulsi Records, Aprile 2010)
G enere : folk rock
Il detroitiano Byron Simpson è sulla scena dai primissimi anni Novanta, ma è arrivato al debutto solista soltanto nel 2008 con l'acclamato Ode To The Ghetto
(produzioni di Madlib, Oh No, Black Milk e Dilla).
OJ Simpson ne è il seguito, tutto curato da Mad e
atteso con trepidazione, con un antipasto di lusso come
Before The Verdict a stimolare ulteriormente l'acquolina.
Quando va a ruota libera il produttore di Oxnard può
essere pericoloso, lo sappiamo, e qui non si smentisce:
qualche bomba isolata (la
title track, Coroner's Music,
Hood Sentence, Mic Check
313) e poi pezzi che non
brillano e tanto tanto vuoto. Tantissimo parlato (tra
cazzeggio, radio-zapping e
le solite voci pescate nei
film di blax) e tanti interludi (quasi mezza scaletta, e
solo un paio notevoli), sperimentali, sì, ma che davvero
poco aggiungono al discorso del Beat Konducta e soprattutto poco servono il rappato di Guilty. La portata
principale ci lascia insoddisfatti.(6.4/10)
Arriva infine anche nel vecchio continente l'omonimo
album di debutto di Harper Simon, uscito negli States
lo scorso ottobre per la di lui etichetta Tulsi Records.
Il trentottenne sembra aver chiari i limiti e i pregi della
propria calligrafia, ragion per cui propone un lavoro piacevole, onesto, realizzato al meglio grazie ai considerevoli
mezzi a disposizione (non si è figli del grande Paul senza
conseguenze). Dal produttore Bob Johnston al bassista
Mike Leech, dal chitarrista Lloyd Green all'armonicista
Charlie McCoy fino al batterista Gene Chrisman, si tratta di gente che ha inciso assieme ai Dylan, agli Elvis, ai
Byrds.
Tanto bendiddio conferisce ai pezzi di Harper una pelle incantevolmente tiepida e levigata, benché la scrittura
non spicchi per brillantezza né tantomeno per originalità.
I geni paterni sono ravvisabili (strategicamente?) soprattutto nei brani che aprono la scaletta - la chiesastica All
To God e la trepida Wishes And Stars - nonché of course
in quella The Shine scritta proprio da paparino. Quindi,
tolte le situazioni in stile nashvilliano come Tennessee o
All I Have Are Memories, le coordinate espressive ricordano vieppiù un Elliott Smith tra l'efebico (The Audit,
Berkeley Girl) ed il lunatico (Ha Ha), mentre Shooting Star
gioca con una certa disinvoltura la carta della ballad
Tom Petty.
Nel complesso, non c'è nessuna infamia da segnalare.
Neanche troppe lodi, a dire il vero. (6.3/10)
Gabriele Marino
Stefano Solventi
Guilty Simpson - OJ Simpson
(Stones Throw, Marzo 2010)
G enere : hip hop
HANK! - Piedali (800A, Marzo 2010)
G enere : pop wave
Piedali è l'EP d'esordio, prodotto da Fabio Rizzo Waines, The Second Grace - della band palermitana
HANK!, già vista l'anno scorso al Temple Rock Festival '09 e fresca reduce da un tour promozionale. La
dinamica 800A, dopo Il pan del diavolo, centra ancora
l'obiettivo, confermando il buon momento per la musica
siciliana in genere.
Here We Go Magic - Pigeons
(Secretly Canadian, Giugno 2010)
G enere : indie pop
Parlammo di Luke Temple esattamente un anno fa, quando esordiva appunto con la sigla Here We Go Magic
sulla scia dei Vampire Weekend e di quei Paul "Graceland" Simon days cui pure il Nostro contribuì al ripescaggio. Nell'arco di 12 mesi le cose cambiano e giocoforza
tocca reinventarsi. Temple lo fa senza perdere smalto in
57
highlight
New Pornographers (The) - Together (Matador, Maggio 2010)
G enere : power pop
Quinto album per il nostro supergruppo neo-power preferito. La formula è più o meno la stessa ma toglietevi dalla testa che possa suonare stanca o stancante. Il loro entusiasmo, la passione, la facilità con cui
sfornano melodie adesive sono stupefacenti, così come l'apparente semplicità di arrangiamenti e intuizioni
soniche che invece sono trame il cui processo di raffinazione non conosce sosta. Nel caso di Togheter,
la consueta fregola power pop è impreziosita da una vocazione dreamy che pesca a piene mani dalle
sontuose eredità Beach Boys (le armonizzazioni vocali, certo baloccarsi bucolico) e Brian Eno (quelle
emulsioni caramellate di tastiere), conferendo al tutto un'adorabile aria postfricchettona.
Ecco quindi che le dodici tracce si crogiolano in un brodo di coltura tutto
guizzi effervescenti e carezze madreperla, siano esse un languore appiccicoso Mark Bolan (Daughters Of Sorrow, Silver Jenny Dollar), dolciastre malinconie Bee Gees (Valkyrie In The Roller Disco) o sbrigliatezze Pretenders (If You
Can't See My Mirrors). A sbalordire davvero è però la freschezza della vena,
vedi la battente meraviglia power-psych di Up In The Dark (tra i primi R.E.M.
e gli Arcade Fires) oppure l'enfasi di We End Up Together coi suoi call &
response quasi Supertramp e le carezze d'archi tra XTC e Badfinger. In più, quale ciliegina sulla torta,
la formidabile Neko Case è piantata come non mai nel centro pulsante della situazione, sia nei controcanti
che quando si occupa in prima persona della melodia (nell'urgente The Crash Years e nella fiera mestizia
di My Shepherd).
Ci sono anche degli ospiti: Will Sheff degli Okkervil River, Zach Condon dei Beirut e la cara St. Vincent. Il risultato è questo disco delizioso, che ribadisce un concetto: l'azienda capitanata da Newman e
Bejar è una benedizione per lo sclerotico mondo del pop-rock. (7.6/10)
Stefano Solventi
Pigeons la cui componente negroide lascia il posto a un
indole essenzialmente indie rock. E nel cambio di pelle ne vengono due delle migliori cose mai uscite sotto
questa sigla: una delizia alla stregua dei Grandaddy dal
passo trasognato e tastierine fanciullesche (Casual) e una
felpata psichedelia tangente gli Air di The Virgin Suicide
(Land Of Feeling).
Ma il ragazzo piace anche per ricordarci un Jeff Buckely
in salsa lo fi (Bottom Feeder) laddove la voce ora dolce
(F.F.A.P.) ora calata glam (Surprise), si lascia alle spalle lo
spauracchio Simon per rammentare addirittura Robert
Wyatt. Alla resa dei conti, è il grande vecchio di Cabterbury la presenza fissa e tangibile di un opera a cui perdoniamo perfino la poca sostanza di Hibernation e Collector
in attacco, di contro a Vegetable Or Native e Herbie I Love
You, Now I Know declinate etno come nel debutto. Un altro strike che ascolteranno in pochi. In questo caso però,
del proselitismo non sarebbe peccato.(7/10)
Gianni Avella
58
Hole - Nobody's Daughter
(Universal, Aprile 2010)
G enere : R ock
Riformare le Hole era l'unica mossa possibile per
Courtney, proprio come lo era stata per l'altra superstar
'90 che si nasconde dietro a questa reunion - e che, per
medesime ragioni, aveva rimesso in piedi l'unico gruppo
con il quale poteva obiettivamente reggersi l'ego.
Per entrambe è stata una scusa. O se volete un'ammissione. Un'etichetta che commercialmente è servita
tantissimo, ma che principalmente restituisce un'identità al singolare. Billy Corgan e le sue protesi Smashing
Pumpkins 2.0, solide e pompate, non hanno mancato
di deludere i fan orfani del songwriter di cui ora rimane
l'icona, o se preferite il simulacro. E, del resto, per entrambi è stata un'incestuosa questione di ex, o, se preferite, di sopravvivenza, perché di ex-qualcosa il disco è
pieno. Oltre a Corgan, al co-writing c'è Linda Perry,
delle dimenticate (ma non troppo) 4 Non Blondes, e
il giovane chitarrista dei Larrikin Love, più che pro-
mettente folk-art band britannica sciolta anzitempo.Tutti
prostituti per qualcosa, nella totale assenza di tutte le
Hole storiche, le sole a dare al gruppo una continuità
plausibile a partire da Melissa Auf Der Maur, impegnata proprio in questi giorni nel promuovere un secondo
album solista tutto rock per le radio con poco, o nulla,
da dire; per non parlare dell'ex Eric Erlandson che, tra un
capitolo e l'altro di un'autobiografia, continua a premere
per una buonuscita economica.
Courtney, a partire dai giornalisti, da raccontare ne ha
parecchio. Le song sono storie di falliti e altre stronzate
- robe da teenager e per perenni teenager quali sono le
rockstar, scritte senza il contorno dei membri storici che
le ricordano il passato e gli anni che passano. Canzoni
che vibrano dentro alla cianfrusaglia grunge della buonanima Cobain (e di un Corgan la cui inflenza a tratti è imbarazzante), sotto all'intercalare macho e screamo che
tutti conosciamo e un singolo comodo come Samantha
che è una cosuccia hard glam losangelina.
E se c'è della corrente sarà perché lo stardom rock di
questi tempi è pieno di vampiri cattolici iscritti al club di
Twilight: Rolling Stones (in studio peraltro a incidere),
Ozzy, Guns N' Roses e persino Pearl Jam, pure loro
in senilità. Della Love tutto si può dire tranne che non si
sia sempre mossa nei più zozzi e opportunisti binari r'n'r.
Niente di generazionale, da sempre solo macha adrenalina, incazzatura con la scusa femminista, un contraltare
alla disperazione femminea (e anche un po' gay) del sensibile Cobain, in comune le droghe ma con effetti diversi.
E' così dai tempi groupie di Echo & The Bunnymen
e Teardrop Explodes, e da quando sognava il palco
e una band per ottenerlo; ora che lo stage è ritrovato
diventa l'unico motivo di esistenza, proprio come per
l'altro bolso del rock e la sua band con le virgolette (i
Cure).
Non è colpa della Love se il rock, nel frattempo non è
mai stato più caricatura di se stesso come nel 2010 - e
questo grazie anche gli ultimi dieci anni di U2 e mettiamoci pure quel boaro arricchito di Bon Jovi, prodotti
commercialmente falsi, totalmente genoflessi allo show,
che se non vi interessa più potete anche cambiare canale, ma se qui volete stare, meglio scegliere chi ha venduto l'anima al diavolo e chi ti racconta che anche tu,
nel tuo mediocre quotidiano, puoi essere un eroe. E' di
baratti come quelli della Love che il rock ha sempre vissuto.(6/10)
Edoardo Bridda
Holy Fuck - Latin (XL, Maggio 2010)
G enere : A lt . dance
Dopo il botto di LP e il conseguente giro di per il mon-
do a raccogliere premi e consensi, dagli Holy Fuck ci si
aspettava un nuovo missile altezza Battles e !!!, magari
un manifesto in sfida ai potentati Black Dice strutturato
sul micidiale duo alle drum kit in dote al combo, e invece
ci ritroviamo un album di cosmic kraut tardivo calato in
una comoda culla psychedelica, lontano dal groviglio di
muscolarità, strumenti "accidentali" e matematica che li
aveva caratterizzati tre anni orsono.
E' dunque una versione più misurata e calibrata del combo di Toronto quella che si ascolta in Latin, album che
ricalca e approfondisce le atmosfere di una nota traccia
quale Lovley Allen rinunciando con ciò all'assalto cibernetico in favore di una latinità notoriamente germanica e
velatamente newyorchese.
Così Red Lights e il suo funk bianco, benché addomesticato, si presenta più come una parentesi e la ripresa di certa cosmica (Latin America), che risponde concisa al rinato
interesse di formazioni come Jonas Reinhardt, risulta
una missiva fin troppo calcolata, come pure il suo ovvio
corollario che è Silvia&Grimes, un motorik à la Neu!. Di
questo passo è fin troppo naturale sentirli toccare quel
pop epico di certi Arcade Fire, qui riprodotti strumentalmente e in salsa elettrock. Niente di sconvolgente
quando questo combo, sconvolgente lo era per davvero.
Latin dunque come figlio di una risconosciuta spendibilità conquistata con il sudore della prova precedente;
tecnica, furbizia e risparmio energetico sulla scia di trend
assodati nell'underground di settore: Sht MTN oblitera
una versione rock dei Black Dice. Stilettos è il solo brano degno del loro passato. I novizi non lo disegneranno.
Gli scafati rimarranno delusi.(6/10)
Edoardo Bridda
Hundred In The Hands (The) - This
Desert EP (Warp Records, Maggio
2010)
G enere : S ynth pop
La reunion flash degli Young Marble Giants ha rappresentato per l'underground il picco di un trend già riscontrato in queste pagine assieme a quello del revival della
4AD storica. Certo pop DIY quanto gotico degli eighties
è di quelli che non si dimenticano in questi anni di riscoperta dei primordi sintetici/psichedelici, e Hundred In
The Hands, duo/coppia degli ex Boggs Jason Friedman
and Eleanor Everdell non fanno certo eccezione.
Reclutati dalla britannica Warp in seguito a un fortunato remix di un primo singolo, che ne rifondava il sound
su basi disco togliendone ogni tentazione Bloc Party
(Dressed In Dresden per mano del DFA Jacques Renault),
la coppia si reinventa in This Desert con un synth pop
contaminato per canto etereo (+ korg) di lei e il chitar59
rismo psych-wave di lui. Ne vengono sei summertimeGothic dreamy bits parallele a quelle degli High Places
con la coppia newyorchese a overdubbare la voce convogliando l'avant in un synth-pop di nostalgia disco Lio
(Building In L.O.V.E), vintage house britannica mescolata
all'indietronica (Tom Tom), fino a trovare una propria collocazione tra il minimalismo degli XX e gli arpeggi dei
Cure (Ghosts), sempre in cassa quattro.(7/10)
Edoardo Bridda
Il Parto delle Nuvole Pesanti Magnagrecia (Ala Bianca, Marzo
2010)
G enere : etno - world
Sopravvissuti con spirito d'iniziativa, vedi collaborazioni
con teatro e cinema, alla fuoriuscita dal gruppo di Peppe
Voltarelli, Il Parto delle Nuvole Pesanti torna ad un
disco di sole canzoni (il precedente, Slum, riportava in
audio e video un intero spettacolo teatrale). Magnagrecia racconta di emigranti e immigrati, diritto alla terra e
culture da salvaguardare virando in palpiti elettroacustici
un'anima etno-world tirrenica da sempre ben lontana da
ogni cartolinismo. Piaceranno agli amanti di Manu Chao
queste dodici canzoni e in certi passaggi sorprenderanno i seguaci della prima ora immaginando i Calexico in
gita a Budapest, come accade nella funeraria e languida
Vite senza vita, o andando a tirare in ballo il solito Vinicio Capossela, bandistico in Sacro osso (con Roy Paci
a dirigere) e alcolico in Car wash. Eppure, buona scrittura a parte (Giorgio è manualistica Mau Mau, e si lascia
ascoltare con gusto), viene difficile negare che il vulnus
del Parto oggi sia la mancanza di una voce all'altezza di
quella del frontman originario. Ci provano a turno, anche
con risultati dignitosi, gli altri tre componenti del gruppo
e poi svariati ospiti tra i quali Claudio Lolli, Amy Denio e la cantante iraniana Sepideh Raissadat. Ma Voltarelli era altra cosa e l'impressione è come di qualcosa
di incompleto, da rinnovare tenendo quanto di efficace
c'è già ora qui.(6.1/10)
Luca Barachetti
Indignant Senility - Plays Wagner
(Type Records, Maggio 2010)
G enere : ghost ambient
Ad inizio anno, Type aveva dato alle stampe due vinili
in edizione limitata intestati a Indignant Senility, uno dei
tanti moniker dietro cui si nasconde Pat Maherr. Intitolati Plays Wagner 1 e 2, altro non erano che la ristampa
in vinile di una cassetta pubblicata in edizione carbonara
sull'etichetta di Maherr stesso. Ora, per allargare ulteriormente il pubblico, Type raccoglie entrambi i vinili e li
60
pubblica in cd, dando alle stampe quella che tecnicamente dovrebbe essere la ristampa della ristampa, se non
fosse che fin'ora il materiale era di così scarsa reperibilità da non considerarsi nemmeno come già pubblicato.
Con queste musiche si scrive un altro capitolo nella storia della classica d'avanguardia, o meglio
di un suo adattamento, di una sua riproduzione. Il taglio cheap e lo-fi
della produzione non tragga in inganno, né tantomeno si
liquidi il tutto come un banale rip-off di Layland Kirby.
Pat Maherr viene da Portland ed è ragazzo dalla tentacolare e multipla espressione. Fa hip hop con il moniker
DJ Yo-Yo Dieting, lo-fi noise come Sisprum Vish, musica
concreta come Moms Who Chop e appunto ambient di
ascendenza industrial come Indignant Senility. Nella serie
in questione, Maherr prende frammenti di partiture di
Wagner è le scioglie in un continuum sonoro e temporale, che sa di liquido amniotico, risacca acida, ipnosi
onirica. Flirta con la patina scura di Eraserhead e finisce
per collidere proprio con Caretaker o meglio con la
trilogia ultima di Layland Kirby, in un mondo dove l'ambient di matrice classica si confonde nelle sue strutture e
nelle sue intenzioni, divenendo l'ombra di se stessa.
C'è sicuramente anche qualcosa della dark ambient virata in colonna sonora della Miasmah, ma Indignant Senility
si distingue per i granuli porosi e "grammofonati" del
suono, per un missaggio che annichilisce le profondità
e al tempo stesso vi si perde dentro, per un umore che
non appartiene né al sogno, né all'incubo, piuttosto ad
uno stordimento offuscato e tossico. Come una registrazione su cassetta, ridoppiata tante di quelle volte, che il
noise di sottofondo si confonde con la traccia registrata.
Maherr ottiene con un approccio strampalato e naive
una musica che non è più tale. Un'ombra di quello che
è stata. Una sua versione fantasma, contaminata e ricodificata. Wagner non è più nulla, se non un sua illusione
irriconoscibile. I formalisti non stiano a sentenziare, una
musica come questa esiste per dare giustizia alle ombre. (7.5/10)
Antonello Comunale
Iron Kim Style - Iron Kim Style
(Moon In June, Aprile 2010)
G enere : avant jazz
Il nome è mutuato da un'arte marziale nordcoreana dedicata al "grande leader" Kim Il-sung, padre dell'attuale "caro leader" Kim Jong. Nessun intento celebrativo,
ovviamente, semmai un modo di affrontare con ironia,
fascino e sconcerto uno dei fenomeni sociopolitici più
controversi dell'era contemporanea. Non stupisce in
Dennis Rea - che del progetto è principale artefice questo sguardo ad oriente, dove è molto apprezzato
highlight
Okkervil River/Roky Erickson - True Love Cast Out All Evil (ANTI-,
Aprile 2010)
G enere : sixties hero
Comodo apporre su Roky Erickson l'etichetta di "vittima dell'acido", tanto
quanto lo è sottolinearne lo status di leggenda vivente. Di icona - involontaria,
ma tant'è - di un'epoca nella quale la musica la si viveva fino in fondo, nel
bene e nel male. Non che, come con tanti altri, la droga non abbia avuto un
peso rilevante in una vita sventurata. Però ci son stati i ricoveri in manicomio
e c'è stato l'elettroshock; innanzitutto c'è stata l'incapacità da parte di una
società ottusa ad accettare il diverso. E allora quanto colpa è degli eccessi e
delle cattive frequentazioni e quanta di chi non capisce che il visionario nel
baratro guarda anche per noi?
Chiedetelo al Daniel Johnston evocato dalla commovente bassa fedeltà di Devotional Number One e God
Is Everywhere, tracce che aprono e chiudono in modo circolare questo lavoro. Il primo in un decennio
abbondante per l'ex Thirteenth Floor Elevators, prodotto da Will Sheff (gli Okkervil River eseguono fermi ma discreti) e allestito pescando canzoni negli archivi per distillare una seduta psicanalitica.
Mai come in questo caso occorre prestare attenzione alle parole con cui quali l'uomo si racconta senza
lesinare in dettagli, aprendosi con un candore da lasciare ammirati a prescindere dall'esito strettamente
musicale. Che è rilevante assai, tra i migliori della non ricca produzione solista del texano fatti salvi un paio
di numeri fiacchi verso la fine; poco propensa, inoltre, al trascinante rock psichedelico cosparso di estatici
bagliori cui il texano ci aveva abituato.
Qui la dimensione è "confessionale", perciò la musica aiuta a raccontare appoggiandosi al folk, al blues,
al country-rock, al gospel. Alla tradizione da cui tutto discende e da dove Roky partì per le sue esplorazioni decenni fa. Radice robusta del capolavoro drammatico Please Judge (una richiesta di perdono in
terza persona che finisce dalle parti del primo Micah P. Hinson) e della rabbrividente John Lawman,
del profondo brano omonimo e di quella You Got The Silver trasfusa di mestizia che è Ain't Blues Too Sad.
Aspettavamo tutti del fragore sonico con i Black Angels, ma l'alieno ci ha fregati ancora. E poi il pazzo
sarebbe lui.(7.3/10)
Giancarlo Turra
come chitarrista solista e per il repertorio dei Moraine
(la sua band di avant prog). In più, sta per pubblicare un
album di musiche tradizionali cinesi rilette secondo la
sua calligrafia, che è appunto prog ma anche jazz, funk e
sia pure - massì - rock. Tornando agli Iron Kim Style, si
tratta di un quintetto stanziato a Seattle capace di mettere in fila dieci tracce in straordinario equilibrio (spesso
formidabilmente squilibrato) tra fusion, post-bop e free.
Ora febbrili fino all'incandescenza (Pachinko Malice, Mean
Streets Of Pyongyang), ora lisergicamente pensose (Don
Quixotic, Dreams From Our Leader), risalgono le radici fino
agli Abercrombie, ai Miles Davis del brodo di cagna, al
Freddie Hubbard in bilico tra estasi e frenesia, ammiccando en passent l'epica travolgente dei King Crimson.
Il tutto - così ci dicono - senza aver scritto una sola nota.
Improvvisando live in studio. Chapeau. (7.4/10)
Stefano Solventi
Jains (The) - Holy Changing Spirit!
(Acid Cobra, Maggio 2010)
G enere : rock
Ammesso che riusciate a superare la tipica orticaria da
volto noto - il cinquanta per cento delle Jains ha le fattezze nordiche della Kristen Reichert altresì nota su
MTV come parte del duo Kris & Kris - e il fastidioso
odore di glamour che sprigiona tutto il progetto già a
chilometri di distanza - la Stronger tratta del primo disco
fu scelta per lo spot di una nota marca di orologi e gioielli -, potreste anche rivalutarle queste Jains. Per lo meno
per un'attitudine rock-noise disposta si a giochicchiare
con un pugno di influenze preconfezionate - Hole, The
Kills, P. J. Harvey, Patti Smith, White Stripes - ma
anche a mettersi in discussione senza troppe remore.
Dimostrazione ne è il fatto che la produzione di ognuno
dei tre dischi pubblicati dalla formazione italo-canadese
61
highlight
Tamikrest - Adagh (Glitterhouse, Marzo 2010)
G enere : T uareg blues
Che il fenomeno Tinariwen dovesse prima o poi generare dei figliastri era più che prevedibile. Ma se
i figliastri in questione hanno i pregi dei Tamikrest allora non possiamo che gioire e sperare in altre
nascite. Ousmane Agg Mossa, maliano di Tinza, oggi ventisettenne, cresce ascoltando su precarie cassettine le gesta del gruppo di Ibrahim Ag Alhabib e impara a suonare la chitarra
secondo la tradizione tishoumaren. Normale che ad un certo punto trovi
persone appassionate come lui al "Tuareg-blues" e fondi un gruppo, meno
che come per i Tinariwen anche per i Tamikrest sia fondamentale il passaggio al Festival in the Desert del 2008, ad Essakane. Lì infatti sono vicini di
tenda dei Dirtmusic di Chris Eckman, il quale si innamora della loro musica e un anno dopo vola a Bamako, ai Bogolan Studio fondati da Ali Farka
Touré, per produrre il disco d'esordio del gruppo, che è appunto Adagh, e
registrare l'ultima fatica Dirtmusic (con Chris Brokaw e Hugo Race) a cui
parteciperanno proprio alcuni Tamikrest.

Diciamolo subito: i Tamikrest non sono al livello dei Tinariwen. Ma probabilmente è solo una questione
anagrafica, perché le premesse ci sono tutte e qualcosa di buono, per non dire ottimo, si sente già qui.
Meno ritmicamente compositi dei loro genitori musicali (in alcuni casi sembrano voler avventurarsi in
semplici quadrature occidentali, vedi Aicha), acquistano ascolto dopo ascolto un'attitudine soul corale che però col genere specifico non c'entra niente - difficile da trovare in quanto è provenuto fino ad oggi
dal Mali e foriera di canzoni contagianti, complice qualche chitarra in levare - ma anche in questo caso il
reggae c'azzecca poco. Nei testi raccontano la cultura dei nomadi Tuareg e le loro problematiche quotidiane con un'attitudine più gioiosa e meno barricadera dei Tinariwen (Mossa e compagni non hanno mai
imbracciato le armi), tuttavia talvolta abbandonano le atmosfere solari e si concentrano su brani crepuscolari (Toumastin, con Race alla slide), se non proprio notturni (Aratane n'Adagh), a cui si affiancano sortite
di autentica psichedelia desertica, come nella splendida title-track.
Insomma, lo dicevamo all'inizio: promettono assai bene, anche perché sono giovani e dichiarano di aver
ascoltato molto altro al di là del tishoumaren (rap, hip-hop, rock recente). Staremo a vedere. Intanto viva
la musica Tuareg.(7.3/10)
Luca Barachetti
è stata affidata a tre personalità piuttosto lontane dal
verbo "stradaiolo" della band: Cesare Basile per Kill
The Ghost, Rob Ellis per il successivo Goddess In You
e Amaury Cambuzat per questo Holy Changing Spirit!.
Segno quantomeno della voglia di provare accostamenti
insoliti e convergenze a prima vista complicate, se non
proprio di un'indole da sperimentatori.
Detto questo, appare tuttavia chiaro come le Jains non
siano destinate a scardinare gli equilibri interni del rock
internazionale. Anche perché le cose più importanti il
duo - alla batteria Anna Di Pierno - le ha già dette
ai tempi di un esordio nervoso al punto giusto. In Holy
Changing Spirit! si tratta al massimo di aggiustare il tiro
con un po' di furbizia, coinvolgendo i distratti con qualche ammiccamento Gun Club (No Limits), un paio di
62
ballads telecomandate (Lullaby e Find Your Way) e qualche blues/pop da airplay a stelle e strisce (Out Of My
Body).(6.3/10)
Fabrizio Zampighi
Jamie Lidell - Compass (Warp
Records, Maggio 2010)
G enere : W arped funk soul
Un fantasma si aggira per i quartieri generali di casa Warp:
Michael Jackson. Il ghostbuster di turno è Lidell, che da
Jacko eredita la metrica e il beat intrisi di soul (Completely Exposed). L'attitude invece si rifà a Prince, tagliato
con la trasversalità del suono now-funk di Dam-Funk
(senza però l'esagerato sproloquio di synth Ottanta) e
con il mesh che da un anno a questa parte ha convoglia-
to tra gli artisti dell'etichetta voci eterogenee del calibro
di Bibio, Hudson Mohawke e Gonjasufi.
Il quinto full length della voce soul britannica di Multiply
punta a coccolare l'ascoltatore con le dovute malinconie
(She Needs Me), ma si spara in vena anche una bella dose
di rudeness blues: in The Ring il ragazzo sembra un Tom
Waits depurato da plurimi coffee & cigarettes', in Gypsy Blood urla in falsetto e distorce senza problemi, in Big
Drift si accosta all'ultimo Eddie Vedder country e nella
conclusiva You See My Light richiama il gospel dei Fleet Foxes; in più eredita quella freschezza acustica che
sembrava scomparsa dopo i capolavori di John Martyn
(Compass è il lentone da brivido remember).
Sarà fighetto, sarà cool, ma quell'aria poshy se la merita
tutta. Il motivo è presto detto: questo disco ha il sapore
dell'autenticità delle produzioni analogiche d'antan. Non
a caso è stato registrato negli Hudson Studios losangeliani di Beck, dove il bluesman americano ha radunato tra gli altri anche Pat Sansone degli Wilco, Feist
e il batterista James Gadson, già presente nei dischi del
Beck's Record Club project; si sente quasi il sapore di
quelle cose britannicissime à la Paul Weller che lasciavi
sul giradischi e che dimenticavi in loop, contemplando
la magia del sound e sognando con l'anima che pulsava
atmosfere fuori dal tempo.(7.4/10)
Marco Braggion
Jamie T - Kings & Queens (EMI,
Settembre 2009)
G enere : indie pop
Ventiquattro anni. Wimbledon, Londra. Una passione
smodata per la tradizione pop della terra di Albione
(ma anche per il rap e il folk), un ego non piccolo (nelle
sue canzoni a volte parla di sé in terza persona) e una
tendenza all'eccesso: di alcol, come testimoniano alcune
sue esibizioni live, ma anche di trovate melodiche e ritmiche. Sono tante, infatti, quelle che costellano Kings
& Queens (uscito in realtà nel 2009, ma che doveva
essere recuperato), la seconda prova sulla lunga distanza
di Jamie Treays aka Jamie T, il cui talento pare oramai
essere arrivato anche al mainstream più modaiolo, come
testimonia il fatto che NME lo abbia premiato come Best
Solo Artist dell'anno passato.
Hocus Pocus è il brano che i Kasabian non hanno mai
scritto e non scriveranno mai. Il basso micidiale di
Sticks'n Stones è un'omaggio alla mai dimenticata lezione
post-punk dei Gang of Four, mescolato a un rapping
che spinge soltanto ad alzarsi dalla sedia e muovere le
anche a tempo. Siamo solo alla quarta traccia, quando
Jamie T sembra far saltare il banco. Con il suo accento
cockney si trasforma in un cantante da pub di periferia,
con la pinta di birra scura sullo sgabello e la sigaretta tra
le dita: è l'inizio di The Man's Machine, che però dopo
la prima strofa - giusto per ribadire che l'inventiva non
manca - si fa rap sulla chitarra acustica, quasi d'un Beck
d'oltre manica. Le citazioni della storia monumentale
del pop anglosassone sono infinite e dimostrano l'amore per Kinks, Beatles e The Specials. Non mancano
riferimenti più moderni, come i Massive Attack (un po'
sbeffeggiati in Castro Dies) e quella cultura urban inglese
che è sfociata nel mainstream quando l'ha presa in mano
Damon Albarn inventandosi i Gorillaz (Earth,Wind &
Fire). Anche nei momenti più intimi il ragazzo di Wimbledon non rinuncia del tutto al rap (Jilly Armeen) e, anzi, lo
colora di sfumature soul (Emily's Heart).
Kings & Queens è un disco comodo da ascoltare come
un paio di pantofole sfondate: estate o inverno, da quel
meticciato musicale salta sempre fuori la canzone giusta.
Alla peggio si può giocare a scoprire le influenze dei suoi
mille padri.(7.3/10)
Marco Boscolo
Javelin - No Mas (Luaka Bop,
Maggio 2010)
G enere : agit pop
Meglio passeggiare per New York, speranzosi magari di
incontrare un Yeasayer, anziché muoversi per la natia
Providence col rischio di imbattersi in un Lightning
Bolt. Il duo Javelin rischia seriamente di farsi nome caldo dei prossimi mesi. Attivi dal 2005, vantano una coppia
di 12" per Thrill Jockey - Javelin e 2 - la cui eco, mossa da
un impeto centrifugo dove ogni scheggia ascrivibile alla
voce pop fa brodo, è stata raccolta nientemeno che da
David Byrne che non ha esitato un attimo a portarseli
alla Luaka Bop. Un legame di sangue, quello di Tom Van
Buskirk e George Langford (sono gugini), e artistico che
sfocia nel caleidoscopico No Mas che tra campioni, violini, ilarità e clima da buona la prima porta la grande mela
per l'ennesima volta sugli scudi.
Dicevamo di Yeasayer, specie per l'aria briosa e la componente negroide, e Javelin li rasentano suonando però
maggiormente brillanti, spericolati e imprevedibili. Poi
balza all'orecchio il groove, tanto da farli sembrare come
dei Fun Lovin' Criminals - non a caso da New York - ingaggiati per un jingle da sit-com a sfondo black (Intervales
Theme appunto, ma anche Tell Me, What Will It Be?), non
prima di sbroccare come delle Chicks On Speed in overdose d'elio naturalmente (Oh! Centra).Talvolta campionano, altre volte suonano electro (On It On It) e synth pop
(Moscow 1980) per poi virare come nulla fosse a pargoli
mai dichiarati di David Axelrod (The Merkin Jerk).
Perfino una seria come Larkin Grimm (guest ma non
63
si sa dove, forse nella succitata Oh! Centra?) si è prestata al gioco; e infine come resistere ad un neo-afro di
scuola Daptone (Shadow Heart) dal refrain prossimo al
Todd Rundgren di A Wizard, A True Star?(7/10)
Gianni Avella
Jennifer Gentle - Concentric (A
Silent Place, Aprile 2010)
G enere : avant - industrial
È ormai assodato che Jennifer Gentle abbia una doppia
anima: su Sub Pop il lato confortante e dolcemente sixties oriented, sulla nostrana A Silent Place quello più oscuro, ambiguo e sperimentale.
Concentric, ormai quarto
disco targato ASP, dopo A
New Astronomy, Sacramento Session/5 Of 3 e
Live In The House Of
God, corrobora questo
sdoppiamento e, a differenza delle precedenti prove,
gioca ancor più pesante.
Oltre cosmica e concreta, sotto la lente deformante di
Jennifer, vera e propria Alice perversa e dissociata dei
giorni nostri, finisce lo spettro più larvatamente industrial delle arti dell'ultimo trentennio. Intransigenti e
oscure, le sette tracce dell'album spaziano dall'ambient
deforme delle introduttive Key e Land ai monoliti postCoil/NWW di Neon e Halos, triturando nel mezzo
quanto di più nero sia stato prodotto in musica: gli sgorbi noise di Scar, l'astrattismo concreto di Hunt, l'afasia
avant di Melt e non solo.
Come un William Blake nato nelle periferie industriali
anglosassoni d'inizi '80, Concentric è un lavoro che
va necessariamente preso come un unicum, uno slancio
verso gli inferi dal taglio fortemente onirico, un gorgo
di ansia ritorta in musica che evoca passaggi e paesaggi
visionari. In quest'ottica, molte sono le affinità rilevabili
con Sator, album dell'amico e collega Gastaldello (Mamuthones): stesso mood tendente al nero e identici
percorsi sperimentali trasversali. Sicuramente segno di
una rinnovata stima e concordanza di visioni musicali tra
i due e, chissà, magari il preludio a nuove esperienze collettive.(7/10)
Stefano Pifferi
Jeremy Jay - Splash (K Records,
Maggio 2010)
G enere : songwriting
Instancabile Jeremy Jay: eccolo di nuovo il songwriter
e polistrumentista americano, innamorato di un'estetica
64
europea a cavallo tra sixties ed eighties con relativo accompagnamento musicale al seguito. Questo è il primo
di due album previsti per il 2010, Dream Diary uscirà
in autunno.
Si potrebbe pari pari in quest'ultimo, Splash, ripetere
quanto già scritto l'ultima volta per Slow Dance (2009),
vale a dire la collaudata formula, un vintage ottanta passato attraverso il cantautorato decadente french e new
vave con tastiere e bassi sempre evidenti, non ha avuto
variazioni evidentissime di sorta.
Ancora songwriting, questa volta virato verso una maggiore malinconia modello Smiths, dei quali riprende anche il cantato nell'iniziale As You Look Over The City e nella
chiusura con Why Is This feeling So Strong?; in generale si
assiste a una preponderanza di ballate, che non spostano
molto il tono generale dell'album, non apportando niente di significativo rispetto a quanto già visto nei lavori
precedenti.(6.7/10)
Teresa Greco
John Zorn - The Dreamers - Ipos:
The Book Of Angels Vol. 14 (Tzadik,
Marzo 2010)
G enere : romantic Z orn / jazz
Lo Zorn romantico era stato una vera sorpresa. Dieci
anni fa. Adesso è una iattura. L'eterna variatio di Masada
era stata uno stimolante gioco a quattro (tra compositore, esecutori, ascoltatore e la musica come tradizione
e come catalogo di generi e stili). Adesso...
Riassumendo il disco: i controtempi di Hashul; il giro di
basso di Galizur (volano per gli interventi in punta di
strumento dei musicisti e della schitarrata finale di Ribot); il delizioso giochino ebraico-minimalista di Zavebe;
l'atmosfera onirica di Qalbam; l'esotismo serpeggiante di
Zortek; l'inseguimento country-western di Kutiel (che fa
davvero un po' sorridere). Il tutto, senza alti né bassi, con
l'arma a doppio taglio della riconoscibilità degli assi zorniani (Ribot in primis e subito a ruota Wollesen) bene
in vista, anche troppo: a un passo dal diventare stucchevole.
Zorn (ormai?) fa jazz nell'accezione peggiore: tema e soli
oppure un tappeto fusion. Manca l'incisività, la capacità di
distinzione di questo da quello. Del resto, anche lo Zorn
rumorista aveva finito col ripetersi e annoiare (da qui la
sorpresa per il recente vitalissimo Moonchild). Ipos è un
disco carezzevole e trasparente. E' muzak elegante. Zorn
lo sa e lo dice perfino, nelle liner notes: perfect for the
early morning, late at night, at home or in the car.(6/10)
Gabriele Marino
Jónsi - Go (Parlophone, Aprile
2010)
G enere : pop rock
Il debutto solista di Jónsi - non considerando l'esperienza in duo col partner Alex di pochi mesi fa - significa
un affrancamento iper-pop rispetto alle ben più epiche
lande Sigur Ròs. Co-prodotto assieme a Peter Katis
(già al lavoro con gli Interpol), il disco si avvale degli
arrangiamenti del genialoide Nico Muhly, le cui guizzanti trame orchestrali allestiscono assieme alla verve
percussiva di Samuli Kosminen una coreografia sonora
di palpiti assieme arcaici e futuristici, fremiti etnico/artici
che schiudono visioni di un presente diverso e (forse)
possibile, però talmente lontano per geografia e cultura
da profilarsi come autentica realtà virtuale ai nostri occhi di mediterranei globalizzati.
Qui stanno i maggiori motivi di interesse di un disco che
si affida a nove canzoni ahinoi poco incisive. Come dichiarato dallo stesso Jónsi, sono state composte nel corso degli anni parallelamente all'attività con la band. Ok,
cosa dire: in tutta franchezza, sembrano versioni sbiadite
di certe intuizioni ben più brillanti e intense che popolano gli album dei Sigur. Persino la voce sembra farsi un po'
il verso, per quanto ci sorprenda a cimentarsi con l'inglese in ben sette tracce. Non resta che sperare si tratti di
una scappatella senza troppe conseguenze, a parte quelle
commerciali che certamente arrideranno.(5.7/10)
di spugna alla cracked Foundation e cambiando l'aria alla
cameretta coi poster della Cat Power dalla quale era
partita. I Just Love You More, uscita via website qualche
tempo fa, tra pose Kim Gordon e chitarre off, pareva
persino andare oltre e mettere in pericolo gli incassi della Polydor, dopodiché un singolo, Do Wah Doo, ribaltava
ancora una volta la frittata presentandola nelle vesti disinvolte della solista da girl group dei Sessanta. Tutto un
bluff dunque?
Prodotto da Bernard Butler, My Best Friend Is You
somma inaspettatamente i lati del foglio mescolando una
manciata di canzoncine sixties pop a un'altra di contaminazioni indie: Don't You Want To Share The Guilt, è una
song à la Allen pronta a tradiere sdolcinatezza e confindenze girly per un finale rrriot; la splendida Higher Plane
rimescola coralità canadese, C90 generation al passo di
Violent Femmes e la buona I've Got A Secret, spegne
gli amplificatori per un lo fi da dopo grunge. Discreta
infine, la piano song à la Regina Spektor Pickpocket e
dunque le carte buone nel mazzo ci sono come pure
certe orchestrazioni azzeccate da parte dell'ex Suede in
odor di Lightspeed Champion a inizio scaletta (Paris, Kiss
That Grrrl).
Romantica, isterica e ironica con quel poshy pop che
non rinuncia alla franchezza autobiografica dell'esordio,
la londoner è cresciuta. Ha trovato una propria strada
unendo capacità tecniche, incanto e frenesia.(7/10)
Stefano Solventi
Edoardo Bridda
Kate Nash - My Best Friend Is You
(Polydor, Aprile 2010)
G enere : P op , indie
Khamsa Khala - All Rites Reversed
(Lens Records, Maggio 2010)
G enere : elettronica esotica
In questi gaga times, il tempo delle mele del pop confindenziale di qualche anno fa sembra un lontano ricordo. Lily Allen avrà anche
tenuto alta l'attenzione
dei media grazie ad alcune
mirate apparizioni a TRL,
un album smaltato di tastiere AIR like e racconti
di serate davanti alla tv (e
sfortunati ragazzi minusdotati), eppure al voltar del
decennio, l'attenzione nella cameretta dei ragazzi videoludici l'ottieni a colpi di r'n'b targato X Factor o con il
folk confidenziale di Kate Nash, rossa numero 1 delle
charts del Regno nel 2008 con Made Of Bricks, che è
forse l'unica in grado di scombinare le carte nel mainstream britannico.
Da mesi la ragazza sbandierava di rispondere alle Allen
del mondo a suon di L7 e Sonic Youth dando un colpo
Fondere elettronica e texture orientali. Non proprio
l'ipotesi più innovativa e originale nel campo della musica moderna. Khamsa Khala è infatti l'ultima (l'ennesima)
sigla che si iscrive nel club dei pittori esotici, di quelli
che salgono e scendono di continuo le sinuose scale mediorientale, contaminandole con il gusto occidentale per
l'elettronica. Aggiungiamoci, com'è d'uopo, le ritmiche
tarantolate di mille e uno vicoli, persi li in mezzo, nei dedali più fumosi e speziati di tanti villaggi africani, sauditi,
persiani, indonesiani e quello che otteniamo è un sound
che conosciamo già molto bene.
Dietro Khamsa Kala si nascondono Neville Harson dei
Mandible Chatter e Don Poe dei Deathpile. Ergo
questo è a tutti gli effetti un progetto estemporaneo che
sta in piedi con una propria logica, ma che vale per il momento (poi un domani chissà) né più né meno che come
un divertimento a latere. Il soundscape è di quelli che ti
aspetti e sta esattamente a metà tra il groove ipnotico e
ossessivo di Muslimgauze e l'etnografia da deviati ses65
suali di Peter "Sleazy" Christopherson con il suo The
Threshold HouseBoys Choir. Ma più che al medio
oriente qui si guarda alle sponde mediterranee dell'Africa evoluta, in particolare al Marocco, tra Marrakech e il
deserto del Sahara, dove gran parte del materiale contenuto nel disco è stato messo in piedi, con tanto di "footage" ripreso in video e messo su un dvd allegato che
vale come compendio visivo alle panoramiche distensive
e descrittive della musica.
Da qui, inevitabilmente, anche un umore arioso e zigano, da nomadi del deserto, à la Tinariwen. Non serve
mettere in risalto episodi singoli, perché tutto il disco
vive come unico discorso strettamente "geocentranto" in
sé. Vale solo la pena notare, che dopo la Passione di
Peter Gabriel e tutti gli excursus nel settore esotico,
a mo' di cartoline deviate e pop, messe in essere da Sublime Frequencies, dischi del genere lasciano il tempo
che trovano sia sul piano etnosociolico che su quello più
strettamente musicale. Comunque sia un bel reportage,
che da solo vale un bel gruzzolo delle trasmissioni di
Licia Colò.(6.5/10)
Antonello Comunale
KK Null/Deison - Into (Silentes,
Dicembre 2009)
G enere : A mbient noise
K.K. Null e Cristiano Deison avevano già avuto modo
di collaborare nel 2003: in particolare, una delle innumerevoli sortite discografiche del primo (Helium Flash)
aveva trovato ospitalità nel catalogo dell'etichetta personale del secondo, la Loud!.
Con Into, la liaison si fa artistica - oltre che logistica. Il
disco, che testimonia una volta di più sulla spiccata attitudine del giapponese alla collaborazione - ne avevamo
parlato in sede di articolo -, è il frutto di una collaborazione a distanza che ha però in un incontro vis-a-vis
(durante una tourneè italiana di Kazuyuki Kishino) le
proprie radici.
La musica qui contenuta, cosa abbastanza prevedibile, si
nutre di rumore, ma lo fa senza passare attraverso le
soluzioni massimaliste di certi lavori solisti del leader di
Zeni Geva. Piuttosto, è con i trucchi tipici dell'isolazionismo dark ambient che l'elemento primario di tutte le
composizioni - il noise - viene triturato (In), smaterializzato (Intramuscolo), centrifugata (Alone), sottoposta a
processi di denaturazione spazio-temporale con o senza
l'utilizzo di macchine del tempo (che sono qui computer).
E' proprio una fenomenologia dei processi di trasformazione della materia - e successiva riconversione di
energia - quella che, in fondo, si rivela più efficace per
66
descrivere un disco come Into: proprio perché come
materia - come organismo vivente sorpreso nel pieno
del proprio (micro)dinamismo - è inteso, dai suoi fautori,
il suono e il suo irradiarsi.(7/10)
Vincenzo Santarcangelo
Laura Marling - I Speak Because I
Can (Virgin, Marzo 2010)
G enere : folk cantautorale
Se l'esordio Alas, I Cannot Swim di due anni orsono
stupiva per la sagacia con cui l'allora diciottenne Laura
Marling maneggiava la materia folk rock, il qui presente
sophomore I Speak Because I Can rinnova il senso
di stupore incrementando l'intensità di scrittura e interpretazione. La ventenne inglese canta come se avesse
vissuto davvero ogni parola, si muove con impressionante disinvoltura nel solco tra alt-country e cantautorato.
Non si accontenta del compitino ma spinge a fondo la
lama affrontando temi a stretto rischio di retorica, vedi
la lettera dal fronte di What He Wrote (il dolore rannicchiato in una sobria litania, una solennità pietosa degna
di Sandy Denny) o la crisi coniugal/esistenziale della
title track (pervasa di fierezza e intima tenacia degne
d'un Mark Lanegan femminino).
Pur nella generale sobrietà, che non impedisce anzi è il
sostrato di episodi intensi quali Hope In The Air e Made By
Maid (laconici anelli di congiunzione tra il giovane Bob
Dylan e la più morbida Cat Power), spiccano interessanti deviazioni come le inquietudini balcaniche di Alpha
Swallows e le febbricole latine di Darkness Descends, mentre l'iniziale Devil's Spoke segna l'apice energetico con
una furibonda meditazione che non sarebbe spiaciuta a
Johnny Cash buonanima.
A questo punto dobbiamo crederci al di là della fenomenologia mediatica: Laura Marling è tra le più interessanti
cantautrici folk in circolazione.(7.3/10)
Stefano Solventi
Lazer Crystal - MCMLXXX (Thrill
Jockey, Maggio 2010)
G enere : E lettrock
Già nei compagni d'etichetta Future Island notavamo
il fascino per la stanza degli specchi che rifletteva crooning Bowie-iano da un lato e certo tastierato '70/'80
dall'altro. Qui s'aggiungono l'amore per le soundtrack di
Vangelis (via Fuck Buttons), tastiere Ultravox (Love
Rhombus) e qualche spruzzata new age, ma quella che si
ascolta è soprattutto una riverenza nei confronti degli
idoli personali Trans Am (Hot Pink Bmx), conditi magari
con qualche goccia cosmic disco (e in versione decisamente elettronica).
highlight
Woven Hand - The Threshingfloor (Glitterhouse, Maggio 2010)
G enere : american gothic
Capisci già da poche ma significative note che aria tira in questo sesto disco dei Wovenhand. Il fatto che
si torni a registrare nel Colorado - terra natale di Edwards - per allestire un nuovo capitolo di questo
grande romanzo (gotico) americano. Lo si fa, tuttavia, tenendo conto del precedente magnifico Ten Stones,
pur in assenza di Emil Nikolaisen, chitarrista dei neo-shoegazers Serena
Maneesh. La presenza anche in questi brani di una psichedelia modernista
(memore dei '60, eppure più vicina alle interpretazioni di Shiva Burlesque
e primi Echo & The Bunnymen) fa però intuire che un anno e mezzo fa
assistemmo a una scelta artistica consapevole.
Resta immutata l'intensità di quest'uomo, l'anteporre qualsiasi sovrastruttura
a un'urgenza incarnata nel profondo e portata, nel canto espressionista, al
massimo grado senza crollare: impresa non da tutti, se si pensa che Eugene è
in circolazione da quasi venti anni. Non importa, allora, la "forma sonora" assunta da questo sentire, poiché esso rimane profondo e robusto, che rivisiti
un folk inteso come respiro del mondo (Terre Haute guarda all'Europa; Raise Her Hands esorcizza spettri
nativi americani); che indaghi l'oscurità con cuore agitato (A Holy Measure) oppure romantico (Singing
Grass); che si misuri da maestro con la California di fine anni '80 (His Rest) e la Liverpool degli albori di
quel decennio (Behind Your Breath).
Tra violoncelli e corde per lo più acustiche, anime in transito e miti che trascolorano nel sogno, pare di
intuire quasi una versione seppiata dei Grant Lee Buffalo, là dove i Joy Division - parla chiaro l'immensa Truth - hanno preso il posto dei Mott The Hoople. Che addirittura, alla fine della confessione, fa
comparire con Denver City un raggio di sole attraverso del solido quanto inatteso country 'n' roll. Pochi
oggi sanno maneggiare l'America e la sua materialità come Mr. Edwads. Probabilmente nessuno.(7.5/10)
Giancarlo Turra
Stranamente di Chicago, e all'esordio, il trio potrebbe
rappresentare l'ennesima meteora, eppure una fissa particolare per il packaging, la cura dei light show dal vivo e
un appurato gusto kitch (da Carpenter ai Kraftwerk in
salsa videoludica, laserate, funk bianco, suono androide)
parrebbero portarli al livello successivo (da ascoltare soprattutto 2029). Staremo a vedere.(6.5/10)
Edoardo Bridda
Lcd Soundsystem - This Is
Happening (DFA, Maggio 2010)
G enere : D ance , post - punk
Quando sei troppo avanti, può darsi che alla prima indecisione siano tutti pronti a impallinarti. All'esordio James
Murphy mostrò - da perfetto figlio dell'epoca in cui vive
e opera - l'invidiabile capacità di approfondire un crossover totale tra generi ed epoche, restituendone un'idea
adatta agli anni zero senza nostalgia; col secondo disco,
ha schivato la fotocopia affidandosi a un gioco di citazioni stordente nel quale incarnava -mettendoci dell'inequivocabile suo - il Brian Eno pendolare tra Berlino e
New York. E tutto questo tenendosi stretti Daft Punk
e krautismi, mutant-disco e new wave senza dimenticare
quel che trovi nel mezzo, impreziosendo la ricetta con
acutezza d'arrangiamento e livello della scrittura elevatissimi.
Logico con tali premesse aspettarsi una quadratura del
cerchio in questo terzo lavoro: verso il quale ci siamo
invece accostati senza attese, per evitare di ascoltare
quello che non c'è. Trovandoci di fronte un'altra mimesi
e nondimeno con apici di tutto rispetto allorché collega territori distanti: accade in Dance Yrself Clean (David
Byrne a capo di Heaven 17), in One Touch (il Duca di
Lodger si concede una danza) e in Somebody's Calling Me
(sensazionale metafisica tra jazz ed elettronica, come i
Cabaret Voltaire a chiaccherare con i Can).
Il resto gioca di disinvolta accademia col già detto in una
pantomima al quadrato piacevole (Home: esuberante giostrina byrniana alla This Must Be The Place, una You Wanted A Hit ironico disco-rock che in altri sarebbe orrore
puro); altrove curiosa ma non risolutiva e più formulaica
del solito (i Cars dietro l'angolo in Drunk Girls; il techno67
pop "made in Sheffield" racchiuso in I Can Change). Al
suo peggio, gioco di prestigio dove si vede il trucco (All I
Want: l'ennesima revisione di "Heroes"; Pow Pow: debole,
prolissa funk-wave).
In definitiva, considerando che si partiva da altezze stellari, nulla che possa ridimensionare la statura di Murphy
in questa era. Prendetevela con lei, per l'eventuale insoddisfazione.(7/10)
Giancarlo Turra
Little Women - Throat (Aum
Fidelity, Aprile 2010)
G enere : free - jazz - core
Ha poco o nulla a che vedere con le bucoliche vicende
delle sorelle Alcott, questo quartetto di Brooklyn. Almeno a giudicare dal senso che muove questo esordio
suddiviso in 7 movimenti untitled: quello di raggiungere
la trascendenza tramite la brutalità dell'assalto sonico,
come recita la cartella stampa della label. E certo, perché armati di sax tenore (Travis Lappante) e sax alto
(Darius Jones) che si rincorrono forsennati e furibondi
con chitarra (Andrei Smiley) e batteria (Jason Nazary),
raggiungere la trascendenza è possibile solo a botte di
terrificanti mazzate free-jazz-core.
Alternando composizione e improvvisazione, mossa
da una continua predilezione per la dissonanza,
così come per una insana
passione ayleriana per la
frammentazione del corpo musicale, la musica del
quartetto è una continua
sfida a se stessa, un rincorrersi, prendersi, lasciarsi per
poi ricominciare con ancor
più foga che miglior titolo non poteva avere. Prende alla
gola, e sia nei momenti più scatenati (il movimento Throat I sembra Ayler alla guida dei Napalm Death, Throat
III le dissonanti improvvisazioni in crescendo degli Zu)
che in quelli più (ehm) riflessivi (Throat II è una ossianica
stasi per borbottii di sax), si ha sempre l'impressione di
un procedere musicale in degrado, sull'orlo della rottura,
marcio fin nel midollo. Quando si giunge alla chiosa, una
Throat VII acapella per grugniti e nonsense grind, la tensione si stempera in autoironia, ma l'impressione resta
sempre quella di una musica che difficilmente si accontenterà di fare prigionieri.(7.2/10)
Stefano Pifferi
68
Locrian - Territories (Basses
Frequences, Aprile 2010)
G enere : B l ack /D rone
Curato da ben quattro etichette provenienti da entrambe le sponde dell'Atlantico (At War With False Noise,
Basses Frequences, BloodLust!, Small Doses), esce finalmente Territories, secondo ellepì dei chicagoani Locrian
dopo Greyfield Shrines (del 2008).
Ed è un ritorno in grande stile con il drone-duo ad avvalersi della collaborazione di svariati ospiti d'estrazione
marcatamente estrema. Oltre al sodale Mark Solotroff
alla voce (Bloodyminded e titolare della label Blooddlust!), alla chitarra troviamo Blake Judd (Nachtmystium) e Andrew Scherer alla batteria (Velnias), oltre al sax di Bruce Lamont (Yakuza) nei pezzi Between
Barrows e The Columnless Arcade; ognuno ad apportare,
a seconda, blastbeats, funerei riffage e voci in sceaming,
fratture stilistiche al fluire Heavy Ambient del duo.
Il senso tragico che accomuna i musicisti, nonché la sua
resa attraverso immagini soniche (ben esplicitate da tracce come Inverted Ruins o Antediluvian Territory), sono i denominatori di un album che alla brutalità sonica affianca
precise suggestioni visive. Nel voler trovare un difetto, si
può argomentare che Territories non riesca a raggiungere
l'espressività stordente di Drenched Lands, la migliore
prova del duo; critica che può trovare facili spiegazioni
nell'inedita dimensione collaborativa con cui è stato realizzato il disco.(7/10)
Leonardo Amico
Lone Wolf - The Devil And I (Bella
Union, Maggio 2010)
G enere : F olk infernale
Lone Wolf. Con un nome di battaglia così ti aspetti chitarra acustica, voce e via di folk cantautorale sul solco
della tradizione rivisitata da un Bonnie Prince Billy
o un Bill Calllahan a caso. E This Is War parte proprio
così. Ma di partenza si tratta, perché Lone Wolf/Paul
Marshall il folk lo prende a calci, scaraventandolo all'inferno, infondendogli la febbricitante profana sacralità
della musicalità di Dave Eugene Edwards (Keep Your
Eyes On The Road e Buried Beneath The Tiles), lo accarezza
e lo riporta in paradiso grazie ad aperture melodiche
delicate e incisive.
Peccato e redenzione a braccetto, intimità acustiche e
arrangiamenti carichi di fiati e archi scopano in un confessionale edificato sulla barca di Caronte. Scott Matthew in preda alla perdizione We Could Use Your Blood e
le due parti della title-track, delicato anelito di melanconia 15 Letters, i Radiohead del dopo Ok Computer se
si fossero innamorati del folk pastorale e non della Warp,
Russian Winter e Dead River. E poi la grancassa risuona
in lontananza, come tuoni di un temporale in arrivo. Un
lupo ci squadra, ci regala uno sguardo compassionevole
e si dilegua.(7.2/10)
Giampaolo Cristofaro
Lonely Drifter Karen - Fall Of
Spring (Crammed Discs, Aprile
2010)
G enere : folk pop
Secondo lavoro per i Lonely Drifter Karen, trio formato dalla cantante austriaca Tanja Frinta, dal batterista
italiano Giorgio Menossi e dal tastierista e arrangiatore
spagnolo Marc Melìa Sobrevias. A due anni dall'esordio il piuttosto apprezzato Grass Is Singing - questo Fall
Of Spring ribadisce la vena pop con striature psych
madreperla e sofisticherie jazz tra il brioso ed il blasé.
Ne esce quindi un album capace di fresca suadente sbrigliatezza in bilico tra club, cabaret, salotto e camporella,
ma anche di miraggi e sfrigolii come una versione frugale
dei Mercury Rev (sentitevi Russian Bells) e strani palpiti
tribal-folk (A Roof Somewhere) che potrebbero irretire i
seguaci di Tori Amos o Joanna Newsom.
Il tutto valorizzato da arrangiamenti agili su una scrittura
a dire il vero più efficace che originale, interpretata da
Tanja con quel misto di tepore e distacco che a qualcuno
può sembrare classe e ad altri sensualità. Da sottolineare
la presenza di Emily Jane White, in duetto con Tanja
nel trepido incanto della conclusiva Seeds. Nel complesso la proposta è curiosa, ti stuzzica, ti blandisce e si ritrae
prima di averti chiarito quanto profonda è stata l'iniezione. Ma stai meglio, ed è questo che conta.(6.9/10)
Stefano Solventi
Madlib - Madlib Medicine Show #3:
Beat Konducta In Africa (Stones
Throw, Marzo 2010)
G enere : africanfunk / HH
Delude questo BK. Per il semplice motivo che Mad, avendo per le mani due topic bollenti e decisamente nelle
sue corde come il funk e l'Africa, poteva davvero buttare
fuori fuoco e fiamme. E invece le quarantatrè produzioni
(nell'edizione superdeluxe) sono piuttosto trattenute: il
colore che le identifica è opportunamente il marrone
sabbioso della copertina cd, non il nero seducente e tigrato dell'edizione in vinile.
African funk e variazioni, comunque, tante voci trovate,
ritmi trotterellanti e traballanti, tribalismi mai esplosivi
e mai esplosi, tracce piuttosto asciutte e lineari, in tendenza col viaggio in Etiopia del fratellino Oh No. I pezzi migliori sono quelli che sembrano virare la battuta
in senso dilliano-appiccicoso (Obataive, Chant 2, Kanika,
Umi). Niente di nuovo sotto il grande sole madlibiano.(6.4/10)
Gabriele Marino
Madlib - Madlib Medicine Show
#4: 420 Chalice All-Stars (Stones
Throw, Aprile 2010)
G enere : reggae & dub
Madlib riprende in tono minore la passione per i suoni
della Giamaica già espressa nei remix di vecchi pezzi di
casa Trojan pubblicati dall'Antidote nel 2002: Blunted
In The Bomb Shelter.
La selecta di questo mixtape è ottima, una valanga di
reggae e dub con picchi di marciume davvero notevoli,
ma restano tutti i limiti dell'operazione già messi in evidenza a proposito del volume dedicato al Brasile. Per
completisti.
Ps: il booklet contiene una guida dettagliata all'uso e al
consumo della "medicinal marijuana", con tanto di indirizzario dei negozi di L.A. che la vendono legalmente. Forse dovresti farti qualche spippacchiata in meno,
Mad.(6/10)
Gabriele Marino
Male Bonding - Nothing Hurts (Sub
Pop, Maggio 2010)
G enere : I ndie R ock , L o - fi
Il fatto è che uno invecchia e pensa di averle sentite tutte
(almeno dal punto di vista musicale) e quello che non ha
ancora sentito, in fondo, è solo a distanza di un click. Poi
arriva una band, che sarà una delle più hyped del momento, ma è comunque cosa che nasce dall'underground
più carbonaro, si propone come portavoce di un nuovo
modo di intendere il rapporto fra un artista e il proprio
pubblico e, insomma, dovrebbe essere ancora in grado
di far salivare come il cane di Pavlov anche l'indie snob
più elitario. Nonostante questo li avvicini con la corazza
di scetticismo temprata da tanti anni di promesse mancate e succede che questa, al primo ascolto, si sbriciola
come un cracker, di fronte all'urgenza di tre giovani londinesi, che non saranno certo rivoluzionari, ma in ambito
strettamente rock sono la
cosa più fresca e svincolata dai cliché che si possa
ascoltare a questo punto
del 2010.
A proposito di cliché: il primo che viene sovvertito è
quello geografico. I Male
Bonding sono inglesi ma
69
suonano come un incrocio fra i Nirvana e qualche punk
band evoluta di metà anni 80, diciamo i Meat Puppets
più funambolici, se avessero gli strumenti che stanno andando a fuoco.
Poi c'è la melodia: aperta, solare, liberatoria. Nascosta
sotto chili di lerciume lo-fi. Britannica come il pudding
e il tè delle cinque. Ma c'è molto di più: c'è lo shoegaze
più dreamy che si scontra con le trame sbilenche dei
Trumans Water, c'è il noise più caotico che si coagula
in rigide ritmiche post hardcore.
C'è anche un brano acustico, Worst To Come, posto in
chiusura dell'album, che dimostra come i tre ragazzotti
non si limitino ad assembrare riff, ma scrivano innanzitutto canzoni. Grandi canzoni, per l'esattezza. Nothing
Hurts ne contiene 13 per un totale di trenta minuti di
eccitazione messa in musica, nessuno dei quali superfluo.
Insomma, per una volta, believe the hype!(7.5/10)
Diego Ballani
Mallory Switch - Mallory (Gb
Sound, Aprile 2010)
G enere : G arbage wannabe
Il potenziale di base sembrava fecondo e in crescendo,
eppure per Mallory Switch l'occasione è di quelle mancate. Troppo altalenanti le sorti dell'album, e un poco
tortuose le declinazioni rock in tono industrial light,
electroclash o in frigidità teutoniche.
In breve, il "rock elettromeccanico per orecchie e menti
inquiete" del combo pare un It's Blitz degli Yeah Yeah
Yeahs riuscito a metà o uno scimmiottare certi Garbage fuori tempo massimo.(5/10)
Giampaolo Cristofaro
Maurizio Bianchi/Cris X Heczplaser/ Black pulse (CX
Records, Marzo 2010)
G enere : free noise
Secondo e, a quanto pare, definitivo ritiro dalle scene di
M.B.. Per salutare gli appassionati delle sue de-composizioni si è scelta la formula dello split album su vinile,
simbolico passaggio di testimone con la nuova leva Cris
X (alias Cristiano Luciani), artista romano talentuoso
e oscuro quanto basta per proseguire il cammino già
tracciato.
Il lato M.B. concede al solito una manciata di brani inzuppati nell'ansia di un mondo disumanizzato, utilizzando
le coordinate di rarefazione e dissonanza con gusto e
mestiere.
Dal canto suo Cris X fa sfoggio di uno stile più elaborato,
frutto di una ricerca sulle possibilità della deflagrazione
70
post-industrial dal volto contemporaneo, pur sprofondando qua e là nell'evocazione di atmosfere oniriche e
dunque immemori di alcuna collocazione temporale (si
ascoltino i due movimenti di Night). Se Twilight propone
un collage di fobie 'concrete' è la conclusiva (o magari, meglio, la 'terminale') Toby Dammit che, evocando lo
spettro di Edgar Allan Poe, si carica di quelle suggestioni culturali capaci di rendere apprezzabili anche poetiche tanto estenuanti.
E' questo il primo passo della neonata etichetta CX Records, che si prefigura interessante realtà dedita a quegli
incubi post-ambient che in molti stanno dimostrando di
apprezzare.(7/10)
Filippo Bordignon
Maximilian Hecker - I Am Nothing
But Emotion, No Human Being,
No Son, Never Again Son (Blue
Soldier, Maggio 2010)
G enere : D ream , pop
Due anni fa il già svenevole incanta-adolescenti Maximilian Hecker, autore di album stucchevoli come I'll
Be A Virgin, I'll Be A Mountain, era entrato in crisi.
"Avevo raggiunto un punto in cui non ero più in grado di
trovare soddisfazione alcuna in quello che facevo... ...mi ero
costretto al perfezionismo e alle convenzioni e in questa fase
traumatica e catartica è entrata a far parte anche Nana,
una ragazza di Tokyo che mi ha portato a una modalità di
decomosizione.. Ho iniziato a vestirmi in tutta e non tagliarmi più la barba" ecc. ecc. In pratica, il bel Hecker si è
spogliato d'ogni arrangiamento e ha iniziato ad incidere
seduto al piano una serie di break up song catturate da
un solo microfono che ne costituiscono il personale Sea
Change.
Max non è Beck bensì un onesto Michael Bolton dei
ghiacci, un cantautore essenziale per il quale la ripetizione del binomio "Don't leave me / come home" è l'unico
moloch possibile.(4.5/10)
Edoardo Bridda
Medications - Completely Removed
(Dischord, Aprile 2010)
G enere : pop - math - rock
Medications è la nuova incarnazione scelta da Devin
Ocampo e Chad Molter quando la loro precedente band
Faraquet (qualche ep e un album per DeSoto e Dischord per una onesta carriera math-core tra '90 e '00)
passò a miglior vita. Ora i due, in combutta con l'ospite
Mark Cisneros, se ne escono col nuovo album: più morbido, melodico e vario del precedente Your Favorite
People All In One Place (Dischord, 2005).
In Completely Removed
troverete intrighi e procedere math-rock al servizio
di sensibilità pop a tutto
tondo, in grado di tirare in
ballo Minutemen e King
Crimson, Fugazi e Tom
Petty, country-indie-rock
alla maniera di Meat Puppets e reminiscenze strokesiane (Seasons). Tutto condensato in miniature classic-rock
da 2 o 3 minuti mai banali, energiche, solari e ricercate.
In alcuni casi sembra addirittura rivivere l'intrigo progpop dei bei tempi andati in mini-suite da pochi minuti,
alla maniera di Wyatt per capirsi (Kilometers And Smiles,
Rising To Sleep), altrove un pop bucolico, trasognante e
swingato memore di rimandi radioheadiani (Brasil '07)
o ancora, melodicamente intersecato alla Animal Collective (Country Air) ma virato ancor più sul pop. Disco
di gran classe e godibilissimo in ascolti ripetuti, anche se
nulla aggiunge alla storia del rock.(6.8/10)
Stefano Pifferi
Melissa Auf Der Maur - Out OF
Our Minds (Roadrunner Records,
Marzo 2010)
G enere : post grunge
Il secondo album solista di Melissa Auf der Maur è di
quelli che fanno parlare di sé. Per almeno tre motivi. Il
primo è che, a giudicare dalle immagini più recenti, la
trentottenne canadese è ancora un bel pezzo di figliola che non fa nulla per nasconderlo, e sappiamo bene
quanto certi argomenti possano essere penetranti e
trasversali. Poi c'è la quasi contemporaneità con l'uscita
del nuovo Hole, col comprensibile rammarico e le polemicuzze da parte della nostra bassista rossocrinita che
pensava di avere voce in capitolo nelle vicende della exband, ma la cara Courtney Love non è tipa da perdersi
in certe sottigliezze. Infine, c'è che a sei anni di distanza
dall'omonimo esordio Melissa ha deciso di fare le cose
in grande, ovvero nel segno della multimedialità: Out
Of Our Minds è infatti disco, fumetto, film e persino
allestimento di manufatti artistici ad esso ispirati.
Uno sforzo concettuale che francamente sorprende, per
il quale la Auf der Maur si è spesa in primissima persona, componendo tutte le dodici tracce nell'ottica di un
disegno più vasto che appiccica in calce a questo disco
la meritata etichetta di concept album. Ecco, appunto,
venendo alla musica: siamo di fronte ad un dispositivo
ingegneristico di buon livello, alesato wave e post-grunge
tecnologico, sbilanciato verso atmosfere cupe ma sorretto da un estro melodico piuttosto abbordabile e da
una definizione sonora che farà sobbalzare d'eccitazione i vostri altoparlanti. Tuttavia, cosa possono farci, cosa
possono darci queste canzoni? Melissa è una cantante
modesta, pressoché incapace d'interpretazione (ciò che
è reso ancora più evidente dall'imbarazzante duetto con
Glenn Danzig in Father's Grave). Come autrice, propone una calligrafia efficace ma inadatta ad esprimere
mezzi toni e sfumature.
Insomma: siamo nel fumettistico, nel senso più deleterio
del termine. Siamo sulla corsia più grossolana del mainstream alternativo, quello che ci va matta MTV e i cacciatori di soundtrack per videogames. Melissa è il marchio
sul congegno. Un bel marchio, come dicevamo.(5.5/10)
Stefano Solventi
Mi Ami - Steal Your Face (Thrill
Jockey, Aprile 2010)
G enere : post - punk - funk
Dopo l'ottimo Watersports e il mini Cut Men, è Steal Your Face, di nuovo sulla prestigiosa Thrill Jockey,
a segnare il ritorno lungo dei Mi Ami. Ed è un ritorno,
è bene dirlo subito, che estremizza se possibile la già
ostica proposta portata avanti da quando Daniel MartinMcCormick (chitarra, voce), Jacob Long (basso) e Damon Palermo (batteria) risorsero dalle ceneri dei Black
Eyes. Spigolosi e ruvidi, post-punk al midollo nel piegare
il funk alla paranoia bianca e suburbana tipica dei punk, i
tre sono ormai maestri riconosciuti e maturi nell'aprire
ad un immaginario sfaccettato, trasfigurato e sempre disturbante come l'eloquente immagine di copertina.
È sempre un suono nervoso e teso, quello dei Mi Ami. Sul
filo del rasoio, perennemente in tensione tra immaginario e reminiscenze black (il dub, il tribalismo, l'afro-beat)
e prassi bianca (la deframmentazione etimologicamente punk della sintassi rock), la musica dei californiani è
world music nella sua accezione più ampia e totalizzante
possibile. L'unica concepibile oggigiorno, dopotutto. Isterico e schizzato (l'opener Harmonics (Genius Of Love)),
acido e ossessionante (una Dreamers PILianamente da
incubo), percussivo e incontrollabile (Secrets), furibondo e corrosivo (la chitarra in overdrive che guida Native
American (Born In The USA)), il suono ha ormai raggiunto una invidiabile maturità sia compositiva (rimasticare
il post-punk di fine 70s senza sembrarne epigoni fuori
tempo massimo) che a livello di resa d'insieme (volutamente pastosa e a grana grossa quanto onnivoro e
massimalista è il background della band). Su tutto, però,
la voce di Martin-McCormick; uno stiletto che si erge
abrasivo sul suono nevrotico dei compagni di sventura
e si propone come una sorta di confessione in divenire,
seduta psichiatrica a cuore aperto e che segna, per forza
71
di cose, il portato musicale dei tre.
Steal Your Face non è solo una grande conferma, ma la testimonianza della grandezza di una band che nello spazio
di un paio d'anni si è ritagliata un posto di prim'ordine
nel panorama musicale odierno.(7.5/10)
e intanto covava un proprio immaginario, cui non a caso
ancora oggi qualcuno guarda con passione.
Ok, certo, potrebbe essere questo. O forse un po' entrambe le cose. Disco in ogni caso curioso, talora affascinante, a tratti formidabile.(7.2/10)
Stefano Pifferi
Stefano Solventi
Mike Patton - Mondo cane (Ipecac
Recordings, Maggio 2010)
G enere : pop nostalghia
Mother-Unit - Brain-Message
(Stickman Records, Marzo 2010)
G enere : P ost -K yus s
Una serie di concerti europei a cavallo tra 2007 e 2008
dedicati alla canzone italiana degli anni Cinquanta e Sessanta. Successo strepitoso per Mike Patton, Roy Paci,
Alessandro Stefana e l'orchestra Arturo Toscanini. Quindi, finalmente, dalle registrazioni di quegli spettacoli - ripulite e rimasterizzate per conferire loro aspetto "da
studio" - esce questo Mondo Cane. Diciamolo subito:
nulla o pochissimo a che vedere col documentario cult
dei sixties nostrani. In programma ci sono undici pezzi
facili, una selezione forse ristretta rispetto alle scalette
dei concerti, ma chissà che non sia una scelta calcolata in
previsione di un secondo volume...
Comunque, cos'è 'sta roba? Come giudicare il buon Patton versione crooner alle prese con pezzi interpretati
a suo tempo da Nico Fidenco, da Gino Paoli, da
Luigi Tenco, da Mina, da
Roberto Murolo, da Nicola Arigliano? Mi sono
fatto due idee. La prima è
che si tratti di un semplice,
appassionato
divertissement. In questo caso, bravo
Mike, pronuncia di tutto rispetto e ottime interpretazioni, belli gli arrangiamenti, validissimi i comprimari (Roy
Paci spesso mattatore), apprezzabile la cura dei dettagli come a ricostruire filologicamente la pasta sonora
dell'epoca. Ok, certo, potrebbe essere così. Oppure no.
Oppure si tratta di qualcos'altro e di più: guardare a
quell'Italia figlia del boom economico come ad un modello di brio avventato e naif, i piedi in molte (troppe)
staffe ma quanta grazia santantonio! La tradizione e i primi vagiti psichedelici, il bel canto ed i languori dei chansonnier, l'urlo della black music e le avvisaglie lounge.
Negli universi culturali e poetici che separano Scalinatella
da Deep Down, Che notte! da Senza fine o Il cielo in una
stanza da Urlo negro, aleggerebbe quindi un approccio
perduto, perché genuino e feroce, generoso e sbruffone,
teatrale e allusivo, capace di mettere in gioco sentimenti
e magagne, mancanze e desideri senza troppa vaselina
culturale. Era un'Italia che scimmiottava con intelligenza
I Mother-Unit sono l'attuale creatura di Bertus Fridael,
che i più ricorderanno come chitarrista dei 35007, seminale formazione stoner/psichedelica olandese a cavallo tra la metà degli anni Novanta fino a tutta la decade
successiva. Dopo alcuni anni di silenzio, Fridael si affianca
a Mark van der Heijden dei trascurabili The Rose Frustrates (e i novizi Hans van de Perre e Jelle Saris) per
comporre quattro lunghi brani filo Kyuss.
Non è math-rock (manca l'uso diacronico del fraseggio),
non è post-rock (gli orpelli o gadgets elettronici sono
solo utilizzati come climax introduttivo e non come
zone strutturate) ma c'è qualcosa di progressive-stonerrock nel susseguirsi dei riff secchi e precisi di una chitarra ingombrante che non lascia alcuno spazio ai suoi
comprimari. Suona piattissimo l'uso degli arrangiamenti:
ogni brano ha i suoi synth-ambientali introduttivi, poi
i crescendo di batteria fino al riff chitarristico con le
sue scale veloci per finire nel medesimo modo in cui
è partito. Ma i tempi sono cambiati e soluzioni come
queste risultavano già esaurite al tempo dei 35007, dove
almeno c'era afflato ed un gruppo degno di chiamarsi
tale.(4.9/10)
72
Salvatore Borrelli
Mumford And Sons - Sigh No More
(Island, Ottobre 2009)
G enere : folk
Le radici sono una costante per ognuno, a prescindere
dalla geografia pop. Americani o sudditi di Elisabetta, prima o poi devono essere affrontate quando non rappresentano la fonte primaria cui abbeverarsi. Come, tanto
per non far nomi, The Man They Couldn't Hang un
quarto di secolo fa e i pionieri Fairport Convention
eoni prima, il quartetto guidato da Marcus Mumford
raccoglie un passato folk per donargli piglio rock e
spruzzarlo di un'epidermicità raffinata che regalerà loro
meritate soddisfazioni economiche. In circolazione dal
2007, i ragazzi posseggono infatti facce e look giusti, sanno porsi romantici (Timshel, White Blank Page), anthemici
(The Cave, Little Lion Man) o tutt'e due le cose insieme
(Dust Bowl Dance, Awake My Soul) eludendo la banalità.
Logico dunque che due e.p. e l'apparizione a Glastonbury
abbiano assicurato l'interesse della Island e la produzione di Markus Drays (già dentro il "grande suono" degli
Arcade Fire; con una coralità più misurata resta abile
e scrupoloso: sentire per credere l'impatto strumentale
e la pienezza dei crescendo
). Ma la sostanza? Non manca e - senza inscenare impossibili rivoluzioni - persuade
fino alla promozione, perché suonare questo materiale
con mezzi espressivi adeguati conduce fuori dal tempo
e dalle mode.
Così che Sigh No More potrebbe recare sulla costina
1985 o 1968: l'unica differenza il fatto che, fosse mosso
da una militanza più spiccata e potesse ancora indicare
nuove vie, si chiamerebbe How Green Is The Valley o Liege And Lief. Quello era li passato, però, mentre l'adesso
colloca i Nostri tra Laura Marling e Noah And The
Whale. Incamminati su una via intermedia che piace a
se stessi e a noi.(7/10)
Giancarlo Turra
National (The) - High Violet (4AD,
Maggio 2010)
G enere : rock
Se ne parla da un po' del nuovo disco di questi ragazzi di
Brooklyn, gente che in poco più di un lustro, scusate se
è poco, è diventata un piccolo classico. Con questa consapevolezza le session sono partite da almeno due anni,
da quando cioé sulla mailing list comparivano le prime
anticipazioni. Le prove su strada hanno successivamente
confermato la tenuta delle canzoni il cui ultimo parto è
stato Bloodbuzz Ohio, offerta in free download sul sito,
prova di un rock 100% adult e nel contempo ben sedimentato nel post-indie.
La nuova fatica della band di Matt Berninger si riporta sulle linee dell'alligatore e del boxeur che conosciamo
bene. Non sorprende con
gli hook che ci avevano
stretto il cuore qualche
anno fa, eppure suona, similarmente agli ultimi Wilco,
come una bella bottiglia di
vino invecchiata: la voce baritonale a ricordare i Cousteau, le chitarre big apple
degli Interpol (Little Faith), il savoir faire dark dal sapore
Joy Division e quella sapiente arte del crescendo costruita usando le percussioni di Bryan Devendorf e la ripetizione mantrica di brevi versi. La pallida viola malinconica
è inevitabilmente sprovvista di quel mistero (e freschezza) che aleggiava nei capolavori Fake Empire o Mistaken for
Strangers, ma è comunque dotata di episodi sopra la media
come l'opening epifanico Terrible Love, la cupa Sorrow, o la
ballad acustica da fine concerto (Runaway).
La catarsi pop non può avvenire senza anestesia. Il disco conferma come dal garage al successo il passaggio
non sia mai indolore: è uno spoiler album che conferma
la buona penna degli arrangiamenti definendo un suono
mainstream per la nuova borghesia democratica americana (per la quale la band ha suonato tante volte alle passate elezioni). Malinconici e un po' bohemien, i National
raccontano al meglio lo zeitgeist USA 2010.(6.9/10)
Marco Braggion
Nina Nastasia - Outlaster (Fat Cat,
Giugno 2010)
G enere : folk cameristico
Arriva a quota sei titoli Nina Nastasia, proseguendo nel
solco di un folk da camera fiero e meditabondo, ormai
maturo al punto da lavorare per semplificazione nonché
capace di sottili sorprendenti deviazioni. Alle consuete
presenze di Steve Albini alla produzione e del batterista
Jay Bellerose, cui va sommato il piccolo aiuto del compagno di vita Kennan Gudjonsson in fase di orchestrazione,
registriamo con piacere la presenza del Tortoise Jeff
Parker (ovviamente chitarra) e del polistrumentista Paul
Bryan (già all'opera per Aimee Mann e Grant Lee
Phillips tra gli altri) che ha arrangiato i pezzi per piccola
orchestra (sezione fiati e archi).
Ne esce un album, questo Outlaster, che azzarda l'ennesima declinazione folk radicata in una tradizione così
lontana così vicina, così presente e viva oserei dire per
quelle movenze che riarticolano forme ben note anzi
stranote in un appassionato progetto di schiva postmodernità. Tra suggestioni medievali (You're A Holy Man),
sorprese tango (l'impagabile This Familiar Way) e strani
intrugli tra vaudeville e cinematico (Moves Away), Nina
mette in mostra la consueta abilità, interpretando come
se melodia e parole fossero state colte di soppiatto tra
cuore e pensiero, in una sorta di confessione armata, di
struggimento autoesorcizzante. Il suo obiettivo sembra
essere una leggerezza apprensiva, una franca inquietudine, una tensione liberatoria capaci di consolarti nel momento stesso in cui ti mettono in guardia.
E' notevole come la malinconia à la Nick Cave di Wakes cresca fino a farsi accalorata invocazione, come la
semplicità spaesata di Cry, Cry, Baby riesca a propinarti
indolente mestizia, come la title track ti conduca attraverso chincaglierie e bruma in una landa eterea quasi
Talk Talk. Probabilmente on è il suo disco migliore, anzi
di sicuro non lo è, ma Nina Nastasia sembra aver ben
capito cosa fare da grande. (7.1/10)
Stefano Solventi
73
Olan Mill - Pine (Serein, Aprile
2010)
G enere : ambient
Nata inizialmente come netlabel, la gallese Serein si è
ora del tutto evoluta in etichetta a tutti gli effetti e dopo
il disco di Nest, dedica ora la sua seconda pubblicazione
al debutto degli Olan Mill, duo neo ambient costituito
da Alex Smalley e Svitlana Samoylenko. Siamo nel terreno
più impalpabile ed etereo della moderna ambient music,
di quella che si fa contaminare sovente e con passione da
inserti neoclassici. Pine è quindi un disco tanto austero
quanto fragile, dove il tono generale dato dai mantelli di
organo e chitarra serve ad innalzare le note sostenute
di piano e violino, in un modo che si potrebbe definire
come liturgico, tanto più che il disco è stato registrato
dentro una piccola chiesa.
Siamo evidentemente in un territorio che sta tra gli Stars
Of The Lid meno densi e i Celer più romantici e per
gli estimatori di entrambi,
Olan Mill aggiunge un ulteriore capitolo di estasi languida, con un gusto anche
parecchio pronunciato per
la melodia malinconica. Un
po' più di varietà e dinamismo non avrebbero guastato, ma non si può chiedere
molto di più ad un disco che si cala così integralmente
nel genere che si è scelto, da apparire anche troppo severo.(6.4/10)
Antonello Comunale
in genere ("un mucchio di sciocchezze, che favoriscono l'alienazione dei più giovani"). Musicalmente il tutto si traduce
in un vortice fatto di chitarre sporche e rumorose, psichedelia a pioggia e un senso di claustrofobia e rabbia
diffusa e palpabile.
Nonostante le tentazioni, Weller non corre il rischio di
fare il verso al se stesso del passato, come poteva essere
probabile, tutto infatti in Wake Up The Nation si tiene bene e il discorso è coerente.(7/10)
Teresa Greco
Plan B - The Defamation of
Strickland Banks (679, Aprile
2010)
G enere : brit soul musical
Secondo album per il rapper e soul singer londinese Ben
Drew aka Plan B, colonna sonora dell'omonimo film da
lui diretto e interpretato.Trama originalissima: Strickland
Banks è un cantante soul che conquista il mondo con
canzoni d'amore agrodolci; accusato di un crimine che
non ha commesso, viene sbattuto in cella e perde tutto.
Melodicità pop pastosa e confortevole (e ruffiana), ben
confezionata; vocalità soul dai toni acuti, alla lunga un po'
stancante; a piccole dosi, però, piglio fresco che aggiorna
la tradizione con qualcosina del nostro Mayer Hawthorne e qualcos'altro (gli arrangiamenti di ottoni?; She
Said) di Amy Winehouse. Quel poco di rappato che
si sente non esalta. Belli gli archi kitsch epico/classici di
Recluse. Ben fatto, miscela sostanzialmente piacevole, ma
non irresistibile.(6/10)
Gabriele Marino
Paul Weller - Wake Up The Nation
(Island, Aprile 2010)
G enere : brit rock
Radar Bros - Illustrated Garden
(Merge, Aprile 2010)
G enere : C ountry folk pop
Con l'aiuto del bassista Bruce Foxton degli storici Jam,
Paul Weller ritorna con Wake Up The Nation, che
vede anche altri ospiti quali Kevin Shields (My Bloody
Valentine), Bev Bevan (E.L.O., The Move), Clem Cattini
(The Tornados) e Barry Cadogan (Little Barrie). Il momento è buono per il musicista inglese, che prosegue
sulla scia dell'ultimo fortunato 22 Dreams, un punto
fermo della discografia degli ultimi anni e un concentrato
del suo songwriting.
Ora la solita miscela di pop, rock, folk e soul di ascendenza sixties e seventies si arricchisce di una vis polemica
rinnovata che lo riporta abbastanza indietro nel tempo. Un'occasione per parlare della contemporaneità e
dell'Inghilterra di oggi, e si sa che Paul non è tenero con
nessuno, si vedano le recenti dichiarazioni rilasciate a
The Indipendent su myspace, facebook e social network
Cambiati due membri della band - Be Hussey al basso e
Stevie Treichel alla batteria - e messa la ragione sociale
per esteso (Radar Brothers), è tempo di piccoli aggiustamenti nella quasi ventennale formula gentle psych
targata Jim Putnam. E questa volta il cambiamento è
di prospettiva: non una nuova scalata a passo d'uomo di
quella montagna floydiana chiamata Green Is The Colour,
piuttosto una tenda alle pendici della roccia a cantarci
dentro. Magari attorno al proverbiale focolare. Ne escono canzoni più concise, voglia di raccontare il
quotidiano e una disinvoltura che testimonia la voglia di
un abitacolo sonico con più comparti agili e confortevoli.
E' il passo giusto verso la classicità. Umiltà e piedi saldi a
terra.(7.1/10)
74
Edoardo Bridda
Ratafiamm - Me Te O ep
(Autoprodotto, Marzo 2010)
G enere : folk - rock
Era la fine del 2006 quando mi ritrovai per caso tra le
mani l'ep dei Ratafiamm, già allora vincitori del Premio
Ciampi per un semisconosciuto esordio sulla lunga distanza datato 2005. Poi dai cinque livornesi più nessuna
notizia, a parte qualche concerto e una serie di recensioni giustamente positive per un dischetto che dettava una
via altra alla leggerezza pensosa dei Perturbazione e al
rock intellettuale dei Virginiana Miller concentrando
insieme entrambe le cose in convincenti soluzioni folkrock.
Ora eccoli ritornare con un altro ep, completamente autoprodotto e autopromosso (si trova in download gratuito sul loro blog) e non privo di qualche sostanziosa
novità. In primis la riduzione della line-up a due elementi
(Enrico Cibelli e Andrea de Nittis); poi una decisa virata verso il folk, che in questo Me Te O fa da canovaccio a cinque episodi senza la stessa rotondità vigorosa
e contagiante della prova
precedente ma esaustivi
in quando ad eccellenza di
scrittura. Siamo dalle parti
dei vari José Gonzáles o
Devendra Banhart rivisti in chiave pop, ma non
si fatica a scorgere anche
l'eredità dei National qualora s'impuntassero improvvisamente su un fingerpicking
innervato da improvvise esplosioni elettriche tipicamente anni novanta (Imparare, Per dove). Ovviamente nulla
di nuovo, tuttavia i Ratafiamm sanno risolvere il tutto
grazie a liriche che cercano nuovi linguaggi guardando al
nostro cantautorato più tradizionale e trovano momenti
di buona intensità (Precari). Un secondo lavoro lungo ora
è proprio quello che ci vuole. Che qualcuno li supporti.(6.9/10)
Luca Barachetti
Record's (The) - De Fauna Et Flora
(Foolica, Marzo 2010)
G enere : rock
Dei The Record's parlammo in tempi non sospetti, quando il motto della band era Money's On Fire e il veicolo
scelto per promuoverlo aveva l'aspetto di un'autoproduzione tiratissima a cui aveva dato forma anche il bravo
Giovanni Ferrario. Allora si scomodarono concetti
come "eclettismo", "ricercatezza nella stesura", "consapevolezza" per descrivere l'approccio "totale" della compagine bresciana nel ridefinire i confini di un rock volubi-
le e multidisciplinare. De Fauna Et Flora non tradisce
la fiducia accordata al trio, vagheggiando un futuro roseo
in bilico tra T.Rex (On Our Minds) e certo etno-cool
à la Vampire Weekend (Call Of The Ice), Supergrass
e mid-tempo Fifties (Rodolfo), cadenze The Fratellis (I
Love My Family) e pop irresistibile (We All Need To Be Alone). Un nomadismo creativo che, se possibile, complica
ulteriormente il quadro clinico rispetto al passato, togliendo spazio a quel chitarrismo rugginoso e giovanile
da esordio in favore di una fluidità stilistica decisamente
contaminata.
Al mixer e al mastering troviamo rispettivamente Matteo Cantaluppi (Bugo, Canadians, Le Luci Della Centrale Elettrica) e Jon Astley (The Who, Rolling Stones,
Stereophonics, Peter Gabriel), tanto per dire che non si
tratta dell'ennesimo lucky strike. Per una produzione che
ricorda a chi fosse ancora convinto del contrario che il
rock italiano è vitale e respira a pieni polmoni.(7.4/10)
Fabrizio Zampighi
Riccardo Tesi/Maurizio Geri Sopra i tetti di Firenze - Omaggio a
Caterina Bueno (Materiali Sonori,
Marzo 2010)
G enere : folk italiano
Caterina Bueno è stata, insieme a Giovanna Marini, una delle più importanti ricercatrici e cantanti della
tradizione popolare italiana. E' grazie alla sua opera di
registrazione sul campo di canti popolari della Toscana
e di tutto il Centro Italia che oggi possiamo ascoltare
un repertorio che fa da spina dorsale ad un bel pezzo di
storia del nostro Paese e, fra i tanti, anche questo disco
di Riccardo Tesi e Maurizio Geri. I quali omaggiano
proprio la loro maestra - fu lei ad avviarli negli anni settanta alla musica vissuta come professione e "missione"
- con un doppio cd che ne riassume l'opera in compagnia di una squadra di ospiti toscani e non solo piuttosto
di rilievo (Piero Pelù, Daniele Sepe, Carlo Monni,
Nada, David Riondino e Gianna Nannini).
Viste le premesse, e tenendo presente chi siano per la
musica popolare italiana Geri e soprattutto Tesi, ci sarebbe da gridare all'evento, perché Sopra i tetti di Firenze - Omaggio a Caterina Bueno, oltre ad essere
una specie di ritorno a casa (in particolare per Geri, che
negli anni si è spostato in altri territori seppur attigui:
dalla canzone d'autore al manouche), ci consegna una
rilettura della musica di Caterina Bueno tirata a lucido e
a dir poco riuscita. I due infatti riarrangiano diciannove
tracce in tutto (ma alcune sono divise a loro volta in
varie sottotracce) insieme al gruppo di musicisti che accompagna Tesi nei suoi progetti più recenti con l'aggiunta
75
della splendida voce di Lucilla Galeazzi, che della nuova generazione di musicisti folk-world italiani è sicuramente una delle maggiori interpreti. Il tutto viene così
pervaso da aromi appenninici, mediterranei, in generale
eleganti ma al contempo veraci, con qualche convincente
azzardo qua e là (una versione di Battan l'otto fatta solo
con percussioni e voce) e l'apporto prezioso di alcuni
degli ospiti (si ascolti a tal proposito 500 catenelle d'oro
cantata da Nada: un po' come se Marianne Faithfull
rifacesse Woody Guthrie).
In chiusura poi non manca Caterina, la canzone che Francesco De Gregori dedicò proprio alla Bueno e inserì
in Titanic. Sorta di sigillo autoriale a un'operazione di
recupero e memoria che riesce a rivitalizzare il passato.
O in altre parole trasforma le radici in rami.(7.6/10)
con queste quattordici tracce rese disponibili gratis sul
web.
Si tratta di asciutte rendition suonate di alcuni beat di
Dilla e di produzioni realizzate ad hoc dai Roots e ispirate al suo suono. Domina la batteria di Quest, che mima
il tipico incedere wonky ante-litteram dilliano, ma è inevitabile avvertire come un "vuoto produttivo" (effetto
questo forse ricercato a bella posta). L'idea di partenza
era certamente interessante, ma il tutto appare francamente un po' troppo frettoloso.
Corto circuito: la più probabile - e fruttifera - destinazione per questo disco è essere sezionato e tagliuzzato
dal/al campionatore da qualche giovane beat-nerd, rientrando così dall'altra parte nella "catena alimentare" delle
produzioni hip hop.(6.2/10)
Luca Barachetti
Gabriele Marino
Robedoor - Burners (Important
Records, Marzo 2010)
G enere : D rone R ock
Roska - Rinse Presents Roska
(Rinse, Aprile 2010)
G enere : UK F unky S tep
Nuovo capitolo nella sconfinata epopea Robedoor con
cui prosegue il ripensamento del sound già stigmatizzato
nel precedete Raiders. Il duo di LA nelle ultime uscite ha
infatti affiancato ai droni color pece degli esordi una sezione ritmica tanto minimale quanto dannatamente greve che conferisce ai brani un'estrema aura down-tempo;
un doom metal ultra distorto e catacombale che ha negli
svedesi Ättestupa gli unici degni rivali.
Queste dunque le coordinate lungo cui si muove
Burners e le tre lunghe cavalcate che lo compongono: riff blues saturi all'inverosimile sommessi lamenti
in odore di salmo, picchi
di orgiastica confusione strumentale. Data la natura volutamente free della proposta è difficile azzardare una
classifica delle varie release, ma l'entrata in squadra del
batterista Grengras aggiunge una marcia in più a quello
che è forse l'ultimo erede del suono più estremo dei
Duemila, portandolo ad un nuovo livello di incisività e di
estatico scompiglio. Ascoltare per credere.(7.2/10)
Uno dei dischi più attesi nel panorama UK bass di questo 2010 un po' asfittico per gli straight edgers dubstep.
Roska è l'anello di congiunzione tra house e dubstep, il
DJ che potrebbe traghettare le masse sul pianeta oscuro
del ritmo westlondinese.
Le 10 tracce che abbiamo sotto le orecchie da un po' di
giorni a questa parte riassumono la deriva tribal (Squark)
e la rudeness garage che la crew Rinse ha nelle vene da
tempo. Ai già conosciuti singoli Love 2 Nite e Wonderful
Day si aggiungono delle instrumental tracks che alla lunga stancano per il minutaggio troppo esteso, invitando
l'ascoltatore occasionale allo skip. Le note positive escono invece dai buoni vocals/featuring di Anesha (I Need
Love), Jamie George e Nikki (Energy). Il risultato soddisfa a metà, dato che le possibilità del
ragazzo sono note sia dal punto di vista produttivo che
compositivo. Il passaggio sul dancefloor del dubstep è
probabilmente ancora troppo prematuro e Roska sarà
uno dei precursori, ma per sfondare aspettiamo il prossimo full-lenght.
(6.4/10)
Andrea Napoli
Roots (The)/Questlove - Dilla
Joints (Sel Released, Aprile 2010)
G enere : hip hop
Il cuore pulsante dei Roots, il batterista e produttore
Questlove, amico di J Dilla fin dai tempi della militanza
comune nel collettivo Soulquarians, gli rende omaggio
76
Marco Braggion
Rufus Wainwright - All Days Are
Nights: Songs For Lulu (DECCA,
Aprile 2010)
G enere : pop rock da camera
"My mother is in hospital / my sister is at the opera / I'm
in love but let's not talk about it / there's so much to
tell ya". Con questi versi della conclusiva Zebulon, Rufus
Wainwright stabilisce un rapporto mai così intimo con
l'ascoltatore: sì, sono innamorato, ma ci sono cose più
urgenti di cui parlare ora. L'autore canadese non nasconde il travaglio personale che contraddistingue la realizzazione di questo All Days Are Nigths: Songs For
Lulu, scritto e registrato durante la malattia della madre
e la conseguente scomparsa. Sebbene sotto forme anche
profondamente diverse, l'intimità pervade tutte le dodici
tracce, ma Zebulon rimane l'unica esplicitamente dedicata
alla madre e a essere stata composta dopo la sua morte.
Giunto al suo sesto album, e dopo il mezzo passo falso di
Release The Stars, Wainwright opera una scelta piuttosto
sorprendente per chi si è abituato al suo stile barocco e
sovraccarico, nel quale spesso anche le buone idee sono
state quasi soffocate da arrangiamenti eccessivi. Qui, almeno apparentemente, il lato più clownesco, da showman tout court, sembra essere messo da parte per dare
spazio a dodici canzoni per piano e voce, tutte intimismo
e romanticismo malinconico. Ecco, appunto: la voce. Mai
così in evidenza, sostenuta dagli arpeggi dell'iniziale Who
Are You New York?, con un sofferto ritornello che fa pensare agli episodi intimisti di Buckley figlio, o dall'upbeat dei
due minuti di Give What I Want And Give To Me Now, dove
invece riemerge il vaudeville, quasi che seppure si tratti di
aprire il proprio diario familiare, Rufus Wainwirght non
riesca a rinunciare a pensarsi su di un palco, per quanto
piccolo e raccolto.
Famiglia tutta musicale (oltre che per la nota sorella, è
l'attività anche di padre e madre) che diventa il fil rouge
di quasi tutto il disco, a cominciare dall'esplicita Martha
("it's your brother calling? / time to go up north and see
mother / things are harder for her now"). Nella dolente
ballata True Love, emergono più che altrove le influenze
della canzone americana degli anni d'oro, da Tin Pan Alley alla tradizione del crooning, quasi a voler affermare
un'appartenenza. La voce baritonale di Rufus Wainwirght
è anche capace di suscitare le delicatezze necessarie per
sostenere i tre sonetti shakespeariani: When Most I Wink
(che ricorda certo modo di cantare di Thom Yorke), A
Woman's Face (forse il numero migliore del lotto) e Shame. Wainwright se ne appropria al punto che non c'è apparente soluzione di continuità con le altre canzoni.
All Days Are Nigths è un disco che dividerà il pubblico.
Chi ha amato il Wainwright di Want One e What Two
probabilmente vedrà questi quarantasette minuti come
momenti interlocutori. Al contrario, chi pensava che le
canzoni di Wainwright soffrissero per i troppi orpelli, qui
ne ritroverà la musica in forma essenziale. Ma proprio
perché così semplice, potente come poche altre volte.(7.2/10)
Marco Boscolo
Sadies - Darker Circles (Yep Roc,
Maggio 2010)
G enere : americana
Come svariati connazionali prima di loro, i canadesi Sadies guardano oltre confine in cerca d'ispirazione. Attingono dal pozzo del classicismo a stelle e strisce e principalmente a un folk-rock dalla tipica confezione sixties che
- devoto per lo più ai Byrds e alternando momenti più
ritmati a oasi pacate - preferisce le maniere educate, pur
mantenendosi lontano dallo svenevole. Che queste maniere riescano poi a lasciare il segno, è ben altra faccenda:
ciò che scarseggia alla band dei fratelli Dallas e Travis
Good non sono infatti le amicizie importanti (Neko
Case, Steve Albini, Robyn Hitchcock) ma una
scrittura all'altezza delle intenzioni, dotata della caratura che si sollevi sulla folle
sovrapproduzione contemporanea.
Darker Circles vede alla regia l'esperto Gary Louris,
mente dei Jayhawks, abile nell'infondere il dovuto rigore
filologico ai suoni ma che null'altro può per arricchire
una scaletta senza guizzi e momenti di nota. Fanno eccezione l'iniziale Another Year Again dal finale diddleyiano,
il vibrante valzer Tell Her What I Said e un'austera Choosing To Fly, per quanto da una formazione all'ottavo disco
pretendi qualcosa in più di abilità esecutiva ed esercizi di
stile, a conti fatti gli unici pregi di un'opera immobile nel
suo rispetto delle regole.(6.5/10)
Giancarlo Turra
Sam Amidon - I See The Sign
(Bedroom Community, Aprile 2010)
G enere : avant folk
Canta con la tenera autorevolezza di Nick Drake, ed
è irresistibile quando si muove tra il garbo d'un James
Taylor, la gravità spiegazzata di Will Oldham e il solenne caracollare di Mark Kozelek. Sam Amidon è tornato
e con lui i soliti compagni di viaggio, in primis il produttore Valgeir Sigurðsson (Mùm, Cocorosie, Björk...), il
chitarrista australiano Ben Frost ed il poliedrico Nico
Muhly, con l'aggiunta di una appassionata e meravigliosamente discreta Beth Orton (chi si rivede!).
Come e più del precedente All Is Well questo I See
The Sign conduce il folk del ragazzo del Vermont tra
esotismi nordici, ipnosi da camera e vibrazioni post-tribali (vedi l'iniziale How Come That Blood), straniandolo in
qualche modo, consegnandolo ad una dimensione assieme familiare ed inedita. Un tepore affettuoso e scostante
77
ni (i Good Stuff House, Taradiddle con Mike Weiss),
una ritrovata verve artistica, che ci porta al nuovo lavoro:
Dandelion.
La musica di Scott Tuma è una vignetta gettata li a
mezz'aria. Una parentesi aperta. Un haiku senza risposta.
Non siamo distanti dalla pittura ambientale di Richard
Skelton, ma la storia degli autori è fondamentale e tanto quest'ultimo è palesemente britannico, tanto Tuma è
americano. Frammenti di un country raggomitolato in un
attimo, come un carillon rotto e dissepolto dalla sabbia,
vengono gettati su una tela che adombra un solido tessuto ambient. Gli arpeggi di chitarra sono cigolii al rallenty,
Stefano Solventi come fotogrammi di un vecchio documentario in bianco
e nero. Tutto il disco vive come unicum sonoro, per cui
le tracce si suddividono l'una dall'altra più per comodità
Scott Tuma - Dandelion (Digitalis,
d'ascolto.Tra queste, si segnalano le più lunghe (Red Roses
Aprile 2010)
For Me, Again and Again, Free Dirt, The Roses Are Red), che
G enere : ambient folk
"Sulle vecchie cartine stradali d'America, le strade principali suonano un po' come le architravi di questa immaginaria
erano segnate in rosso e quelle secondarie segnate in blu. cattedrale, così fragile e sottile, che un soffio di vento
Adesso i colori sono cambiati. Ma subito prima dell'alba e sembrerebbe spazzarla via.(7.5/10)
subito dopo il tramonto - brevi istanti, né giorno né notte - le
Antonello Comunale
vecchie strade restituiscono al cielo un poco del suo colore, assumendo a loro volta un tono Shipwreck Bag Show (The) - KC
misterioso di blu. E' l'ora in cui (Wallace Records, Aprile 2010)
le strade blu hanno un fascino G enere : avant - rock
intenso, e sono aperte, invi- Tanto era trasversalmente avant-blues il precedente Il
tanti, enigmatiche: uno spazio Tempo
Tra Le Nostre Mani, Scoppiaaaaaaaaaaadove l'uomo può perdersi".
aa! quanto è visceralmente rock questo inaspettato coLe strade blu di cui parla- meback. Bertacchini e Iriondo continuano imperterriti a
va in un suo vecchio libro circumnavigare il globo terraqueo della sperimentazione
William Least Heat rock-blues e per farlo al meglio stavolta si affidano alle
Moon, ovvero il tragitto nascosto per addentrarsi den- canzoni in maniera ancora più decisa. Canzoni compiute
tro l'umore più interno e privato del sogno americano. La e ben definite in chiave rock, con tanto di distorsioni di
provincia fatta di paesini persi nel nulla, di praterie vaste, chitarra e (semi)linearità nel drumming, ma soprattutto
di motel scalcinati, di polvere e terra e stivali consumati cantate come se i due avessero limato le asperità struper i troppi kilometri percorsi, alla ricerca di qualcosa o mentali per riversare l'asincronia, lo sfasamento, l'effetto
di qualcuno. Scott Tuma illustra tutto questo, meglio di disturbante su voce e testi.
qualunque didascalia. Un mondo ripiegato su se stesso, Sia chiaro, non che i suoni prodotti dalla chitarra (e altri
ingiallito come una vecchia foto conservata in soffitta, ammennicoli) di Iriondo o dalla batteria di Bertacchini
quasi nel tentativo di nascondersi all'attenzione del tem- siano accomodanti o le trame dell'interplay meno speripo, che passa e cancella. Memorie, vite, storie.
mentali (ascoltatevi lo scheletro rock disturbato di Venite
Era scomparso anche lui, vecchio cowboy sui generis che Spiriti o i suoni monchi di Ratti Nella Via). È però nella
aveva militato prima nei Souled American e poi nei centralità del cantato del batterista che risiede la novità,
Boxhead Ensemble, armato di una sei corde in chiave spiazzante eppur fascinosa, di KC. Ora anthemica (Siete
metafisica e di un senso quasi mistico della tradizione Solo TV) o memore di un Lindo Ferretti d'antan (Non Ci Sei
americana. Una sorta di country'n ambient aveva segnato Più), ora aggressiva e filologicamente punk-senza-esserei suoi dischi solisti: Hard Again e The River 1 2 3 4. punk (No Man Say Yeah) o stonata e fuori fase (Azioni/
Poi più il nulla per cinque anni. Salvo la riscoperta e il Reazioni), la voce dell'ex Starfuckers/Sinistri è lo strusalvataggio dall'oblio ad opera di Brad Rose e di Mike mento in più che allarga l'orizzonte della band. Minimali
Weiss che esortano l'eroe solitario a ritornare nei ranghi e visionarie, quasi frattali di cut-up a sfiorare il surreale o
e da qui altri dischi (Not For Nobody), altre collaborazio- l'ispirazione letteraria alta (P.P.P. in Capitani Coraggiosi), le
attraversa le undici tracce, come reminiscenze sbalzate
nel futuro e ritorno: è il caso di Way Go Lily e Johanna The
Row-di, incantevoli canzoncine della cantante gospel Bessie Jones che Sam ascoltava da bambino. I pezzi originali
sono fatti di premura grave e appassionata, come quella I
See The Sign che procede jazzy e attonita come un lascito
Talk Talk. Oppure si muovono con dolcezza incalcolabile e spersa (Kedron), alimentando un trasporto vaporoso
che si esalta incrociando la voce della Orton (Relief, You
Better Mind).
Anche noi abbiamo visto dei segni, e sono abbastanza
chiari: Sam Amidon è un grande.(7.6/10)
78
liriche rappresentano una sfida con l'ascoltatore, chiamato a decrittare ogni singolo fonema come simbolo d'altro,
in un continuo frantumarsi della parola come non se ne
ascoltava da tempo.
Obliqui e alienanti, visionari e furibondi, i due anche stavolta sono in grado di spiazzare l'ascoltatore. Grande
merito, oggigiorno.(7.5/10)
Stefano Pifferi
Sight Below (The) - It All Falls
Apart (Ghostly International,
Aprile 2010)
G enere : ambient techno
Come già analizzato in altri lavori, primo tra tutti Pantha
Du Prince, pare che The Sight Below stia muovendo
verso la totale assenza di beat acuendo di contro possenza
e feeling. La due tracce in apertura sommano undici minuti
di sognante musica discreta fatta di epici bordoni cosmici
(Shimmer) e liquide trame ancestrali (Fervent), ovvero un
esplicito biglietto da visita di pari e inversa portata alle
battute iniziali dei My Bloody Valentine di Glider.
La cassa dritta diventa eccezione e non regola, nondimeno seducente in Through The Gaps In The Land e Burn Me
Out From The Inside ma quasi marginale accessorio di un
modus già compiuto. Il crocevia del cambio di rotta lo
si poteva trovare nell'Extended Play dello scorso anno,
Murmur, dove l'apporto del vecchio amico Simon Scott
(ex Slowdive) e soprattutto Eluvium è stato decisivo.
Ed anche qui c'è una traccia cantata, una cover, che fa il
paio col background Factory mai nascosto. New Dawn
Fades dei Joy Division viene proposta come avrebbero
potuto dalle parti dei This Mortal Coil: intensa e liquida
dove spicca la voce di Jesy Fortino (aka Tiny Vipers) calatasi perfettamente in atmosfere a lei poco congeniali.
L'acme dell'intera opera risiede tuttavia nei tredici minuti
Stagger: un remix tra Basic Channel (quella cassa monca)
e Labradford operato da un raver pentito. A rigor di logica, nel prossimo lavoro l'abiura del beat dovrebbe essere
il passo obbligato.(7/10)
Gianni Avella
Sikitikis - Dischi fuori moda
(Infecta, Aprile 2010)
G enere : psych rock
Dopo un decennio di attività arrivano al terzo album i
cagliaritani Sikitikis, già sulla Casasonica di Max Casacci; ancora niente chitarre come recitano i credits dei due
precedenti, e ancora la loro proposta intelligente di psych
rock variamente coniugato a destare la nostra attenzione.
La matrice Subsonica si sente sempre, coniugata con
ingredienti electro punk funk, pop wave, surf e garage,
condita da un immaginario
straripante che frulla sci-fi,
attualità, ironia sferzante,
modernariato, lounge e cocktail, Ennio Morricone,
colonne sonore dei '60 e
'70 e testi necessariamente
in italiano. Del resto hanno
già un curriculum nutrito in fatto di sonorizzazioni per il
cinema.
Dischi fuori moda, realizzato in collaborazione con
Max Stirner e Max Fusaroli, vede la presenza al solito
di cover stravolte, qui Malamore, omaggio allo stralunato
genio di Enzo Carella (1977) in psych acido. Un ibrido
energetico, che fa il punto sulla loro attività. Un gran bel
ritorno.(7.1/10)
Teresa Greco
Speedy Peones - Karel Thole
(Shyrec Records, Maggio 2010)
G enere : psych - punk - new wave
Una via di mezzo tra i Fleshtones, gli Hives e degli
Stooges sotto anfetamina. Padri putativi, quei Crystal
Antlers di Tentacles che spuntano dagli incroci al fulmicotone tra chitarre elettriche e tastiere e che danno vita
a una psichedelia urticante mista a un punk imbastardito.
Gli Speedy Peones riescono a riassumere in una ventina
di minuti il post-punk di A Bear e Cinebrividus, il rockabilly
di Die Neue Kindheit, la new wave di Système Solaire, lo
sci-fi spacey di Moon, le inflessioni mediorientali/noise di
Gt-Junior, comprimendo in dodici episodi intuizioni che
sono vuoti a perdere. Un consumismo da toccata e fuga
che non si accontenta dei punti di riferimento classici ma
imbocca strade alternative saltando pure qualche passaggio, come nel deragliante elettro-rock & roll di Voiture
Tempo. Fa quasi impressione scoprire da qualche intervista in giro per il Tubo che i Nostri hanno cominciato
materialmente ad imbracciare uno strumento solo nel
2001 e senza avere contatti con altri musicisti o scene
particolari. Fa impressione ma forse questo più di altro
spiega la freschezza incongruente e feroce che emerge da
Karel Thole e che rende il disco una delle esperienze
più eccitanti degli ultimi mesi.(7.2/10)
Fabrizio Zampighi
Starkey - Ear Drums And Black
Holes (Planet Mu Records, Aprile
2010)
G enere : H op step , bas s
Al secondo album per la Planet Mu, Starkey, dj e producer di stanza a Philadelphia e matto per l'elettro UK, cala
79
l'asso del feat. confezionando una raccolta che angola,
con maggiore precisione e qualità, le cadenze e le movenze del dubstep in una pletora di suggestioni now on.
E' tutta roba che conosciamo bene come il trillo otto
Bit videogioco di Ok Luv (traccia giocata su breakbeat al
sapor di dub step e ricordi balearici), oppure l'altrettanto
rilassata Stars (con il feat. soul dell'affascinante Anneka);
eppure il maglione è sempre messo al contrario. Il nerd
pensa hip hop e chiama a sé gente che rappa strofe grime lavorando di bass e spezzettamenti step (Murderous
Words con ospiti i Celebral Vortex), oppure omaggia la
sua philly con cose r'n'b elettronizzate (e altrettanto svagate) come 11Th Hour che gli tirano fuori una mai sopita
vena soundtrack.
Rispetto al gioco mimetico di un Harmonic 313, si gioca a carte scoperte con la negritudine e il ghettoblaster.
Niente oscurità urbane degli amici Vex'd per Ear Drums
And Black Holes tutt'altro: è un lavoro di sole, grasso, cuore e pancia innestata nei circuiti (Spacecraft è Carpenter
e bum bum cha, i ritmi in french fries e lo slaking degli
Amari di Club Games). E alle volte la mano cicciona è
quella che serve.(7/10)
se stesso, ma il fascino di quest'opzione minimale resiste
a tutto, anche ad armonie così dilatate e compromesse
da rendere le canzoni, astratti teoremi gettati nell'etere.
Qualcuno parla di soundsculpture. Se fossero materia tangibile queste forme singolari (a volte ripetute) sarebbero
qualcosa che sta a metà tra gli uomini scarnificati di Giacometti e le architetture open space ormai sempre più in
voga.(7/10)
Antonello Comunale
Tape Tum - The Night We Called It A
Day (Kimi Records, Maggio 2010)
G enere : C hamber P op
Quattro anni per confezionare l'album d'esordio dopo
un eppì rilasciato nel 2006 e due tracce prestate a una
compilation della Domino affiliata al magazine The Wire.
Un tempo trascorso a sviluppare un chamber pop che, da
voglie arty e retrò (come anche da mutazioni indietroniche europee del suono post-rock chicagoano), si è reinventato dream e soundtrack '70, memore com'è di certo
Brian Wilson quanto dei migliori delfini dell'uomo oggi
in circolazione (i Grizzly Bear) passando per giovani
Edoardo Bridda maestri quali Divine Comedy e Field Music.
Paragoni altisonanti per
Sylvain Chaveau - Singular Forms
nove tracce un po' barocche
(Sometimes Repeated) (Type
e dal songwriting in alcuni
Records, Aprile 2010)
frangenti ancora incerto,
G enere : avant songwriter
Less is more. Il minimalismo come forma d'espressione vestite tuttavia di soundscapura. Chauveau ci ha sempre girato intorno, cercando pe piantati su un terreno nelle pause e nei silenzi le motivazioni principali per fare quello delle contaminazioni
musica, ma mai come ora si era dedicato con meticolo- tra cantautorato, glitch e residui post-rock - ancora ricco.
sità a cercare il fascino che si nasconde nelle pause e nei Brani forti di una formula affascinante e, a tratti, persino
vuoti. Singular Forms segna un ritorno alla scrittura entusiasmante.
autografa e solitaria dopo un nutrito numero di espe- L'indie è ripreso all'osso (Crabp pare prodotta da John
rimenti estemporanei, collaborazioni e colonne sonore. McEntire, tant'è abile nell'incastrare basso, batteria ed
Un ritorno alle canzoni, dopo il disco di tributo ai Depe- effetti), l'impro elettro-jazz dei Tied Tickled Trio appreso a dovere, le bordate digitali dei 65daysofstatic tenuche Mode, Down To the Bone, di cinque anni fa.
Il taglio della musica non potrebbe essere più severo e te a bada e così Yepepe - uptempo primadonna prog della
contrito. Le note di piano, come lacrime sul volto, con- cordata - è senz'altro quel brano che già supera alcuni
quistano il proprio spazio, frammento dopo frammento. succitati limiti e ci fa scommettere su questa coppia di
E' il fascino quasi morboso che si prova a farsi calare su di fratelli fiamminghi la cui strada - se il coraggio li supporta
se, i silenzi e le attese. Osservare lo scorrere del tempo. - è tutta in salita.(7/10)
Attimo dopo attimo, nei vuoti abissali tra una nota e l'alEdoardo Bridda
tra. Pause su cui una voce incredibilmente simile a quella
di David Sylvian sibila da crooner alcolico. La tavoloz- Ted Leo And The Pharmacist - The
za strumentale non si arricchisce di molto. C'è un uso Brutalist Bircks (Matador, Aprile
molto parco dell'elettronica in una musica che fa rima, 2010)
per evidenti assonanze, con quelle di Carsten Nicolai e G enere : I ndie R ock
Ryuichi Sakamoto.
Un giro per le classifiche del decennio e in almeno un
C'è un odore anche troppo forte di intellettualismo fine a paio figureranno The Tyranny Of Distance e Hearts
80
Of Oak, vertici artistici di un rocker dell'East Coast che
da Kinks o Who era riuscito a confezionare una micidiale formula di punk e soul, hardcore e folk finendo
per intraprendere nel corso degli anni un corso power
pop e, infine, indie rock tout court alla caccia dell'hook
melodico.
Lo scorso Living With The Living (2007) aveva parzialmente deluso, peccando in logorrea e mancanza di
energia. The Brutalist Bricks tenta il riscatto mescelando Spoon, Dinosaur Jr. (al netto di Mascis), college
rock evoluto e Dismemberment Plan. Non è proprio
quel ritorno in grande, ma quanto basta per la stretta di
mano come dimostra Tubercoloids Arrive In Hop (gli Weezer in stato di grazia), o il cuore rockarolla di The Stick,
Bottles In Cork e Woke Up Near Chelsea. Di Ted ci si può
ancora fidare.(6.8/10)
connubio da seguire con molta attenzione. (7.5/10)
Stefano Solventi
To Rococo Rot - Speculation
(Domino, Aprile 2010)
G enere : P ost rock
Dopo il passo falso di Hotel Morgen risalente oramai a
un lontano 2004, e l'altrettanto interlocutorio eppì commissionato per il cinquantesimo anniversario del font tipografico Helvetica (abc 123) nel 2007, i To Rococo
Rot ritornano con il più volte dichiarato (e posticipato)
album "suonato".
Suonato innanzitutto da strumenti rock come chitarra,
basso e batteria, in simbiosi come se la band stesse suonando ad un live show: a dichiararlo è il portavoce Stefan
Schneider. Speculation, sesto album lungo dei tedeschi,
Giampaolo Cristofaro è un ritorno al passato: un tentativo di azzeramento che
riallaccia il trio ai numi tutelari di sempre (i Tortoise)
Tiziano Zanotti/Alessio Alberghini - e al contempo rimette il sangue krauto in circolazione
attraverso soffici ritmi motorik e altrettanto proverbiali
Psaico Bop (ECHOES, Marzo 2010)
geometrie a incastro.
G enere : avant jazz
Torna ad agitare l'alberello del jazz nostrano il duo che Un misto di propulsione e rilascio (letting go), il disco è
abbiamo parecchio apprezzato col precedente Influen- stato concepito nello stuces, oggi come allora all'insegna di un sound che si di- dio dei Faust, altro tassello
simpegna tra avanguardia post-bop e sbrigliatezze free, che conferisce un decisivo
o meglio cerca di definire una propria voce attingendo tocco di "vintage modercon piglio progressivo alla cornucopia del passato (come nità" ed autoreferenzialità
è giusto che sia, come più spesso dovrebbe essere). Sta- storicizzante.
volta però non si tratta di reinterpretare standard più o L'incertezza sul futuro con la
meno celebri: le quattordici tracce di Psaico Bop sono quale l'album starebbe fatutte originali, il che ci consente di apprezzare anche cendo i conti, non è che una
l'abilità compositiva di Alessio Alberghini, sassofonista, e session di vecchi amici che
Tiziano Zanotti, contrabbassista col vizio del violoncello, nel frattempo sono diventati consapevoli e tecnicamente
entrambi ben disposti verso loop, escursioni & perturba- preparati, ma senza una seria volontà d'aggiornamento
o di messa in discussione, come avvenne per esempio
zioni elettroniche.
Ad aiutarli per l'occasione ci sono il pianista Fabrizio Pu- ai tempi del loro primo tentativo in Music is a Hungry
glisi ed il batterista Claudio Trotta, che alternativamente Ghost.
espandono il duo in trio, laddove la situazione sonora lo Infine, come non negare a Speculation la natura nostalgica: quel '96 in cui, sulla scorta di Chicago e del post
richiede.
Una formula decisamente azzeccata, perché se l'intera- rock, i tre avevano sperimentato la sensazione di non
zione tra i due co-leader frutta momenti di meditabondo avere limiti né barriere tra jazz, rock, techno, kraut, cotrasporto (Un giorno per amare) e angolosa suggestione smica e ambient. Bei tempi andati...(6/10)
(Movimento statico, Because), l'additivo della batteria faEdoardo Bridda
vorisce ultrabop spasmodici (Punk Meditations, la straordinaria Harry) e visionarie frenesie free-funk (Evidenze), Tony Allen - Secret Agent (World
mentre gli interventi del piano - sia esso "cageanamente" Circuit Records, Giugno 2009)
preparato (Tarratalla) o meno (Fat) - arricchiscono non G enere : african funk
poco il già considerevole campionario espressivo.
Lo avevamo perso per strada, in un 2009 superaffollato;
Trova quindi conferma la calligrafia intensa e impertinen- lo recuperiamo adesso in occasione dell'uscita negli Stati
te, non priva di umorismo (fin dal titolo dell'album) né di Uniti (su Nonesuch).
sintomatico mistero, della ditta Alberghini & Zanotti. Un Pochissimo da dire su questo nuovo album della leggen81
da Tony Allen (inutile ripetere le solite cose: Fela, Eno,
eccetera). Disco calibrato e rilassato, suonato in maniera
impeccabile; scrittura di mestiere senza picchi ma di livello decisamente medio-alto; consueta fusione tra elementi della tradizione africana (i cantati femminili, protagonisti assoluti dell'intermezzo a cappella Atuwaba), fiati e
chitarre funky (con un paio di soli rock-blues pulitissimi,
e sporcati di psichedelia) e batteria tra r'n'b e jazz.
Piacevolissimo. Classe col pilota automatico.(6.8/10)
Gabriele Marino
Tosca - Pony - No Hassle Versions
(G-stoned, Marzo 2010)
G enere : adult oriented chill
La visione di Tosca non si ferma e in un moto di iperattività Dorfmeister e Huber chiamano gli amici del
giro giusto a remixare di pancia il disco dell'anno scorso.
Il risultato è una bomba che connette la deriva adult
dell'Elevator Music inglese con i ricordi della premiata
ditta K&D. La differenza sta però nelle droghe catalizzatrici il chilling. Se nella cricca del Fabric londinese c'è la
sopravvivenza al post-E, qui si respirano i fumi retroattivi
della cannabis.
Il paesaggio dipinto sul trompe l'oeil della memorabile copertina con i pony è influenzato dalla sempreverde bossa
di Nicola Conte (My First con un assolo di flauto da paura), dalla classe chiccosissima del redivivo Rodney Hunter (Rosa) e da un inaspettato post-funk di Kalabrese
(Oysters In May). Ci sono poi rivisitazioni su quartetti d'archi à la Steve Reich (la versione di Rosa del K&K Streichquartett), qualche richiamo alla Giamaica da parte di
Grant Phabao (Birthday) e per finire l'inevitabile risacca
ottantiana (Joe Si Ha di Reverso 88).
Esagerata epifania o canto del cigno? A noi sembra decisamente meglio dell'originale. Consigliata ovviamente
per tutti gli opening della prossima estate. Tosca ha ancora molte cartucce da sparare. Roulette russa d'obbligo
per noi.(7.3/10)
Marco Braggion
Trans AM - Thing (Thrill Jockey,
Aprile 2010)
G enere : kraut , synth , rock
Heaven's Gate è una lunga eiaculazione per cavalcata di
batteria e solo hard-rock di chitarra, poi stemperata alla
comparsa dei synth. Rappresenta forse il culmine tradizionale dei Trans Am di Thing, ed è un buon punto
da cui partire per leggere l'ennesima opera del combo
di Washington. Ci serve da pretesto per parlare dei TA
come irriducibili massimalisti, che stanno due anni a incidere certosinamente un disco e si reputano ormai so82
vraesposti nei media.Vorrebbero chiudersi nella culla del
proprio suono e, per farcelo capire, mettono la scorza
più dura che possono ai brani che realizzano.
Il vezzo - più che la novità - di Thing sono in realtà i vocoder, che ci fanno parlare di una forma hard di Giorgio
Moroder, più che dei Kraftwerk. Il riferimento è sempre il synth-kraut più lascivo, a volte preso per se stesso
(appena motorizzato, come in Apparent Horizon, che è
difficile ascoltare fino in fondo, tanta è la noia che fa
insinuare), più spesso virato in bulldozer, o nelle migliori
occasioni in matematica androide (Arcadia, dove si riconosce una chitarra ritmica
che ricorda tanto i Pink
Floyd di The Wall).
In sostanza si nota il tentativo di trovare un sound
coeso al massimo grado. Il
problema è che la coesione non è accompagnata da
estro, ma dà luogo a una
forma di scrittura enfatica (anche se ben decostruita,
a partire dalla propria banalità armonica, almeno nella
conclusiva Space Dock, che diventa peraltro sempre più
cosmica man mano che si alza il volume). Inevitabile forse che dopo quindici anni una band si parli addosso. Per
evitarlo servono un concept forte e un'enorme lucidità.
Qualità che i Trans Am hanno sempre avuto solo in parte.(6.5/10)
Gaspare Caliri
Ufomammut - Eve (Supernatural
Cat Records, Maggio 2010)
G enere : heavy - psych - rock
Un unicum lungo 45 minuti segna il ritorno di una delle
band più heavy del panorama italiano. Eve - disco concettuale sulla prima donna, suddiviso in 5 movimenti senza
soluzione di continuità - mette sul piatto tutto il potenziale del terzetto oltre che le infinite sfumature di un
suono in apparenza staticamente heavy-rock. Ipnotiche
suite e slanci al limite del raga-rock, apocalittiche svisate
post-neurosisiane e nenie ossianiche si alternano anche
all'interno dello stesso movimento creando una tensione che avanza a ondate e flutti. Un procedere ormai
noto ma che riserva, a dieci anni buoni dai primi passi
della formazione, sorprendenti sviluppi stilistici oltre che
mostrare una invidiabile perizia strumentale.
Dall'incedere salmodiante Om-style del primo, ipnotico
movimento, in costante vertigine ascendente, al fiume in
piena da apocalisse in progress del terzo, lambendo territori quasi da sci-fi/horror soundtrack come potrebbero concepirla gli amici Morkobot, i tre si muovono agili
come non mai nelle fosche lande heavy-psych alternando tensione e rilascio, vertigine e trascendenza. Roba da
iniziati, ovviamente, ma supportata da una poetica della
"ribellione dal preconcetto" (il concept su Eva ruota tutto intorno al concetto della conquista della conoscenza) che mostra gli Ufomammut non fossilizzati su schemi
musicali ormai ben definiti e storicizzati.(7.2/10)
Stefano Pifferi
Umberto - From The Grave
(Permanent, Marzo 2010)
G enere : H orror S oundtrack
Ricordate i Goblin? Sì, quelli di Profondo Rosso. Ricordate il sound sintetico e analogico di quelle progressioni
cromatiche? Oggi c'è chi, a trent'anni e più di distanza,
subisce ancora il fascino delle colonne sonore dei film di
Argento, Fulci e Carpenter (sempre nella doppia veste di
regista e autore delle musiche). Parliamo di Matt Hill, già
basso e synth negli Expo'70, e del suo nuovo trip solista
a nome Umberto.
Il tributo che il ragazzo di Kansas City paga alla tradizione del giallo e del thriller è notevole, a partire dal
moniker in italiano, passando per la veste grafica da locandina settantina, per arrivare a pezzi come Forsaken
Dawn che fa il verso proprio a Profondo Rosso. Rispetto
ai gruppi prog dei '70 l'impronta è più elettronica, fedele
ai lavori del sopracitato John Carpenter, sconfinando
spesso nel minimalismo dei Dark Day di Windows. Di
tanto in tanto schegge di scuro funk mutante (It Came
From The Swamp) e dance gotica anni '80 (In The Name Of
Zuel) movimentano la scaletta, ma per lo più si precipita
lungo pareti immaginarie, dentro baratri vorticosi, senza più cognizione del tempo. Proprio come la migliore
soundtrack di un film horror d'antan.(7.1/10)
Andrea Napoli
UNKLE - Where Did The Night Fall
(Surrender All, Maggio 2010)
G enere : electro pop rock
Dopo essere partito in promozione già un anno fa disseminando anticipazioni prima su un neonato blog, poi
attraverso sito ufficiale, James Lavelle sforna un quinto
album che è tutto fuorché di sostanza.
Sotto il vestito del marketing post-00 con i video dei making of, le leccatine a mo di featuring (l'unico memorabile
è il blues di Mark Lanegan) non c'è che dell'electro
pop scadente (Joy Factory), stantii stupori orchestrali UK
(The Answer), punkettini inutili (On A Wire) e pseudo wave
Ottanta (Caged Bird). Tanti saluti.(5/10)
Upsilon Acrux/Honey Ride Me A
Goat - Upsilon Acrux/Honey Ride Me
A Goat (Kitchen Dweller, Febbraio
2010)
G enere : P rog -P unk
Pollo al Curry. Una ricetta piccante accompagna la quarta uscita dell'etichetta musical-culinaria Kitchen Dweller.
Ed è roba urticante, quella proposta dalle due band dello
split. Un 12" in cui gli anglosassoni Honey Ride Me A
Goat e i losangelini Upsilon Acrux si spartiscono un
lato a testa della stessa medaglia - due modi differenti di
interpretare un comun denominatore prog-punk.
Gli Upsilon Acrux, freschi di stampa con l'album
Radian Futura (Cuneiform
Records), continuano lungo il loro personale sentiero: frammenti rock prelevati direttamente dai King
Crimson di Discipline e riletti attraverso le montature spesse di un qualsiasi teen indie-pop. Nessuna voce
s'intenda, ma tra mille spericolatezze ritmiche, intrecci
chitarristici e tecnicismi vari - ed emergono sensibilità
strappalacrime. Ma è un'emotività inevitabilmente compulsiva, fratturata com'è dai continui cambi di tempo e
velocità. Quasi vengono in mente quegli studenti secchioni che, per scacciare dalla mente troppi amori non
corrisposti, si gettano a capofitto su matematiche non
ordinarie e algebre di livello superione. Salvo poi - il finale di Caspar Brötzmann of Faux-Hawks - affogare ogni
minuziosa costruzione, ogni accorta distrazione cervellotica in un disastro di cacofonie industriali (e che fine
fanno gli studenti secchioni?).
Di un'altra scuola sono invece gli Honey Ride Me A
Goat. Partono già male con un suono tanto scellerato quanto quello di casa negli esordi di Trumans Water. Da lì, poi, devono essersi innamorati delle furberie
sghembe di casa Skin Graft - US Maple e Flying Luttenbachers su tutti - e il risultato è facilmente prevedibile. Quattro schegge di un rock che più scellerato non si
può, in puro stile now! wave - in cui ogni rottura ritmica
sembra provocata da inciampi fuori programma e i riff
ripetuti all'ossesso causati da vuoti di memoria. Il tutto
confezionato in una qualità di registrazione amabilmente
schifosa.(7/10)
Leonardo Amico
Marco Braggion
83
Veronica & The Red Wine
Serenaders - Veronica & The
Red Wine Serenaders (Totally
Unnecessary Records, Maggio
2010)
G enere : blues - jazz - ragtime
Ragtime (You Drink Too Much), vaudeville (Nobody Knows
But Me), country blues del delta del Mississipi (Busy Bootin'), soul (You Must Come In At The Door), Bessie Smith
(Good Old Wagon), jug band music e chi più ne ha più ne
metta. In pratica, i vecchi medicine shows, la scuola di New
Orleans e il jazz anni '20-'30 in un'unica soluzione.
Si tratta di rivisitazioni, è vero, ma i Veronica & The Red
Wine Serenaders non hanno nulla a che vedere con l'universo delle cover band. Anche perché nel primo, omonimo, disco della formazione lombarda si parla al massimo
di filologia sentimentale, di recupero, se non proprio di
reinterpretazione di classici poco noti al grande pubblico.
Il tutto con una professionalità affezionata e un intendo
pseudo-educativo che non dispiace affatto.(6.7/10)
Fabrizio Zampighi
Vex'd - Cloud Seed (Planet Mu
Records, Marzo 2010)
G enere : ambience dubstep
Jamie Teasdale e Roly Porter ritornano dopo il non troppo sconvolgente esordio del 2005 (Degenerate). A seguito dello scoppio della bolla dubstep, il duo di Bristol si
scioglie per imboccare strade e progetti diversi. Quello
che rimane è raccolto in questa nuvola postuma.
Qualche featuring di classe (Warrior Queen in Take
Time Out), qualche atmosfera ambience ereditata da un
non eguagliato Scuba (Remains Of The Day), un remix di
Plaid e le incursioni nella classica (Prokofiev e Williams)
sono il minestrone cinematico che ambiva nel 2006 a
dipingere il nuovo dopobomba post-Terminator. La proposta eredita il cupo sentire dei Portishead, ma resta ancorata a stilemi impolverati e quindi non aggiunge molto
alle proposte dark di Burial o tech di Benga. Niente di
più che una mediocre ristampa. Prescindibile.(5/10)
Marco Braggion
Vivianne Viveur - Rain Feelings (My
Fay Records, Aprile 2010)
G enere : dark wave
Arrivano alla terza uscita gli italo-inglesi Vivianne Viveur, titolari di un songwriting crepuscolare con codice
genetico prevalentemente dark wave. I panorami sonori
sono i medesimi del precedente, tra onirismo e dark
wave, atmosfericità e qualche dissonanza rimasta dalle
prove precedenti.
84
Molti gli ospiti coinvolti nel progetto, fra i quali Christian Rainer, piano e arrangiamenti in Gray, uno dei
pezzi più suggestivi. Il gruppo si conferma allora buon
divulgatore del genere di riferimento, con una bella padronanza e una crescita evidente dalla penultima prova
Vert di un paio di anni fa.(6.9/10)
Teresa Greco
Wooden Shjips - Vol. 2 (Holy
Mountain, Aprile 2010)
G enere : psych - rock
Mentre qualcuno (il chitarrista Erik Ripley Johnson) si
intrattiene altrove (Moon Duo) facendo qualcos'altro
(ma non troppo, vedi Escape) la casa madre non se ne
sta con le mani in mano. Così, come da tradizione, si
intervallano i vuoti tra disco e disco con raccolte di ciò
che nel frattempo si è disseminato un po' in giro, quasi
sempre in vinile e tirature killer. Stavolta tocca al 7" su
Sub Pop, l'ep per Mexican Summer, qualche cianfrusaglia
live, un pezzo per la compila Yeti e gli immancabili vinilini
tour-only, reale vezzo dei giorni nostri.
Detto questo e appurata l'eterogeneità di dischi del genere, i suoni di Vol. 2 non si distaccano molto dal solito
procedere da fuzzed-out
psych jams tirato in ballo
dall'etichetta. Anche se qua
e là, come già per il Vol. 1,
qualcosa di intrigante esce
fuori: una resa catacombale, almeno per le vocals,
di Death's Not Your Friend,
ad esempio, che riecheggia
vagamente alcuni passaggi bauhausiani, seppur sempre
seppelliti sotto strati e strati di fuzz; e poi le due cover, a
dir poco sorprendenti, almeno per i nomi dei coverizzati.
La prima è una rendition organ-driven di Vampire Blues
di Neil Young che del blues dell'originale mantiene lo
scheletro mentre le forme sono quelle dello stomprock. L'altra sottopone alla centrifuga psych il classico
di Gainsbourg Contact, fino a stenderlo per 8 minuti
abbondanti di liquida e incessante psichedelia.
Se non siete tra quei pochissimi fortunati ad avere tutta
la discografia dei losangelini, questa è l'occasione giusta
per rimettersi in pari.(6.8/10)
Stefano Pifferi
Yannis Kyriakides - Antichamber
(Unsounds, Febbraio 2010)
G enere : M odern C omposition
Cosa fa un compositore, o comunque l'artista che fronteggia la pagina scritta, per sbarcare il lunario, oggi? So-
litamente vive di commissioni, statali - se non opera
in Italia - o, più frequentemente, di oboli più o meno
munificamente concessi da fondazioni, istituti di cultura,
semplici mecenati.Cosa fa il compositore, o comunque
l'artista che fronteggi la pagina scritta, per sbarcare il lunario, oggi? Solitamente vive di commissioni statali - se
non opera in Italia - o, più frequentemente, di oboli più
o meno munificamente concessi da fondazioni, istituti di
cultura, semplici mecenati.
E' con una situazione del genere che anche i migliori
sono costretti a fare i conti quotidianamente. Prendiamo
Antichamber. Poderoso doppio cd che Yannis Kyriakides - compositore di origini cipriote da tempo stabilitosi in Olanda - ha licenziato tramite l'etichetta che
gestisce, insieme ad Andy Moore degli Ex, ormai da
anni. Primo assaggio (antichamber: anticamera, appunto)
di una serie di pubblicazioni che faranno luce, di qui a
qualche mese, su un repertorio molto vasto ma ancora,
disgraziatamente, poco conosciuto.
La qualità della scrittura si assesta, in tutte e dieci le
composizioni, su livelli qualitativi mai meno che molto alti.
Qui, tra riproposizioni futuriste di quartetti bartokiani
(Antichamber, per quartetto d'archi e computer), formazioni cameristiche rinforzate con protesi più o meno
tecnologiche (qua un telegrafo, là un iPod shuffle), tra
minimalismi di terza generazione (Chaoids, per violino,
sax alto, vibrafono, soundtrack), cori meta-semantici (U,
per coro e onde sinusoidali) e folk songs (PNeuma, per
fagotto, piano, soundtrack) post-Berio, sembra davvero
essercene per tutti i palati.
Ma è proprio qui che si annida la grandezza e, al contempo, il limite, di un lavoro siffatto. Ogni brano, lo illustra
diffusamente il booklet interno, è occasionale: occasionato da una manifestazione culturale, dal volere di un'istituzione, dalla curiosità famelica di un ensemble in cerca
di nuove note. Di più: l'arco temporale coperto è molto ampio, estendendosi dal 1995 di Zeimbekiko 1918 al
2007 di Telegraphic e As They Step Into The Same Rivers.
Forse, allora, che il valore di Manifesto che avremmo
voluto conferire alla seconda accezione del titolo Antichamber - non solo anticamera, ma anche anti-camera:
una nuova musica da camera - emergerà con le prossime,
si spera più coese, uscite discografiche? Non lo sappiamo: per il momento, Antichamber resta in ogni caso
un disco imperdibile, e pazienza, se la speranza di rivoluzioni paradigmatiche in musica deve cozzare con i limiti
- fisici - del supporto e quelli - spirituali - della politica
culturale.
(7.5/10)
Zoo - Trilogi Peradabam (Dual
Plover, Marzo 2010)
G enere : noisecore
Originariamente un boxset in legno dipinto a mano con
3 (mini)cd-r, Trilogi Peradabam viene ora ristampato
in un unico cd e distribuito worldwide, tanto che l'uscita
è da considerarsi come nuova di pacca. Non è questa
l'unica sorpresa, visto che gli Zoo vengono dall'Indonesia
e mostrano come anche in quello che pensiamo essere il
terzo mondo esistano spiriti affini alle musiche estreme
prodotte in occidente.
Sono in tre e fanno a meno della chitarra, ma grinta e approccio schizoide fanno sì che l'assenza non sia un peso,
quanto l'ennesima nota esotica al portato post-noisecore dei tre. Nell'album - un concept sulla civilizzazione
suddiviso in tre sezioni proto-storiche Neolithikum, Mesolithikum e Palaeolithikum - brevi frammenti da poche
decine di secondi si alternano a composizioni più ampie,
seppure circoscritte sempre in un formato canzone che
nel migliore dei casi rimanda a certe svisate zorniane
d'inizi '90, mentre in altri
alle peripezie da ipercinesi
dell'assurdo dei Melt-Banana.
Non a caso citiamo il folle
collettivo di Tokyo, perché
sulle musiche degli indonesiani molta influenza sembra avere proprio l'estremismo nipponoise da Ruins in giù, con le sue bands in
grado di risemantizzare la musica estrema occidentale
portandola ad un livello inusitato di follia e violenza. Cosa
che, specialmente nel mix con le musiche tradizionali del
sud-est asiatico, riesce anche agli Zoo.(6.7/10)
Stefano Pifferi
Vincenzo Santarcangelo
85
— live report
Ninni Morgia Control Unit
A s sociazione , B ologna F arm (10 A prile )
È già nel moaning ossessivo di Silvia Kastel, titolare
dell'etichetta Ultramarine nonché occasionale presenza ai synth per la Ninni Morgia Control Unit, che si
possono individuare le direzioni stilistiche dell'ennesima
incarnazione del chitarrista catanese. Una voce che sembra richiamare i disagi di Lydia Lunch epoca Teenage
Jesus, ma dalla quale sono sciolti tutti i riferimenti ad
una quotidianità inquietante. E raggiunto un punto di vista quasi straniante da cui spiegare come vanno le cose,
persino il disagio diviene un'astrazione. Dopotutto si
tratta di musica strumentale. Il resto lo chiamano freejazz. Ma già nell'album di esordio, nell'improvvisazione
di Ninni Morgia trapelano spunti che si rivelano distanti
dalle spinte escapiste dei nomi tutelari che pure lo ispirano: Sun Ra e le sue derive cosmologiche, i richiami
all'oriente di Alice e John Coltrane o i riferimenti alla
madre Africa di Archie Shepp. E neppure nella New
York che l'ha accolto, trova facili corrispondenze il suo
predicare. Non nelle furberie citazioniste dei Talibam,
nè nelle grammatiche sghembe di Peeesseye, compagni
di dischi e collaborazioni, ma che prediligono un approccio ludico alla loro musica. Nella musica di Ninni, invece,
al di là della psichedelia di cui pure l'album è ricco, ci
sono dei momenti in cui la visione è lucida, trapelante
una fredda tragicità.
Di questi momenti, che nel disco occupano solo una
parte del corposo doppio LP, si costituisce la norma del
live. Queste sono le premesse da cui si sviluppa il concerto della Control Unit, in una formazione di cui Morgia rimane la sola costante. Ad accompagnarlo oltre ai
synth si aggiunge il sax di Edoardo Marraffa, fautore
di un approccio quasi rabbioso, decisamente distante dai
fraseggi di Daniel Carter con cui il disco è stato inciso.
Urla disperato il suo fiato, mentre accompagna i lunghi
sospiri della voce per poi frammentarsi su staccati ipnotici. Uno strumento abusato, forzato a suoni non previsti
dalla sua natura: fischi, ruggiti, risonanze anomale, in un
modo di suonare di cui andrebbe fiero anche il Pharoah Sanders dei tempi di Ascension. Dal lato dei synth
emergono invece scarni pattern ritmici, e rumorose mo86
dulazioni caratterizzano il suono della band in apporti
essenziali quanto decisivi. Infine Ninni Morgia. Se ne sta
in disparte il chitarrista, ai margini della musica nonostante la posizione centrale nel fondo della sala. Perché il
suo è un lavoro artigiano, che del suono rifinisce i bordi
e ne definisce le strutture. Un defilato centro nevralgico,
intorno a cui ruotano le espressioni degli altri strumenti.
Ed è sempre lui che da forma organica alla musica col
suo pulsare di crescendi e rarefazioni. Lavora esperto
sulle corde e sui pedali, tre le pieghe della dinamica come
ad aggiungere memoria alle urgenze del sax e del synth.
Unità di controllo di un entità inafferrabile, che cambia
di numero ed elementi pur rimanendo coerente con la
sua identità.
Il resto della serata lo caratterizza una scaletta piuttosto variegata. Si inizia con dei brani di chitarra o arpa
di un cantautore bolognese. Da solo - come spiega anche
in una canzone – perché il suo percussionista senegalese è stato rinchiuso in un C.P.T. Dopo la Control Unit,
chiudono i Two Moons, che sono in tre ed occupano il
palco in vestiti scuri ed un paio di mele-Mac ostentate
ad un pubblico decisamente troppo pettinato, ormai. La
loro musica è una sorta di Depeche Mode in versione
digitale, con tutti i teatralismi e pigli da poseur che ne
derivano. Lo spettatore più eclettico è confuso pure lui.
Leonardo Amico
Fausto Rossi
C aracol , P isa (26 M arzo )
Prima del concerto la serata prevede un incontro tra
Fausto Rossi e il pubblico: è l' occasione per fare luce
sui passaggi recenti della sua carriera, in particolare sulla
svolta, dopo un silenzio discografico più che decennale,
verso una scarna veste folk blues con testi in inglese.
L'artista un tempo noto come Faust'o spiega che un
disco così diverso dai suoi pur mutevoli standard è stato
un modo per liberarsi dell'ombra di Exit, che di quella seconda fase (nella quale l'invettiva dolente aveva scacciato
dal menù l'ironia che era stata di Suicidio e immediati
successori), era stato punta estrema.
Quello è uno dei pochi dischi miei che ancora riesco ad
ascoltare volentieri, aggiunge e, infatti, il passaggio dall'in-
Fausto Rossi
tervista all'incontro avviene mediante la lettura dell'invettiva Blues, climax emotivo di Exit dalle parole crude e
provocatorie (come quelle dell'altro brano letto, l'autodifesa di Manson) la cui violenza viene esaltata dal tono
pacato e quasi dimesso del recitato.
La scelta di mettere in evidenza quel testo è il segno
di una continuità nella differenza, che si vede anche nel
modo pacifico in cui le canzoni dell'ultimo Becoming Visible convivono con un paio di inediti e il resto di una
scaletta che pesca esclusivamente dai suoi anni '90 e in
quello in cui queste ultime, nate ancora con una vaga
impronta new wave e vicine a certi cupi episodi dei Violent Femmes, si lasciano riportare al mood sommesso
della serata.
Per quella parte di pubblico che non aveva seguito gli
sviluppi musicali del cantante successivi agli anni d'oro
è stato un modo per scoprire che il Faust'o dall'ironia
nevrotica è scomparso da tempo, ma che la strada dei
compromessi zero non ha mai subito deviazioni.
Giulio Pasquali
Le luci della centrale elettrica
teatro duse , B ologna (7A prile )
Che la si ascolti in forma di demo, su disco ufficiale, dal
vivo con le chitarre elettriche di Giorgio Canali o accompagnata da un terzetto d'archi come in questo caso, la
canzone d'autore di Vasco Brondi rimane una questione tra l'autore e l'autore. Un modulo comunicativo voce/
chitarra poco propenso alla conversazione creativa e che
riserva spesso alla musica che gli sta attorno un ruolo
prevalentemente descrittivo. Poi c'è il caso particolare di
questo concerto: poteva essere una buona occasione per
una contaminazione interessante tra due mondi agli antipodi – il classicismo degli archi e le ruvidezze nichiliste
del cantato - e invece tutto si riduce a un accatastarsi di
livelli senza uno spartito corale che organizzi i contenuti
in maniera significativa. Con il violino di Rodrigo D'erasmo, il contrabbasso di Stefano Pilia e il violoncello di
Guglielmo Ridolfo Gagliano a perdersi in un tappeto
noise di effetti capace di alzare i volumi nei momenti di
catarsi ma poco propenso all'arrangiamento elaborato
(fatta eccezione, forse, per la sola Sere feriali).
Contenuti di valore filtrati da una poetica peculiare,
qualche caduta di tono, ma soprattutto un'occasione per
riflettere sulla "durabilità” del progetto Le luci della
centrale elettrica. La verità, se escludiamo le convergenze obbligate con lo zoccolo duro dei fans perennemente – e acriticamente – in sintonia con l'estremismo
verbale da generazione zero del Brondi, è che ultimamente viene inevitabilmente da porsi qualche domanda.
Anche perchè nel giro di due anni la carica impulsiva del
messaggio è deflagrata, ha fatto vittime eccellenti e non
(noi compresi) ed è scemata, in favore un immaginario
che impressiona ancora, pur offrendo il fianco anche a
una certa retorica. Dovrà faticare non poco il titolare
del progetto per uscire dallo stereotipo del cantore da
quartiere popolare che si è ritagliato in questi anni, nonostante le boccate d'ossigeno che le parentesi di reading
– ma i Massimo Volume sono un'altra cosa - sembrano
garantire al set.
La cronaca dell'evento si riduce a un paio di momenti particolarmente riusciti: una conclusione di concerto
con i musicisti a suonare in platea circondati dal pubblico
e una cover del De Andrè de La domenica delle Salme irriconoscibile e “brondizzata” a dovere. Il resto è una buona introduzione per i neofiti e un Vasco Brondi al solito
generoso e umile di fronte al suo pubblico. Con buona
pace dei diciassette/venti euro spesi dalla maggior parte
dei presenti.
Fabrizio Zampighi
87
Gimme Some
Inches #5
Maggio è il ritorno dei grossi calibri.
Edizioni grandi e piccole per Mi Ami,
Fuck Buttons, Blank Dogs,These Are Powers, Aa, Japandroids e molti altri.
Dopo il mese dello split, a Gimme Some Inches arrivano i grossi
calibri. Alcuni con vinili apripista per
i nuovi lavori, altri così, tanto per dimostrare l’amore per i pezzi piccoli,
duttili e maneggevoli. E allora via con
i giri di vinile.
A 33 girano i primi 12”, in primis
i newyorchesi Aa, da noi e non solo,
con Glossy, gioco di parole tra la
Glow Wreath del lato A e la Mossy
del lato B, che ci confidano essere
solo il primo di una serie di 12” di
prossima pubblicazione. Un paio di
spiazzanti minuti di synth volatili e
lievi e poi via, si riparte di sarabanda
tribaloide quartomondista con un
lieve ma significativo scarto rispetto
ai dischi precedenti: l’ambientazione
è molto meno aggressiva e muscolare e il focus è la melodia vocale,
coralmente straniante sul lato A e
hypno-stranita su quello opposto.
Bel modo di far fruttare quelle che
da lontano sembrano pause di riflessione.
88
Altro giro e altri campioncini del
sottobosco a stelle&strisce. Non paghi di aver appena rilasciato l’ottimo
comeback Steal Your Face, i Mi Ami
pubblicano Towers Fall via Hoss
Recs e sorpresa: abbandonano i lidi
post-punk-funk e vanno di techno.
Una techno alla Mi Ami in cui a farla
da padrone è una dilatazione degli
spazi sonori virata sull’ossessivo con
un taglio black-acid non da poco. Le
percussioni distorte del Cassette
Mix del lato B creano cortocircuiti
probabilissimi e fascinosi tra periferie di Lagos e acida meccanicità chicagoana. Promossi.
Per due ottime conferme, una
mezza delusione. Sempre USA per
il 12” che vede protagonisti i These
Are Powers: Candyman, su RVNG
Int’l e introdotto da un video disponibile online, non convince affatto. La
“svolta” electro di All Aboard Future e il virare verso il digitale sono
ok, eppure nelle tre tracce originali (più due remix che amplificano i
bpm) l’impasto di rumori industriali
e voce simil-M.I.A. di Anna Barie decolla solo a tratti (la title track, e non
sempre). Leggete altrove di un 12”
targato Blank Dogs, ma dato che di
ritorni si tratta non poteva mancare
mr. Sniper su GSI. Per l’etichetta di
casa Captured Tracks, esce una cassettina limited con due pezzi, Leaves
e Carry It Well che non aggiungono
quasi nulla al noto (lo-fi pop songs
dai toni goth), se non fomentare ancor di più l’hype sotterraneo, cosa in
cui BD è maestro da sempre.
Nell’attesa del primo vagito da
This Is Happening di LCD Soundsystem, accontentiamoci di altri
due pezzi grossi. In primis, anche soltanto per i nomi dei remixers che
si porta dietro, Olympians, 12” dei
Fuck Buttons che oltre alla versione
presente su Tarot Sport aggiunge
due rivisitazioni targate nientemeno che J. Spaceman aka Jason Pierce
(Spacemen 3/Spiritualized) e Alan
Vega (Suicide). Cinque diverse edizioni per ognuno dei colori dei cerchi olimpici e due chicchette che impreziosiscono l’originale Olympians
(stranamente bucolico e pastorale il
mix dell’ex Spacemen 3, ovviamente
ipnotico e paranoico quello di Vega).
Poi Art Czars, formato piccolo che
introduce No Singles dei Japan-
droids, duo dalle belle prospettive in
ambito rock NoAgeiano. Il self-titled
sul lato A, vergato sull’equazione
melodia+potenza=anthem del duo
californiano, riporta alla mente i sottovalutati eroi del chitarra/batteria
Death From Above 1979; la Racer-X
del lato B, inaspettata cover dei Big
Black, gioca tutto di stop&go chirurgici e distorsioni di chitarra per immolarsi al dio del rumore, mr. Steve
Albini.
Nuovo mini di sei pezzi anche
per i Fresh & Onlys con cui il blasonato combo di Frisco vira dalle ballate folk di Grey-Eyed Girls verso il
cuore pop degli ultimi tre lustri. Le
citazioni Echo & the Bunnymen in
You're Known To Wander e Another
Sunny Day in Dreaming Is Easy dicono di uno sguardo al pop-punk più
emotivo degli '80 e primi '90, mentre la lezione sotterranea del Paisley tinge le trame della title-track
August In My Mind di tenue psichedelia. Come suggerisce il titolo, una
manciata di brani per festeggiare
l'arrivo della bella stagione. Ritornano in pista anche gli Psychedelic
Horseshit, artefici della famigerata
etichetta shit-gaze che terrorizzò le
board di mezzo mondo un paio di
anni fa, con una tape fresca di stampa
in cui muovono dal bagno di sangue
di feedback che fu Magic Flowers
Droned in favore di una manciata di
pezzi vagamente più intimi. Sempre
registrazioni a fedeltà sotto zero
per i drogati di Columbus, ma brani
meno esplicitamente violenti; come
l’elettronica ultra cheap dal sapore
tropicale di Modern Daze, il dub
scarno di Hard As It Gets e il folk
zoppo di Bleak Vacations. Insomma,
come cercare di andare avanti con i
tre strumenti (scassati) che si hanno
in mano.
Gettando uno sguardo al Vecchio
Continente troviamo ancora un
volta attiva l’olandese Enfant Terrible; già da un paio di mesi la label,
guida del panorama electro-wave
europeo, ha rilasciato il singolo di
debutto di un progetto autoctono a
nome di Distel. Le tracce che occupano i due lati del 7 pollici parlano
un freddo idioma caro a etichette
come Galakthorrö e Basic Channel;
i tecnici lo chiamano angstpop, ma
potremmo semplicemente definirla
elettronica minimale e oscura, sorretta da beat ultra scarni e sussurranti voci effettate. Una paio di cartoline da un mondo algido e avulso
dal caos cui siamo avvezzi. Restando
in ambiti synthetici, segnaliamo la
cassetta split tra Death Domain (dei
cui due singoli già parlammo qualche
numero fa) e High Marks uscita nel
2008 su Chicago On A Spree e oggi
ristampata da Campaign For Infinity.
I due partecipanti si sfidano a colpi di oscure trame sonore, ritmiche
robotiche e vocalizzi goticheggianti; difficile stabilire un vincitore ma
poco importa: i fan dell’elettronica
più mortifera sanno già cosa aspettarsi.
Stefano Pifferi, Andrea Napoli
89
Re-Boot
#4
S tupori , sorprese e
( false ) redenzioni
Rieccoci al nostro giro d'Italia in
cerca di cose nuove, di ruspanti proposte dal basso, di ruggenti emergenti più o meno pronti per il grande
salto. Eh, sì. Ci sono nuove proposte
e nuove proposte. Alcune nascono
già incamiciate da un background
che regala loro buona produzione,
etichetta scafata e sapiente promozione. E' il caso dei Fonokit, ovvero
la nuova avventura di Marco Ancona,
già leader dei salentini Bludinvidia.
Così questo Amore o Purgatorio
(Fondazione Sonora, 6.8/10) viene
sontuosamente lanciato come "la
redenzione dell'indie italiano". Questione di slogan pubblicitari, certo.
Intanto però una bella tensione sostiene le 13 tracce, emotivamente
sostenute e sufficientemente scorbutiche, diciamo una post-wave
innestata da qualche parte tra Afterhours e Subsonica. Nessuna
redenzione, ok, ma bella personalità.
Poi ci sono quelli che ancora
cercano e soprattutto si cercano,
come il toscano (di Prato) Un Incoerente Come Tanti. In questo
90
Un mese di ascolti
emergenti italiani
Dettagli Marginali (autoprodotto,
6.9/10) il Nostro sembra una probabile via di mezzo tra Luca Carboni
e Le Luci Della Centrale Elettrica, vale a dire testi disarmanti su
melodie indolenzite, una certa furia
tenuta al guinzaglio tipica di chi è
abituato ad usare più l'abbraccio che
il pugno. Rispetto al precedente Il
pianobar ai giardinetti è netto il
riflusso verso la forma canzone, italianamente intesa e dignitosamente
realizzata, condita dal vizio della genuinità. Bene così. E che dire di quelli che ti prendono alla sprovvista?
Gente tipo Le Visioni di Cody col
loro cantautorato rock strisciante
e mutevole. Trattasi di band toscoromagnola giunta al secondo lavoro
con Écrasez l'Infâme! (Collapse
Records, 7.2/10), album - disponibile
in free download - che in sostanza
deve il proprio immaginario a quanto sperimentato nei concerti-performance dello spettacolo teatrale
L'infame. Raramente capita di imbattersi in una marginalità tanto ricca e
intensa: vedi dove può portare l’ennesima elucubrazione di tradizioni
melodiche e perturbazioni post,
devozioni CSI e fregole arty pescate
tra sixties e new wave. Nuovo disco
in preparazione. Stiamoci attenti. E
proseguiamo.
L'immaginario di Zibba e gli
Almalibre è grossomodo quello
di Vinicio Capossela, tra bicchieri
che brindano e bande di paese, storie di strada e musica d'autore. Con
in più un'attenzione particolare per
quelli che del Capossela pensiero
sono - o potrebbero essere - i principali referenti: il Tom Waits funkblues di Dauntaun, il Paolo Conte
di Bon Voyage, l'Ivano Fossati di
L'odore dei treni, il Finardi di Quattro
notti. In parole povere, ciò che serve
a Una cura per il freddo (Cramps, 6.7/10) per farsi considerare dai
salotti buoni del Premio Tenco, con
le cinture di sicurezza ben allacciate
e una velocità di crociera costante.
Discorso diverso per gli emiliani
Phono Emergency Tool, che già ci
avevano convinti ai tempi dell'omonimo esordio e che con Get Lost
(autoprodotto, 7.3/10) rinnovano la
fiducia accordata loro. A dirimere
i punti interrogativi dei più scettici
un'esplosione di chitarre Pavement
(Get Lost), stramberie in stile Robyn
Hitchcock/Beck (Strange) e una
vena pop che cita gli XTC mirando
nel contempo a una melodia obliqua
dal gusto sopraffino. Stupisce non
poco vedere un gruppo con queste
potenzialità non rientrare ancora
nel roster di qualche etichetta lungimirante. Restiamo in attesa, convinti
di un imminente mea culpa.
Stesso discorso anche per i bolognesi What Contemporary
Means, che invece qualche contatto
con le scene che contano devono
averlo, almeno a giudicare dai ringraziamenti a Paolo Torregiani e Alessandro Scagliarini dei My Awesome
Mixtape che leggiamo tra i crediti
del loro Deceive Ep (autoprodotto, 7.2/10). Sia come sia, il quintetto
lavora di cesello tra post-rock, jazz,
math, riuscendo a suonare raffinato
ed energico al tempo stesso grazie
a una buona varietà nelle geometrie e a un'indole pop che ricorda,
tra i tanti, i Death Cab For Cutie.
Cambiamo scenario: Paolo Iafelice
in cabina di regia (Pacifico, De André) e un'attitudine alla mescolanza
che coinvolge una fetta del panthe-
on cantautorale italiano dai settanta
ad oggi: gli Etnia Supersantos di
Arlecchino Cinema (Adesiva Discografica, 6.5/10) impastano con
perizia strumentale jazz, rocksteady,
reggae, folk, dondolamenti elettroacustici e tanto funky, che in Butta la
chiave risulta addirittura più credibile della recenti sbandate silvestriane.
Più personalità nella scrittura e questo combo diverrà un fiero difensore della canzone(tta) con coraggio
zappiano, piglio ironico, freschezza
ultrapop.
E pop, ma virate su coordinate sintetiche e wave, sono anche le cinque
tracce de L'amore e La Filosofia
ep (6.8/10) dei MasCara. Gli U2 di
Achtung Babies in Andromeda, l'alterità vocale dei primi Diaframma
in Fiore del male e una buona capacità nel disegnare traiettorie rotonde su liriche cantautorali fanno dei
varesini una convincente filiazione di
Garbo. Ottimi quando ne Il Gesto di
Ettore rivalutano i Coldplay in saliscendi crepuscolari, da rivedere nei
dosaggi acustici della title-track. Ma
se di azzardi pop vogliamo trattare
difficile non menzionare L'Emote-
rapia (Grezzissimo Productions,
7.0/10) di Trivo. Sotterraneamente
diffuse da due anni a queste parte,
le canzoni del cantautore foggiano
sono ciò che farebbe Lynch se scrivesse musica: tastierame acidamente
appiccicoso ed evocativo, rumorismi
in settaggio casio, urlacci e malinconie alla Daniele Brusaschetto via
Beck in Ho bisogno di qualcosa di cui
non ho bisogno. Tanta follia verrà premiata ricalibrandone tutte le derive
eccessivamente sfilacciate, ma qui
c'è molto di buono.
Ci rimettiamo in ascolto. Alla
prossima.
Fabrizio Zampighi,
Stefano Solventi,
Luca Barachetti
91
Rearview Mirror
—ristampe
highlight
AA.VV. - The Afrosound Of Colombia (Vampisoul, Maggio 2010)
G enere : afro l atino
2+2=5 - Into The Future... (Spittle,
Aprile 2010)
Genere: goth-post punk
Un'altra storia tipica, di quell'Italia dei primi anni '80
di cui la Spittle sta facendo un atlante (o un archivio, è
da discutere). È la vicenda dei milanesi Nino La Loggia,
Giacomo Spazio, prima, e anche di Cha-Cha Hagiwara,
dopo. Frequentatori del Bar Concordia, e protagonisti
del passaggio nella metropoli del Nord dal punk al post
punk, con oscuramento complessivo delle atmosfere.
Nino all'elettronica, Giacomo ai visuals e testi, poi anche Cha-Cha alle tastiere. Combo ideale per mimare
- pur con una capacità di sintesi mai caricaturale - le
vicende musicali inglesi e tedesche, dai primissimi Cabaret Voltaire a primi Ultravox, da D.A.F. al gothico
più androide. Estetiche che ricordano anche i radicali
dell'architettura degli anni Sessanta - immaginateli velati da cupezza, filtrati da dei Kraftwerk senza elemento ludico, per certi versi, e vi ritroverete versi come
"Computer is a brain's
extension", o "Meeting
Electric
Baby
Tv
", tradotti nel booklet anche in
italiano.
Into The Future..., l'esordio
dei 2+2=5 datato 1983,
che in questa ristampa
include due bonus track
- Guangzhou (tratta dalla compilation F/Ear This!, del
1986) e Incontrando Mc.L. (tratta dalla compilation in
cassetta della fanzine Zero Zero) - è quasi un concept
sulla vita metropolitana - e sul quotidiano, e ancora risuonano i radicali. In questo troviamo il suo aspetto
più convincente. Si respirano le strade umbratili ma
92
elettriche piene di tram e notte. Fuor di metafora, si
sente una convergenza e un'immedesimazione tra città
e uomo. Con esiti forse non euforici, ma fortemente
espressivi.(7/10)
Gaspare Caliri
AA.VV. - Next Stop
Soweto Vol. 2:
Soul, Funk & Organ Grooves From The
Townships 1969-1976 (Strut Records,
Maggio 2010)
Genere: African funk
Con certi dischi basta leggere l'etichetta e subito ogni
cosa è chiara come il sole
o quasi: al secondo volume di pepite provenienti
da anni in cui il Sud Africa era ancora prigioniero dell'apartheid, la Strut
spulcia tra i devoti di funk,
soul ed errebì. Di una musica d'importazione americana che, guarda un po', rintracciava la propria genesi
giustappunto in Africa ed ecco un cerchio che si chiude. Nonostante l'ostracismo governativo, nacque in tal
modo una piccola ma florida scena, per quanto non
sempre capace di riappropriarsi del suono di Fratelli che, al di là dell'Atlantico, facevano di nome James
Brown, Meters, Booker T.
Dunque spetta a chi fonde e mescola i prestigiosi modelli con la propria realtà convincere: Mgababa Queens, J.K. Mayengar & The Shingwedzi Sisters,
Soul Throbs e Mahotella Queens scuotono membra e cervello e rimandano Talking Heads, Specials
e Can là dove tutto ha avuto origine. Soprattutto esal-
Elefantiaco, il nuovo scavo dei madrileni: oltre due ore e mezza tratta dagli archivi dell'etichetta colombiana
Discos Fuentes tra '60 e '70. La solita roba, direte, non senza ragione, considerando il fatto che - la pubblicità
è l'anima del commercio - il comunicato stampa la racconta come "seminale". Vero se è solo del contesto
locale che si parla, benché il calderone di generi dispiegato sia garanzia di divertimento e invito a danze sfrenate: salsa, cumbia, boogaloo e tropical-funk pronti a servirvi. Con l'ovvia alternanza tra artigianato di fattura
ottima (robuste chitarre rock che fanno capolino, funk ben amalgamato), curiosità novelty (cavalcare di mode
tra garage, modernismo easy listening e occasionale demenza) e porcate (certi moog da rabbrividire
) ma in
misura minore dell'usuale.
Sta proprio nella solidità la forza di una raccolta con l'ulteriore merito di far riflettere sul concetto di contaminazione culturale: nello specifico drammatica, poiché la tradizione degli schiavi
africani fu innestata a forza sul già violento rapporto tra colonizzatori europei
e cultura autoctona; in tale panorama, il trauma successivo sarà il passaggio dal
sistema della piantagione alle metropoli. Tuttavia, a Medellín e Bogotá non trovavi solo raffinerie di polvere bianca, ma pure un'industria discografica in cui il
marchio di "Fruko" Estrada ricopriva un ruolo rilevante, spesso affacciato sui
Caraibi - Cuba in particolare - a trarre ispirazione. Lo dimostrano quarantatre
tracce con poca zavorra, irresistibili da mandare il cinismo del critico a farsi benedire. Anzi, a bailar!(7/10)
Giancarlo Turra
tano Gibson Kente e la sua Saduva, nemmeno tre minuti di funk sciacquato nell'acido lisergico che vorresti
protratto all'infinito. Escluse tali favolose eccezioni, lungo un'ora abbondante ci si stupisce meno dell'usuale
e nondimeno si gode spesso e volentieri. Impossibile
avere di meglio, in attesa del terzo tomo incentrato sul
jazz del periodo 1960-1978. Non stiamo già nella pelle
(nera)
(7/10)
Giancarlo Turra
Conformists (The) - Three Hundreds
(Africantape, Aprile 2010)
Genere: noise-rock
Ristampa per questo classico minore del noise-rock
americano a qualche anno di distanza dalla release originale su 54° 40' Or Fight. I Conformists, tutt'altro che
in tono col nome che si sono scelti, sono piuttosto restii
a conformarsi coi canoni di genere e procedono spesso
per contrasto, andando di secchezza (quasi scheletrica
nei suoni) e minimalismo (nella fase creativa), tanto che
non è casuale che Steve
Albini abbia offerto loro la
propria maestranza dietro
la consolle.
Poco propensi a socializzare o sembrare accomodanti (you might like them
you
might not, recita laconicamente la loro press-sheet)
mostrano un non deprecabile noise-rock innervato di
stralci post-rock louisvilliani, minimale ed stilizzato, tutto angoli spigolosi e curve a gomito a livello ritmico e
melodicamente annoiato e disilluso. Un disco dai connotati oscuri, a volte impenetrabile nella cortina fumogena
di ansia repressa e asperità shellacchiane (Tax Reduction)
o negli slanci avant-rock sghembi e malsani (A.S.M.M.C.).
Three Hundreds è dissonante e disturbante, ma risulta per forza di cose un po' datato. Vedremo se i 4 sapranno aggiornarsi; per ora accontentiamoci.(6.5/10)
Stefano Pifferi
93
Illogico - Requisiti (Spittle, Aprile
2010)
Genere: funk-jazz-postpunk
Gli Illogico furono una band romana che non ebbe
modo di farsi molto notare all'epoca - allo stesso modo
di altre realtà capitoline. Ciò nonostante in Requisiti - cassetta registrata nel 1984 e ora rimasterizzata
e pubblicata dalla solita Spittle - non si sente il solito
provincialismo pedissequo a cui, per quantità, ci stiamo
abituando, in mezzo all'operazione di recupero delle
opere nostrane post-punk.
Mogadiscio, con cui l'album si apre, scoperchia un uso
del jazz-funk che non adagia il primo sulle dissonanze alla James Chance (che ci aspetteremmo) ma a
costumi più vicini all'hardbop, e a una stratificazione
dei fiati che ci sembra parecchio azzeccata. L'optimum si raggiunge quando
sax e tromboni sornioni
(e non solo i soliti sax) si
spalmano su strutture in
tutto e per tutto Talking
Heads-iane. E di fatto questa è la formula - con la voce
di Antonio Amendola del tutto figlia del suo tempo, e
dell'insegnamento di David Byrne (ma spassosissimo
anche il coro femminin-robotico di Africani Gemiti).
La scuola jazz - oggi ce ne rendiamo conto - alza di una
spanna l'esito della creatività degli Illogico: stupefacente 871-Zx, con una decostruzione del riff che nel rock
più colto sarebbe stata acquisizione successiva.Vale una
menzione, oltre che nel catalogo Spittle, nello spirito
di quei tempi. Un milieu ricchissimo condensato in un
solo brano. Niente che procuri nostalgia, ma un appiglio
per mettere in moto il ragionamento.(7/10)
Gaspare Caliri
James Chance - The Fix Is In (Le Son
Du Maquis, Febbraio 2010)
Genere: jazz
Mistero sul nuovo James Chance? Nient'affatto, The
Fix Is In è solo una riedizione - formalmente a nome
James Chance & The Terminal City - di quel Get
Down And Dirty del 2006, stampato a suo tempo
dalla Winfd Bell, in Giappone, e poco frequentato dalle
nostre parti. Sembra comunque un disco del tutto nuovo, e ha quanto basta per fare notizia, specie a causa del
DVD di bonus con 24 minuti tratti dalla vita di Chance/
White e dal concerto the suoi Contorsions all'ATP
che fu curato da Vincent Gallo, nel 2005.
Il primo commento è un non commento. Le stecche
94
alla voce di Blonde Ice, su
tappeto di facile ascolto,
non mettono più in moto
quella ricerca critica e quel
ragionamento che prova a
scavare e andarci sotto. E
da lì la chiave potrebbe restare la stessa per tutto il
disco. Il mostro della no wave, uno dei suoi geni, con la
scusa di suonare, con un settetto, un omaggio alle sue
origini, un po' be-bop, realizza cose molto più vicine alla
lounge e al grottesco.
Prendiamo la title-track, la facilità del tema su cui il combo imbastisce per otto minuti la cavalcata hard-bop da
piano bar. Il canto di James è più convincente quando
diventa urlo e latrato, ovviamente trovando il meglio di
sè. Ci accorgiamo, poi, scoprendo l'acqua calda, che alla
fine ciò che ci piace di più è il sax free alla Albert Ayler che cerca di fuggire, pur facendo finta di trovarsi a
proprio agio; ricerchiamo sempre la dissonanza, la freakeria (in senso letterale: l'abnormità del suono) e non il
ludico divertimento intellettuale che sembra suggerire
questo disco. Che, a conti fatti, si basa sulla linearità, finendo con il lasciare un ricordo un po' tiepido.(6/10)
Gaspare Caliri
Jon Spencer Blues Explosion - Dirty
Shirt Rock 'N' Roll: The First Ten
Years (Shout! Factory, Aprile 2010)
Genere: r'n'r
Tempo di celebrazioni per Jon Spencer e la sua banda di
squilibrati. Dopo un pluriennale silenzio rotto solo dalla Jukebox Explosion targata In The Red, ad aprire la
strada ad una cospicua serie di ristampe in modalità deluxe è ora Dirty Shirt Rock'n'Roll, compilation che,
come da sottotitolo, pesca in maniera a-cronologica dal
primo decennio della Blues Explosion. Chi segue le vicende dell'ex reietto del rock-made-in-Pussy-Galore,
saprà benissimo come e quali trasformazioni abbia avuto il sound della Blues Explosion dalle prime efferatezze
in lo-fi del periodo Crypt alle contaminazioni hip-hopsoul-black patinate e glamour degli ultimi album. Ma le
22 perle infilzate in questa
collana di depravazioni e
massacri sonori sul corpo
morto del rock, non fanno
una grinza che sia una.
Scorazzando in avanti o indietro come niente fosse
nella prima decina d'anni
della JSBX a emergere è
sempre quel dissacrante e fascinoso mix di verve giovanile e velleità sperimentali, crudezze rock'n'roll e viscerale amore per quella primigenia forma di musica che è
il blues. Non a caso la musica del diavolo, uno che come
ci insegna il cinema, veste elegante; esattamente come
il qui presente Jon Spencer, chioma fluente e charme da
patto col demonio.
In Dirty Shirt Rock'n'Roll non troverete nulla di
nuovo, fatta eccezione per qualche radio edit o qualche
rarità (ma nemmeno troppo) sparsa qua e là. Non rimarrete però delusi dalla copiosa scaletta in programma perché è la dimostrazione vivente della capacità del
trio e soprattutto del suo frontman di muoversi ora
felpato, ora ruggente, ma sempre eclettico e trasversale
tra blues, r'n'r, soul e contaminazioni varie.(7/10)
incerto se seguire - un repertorio già prezioso di Me
And Bobby McGee, Come Sundown, Border Lord - Leonard Cohen o Hank Williams, Waylon Jennings o
Johnny Cash. Il resto lo spiegano il sontuoso libretto
di sessanta pagine, pieno di interviste e testimonianze, e l'apparato iconografico. Studiosi e curiosi avranno
pane per i loro denti, tutti gli altri un pugno di canzoni
sincere, belle e ancora un poco grezze.(7/10)
Giancarlo Turra
Stefano Pifferi
Kris Kristofferson - Please
Don't Tell Me The Story Ends: The
Publishing Demos 1968-72 (Light In
The Attic Records, Maggio 2010)
Genere: cantautorato USA
Un progetto che ha portato via ben cinque anni alla
Light In The Attic, casa tra le più valide nel campo delle ristampe. In occasione della cinquantesima uscita ha
contattato Kris Kristofferson per compilare una raccolta di suoi demo risalenti alla fine dei '60 e ai primi
'70, allorquando nell'aria avvertivi il riflusso della controcultura e quest'ultima si frantumava contro la dura
realtà. Ne sarebbe scaturita la reazione di un cantautorato introspettivo che per un po' si imporrà sulla
dimensione della band e anche lì sta il senso di questa
quindicina di brani che indagano su un autore in bilico
tra culto e celebrità.
Del quale, in fondo, definisci imperdibile come "classico di genere" solo l'esordio Kristofferson datato 1970,
noto anche come Me And Bobby McGee come la canzone immortalata l'anno seguente da Janis Joplin e ivi
contenuta. Resta la cosa migliore di questo ragazzone
dalla vita che più americana non potrebbe, studioso di
letteratura, pugile e militare di carriera finché qualcuno
non si accorse di lui. Tra un disco e l'altro diventerà un
attore non disprezzabile,
sempre seguendo quel che
il cuore gli dettava e ciò
basterebbe a ritagliare per
lui un cantuccio nel cuore
e metterci l'album di cui
sopra.
Qui è ai primi passi, volenteroso e piacevolmente
95
Rearview Mirror
—speciale
"I n
the end , nothing beats volume and
lights and drunken people .
just have to sound cool "
Pixies
erte cose si colgono nell'aria. Ammesso d'averne
la fortuna, l'abilità, l'istinto e in ultimo la risoluta
volontà di farlo. A Charles Michael Kitridge Thompson
IV non mancò nessuno di questi fattori, così colse ciò
che doveva cogliere. Aveva vent'anni, in quel 1985. Era di
Boston ma da sei mesi risiedeva a San Juan, in Portorico.
Studente della Amherst University of Massachusetts, non
si era lasciato sfuggire l'opportunità di un corso lontano
da casa, dove avrebbe perfezionato il proprio spagnolo e
nel frattempo dato una scossa alla propria esistenza. Ma
la scossa non arrivò, anzi. Dopo sei mesi, con la prospettiva di altri sei da trascorrere in quel cul de sac caraibico,
capì di trovarsi ad un bivio. Con una certezza a pungolargli il cuore: quello che più desiderava era formare una
rock band.
Ok, ma cosa colse esattamente nell'aria il buon Charles? Per quale motivo era disposto a mandare in fumo i
propri studi, la propria vita per mettere su una band? Possiamo solo permetterci delle supposizioni che le vicende
successive contribuiranno ad irrobustire: Charles aveva
realizzato che il senso di vuoto in cui oramai galleggiava
sarebbe stato spazzato via da uno spasmo vitale del tipo
che solo il rock'n'roll sa dare, e che quello stesso vuoto
era un problema generazionale che richiedeva analoga
terapia. Una medicina di cui però da un po' di tempo
erano andate perdute la formula e l'arte. E l'abitudine.
Ecco una dichiarazione illuminante che Charles rilascerà
qualche anno più tardi: "MTV è inondata da tutto questo
falso hard rock ed heavy metal. Da dove spuntano tutte queste band? Spuntano dal nulla e sono del tutto sprovvedute.
Non è certo la loro mancanza di coraggio che mi preoccupa,
né la loro musica. E' il loro abbigliamento del cazzo che non
riesco a sopportare!". Poteva ben dirlo lui, un "normal guy"
col rock sempre fumante nella fondina.
Quella squinternata ultima utopia
96
songs
C
R oba
Una band storicamente necessaria, musicalmente imprescindibile, così poco celebre rispetto a chi ha fatto
tesoro della sua lezione. I Pixies da Boston, antieroi
cazzoni dei tardi eighties.
T he
Testo: Stefano Solventi
for te
Nel bel mezzo degli anni ottanta, ancora scossi e a dirla tutta estasiati dall'avvento della videomusica, non c'era
stato il tempo di scavare le trincee tra rock mainstream
e cosiddetto alternativo. La stampa per prima cavalcava
l'onda edonistica: ad esempio, sostenendo che poseur
come i Bon Jovi rappresentavano "i nuovi Led Zeppelin". E' vero, credeteci: chi scrive l'ha letto coi suoi occhi
un triste giorno su una triste rivista. Esisteva - certo - un
rock più "autentico", idealmente opposto a quello caciarone offerto senza risparmio di acconciature e mise in
similpelle. Sempre su MTV ad esempio impazzavano gli
Springsteen e gli U2, portavoce di un rock che sembrava
recuperare il polso della situazione come qualche lustro
prima. Ma non era certo in personaggi come loro che
Charles riponeva le proprie speranze: non era tipo da
perorazioni, da terre promesse, da denunce e rimpianti sociopolitici, da canzoni che si facessero portavoce e
soundtrack di istanze generazionali.
Quanto all'underground, con internet ancora lontano da venire era veramente underground, un fenomeno spesso locale, difficile da organizzare in scene che ne
esaltassero la visibilità. Era quindi molto probabile che
in molti scambiassero quella dei video come la principale se non l'unica modalità rock esistente.Una modalità
dannatamente priva di quella scossa, di quel fremito che
Charles e chi come lui andava cercando: un rock che arrivasse come uno scapaccione facendoti esclamare "ehi,
forte questa roba!". Charles non era tipo da stendere manifesti o elucubrare teorie, però qualche idea ce l'aveva
eccome. Intanto, c'era la questione della band. Per costituirla, bisognava scegliere tra persone fidate.
Rientrato a Boston, strinse d'assedio l'ex compagno di stanza all'università Joey Santiago finché non lo
convinse ad imbarcarsi nel progetto. Andava sul sicuro,
Charles, che con Joey aveva condiviso i primi tentativi di
strimpellare chitarre e inquieti sogni di rock'n'roll. Per
entrambi le esperienze nel ramo erano, per così dire,
trascurabili. Charles aveva frequentato cover band dedite perlopiù alla soul music. Il buon Joey non aveva certo
un curriculum più robusto, ma poteva dirsi musicalmente più scafato: originario delle Filippine, era cresciuto nel
mito beatlesiano grazie alla discoteca dei genitori, quindi
una volta emigrato negli States - la famiglia non era ben
vista dal regime di Marcos - maturò la propensione psichedelica verso lo spacey-glam dei settanta approdando
al punk e alla new-wave. L'entusiasmo febbrile di Charles
e la flemma balzana di Joey rappresentavano un'accoppiata niente male: in nuce, la band esisteva già.
N omen
omen ?
C'era da pensare al nome, e ci pensò Joey, che nelle
abituarie consultazione di dizionari ed enciclopedie per
migliorare la propria conoscenza dell'inglese s'imbatté
nell'espressione "Pixies In Panoply", rimanendone estasiato. A Charles piacque, anche se propose di abbreviare
in Pixies. E così andò. Un'aneddoto illuminante. Infatti,
cos'è un nome? Nulla, e tutto. Il significato letterale di
pixies - elfi, folletti - ha poco a che vedere con quello
che la band sarà (la sua estetica, la sua poetica), eppure
contiene quella dose di mistero e bizzarria, di inesplicabile e sfacciato, di insensato e profondo che ne informerà tutta la produzione. Non c'è nulla da spiegare né da
interpretare, così è perché così è andata. E forse così
97
98
doveva andare. Una combinazione colta al volo, nell'aria.
Un nome: inezia così importante che lo stesso Charles decise di ribattezzarsi per l'occasione, optando per
Black Francis, proprio come suo padre avrebbe chiamato
il prossimo figlio qualora fosse venuto al mondo. Inutile cercare risvolti psicologici, perché in fondo la vera
ragione era che come pseudonimo suonava "divertente
e pomposo come Iggy Pop e Billy Idol". Sulla stessa falsariga di arguto understatement, cosa di meglio che un
annuncio nella bacheca dell'università che recitasse più o
meno: "cercasi bassista con gusti musicali tra Hüsker Dü e
Peter, Paul & Mary". Come dire, tutto e il suo contrario,
melodia al fulmicotone e soffici ballate, il massimo del
rock underground contemporaneo e quei tromboni del
passato, insomma pensate un po' quel che cazzo vi pare.
Kim si rivelò un acquisto azzeccatissimo, anche perché
suggerì David Lovering come batterista. Uno che i tamburi li aveva percossi per troppe band troppo poco originali e si aggrappò senza indugio all'offerta. Oltretutto
Pixies era un nome che gli piaceva parecchio. Oltretutto
aveva un garage in cui la band avrebbe potuto provare.
Correva l'anno 1986. Luglio, per la precisione. C'erano
questi quattro sciagurati con l'idea formidabile di fare
rock'n'roll, un po' alla maniera dei punk: prendi uno strumento e fallo, e della tecnica chi se ne frega. Ma ci davano
dentro. Avevano idee. Il primo show fu un disastro, ma
continuavano a darci dentro. E migliorarono così tanto
che quando toccò loro aprire per i Throwing Muses,
impressionarono un po' tutti, tra cui il produttore Gary
Smith che li invitò a registrare presso i Fort Apache stu-
Si presentò la sola Kim Deal, ed era quella giusta.
La dolce Kimberley da Dayton, Ohio. Una streghetta
da ragazzina, nel senso che era affascinata davvero dalla
stregoneria, ma poi redenta sulla via del folk rock assieme alla sorella, con la quale fondò la prima versione delle
The Breeders. Una tipa pane al pane, brillante ma poco
disposta a raffinatezze. Una che sarà capace di rispondere
al suo intervistatore: "Di norma non faccio cattivi pensieri,
ma negli ultimi cinque minuti sono stata qui seduta pensando
che non c'è niente che mi piacerebbe di più che andare nella
mia camera e fare una gran cagata". La dolce, cara Kim. Si
era sposata con John Murphy poco prima di trasferirsi a
Boston, dove trovò ad attenderla quel famoso annuncio
in bacheca. Neppure aveva con sé il basso, ma la chiamata
era troppo forte. Fu lo stesso Charles/Black Francis a
prestarle i soldi necessari all'acquisto dello strumento.
dios. Tre giorni per diciotto canzoni che andarono a costituire il The Purple Tape.
N uovi
antichi vangeli
Fu il loro lasciapassare per la gloria, se di gloria si potrà
mai parlare. Di colpo si trovarono con un manager (Ken
Goes) e con un'etichetta. Non una a caso, ma la 4AD di
un entusiasta Ivo Watts, che volle fosse subito pubblicato un mini album contenente otto estratti dal nastro
viola. Come On Pilgrim (4AD, ottobre 1987, 7.5/10)
è molto più che un biglietto da visita. Ci spiega molte
cose. Ad esempio come il rock avrebbe dovuto essere
secondo ciò che Charles aveva colto nell'aria. Prendete
ad esempio un pezzo come Caribou: cos'altro è se non
una poltiglia di disagio che da esistenziale si fa escatologico, eppure senza perdersi in menate, enigmatico sbocco
99
principale se non unico di tutto il materiale, non era solo
un cazzone scazzato? La risposta è: sì. Ma non proprio.
Non solo. Aveva le sue ossessioni, i suoi riferimenti, un
humus da coltivare. Il cinema, ad esempio. David Lynch
in particolare: non a caso tra i demo del Purple Tape è
presente una versione di In Heaven, dalla colonna sonora
di Eraserhead. Una vera e propria idolatria sancita dalle parole dello stesso Charles: "Se qualcuno ha avuto una
grande influenza su di me, quello è stato David Lynch. Lui ti
mette davanti una cosa ma non te la spiega. Lui è proprio:
'Questa è un'immagine, questa è un'idea, non è fico?'". Quindi: David Lynch. Grande visionario, tutto un immaginario
legato al macabro, all'assurdo realistico, al sogno come sublimazione del vero.A cui è il caso di aggiungere il retaggio
della formazione cattolica di Charles, opprimente as usual,
da cui gli striscianti riferimenti biblici come il pellegrino
di Levitate Me, ed altri più avanti. Ma sempre senza complicare il peso specifico della proposta, che deve arrivare
semplice e minimale come una scudisciata.
Il
di rabbia che nulla spiega anche se è tutto lì a marcire
alla luce del sole. Chitarre languide e lancinanti che scoritcano memorie anni sessanta, il caracollare psych della
sezione ritmica e la voce che cincischia indolenzita fino
a slabbrarsi in furia punk. Da dove viene quel modo di
cantare? Charles stesso ce lo spiega: dall'Iggy Pop che
s'incendia le adenoidi in Loose e dai Beatles sguaiati di
Oh! Darling. "Questo è vangelo!", sosterrà il buon Charles.
Gran pezzo, Caribou. Ci sono già metà dei Nirvana
di Cobain, lì dentro. Quanto alle altre tracce, delineano
da par loro il concetto pixiesiano di rock melodico, potenzialmente pop ma incapace di sconti, come quella Ed
Is Dead tutta ritornello affabile e tremori nevrastenici,
una Vamos in graffiante controtempo, la febbrile apoteosi masturbatoria dell'impagabile Holyday Song , infine la
trasfigurazione jingle jangle acida di Levitate Me. Musicalmente ci senti sì gli Hüsker Dü ma anche i sixties
di riporto dei Teardrop Explodes, i Velvet Underground più sbrigliati, quei facinorosi dei Fall e l'urticante brio dei Seeds, nonché in filigrana l'aura sguaiata e
sacrale dei Pere Ubu. Quanto alle preveggenze, oltre ai
Nirvana avverti chiaro un antipasto dei Flaming Lips a
cavallo dei novanta, e scusate se è poco.
Certo, ok, ma: com'è possibile? Ma Charles, autore
100
buco
( in
cui vieni risucchiato )
Di tutto ciò Surfer Rosa (4AD, marzo 1988, 7.8/10)
sarà una formidabile conferma. Fu lo stesso Ivo Watts a
suggerire Steve Albini come produttore. C'era bisogno
di aumentare la tensione, di accalappiare la serpe mentre
si dimenava. E andò proprio così: album intriso di situazioni scomode, oppure grottesche, oppure - lynchianamente - macabre, caratterizzato da chitarre che sferzano
l'orecchio anche quando la band sembra giochicchiare
(Broken Face) o azzarda frequenze epiche di taglio wave
(River Euphrates), d'un tratto esplosive laddove pochi secondi prima caracollavano in un brodo sognante, come
in quella Where Is My Mind che non c'è miglior definizione di quella fornitaci dallo stesso Francis Black: "una di
quelle canzoni di Neil Young che aleggiano nell'aria".
Nei testi un campionario di facce tumefatte, di sesso
meccanico e pugni veloci, di centauri teppisti e lune caraibiche, cantato soprattutto da Charles con la nevrastenia
di un invasato senziente. Per una Cactus che raccoglie i
più riposti desideri di un carcerato ("Bloody your hands on
a cactus tree/Wipe it on your dress and send it to me"), c'è
una Gigantic che si fa largo nelle college radio riferendo
di un sogno impertinente di Kim con un tipo superdotato (una bella differenza con - ad esempio - Where the
Streets Have No Name degli U2, no?). La stampa non si
rassegnava però all'idea di un rock tanto intrigante e così
apparentemente disengagee. Charles era letteralmente
assediato da domande del tipo: qual è il senso recondito
di Bone Machine? Cosa simboleggiano gli occhi color del
ghiaccio? Cosa c'è dietro e dentro Surfer Rosa?
Lui si scherniva: "magari cinque parole significano qual-
con la ribellione. Fa parte della cultura di massa ormai. Tutto
è accettabile, nulla è estremo, pericoloso o sovversivo. Niente
che possa spaventare mia madre. Lei ama i Pixies".
Il secondo album Doolittle (4AD, aprile 1989, 8.5/10)
sembra un album concepito per soddisfare l'esigenza di
"diventare celebri come gli U2 ma continuare a sembrare
degli squinternati". E' un lavoro più meditato e costruito
rispetto a Surfer Rosa, ma stiamo parlando pur sempre
dei Pixies. Ragion per cui: quindici tracce di miele e anfetamina, di dolciastra avventatezza e nevrastenici assalti.
Meccanismi assassini dove la dinamica tra le parti gioca
un ruolo decisivo, con gli elementi melodici e gli spasmi
al calor bianco ad alternarsi con primordiale maestria.
La produzione da Gil Norton, già al lavoro con China
Crisis, Throwing Muses ed Echo & The Bunnymen,
sbilancia il sound verso una wave mutante, psicotica, fuori
tempo e in un certo senso deteriorata.
Del resto, il caro Francis-Charles introdusse ingreE sperienze ar tificiali
Siamo già in grado di sostenere che la missione o se dienti disparati sia dal punto di vista atmosferico che
vogliamo l'utopia dei Pixies faceva perno su un tenace contenutistico, senza mai rinunciare ad una inquietante
ideale di purezza rock. Che, come ogni ideale, deve se ambiguità di fondo: Here Comes Your Man è una ballatina
stesso ad una stratificazione di costrutti mentali che non gradevole e insidiosa, Hey qualcosa di simile ad una perhanno necessariamente fondamenti concreti. Tuttavia, a versa dichiarazione d'amore ("must be a devil between us/
grandi linee, Black Francis e compari abbracciarono pro- or whores in my head"), Tame un j'accuse infervorato ("fall
prio questa naiveté rock, che ovviamente contemplava la on your face in those bad shoes/lying there like you're tame"),
scelleratezza, il torbido, l'impertinenza, la sfida alle con- La La Loves You - cantata da Lovering - un languido divervenzioni tipica dell'età dell'oro. Una ingenua, avventata, tissement surf, mentre Mr. Grieves e Dead si permettono
generosa età dell'oro. Prima dell'istituzionalizzazione del- di tirare in ballo il sempreverde tema della morte in chiale forme e dei tipi rock'n'roll. Come dire, un'utopia con ve biblica. Poi ci sono i capolavori, tracce che segnano a
fondamenta parecchio labili e tutto sommato disperata. fuoco l'immaginario: una Debaser tutta allarme e disperaIn ogni caso, Charles per primo sapeva bene che ormai il zione, surrealismo e nevrastenia, riff geniale e andamento
rock era divenuto un linguaggio inoffensivo: "il rock'n'roll travolgente, ammiccando senza timore al cane andaluso
è divenuto un'esperienza artificiale. Non ha nulla a che fare di Buñuel; quella Wave Of Mutilation che si fa anello man-
cosa, ma le cinque precedenti o le successive di sicuro non
hanno nulla a che vedere con quelle". Minimizzava: "alla
gente non frega un cazzo delle parole. Alla critica sì, ma la
maggior parte della gente vuole solo sentire del rock'n'roll.
Quando ero ragazzo non m'interessavano i testi, l'unica cosa
che contava era se un pezzo è buono o no". Quindi, arrivava al punto: "quello che mi attrae della musica è il buco in
cui vieni risucchiato quando una canzone riesce realmente
a prenderti". Infine sentenziava: "credo che la maggior parte delle band non abbiano altre motivazioni che essere una
band. I loro pensieri sono gli stessi di tutti. Quanto a noi, non
abbiamo un bel niente da dire". Chiarissimo.Anche se poi ci
pensa l'ineffabile Santiago a chiosare enigmaticamente la
questione: "La mia teoria è che se provi a spiegare il mistero
che c'è in un cosa che hai scritto, quello che prima sembrava
destinato all'eternità, in un attimo diventa stupido".
101
Grandaddy prossimi venturi (Blown Away). E' un album
piuttosto ispirato e di norma sottovalutato, anche se un
predecessore come Doolittle è una scusante di tutto
rispetto. Di pezzi killer ce ne sono almeno un paio: una
Dig For Fire che impasta wave, caraibi e funk tra quadretti
enigmatici un po' Raymond Carver e un po' Cormac McCarthy, mentre Velouria è sogno, melodramma ed estasi
come avrebbe potuto un Brian Wilson spalleggiato dagli Hüsker Dü. Se Bossanova non fu accolto benissimo
dalla critica, il pubblico continuava ad adorare la band.
Che in quello stesso agosto ebbe la possibilità di misurarsi da headliners di fronte ai trentamila paganti del
festival di Reading. Fu un'esibizione travolgente. I Pixies
erano al culmine, e sul punto di scoppiare. Troppe pressioni, equilibri inadeguati.
(N on è )
che il 1989 fu l'anno in cui i Pixies realizzarono appieno
se stessi. Tutto il resto fu una conseguenza, rilevante certo anzi eccome, ma per forza di cose minore.
Ok, non fu certo un episodio minore la nuova incarnazione delle The Breeders, progetto col quale Kim Deal
volle compensare il ruolo sempre più marginale - come
cantante e autrice - nei Pixies. Richiamata la sorella e
coinvolti tra gli altri Tanya Donnelly delle Throwing Muses e Britt Walford degli Slint, sfornarono un esordio da
S concer ta il rockettaro !
Ok, i Pixies non diventarono famosi come gli U2 - urlo come Pod (4AD, maggio 1990, 7.8/10). Prodotto da
anche se in Uk riuscirono a fare capolino nella top ten Steve Albini, si rivelò una stupenda combinazione di in- però diventarono un punto di riferimento irrinunciabi- fluenze sonore, sancendo una volta per tutte l'abilità della
le per tutto ciò che si muoveva nell'indefinito caldero- Deal sia come compositrice che come interprete. Una
ne indie-rock. E' risaputo che Kurt Cobain si innamorò scappatella di quelle rumorose, che tuttavia non sembrò
perdutamente del loro sound, al punto che durante le turbare la vicenda Pixies, i quali anzi rilanciarono - Kim
sessioni di Smells Like Teen Spirit il caro Dave Grohl se regolarmente rientrata a bordo - con Bossanova (4AD,
ne uscì sbottando: "Hey, ma sembra un pezzo dei Pixies!!!". agosto 1990, 7.4/10), album che li vide protagonisti di una
Cobain non se ne curò e i Nirvana sfornarono la trac- doppia sconcertante sterzata.
Musicalmente, Francis volle perseguire la propria pascia che segnerà il rock anni novanta. Così vanno le cose,
così devono andare. Intanto Francis e soci si godevano la sione per la surf music (la traccia di apertura, Cecilia Ann,
loro fetta di celebrità, le buone recensioni, il dichiarato è una cover dei The Surftones) rielaborandola in chiave
apprezzamento e persino l'amicizia di Michael Stipe, indie-wave, mentre per quanto concerne i testi pensò
Nick Cave e Robert Smith, tutte quelle college radio bene di infarcirli di temi sci-fi ("Crediamo che gli UFO
che mettevano il pepe al culo a quasi tutti i pezzi di Do- siano un argomento adattissimo. Sono romantici."). Una
fiction sfuggente e allusiva però, che rinuncia a mutilazioni
olittle, un bel mucchio di concerti sold-out.
Tutto ciò senza mai perdere il vizio di sconcertare & perversioni per abbracciare uno spaesamento trepido,
l'amato pubblico, ad esempio suonando scalette in rigo- tra il laconico ed il febbrile (vedi la stupenda The Happeroso ordine alfabetico oppure mettendo il bis in testa ning), capace di fulminei slanci (Allison, dedicata al pianista
allo show (uno o due pezzi) dopodiché uscire e rientrare jazz Moose Allison), di spunti angelici (Havalina) e spurper il concerto vero e proprio. Espedienti marginali, cer- ghi feroci (Rock Music), di psichedelie robotiche e medito, però anche tentativi di scuotere i canoni, elargire la tabonde (All Over The World), giochicchiando per acronimi
scossa squinternata, tagliare l'occhio al cane andaluso con (l'iniziale di ogni verso della suggestiva Ana compone la
un movimento rapido surreal-dadaista. Possiamo asserire parola SURFER) e anticipando en passent un bel po' dei
cante tra new wave e indie rock, satura di stringente,
onirico abbandono; una Gouge Away tarantiniana ante litteram e infine - e soprattutto - Monkey Gone To Heaven,
visionaria e grave, coretti da sirena corrucciata e sottofondo d'archiun mid tempo urticante - ispirato pare ad
un episodio di polluzione oceanica - che sarà in grado di
fare sfracelli nelle rockoteche.
102
il pianeta del suono
Tuttavia, c'era tempo e modo per un altro album,
Trompe Le Monde (4AD, settembre 1991, 7.0/10), titolo che riassume tutta una vicenda poetica. Prodotto
ancora da Norton e impreziosito dalle tastiere di Eric
Drew Feldman (già nell'ultima Magic Band di Captain
Beefheart e nei Pere Ubu), è un disco che recupera la
durezza degli esordi portandosi dietro la obliqua complessità wave maturata nel frattempo, nonché i recenti
retaggi sci-fi. A tratti sembra di sentire dei nipotini degli
Animals (Lovely Day), altrove dei Fall contagiati Red
Hot Chili Peppers (Space I Believe In), oppure degli
Smiths strattonati Gun Club (Motorway to Roswell).
Se Francis si stupirà delle scarse vendite (malgrado la
settima posizione in UK e una dignitosa 92° in USA), è
perché contiene potenziali hit come U-Mass (stradaiola,
cazzona e sguaiata come più avanti certi Pavement),
una bella cover di Head On dei Jesus And Mary Chain,
il serrato modernismo tra Stranglers e Wire di Alec
Eiffel, quella Letter To Memphis che spaccia tipica melodia
pixiesiana in un bel crogiolo di watt e soprattutto Planet
Of Sound, pezzo formidabile ma evidentemente troppo
duro per i timpani del mercato (come singolo, non andrà
oltre la top 30).
Ad un tour ancora una volta fortunato fa seguito una
circostanza leggibile come una possibile svolta: gli U2 li
chiamano ad aprire le date americane del loro Zoo TV
Tour. Un'offerta irrinunciabile, forse la breccia che potrà finalmente schiudere loro la via della celebrità vera,
quella dei dischi di platino e della heavy rotation su MTV.
E invece, troppo squinternati, i Pixies. E al capolinea.
Nell'autunno del 1992 la band di fatto era già dissolta,
come ufficialmente dichiarerà Francis Black nel gennaio successivo, poco prima di ribattezzarsi Franck Black,
pseudonimo col quale firmò i suoi lavori solisti. Kim Deal
dedicò tutta se stessa alle Breeders, ottenendo successo
e soddisfazioni. Joey Santiago bazzicò Franck Black per
un po' prima di fondare i The Martinis. Dal canto suo,
David Lovering prestò il suo drumming occasionalmente
per poi svoltare e farsi prestigiatore ("scientific phenomenalist", a suo dire). Erano rimasti amici, ma non era il
caso di proseguire assieme. Inutile spiegare. Anche questo è rock'n'roll.
Intanto Nevermind solcava le classifiche di tutto il
mondo occidentale, aprendo di fatto una nuova fase per
il rock alternativo. E i Pixies non c'erano più. Così vanno
le cose. Quanto alle reunion, sono un po' come le lapidi:
dei validi palliativi.
103
(GI)Ant Steps #38
classic album rev
Archie Shepp
This Mortal Coil
Fire Music (Impulse!, Marzo 1965)
It'll End In Tears (4AD, Maggio 1984)
Tensione sociale, passione politica, avanguardia jazz: Fire
Music. Il free con tutto il suo impeto rivoluzionario sorpreso a dialogare con un sentimento di ritrovata identità
razziale, in un periodo in cui la "negritudine" diventa un
valore aggiunto, un motivo d'orgoglio, una carattere sociale dirompente. Max Roach era andato a cercarsela
in Africa la sua personalissima rivoluzione con un disco
come We Insist! Freedom Now Suite. Per Archie Shepp la
rivoluzione è già arrivata e ha il volto di Malcom X (Malcom, Malcom-Semper Malcom), le potenzialità di aggregazione della cultura accademica - la cattedra di sociologia del jazz che il Nostro ricoprirà presso l'università di
Amherst nel Massachusetts -, la visione globale garantita da una genetica polistrumentale - suona clarinetto,
pianoforte, sax - che cita la modernità di Coltrane e
i fascinosi fraseggi di Ellington. Avanguardia si, ma per il
popolo: "Il musicista "negro" è esattamente come il popolo "negro" un fenomeno sociale e culturale. Il suo obiettivo
dev'essere liberare esteticamente e socialmente l'America
dalla sua assenza di umanità."
E allora una Hambone posta in apertura che da sola
spiega tutto il disco, con i suoi dodici minuti in bilico
tra Charles Mingus, temi al ralenti, aspirazioni atonali
su deflagranti imbottigliamenti di ottoni - oltre al sax
104
tenore di Shepp sono della partita il sassofono alto di
Marion Brown, il trombone di Joseph Orange e la
tromba di Ted Curson - e batteria. Quasi a sottolineare che il jazz stesso è il linguaggio della nuova società
che avanza, col suo connubio di eleganza bianca e fisicità
tribale espressione dell'America multiculturale degli anni
Sessanta: "Quei bianchi che frequentavano i localini di New
Orleans pensavano di ascoltare musica dei niggers ma si sbagliavano: ascoltavano musica americana." Prelude To A Kiss
è il lato romantico di Shepp debitore nei confronti del
Duke Ellington più aristocratico, The Girl From Ipanema
è Sud America virato pop, Los Olvidados è hard-bop teatrale e strutturato in prospettiva free da cui emergono
soprattutto i tamburi balbettanti di Joe Chambers. In
una convergenza tra cambi repentini, intensità, nostalgia, attacchi selvaggi, vibrati, che recupera idealmente più
scuole di pensiero fondendole in un unicum in cui far
convivere Cecil Taylor, Horace Silver, Charlie Parker, Ben Webster.
"Uno dei migliori interpreti della memoria babelica del jazz"
si legge a proposito di Archie Shepp sul Dizionario del
Jazz di Charles-Clergeat-Comolli. Impossibile non essere d'accordo.
Fabrizio Zampighi
Leggenda vuole che già nello script di Velluto Blu,
David Lynch avesse messo un riferimento a Song to
the Siren dei This Mortal Coil, "canzone che tra un milione di canzoni doveva assolutamente avere". Eppure i diritti
d'autore erano troppo alti e il regista americano si costrinse a mandare un testo ad Angelo Badalamenti,
per farglielo musicare e ottenere qualcosa di simile, "something cosmic, angelic, very beautiful". Alla voce ci si mise
Julee Cruise e saltò fuori così Misteries of Love, tema
di chiusura del film che per canto e arrangiamenti sembra proprio una versione alternativa del brano cantato
da Elizabeth Frazer. Solo molto dopo Lynch avrà la
possibilità di usare quella canzone, mettendola nel finale
di Strade Perdute e coronando un po' un suo personale sogno. E non è il solo ad appassionarsi così tanto a
questo brano, visto che frammenti di Song to The Siren
saranno poi ripetutamente ripresi da spot televisivi (il
profumo Noa di Cacharel) e da altri registi (Peter Jackson nel recente Lovely Bones).
Tanta passione si spiega solo con la qualità della musica, rilettura geniale dell'originale di Tim Buckley, ad
opera di Liz Frazer e Robin Guthrie, ovvero i Cocteau
Twins del pre-Treasure, che ottengono così il brano
simbolo del disco simbolo della 4AD, quell' It'll End In
Tears che potrebbe essere preso come chiave d'accesso a tutto il primo catalogo della label britannica. I This
Mortal Coil, prendono il nome da un passo dell'Amleto
("What dreams may come, when we have shuffled off this
mortal coil, must give us pause") e nascono come un progetto di Ivo Watts-Russell e John Fryer, creato intono
all'ep Sixteen Days/Gathering Dust, dopo che il boss
dell'etichetta aveva cercato inutilmente di convincere i
Modern English a registrare un medley dei due brani.
Dopo l'ennesimo rifiuto, Ivo decise di registrare ugualmente i due brani, chiamando a raccolta alcuni nomi illustri scritturati per 4AD, come appunto la Fraser e Guthrie dei Cocteau Twins, Gordon Sharp dei Cindytalk
e membri degli stessi Modern English.
Di Tim Bukley si è già detto, ma in apertura appare su-
bito l'ombra di Alex Chilton nella rilettura del classico
Big Star, Kangaroo, ad opera di un efebico ed effimero
Gordon Sharp che più in avanti bissa con Fond Affections
dei Rema Rema. Ancora il fantasma di Chilton appare
nelle sembianze di Howard Devoto nella rilettura di
un altro brano dei Big Star, Holocaust, e fa capolino anche
Roy Harper nella magnifica Another Day per violino, archi e voce di Liz Frazer, mentre l'altra ugola d'oro della
label inglese, la Lisa Gerrard dei Dead Can Dance si
produce in un tris originale, che profuma molto di scuola
della decadenza: Wave Become Wings è una lied gotico
che sta tra Spleen And Ideal e Within The Realm
Of Dying Sun, quindi appartiene alla parte più cameristica del repertorio DCD; nello strumentale Barramundi,
fa quasi tutto Simon Raymonde (infatti si respira aria
di Victorialand e Blue Bell Knoll) e la Lisa aggiunge solo
una manto di accordion, mentre nel terzo brano Dreams
Made Flesh, ritorniamo in territori gotici da primi DCD.
Detto che Not Me, rilettura di un brano di Colin Newman degli Wire, a cui mettono mano membri di Xmal
Deutschland, Modern English e Cocteau Twins, con il
suo guitar pop neo wave spezza non poco l'atmosfera
irreale e sospesa, il disco va a chiudersi così come era
iniziato, in pieno humus fatalista, con la ballad per piano
A Single Wish e un Gordon Sharp ancora una volta con
l'aria di chi ha subito tutte le sconfitte del mondo su di
sé. Appunto quel "mortal coil" su cui, a questo punto, ci
interroghiamo tutti mentre osserviamo rapiti, la sirena
in copertina, ennesima geniale creazione della 23 Envelope, partership di Vaughan Oliver e Nigel Grierson a
cui si deve il taglio grafico di tutte le uscite d'epoca della
4AD.
Antonello Comunale
105
la sera della prima
—cult movie
Notte Italiana
C arlo M azzacurati (I talia , 1987)
“…uomini cioè, non cose e luoghi…”
Michelangelo Antonioni
La citazione da Michelangelo Antonioni di Giorgio Tinazzi (Il Castoro Cinema, Milano, 1994) illumina il pensiero a questo film di Carlo Mazzacurati. Pare che il regista padovano abbia fatto propria questa stringa sottile,
questa veloce direttiva, per il suo lungometraggio d’esordio Notte Italiana,
del 1987.
L’avvocato Otello Morsiani, forse il miglior Marco Messeri di sempre, accetta l’offerta propostagli dall’assessore padovano Melandri, Tino Carraro,
di recarsi alle foci del Po per stimare il patrimonio immobiliare Romanin in
vista della realizzazione di un parco naturale che troverà spazio lì, dove un
tempo si estraeva fraudolentemente il gas e ora la terra sprofonda a causa
dell’impauperimento idro-geologico. L’avvocato si trasferisce nel Polesine e
la situazione che trova pare diversa da quella prospettata. La stima si fa più
difficile del previsto, la convivenza con i polesani non è così semplice e l’integrazione non è immediata ma presto queste difficoltà iniziali lasciano spazio
a un duplice innamoramento, Quello per le meraviglie della pianura e della
palude e quello per Daria, Giulia Boschi, bellissima ragazza madre rifugiatasi
106
possono metonimicamente dare tutto quanto serva a capire la portata
dell’esordio, il valore di un’opera che,
rivista ora, si carica di significati allora forse non ancora ben definibili e
stigmatizzabili. Messeri corre dietro
a un’oca nell’aia, seguito dai bambini
zingari e dalla camera a mano. Incespica, cade, si rialza e alla fine capisce,
immobile nel campo, che quel posto
è uno stato mentale prima che un
luogo geografico e che lui, forse, ne
è stato toccato, contagiato e rapito.
Sempre più, infatti, la giocosa serietà
dell’avvocato, la malinconica aria sospesa che Messeri dona al personaggio muta in un sorriso recuperato, in
nei luoghi natali dopo la stagione del- un timido riaffacciarsi alla vita. Quanla contestazione e della lotta armata. to è impossibile nella città chiusa e
Di lei Otello era stato avvertito grigia che cresce di cemento, d’asfalda Melandri, senza capirne la moti- to piovoso, d’autobus arancioni, dello
vazione se non fino a un’agnizione straniamento dei ristoranti cinesi o
storica dolorosa e coraggiosa. Tante dei videogames nei bar.
Tutto questo Carlo Mazzacucose scopre Morsiani, molte anche
oltre la legge e la sua onestà e ret- rati lo racconta con l’ambizione
titudine morale da queste lo salva- dell’esordiente, col tratto instabile
guardano ma lo fanno scontrare con del cinefilo che, per la prima volta,
la consuetudine, con la tipicità delle si trova ad avere la sua chance – e
zone di frontiera, degli avamposti quanto importante! Vista la produnelle terre di nessuno, dove è il più zione della nascente Sacher Film di
forte a comandare e a lasciar soprav- Nanni Moretti e Angelo Barbagallo! vivere i più deboli che lo rispettano e doverla colmare di riferimenti, d’ine temono. Risolta la missione per la tenti e di sogno. Case basse e linea
quale era stato inviato in quelle lan- dell’orizzonte sempre ben mostrata,
de desolate, il protagonista torna in strade vive e fangose, locande dalle
città, chiarisce la posizione di Daria grappe fatte in casa e un flipper. Con
con Melandri, secondo l’assessore la questo Mazzacurati accoglie Messeri
ragazza era stata parte del comman- nel Polesine sconosciuto. Si deve sudo inviato a gambizzarlo, e capisce bito specificare che non è qui in atto
d’improvviso d’aver assistito a una il più banale e ridondante capovolmessinscena, a una finzione costrui- gimento di fronte, l’ovvio recupero
ta ad hoc per consolidare segreti e del pregresso contadino dimenticatramandare l’omertà dominante. Tor- to e vero in opposizione alla città
na nel Polesine e risolve la situazione fredda e individualista fatta di bugie
nell’unico modo possibile nei posti di e denaro. La straordinarietà del film
frontiera e nelle terre di nessuno. Fe- sta nell’invitare lo spettatore a querito, nell’animo come nel corpo, por- sto tipo di visione ormai canonica
ta con sé, in città, quanto di meglio ha e diffusa per poi stravolgere quanto
trovato nella sua discesa alla palude. atteso e scontatamente subodorato.
Sequenze. Alcuni estratti di questo Ben presto, infatti, Otello capisce che
film lo possono raccontare per intero, il male è endemico all’uomo e che la
palude altro non è che straordinaria
metafora di questo, dell’agire umano
e del suo più ultimo e basso istinto. In
questa discesa nel fango, sporcandosi,
il protagonista ritrova il coraggio per
gesti estremi e forti, più tipici dell’uomo di frontiera che dell’avvocato di
città. In un’opposizione - questa sì
necessaria - Morsiani trova la forza
e la linfa vitale che sono mostrate
mancargli sin dall’inizio del film. Non
si raggiungono di certo gli apici violenti di Cane di paglia (Straw Dogs,
Sam Peckinpah, 1971), è tutt’un altro
film quello di Mazzacurati ma Otello
torna uomo e risolve il contenzioso
con la palude – quella dei sentimenti
e della morale – dalla quale lui resta
toccato, riuscendo però a salvarsi e a
tenere caldo il cuore grazie agli affetti
sinceri e al locus amoenus dell’interno famigliare.
Sequenze, si diceva. L’avvocato
fa visita allo stabilimento di Tornovo,
Mario Adorf, vero e proprio ras della
palude e signore di un feudo dimenticato e malsano che già ha cercato
di corromperlo e di assoggettarlo. La
macchina da presa si abbassa e resta
all’altezza dei pulcini che pigolando
corrono spaventati lungo il loro recinto e non riescono a trovare riparo
dallo sguardo implacabile della macchina da presa di Mazzacurati. Siamo
noi italiani quei pulcini, è la società di
questo paese che, in quegli anni, cristallizzava ruoli e modi malsani e infausti
come una palude. Con tutto questo
ci chiede di fare i conti il regista e il
suo ruolo profetico ha del miracoloso o, meglio, ha del tristemente certo
ed evidente. Qui il titolo si spiega e
definisce. Mazzacurati racconta una
storia inventata che ben presto sarà
traslata dagli schermi cinematografici
alle stampe dei quotidiani. La realtà di
questo paese è estratta dalla palude
e mostrata. Quest’ostensione è passata per i caratteri comici e i tipi della
commedia presenti e questa deviazione, questo filtro, non fa altro che
107
—recensioni
Mine Vaganti
F erzan O zpetek (I talia , 2010)
rendere l’effetto più doloroso, più sarcastico e pungente. Il cinismo e il qualunquismo ignorante di questo paese sono
mostrati favorendo la risata che, presto, si disarticola in un’espressione triste, tanto quanto quella dello straordinario
Messeri del finale, nello sguardo perso e nel paese fottuto. L’uomo trova la serenità affianco a Giulia e al piccolo Enzo,
suo figlio. La donna ha preso parte alla stagione della lotta armata restandone scottata e trovando riparo nella casa del
padre che ora è assoggettato al padrone Tornovo. Mazzacurati inserisce così un altro riferimento storico e sceglie da
che parte stare, come leggere i fatti, chi difendere e chi accusare. Un coraggio poco diffuso tra i suoi colleghi registi, basti
pensare a Michele Placido e al suo deprecabile Il grande sogno (2009).
Sull’argine che porta a Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni e Bernardo Bertolucci, passando per Alfred
Hitchcock – più che citazionistica la macchina da presa sul piatto con il pollo - questo film è un esordio perfetto per
un regista che ha saputo, nel tempo, confermare quanto promesso, mantenere quanto qui tratteggiato. Continuando a
interrogare la realtà e la terra grezza, nuda e fredda, dove tutto poggia e a guardare all’orizzonte che si dipana dinanzi
cercando il modo migliore di collocarci la figura umana. Questo va sottolineato del film e di tutto il cinema di Carlo
Mazzacurati. Questo il senso dell’incipit di Antonioni: al regista padovano interessa la figura umana, lo sviluppo del
carattere all’interno del contesto scelto. La campagna, spesso, come luogo di una fuga necessaria esplicita o rivelata
solo all’arrivo, la wilderness come condizione con la quale misurarsi – si pensi alla metafora della forza coatta del
toro chiuso nel camion nel bellissimo Il toro (1994) - con la quale stabilire un contatto che inevitabilmente non sarà
timido o delicato e riconoscerne la forza. Tutto avviene senza il “misticismo della terra” tipico di Terrence Malick ma
sempre attraverso il gusto delle terra in bocca, l’odore di sterco e la nebbia nelle ossa.
Per i venticinque anni de La Settimana della Critica della Mostra del Cinema di Venezia, nel settembre 2010, sarà
presentata un’edizione restaurata del film. Si tratta di un degno tributo sia alla manifestazione più interessante del panorama veneziano sia all’opera del regista padovano che sarà in sala nello stesso periodo con La passione (2010).
Il paese, intanto, resta in balia della palude morale e sociale che Otello Morsiani si è trovato a sfidare e a vincere
seppur provandone la violenza attrattiva e l’efferatezza. L’invito intimista che Mazzacurati pone alla fine del suo film
più bello, quello di chiudersi negli affetti più veri e lasciare fuori il mondo, ora dev’essere disatteso non per scortesia
ma per la necessità improcrastinabile di bonificare la palude, di sanare l’aria.
Ando Romanelli
108
Lecce. Oggi. La famiglia Cantone, nonna, padre, madre, zia,
due figli maschi e una femmina, si ricompone per l'arrivo
del figlio minore Tommaso, Riccardo Scamarcio, da
Roma dove studia Lettere e non Economia, come tutti a
casa pensano. Più di uno è il segreto, infatti, che il giovane porta dentro di sé e questo viaggio in Puglia, questo
ritorno a casa, farà deflagrare ogni silenzio con grande e
colorato clamore.
Ferzan Ozpetek racconta una famiglia borghese pugliese di provenienza agricola, racconta quel esempio di
condizione familiare per il quale tutte le speranze e i sacrifici dei genitori sono spesi per i figli, cercando nei loro
successi e nella loro affermazione una ricompensa alla
"schiena spezzata" e alle "mani aperte" dalla fatica. Anche in modo castrante, però. Non tutto, infatti, è come
sembra. Non tutto va come vorrebbe il padre retrogrado Vincenzo, Ennio Fantastichini, al quale tocca l'onta
peggiore, la pena massima per i vicoli del meraviglioso
borgo salentino. Il figlio maggiore Antonio, Alessandro
Preziosi, il delfino, è omosessuale. E, giunto a trent'anni,
non riesce più a nasconderlo.
Da qui si parte. Da un tradimento. Da una rimozione
del padre effettuata da chi non credevi. Da un affrancamento dai vincoli imposti dallo stampo patriarcale della
famiglia pugliese dove "meglio morto che finocchio". Fin
qui tutto bene, come diceva qualcuno in quell' epocale
film di Mathieu Kassovitz. Fin qui il film pare reggere
ed è interessante, malgrado Ferzan Ozpetek. Confesso di non amare questo regista ma di considerare Le
fate ignoranti (2001), un film straordinariamente bello
e importante e di avere renitenza per tutto ciò che è
da lui giunto dopo. Anche qui girotondi di travelling su
commensali che mangiano e bevono, ridono e piangono;
anche qui caratteri tracciati con il carboncino piuttosto
che con l'acquerello; anche qui luoghi comuni stereotipici a profusione e dialoghi vacui e vani.
Tommaso, "tradito" dal fratello, si trova definitivamente
chiuso in un mondo dal quale voleva scappare, impossibilitato a uccidere il padre perché già il fratello l'ha mandato all'ospedale. Da qui la confusione. Il film si scioglie sul
doppio binario del dovere familiare e dell'affermazione
del sé oltre ogni vincolo imposto ma non riesce ad affermare una certezza in nessuno dei due casi, su nessuna
delle due direzioni. Molta confusione, altro tratto tipico
del regista, si sparge tra colori e gridolini, tra ricordi e vo-
lontà, tra ruoli socialmente imposti e vincolo del sangue.
Si aggiunge, poi, a suggellare tanto polverone lo sguardo.
La potenza dell'istanza di visione che Scamarcio impone
su Marco, Carmine Recano, e su Alba, Nicole Grimaudo,
prima singolarmente e poi quando i due sono uniti in
abbraccio non è che un gesto muto, una macchina celibe
per la quale, nelle intenzioni del regista, dovremmo cogliere l'indeterminatezza della declinazione amorosa, la
potenza non canalizzabile tassonomicamente del Sentimento ma, in tanto guazzabuglio emotivo, si fa dura compiere questo movimento.
Nella Puglia della migliore Film Commission di sempre,
nella Puglia di Vendola modernamente illuminato e omosessuale, nella Lecce "Bologna del Sud", Ozpetek realizza l'ennesimo e inutile "film frocio". Preferisce stare
alla macchietta del "diverso" alla Ranieri/ Pozzetto ne
La patata bollente (Steno, 1979), piuttosto che cercare
di realizzare un cinema omosessuale italiano maturo e
culturalmente valido. In questo sta tutta la critica nei
confronti di questo film anche ben girato e fotografato
ma oltremodo provinciale e non nel senso ammiccato da
Ozpetek di una Lecce lontana provincia della Roma testacciana dove la parola omosessuale non è dicibile a tavola
109
ma nel senso della commedia all'italiana di più basso lignaggio e valore. Peccato.
Aldo Romanelli
Io sono l'amore
L uca G uadagnino (I talia , 2010)
Il film di Luca Guadagnino alla mostra di Venezia mi
era piaciuto. Lo dico subito. Anzi non avevo proprio capito perché fosse stato accolto con fischi, ironie e trambusto futurista. Sono andato a rivederlo e l'esito è stato
radicalmente opposto. Da dar ragione al futurismo festivaliero.
Luca Guadagnino, suo anche il soggetto, racconta di
Emma Recchi, Tilda Swinton, signora dell'alta borghesia
industriale milanese e del suo vivere annoiato e opulento.
Fino all'incontro con Antonio, il redivivo Edoardo Gabriellini, cuoco e amico del figlio di lei Edoardo, Flavio
Parenti.
Sin dall'inizio tutto è concesso al potere estetico dell'immagine. Ai movimenti di macchina. Alla costruzione delle
inquadrature. Tutto nel film si presta alla ricostruzione
oltremodo precisa dell'alta borghesia milanese. Dei suoi
interni. Delle sue usanze. Dei suoi vezzi. E dei suoi limiti
più beceri e antiprogressisti. La storia, senza dubbio né
originale né di portata epocale, quasi scompare sotto
110
il peso di plongée e carrelli che si arrestano su pesanti
porte che si chiudono sempre. Su stanze che portano ad
altre porte. Su decorazioni barocche ridondanti e mute.
Sulla Milano di cemento e neve. Sulla Londra finanziaria e
mondiale. E anche sulla San Remo di carne e sole.
Guadagnino cita. Questo è il punto. Ma di quel citare
che avoca a tutto lo stile, a tutta l'opera omnia, dell'autore omaggiato. Michelangelo Antonioni. Luchino
Visconti. Pier Paolo Pasolini e Terrence Malick in
toto. Non in particolare. Guadagnino omaggia il cinema
d'autore italiano degli anni '60. Omaggia i maestri di oggi.
E questo non basta. Lo fa in un contesto poco interessante. Dell'alta borghesia milanese che si autotutela e
diverte, che se la gode e produce- sempre meno e peggio - che s'incapriccia per il giovane proletario e manda la figlia sessualmente annoiata a studiare fotografia a
Londra non se ne sente davvero la necessità né la sincerità espressiva. Questo è quanto. Formalmente barocco.
Sostanzialmente anacronistico.
Pare che Guadagnino denunci ma l'oggetto del suo attacco ricorda quello fuori tempo massimo gattopardesco. Del tipo che non può fingere di non vedere che i
giochi si decidono altrove. Non più lì e da tanto, ormai.
Tra cammei di pregio, un Ferzetti d'antan, e macchiette
manieriste, la suocera Rory, Marisa Berenson, l'autore
inserisce persino un imprenditore indiano, tale Mr. Kubelkian, Waris Asluwalia, che filosofeggia flemmatico
sull'economia dal ruolo di rinnovatrice del mondo e sulle sinapsi aziendali che lo renderanno migliore.
Resta irrisolto parecchio nel film. Tanto non è compreso
e assimilato perché citazionismo ed evidente anacronismo non permettono una reale analisi psicologica dei
caratteri del film. Dura è interessarsi realmente ai ricordi pregni di Emma o ai silenzi di Antonio o, tantomeno,
ai flebili abbracci tra lui ed Edoardo. Al fatto che tutti
abbiano qualcosa di nascosto e inconfessabile o, meglio,
di latente e pericoloso non ci si può dedicare perché lo
stridore del contesto è limitante e fastidioso. Guadagnino crea, quindi, un mondo volutamente molto vivido e
variegato. Tutto sta nelle sfumature dell'elegante grigio
piombo borghese nel quale il regista vorrebbe seguissimo il filo del rosso e dell'arancione degli abiti Jil Sander
e Fendi di Swinton quasi fossero un bianconiglio dello
svelamento e della comprensione, della denuncia e della
necessaria realtà. Tutto questo si arena perché troppo è
dato e detto e non è lasciato lo spazio allo spettatore
per interrogarsi e decifrare.
Il ritorno allo stato di natura, al silenzio, alle porte finalmente aperte, al far l'amore nei campi non è poi che
uno stantio tentativo di giustificare l'operato di una protagonista alla quale non ci affeziona né cura se non per
l'eleganza e l'abilità attoriale.
Guadagnino recupera il cinema che ama e lo omaggia
nel peggiore dei modi possibile, ovvero riversandolo ai
giorni nostri con i modi di ieri e non approfondendo gli
interrogativi e i motivi interiori di chi era raccontato in
quelle opere.
Aldo Romanelli
L'uomo nell'ombra
R oman P ol anski (R egno U nito , G ermania ,
F rancia , 2010)
Lo scrittore Ewan McGregor, il suo nome non è mai
rivelato nel film, accetta malvolentieri di diventare il
ghostwriter (come da titolo originale del film, The Ghost
Writer, 2009) dell'ex primo ministro inglese Adam Lang,
Pierce Brosnam, e di recarsi su un'isola antistante al
New Jersey dove il politico si è ritirato e vive. Presto il
protagonista si accorge degli strani eventi che sono accaduti e che accadono tutt'attorno a lui.
La messa in scena di Roman Polanski parte da un romanzo di Robert Harris, The Ghost, ed è piena ed energetica, contemporanea e, allo stesso tempo, fedele al marchio del regista. Alfred Hitchcock è avocato, eletto.
Tra il dentro e il fuori, le luci e le ombre, tutto è presto
schierato. Gli attori, su tutti Olivia Williams, l'ex first lady, si
affidano pedissequamente a un plot perfetto e alla mano
Kim Cattrall, la segretaria molto particolare di Lang,
è meritevole e contribuisce alla costruzione di questa
catabasi nel potere politico e delle sue derive.
Pare sovente di essere mossi all'ironia durante la visione,
si passi la forzatura, a causa dello straniamento infuso
alle vicende, dell'andamento di un thriller illuminato dalla verve di Polanski. La colonna sonora incalzante e ben
ponderata di Alexandre Desplat si articola in una venatura ilare che sottende tutto quanto è mostrato e i due
protagonisti maschili hanno molto della coppia comica
classica. Brosnam gigioneggia manifestamente, Mc Gregor pare la pantomima del reporter classico che beve
solo whiskey e non capisce il senso del vino bianco.
C'è un valore sotteso fondamentale in questo film, un
altro modo di vedere le cose più importante e meritevole. Tutto sta nel riconoscimento del ruolo dell'opinione
pubblica libera, reale arma propria dei paesi anglofoni,
nella sua capacità di sostenere tesi, combattere battaglie
e apportare cambiamenti rivoluzionari. Questo è l'intento di Roman Polanski. Anche un politico come Adam
Lang, "una moda", come lo definisce Mc Gregor, può essere messo in discussione e, alla fine, da parte. Ancor più
specificamente sono la carta stampata, i giornali e, infine,
la forza testimoniale della parola scritta, quanto è onorato dal regista qui. Si semplifichi così, nell'ordine. Un
mcguffin cartaceo, come prologo: la revisione di un libro
lasciato incompiuto. Un giornale letto in aereo, per avvicinasi all'incarico. Un comunicato stampa scritto quasi
per gioco, per ritrovarsi complici del proprio dominus,
come dice la segretaria allo scrittore. Un antico gioco
filologico alla Eco e un bigliettino passato di mano in
mano, per svelare tutto, per distanziarsi da quanto visto e scoperto, per denunciare. Una tempesta di fogli
volanti, nella Londra degli editori - splendido il cammeo
di James Belushi che "raccomanda" il cuore - per la
meravigliosa sequenza finale del film.
Una sostituzione amaramente ironica è messa in atto
nell'ultimo film di Roman Polanski, Orso d'Argento a
Berlino nel 2009. Una terza sfumatura, la più sincera probabilmente, la più intima. Lang non è altro che Polanski
stesso, chiuso nella sua villa su un'isola blindata in attesa
che qualcuno chiarisca la sua posizione allo stesso modo
in cui il regista aspetta in uno chalet in Svizzera che si
decida del proprio destino. Speriamo l'esito sia diverso.
Aldo Romanelli
Fantastic Mr. Fox
W es A nderson (USA-G ran B retagna , 2010)
Pochi celebratissimi autori cinematografici, oggi, hanno la
capacità di sintetizzare e di rendere ampiamente ricono111
scibile non solo il proprio "marchio di fabbrica", il proprio stile e le proprie convinzioni, ma anche il proprio
universo narrativo, il proprio mondo e modo di guardare. Tra questi pochi, per nostra fortuna, c'è Wes Anderson e, ultima prova di tanta capacità, è il suo ultimo film
Fantastic Mr. Fox.
La vicenda è quella raccontata da Roald Dahl, si tratta
dell'ennesimo prelievo per il cinema dall'autore inglese,
e della sua favola omonima pubblicata nel 1970. Mr Fox
è - meravigliosa tautologia - una volpe che mette la testa
apposto e scorda il passato fatto di scorribande e razzie
nei pollai. La moglie incinta, Felicity, riesce a riportarlo
sulla retta via e a fare di lui un giornalista. Il carattere
è destino, si sa, e la volpe non riesce a trattenersi dal
commettere un'ultima serie di colpi che vanno a buon
fine ma suscitano la vendetta smisurata dei tre allevatori
e agricoltori colpiti, Boggin, Bounce e Bean. Da qui s'innesca una serie di rischiose avventure per fuggire all'attacco umano e per difendere i propri cari come si chiede
a una volpe matura e responsabile.
La cosmogonia del regista è rispettata. Questo va presto
detto per tutti i fan spaventati o incuriositi dal cambio di
genere, la scelta dell'animazione stop motion a 12 frame al
secondo, con il quale l'affrescatore americano, lo diremo
così, ha deciso di cimentarsi per il suo ottavo film. Tutto
112
cambia visivamente, è ovvio, ma nulla si sposta dal punto di vista narrativo e ontologico. Tutto è perfettamente
rinchiuso nell'inquadratura e in quello che da essa si sviluppa. Pare evidente qui che Anderson parta dalla favola
morale di Dahl per raccontare la sua storia o, meglio, per
dirla con il mio amico Alfonso Mastrantonio, sempre lo
stesso film.
Ancora una volta ci si trova dinanzi a una proposta di
cambiamento, a un racconto del crescere e del passare
ad altro. Tutti qui devono mutare il proprio essere cercando di non farsi troppo male. Il piccolo Ash, la sua voce
è di uno dei pupilli di Anderson, il mio amato Jason Schwartzman, è "diverso" e non ha ancora capito da chi
o da cosa. Non ha ancora capito che le sue invidie e le
troppo nette orme paterne non lo salveranno dalla vita
vera. Suo padre, Mr.Fox/George Clooney, è nella stessa situazione, intrappolato tra le responsabilità del suo
ruolo famigliare e un istinto da wild fox incontenibile.
La madre e moglie Felicity/Meryl Streep, è timoniere
di questo maremoto al rallentatore, di questa rivoluzione in muto, di un incendio senza fumo. Tutt'attorno, una
miriade di piccoli animali con le loro debolezze, geniali
peculiarità e difetti di pronuncia.
Mi accorgo di aver ritagliato bruscamente, nomi e specie
a parte, tutto il cinema di Wes Anderson. Gli uomini
cercano di capire, di capirsi, le donne li guardano cercando a loro volta di essere capite e, ovviamente, di capirsi.
Corollario di questo girotondo sono le macchiette, le
presenze che passano per il racconto dando del loro
o senza neppure aprire bocca, solo ammiccando. Tutti,
protagonisti o comparse, rivolgono al mondo lo stesso
sguardo, carico della stessa malinconica distanza, ascoltando la stessa canzone che, allegra o triste, ricorda sempre che l'estate è bella perché finisce presto. Di tutto
questo ringrazio Wes Anderson.
Aldo Romanelli
Departures
Y ojiro T akita (G iappone , 2010)
Tokyo. Oggi. Daigo Kobayashi, Masahiro Motoki, suona il violoncello in un'orchestra. Non è poi così sicuro
dei suoi mezzi né, tanto meno, di meritarsi l'incarico che
ricopre. Improvvisamente l'orchestra è sciolta e tutto
deve cambiare per lui. Il violoncello da riconsegnare, la
vita dispendiosa della capitale più costosa del mondo da
mantenere, una moglie giovane e devota, Ryoko Hirosue,
dinanzi alla quale fingere che tutto vada bene. L'uomo
decide allora di tornare al paese natale, in un villaggio
di campagna, portando con sé la moglie. Il lavoro che
fortunosamente lì trova, il tanatoesteta, cambia la sua vita
in più modi ricongiungendolo alle sue radici recise e a se
stesso. La strada che porta alla piccola caffetteria dove
l'uomo e sua moglie trovano riparo all'arrivo dell'inverno, in fuga dalla città, inizia ben prima di quanto mostrato
dal film. Daigo ha un trauma nel suo pregresso che lo
ha segnato, uno scisma che lo rende titubante e labile
nel piglio. Ripete spesso l'uomo, infatti, che non è sicuro,
che non è certo di quanto ha scelto di fare, delle sue
azioni. Dinanzi alla vita nel suo scorrere, l'uomo guarda
tutto con l'aria persa e instabile, con la trasparenza di
chi non si fida dei propri mezzi. Il padre putativo, il suo
datore di lavoro, lo straordinario Tsutomu Yamazaki, lo
redarguisce e avvia al suo ruolo, insegnandogli la dignità
della morte, quindi di ogni vita, compresa quella del suo
vero padre.
La parabola di Daigo e il suo incontro con la morte
sembrano assemblate ad hoc e senza una fondamentale
sincerità di fondo. Il problema è che qui si mescola la saggezza della millenaria tradizione giapponese con stilemi
e modi più tipici della rappresentazione occidentale di
oggi - l'insostenibile raccordo di sguardo sul soffitto tra
il protagonista e la collega, Kimiko Yo - e questo incontro
spurio non porta bene all'antico e renda mediocre, ancor di più, il moderno. Quale più perfetta metafora della
globalizzazione! Nel raccontare il percorso di formazione del protagonista, la sua evoluzione, il suo sbocciare
in fiore come la pianta grassa sul tavolo di Yamazaki il
primo giorno di lavoro, è decisamente preferito il soffermarsi sull'ennesima e stantia cronaca dell'abilità, mentale
prima che fisica, dell'uomo asiatico, sulla serialità delicata
del suo gesto, sul filosofico sentimento dell'attesa e del
mutare. Solo lievemente si passa sul trauma dell'individuo - la meravigliosa sequenza del volto paterno sfocato
- sul dissidio interiore di Daigo che tutte le metafore dovrebbe sorreggere. E quando accade subito la traiettoria
è corretta, ricalibrata la portata del mostrato - la vana
sequenza del volto del paterno messo a fuoco- di modo
da esser certi che il messaggio sia chiaro e recapitato,ma
così da rendere privo di valore il contenuto per una ridondanza di significante.
Il film giunge nelle sale italiane solo ora, dopo aver vinto
l'Oscar come miglior film straniero nel 2009 ed essere
passato in anteprima sugli schermi del Far East Festival di Pordenone nel 2009. Proprio dal Friuli giunge, infatti, questa distribuzione: la Tucker Film - dal nome delle
auto costruite da Jeff Bridges in quel bel film di Coppola
dell'88 - è filiazione diretta tra Cinemazero di Pordenone e il Centro espressioni cinematografiche di Udine.
Simbolico è il fatto che Departures (Okuribito, 2008)
abbia fatto strage di cuore tra i membri dell'Academy,
quelli che l'hanno preferito a Valzer con Bashir (Waltz
with Bashir, Ari Folman, 2008): questo film infatti è un
eccellente esempio di cinema asiatico ad usum americanorum. Senza dubbio non si deve banalizzare e ridurre a
un unico modus operandi tutto il cinema proveniente
da quelle zone del mondo ma, forse, può risultare illuminante la notizia che il prolifico Takita, molto attivo
sia in televisione che al cinema con ampie e discutibili
acrobazie tra i generi, abbia confezionato, dopo il film qui
analizzato, la riduzione per lo schermo (Tsurikichi, 2009)
delle avventure dell'anime Sampei (Tsurikichi Sampei,
1980) di Takao Yaguchi.
Aldo Romanelli
113
La casa editrice Odoya e SentireAscoltare presentano:
PJ HARVEY
Musica.Maschere.Vita
Un libro di Stefano Solventi
La sua musica è una sferzata misteriosa e misteriosamente liberatoria.
Un’ossessione blues sbocciata nella culla del Dorset, cresciuta tra inquietudini adolescenziali e una incontenibile brama di mondo. Quando infine
è esplosa, lo ha fatto col piglio travolgente dei predestinati. Dei suoi primi
quaranta anni, Polly Jean Harvey ne ha dedicati venti a tracciare una
parabola fatta di musica, maschere e vita.
240 pagine
Volume illustrato
euro 15,00
CONCEPT ALBUM
Un libro di Daniele Follero
Introduzione Franco Fabbri
Nata sull’onda della rivoluzione musicale di fine anni Sessanta, la pratica
del concept album ha accompagnato la maturità del rock, scrivendo un
capitolo importantissimo nella storia della popular music. I dischi “a tema”
continuano ancora oggi a rappresentare un affascinante mezzo espressivo,
anche negli ambienti del pop da classifica. I recenti concept album dei Green Day sono la testimonianza più lampante di un filo rosso che, partendo
da Frank Sinatra, tiene insieme Sgt. Pepper’s dei Beatles, Tommy degli Who,
The Dark Side of the Moon e The Wall dei Pink Floyd, le storie d’amore di
Claudio Baglioni arrivando fino ai Dream Theater e al brit-pop.
226 pagine
Volume illustrato
euro 15,00
www.odoya.it
www.sentireascoltare.com
In tutte le librerie