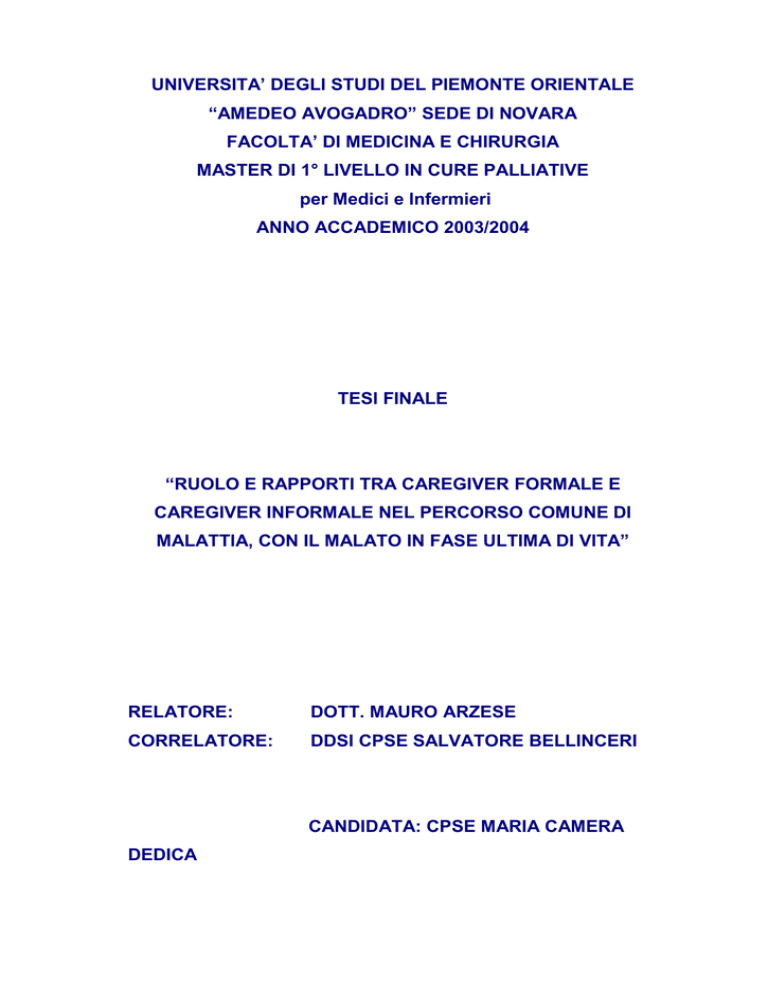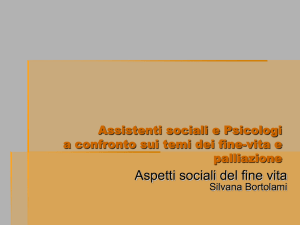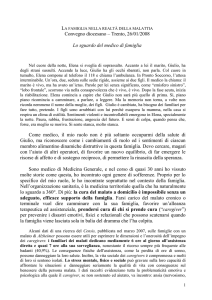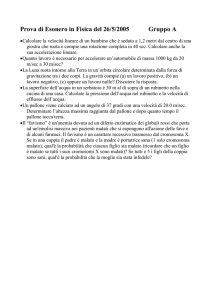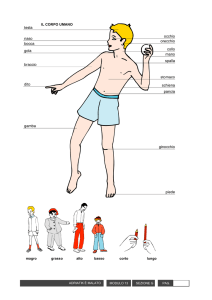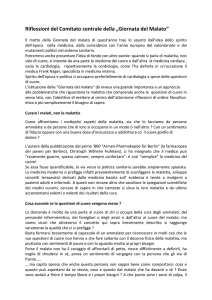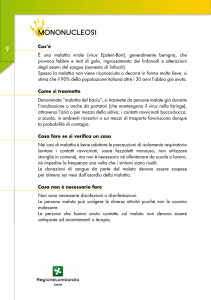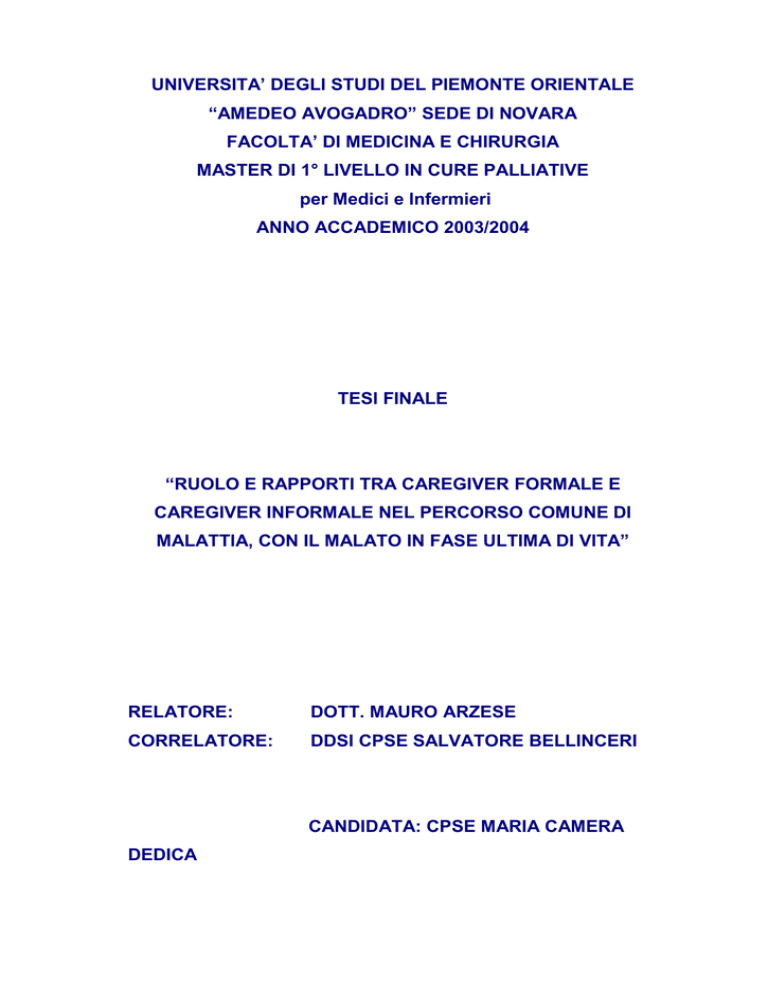
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE
“AMEDEO AVOGADRO” SEDE DI NOVARA
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
MASTER DI 1° LIVELLO IN CURE PALLIATIVE
per Medici e Infermieri
ANNO ACCADEMICO 2003/2004
TESI FINALE
“RUOLO E RAPPORTI TRA CAREGIVER FORMALE E
CAREGIVER INFORMALE NEL PERCORSO COMUNE DI
MALATTIA, CON IL MALATO IN FASE ULTIMA DI VITA”
RELATORE:
DOTT. MAURO ARZESE
CORRELATORE:
DDSI CPSE SALVATORE BELLINCERI
CANDIDATA: CPSE MARIA CAMERA
DEDICA
A TUTTI QUELLI CHE SANNO STARE SEDUTI IN SILENZIO
CON I LORO SIMILI, NON SAPENDO CHE COSA DIRE MA
SAPENDO CHE DEVONO “ESSERCI” E, POSSONO PORTARE
NUOVA VITA IN UN CUORE MORENTE.
A TUTTI QUELLI CHE NON HANNO PAURA DI STRINGERE
UNA MANO CON GRATITUDINE, VERSARE LACRIME NEL
DOLORE,.... ACCOMPAGNARE E..... LASCIAR ANDARE..........
A TUTTI QUELLI CHE SI SENTONO “VINTI” E RIESCONO
COMUNQUE A SUPERARE LIMITI PARALIZZANTI.
A TUTTI QUELLI CHE SANNO PERDONARE.
(Henri J.M. Nouwen, Out of Solitude)
A TUTTI I MIEI PAZIENTI, ALCUNI VIVI, LA MAGGIOR PARTE
MORTI, CHE MI HANNO INSEGNATO MOLTO DI QUELLO
CHE SO SULL’INFERMIERISTICA, SUI RAPPORTI UMANI E
SUL SUPPORTO EMOTIVO.
Grazie
INTRODUZIONE
Pag.
2
IL PUNTO DI PARTENZA
Pag.
3
MIERISTICO
Pag.
5
LEADERSHIP EMPOWERING: I MODELLI
Pag.
5
DELLE CURE PALLIATIVE?
Pag.
6
L’EMPOWERMENT E LE CURE PALLIATIVE
Pag. 14
EMPOWERMENT E ORGANIZZAZIONE
Pag. 15
EMPOWERMENT E RISORSE
Pag
OBIETTIVO
GLI STRUMENTI OPERATIVI
COMPETENZE DEL COORDINATORE INFER-
QUALE STILE DI LEADERSHIP PER UN COORDINATORE INFERMIERIATICO NELL’AMBITO
16
QUALI RISORSE PER UN’EQUIPE
DI CURE PALLIATIVE?
Pag. 17
DALLE RISORSE TECNICHE ALLE
RISORSE UMANE
Pag. 19
I TEMPI DEL COORDINAMENTO
Pag. 24
I RUOLI E I RISCHI DEL COORDINAMENTO
Pag. 25
DARE VALORE ALLE PERSONE: VALUTARE
Pag. 26
IL COORDINATORE INFERMIERISTICO
E LA VALUTAZIONE
Pag. 27
CONCLUSIONI
Pag. 29
BIBLIOGRAFIA
Pag. 30
C.
Piccardo
“Empowerment”
Strategie
di
sviluppo
organizzativo centrate sulla persona, R. Cortina Ed., 1995;
M. Manetti, A. Piermari, N. Rania, A. Zumino “I processi di
gestione delle risorse nelle organizzazioni di cura” Facoltà di
scienze della Formazione-Università di Genova- Master di
Coordinamento, 2004;
S. Capello “Leadership empowering e stile di coordinamento”
Master in management infermieristico per le funzioni di
coordinamento- Facoltà di Medicina e Chirurgia di Genova,
2004;
S. Cappello “Risorse, valutazione” 4° Modulo Master in
Management infermieristico per le funzioni di coordinamento,
Genova, 2004;
L. Ribaldi “L’apprendimento organizzativo” Master in
management infermieristico per le funzioni di coordinamentoFacoltà di Medicina e Chirurgia di Genova, 2004;
www.avianorossi.it “La dinamica di gruppo”, Relazione
presentata all’iniziativa di aggiornamento: Giornate di studio
Collegio IPASVI di Pescara,25/10/1995;
www.avianorossi.it “Valorizzazione delle funzioni del caposala
per una migliore organizzazione dell’assistenza”, intervento
presentato alla tavola rotonda organizzata da Coordinamento
Nazionale dei Caposala (CNC)-Regione Umbria, 14/3/2003
30
INTRODUZIONE
L’assistenza al paziente terminale e le cure palliative sono
diventati sempre più temi attuali di discussione.
Di fatto, la morte e l’assistenza al paziente che muore
rappresentano uno degli argomenti che ha, da sempre,
occupato spazio nella pratica, nella formazione e nella
letteratura infermieristica. Chi è coinvolto nell’assistenza al
malato oncologico, nel periodo terminale della propria
esistenza, vive un’esperienza umana e professionale di
grande intensità. Quale attenzione viene rivolta a queste
persone: medici, infermieri, terapisti, psicologi, familiari e
volontari? Quale attenzione è riservata alla famiglia di un
paziente in fase ultima di vita? Chi e come garantisce che
queste persone conservino la vitalità del proprio ruolo di
caregiver senza cadere vittime di emozioni, stress e burnout?
Lungo il percorso, questo mio lavoro sarà interrotto da
racconti di casi; non situazioni cliniche, bensì situazioni
assistenziali difficili, che hanno portato a scelte complesse,
in cui è stato in particolare il paziente a insegnare, o che
hanno messo in luce carenze organizzativo-strutturali.
Il racconto rispecchia una duplice esigenza:
quella di mettere in comune esperienze e vissuti, ma anche di
rispecchiare, rispettare e sfruttare la ricchezza qualitativa
della
realtà,
predefinite,
che
per
non
farne
sembra
riconducibile
occasione
di
a
riflessione
regole
e
di
apprendimento.
Con il racconto si rende visibile il paziente e le sue
sofferenze, si suggeriscono ipotesi, documentandole, si
rendono vive le storie del quotidiano che finirebbero per
perdersi, per finire dimenticate, per rimanere patrimonio di
pochi.1
PARTE PRIMA: IL PAZIENTE IN FASE ULTIMA DI VITA
1.1
DEFINIZIONE.
La malattia è una delle situazioni più frustranti della vita, ha
sempre un riflesso acuto sulla personalità: la mette in crisi e
la rivela nella sua autenticità, spogliata da tutte le maschere.
La persona malata è coinvolta in tutto il suo essere, la sua
identità, il suo ruolo sociale, il mondo affettivo, la sua
progettualità.
Una patologia oncologica colpisce non solo il corpo ma
anche la psiche e l’universo esperienziale delle persone, non
lasciando indenne tutto il sistema di relazioni sociali e
familiari dell’individuo. Da subito, il soggetto è chiamato a
porsi domande sulla propria vita, sul significato della stessa,
sui progetti a medio e lungo termine e sulle relazioni che
intrattiene con gli altri e con il mondo. (1)
La malattia è un evento in quanto colpisce improvvisamente,
che prorompe nel quotidiano e fa uscire il corpo dal silenzio.
Tutti siamo a conoscenza che la vita non è infinita, ma
viviamo come se così fosse. La malattia apre un varco al
sentimento di finitudine, introduce domande sull’esito della
(1) Note: Susan Sontag, “La malattia come metafora”
malattia, sul tempo che rimane da vivere, sul senso da
attribuire alla vita che resta.
La dimensione temporale con l’evento malattia si modifica. Il
tempo presente è il tempo della terapia ed è vissuto come un
“non-tempo”,
organizzato
e
scandito
dai
cicli
di
chemioterapia, dai colloqui con i curanti, dagli esiti dei
controlli clinici; il tempo prima della malattia è denso di
obiettivi e progetti spesso non realizzati che alimentano
rimpianti e autoaccuse. Il tempo futuro sembra ipotecato
dalla malattia e dal suo decorso.
L’esperienza di accompagnamento con pazienti oncologici
fa intravedere, talvolta, un passato biografico ingombrante,
caratterizzato da complesse situazioni familiari, lutti, episodi
di vita che hanno messo a dura prova le capacità e le risorse
di queste persone. Il cancro, allora, viene percepito come
l’atto finale di un percorso di vita complesso e può essere
vissuto come una punizione per qualcosa che si pensa di
aver fatto di male come una colpa che angustia.
3
1.2
CHI E’ IL MALATO TERMINALE?
Per malato terminale s’intende ogni persona malata, senza
speranza di vita residua, colui verso il quale la terapia medica
non offre più alcuna possibilità di guarigione o di remissione.
La fase terminale della malattia è dunque quella fase
avanzata in cui la prospettiva finale è rappresentata dalla
morte.
La fase terminale ha inizio nel momento in cui il paziente non
risponde più ai trattamenti attivi intesi a prolungare la vita,
per il quale le cure oncologiche specifiche lasciano il posto ai
trattamenti palliativi. (2)
Tale periodo non riguarda solo le ultime ore di vita, ma è
impossibile collocare in una dimensione temporale la
situazione di irreversibilità clinica che può coprire varie
settimane e talora mesi. In taluni casi può coincidere con la
diagnosi.
La
malattia
terminale
è
un
processo
che
evolve
gradualmente, non un evento statico. Per il malato vengono a
crearsi nuovi bisogni, nuove abitudini, un nuovo stile di vita
ed essendo questi bisogni di natura diversa, è necessario e
corretto affrontarli attraverso un approccio multidisciplinare,
utilizzando specifiche competenze e figure diverse, che si
prefiggono l’obiettivo comune di apportare un miglioramento
della
qualità
di
vita
residua
del
paziente
e
un
accompagnamento dignitoso. Il mondo del malato terminale
ruota intorno al bisogno, espresso o non espresso, di sapere
che non verrà abbandonato soprattutto nel tempo ultimo
della sua esistenza.
4
(2) Note: “Palliativo” deriva dal latino “Pallium” Mantello.
1.3 CHE COSA SONO LE CURE PALLIATIVE?
Le Cure Palliative, secondo la definizione dell’Organizzazione
Mondiale della sanità (OMS), costituiscono una serie di
interventi terapeutici ed assistenziali finalizzati alla “cura
attiva, totale, di malati la cui malattia di base non risponde
più a trattamenti specifici”. Fondamentale è il controllo del
dolore e degli altri sintomi, e in generale dei problemi
psicologici, sociali e spirituali.
Le Cure palliative si caratterizzano per:
la globalità dell’intervento terapeutico che, non si limita
al controllo dei sintomi fisici, ma si estende al supporto
psicologico, relazionale, sociale e spirituale;
la valorizzazione delle risorse del paziente e della sua
famiglia oltre che del tessuto sociale in cui sono inseriti;
la
molteplicità
delle
figure
professionale
e
non
professionali che sono coinvolte nel piano di cura;
il pieno rispetto dell’autonomia e dei valori della
persona malata;
il pieno inserimento e la forte integrazione nella rete dei
servizi sanitari e sociali;
5
l’intensità dell’assistenza globale che deve essere in
grado di dare risposte specifiche, tempestive, efficaci ed
adeguate al mutare dei bisogni del malato;
la continuità della cura fino all’ultimo istante di vita;
la qualità delle prestazioni erogate.
Complesso di cure quindi finalizzate a sostenere il paziente
nella fase ultima del decorso della sua malattia.
Obiettivo primario di questo approccio terapeutico è di
mantenere il più possibile elevata la qualità di vita residua, il
livello di dignità e decoro della persona malata. In altre parole
le Cure Palliative si prefiggono lo scopo di umanizzare la
relazione terapeutica.
Umanizzare significa considerare e tenere insieme le
dimensioni e le esigenze della persona. Riconoscendo che
anche se paziente e in grande sofferenza, l’uomo è
protagonista della propria vita e della propria morte.
Con le Cure Palliative è avvenuto il passaggio, nel campo
medico-sanitario, dal modello bio-medico, centrato sulla
malattia, a quello psico-sociale centrato sulla persona.
6
1.4
PER QUALI PAZIENTI LE CURE PALLIATIVE SONO UNA
RISPOSTA APPROPRIATA ?
Stimare il fabbisogno di Cure Palliative non è cosa facile. Per
fare ciò si possono utilizzare diverse fonti di dati in parte
provenienti da statistiche correnti, in parte presenti nella
letteratura scientifica sull’argomento. Più precisamente, è
possibile utilizzare:
- la mortalità specifica per causa, per stimare il numero di
pazienti che sono deceduti dopo aver attraversato una
fase
terminale
di
malattia
caratterizzata
da
una
compromissione della qualità di vita;
- i risultati di studi prospettici e retrospettivi che hanno
stimato la prevalenza dei problemi dei pazienti nei loro
ultimi mesi di vita;
- i dati di utilizzo dei servizi, in primo luogo, quelli di Cure
Palliative laddove esistono.
La fase terminale di malattia è stata stimata nella sua
incidenza e durata solo per i pazienti oncologici. La
maggior parte degli studi sono stati condotti in
Inghilterra e Stati Uniti,e il trasferimento dei dati
potrebbe rivelarsi non appropriato.
7
La compromissione della qualità di vita durante la fase
terminale del paziente oncologico è studiata in studi
retrospettivi
(condotti
intervistando
il
caregiver
principale del paziente deceduto) e in studi prospettici (
condotti su coorti di pazienti seguiti dai servizi).
L’approccio retrospettivo permette di studiare campioni
rappresentativi dei deceduti per tumore, ma sconta il
limite della difficoltà a “ricordare” da parte del
caregiver. L’approccio prospettico su coorti di pazienti
seguiti dai servizi di Cure Palliative è più preciso nella
valutazione della compromissione della qualità di vita,
ma
è
basato
su
campioni
non
rappresentativi
dell’insieme dei deceduti. I dati riferiti all’utilizzo dei
servizi scontano il limite dell’impossibilità di includere
nella valutazione i bisogni non soddisfatti dai servizi
esistenti: si fa riferimento ai pazienti che avrebbero
potuto ricevere beneficio da interventi specifici di cure
palliative, ma che non sono stati presi in carico in modo
appropriato.
Tutte le tre fonti citate possono essere utili al fine di riuscire
a stimare il fabbisogno di cure palliative nei pazienti
oncologici.
Studi condotti in diversi paesi sono concordi nello stimare
quanto segue:
il 90% dei deceduti per tumore necessita di interventi di
cure palliative, a diverso livello di complessità;
la durata media della fase terminale è stimata in circa 90
giorni;
il 15-25% beneficerebbe di ricoveri in strutture tipo
Hospice.
8
2. LA MORTE (L’ESPERIENZA DEL VIVERE E DEL MORIRE).
La morte non è un evento particolarmente situabile all’inizio
o alla fine dell’esistere, ma è sempre presente come
anticipazione dell’evento.
“....Dal momento che la morte non è comprensibile se non
come possibilità, tale comprensione si dà appunto come
l’anticipazione emotiva di essa, cioè come angoscia. Essa
implica la consapevolezza della propria finitudine e della
strutturale impossibilità, per chi vive autenticamente, del suo
velamento. Al contrario comprensione di un’oscurità cui
apparteniamo da sempre, che ci ha partoriti e che ci richiama
verso di sè, ciò da cui veniamo e ciò verso cui, come alla
propria origine, tendiamo....”. (3)
Le idee attuali sulla morte e le relative immagini sociali hanno
creato modelli di rappresentazioni collettive che nulla hanno
a vedere con quanto l’umanità ha sperimentato negli anni
passati. In passato la morte era un evento noto a tutti che
accadeva generalmente in casa alla presenza dei figli e dei
nipoti piccoli: era un normale avvenimento della realtà e
dell’esistenza che non richiedeva spiegazioni, giustificazioni
o nascondimenti.
Morte e vita erano considerati eventi ugualmente sacri, cioè
tolti dall’arbitrio dell’uomo e ricomponibili solo a livello di
una visione superiore, la vita e la morte quali fasi di
passaggio verso l’eternità. Il tema della morte per il “mistero”
che coinvolge e la complessità dei problemi che propone,
richiede riferimenti culturali che superano i confini della
clinica strettamente intesa. La morte è un personaggio
scomodo e la si vorrebbe dimenticare dato che non riguarda
solo il singolo uomo, ma che inevitabilmente, prima o dopo
riguarderà l’Umanità stessa.
Nelle società tradizionali la morte non rappresenta la fine
definitiva ed irreversibile dell’individuo ma soltanto un
cambiamento
di
stato,
preludio
alla
rinascita
e
al
miglioramento oppure la continuazione della vita stessa in
un’altra dimensione, in un mondo parallelo.
Nella visione delle società moderne la morte è considerata un
fatto tragico perchè intesa come la fine dell’esistenza
individuale; è l’antitesi della vita stessa nonchè interruzione
di un processo produttivo. Per l’uomo moderno la morte è
sempre più indice di “fallimento” e pertanto è inaccettabile.
La negazione della morte oggi è l’ultimo tentativo disperato
del malessere di una società efficientista.
Per i curanti in genere la morte rappresenta l’insuccesso di
cui vergognarsi e per questo motivo viene allontanata. La
conseguenza pratica è quindi la fuga di fronte all’uomo che
muore; essa si concretizza o con l’accanimento nella cura
della malattia o con il diradarsi degli incontri interpersonali.
Freud ha affermato che l’inconscio non riconosce la propria
morte
perchè
si
considera
immortale:”
E’
davvero
impossibile immaginare la propria morte; ogniqualvolta
proviamo a farlo, ci accorgiamo che in realtà siamo presenti
solo e sempre come spettatori”.
Da tempo si parla del diritto alla vita e solo da poco si chiede
che anche morire con dignità e serenità sia riconosciuto
come un diritto del malato.
Bisogna in ultimo ricordare che ciò che oggi più di tutto
spaventa, soprattutto i familiari, non è tanto la morte in sè,
quanto tutto ciò che la precede con tutte le sofferenze che
una persona deve subire prima di spegnersi.
Mansell Pattison definisce diversi tipi di morte:
la morte sociale: cioè il rito e la separazione del
paziente dagli altri. Può accadere giorni o settimane prima
della fine, se il paziente viene lasciato solo a morire;
la morte psichica: la persona accetta la propria morte e
si ritira in se stessa. Può essere accompagnata dal
naturale indebolimento dello stato fisico e può precedere
la fine;
la morte biologica: l’organismo come entità umana non
esiste più, non vi è coscienza nè consapevolezza;
la morte fisiologica: gli organi vitali come cuore,
polmoni e cervello non funzionano più.
Il
nostro
compito
di
caregivers
formali
è
quello
di
sincronizzare i diversi tipi di morte, facendoli convergere on
modo ottimale. Possiamo raggiungere questo obiettivo
aiutanto il
paziente e i
suoi
familiari
a comunicare
apertamente perchè entrambi possano vivere la fase della
terminalità nel modo più adatto a loro.
2.1 L’INTERVALLO TRA IL VIVERE E IL MORIRE.
Secondo il pensiero di Elisabeth Kubler-Ross
Tutti noi viviamo proiettando una traiettoria nel futuro;
prevediamo cioè un lasso di tempo all’interno del quale
programmiamo le nostre attività e pianifichiamo la nostra
vita. Improvvisamente possiamo trovarci di fronte alla crisi:
la crisi della presa di coscienza della morte. Per una malattia
o per un incidente la nostra ipotetica traiettoria muta di
colpo. Scopriamo che moriremo nell’arco di pochi giorni, di
settimane, di mesi, o anche di anni. La prospettiva della
nostra
vita
si
è
ristretta;
ogni
attività
deve
essere
riorganizzata. Non possiamo programmare ciò che è solo
ipotetico: dobbiamo confrontarci con ciò che è attuale.
L’intervallo tra il vivere e il morire è proprio quello che sta tra
la crisi della presa di coscienza della morte e il momento
della morte stessa. (Fig. 1)
Fig. 1
Crisi della presa
di coscienza della
morte
Potenziale traiettoria
di morte
Momento della morte
Traiettoria reale di morte
INTERVALLO DEL VIVERE-MORIRE
Elisabeth Kubler-Ross in On Death and Dying (Sulla morte e
sul morire), sua opera fondamentale, ha delineato le sue
osservazioni sul processo della morte coordinandolo in una
serie di fasi o stadi: ha cioè intuito che il morente, in risposta
al suo morire, attraversa in modo tipico, anche se non
consequenziale, una serie di fasi o reazioni psicologichecomportamentali. Tutto ha inizio con il concetto di “verità” da
rivelare al malato e/o ai familiari. E. Kubler Ross afferma che
per raggiungere l’ultima fase, quella di accettazione, è
necessario superare la “congiura del silenzio”. La rivelazione
della verità al malato non è un punto di partenza, ma di
arrivo. E’ una scelta che investe l’intero gruppo assistenziale
e familiare che è preparato a sostenerla e che conosce le
implicazioni psicologiche per il paziente e per chi lo assiste.
Il 7 Maggio 2004, durante una visita domiciliare con il Dott.
Peruselli (Resp. UOCP di Biella) ad un paziente affetto da
Carcinoma epatico, in fase ultima di vita, la moglie ci confida:
” Il peso più grosso che devo sostenere con mio marito è
quello di far finta che tutto vada bene: le gambe gonfie si
sgonfieranno, e così la pancia. Non posso farcela, temo che
lui possa leggermi sul viso ciò che le mie parole non
dicono....”.
Dire
la
verità
significa
impegnarsi
ad
una
coerenza
individuale e collettiva e ad una disponibilità sicuramente
maggiori che se si optasse per “la congiura del silenzio”.
Secondo la kubler Ross la prima fase del paziente che
conosce la verità sulla sua malattia ( e dei familiari) è quella
del RIFIUTO che si concretizza con la frase: “no, non a me” .
La fase successiva è quella della RABBIA: “ perchè a me?” I
familiari attraversano lo stesso stadio: “Dio, perchè?” E’ una
fase molto difficile sia per la famiglia, sia per l’equipe
assistenziale in quanto il malato è collerico, insoddisfatto,
insulta e minaccia.
Il
terzo
stadio
è
più
tranquillo;
è
quello
della
CONTRATTAZIONE, (della vendita dell’anima al diavolo) . Il
paziente ha accettato che “sta accadendo a lui” e che la sua
ira non cambierà la sorte; richiede più tempo per “risolvere i
suoi problemi”. Per esempio, chiede di vivere fino alla
comunione del nipote, al matrimonio del figlio e, raggiunto
questo obiettivo, propone nuove contrattazioni.
Lo stadio o fase successiva è quella della DISPERAZIONE.
Coincide generalmente con la ricomparsa dei sintomi e/o con
il rapido decadimento dello stato generale di salute (che
richiedono
spesso
trattamento
un
infruttuoso),
nuovo
o
ricovero
spesso
ed
con
lo
un
nuovo
sgretolarsi
dell’organizzazione familiare non più in grado di sostenere un
onere così gravoso soprattutto se non sostenuta da Servizi
esterni (UOCP, ADI, Hospice). Il malato chiede che gli
vengano
risparmiati
prelievi,
indagini
radiologiche;
è
impegnato in un compito più vasto: prepararsi a morire e ad
analizzare quelle cose da lui in precedenza sottovalutate. E’
silenzioso ed il suo silenzio va rispettato: basta la presenza.
La speranza non va comunque mai troncata: si affronta il
“qui e ora”. Se il paziente ne ha il tempo raggiunge la fase
dell’ACCETTAZIONE. Non è uno stadio felice, ma d’intensa
sensazione da condividere con la famiglia o con le persone
care. Il malato è contento di non essere solo. (Fig. 2)
Le cinque fasi sopra riportate non sono da considerarsi in
sequenza cronologica e ordinata; tali fasi possono avere
invece una durata variabile e si possono sovrapporre in tutto
o in parte per evolversi in modi e forme spesso differenziate.
Fig.2
LA CARTA DEI DIRITTI DEI MORENTI
Ho il diritto di essere trattato come un uomo vivente finchè non sia morto.
Ho il diritto di conservare un senso di speranza qualunque cosa accada.
Ho il diritto di essere curato da coloro che possono conservare un senso di
speranza qualunque cosa accada.
Ho il diritto di esprimere a mio modo i miei sentimenti e le mie emozioni per
l’avvicinarsi della mia morte.
Ho il diritto di partecipare alle decisioni riguardanti la mia assistenza.
Ho il diritto di attendermi continue attenzioni mediche ed infermieristiche finchè
l’obiettivo di cura non debba essere mutato nell’obiettivo del conforto.
Ho il diritto a non morire da solo.
Note: CARTA DEI DIRITTI DEL MORENTE (da R.L. mcIntyre, Medical Decision-Making and
Patients’ Rights-Ethical and Legal Issues, in A.R. Somers e D.R. Fabian, The geriatric
Imperative: An Introduction to Gerontology and clinical Geriatrics, Appleton-Century-Crofts,
New York 1981, p.73.)
3. Aspetti psicologici del malato terminale.
I malati oncologici in fase avanzata di malattia si confrontano
con
la
natura
progressiva
della
patologia
e
con
il
conseguente deterioramento delle funzioni fisiologiche.
L’individuo è in crisi, ha paura perchè nella nostra
educazione e cultura si sfugge all’argomento morte e
bisogna allora rimuovere questo tabù con determinazione e
coraggio. Per il malato in fase ultima di vita la nozione del
tempo non è suddivisa in passato, presente e futuro, ma è
concentrata su un tempo unico, il presente. Per lui vivere è
trovarsi nel presente e il presente resta tale anche quando si
è certi che entro breve non ci sarà più futuro. Non c’è più
tempo e il tempo diventa tempo per sè e a sè. La vita del
malato terminale possiede un’intensità che non possiamo
immaginare. La sua sensibilità è altissima. Sembra che possa
leggere nel nostro cuore. Intuisce l’angoscia e la paura di chi
gli è vicino, capisce quello che gli si cerca di nascondere.
Pare che la sua comprensione non sia più filtrata dagli
schermi abituali dell’educazione e delle relazioni sociali. In
genere
c’è
una
diminuzione
degli
interessi
e
delle
preoccupazioni, ci sono brevi periodi di limitata attenzione e
lunghi periodi di quieta vigilanza o sonno leggero, alternati a
brevi momenti di attività o a manifestazioni di disagio o di
necessità.
Sensazione di fallimento e oscuro senso di consapevolezza
fanno parte di ogni malattia deteriorante, sia che uno sappia
o no di star morendo.
I maggiori problemi del malato sono: la paura di un
silenzioso isolamento a causa di mancanza di comunicazione
con i familiari e operatori sanitari, la paura di dolori
insopportabili, la paura di perdere la capacità di comprendere
e di essere privato di tutti i poteri decisionali. Nell’ammalato
grave, in modo particolare quello alla fine della vita,
emergono
invasivamente
quelli
che
vengono
chiamati
“fantasmi infantili”: intesi come ricordi, “vissuti”, delle
fantasie e delle situazioni infantili appunto per cui l’ammalato
tende ad assumere molti degli atteggiamenti propri di un
bambino. Poichè la sofferenza è sgradevole e il pensiero
della fine è pauroso, tutto ciò viene vissuto come “ingiusto”.
“...il paziente terminale entra in un silenzio interiore. Il
silenzio è uno ma le strade per comprenderlo sono infinite ed
ognuna ha lo stesso carattere di unicità dell’essere a cui
appartiene. Il silenzio di una persona non è quello di un’altra
e, all’interno della stessa persona, ci sono tanti gradi di
silenzio, tuttavia nessuno di questi è paragonabile al silenzio
della sua morte: ogni grado di silenzio in vita introduce ed
appena educa al silenzio in morte. Un grido così grande che
implora aiuto, grazia, amore e speranza di vita, non può
essere taciuto: nessun suono di linguaggio verbale può
esprimere la sofferenza ch’esso contiene. Laddove un urlo
della voce si perderebbe nel nulla, fra la confusione dei suoi
mille echi, un grido tacito invece apre l’orizzonte umano agli
spazi della trascendenza....” (4)
In verità il morire spesso comincia proprio appena fatta la
prima diagnosi . Talvolta però il suo significato non si palesa
finchè la progressione metastatica o il progredire della
malattia non obbligano il paziente a dipendere fisicamente e
socialmente da qualcun altro.
La malattia terminale mette la persona morente alla mercè di
altre persone. Il malato alla fine della vita è quindi un a
persona che soffre per funzioni lese, per segni e sintomi
(dolore, fatigue, dispnea, cachessia, ecc.), per problemi
psicologici e sociali direttamente o indirettamente connessi
alla patologia di base.
La perdita di ogni speranza e il senso di isolamento
rappresentano l’aspetto peggiore della sofferenza di questi
pazienti. Il confronto con la realtà produce nell’ammalato alla
fine della vita un’ansia legata ad un’esperienza difficile da
condividere e che, da un certo punto in poi, deve affrontare
da solo. Il malato che sta per morire spesso “sente” quando
la morte è vicina e la sente indipendentemente dalla gravità
del male, dalla prognosi formulata dai medici, da quanto gli
viene detto. Colui che è vicino alla morte percepisce che la
fine sta arrivando osservando se stesso, osservando le
persone intorno a lui.
NOTE: R. Sala, “Di fronte al morente”. Aspetti filosofico-Antropologici.” In Elio Sgreccia,
Antonio G. Spagnolo, Maria Luisa Di Pietro, “L’assistenza al morente”. Aspetti socio-culturali,
medico-assistenziali e pastorali”, Ed. Vita e Pensiero, Pubblicazioni dell’Università Cattolica,
del sacro Cuore, Milano, 1994
Il 9 Gennaio 1987 a casa del Sig. Pietro, affetto da
microcitoma multiplo polmonare con metastasi epatiche, in
fase terminale, nel sollevare la tapparella della finestra per
dar luce alla stanza, lui mi si rivolge dicendo: “ Tieni su la
tapparella. Oggi c’è il sole, lascia che io possa goderne un
pò. Oggi è l’ultimo volta che vedo il sole ”. Il Sig. Pietro
muore il 10 Gennaio 1987 alle ore 05.30.
Il paziente terminale si trova ad affrontare la riattivazione di
problemi non risolti prima e che riguardano i rapporti con gli
altri, giungendo a rotture nelle relazioni affettive. Una malattia
mortale è deleteria per le eventuali vocazioni, per le ambizioni
scolastiche, per i normali rapporti tra la coppia e tra i genitori
e i figli, per la stabilità finanziaria e per il modo stesso di
vivere. Una malattia prolungata mette in crisi i sistemi di
assistenza sociale dentro e fuori la famiglia e comprende
anche la riduzione delle risorse finanziarie e l’incrinamento
del rapporto paziente-famiglia.
I pazienti oncologici in fase avanzata di malattia devono
confrontarsi con la natura progressiva della patologia e con il
conseguente deterioramento delle funzioni fisiologiche. Le
modificazioni corporee, la comparsa e l’aggravarsi dei
sintomi, la diminuzione e la perdita dell’autosufficienza si
accompagnano a numerosi cambiamenti che incidono
pesantemente sull’equilibrio psicologico non solo della
persona, ma di tutta la famiglia. Tutto il corpo viene
compromesso dalla malattia neoplastica sia in relazione alla
localizzazione della stessa ed alla sua espansione, sia per i
trattamenti ai quali viene sottoposto. In ogni caso il malato ha
l’impressione di perdere ogni potere e ogni controllo sul
proprio corpo. Il paziente passa alla “consegna” del proprio
corpo a tanti curanti diversi (medici, infermieri, fisioterapisti,
ecc.) come se fosse solo un oggetto, l’oggetto malato che è
sempre più difficile riconoscere come sè. Si sentono vinti,
quasi come se il diritto alla speranza di vivere non avesse più
senso. (5)
NOTE: G. Morasso , F. Cianfraglia, F. De Falco, M. Tamburini, C. Borreani, V. Fontana “La
risposta psicologica del paziente all’esperienza “cancro”: analisi della fase avanzata di
malattia”, Masson, Milano 1989.
“...L’isolamento esistenziale è sperimentato dall’uomo che è
vicino a morire con un senso di allontanamento dai vivi. Il
poter comunicare con il mondo sociale, dà al morente la
sensazione di condividere con un altro essere umano il suo
isolamento esistenziale. In questo modo il morente può
esprimere anche la paura della morte che si delinea sempre
più forte con il progredire della malattia e l’avvicinarsi della
fine. La paura della morte porta all’isolamento sociale perchè
fa nascere una certa distanza fra noi e quei malati che sono
“minacciati” di morte. Il malato è e sarà sempre solo, come
solo è l’uomo nel momento della finale accettazione della sua
morte. Il silenzio prende il sopravento, e con il silenzio la
solitudine e la paura, spesso non verbalizzata, non solo della
morte ma anche della durezza del morire....” (6)
NOTE: E. Seravalli, “Solitudine del malato terminale” in G. Morasso, G. Invernizzi, “Di fronte
all’esperienza di morte: il paziente e i suoi terapeuti”, Masson, Milano 1989.
4. “PRENDERE IN CARICO” 0 “PRENDERSI CURA”?
Chi si occupa del malato oncologico in fase ultima di vita?
Per troppo tempo si è usato in maniera quasi automatica e
superficiale il modo di dire: “prendere in carico”, termine sul
quale è invece necessario fermarsi a riflettere. Se da una
parte infatti tale espressione rimanda all’assunzione per
intero, con autorevolezza e competenza, di un “fardello”
anche gravoso, quale è un malato in fase ultima di vita,
dall’altro segna una delimitazione precisa rispetto a quei
pazienti terminali che per vari motivi (non esistenza di UOCP
e/o Hospice, Servizi ADI, ecc.) non è stato possibile
“prendere
in
carico”
e
che
pertanto
sono
rimasti
sostanzialmente “a carico” delle famiglie o in appoggio a
Case di riposo.
Il concetto di “prendersi cura” è invece profondamente
diverso, poichè delinea un “tutoring” ad intensità variabile
(dalla più “leggera” alla più “pesante”), nell’ambito di una
responsabilizzazione di più ampio respiro di ciascun servizio,
sia rispetto ai singoli che alla comunità nel suo complesso: si
tratta infatti di un intervento professionale da parte di equipe
multi-disciplinari a tutto campo, che va dalla lettura attenta
della comunità attraverso ben precise “mappe di rischio”
(quanti casi di neoplasie/per abitanti, la composizione dei
nuclei familiari di una determinata zona e/o quartiere, quali le
risorse), alla “facilitazione” di contatti tra la famiglia e le
associazioni di volontariato, le ONLUS, la Lega Tumori, fino
all’assunzione di responsabilità dirette, talvolta anche molto
onerose, del servizio pubblico nel suo complesso (ad
esempio per mantenere al domicilio malati con una prognosi
di sopravvivenza inferiore ai 90 giorni, in condizioni di grave
dipendenza).
Da quanto sopra riportato si evince la grande diversità tra il
“prendere in carico” attraverso uno o più ricoveri ospedalieri
in Unità operative la cui tipologia non rispecchia l’ottica delle
Cure Palliative di fine vita e, il “prendersi cura” vero e proprio
delle Cure Palliative che davvero può cambiare tanta parte
del nostro modo di lavorare nella comunità.
Quanto fin qui affermato deve tradursi nella necessità che
ciascun Servizio, sia esso UOCP, Hospice, ADI, sappia
individuare, raccogliere e valorizzare l’esperienza e la
disponibilità di tutte le risorse formali ed informali che
ruotano intorno a ciascun paziente neoplastico in fase
terminale di malattia, ma anche quelle ancora soltanto
potenziali, e perciò da stimolare, far nascere e crescere.
Senza voler nascondere le ormai note esigenze di contenere
la spesa sanitaria, credo che oggi si possa tentare di
utilizzare le innegabili “criticità” per ripensare la relazione
con le famiglie ed i caregivers, il cui ruolo deve essere
valorizzato, riconosciuto e concretamente sostenuto con
azioni concertate e condivise a partire dal nostro Welfare. Nei
confronti della famiglia il Servizio pubblico può e deve
diventare interlocutore privilegiato, sia nella definizione
concordata dei singoli programmi assistenziali, che in veste
di “soggetto esperto” a cui affidare semplicemente una
funzione di garante rispetto all’uso di risorse private, o
all’interno
dei
percorsi,
talvolta
molto
complessi,
di
assistenza, cura e accompagnamento.
E’ proprio in quest’ottica che si rende più che mai
necessario, in ambito palliativo, ribadire il seguente concetto:
la persona malata in fase terminale di malattia è inscindibile
dal proprio ambiente di vita, di affetti e relazioni; per questo
ogni programma a lei rivolto non può che tenerne in debito
conto, mirando anzitutto ad individuare e valorizzare le
risorse, le specificità e le valenze disponibili.
4.1 IL CAREGIVER: FORMALE E INFORMALE.
Letteralmente, dall’inglese, è “COLUI CHE PRESTA LE
CURE”.
Si possono distinguere:
il “caregiver” informale o primario, che in genere è il
coniuge, il figlio/a, un genitore, più raramente un altro
familiare;
il “caregiver” formale è costituito invece dall’equipe
multi-disciplinare di Cure Palliative, dall’Infermiere del
Servizio
Domiciliare,
dell’UOCP,
dallo
psicologo,
dall’algologo, dal fisioterapista.
In Italia i caregivers informali sono:
- 22,5% della popolazione con oltre 14 anni;
-
le donne aiutano più degli uomini: 28,7% contro il
21,8%;
- la percentuale di caregivers è maggiore nel Nord e in
particolare nel Nord-est: 27,9% e 37,2%;
- la percentuale di caregivers scende al diminuire del
grado di istruzione, più per gli uomini che per le donne:
26,6% dei diplomati e 12% di quelli senza titolo di studio
per gli uomini, 31,1% e 23,2% per le donne;
- se gli uomini lavorano la percentuale di caregivers e ol
19,1%, se la donne lavorano è il 26,5%.(*)
Il caregiver, sia esso informale che formale, ha un ruolo
nodale nella storia della malattia, a partire dal suo esordio
fino agli ultimi istanti di vita. Quando l’onere dell’assistenza
ricade in maggior misura sul familiare, si parla di “seconda
vittima” del cancro, per mettere in risalto il grado di
coinvolgimento e di stress a cui viene sottoposto. Ambedue
le vittime della malattia, il malato e il familiare che lo
accudisce, hanno bisogno di aiuto. Mentre per il malato
questo risulta evidente, per il familiare spesso bisogna
superare la sua possibile incapacità a manifestare questo
bisogno.
*NOTE: Dati tratti dall’indagine Multiscopo sulle famiglie condotta dall’ISTAT nel 1998.
L’aiuto di cui ha bisogno una famiglia al cui interno vi è un
malato terminale può essere di diverso tipo:
PRIMARIO
O
CONCRETO,
per
quanto
riguarda
l’organizzazione delle cure a casa, della vita, nella
risoluzione dei problemi pratici inerenti il controllo dei
sintomi ad esempio, nell’agire in modo competente nei
confronti dell’ammalato;
PSICOLOGICO, necessario per affrontare tematiche
importanti che emergono sempre nell’accudimento di una
persona alla fine della vita ( la sedazione terminale, la
morte, l’eutanasia) e che, se ignorate, porterebbero il
caregiver ad un “catastrofico” esaurimento.
4.2 IL CAREGIVER FORMALE.
Ancora oggi per gli operatori sanitari, siano essi infermieri
che medici, non è facile concepire la morte al di là dell’evento
biologico. Essa invece costituisce una realtà che riguarda
l’intera persona e tutta la famiglia. Il superamento di questo
ostacolo rappresenta il passo decisivo per poter aver cura di
una persona sofferente e per comprendere come ogni malato
ha il diritto di morire nel modo più sereno e dignitoso
possibile, con un sostegno terapeutico e, se lo desidera,
possibilmente in un contesto familiare.
Assistere un malato in fase ultima di vita significa, dal punto
di vista infermieristico, aiutarlo a restare sino alla fine, per se
stesso e per i suoi, un uomo o una donna vivente, cioè un
essere umano capace di un desiderio che bisogna capire e
soddisfare, di una dignità che è necessario rispettare.
Di fronte al malato terminale l’operatore sanitario può trovare
nuovi scopi, nuove gratificazioni, nuovi ruoli solo se, calato
in una nuova atmosfera culturale, si rende conto che
“curare” (to cure) non vuol dire sempre guarire, ma
“prendersi
cura
di”
(to
usando
care),
anche
l’arma
terapeutica dell’ascolto, dell’attenzione, della solidarietà,
inquadrando il paziente nella sua unicità, con i diritti
personali inviolabili. Tanto più il paziente affetto da malattia
terminale procede nel suo cammino, tanto meno ha bisogno
di
una
visione
organicistica
e
settoriale
fortemente
medicalizzata.
Il processo terapeutico-assistenziale si modifica: l’intervento
farmacologico assume un ruolo meno rilevante e relegato
solo al contenimento dei sintomi (dolore, dispnea, ecc.),
mentre
diviene
relazionale.
preminente
Ambedue
i
l’aspetto
momenti
comunicativo-
terapeutici
sono
indispensabili, mai separabili ed hanno uguale dignità.
Come non è etico affrontare un problema medico e/o
farmacologico, senza l’aggiornamento costante e senza tener
conto dell’evidenza scientifica (EBM), così non è pensabile
improvvisare una competenza infermieristica nei delicati
meccanismi
relazionali.
che
regolano
i
processi
comunicativi
e
4.3 LA RELAZIONE INFERMIERE-MALATO TERMINALE.
I professionisti della salute, a qualsiasi livello, devono essere
adeguatamente formati affinchè, possano essere in grado,
non solo di affrontare i problemi clinici per aiutare il corpo,
ma a far fronte all’approccio umano verso l’essere nella sua
totalità.
Ogni malato porta nella relazione con il curante la sua storia
attuale di malattia ma anche il proprio sistema di riferimento
culturale e valoriale, sia come ogni infermiere si trova
coinvolto sia come operatore con un ruolo terapeuticoassistenziale, sia come individuo con il proprio bagaglio di
esperienze personali.
L’assistenza ad un malato alla fine della vita è un’arte. Si
tratta di costruire una squadra vincente che non sbagli una
porta. La sfida non è segnare dei punti contro la malattia e la
morte, ma con entrambe.
Le funzioni dell’infermiere sono finalizzate in gran parte
all’identificazione e alla soddisfazione dei bisogni del
paziente, bisogni che interessano diverse aree:
l’area fisiologica:
- bisogno di maggiore controllo dei sintomi;
- bisogno
di
migliorare
e
ripristinare
dell’alimentazione, del sonno;
- bisogno di far fronte alla cura della persona;
la
qualità
l’area emotiva:
- bisogno di rassicurazione;
- bisogno di informazione sulla malattia e sul suo
decorso;
- bisogno di non morire solo;
l’area sociale:
- bisogno di comunicare con i familiari e le persone care
riguardo alla malattia;
- bisogno di occupare la giornata in modo soddisfacente;
- bisogno di assistenza per le necessità pratiche.
Lavorare con i malati terminali, parlare con loro e capirli
provoca intensi sentimenti personali, fa sorgere alcune delle
più profonde paure:
paura dell’estinguersi
paura dell’essere impotenti
paura di essere abbandonati
paura di essere sfigurati e non più riconoscersi
paura di perdere la propria dignità
Essere professionisti significa saper stare accanto al malato
e parlare con lui. La comunicazione con il malato alla fine
della vita implica, da parte dell’operatore, la disponibilità ad
ascoltare ed eventualmente ad accogliere le sofferenze non
solo del singolo malato ma, molto spesso, le sofferenze di
un’intera famiglia.
Ogni morte ci ricorda la nostra morte.
Freud ha affermato che l’inconscio non riconosce la propria
morte
perchè
si
considera
immortale:
“E’
davvero
impossibile immaginare la propria morte; ogniqualvolta
proviamo a farlo, ci accorgiamo che in realtà siamo presenti
solo come spettatori “.
Questa osservazione di Freud ci dice che noi abbiamo paura
del mistero della morte. D’altra parte, osservazioni più recenti
suggeriscono che l’angoscia della morte non riguarda la
morte fisica, ma i sentimenti primordiali di abbandono e di
impotenza. La paura del mistero della morte è la paura del
mistero dell’annientamento dell’Io, dell’essere, dell’identità.
Improvvisamente si è consapevoli che la nostra nonesistenza è possibile.
La necessità di avvicinarsi al malato non più soltanto con lo
sguardo oggettivante della scienza medica, ma con uno
sguardo che consenta di cogliere gli aspetti soggettivi della
consapevolezza di malattia significa mettere in discussione e
ridefinire il proprio ruolo di curante. Questo rapporto
quotidiano
con
la
sofferenza,
con
la
morte,
crea
nell’operatore ansia legata a conflitti esterni ed interni;
conflitti legati all’ambiente di lavoro, non organizzato in
maniera ideale, situazioni particolari in cui l’operatore deve
scegliere una determinata condotta rispettando i valori della
vita e della salute dell’uomo, i parenti che “scaricano” le loro
angosce sugli infermieri considerandoli responsabili delle
condizioni di salute e delle sofferenze dei propri cari.
I professionisti della salute devono avere il coraggio e la
volontà di riconoscere che i desideri del malato hanno la
priorità per permettere al paziente di usufruire del basilare
diritto di scegliere l’assistenza che desidera e dargli la
possibilità di porsi in rapporto con la sua morte imminente in
modo ricco di significato (etica dell’autodeterminazione). Il
contatto
con
la
malattia
e
la
sofferenza
è
sempre
caratterizzato da ostacoli emotivi, dovuti in parte alle
innumerevoli proiezioni che vengono messe in atto dagli
operatori nei confronti dei propri pazienti.
La sofferenza e la morte esprimono in qualche modo il
fallimento della propria opera. La disorganizzazione, la
difficoltà
nella
comunicazione
all’interno
dell’equipe
e
dell’istituzione, il non ascolto da parte dei dirigenti, il
contatto permanente e prolungato con i malati sofferenti o
moribondi comporta negli operatori l’insorgere di uno stato
d’animo di depressione.
“Quando nel 1981, subito dopo il Diploma, fui assegnata al
reparto di Ematologia del Prof. Marmont, dell’Ospedale S.Martino
di Genova, mi sembrò di toccare il cielo con un dito. Il primo
contatto l’ebbi con i pazienti in camera sterile, per lo più bambini
trapiantati di Midollo osseo, glabri e un pò avvizziti. Il contatto con
loro avveniva attraverso una paratia di plastica dove infilavo le
mani dentro dei guanti. Solo così potevo toccarli. Quando parlavo
con loro il mio fiato sulla plastica si condensava, appannava tutto
e rendeva le immagini sfuocate. Loro erano in isolamento e noi,
isolati da loro. Pesavo la loro pipì, le loro feci e calcolavo tutto il
giorno le entrate e le uscite; tutto ruotava intorno all’andamento
degli esami clinici. Ogni settimana moriva qualcuno. Dopo un
anno chiesi il trasferimento e andai a lavorare in reparto. Lì il
dolore era diluito e il contatto umano più ravvicinato: potevo anche
sedermi sul loro letto e tenere tra le mie la loro mano. Il più delle
volte avevamo una mascherina sul viso. Restavano fuori solo gli
occhi, lo specchio dell’anima. A quante mute domande non ho
saputo rispondere! Dopo 23 anni ho chiesto il trasferimento.
Adesso lavoro al Servizio di Day Hospital sempre dell’U.O. di
Ematologia: ho dovuto farlo per sopravvivere”. (Testimonianza di
Gianna Zappaterra Infermiera Professionale presso l’Azienda Ospedaliera
S.Martino di Genova).
4.4 DALLO STRESS AL BURN-OUT.
L’infermiere in continuo contatto con malati gravi, terminali,
va incontro a stress psichico che si manifesta in diversi
modi. A volte è un’indefinibile scontentezza di se stessi,
disamore per il proprio lavoro, la sensazione di non
soddisfare il paziente e di non essere partecipe all’equipe
assistenziale. Altri segni possono essere moti di ribellione,
aggressività verso pazienti e colleghi.
E’ particolarmente importante che, all’interno dell’equipe
assistenziale, vi siano delle figure che sia sul piano
professionale che sul piano psicologico si prendano cura
dell’infermiere in “crisi”, che può necessitare di ripetuti
colloqui, di supporto psicologico, di incoraggiamento, di
conferme e anche di chiarimento sul suo campo di attività e
responsabilità. L’assistenza ai malati di cancro in fase ultima
di vita richiede sempre nuova forza e fiducia, senza togliere
valore alla formazione e all’esperienza.
Le carenze dei servizi e una cattiva gestione, insufficienti
appoggi e consigli al personale sanitario, una cattiva
comunicazione, direttive troppo minuziose e un sovraccarico
di lavoro consumano la riserva di energie e contribuiscono al
fenomeno del burn-out.
Freudenberg (1974) utilizza per la prima volta in ambito socio
sanitario il termine burn-out (scoppiato, bruciato), usato sino
allora nel giornalismo sportivo anglosassone per descrivere
il brusco calo di rendimento di un atleta, dovuto al venire
meno dei stimoli motivazionali.
Maslach lo definisce una sindrome di esaurimento psichico
ed emotivo che provoca un atteggiamento “negativo” nei
confronti di se stessi e dell’immagine del proprio lavoro e
una perdita di sentimenti nei confronti del paziente.
I caregivers formali percepiscono questa situazione come
una distanza incolmabile tra la quantità di richieste che
giungono dagli utenti/clienti (sia interni che esterni), e le
risorse disponibili (individuali e organizzative) per rispondere
positivamente a tali richieste.
Manifestazioni tipiche di questo stato di esaurimento sono:
mal di testa
mal di stomaco/sintomi gastrointestinali
rigidità nucale
insonnia e stanchezza
mal di schiena
uso di farmaci
cambiamenti nelle abitudini alimentari
difficoltà a prendere decisioni
incapacità di ascoltare gli altri
propensione alla collera
tendenza ad essere suscettibili e irritabili
utilizzo di un linguaggio denigratorio
evitamento del coinvolgimento limitando la quantità e la
qualità dei propri interventi professionali fino a fuggire
dalle richieste di
aiuto
e sottovalutare
i
problemi
dell’utente
caduta dell’autostima e della fiducia nelle proprie
capacità personali e professionali
un modo di fare duro e ostinato che può rendere
pesante l’atmosfera all’interno dell’equipe assistenziale.
Tale fenomeno di sovraccarico, detto anche burn-out, può
essere evitato:
conoscendo e accettando i propri limiti;
migliorando l’ascolto dei propri bisogni;
avendo spazi di approfondimento comuni (riunioni,
supervisioni, scambi, letture) – l’equipe come “nicchia”
di reciproco sostegno;
richiedendo e accettando aiuto
avendo spazi di divertimento e relax
avendo in generale “cura di sè”.
L’accompagnamento
comprensione,
alla
amore,
morte
non
condivisione,
è
fatto
ma
solo
anche
di
di
frustrazione, stanchezza, rabbia, ambivalenza e odio.
Permettere alla persona malata di affrontare l’angoscia di
morte,
quando
questa
è
ormai
prossima,
significa
identificarsi con “empatia” nella sua condizione, per aiutarla
ad esprimere i suoi sentimenti e le sue emozioni, per guidarla
a scoprire ed accettare la “sua” verità, cioè quell’unica verità
che in quel momento essa è in grado di comprendere,
affrontare ed elaborare.
Il lutto non è un “lavoro” da iniziare dopo la morte. Deve
cominciare prima, nella fase in cui la consapevolezza
dell’inguaribilità
della
malattia
si
sostituisce
all’atteggiamento mentale della lotta per la guarigione.
L’obiettivo finale è radicalmente cambiato, il traguardo non è
più la vittoria contro una patologia, ma un percorso dove gli
ostacoli aumenteranno progressivamente rendendo la marcia
ogni volta più faticosa e dolorosa. La finalità non è vincere,
ma partecipare offrendo il massimo di assistenza e di
conforto alla persona, sia essa assistita a domicilio, in
ospedale o in Hospice, permettendole di capire la nuova
situazione
che
l’impossibilità
si
di
è
venuta
vincere
la
a
creare,
gara,
di
accettare
rassicurandola
e
confermandole che non sarà mai abbandonata e che verrà
invece privilegiata la qualità della vita residua. Aiutare la
persona ammalata ad elaborare il lutto delle sue “perdite” è
parte integrante del “fare” infermieristico.
Dalla Lettera di San Paolo ai Corinti: “ Mentre il nostro uomo
esteriore se ne va in rovina, il nostro uomo interiore si
rinnova di giorno in giorno “.
Può diventare difficile stabilire un contatto con l’uomo
interiore, ma esso, anche se apparentemente non visibile o di
difficile accesso, continua ad esistere ad di là della malattia
e, a prepararsi per raggiungere il traguardo finale. ()
NOTE: Amanda Castello, “Il ruolo del personale non finisce con la morte del paziente”, in
“Nursing Oggi”, periodico trimestrale di cultura infermieristica, Lauri Edizioni, n.1, gennaiomarzo 1999, anno IV.
4.5 LA COMUNICAZIONE CON IL MALATO ONCOLOGICO IN
FASE ULTIMA DI VITA.
In alcune culture medici, personale infermieristico o familiari
credono
che
la
rivelazione
totale
della
verità
sia
pregiudizievole per il paziente; in altre culture si suppone che
si debba preferire una comunicazione che metta in luce la
verità. Dare cattive notizie è un compito comunicativo
complesso tenuto conto del grado di comprensione del
paziente, del soddisfacimento delle cure e del livello di
speranza residuo.
Un’insoddisfacente informazione spesso compromette il
rapporto curanti-paziente e/o famiglia.
Una comunicazione difficile, a qualsiasi stadio della malattia,
determina:
mancato coinvolgimento del paziente;
inadeguata fornitura di informazioni al paziente e alla
famiglia;
sconforto dei curanti, soprattutto per quanto riguarda la
prognosi.
Sarebbe opportuno optare per una valutazione individuale
dei bisogni e delle aspettative.
Il malato, d’altra parte, ha il diritto di sapere, già al momento
della diagnosi, tutto ciò che lo riguarda per superare l’ansia
dell’incognito e per poter avere la possibilità di gestire,
adattare e riorganizzare la propria vita in rapporto alla gravità
della malattia stessa.
Il problema della comunicazione si fa più difficile col paziente
in fase ultima di vita. I punti essenziali di cui bisogna tener
conto nella comunicazione col paziente terminale sono:
L’informazione,
la comunicazione,
il tempo,
il supporto psicoterapeutico.
Quando si parla di INFORMAZIONE ( in-formazione) non si
intende
la
comunicazione,
perchè
l’informazione
può
avvenire anche in termini di asetticità emotiva, con distacco
emozionale.
La COMUNICAZIONE comporta invece uno scambio tra due
persone e implica un certo coinvolgimento emozionale
dell’uno e dell’altro. E’ un elemento indispensabile perchè
permette
di
affrontare
tutto
quel
bagaglio
relativo
all’affettività, è qualcosa che deve essere fatto tenendo conto
che esistono dei movimenti e degli scambi emozionali da una
parte e dall’altra. Ci sono però nella comunicazione degli
elementi perturbanti dei quali tener conto e che sono definiti
da Cosnier come “rumori contestuali”. Esistono diversi tipi di
rumore:
“rumore
tecnico”:
è
un
rumore
proveniente
dall’ambiente, che è importante eliminare per creare un
certo tipo di facilitazione allo svolgimento delle manovre
terapeutiche.
“rumore semantico”: quando il curante, sia esso
medico o infermiere, parla con il suo paziente usa un
codice per cui la comunicazione è chiara per lo stesso
operatore sanitario, ma è equivoca per il paziente che la
riceve.
“rumore pragmatico”: nella comunicazione non si
guarda tanto quello che si dice, quanto piuttosto a quello
che si vuole fare.
“rumore cronologico”: il tempo in cui vive il malato
neoplastico viene chiamato “extratime” proprio perchè
vengono perduti, dopo l’annuncio della malattia, certi
parametri temporali in cui vive l’uomo normalmente.
Questo “extratime” fa sì che il cancro venga vissuto dal
paziente come una specie di “orologio marcatempo”, che
scandisce i ritmi della sua vita.
Quando noi parliamo del dire o non dire la verità nella
comunicazione, dovremo spostare il problema non sul fatto
di dire o non dire, ma sulla qualità e sul tipo di
comunicazione che si stabilisce con il paziente, nell’intento
di valutare quanto egli vuole sapere e può tollerare di sapere.
Ogni campo comunicativo è determinato da un complesso
interrelato che include:
un
soggetto
emittente
(colui
che
produce
il
messaggio);
il significato che esso attribuisce a ciò che dice;
un messaggio ( ciò che si vuole trasmettere);
un
contesto,
in
cui
il
messaggio
è
inserito
(l’ambiente, ad es.);
un canale, cioè un mezzo fisico-ambientale che rende
possibile la trasmissione del messaggio ( la voce, il
corpo, ad es.);
un ricevente
il significato che questi attribuisce al messaggio.
Occorre
inoltre
considerare
che
qualsiasi
espressione/messaggio è atto a venire interpretato in vari
modi dal ricevente a seconda dello schema interpretativo che
esso
presceglie
in
quel
dato
momento
e
in
quelle
circostanze. Un medico che informa il paziente, ma non
verifica se effettivamente c’è stata comprensione, non
comunica realmente.
Anche la distanza o la vicinanza corporea dal paziente con
cui intratteniamo un dialogo, distanza interpersonale distinta
in: zona intima, zona personale, zona sociale, zona pubblica
(Hall 1966), così come la nostra postura (posizione del corpo)
nei suoi confronti, sono esplicative della nostra familiarità o
del nostro disagio. Le espressioni del volto e la gestualità
rappresentano le aree più importanti sul piano espressivocomunicativo.
M. Balint ha riconosciuto nell’incontro tra curante e paziente
un desiderio più importante di quello del conoscere la verità
sulla propria malattia: il bisogno di essere ascoltato,
riconosciuto e creduto nelle proprie sofferenze. Ma il
paziente, quando nell’incontro con il suo curante può
descrivere la sua malattia, esprime una verità che è legata
strettamente al suo modo di immaginarla e che spesso è
impregnata di fantasie di distruzione e di morte. Queste
fantasie sono proprio ciò che il medico non vuole ascoltare, e
risponde
di
conseguenza
al
malato
filtrando
la
comunicazione attraverso la griglia della logica e della
razionalizzazione. La comunicazione si inaridisce a poco a
poco
e
si
trasforma
in
un’informazione
asettica
emotivamente, in un discorso tra sordi dove ognuno è
bloccato nella comunicazione dai propri fantasmi e dalle
proprie paure; fantasmi aleggianti attorno più al “non dire”
che “dire la verità”. Dire tutto o non dire niente sono due
facce dello stesso problema; cruciale è conoscere che cosa il
paziente desidera veramente sapere e quanto è in grado di
sopportare della sua diagnosi infausta (comunicazione a
piccoli passi). Se non vengono valutati e riconosciuti i
bisogni concreti e psicologici del paziente non può essere
attuata una valida e corretta comunicazione con il malato alla
fine della vita.
Alcuni pazienti non vogliono realmente sapere e il loro
bisogno va compreso e rispettato. Questa volontà deve
essere tuttavia cautamente verificata attraverso l’ascolto
empatico, la chiarificazione e l’interazione supportiva con la
persona nella sua totalità, come soggetto portatore di una
storia sulla quale si è innestato un evento “critico”.
Spesso medici e infermieri sono colti di sorpresa da
particolari domande che qualche volta i malati pongono e alle
quali spesso, se non si è ricevuto una formazione specifica,
si risponde in modo evasivo e con un certo imbarazzo. Dire la
verità significa assumersi le proprie responsabilità di curanti,
significa essere capaci di dire cise spiacevoli con molta
delicatezza.
4.5 IL GRIEF COUNSELLING.
5. IL CAREGIVER INFORMALE: RUOLO DELLA FAMIGLIA
NEL PERCORSO DI MALATTIA.
(Nessun uomo è un’isola)
“La famiglia di Padron ‘Toni era disposta come le dita della mano.
Prima veniva lui il dito grosso, cioè il padrone, il capo della
famoglia; poi suo figlio Bastianazzo grande e grosso ma che filava
dritto sotto le direttive del padre. Poi veniva la Longa, moglie di
Bastianazzo, che da buona massaia, tesseva, salava le acciughe,
e faceva figli. Infine i nipoti: ‘Toni, il maggiore, un bighellone di 20
anni che ogni tanto li buscava dal nonno; luca che aveva più
giudizio del grande; Mena chiamata anche S.Agata perchè stava
sempre al telaio; Alessi, un moccioso tutto suo nonno; e Lia
(Rosalia) ancora ne carne ne pesce. Alla domenica quando
entravano
in
chiesa,
l’uno
dietro
l’altro,
sembrava
una
processione”.
“Il nonno, Padron ‘Toni, morirà solo tra le bianche lenzuola,
all’ospedale, senza aver potuto fare ritorno alla vecchia “casa del
nespolo”.
(Brano tratto da “I Malavoglia di G. Verga)
Nel nostro paese, oggi più di ieri, la famiglia costituisce il
capitale sociale primario della società per almeno due ordini
di motivi:
1) perchè è a partire dalla famiglia che si genera la
coesione del tessuto sociale nella sfera del lavoro, della
partecipazione civica, dell’impegno pro-sociale, e non
viceversa;
2) la famiglia diventa sempre più decisiva agli effetti “dell’
assistenza “ e dell’accudimento delle singole persone,
perchè il benessere degli individuo dipende sempre di
più dal loro capitale sociale familiare.
Questo si concretizza, in modo particolare, quando un
componente della famiglia è malato in fase ultima di vita,
quando le cure attive lasciano il posto alle cure palliative.
Tale assistenza, definita informale, fornita prevalentemente
da familiari, è in maggior misura sulle “spalle” di persone a
loro
volta
anziane.
Nell’attuale
contesto
culturale
e
considerando le attuali risposte delle istituzioni ai bisogni di
chi è affetto da una patologia neoplastica terminale (
distribuzione a macchia di leopardo su tutto il territorio
nazionale di Hospice e Centri di Cure Palliative; in Piemonte
sono stati attivati 4 Hospice su 12 previsti), si può
quantificare in un terzo la popolazione che diventerà
fornitrice di assistenza – caregiver- per coniugi, genitori,
suoceri, ecc. Parte dei caregiver dovrà, e già deve, conciliare
tale attività con il lavoro; una minoranza inoltre è costretta ad
effettuare attività complesse (dal punto di vista assistenziale)
che richiedono o richiederebbero training, ausili tecnici e
consigli professionali.
Fornire assistenza – caregiving- è un impegno spesso
complesso e talora profondamente gravoso. Le possibili
motivazioni alla scelta di diventare caregiver possono essere
di natura sociale o di carattere altruistico piuttosto che
egoistico: per lo più la motivazione affonda nell’obbligo, nel
sentimento di responsabilità, per assecondare il desiderio
della persona malata, perchè non vi sono Servizi ai quali
appoggiarsi.
Una famiglia, al cui interno vi è un malato in fase ultima di
vita,
subisce un cambiamento di
velocità nel
vivere
quotidiano, sconvolgendo il prevedibile ed introducendo in
modo
accelerato
elementi
emotivi
e
traumatici
che
ingenerano uno stato di confusione, di crisi.
Bisogna comunque riconoscere che:
LA FAMIGLIA è il naturale terreno di risposta ai bisogni;
è il luogo fisico ed emozionale in cui i bisogni
dell’individuo, mediati tra le esigenze del singolo e le
esigenze degli altri membri, trovano il principale terreno di
soddisfazione (Famiglia autopoietica);
LA FAMIGLIA ha una propria cultura di risposta ai
bisogni che “l’expertise” professionale non può ignorare;
L’AUTODETERMINAZIONE del singolo e della famiglia
va riconosciuta e sostenuta;
il ruolo dei CURANTI deve essere di integrazione
rispetto alle risorse esistenti;
la trasmissione di CONOSCENZE e COMPETENZE gioca
un ruolo indispensabile al fine di creare un rapporto di
collaborazione e non dipendenza della famiglia, primo
passo per la restituzione della maggior autonomia
compatibile con la situazione di crisi;
intorno al malato si costruisce una rete di “HELPERS”
professionali e non che condividono il percorso comune
di malattia (pluralizzazione delle forme familiari).
5.1 RISORSE CENTRALI: CHI FA, CHE COSA.
Le relazioni familiari sono legami vincolanti e con poca
libertà, un continuo scambio pratico, emozionale e affettivo.
Si può contare su:
IL CONIUGE
I FIGLI (a)
FRATRIA
NIPOTI
DONNE (tra i 45 e i 64 anni)*
Chi si prende cura:
1) IL CONIUGE è la prima e principale fonte di aiuto per l’altro
( sia nelle coppie sposate –98%- che nelle unioni libere-2%-)
ASPETTATIVE DIVERSE NELLA CURA
I MASCHI SONO CURATI
DA MOGLIE E PARENTI
LE FEMMINE DALL’AMBIENTE
SOCIALE
2) nella cura le donne sono più brave:
la donna svolge le attività proprie della sfera femminile come
l’assistenza e l’accudimento; l’uomo tutte le attività che il
senso comune considera proprie della sfera maschile, quali
l’espletamento delle pratiche burocratiche e lo svolgimento
di lavori extra-domestici
3) nelle donne aumenta considerevolmente la tensione
emotiva e la depressione
3) la cura intragenerazionale è più faticosa di quella
intergenerazionale.
*NOTE: Dati tratti da l’indagine Multiscopo sulle famiglie condotta dall’ISTAT nel 1998
Se ci sono figli:
A) i genitori, specie se anziani, si aspettano in genere una
più aperta comunicazione e manifestazioni di affetto e
premura;
B) le madri hanno maggiori aspettative di essere aiutate
dai figli ( se adulti); se tali aspettative vengono disattese
le madri subiscono un più forte senso di fallimento;
C) se il figlio sente di aver subito ingiustizie, la relazione
con il genitore malato sarà ostile;
D) i figli curano sì, ma non gradiscono cambiamenti
nell’organizzazione familiare o del lavoro;
E) la loro disponibilità è maggiore se esiste una vicinanza
abitativa, se la loro abitazione è sufficientemente
grande per accoglierli, e se sono di sesso femminile.
Se ci sono fratelli:
avere dei fratelli è fonte di sicurezza e benessere per la
persona malata;
funzione della condivisione dei ricordi;
rapporto di intimità con i fratelli, in particolare con la
sorella;
se il rapporto tra fratelli è conflittuale genera ancor più
depressione (fig.3).
Fig.3
STILI DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ FAMILIARE
STILE
CHI LO INCARNA
CARATTERISTICA
ROUTINARIO
DONNE
CAREGIVER CHE
ASSISTE QUOTIDIANAMENTE
(oltre le 14 ore al giorno)
BACK-UP(*)
DONNE E MASCHI
CURA CIRCOSCRITTA A
SPECIFICHE ARRE DI AIUTO
SPORADICO
DONNE
AIUTO LIEVE
DISIMPEGNATO
MASCHI
NON PARTECIPA
5.2 CHE COSA SUCCEDE AL CAREGIVER INFORMALE?
Le preoccupazioni maggiori e più frequenti dei familiari dei
pazienti
terminali,
quelle
che
più
ingenerano
ansia,
riguardano la capacità di assistere in maniera continuativa, di
essere adeguati alle nuove necessità che il progredire della
malattia determina, sia per quanto riguarda i bisogni fisici,
sia per quanto riguarda fronteggiare sintomi come il dolore,
la fatigue, l’anoressia, la dispnea, i cambiamenti dell’umore,
della personalità, la confusione. I familiari manifestano la
necessità di “sapere di più” non tanto sulla malattia ma,
principalmente sulla prognosi (Quanto gli resta da vivere?),
sull’evolversi dei sintomi e sul loro controllo, su “cosa li
aspetta”. L’assistenza al malato in fase ultima di vita richiede
un investimento grandissimo di energia ( in modo particolare
psichica): la forza vitale del caregiver scende in campo a
contrastare direttamente la malattia, appesantita dal dolore,
dalla frustrazione e dal senso di impotenza e inadeguatezza.
Il lavoro di chi cura un malato terminale non ha al suo interno
fonti di ricarica: non vi è miglioramento, la dipendenza dal
caregiver diventa sempre più stretta, i rapporti familiari
diventano sempre più tesi, i problemi pratici si moltiplicano e
il caregiver segnala la perdita della propria energia dicendo:
“Non ce la faccio più, mi sto ammalando anch’io “.
Ad un certo punto del percorso di malattia il caregiver
informale:
mette in discussione la motivazione: “Perchè fare?”
amplifica il problema delle scelte: “Che cosa è meglio
fare?”
ha sensi di colpa
I sensi di colpa sono dovuti ad una vastissima gamma di
sentimenti
e
di
emozioni:
paura,
preoccupazione,
risentimento, sfiducia nelle cure e nei curanti, timore di non
essere adeguati o di aver fatto degli errori.
Così mi racconta Cinzia il 07 Gennaio 2004 dopo aver
accompagnato la mamma, affetta da neoplasia mammaria
con metastasi multiple e in fase ultima di vita, presso il
Pronto Soccorso dell’ospedale dove io lavoro, con vomito
incoercibile da più giorni : “Ho assecondato il suo desiderio di
rimanere a casa, anche perchè l’oncologo che la segue mi aveva detto che
non sarebbe arrivata all’Epifania. Credo di aver sbagliato tutto: è da tre giorni
che vomita e non mangia e io non sò cosa fare. Spero che venga ricoverata.
Già il vederla con la flebo attaccata mi fa star meglio”.
A volte il familiare si sente in colpa per il disagio che prova di
fronte al suo caro, si scopre a desiderarne la morte come fine
di una condizione drammatica, non più sostenibile. Si sente
in colpa quando il malato si comporta “male”, quando non
mangia. Si sente in colpa quando lo deve affidare ad altri, se
alla fine deve ricoverarlo, se pensa di non aver fatto o tentato
tutto il possibile. A volte nascono sensazioni di rabbia o di
ribellione.
E’ importante che il familiare comprenda che queste
emozioni contrastanti sono possibili, comprensibili, comuni e
che solo con la consapevolezza, si possono superare. La
coscienza dei propri limiti e delle cose importanti e positive
che si sono fatte per il proprio caro, è la chiave di lettura del
difficile compito di caregiver.
5.3 CHI AIUTA IL CAREGIVER INFORMALE?
(Ruolo e rapporti tra famiglia e curanti)
Per definire come, e attraverso quali percorsi e scelte debba
compiersi l’integrazione tra curanti e famiglia per la
costruzione di una “rete di servizi di/per le cure palliative” è
necessario prendere in considerazione alcune variabili:
Chi è l’elemento fragile e qual’è la sua posizione
all’interno del nucleo (madre, padre, figlio, nonno....). Chi
ha un ruolo centrale su quelle che sono le quattro
categorie principali di problemi che l’assistenza al malato
terminale comporta:
il carico di lavoro;
il coinvolgimento psicologico;
i cambiamenti di ruolo;
i cambiamenti economici.
Chi
è
il
familiare
“leader”
ossia
il
familiare
prioritariamente implicato come portatore di cure, e quali
sono le sue aree di maggiore difficoltà. Egli è il più
predisposto a sviluppare problemi di salute, sperimentare
frustrazione e isolamento quindi è insieme al paziente il
“sorvegliato speciale”.
Connessione esistente con parenti diretti e non, e non
conviventi.
Possibilità o meno di attingere a fonti di aiuto esterne
quali amici, vicini di casa (condizione questa particolarmente
critica nelle grandi città), volontari.
Chi aiuta chi aiuta:
- il
medico
di
famiglia
promotore
e
gestore
dell’assistenza a casa con attività di collegamento e
coordinamento al fine della continuità assistenziale
Ospedale-Territorio (presenza di un data base comune).
Ruolo nodale di direzione assertiva soprattutto
per
quanto riguarda il riconoscimento che, su obiettivi e
compiti specifici più figure professionali sono elegibili a
esperti pur mantenendo la rete relazionale orientata al
paziente
- l’assistente domiciliare (ADEST);
- l’assistente
sociale
per
quanto
riguarda
la
riorganizzazione interna dei ruoli secondo un approccio
sistemico-relazionale (Teoria generale dei sistemi sec.
Ludwig von Bertalanffy);
- l’infermiere professionale del Servizio di assistenza
domiciliare;
- l’equipe di Cure Palliative (laddove istituita);
- il fisioterapista;
- il sacerdote;
- gruppi di auto-aiuto indicati per il miglioramento delle
capacità
di
coping,
permettendo
una
valida
elaborazione del lutto nelle fasi terminali.
Tutti insieme possono:
INFORMARE sul CAMBIAMENTO: riduzione e/o perdita
di alcune capacità fisiche (alzarsi, andare in bagno da solo,
alimentarsi autonomamente), intellettive, di iniziativa, di
decisione, di instabilità emotiva, depressione: “Piange per
niente. In alcuni momenti si arrabbia ed è aggressivo. Non sa più
cosa vuole”.
EDUCARE
ALLA
GESTIONE
del
CAMBIAMENTO
sfruttando ad esempio le capacità residue del malato.
AIUTARE ad ENTRARE in CONTATTO migliorando ad
esempio l’ambiente ai fini della comunicazione: non parlare
con altri in sua presenza come se non ci fosse, utilizzando
spesso sottintesi e mezze frasi; migliorando le capacità di
ascolto
del
caregiver:
pazienza,
interesse,
calma,
rassicurazione; stimolare e richiamare i ricordi; dare la
possibilità di risolvere questioni in sospeso; cercare il
contatto fisico, mantenere il contatto visivo.
AIUTARE
ad
AFFRONTARE
i
COMPORTAMENTI
PROBLEMATICI: come l’agressività e la rabbia spesso
scatenate dalla paura e dalla frustrazione per la perdita di
controllo della situazione.
AIUTARE nei PROBLEMI PRATICI: attività di tutoring
per l’esecuzione di attività semplici ( l’esecuzione di una
peretta ad. es., di un lavaggio vescicale).
DARE SOSTEGNO: al caregiver nella gestione delle
proprie reazioni emotive al fine di ottenere:
- miglior benessere di chi presta le cure;
- aumento dell’impegno nella relazione assistenziale;
- riduzione degli accessi in DEA e dei ricoveri in
ospedale.
INSEGNARE a PRENDERSI CURA DI SE, per POTERSI
PRENDERE CURA dell’ALTRO: un’assistenza così gravosa
sia emotivamente che fisicamente fa sì che il caregiver si
dimentichi di prendersi cura di se stesso. E’ importante che:
ritagli un pò di tempo per sè
eviti di isolarsi
cerchi di conoscere, accettare e non giudicare i
propri sentimenti
chieda aiuto
cerchi aspetti positivi in ciò che sta facendo
INSEGNARE a CONFRONTARSI con la MORTE: il lutto è
la reazione dei vivi alla morte, rappresenta il tentativo di far
rivivere il morto nella interiorità della coscienza e negli affetti
dei sopravvissuti; è il processo di separazione da una
persona precisa, portatrice di un nome e di una storia,
collegata a luoghi, attività, fatti, date. Per questo motivo
parlare del lutto, o meglio della perdita e della separazione
come esperienza fisica e psichica, sociale, etica, intorno alla
quale elaborare nuovi rituali che corrispondono alla realtà
socioculturale contemporanea, rappresenta una istanza
essenziale di un programma di assistenza al morente
Fig.4
I SENTIMENTI
LA MALATTIA
IL PAZIENTE
L’ESPERIENZA DI VITA DEL CAREGIVER
L’ASSISTENZA
GLI ALTRI
IL CONIUGE
E LA FAMIGLIA
IL COPING
LA VITA, LA SALUTE
DEL CAREGIVER
La realtà multi-dimensionale emersa, e sintetizzata nelle otto
sfere di temi, ha messo in evidenza il grande impatto che la
malattia ha sulla vita del caregiver. La carenza e, talvolta,
l’assenza
di
supporti
esterni
comportano
l’istituzionalizzazione forzata, e quindi la perdita della
persona malata ancor prima della sua morte.
5.4 QUANDO LA FAMIGLIA SCOPPIA: LO STRESS DEL
CAREGIVER.
Frequentemente il familiare che svolge in prima persona
l’accudimento a casa di un malato terminale di cancro va
incontro ad uno scadimento del proprio stato di salute psicofisico(stress del caregiver).
Northouse ha identificato 3 problemi centrali della famiglia
nelle varie fasi del percorso di malattia, che se non affrontati
possono condurre a stress:
1) l’esclusione
da
parte
dei
curanti
dei
sentimenti
provocati dalla diagnosi: i familiari si definiscono
“esausti”;
2) frustrazione nel tentativo di comunicare con i membri
dello staff curante e con altri;
3) difficoltà a gestire la tensione emotiva con sviluppo di
ansia, depressione, astenia, insonnia ed altri disturbi
organici quali: ipertensione, dolore toracico, ecc.
*NOTE: Northouse L. ,”The impact of cancer on the family: an overview. Int J Psychiatry Med
1984; 215-42.
DEFINIZIONE DI STRESS
Hans Selye, nel 1936, definì lo stress una reazione biologica
aspecifica dell’organismo come conseguenza di un agente
stressante (stressor). Ogni risposta dell’organismo allo
stress attraversa tre fasi:
ALLARME: che comporta modificazioni di carattere
biochimico e ormonale;
ADATTAMENTO: l’organismo per adeguarsi alla nuova
situazione si organizza in senso difensivo;
ESAURIMENTO: in cui avviene il crollo delle difese e
l’incapacità di adattarsi ulteriormente.
Si distinguono due tipi di stress: uno benigno, adattivo e non
dannoso; l’altro disadattivo che non porta all’omeostasi. Se il
soggetto è in grado di adottare una strategia adeguata, si
potrà avere un miglioramento della performance (eustress);
in caso contrario si avrà un peggioramento distress con la
comparsa sia di sintomi di tipo psicologico quali nervosismo,
tensione, depressione, irritabilità, sia disturbi fisici quali
disturbi digestivi, difficoltà respiratorie, alterazioni del ritmo
cardiaco, mal di testa, nausea, debolezza e altro.
Cassileth, nel 1985, ha condotto uno studio su 201 soggetti
con differenti patologie neoplastiche e in diverse fasi di
trattamento. Ai pazienti e al familiare significativo (caregiver
leader) ha somministrato tre scale di autocompilazione: la
Spielberg State Anxiety Scale (SSAS) per la valutazione dello
stato di ansia, correlato a specifiche condizioni di malattia; la
Profile of Mood State (PMS) per la misurazione del disturbo
dell’umore; e la Mental Health Index (MHI) per la misurazione
globale della salute mentale, selezionando gli indici di alcune
sottoscale:
ansia,
depressione,
perdita
di
controllo
comportamentale/emotivo, rapporti affettivi in generale. Il
confronto tra i dati dei pazienti e dei caregivers, nelle diverse
fasi di trattamento della malattia ha evidenziato una stretta
correlazione tra gli indici psicologici dei malati e quelli dei
loro familiari, soprattutto se questi erano curati a casa. E’
emerso inoltre l’aggravarsi del disagio nei soggetti (e nei
familiari) in fase terminale, rispetto ai pazienti in trattamento
chemioterapico e ad altri, in remissione, seguiti in follow-up
(Fig. 5).
Differenti gruppi di ricerca hanno messo in evidenza
l’incidenza delle reazioni e della comunicazione familiare
sull’adattamento alla patologia da parte del malato e
dell’intero nucleo familiare. Soprattutto nelle fasi avanzate o
terminali della malattia, quando il disagio psicologico e i
sentimenti di disperazione e impotenza sono acuti, il rischio
di costruire patterns relazionali disadattivi è molto alto e il
suo esito incide sfavorevolmente sul benessere psicologico
di tutti i membri interagenti. E’ anche vero che in alcuni casi,
all’opposto, la “morte annunciata” induce ad una riflessione
sul senso della vita e sui valori più importanti ad essa
connessi, tale da portare ad un rafforzamento dei legami
familiari.
Fig. 5
CONDIZIONE PSICOLOGICA DI PAZIENTI E FAMILIARI NELLE VARIE FASI DI MALATTIA
(Cassleth, Cancer, 1985)
Pz.in
Follow-up
N°
ANSIA*
Pazienti
Familiari
MEDIA
Paz. in tratt.
Chemio/Rxterapico
(DS) MEDIA
(DS)
MEDIA
(DS)
ANOVA
37.1
36.2
12.9
11.4
42.0
44.9
11.6
12.6
0.05
0.0002
194
195
34.6
33.0
DISTURBI*
Dell’UMORE
Pazienti
193
Familiari
195
10.7
5.8
29.7
29.8
17.3
11.6
31.1
25.9
33.4
35.8
34.7
40.2
0.01
0.0001
INDICE DI
SALUTE
MENTALE**
Pazienti
Familiari
181.0
180.4
26.8
23.5
171.4
173.4
27.7
25.8
154.6
149.3
29.2
33.9
0.001
<0.0001
189
190
11.2
9.7
Paz. in trattamento
Palliativo
LEGENDA:
*Punteggi più alti indicano ansia più elevata e> disturbo dell’umore
** Punteggi più alti indicano un miglior stato di salute mentale
DS= Deviazione Satandard
ANOVA= analisi della varianza
Viene confermato, anche da questi dati, che il distress
emozionale non solo si riflette circolarmente tra paziente e
coniuge, ma aumenta progressivamente con l’avanzare della
patologia e l’avvicinarsi della morte.
5.5 L’utlizzo della Scala di J.G. GREENE per la valutazione
dello stress del caregiver informale.
(Relatives’ stress scale)
5.6 SOSTENERE CHI CURA.
“E’ arrivato il tempo in cui porre attenzione alla problematica di curare chi
cura partendo dal punto di voista dei soggetti curanti, anche a fronte di
un’emergente domanda di riconoscimento del ruolo sociale di chi è
impegnato nella cura informale”. (Patrizia Taccani Convegno “Sostenere chi
cura” AUSER –Roma 25/26-9-2001)