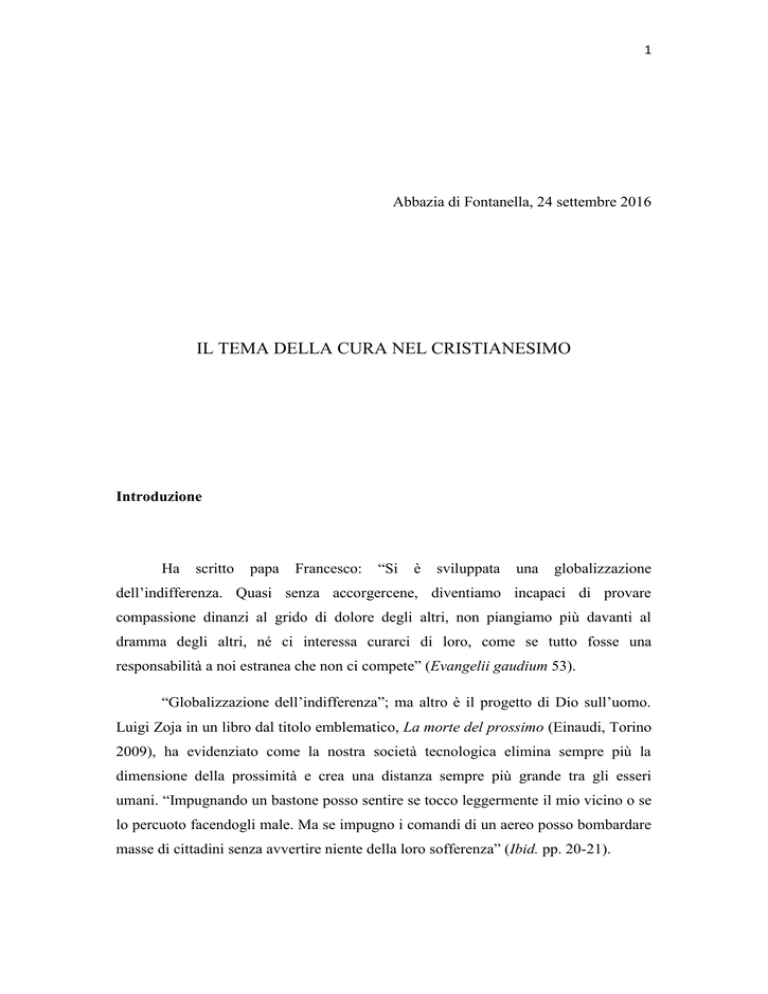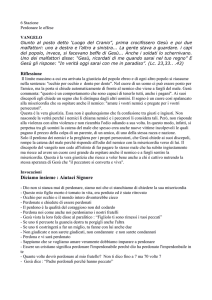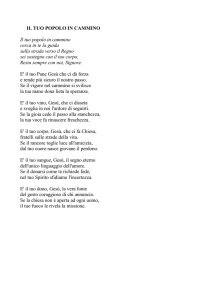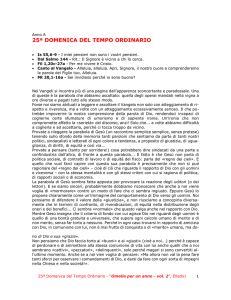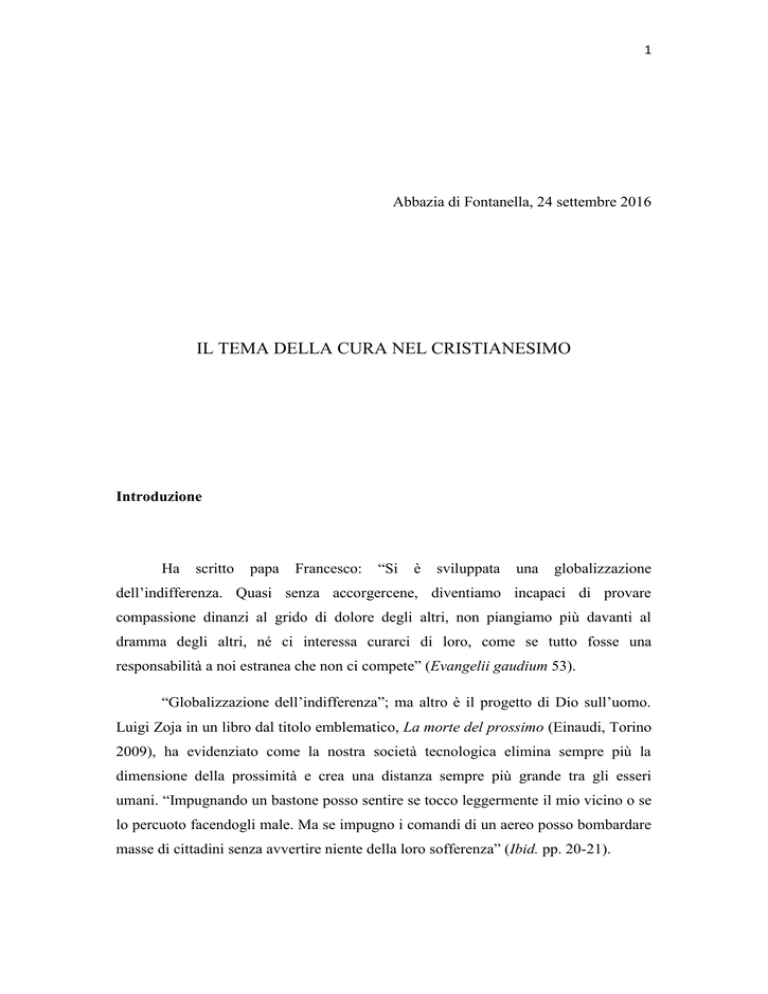
1
Abbazia di Fontanella, 24 settembre 2016
IL TEMA DELLA CURA NEL CRISTIANESIMO
Introduzione
Ha
scritto
papa
Francesco:
“Si
è
sviluppata
una
globalizzazione
dell’indifferenza. Quasi senza accorgercene, diventiamo incapaci di provare
compassione dinanzi al grido di dolore degli altri, non piangiamo più davanti al
dramma degli altri, né ci interessa curarci di loro, come se tutto fosse una
responsabilità a noi estranea che non ci compete” (Evangelii gaudium 53).
“Globalizzazione dell’indifferenza”; ma altro è il progetto di Dio sull’uomo.
Luigi Zoja in un libro dal titolo emblematico, La morte del prossimo (Einaudi, Torino
2009), ha evidenziato come la nostra società tecnologica elimina sempre più la
dimensione della prossimità e crea una distanza sempre più grande tra gli esseri
umani. “Impugnando un bastone posso sentire se tocco leggermente il mio vicino o se
lo percuoto facendogli male. Ma se impugno i comandi di un aereo posso bombardare
masse di cittadini senza avvertire niente della loro sofferenza” (Ibid. pp. 20-21).
2
Diventando estranei agli altri finiamo per diventare estranei anche a noi stessi.
Come prendersi cura di sé, come prendersi cura dell’altro? Chi è per noi l’altro di cui
siamo chiamati a prenderci cura?
1. Chi è il mio prossimo?
Parto da una parabola conosciutissima, quella che viene usualmente chiamata
“parabola del buon samaritano”, l’unico passo del vangelo in cui appare (due volte) il
verbo greco epimeléomai che significa “prendersi cura di” (lo troviamo anche in 1Tm
3,5: “Se uno non sa guidare la propria famiglia, come potrà aver cura della chiesa di
Dio?). La parabola viene raccontata da Gesù a un dottore della Legge, uno che
conosceva bene la Scrittura e tutte le sue interpretazioni.
È importante considerare il contesto immediato in cui l’evangelista ha
collocato questo episodio. Gesù ha appena riconosciuto (non: “ringraziato”) che
l’evangelo è nascosto ai sapienti e agli intellettuali ed è rivelato ai piccoli. Subito
dopo entra in scena lo scriba, uno che sa (e infatti Gesù non corregge quello che dice;
anzi, lo approva). La sua domanda è subdola – Luca dice che “si alzò per tentarlo” -;
vorrebbe coglierlo in fallo, forse spera che si lasci sfuggire un parere in contrasto con
la tradizione. “Che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?”. Gesù risponde a sua
volta con una domanda, vuole che sia lo scriba a rispondere: “Che cosa sta scritto
nella Legge? Che cosa vi leggi?”. Lo scriba dà una risposta che ci aspetteremmo di
trovare soltanto sulla bocca di Gesù, come accade ad esempio nel passo di Mc 12,2834. Lo scriba coglie l’essenziale della Legge: l’amore per Dio e l’amore per il
prossimo e Gesù gli dice: “Hai risposto bene. Fa’ questo e vivrai”. Fa’ ciò che sai così
bene, mettilo in pratica, traducilo nella tua esistenza quotidiana.
A questo punto Luca pone un’altra domanda dello scriba introdotta
dall’annotazione: “Quello volendo giustificarsi”; sa di non essere “un giusto”, sa che
in lui non vi è coerenza tra parola e vita, cerca di “addomesticare” il comandamento di
Dio, di abbassarlo a propria misura. “Chi è mio prossimo?”. Era, a quei tempi, una
3
questione dibattuta nelle scuole rabbiniche. Il prossimo che deve essere oggetto
dell’amore dell’ebreo è innanzitutto il fratello ebreo (cf. Lv 17,8.10.13; 19,34). Nelle
cerchie rabbiniche di più ampie vedute era considerato prossimo chiunque abitasse la
terra di Israele, anche l’immigrato dunque (“Quando un immigrato sta nella vostra
terra, non opprimetelo, ma sia tra voi come un fratello e lo amerai come te stesso,
perché voi foste immigrati in Egitto”, Lv 19,33-34). Ma ancora di più, secondo alcuni
testi dell’Antico Testamento, l’amore si estende al nemico: “Quando incontrerai il bue
del tuo nemico o il suo asino dispersi, tu ricondurrai al nemico l’animale, e quando
vedrai l’asino del tuo nemico venir meno sotto il carico, non abbandonarlo a se stesso,
ma mettiti con lui ad aiutarlo” (Es 23,4-5).
Lo scriba vorrebbe che Gesù si pronunciasse apertamente. Fino a dove si
estende il precetto dell’amore del prossimo? Gesù in risposta racconta una storia, una
storia che conoscete tutti. C’è un uomo che scende da Gerusalemme a Gerico e lungo
la via incappa nei briganti che gli portano via tutto quello che ha, lo maltrattano e lo
lasciano a terra mezzo morto. Passa un sacerdote; probabilmente aveva appena finito
il suo turno di servizio al tempio; aveva vegliato sulla casa di Dio, ma non si piega a
vegliare su Dio che dimora in quell’uomo ferito e bisognoso. “Lo vide e passò oltre”,
(lett. “passò dall’altra parte”; “girò alla larga”). Non vuole rendersi impuro toccando
un moribondo (Lv 21,1-4: “Un sacerdote non si esporrà a diventare impuro per il
contatto con un morto, a meno che si tratti di uno dei suoi parenti più stretti”). Anche
un levita di passaggio sulla stessa strada “vide e girò al largo”. Luca non spreca molte
parole per descrivere il comportamento delle due prime figure che mette in scena. Si
ferma invece sulla terza: quella del samaritano. “Vide e ne ebbe compassione”;
dovremmo tradurre “le sue viscere furono mosse a compassione”. Il verbo greco
splanchnízomai viene usato per parlare della compassione che prova Gesù al vedere la
vedova di Nain in pianto per la morte del suo unico figlio (cf. Lc 7,13) e per
descrivere l’atteggiamento del padre misericordioso che da lontano vede il ritorno del
figlio minore (“le sue viscere furono mosse a compassione, gli corse incontro e lo
abbracciò”, Lc 15,20).
Il suo vedere è diverso da quello del sacerdote e del levita. Vede e scende
vicino a lui come il Signore dopo aver sentito il grido del suo popolo in Egitto (cf. Es
3,7-9). Il suo è il vedere di Dio che è sempre com-passionevole, è capace di divenire
compassionevole come Dio è compassionevole (cfr. Lc 6,36). “Gli si avvicinò, gli
4
fasciò le ferite versandovi sopra olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo
portò in un albergo e si prese cura di lui”. Il racconto si dilunga a descrivere le azioni
del samaritano quasi a indicare che non si tratta di un singolo atto di generosità, ma di
un atteggiamento che è frutto di attenzione all’altro, di un amore intelligente che sa
prevenire i bisogni del sofferente, di un interessamento colmo di amorosa
sollecitudine (le sue azioni vengono descritte con sei verbi in due versetti). Dopo aver
provveduto ai bisogni immediati pensa al suo futuro; dà una somma all’albergatore e
gli raccomanda: “Abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo darò al mio ritorno”;
viene impiegato di nuovo il verbo epimeléomai. Il samaritano non solo si prende cura
in prima persona di quell’uomo sofferente, ma coinvolge anche altri, in questo caso
l’albergatore.
A differenza del sacerdote e del levita che, visto l’uomo ferito, passano
dall’altra parte della strada, il samaritano accetta di incontrare l’uomo moribondo e di
lasciarsi scomodare da lui, non è indifferente, riconosce in lui un fratello, fratello
anche nella sofferenza. Ci vuole coraggio per accettare di incontrare l’altro,
soprattutto quando è nel bisogno … il coraggio di guardarci in faccia, il coraggio di
riconoscere che la sofferenza dell’altro fa da specchio alla nostra, che la debolezza, la
solitudine dell’altro ci rinvia alla nostra solitudine, alla nostra impotenza. La cura
dell’altro: forse saremmo disposti a praticarla a patto che fosse un atto di onnipotenza
che risolve tutto come per magia, e invece ci scontriamo con i nostri limiti, con la
nostra fatica. Per ascoltare l’altro, occorre aver imparato ad ascoltare il primo altro
che incontriamo: noi stessi. Per arrivare a “fare compassione” (Lc 10,37; non
“provare” o “sentire”, ma mettere in pratica la compassione: fecit misericordiam,
traduce Girolamo), occorre riconoscere tutto ciò che dentro di noi si oppone alla
solidarietà. Per saper aver cura degli altri occorre saper aver cura di noi (ma su questo
ritorneremo più avanti).
5
“Chi di questi tre ti sembra sia diventato prossimo di colui che è caduto nelle
mani dei briganti?”. La domanda non è più: “Chi è il mio prossimo?”, ma: “Di chi sei
disposto a diventare prossimo?”. Dipende da te, non dall’altro. Sei tu che devi farti
prossimo all’altro. È una parabola che sfida ogni nostro particolarismo ed
esclusivismo. Dicendo: “Hai risposto bene (“correttamente”, in greco: orthôs); fa’
questo e vivrai” (Lc 10,28), Gesù incita il dottore della Legge a passare da un sapere
sterile alla realizzazione della parola di Dio. Cerca di essere tu una parola di Dio nel
mondo.
2. “Beato chi discerne il Povero” (Sal 41,1)
L’altro ci dà fastidio, ci interroga, mette in discussione le nostre sicure
abitudini, i nostri pretesi diritti. Incontrare l’altro è morire per rinascere; è una
ricchezza se accetto di morire al mio egoismo, alla mia pretesa di essere il centro della
realtà. L’altro è altro da me, è un simile dissimile. Il dono più grande che possiamo
fargli è riconoscere che esiste e che è altro da me.
Il salmo 41 al v. 1 nella versione ebraica suona: “Beato chi ha cura del
povero”, ma nella traduzione greca dei LXX si dice una cosa un po’ diversa: “Beato
chi discerne il povero”, e dovremmo scrivere il Povero con la maiuscola. Beato cioè
chi sa riconoscere nel povero il volto del Signore. A volte ci limitiamo, come dice
Ignazio di Antiochia, a essere cristiani “apparenti”; a proposito dei doceti, gruppi di
cristiani i quali affermavano che in Gesù Dio si era fatto uomo soltanto “in
apparenza”, dice: “A costoro non importa dell’amore, né della vedova, né dell’orfano,
né di chi è nel dolore, né di colui che è in catene o che è stato liberato, né di colui che
ha fame e sete! Si tengono lontani dall’eucarestia e dalla preghiera, perché non
confessano che l’eucarestia è carne del Salvatore nostro Gesù Cristo” (Lettera agli
smirnesi 6,2-7,1). “Si tengono lontani dall’eucarestia”: in greco “si tengono lontani
dall’agape”, che significa sia l’amore che l’eucarestia. C’è una confusione
intenzionale tra i due termini. L’eucarestia è un magistero di amore, è il luogo in cui
impariamo che cosa significa amare l’altro come il Signore ci ha amati, un amore
6
gratuito fino al dono per della vita. Non dimentichiamo che nel vangelo di Giovanni
al posto dell’eucarestia viene narrata la lavanda dei piedi. Ireneo di Lione chiedeva
con forza che l’eucaristia e la vita non fossero disgiunte, ma armonizzate: “Il nostro
modo di pensare sia in accordo con l’eucaristia e l’eucaristia plasmi il nostro modo di
pensare” (Ireneo di Lione, Contro le eresie IV,18,5). E oggi? Abbiamo questa
consapevolezza?
Dove troviamo la forza di amare, di prenderci cura dell’altro? Attingendo
all’amore che abbiamo ricevuto. La chiesa, ha detto un giorno papa Francesco, è “un
ospedale da campo”, un luogo di rifugio per chi è ferito, bisognoso, un luogo in cui si
sperimenta l’accoglienza, l’amore gratuito, e si impara a riversare quest’amore sugli
altri. Giovanni Crisostomo nel
V
secolo diceva che la chiesa è “una farmacia”, nella
quale ciascuno può trovare la medicina adatta al suo male. Ma anche nella chiesa di
Bergamo si parla di “curato” per indicare il presbitero che coadiuva il parroco
(“parroco” = straniero, è colui che presiede la comunità di cristiani, stranieri in questo
mondo, viandanti e pellegrini verso il Regno). Si chiama “curato” perché deputato a
esercitare il ministero della cura della vita. Chi ha sperimentato e conosciuto l’amore,
un amore che viene da Dio è inviato a riversarlo sugli altri.
Quest’amorosa cura del prossimo non è buonismo, non è un singolo gesto di
buon cuore. L’abbiamo visto nella parabola di Luca; esige vedere, pensare, agire. Nel
più antico catechismo cristiano (entro la fine del
I
secolo) troviamo questo
ammonimento: “Sudi la tua elemosina nelle tue mani finché tu non sappia a chi darla”
(Didachè 1,6). Origene nel III secolo invitava l’oikónomos della comunità cristiana ad
andare a cercare i poveri, perché, faceva osservare, molti si vergognano e non hanno il
coraggio di presentarsi a chiedere aiuto.
Richiederebbe troppo tempo enumerare anche solo i testi più significativi dei
padri della chiesa sul tema della cura dei poveri. Ne ricordo soltanto alcuni. La
Didascalia degli Apostoli (inizio
III
secolo) al c. 4,5 ammonisce: “Vescovi e diaconi,
abbiate cura dell’altare di Cristo, cioè delle vedove e degli orfani”. Gregorio di Nissa
esorta a non disprezzare i poveri con queste parole: “Considera chi sono e scoprirai la
loro grandezza: hanno il volto del Salvatore” (Discorso 1). Da vedere a volte c’è solo
il dolore, la miseria materiale e spirituale, un’estrema povertà declinata in tutte le sue
forme. Solo nella fede possiamo credere che nel povero regna il Signore e che siamo
7
chiamati a servirlo e ad amarlo. “Vuoi onorare il corpo di Cristo? Non tollerare che
sia ignudo! Dopo averlo ornato qui, in chiesa, con stoffe d’oro, non permettere che
fuori muoia di freddo … Il corpo di Cristo che sta sull’altare non ha bisogno di
mantelli, ma di un cuore puro quello che sta fuori, invece, ha bisogno di molta cura”
(Om. su Matteo 50,3), dice Giovanni Crisostomo.
Infiniti sono anche i testi della tradizione patristica che ricordano che “la terra
è di Dio”. “Il mio e il tuo sono fredde parole che introducono nel mondo infinite
guerre” (Om. su 1Cor 11,19). “Non abbiamo la proprietà di alcun bene, né il dominio
assoluto, ma soltanto l’uso … Il termine (greco) “ricchezze” proviene dal verbo
‘usare’, non dall’espressione ‘essere padroni’; i beni li abbiamo in uso, non in
proprietà” (Giovanni Crisostomo, Om. su 1Tm 11,2-3). Basilio quando cita il testo di
1Cor 7,31 che nelle nostre versioni suona: “Il tempo si è fatto breve; d’ora innanzi
quelli che hanno moglie, vivano come se non l’avessero … quelli che usano i beni di
questo mondo, come se non li usassero”, segue un manoscritto diverso (oppure cita a
memoria variando il testo originale) e dice: “usino di questo mondo senza abusarne”
(Regola diffusa 20,3). Si aprirebbe qui il tema della cura del creato; usare la terra
senza farne un cattivo uso. Aver cura dell’altro è anche non sfruttare in modo iniquo
le risorse della sua terra, custodire il creato per le generazioni future …
Nel corso del tempo si sono moltiplicate all’interno della tradizione cristiana
delle liste di opere di misericordia “corporali” e “spirituali” che sono giunte a una
sistematizzazione verso il
XII
secolo. Queste liste non sono esaustive, ma soltanto
indicative, intendono essere delle sollecitazioni indirizzate alla creatività e
all’intelligenza dei cristiani; in ogni tempo, in ogni situazione vi è un gesto di cura
profetico.
3. Veglia su di te
Per aver cura dell’altro occorre innanzitutto saper avere cura di sé. Ascolto e
cura di sé, cioè ascolto e cura della prima persona con la quale ci incontriamo!
8
In certo senso noi siamo un dono che Dio ha fatto a noi stessi e di cui
dobbiamo avere cura. Io non sono “mia”; sono stata donata a me stessa da Dio
attraverso mediazioni umane (mio padre, mia madre); ho ricevuto la cura, più o meno
intelligente e premurosa, di insegnanti, di preti o di altri adulti, ma a un certo punto
devo assumermi la cura di me per collaborare con quel Dio che mi ha pensato, voluto,
inviato nel mondo in un luogo e in un tempo preciso della storia per essere
trasparenza del suo amore con la mia esistenza, con la mia carne. Origene afferma: “A
che serve confessare che Cristo nasce nella carne, se non nasce nella tua carne?” (Om.
sulla Genesi 3,7).
“Il Creatore ha assegnato all’uomo come compito il corpo”, ha detto Giovanni
Paolo II (Uomo e donna lo creò. Catechesi sull’amore umano, Roma 19872, p. 255).
Vegliare su di sé, aver cura di sé per diventare uomini e donne secondo il progetto di
Dio, uomini e donne che vivono nella loro carne l’amore per l’altro.
Sono creato a immagine e somiglianza di Dio. L’Antico Testamento proibisce
di produrre immagini di Dio perché l’immagine di Dio c’è già: l’essere umano. Siamo
chiamati a collaborare con Dio per diventare uomini e donne in pienezza; quando
JHWH dice: “Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza” (Gen 1,26),
secondo alcuni esegeti, si rivolge all’essere umano. Si tratta di un plurale; non è
soltanto Dio che lavora, ma anche l’uomo/la donna deve fare la propria parte per
portare a compimento se stesso. È creato a immagine di Dio: l’immagine c’è e non
viene mai meno, può essere nascosta, offuscata dal peccato, dall’ignoranza, dalla
stupidità, ma resta comunque. Siamo chiamati a portare a compimento la somiglianza:
questo dipende da noi, è la nostra parte di lavoro; se vogliamo, se collaboriamo
possiamo poco per volta diventare un po’ più somiglianti a Cristo, l’unica vera,
perfetta immagine del Padre.
Aver cura di sé significa anzitutto conoscere se stessi: è un cammino che non
finisce finché si è in vita. Ogni fase della vita mi impone un ri-aggiustamento della
mia conoscenza di me stesso.
L’essere umano è capace di interrogarsi. Si interroga nel rapporto con se
stesso: “Chi sono io in verità? Che cosa voglio? Dove vado? Perché sono? Che cosa
mi sta a cuore?”. Si interroga sul rapporto con gli altri: “Perché agisco così? Perché
9
quella persona mi incute soggezione o mi fa arrabbiare o desta in me sentimenti di
ostilità? Perché provo invidia o gelosia?”.
Si interroga dinanzi agli eventi: “Perché è accaduto questo? Come mi devo
comportare? Perché ho reagito in questo modo? Come posso viverlo bene, integrarlo
nel mio cammino umano anche se è un evento spiacevole, negativo? Che devo fare
delle mie delusioni, del fallimento, dello scacco, della malattia?”.
Chi impara a interrogarsi non subisce la vita in modo passivo, ma la accoglie,
la orienta. Certamente oltre a interrogarsi di fronte agli eventi personali, l’essere
umano si interroga anche dinanzi agli eventi della storia: “Perché la guerra? La fame,
le carestie? Perché l’ingiustizia?”. Aver cura di sé e dell’altro è atto eminentemente
“politico”, nel senso che riguarda la pólis, la comunità umana. Non m limito all’aiuto
concreto e immediato al povero, ma mi impegno per una società in cui non vi siano
più poveri!
Ma non ci si interroga soltanto sul negativo. Si cerca un perché e un come
anche per l’amicizia, l’amore, le cose bellezze, l’arte ... Come farle durare, come
goderne? L’arte in tutte le sue forme – musica, arti visive, letteratura, ecc. – sono
espressione di una vita interiore, di una ricerca di senso, di contemplazione del bello.
Queste domande sempre ripetute ci accompagnano in certa misura per tutto il
corso della nostra vita e che si pongono con più forza nei momenti di “svolta”, nelle
tappe che segnano la nostra esistenza. Fanno parte di un cammino di
“umanizzazione”. Una risposta occorre cercare di darla, o per lo meno occorre
imparare a convivere con queste domande, a lasciare che ci inquietino, che ci tengano
svegli. Il rischio dell’assopimento è grande.
Chi si conosce è padrone di sé e allora può mettersi liberamente e per amore a
servizio di Dio e degli altri. Il sal 119,109 nella versione greca della LXX suona: “La
mia anima è sempre nelle mie mani”, cioè vigilo su di me, sul mio cuore. In una
splendida omelia a commento dell’ammonimento di Dt 15,9: “Veglia su di te”,
Basilio dice: “Veglia su te stesso, veglia non su quello che è tuo, o su quello che sta
attorno a te, ma su te stesso soltanto … Poiché ciascuno di noi è più facilmente incline
a interessarsi delle cose altrui invece che meditare sulle proprie, affinché non abbiamo
ad ammalarci di questa malattia il Signore ci dice: ‘Smetti di interessarti della
10
cattiveria del tale o del tal altro; non dar tempo ai tuoi pensieri di esaminare le
debolezze altrui, ma veglia su di te, cioè volgi gli occhi del cuore a scrutare te stesso’”
(Veglia su di te 3.5).
Conoscere se stessi non è sempre facile, non è sempre “bello”. A volte
facciamo di tutto per non vederci, per fuggire da noi stessi, per non riconoscere che
costantemente ci perdiamo e costantemente abbiamo bisogno di essere salvati. La via
di fuga per eccellenza secondo la tradizione cristiana è cedere all’acedia, alla
sonnolenza spirituale, lasciarsi vivere invece che vivere. Si cede alla routine, senza
farsi troppe domande e, poco a poco, ci sia lascia vincere dall’indifferenza.
Diventiamo incapaci di ascoltare noi stessi (ci fa paura); diventiamo incapaci di
ascoltare gli altri (ci fa molta paura).
Interrogarci sulle motivazioni che ci spingono ad agire per non far da padroni
sugli altri magari con la scusa di far loro del bene (cf. 2Cor 1,24).
Un’adeguata conoscenza di sé ci consente di non fare da padroni sugli altri
(2Cor 1,24), magari con la scusa d far loro del bene; di non seducere, cioè di non
“trascinare verso di sé, legare a sé, con un’azione che imprigiona (“i miei poveri”, “i
miei malati”, “i miei giovani”, con una forte accentuazione di quell’aggettivo
possessivo). Finiamo per diventare come Marta padroni del nostro servizio (Lc 10,
38-42). Si tratta invece di educere, cioè di far uscire verso la relazione con Dio, con
gli altri, con la realtà.
Serafino di Sarov amava dire: “Trova la pace e migliaia di uomini presso di te
troveranno salvezza”. È questo il primo modo di venire in aiuto all’altro; essere
uomini e donne di pace, uomini e donne che hanno fatto pace con se stessi.
4. Un’opera di carità possibile a tutti
11
Abbiamo parlato di liste di opere di carità. Molto presto (già con Origene,
prima metà del
III
secolo) alle liste di opere corporali si aggiunsero le liste di opere
spirituali. La lista tradizionale delle opere di misericordia corporali è la seguente:
1. Dare da mangiare agli affamati
2. Dare da bere agli assetati
3. Vestire gli ignudi
4. Dare ospitalità ai pellegrini
5. Visitare gli infermi
6. Visitare i carcerati
7. Seppellire i morti
E la lista delle opere di misericordia spirituali è la seguente:
1. Consigliare i dubbiosi
2. Insegnare agli ignoranti
3. Ammonire i peccatori
4. Consolare gli afflitti
5. Perdonare le offese
6. Sopportare pazientemente le persone moleste
7. Pregare Dio per i vivi e per i morti
Non possiamo fermarci a commentare queste liste, ma vorrei ricordare quello
che dice Cesario di Arles: “Ci sono due forme di elemosina: una del cuore, l’altra del
denaro … A volte tu vorresti dare qualcosa a un povero, ma non hai niente; invece
perdonare lo puoi sempre fare, se solo lo vuoi” (Discorsi al popolo 38,5).
L’amore cristiano non è soltanto simpatia, amicizia, non è l’amore passionale
che posso provare per qualcuno. L’amore cristiano discende dall’alto, è dono di Dio, è
un carisma, è quell’amore che Dio ha per noi, che si riversa nei nostri cuori e che da
noi trabocca all’esterno.
La cura dell’altro giunge all’amore per il nemico; l’amore non è aggressivo,
non tiene conto del male ricevuto, ma sa andare oltre, sa perdonare. Già nell’Antico
Testamento troviamo l’invito a perdonare il nemico. Si pensi alla storia di Giuseppe.
12
È una storia di rapporti fraterni “sbagliati”, se così si può dire. Giuseppe non è un
modello di santo; provoca i fratelli con i suoi sogni in cui si vede come il più grande
di tutti, davanti al quale tutti si devono piegare. È il più amato dal padre e sa sfruttare
questo amore a suo vantaggio contro gli altri. E gli altri fratelli non hanno pazienza,
non lo sopportano più, fino a decidere di ucciderlo. Poi interviene un fratello e li
convince a venderlo come schiavo invece di ucciderlo. E Giuseppe in Egitto
attraversa una serie di vicende dolorose che vincono il suo orgoglio; grazie alla sua
abilità e alla sua intelligenza fa strada fino a diventare viceré dell’Egitto. Quando la
carestia si abbatte sulla terra di Canaan, il vecchio Giacobbe manda i suoi figli in
Egitto a cercare del grano e Giuseppe riconosce i suoi fratelli. Poco tempo dopo si
farà riconoscere, svelerà: “Io sono Giuseppe, vostro fratello che voi avete venduto
come schiavo in Egitto” e farà venire in Egitto tutta la sua famiglia. Dopo la morte di
Giacobbe, i fratelli temono che ora, in assenza del padre che in qualche modo li
difendeva, giunga per Giuseppe l’ora della vendetta per tutto il male che gli hanno
fatto patire. Hanno paura, ma Giuseppe dice loro: “Non temete. Sono io forse al posto
di Dio? Se voi avevate pensate del male contro di me, Dio ha pensato di farlo servire a
un bene, per compiere quello che oggi si avvera: far vivere un popolo numeroso”
(Gen 50,19-20). Giuseppe non tiene conto del male ricevuto dai suoi fratelli, anzi sa
trasformarlo, trasfigurare il male che ha patito da parte dei fratelli, ricavando da quella
storia che è stata così dolorosa, qualcosa di buono, di positivo, sa trarre il bene anche
dal male. A volte è proprio così; se viviamo tutto con bontà e pazienza scopriamo che
anche da quello che è andato male, dal dolore, dalla sofferenza possiamo ricavare un
insegnamento, imparare un po’ di bontà.
L’Antico Testamento, l’abbiamo ricordato all’inizio del nostro incontro, esorta
all’amore per lo straniero, alla compassione per il nemico. Nel Nuovo Testamento
Gesù dona il comandamento nuovo: “Amatevi come io vi ho amati. Da questo tutti
sapranno che siete miei discepoli: se avrete amore gli uni per gli altri” (Gv 13,34-35).
Il modello dell’amore, il maestro dell’amore è Gesù stesso, è la sua vita.
Se il cristiano, vivendo lo spirito delle beatitudini, conosce opposizioni, rifiuti,
persecuzioni, d’altro lato non deve essere lui a entrare in conflitto con gli altri, crearsi
dei nemici. È nemico di nessuno, ma ha molti nemici. Il suo amore per chi gli ha fatto
del male è generato dall’amore che Dio ha avuto per lui “mentre ancora gli era
nemico” (Rm 5.8.10). Dobbiamo amare fino alla fine, come ha amato Gesù.
13
Occorre uscire dalla demonizzazione dell’altro: il pagano, lo straniero, l’ebreo,
l’eretico, il musulmano sono alcuni dei visi storici in cui i cristiani hanno incarnato il
nemico.
Nella
Tertio
millennio
adveniente
Giovanni
Paolo
II
ricordava
“l’acquiescenza manifestata specie in alcuni secoli a metodi di intolleranza e persino
di violenza nel servizio della verità”. Il vero nemico è in noi e non fuori di noi e la
lotta che dobbiamo ingaggiare è quella contro l’assolutizzazione del nostro io. I padri
giungono a dire che il nemico può diventare nostro maestro (Zosima, pp. 103. 124125). Quando qualcuno ci fa del male, noi che ci credevamo tanto buoni, scopriamo di
avere dentro di noi desideri di vendetta, tanta rabbia, il desiderio cattivo di farla
pagare all’altro. In questo il nemico ci fa da maestro: ci fa toccare con mano che non
siamo buoni, ci fa conoscere i sentimenti che abbiamo nel cuore, ci offre un’occasione
per convertirci.
“L’amore non tiene conto del male ricevuto … tutto scusa, tutto crede, tutto
spera, tutto sopporta” (1Cor 13,5.7). Perdonare è qualcosa di gratuito, è un dono che
noi facciamo a chi ci ha fatto del male. É un atto creativo che ci trasforma da
prigionieri del passato in uomini liberi, in pace con le memorie del passato. Solo chi è
libero sa perdonare, perché il perdono non è una re-azione, una risposta vincolata,
predeterminata, ma è un atto nuovo, non condizionato da ciò che l’ha provocato; è
spezzare la logica del taglione, il desiderio di vendetta. Il perdono è una risposta a una
sofferenza che si subisce per mano di qualcun altro. Essa esige, dunque, l’onesto
riconoscimento che stiamo soffrendo a motivo di un altro dal quale aspettavamo
amore. “Proprio da lui! Proprio da lei!”. Ci è più difficile perdonare le persone che
amiamo di più. Se patiamo ingiustizia da parte di un estraneo, la sopportiamo più
facilmente. Il perdono è rivolto a coloro che non scusiamo, perché capiamo che in
qualche modo sono responsabili dell’offesa che stiamo subendo. Siamo disillusi, ci
attendevamo molto da alcune persone, e invece ... Ci sentiamo vittime di gesti di
slealtà e di tradimento.
Il perdono è un atto intenzionale. Dobbiamo volerlo, porre dei gesti, fare un
cammino. Non è un atto, è un processo, un cammino che richiede ripetuti atti di
volontà. Tante volte non abbiamo perdonato il passato, anche un lontano passato: i
nostri genitori, un torto subito nell’infanzia ... Perdonare significa ricordare il passato,
che non vuol dire ripetere mentalmente il passato, ma far riemergere la memoria
dell’atto per convertirla. L’oblio non cancella, bensì seppellisce il ricordo indesiderato
14
nella profondità della memoria, dov’è inaccessibile alla coscienza e produce
distruzioni tanto più gravi quanto più nascoste. Dimenticare è un modo per non
affrontare un ricordo fastidioso o relegarlo nel passato.
Gesù non chiede di dimenticare, chiede molto di più. Ci sono ferite che non è
possibile dimenticare, perché dopo anni sanguinano ancora. C’è il rischio di essere
dominati dall’odio, dall’avversione, ma proprio in quest’odio per chi mi ha fatto del
male gli consento di diventare signore e padrone della mia vita. La tragedia più
grande dell’essere oggetto del male è il fatto che facilmente la vittima viene
trasformata in peccatore, e per questa via si accresce la spirale della violenza. Non c’è
da meravigliarsi se i giudei dissero che Gesù stava bestemmiando quando perdonò i
peccati. Umanamente il perdono sincero e incondizionato sembra al di là delle nostre
possibilità naturali. E allora, come perdonare? Cessando di guardare a ciò che mi ha
fatto l’altro per guardare a ciò che ha fatto per me l’Altro, il Signore. Cristo che abita
in me può perdonare, lui che ha concluso la sua vita terrena perdonando (Lc 23,34:
“Padre, perdona loro; non sanno quello che fanno”). Hanno ucciso Gesù, ma non il
potere dell’amore sconfinato. Gesù non chiede il risarcimento delle offese fatte contro
di lui, infrange la legge del taglione e va incontro alla morte liberamente, vivendola
non come condanna, ma come dono d’amore.
È iniziata una nuova via per far fronte al male. La base del rapporto non è più
costituita dalle offese che ci procuriamo reciprocamente, ma dall’amore che è capace
di vincere il dolore e l’amarezza delle offese.
A volte uno non perdona altri perché non sa perdonare a se stesso di aver
permesso che l’altro lo offendesse. Perdonarsi: accettare di essere persone fragili,
limitate, che sbagliano, accettare i propri errori con serenità senza rabbia contro di sé,
avere comprensione e misericordia per se stessi, aver cura delle nostre ferite e delle
nostre fragilità.
5. Ancora sulla parabola del buon samaritano: un personaggio di cui si
parla poco
15
Ritorniamo per un momento alla parabola del buon samaritano dalla quale
abbiamo cercato di lasciarci interrogare. La tradizione patristica ha visto nel buon
samaritano Gesù, che si è chinato da fratello sull’uomo ferito, sull’Adamo ferito dal
peccato, per curarlo. I padri facevano dunque una lettura cristologica della parabola. Il
buon samaritano è Cristo e il discepolo è chiamato a imitare il suo atteggiamento così
come al momento della lavanda dei piedi nel vangelo di Giovanni Gesù dice: “Se io
che sono maestro ho lavato i piedi a voi che siete i miei discepoli, quanto più dovete
lavarveli voi gli uni gli altri” (Gv 13,1-20).
Ma io vi propongo un’altra lettura che può essere accostata a quelle che già
abbiamo fatto. C’è nella parabola un personaggio di cui non si parla mai e di cui la
parabola stessa dice molto poco. Certo, al centro del racconto vi è il buon samaritano,
figura positiva, che attira i nostri sguardi e che ci è proposto come modello da imitare.
Vi sono poi le due figure negative del sacerdote e del levita, due figure che in qualche
modo ci abitano. Dobbiamo saperci riconoscere in esse e iniziare un movimento di
conversione per diventare buon samaritano, per diventare prossimo – è un cammino,
un movimento, una dinamica che non si risolve una volta per tutte -. Ma in realtà tutta
la parabola ruota intorno a quell’uomo che scendeva da Gerusalemme a Gerico e che
fu lasciato privo di tutto e moribondo da una banda di malviventi. Di quest’uomo non
conosciamo il nome, non sappiamo nemmeno se fosse ebreo, non è detto se si trattava
di una vittima innocente o se quello che è accaduto è semplicemente un regolamento
di conti. Quell’uomo anonimo sembra ridotto a oggetto, preso, gettato, trasportato. È
semplicemente un uomo che è nel bisogno, un uomo che soffre.
Io vorrei ripercorrere la parabola dal punto di vista di quest’uomo, in cui si
potrebbe rispecchiare ciascuno di noi. A un certo punto del suo cammino, della sua
storia, della sua vicenda umana, potremmo dire, vede delle mani tese su di lui per
derubarlo, per fargli del male, per togliergli un po’ della sua vita fino a lasciarlo
mezzo morto. Chissà quanto si sarà spaventato! Mani ostili, mani nemiche.
Probabilmente senza un motivo. La vita, a volte, si presenta con queste mani ostili che
ci gettano a terra: giunge la malattia, la morte di una persona cara, situazioni avverse
… Mani ostili che si abbattono su di noi. E quell’uomo è a terra, nel bisogno. Vede
passare il sacerdote e il levita, o meglio, mi verrebbe da dire, vede i tacchi delle loro
16
scarpe che se ne vanno via rapidamente! Forse li conosceva, forse si salutavano
quando lui stava ritto in piedi. Adesso è prostrato a terra, fagotto di sangue e di
stracci; non è dignitoso fermarsi a parlare con lui; è una perdita di tempo, c’è altro da
fare di più importante, ci penserà qualchedun altro. Perché dovrei occuparmene
proprio io? E poi quelle ferite da dove vengono? Forse è un poco di buono, non è così
innocente come vuol farci credere. E quell’uomo è solo, solo nel momento del
bisogno, della sofferenza, come spesso ci troviamo noi nel momento del nostro
bisogno. Spesso la tentazione in questi casi è quella di non fidarsi più di nessuno; di
concludere che tutti sono come il sacerdote e il levita, tutti sono ipocriti e bugiardi.
Tentazione di chiudere le porte a chiunque … E invece quell’uomo si fida di quelle
mani tese su di lui, crede che non si tratta più di mani tese per fargli del male, mani
ostili; spera, crede che possono essere mani tese per aiutarlo, per venirgli incontro. Ha
fede, fa fiducia, si lascia aiutare. Ha quella fede/fiducia che tante volte noi non
riusciamo più ad avere; si lascia toccare là dove è ferito, lascia che sia versato olio e
vino per lenire le sue piaghe e si lascia portare.
Non esiste soltanto la cura che siamo chiamati ad avere per gli altri; noi sani
verso i malati; noi ricchi verso i poveri; noi giusti verso i peccatori … Chi di noi può
affermare di non avere ferite, di non conoscere forme di povertà, di solitudine, di
peccato? Anche noi non possiamo fare a meno della cura degli altri, ma non sempre
sappiamo riconoscere che il Signore ci invia “mani” premurose per sostenerci e
aiutarci, non sempre sappiamo accettare la cura che gli altri ci offrono con umiltà e
gratitudine.
Forse nel corso della nostra vita abbiamo avuto cura di chi era nel bisogno, ma
sappiamo diventando anziani, malati, accettare di essere bisognosi? Anche questo,
credo, ci sia suggerito da questa parabola, anche questo discorso fa parte di una
riflessione sul tema della cura.
17
Chi porta chi?
Questa è la storia di abba Sisoés e del suo discepolo, monaci nel deserto di
Scete, in Egitto, nel IV secolo. Abba Sisoés, padre spirituale di una colonia di monaci,
era molto anziano; ormai le gambe non lo reggevano più e gli era molto faticoso
percorrere il cammino che dalla sua cella lo conduceva alla chiesa, dove ogni sabato
si intratteneva con i fratelli sulla vita spirituale. Il suo giovane discepolo decise allora
di costruire una galleria che congiungeva la cella di Sisoès alla chiesa; ogni sabato, si
caricava sulle spalle l’anziano e lo trasportava in chiesa senza che nessuno lo vedesse.
Abba Sisoés poteva così continuare il suo ministero di guida spirituale senza perdere
la sua autorevolezza; nessuno infatti si accorgeva della debolezza e fragilità del suo
corpo.
Chi porta chi?
L’icona rappresenta il giovane che porta l’anziano, sua guida spirituale. Ma è
tutta la verità?
Il giovane, portando la sua guida, è portato e condotto e non si smarrisce nel
cammino. Ma è tutta la verità?
Il Signore, lui che è la guida e la via, l’uno e l’altro ha portato e guidato
perché, nel portarsi a vicenda (cf. Gal 6,2), non si smarrissero dalla via.