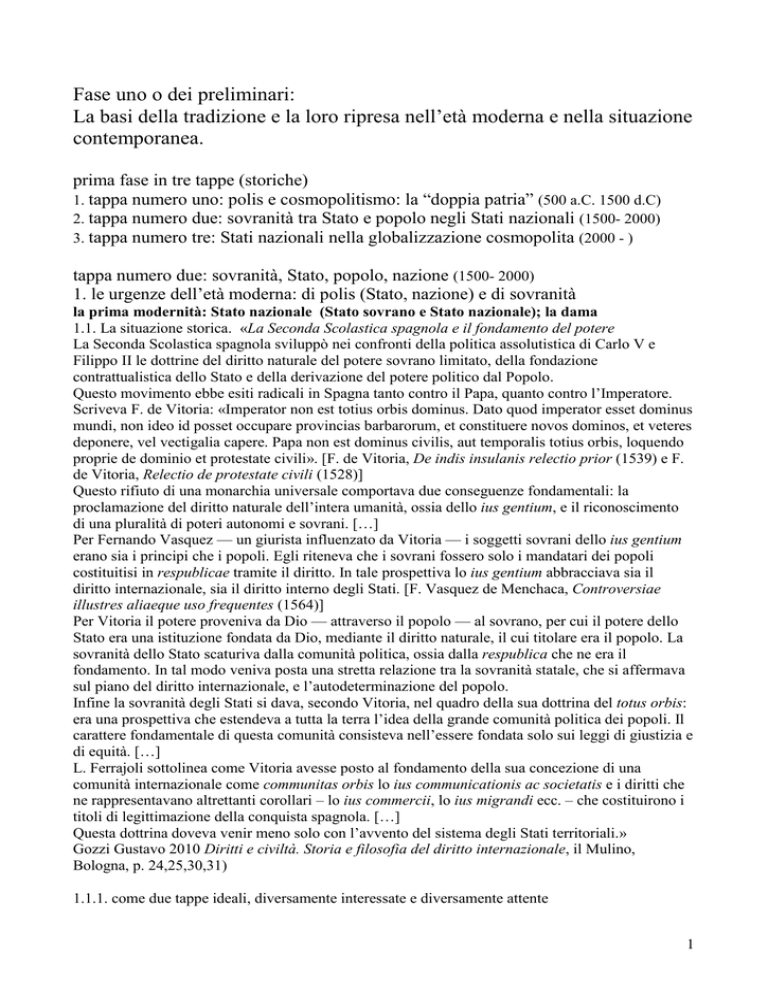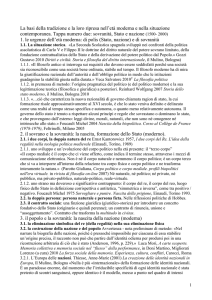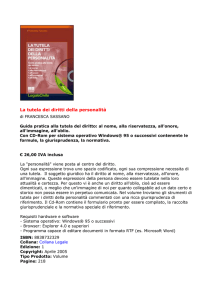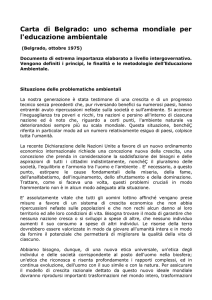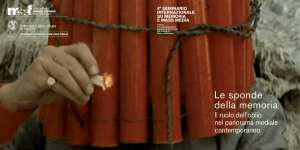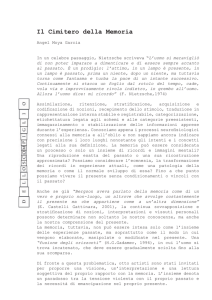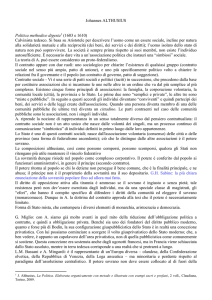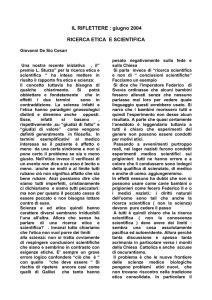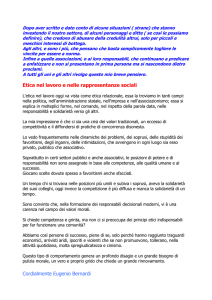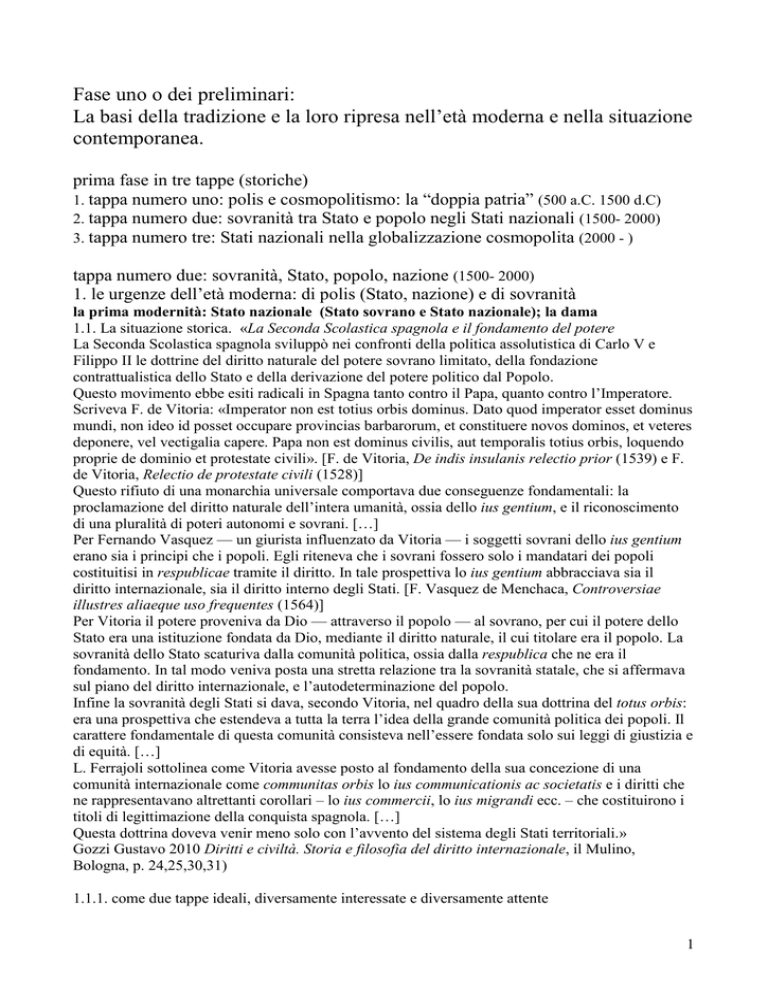
Fase uno o dei preliminari:
La basi della tradizione e la loro ripresa nell’età moderna e nella situazione
contemporanea.
prima fase in tre tappe (storiche)
1. tappa numero uno: polis e cosmopolitismo: la “doppia patria” (500 a.C. 1500 d.C)
2. tappa numero due: sovranità tra Stato e popolo negli Stati nazionali (1500- 2000)
3. tappa numero tre: Stati nazionali nella globalizzazione cosmopolita (2000 - )
tappa numero due: sovranità, Stato, popolo, nazione (1500- 2000)
1. le urgenze dell’età moderna: di polis (Stato, nazione) e di sovranità
la prima modernità: Stato nazionale (Stato sovrano e Stato nazionale); la dama
1.1. La situazione storica. «La Seconda Scolastica spagnola e il fondamento del potere
La Seconda Scolastica spagnola sviluppò nei confronti della politica assolutistica di Carlo V e
Filippo II le dottrine del diritto naturale del potere sovrano limitato, della fondazione
contrattualistica dello Stato e della derivazione del potere politico dal Popolo.
Questo movimento ebbe esiti radicali in Spagna tanto contro il Papa, quanto contro l’Imperatore.
Scriveva F. de Vitoria: «Imperator non est totius orbis dominus. Dato quod imperator esset dominus
mundi, non ideo id posset occupare provincias barbarorum, et constituere novos dominos, et veteres
deponere, vel vectigalia capere. Papa non est dominus civilis, aut temporalis totius orbis, loquendo
proprie de dominio et protestate civili». [F. de Vitoria, De indis insulanis relectio prior (1539) e F.
de Vitoria, Relectio de protestate civili (1528)]
Questo rifiuto di una monarchia universale comportava due conseguenze fondamentali: la
proclamazione del diritto naturale dell’intera umanità, ossia dello ius gentium, e il riconoscimento
di una pluralità di poteri autonomi e sovrani. […]
Per Fernando Vasquez — un giurista influenzato da Vitoria — i soggetti sovrani dello ius gentium
erano sia i principi che i popoli. Egli riteneva che i sovrani fossero solo i mandatari dei popoli
costituitisi in respublicae tramite il diritto. In tale prospettiva lo ius gentium abbracciava sia il
diritto internazionale, sia il diritto interno degli Stati. [F. Vasquez de Menchaca, Controversiae
illustres aliaeque uso frequentes (1564)]
Per Vitoria il potere proveniva da Dio — attraverso il popolo — al sovrano, per cui il potere dello
Stato era una istituzione fondata da Dio, mediante il diritto naturale, il cui titolare era il popolo. La
sovranità dello Stato scaturiva dalla comunità politica, ossia dalla respublica che ne era il
fondamento. In tal modo veniva posta una stretta relazione tra la sovranità statale, che si affermava
sul piano del diritto internazionale, e l’autodeterminazione del popolo.
Infine la sovranità degli Stati si dava, secondo Vitoria, nel quadro della sua dottrina del totus orbis:
era una prospettiva che estendeva a tutta la terra l’idea della grande comunità politica dei popoli. Il
carattere fondamentale di questa comunità consisteva nell’essere fondata solo sui leggi di giustizia e
di equità. […]
L. Ferrajoli sottolinea come Vitoria avesse posto al fondamento della sua concezione di una
comunità internazionale come communitas orbis lo ius communicationis ac societatis e i diritti che
ne rappresentavano altrettanti corollari – lo ius commercii, lo ius migrandi ecc. – che costituirono i
titoli di legittimazione della conquista spagnola. […]
Questa dottrina doveva venir meno solo con l’avvento del sistema degli Stati territoriali.»
Gozzi Gustavo 2010 Diritti e civiltà. Storia e filosofia del diritto internazionale, il Mulino,
Bologna, p. 24,25,30,31)
1.1.1. come due tappe ideali, diversamente interessate e diversamente attente
1
« Basta pensare all’impresa monumentale della Repubblica di Platone o al capolavoro della teoria
politica moderna, il Leviatano di Hobbes. Il filosofo antico si interroga sui requisiti che devono
essere soddisfatti perché una società sia riconoscibile come una società bene ordinata, stabile nel
tempo. Il filosofo moderno ha di mira la giustificazione razionale dell’autorità e dell’obbligo
politico in modo che le istituzioni guadagnino la stabilità giusta nella durata.» Veca Salvatore 20102
La filosofia politica Laterza, Roma-Bari p.23
1.1.2. in premessa di metodo: l’origine pragmatica del politico (e del politico moderno) e la sua
legittimazione teorica (filosofica e giuridica) a posteriori
«Originariamente con esso [concetto di «cultura politica»] si indicavano idee e valori che regolano
l’agire politico degli uomini offrendo loro orientamenti mentali. La nuova storia della cultura ha
invece spostato l’attenzione dal pensiero all’azione. L’ordine della cultura politica si può leggere
infatti bene (e spesso soltanto) nella prassi politica priva di riflessione, in quanto proprio nelle
epoche premoderne la cultura politica si rifletteva ed esprimeva nei testi meno di quanto ciò accada
nella modernità.
Vale la pena dunque di partire, diversamente da come si è fatto finora, proprio dalla prassi, e di
definire la cultura politica come il comportamento politico regolarmente osservabile di tutti i
partecipanti. Tale prassi può servirsi di testi e istituzioni già esistenti o si può condensare in nuovi
testi e istituzioni. La prassi produce innovazioni attraverso un calcolo razionale, ma solo raramente
attraverso progetti puramente teorici, e più spesso attraverso una prova nella realtà politica. Ciò vale
anche e soprattutto per quei processi e quelle istituzioni che si sono coagulate in quella
«iperistituzione» che è lo stato moderno. […] Le fondamenta dello stato moderno furono poste dal
soldato e dall’esattore delle tasse… [e…] la formazione dello stato spesso ha dovuto precedere
quella della nazione» Reinhard Wolfgang 2007 Storia dello stato moderno, il Mulino, Bologna
2010 p.30, 68, 113.
1.1.3. Il bilancio storico sulla formazione degli stati sovrani nazionali proposto e riassunto da
Michel Foucault: «…ciò che caratterizza la nuova razionalità di governo chiamata ragion di stato, la
cui formazione risale approssimativamente al XVI secolo, è che lo stato veniva definito e delineato
come una realtà al tempo stesso specifica e autonoma, o quanto meno relativamente autonoma. Il
governo dello stato è tenuto a rispettare alcuni princìpi e regole che sovrastano o dominano lo stato,
e che provengono dall’esterno: leggi divine, morali, naturali, che non sono né omogenee né
intrinseche allo stato. Tuttavia, nell’osservare queste leggi, il governo si propone tutt’altra cosa che
garantire ai propri sudditi la salvezza ultraterrena, come accadeva nel Medioevo, allorché il
sovrano veniva solitamente visto come colui che doveva aiutare i sudditi a raggiungere l’aldilà.
D’ora in poi invece, chi governa lo stato non deve più preoccuparsi della salvezza dei suoi sudditi
nell’aldilà, o quanto meno non più in maniera diretta. Non è tenuto nemmeno più a estendere la
propria benevolenza paterna sui sudditi, stabilendo con loro un rapporto da padre a figli, a
differenza del Medioevo, quando il ruolo paterno del sovrano era continuamente ribadito e marcato.
In altre parole, lo stato non è una casa, né una chiesa, né un impero. È una realtà specifica e
discontinua: esiste soltanto per se stesso e in relazione a se stesso, qualunque sia il sistema di
obbedienza che deve ad altri sistemi, come la natura o Dio. Lo stato non esiste che di per se stesso e
in funzione di se stesso. D’ora in poi, inoltre, esiste solo al plurale, vale a dire che non è obbligato,
in un orizzonte storico più o meno prossimo o remoto, a fondersi o a sottomettersi a qualcosa come
una struttura imperiale che sarebbe in qualche modo una teofania di Dio nel mondo, destinata a
condurre gli uomini alle soglie della fine del mondo, in una umanità finalmente riunificata. Non vi
è, dunque, integrazione dello stato nell’impero. Lo stato esiste solamente al plurale, in quanto
esistono tanti stati.
A proposito della specificità e pluralità dello stato, ho anche cercato di mostrarvi che tale specificità
plurale dello stato aveva preso corpo in alcune precise modalità di governare, conformi a istituzioni
a esse correlate. In primo luogo, sul piano economico c’era il mercantilismo … La seconda
modalità con cui il governo basato sulla ragion di stato si organizza, prendendo corpo in una pratica,
è la gestione interna, vale a dire quella che all’epoca veniva chiamata la polizia, ovvero la
2
regolamentazione indefinita del paese secondo il modello di una rigida e serrata organizzazione
urbana. In terzo luogo, infine, la creazione di un esercito permanente e di una diplomazia a sua volta
permanente. Potremmo dire che abbiamo a che fare con l’organizzazione di un appaiato
diplomatico-militare permanente che ha l’obiettivo di preservare la pluralità degli stati al di fuori di
ogni assimilazione imperiale, e far sì che possa stabilirsi fra di essi un certo equilibrio, in modo da
evitare che in Europa si abbiano unificazioni di tipo imperiale.
Mercantilismo, stato di polizia, bilancia europea hanno dunque costituito, insieme, il corpo concreto
della nuova arte di governare organizzata in base al principio della ragion di stato.» Foucault Michel
2004 Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979), Feltrinelli, Milano 2005
16-17
2. il sovrano e la sovranità: la nascita, formazione dello Stato (moderno).
Concetti e sedi
2.1. i due corpi, la doppia natura del re
Ernst Kantorowicz, nell’opera, del 1957, I due corpi del Re. L'idea della regalità nella teologia
politica medievale (Einaudi, Torino, 1989), affronta la tesi dei due corpi del re, formulata sin dal
medioevo, accettata e utilizzata come politicamente e giuridicamente nell’età moderna (come nei
Commentaries or Reports of the learned and famous Lawyer Edmond Plowden, formulate nel 1539
e pubblicata nel 1571 [Trebeschi Giada Un importante caso giuridico dell’Inghilterra
Elisabettiana: il Ducato di Lancaster di Edmund Plowden, in: Quaderni Meridionali. Rivista di
studi storico-sociali, attualità e ricerche archivisticobibliografiche, Anno XIV, n.30, Napoli,
Dicembre 1999]. Nella persona del monarca vi è una doppia natura, un doppio corpo: il corpo
mortale e il corpo trascendente, mistico, che, attraverso la consacrazione regale, entra nel corpo
mortale del sovrano; una parte del re quindi non muore mai; è il corpo trascendente di origine
divina, diremmo la sovranità, la regalità, che passa di re in re senza mai mutare e che trasferisce nel
nuovo re i principii della regalità e del potere dei suoi predecessori.
La finzione della duplicità della natura richiama quella della natura di Cristo Dio-Uomo (una sola
persona con due nature) e della Chiesa (terrena e spirituale, mondana e celeste, immanente e
trascendente, storica e mistica, transeunte e eterna ad un tempo). «E' in questo contesto che si forma
l'espressione "corpo mistico dello stato". Ora, è proprio il corpo mistico dello stato che,
aggiungendosi al corpo naturale del Re va a costituire il "Doppio Corpo". Su questa duplicità […] si
scandisce il rapporto tra il corpo del re e il corpo politico: questo individuale, perituro, fragile,
mortale, quello universale, immortale, imperituro, ed altresì fictum, imaginatum, raepresentatum.»
(Parotto Giuliana, Corpo politico e corpo mediale. profili biopolitici nell'era virtuale. in rivista di
filosofia on-line WWW.METABASIS.IT marzo 2007 anno II n°3)
«La duplicità, che come sopra ho accennato, diviene pensabile solo alla luce della nozione di
aevum, ovvero di uno spazio metafisico abitato dalle essenze universali, è ciò che permette al corpo
del re di farsi corpo statale, facendo trasmigrare l'autorità dalla figura concreta del Re al potere che
rappresenta e che sopravvive ben oltre la sua vicenda terrena. E' altresì proprio da questa duplicità
che discende, come molti hanno notato, la complessa e travagliata costruzione della sfera pubblica
moderna, che è svincolata dalla finitezza della persona ed assegnata all'apparato possente della
burocrazia. […] è attraverso questo corpo che viene infatti rappresentata l'intera comunità politica.
Il corpo del leader è quello designato a rappresentare il paese nelle situazioni pubbliche, il corpo
disciplinato all'interno del cerimoniale diplomatico, il corpo-emblema che si mostra nelle occasioni
ufficiali. Si tratta, in altri termini, "del livello delle funzioni politiche e sociali di cui il leader
politico è portatore in quanto persona nell'ambito di un determinato sistema di potere."In tale
quadro possiamo considerare il corpo del leader come una sorta di res extensa,
ovvero semplice, quasi impersonale supporto alla funzione politica di rappresentanza. […]
La regalità cristocentrica è caratterizzata in Kantorowicz, non dall'esistenza di due corpi quello del Re e quello, mistico, dello stato - bensì da un solo corpo, quello del Re. E' nell'unico
corpo del re che si mescolano gli attributi umani e quelli divini del potere: il corpo del Re è un
3
corpo duplice; è persona mixta. […] La duplice natura (gemina natura) del Re è fatta della stessa
materia della duplice natura, umana e divina, di cui è fatto Cristo. L'unica caratteristica posta a
differenziare la duplice natura del Re e quella di Cristo è sita nelle origini: la duplicità di Cristo
risiede nel suo essere stesso, mentre quella del Re è puro effetto della grazia, ovvero dell'unzione
sacra.» (Parotto 2007)
2.1.1. uno sviluppo e un’evoluzione del corpo politico nella età presente: il “terzo corpo”
«Ora, l'avvento dei media elettronici rovescia radicalmente questo spazio e sconvolge la
grammatica della rappresentazione introducendo uno spazio terzo, che non è né quello metafisico
dell'aevum e nemmeno quello naturale del corpo del Re. Le caratteristiche di questo spazio sono
state illuminate da molti autori. Quello che si apre qui è lo spazio del virtuale, lo spazio che
perimetra un ambito di esperienza nuovo. […] E' in questo spazio nuovo, estraneo alle categorie di
Kantorowicz, che irrompe un corpo ibrido dotato di una strana forma di esistenza: il corpo mediale
del leader.
Il corpo mediale è il corpo che ci viene offerto, come indica il termine stesso, attraverso i mezzi di
comunicazione elettronica. Non è né il corpo naturale e nemmeno il corpo politico; è un corpo terzo
che si va a interporre all'interno della relazione tra corpo fisico e corpo politico e ne trasforma
interamente la natura.» (Parotto 2007) [né naturale, né politico; né privato, né pubblico, ma privatopubblico, naturale-politico, reale-virtuale].
Rivoluzionario è il campo dei mutamenti paralleli che accompagnano e rendono efficace
politicamente e nel sociale il “terzo corpo”; lo studio del corpo politico diventa presentazione della
forma (delle forme note) che la politica tende ad assumere nell’età contemporanea. (Aspetti
richiamati per brevi tratti dallo studio citato di Parotto).
1. personalizzazione della politica, sempre più legata appunto alla singola personalità del leader
politico piuttosto che alle tradizionali strutture istituzionalizzate ancorate a visioni ideologiche o ad
interessi. Risponde in fondo all'esigenza di semplificazione che si origina dalle dinamiche
difficilmente controllabili che governano una società complessa; spiegazioni semplici, tradotte in
situazioni familiari, che permettono di attivare meccanismi di empatia, di identificazione.
2. Il corpo mediale (la figura del leader e, di conseguenza, anche il suo corpo) scardina il principio
stesso della funzione rappresentativa, in quanto mette in crisi uno dei suoi principali presupposti,
ovvero la separazione tra uno spazio pubblico e uno spazio privato, tra lo spazio dell'ufficialità e
quello esclusivamente personale. (qui gli studi di Erwing Goffman sul ruolo della distanza nella
relazione sociale e nella costruzione della funzione politica: i media elettronici irrompono facendo
saltare esattamente questa distanza. Lo spazio terzo introduce un punto di vista che scardina e
trasforma la grammatica della rappresentazione perché toglie al potere la sua aura, la sua unicità.)
3. L'immagine del corpo che viene prodotta è un'immagine inedita: il corpo mediale è un corpo
debole, fragile, docile; proprio perché è un corpo a cui è sottratta la possibilità di ritirarsi nel rifugio
sicuro del "retroscena". … gettato sullo schermo nella sua totale immediatezza, che fa
risaltare gli aspetti deiettivi, materiali e concreti della corporeità, le sue imperfezioni, le sue
mancanze. Lo violenta nella sua sfera intima. E' qui che emerge un ulteriore aspetto connesso al
corpo mediale. Il corpo mediale è tragico per un verso e ridicolo per l'altro. E' ridicolo per essere
stato mostrato nei suoi aspetti osceni, come è improvvisamente ridicolo l'imperatore che viene
denunciato nella sua nudità, secondo la celebre favola dei Vestiti dell'Imperatore. Basta aprire il
computer per rendersene conto. … riflettendo sugli aspetti politici del corpo mediale, è evidente che
l'emergenza della sfera privata, intima, comune, espressiva, vada ad annullare proprio quella
dimensione metafisica che è ascritta all'autorità, nella sua funzione rappresentativa. Si configura in
sostanza una sorta di situazione paradossale: proprio nel momento in cui la personalizzazione
enfatizza il carattere rappresentativo del leader politico allo stesso tempo mina alla base il
linguaggio della rappresentazione. Il corpo del leader rappresenta soprattutto se stesso, non ha più
l'"aura", non riesce più a rappresentare il corpo politico.
"…la televisione impedisce di vedere doppio. Non crede nell'invisibile …" (R. Debray, L'Etat
séducteur, Ed. Gallimard, 1993, trad it. Lo stato seduttore, Editori Riuniti, 2003, p. 31.)
4
4. Il tramonto della funzione rappresentativa del corpo non ne compromette il significato sul piano
politico ma lo sposta. Il corpo del leader non ha più il compito di rappresentare una comunità
politica astratta fissata, come nel contesto della riflessione di Kantorowicz, nello spazio metafisico
dell'aevum, quanto di mettere in opera meccanismi di identificazione, di imitazione, di proiezione e
di riproduzione. E'attraverso questa articolazione che trova spiegazione quello che possiamo
definire il plusvalore politico del corpo mediale. Come afferma icasticamente Régis Debray lo
slogan del principe fotosensibile suona così: "Lo stato non sono io, siete voi. Io sono voi, voi siete
me".
5. Il corpo mediale è presente immediatamente, ovvero non sta per qualcos'altro, non può
rappresentare e non rappresenta il corpo politico. Cionondimeno, come si è visto, è politico, è corpo
politico. E' il luogo in cui il corpo naturale e il corpo politico si riunificano e si sovrappongono. E'
proprio in virtù di questa sovrapposizione che vediamo ascrivere al corpo mediale caratteristiche
che nel modello di Kantorowicz sono attribuite esclusivamente al corpo politico. Una di queste è
l'immortalità. La continuità, che nella teorizzazione di Kantorowicz troviamo attribuita al corpo
politico, viene ad essere assegnata al corpo naturale. Come la regalità cristocentrica è caratterizzata
in Kantorowicz, non dall'esistenza di due corpi - quello del Re e quello, mistico, dello stato - bensì
da un solo corpo, quello del Re (è nell'unico corpo del re che si mescolano gli attributi umani e
quelli divini del potere: il corpo del Re è un corpo duplice; è persona mixta.), cos’, ora, nel corpo
mediale del politico le qualità naturali e quelle politiche non possono essere distinte e poste su due
piani diversi, sono mescolate nella concretezza paradigmatica del corpo sovrano. Nel corpo mediale
e nell’unione indistinguibile che esso rappresenta tra corpo mistico (politico) e corpo naturale si
verifica il ritorno della sacralità in ambito politico e in tempi contemporanei e secolarizzati. "I due
corpi del Re formano così un'unità indivisibile, essendo ciascuno di essi pienamente contenuto
nell'altro". Vista l’analogia cristologia: sarebbe infatti difficile, o meglio impossibile, interpretare
la natura divina di Cristo come un "ufficio", dal momento che la natura divina è il suo "essere". Si
tratta qui di constatare come si produca nuovamente una forma di immediatezza per cui il corpo del
leader in quanto tale incarna e manifesta il potere, in perfetta analogia con il tipo cristocentrico di
regalità. Ciò configurerebbe, come sopra accennato, un fenomeno esattamente contrario a quello
della dissacrazione, ovvero un fenomeno di ritorno del sacro, che evidentemente avviene al di fuori
della cornice fornita dalle forme simboliche, culturali ed istituzionali definite dalla chiesa. Si tratta,
in altri termini, di un sacro "selvaggio" che si mostra nel suo nucleo primitivo originario, ovvero
nella forma dell'ambivalenza. Come afferma Mircea Eliade: "L’ambivalenza del sacro non è
soltanto di ordine psicologico (attrazione e repulsione), ma esiste anche nell’ordine dei valori; il
sacro è nello stesso tempo „sacro“ e „contaminato“…attrazione e repulsione, degradazione e
idealizzazione sono entrambi presenti in relazione al corpo mediale del leader. La categoria del
sacro riuscirebbe, in tale direzione, anche a spiegare perché la degradazione del leader alla fine non
porta danno di immagine, danno che pregiudica invece definitivamente la funzione rappresentativa,
ma costituisce un ulteriore capitale simbolico, il plusvalore politico del corpo mediale. (vedi
l’esibizione del corpo malato, ferito del leader)
2.1.2. uno strano ma doveroso e significativo contrappunto: il corpo del re, il corpo del reo, luogo
fisico dello Stato in definizione corrispettiva e antitetica, “simmetrica e inversa”, come tra positivo /
negativo.
«Kantorowitz [E. Kantokowitz, The King’s two bodies 1959] ha dato un’importante analisi del
«corpo del re»: corpo doppio, secondo la teologia giuridica formatasi nel Medioevo, perché
comporta, oltre all’elemento transitorio che nasce e muore, un altro che permane nel tempo e si
mantiene come supporto fisico e tuttavia intangibile del regno. Attorno a questa dualità, che fu
all’origine vicina al modello cristologico, si organizzano una iconografia, una teoria politica della
monarchia, dei meccanismi che distinguono e insieme legano la persona del re e le esigenze della
corona; e tutto un rituale che trova nell’incoronazione, nei funerali, nelle cerimonie di sottomissione
i suoi tempi più forti. All’altro polo potremmo immaginare di mettere il corpo del condannato; lui
pure ha il suo stato giuridico, suscita il suo cerimoniale e richiama tutto un discorso teorico, ma non
5
per sostenere il «più di potere» che si accompagnava alla persona del sovrano, bensì per codificare
il «meno di potere» da cui sono segnati quelli che vengono sottomessi ad una punizione. Nella
regione più buia del campo politico, il condannato disegna la figura simmetrica e inversa del re.
Bisognerebbe analizzare quello che, in omaggio a Kantorowitz, potremmo chiamare il «corpo
minimo del condannato». Foucault Michel 1975 Sorvegliare e punire. Nascita della prigione,
Einaudi, Torino 1993, 32. [tema da riprendere in Foucault]
2.2. la doppia persona: persona naturale e persona ficta.
Nelle riflessioni politiche di Hobbes (1588-1679), che per prime avviano in forma teoretica
complessiva il disegno dello stato moderno, il potere politico sorge come persona e si presenta
come un ambiguo e gigantesco mostro (monstrum): Leviatano e Dio (terreno). [tema da riprendere
in Hobbes]
Nello Stato la sovranità diventa persona, acquista una autonomia giuridica; è soggetto e non
funzione o prerogativa di una persona naturale o fisica (individuale o collettiva), né emanazione –
dono di entità sacre e trascendenti ; è capace di azioni nel campo del diritto; la sua volontà non
coincide più con quella del sovrano o del popolo, fisicamente intesi. Nel Leviatano, del 1651,
Hobbes opera una distinzione tra persona ficta e persona naturale; a differenza della teoria dei due
corpi del Re, che parla di una sola persona con doppia natura, persona mixta, qui si introducono due
persone: persona naturale e persona ficta, (giuridica).
Scrive Hobbes: «Una persona è quella le cui parole o azioni sono considerate o come proprie o
come rappresentanti le parole e le azioni di un altro uomo o di qualche altra cosa, a cui sono
attribuite veramente o per finzione. Quando quelle sono considerate come proprie, allora la persona
è chiamata naturale; quando sono considerate come rappresentanti le parole e azioni di un altro,
allora la persona è detta ficta o artificiale.» (T. Hobbes, Leviatano, Laterza, Roma-Bari 1997, libro
XVI).
2.3. il contratto sociale: una finzione giuridica (giuridico-storica) per introdurre un concetto
fondativo dello Stato (originario e quindi perenne); la teoria della nascita dello Stato in forza di un
contratto sociale: un contratto di rinuncia, unione e “assoggettamento”. Contratto che trasforma la
multitudo in civitas, a garanzia del rispetto del contratto e dell’ordine che ne deriva lo Stato assume
su di sé in modo riservato e gestisce la vergogna della violenza come condizione di pace e di
giustizia (prende su di sé togliendola al sociale… e gestendola in monopolio; con le garanzie e i
rischi che tale uso riservato può comportare).
«Ciò torna a dire: è che nominino un uomo o un’assemblea, che sostenga la loro persona; e che
ciascuno di essi riconosca come proprie (e se ne riconosca come autore) tutte le azioni che colui che
in tal modo sostiene la loro persona compirà o farà compiere, in quelle cose che riguardano la pace
e la sicurezza comuni; e che tutti sottomettano, a questo riguardo, le loro volontà alla sua volontà e i
loro giudizi al suo giudizio. Questo è più del consenso o della concordia: si tratta di una unità reale
di tutti loro in una sola e identica persona, costituita mediante il patto di ogni individuo con
ciascuno degli altri; come se ognuno di essi avesse detto all’altro: io autorizzo, e cedo il mio diritto
di governarmi a quest’uomo o a questa assemblea di uomini a condizione che tu ceda a lui il tuo
diritto, e autorizzi allo stesso modo tutte le sue azioni. Ciò fatto, la moltitudine così unita in
un’unica persona è detta Stato, in latino civitas. Questa è la generazione del grande Leviatano, o
piuttosto (per parlare con maggiore reverenza), di quel Dio mortale, cui dobbiamo, sotto il Dio
immortale, la nostra pace e la nostra difesa. Infatti per questa autorità, che gli è stata data da ogni
singolo uomo dello Stato, gli è conferito l’uso di tanto potere e di tanta forza, da essere in grado,
con il terrore da essi suscitato, di conformare le volontà di tutti alla pace interna e all’aiuto
reciproco contro i nemici esterni. In lui risiede l’essenza dello Stato, che, per definirlo, è una
persona unica, dei cui atti si sono fatti individualmente autori, mediante patti reciproci; una grande
moltitudine di uomini alfine che possa usare tutta la loro forza e tutti i loro mezzi, come riterrà
opportuno, in vista della loro pace e della loro difesa comune. E chi sostiene questa persona è detto
6
sovrano; e si dice che detiene il potere sovrano. Tutti gli altri sono i suoi sudditi.» Thomas Hobbes,
Leviatano, ed. Riuniti, Roma 1982
La tesi di Hobbes è rivoluzionaria: il potere è conferito allo Stato da ogni singolo uomo dello Stato
e non deriva imperscrutabilmente da Dio; il potere conferito è tuttavia assoluto, lo Stato è persona.
L’unità politica della società coincide e pretende l’estinzione delle singole volontà; lo esige il fine
della pace e della giustizia. Lo Stato assume su di sé la violenza “naturale” sottraendola al sociale
per restituirla ad esso nella forma della forza della legge e delle strutture pubbliche (una violenza
svergognata dalle forme del diritto). Solo un complesso (e fragile) sistema di controlli può arginare
il pericolo di un ritorno, attraverso lo Stato, di quella violenza che gli è stata consegnata come
strumento riservato di pace e di giustizia. Un ritorno facilitato dal contratto e reso fatale perchè
privo di qualsiasi forma possibile di vergogna: la dittatura e il totalitarismo possono esibire senza
pudore il contratto da cui lo Stato è generato e, poiché ne possiede i mezzi, può facilmente costruire
e mostrare il consenso da cui dichiara di essere legittimato e sostenuto.
3. il popolo e la sovranità: la nascita della nazione (moderna)
Anche i concetti di popolo (uno e sovrano) e di nazione (area di identità) sono frutto di laboriosa
costruzione storica, culturale e politica, in un continuo succedersi e richiamarsi di urgenze
pragmatiche e necessità teoretiche.
Ma occorre segnalare il diffondersi di una distinzione: alla sua prima comparsa, nell’età moderna, il
termine “nazione” coincide con “Stato sovrano” e lo vuole presentare come istituzione autonoma e
come società politica indipendente; nell’età definita romantica (tra Settecento e Ottocento) il
termine nazione indica l’unità del popolo al di là e oltre, a volte contro, la configurazione degli Stati
sovrani; e intende avviare un processo di unificazione e riconoscimento che dovrà attribuire al
nuovo soggetto in azione, il popolo, la prerogativa e le caratteristiche dello Stato sovrano.
3.1. la eliminazione simbolica del re (della regalità) nella sua eliminazione fisica (l’eliminazione
della doppia persona del re). «Per i rivoluzionari francesi, il processo e l’esecuzione di Luigi XVI
non avevano molto a che vedere con la colpevolezza o l’innocenza personale del re. Si trattava in
primo luogo di mettere in scena la distruzione definitiva dell’Ancien régime. Questo atto mirato
spogliò la monarchia della sua aura simbolica e «degradò» il sovrano a comune cittadino; il
processo e l’esecuzione furono la dimostrazione della sottomissione del re alla sovranità popolare.»
Reinhard Wolfgang 2007 Storia dello stato moderno, il Mulino, Bologna 2010 p. 29
3.2. la costruzione della nazione e del popolo
Avvertenza - nota preliminare di metodo: «Nel narrare la biografia delle nazioni, poiché è pressoché
impossibile per ciascuna di essa stabilire un’origine precisa, il racconto non può che partire
dall’identità odierna per prodursi poi in una ricostruzione arbitraria di ciò che è stato (Anderson,
1996, p. 229).» Luca Mori, A carte scoperte. Memoria collettiva e memoria sociale nel “flusso”
della performance, in Doni Martino, Migliorati Lorenzo (a cura di) 2010 La forza sociale della
memoria. Esperienza, cultura, conflitti, Carocci, Roma, p. 36
3.2.1. L’Europa delle nazioni.
Thiesse, Anne-Marie (2001) La creazione delle identità nazionali in Europa, Il Mulino, Bologna
«Nulla è più «internazionale» della formazione delle identità nazionali. È un paradosso enorme, dal
momento che l’irriducibile specificità di ogni identità nazionale è stata pretesto di scontri
sanguinosi, eppure identico è il modello, messo a punto nel quadro di intensi scambi internazionali.
Le nazioni moderne si sono costituite in modo diverso da come raccontano le storie ufficiali. Le
loro origini non si perdono nella notte dei tempi, nelle età oscure ed eroiche descritte dai capitoli
iniziali delle storie nazionali. Neppure la lenta formazione di territori in seguito a conquiste e
alleanze è stata all’origine delle nazioni, poiché essa altro non è che la storia tumultuosa dei regni o
dei principati. La vera nascita di una nazione è il momento in cui un pugno di individui dichiara che
essa esiste e cerca di dimostrarlo. I primi esempi non sono anteriori al XVIII secolo, non essendovi
7
nazioni in senso moderno, cioè politico, prima di questa data. L’idea si inserisce, in realtà, nel
quadro di una rivoluzione ideologica. La nazione è concepita come una comunità vasta, tenuta
insieme da vincoli che non si riferiscono alla dipendenza da uno stesso sovrano, né all’appartenenza
a una stessa religione o a una stessa classe sociale: essa non è determinata dal monarca, la sua
esistenza è indipendente dai rischi della storia dinastica o militare. La nazione somiglia
straordinariamente al popolo della filosofia politica, quei popolo che da solo, secondo i teorici del
contratto sociale, può conferire la legittimità del potere, ma è anche qualche cosa di più: il popolo è
un’astrazione, la nazione è viva. […]
Il processo di formazione identitario consiste nel determinare il patrimonio di ogni nazione e nel
diffonderne il culto. La prima fase dell’operazione non è stata così evidente, poiché in realtà gli
antenati non avevano redatto un testamento indicante ciò che desideravano trasmettere ai
discendenti, ed era oltretutto necessario scegliere fra gli antenati i presunti donatori, ossia trovare
ipotetici ascendenti comuni agli alverniati e ai normanni (o agli svevi e ai sassoni, ai siciliani e ai
piemontesi). Perché si producesse il nuovo mondo delle nazioni, non era sufficiente inventariarne
l’eredità, si doveva piuttosto inventarlo. Ma come? Che cosa era necessario escogitare alfine di dare
la testimonianza vivente di un passato prestigioso e l’immagine autorevole della coesione
nazionale? Il compito era arduo, di lunga durata e fu svolto collettivamente. Un grande cantiere di
sperimentazione, senza capomastro eppure intensamente animato, venne aperto in Europa nel
Settecento: esse conobbe l’epoca di maggiore produttività nel secolo successivo e la sua
caratteristica fu quella di essere transnazionale. Non vi è stato accordo preventivo o divisione del
lavoro; ma ogni singolo gruppo nazionale si mostrava molto attento a quanto facevano i loro simili
e rivali, cercando di adattare alle proprie esigenze le idee degli altri e venendo a sua volta imitato,
quando aveva scoperto qualcosa di nuovo o era riuscito a migliorare l’esistente. Appena i letterati
tedeschi avevano esortato, con successo, i compatrioti a seguire l’esempio inglese nella
riesumazione del patrimonio culturale e nazionale, i loro omologhi scandinavi o russi invitavano a
prendere esempio dai tedeschi. Qualche decennio più tardi, gli eruditi francesi fustigavano i
concittadini che avevano esitato a impegnarsi in un’impresa che, nel frattempo, era stata un banco
di prova per russi, spagnoli e danesi. Le esposizioni internazionali, luoghi privilegiati di esibizioni
identitarie, sono state, a partire dalla metà dell’Ottocento, occasioni privilegiate di questo
commercio simbolico. Le rivalità furono aspre, ma in genere pacifiche, gli accordi frequenti, come
pure gli scambi di consigli o anche gli incoraggiamenti agli esordienti.
Il risultato della creazione collettiva delle identità nazionali non è un modello unico, ma piuttosto
secondo l’espressione provocatoria del sociologo Orvar Löfgren, una sorta di kit per il «fai da te»:
una serie di declinazioni dell’«anima nazionale» e un insieme di procedure necessarie alla loro
elaborazione. Oggi siamo in grado di redigere la lista di elementi simbolici e materiali che una
nazione degna di questo nome deve offrire: una storia che stabilisca la continuità con i grandi
antenati, una serie di eroi prototipi di virtù nazionali, una lingua, dei monumenti culturali, un
folclore, dei luoghi sacri e un paesaggio tipico, una mentalità particolare, delle rappresentazioni
ufficiali — inno e bandiera — e delle identificazioni pittoresche — costume, specialità culinarie o
animale totemico. Le nazioni che di recente hanno avuto diritto al riconoscimento politico, e
soprattutto quelle che ancora lo rivendicano, testimoniano, insieme ai segnali che inviano per
attestate la propria esistenza, il carattere prescrittivo di questa lista di priorità identitaria. Il «sistema
Ikea» di costruzione delle identità nazionali, che permette assemblaggi differenti a partire dalle
stesse categorie elementari, appartiene al dominio pubblico mondiale, avendolo l’Europa esportato
nello stesso tempo in cui imponeva alle vecchie colonie il proprio modo di organizzazione politica.
Il ricorso alla lista identitaria è il mezzo più banale, perché più immediatamente comprensibile, di
rappresentare una nazione, che si tratti della cerimonia di apertura dei giochi olimpici, delle
accoglienze riservate a un capo di stato straniero, dell’iconografia postale e monetaria o della
pubblicità turistica.
La nazione nasce da un postulato o da un’invenzione, ma essa vive solo per l’adesione collettiva a
questa finzione. I tentativi abortiti sono numerosissimi, mentre i successi sono il frutto di un
8
costante proselitismo che insegna agli individui ciò che sono, li obbliga a conformarsi al modello
proposto e li incita a diffondere a loro volta quel sapere collettivo. Il sentimento nazionale è
spontaneo solo quando è stato perfettamente interiorizzato ma per ottenere ciò occorre anzitutto
averlo insegnato. La messa a punto di una pedagogia è il risultato di osservazioni basate su
esperienze condotte in altre nazioni e trasposte quando sembrava opportuno farlo.»
Thiesse 2001 p. 7-10
«Molti intellettuali conservatori (e non solo conservatori), da Blaise Pascal a Immanuel Kant a
Joseph de Maistre elaborarono il concetto delle origini illegittime del potere, del «crimine fondante»
su cui sono basati gli Stati, che è poi la ragione per cui si dovrebbero offrire «nobili bugie» al
popolo sotto forma di narrazioni eroiche sulle origini di una nazione.» Žižek Slavoj 2007 La
violenza invisibile, Rizzoli, Milano 2007 p. 119
3.2.2. La formazione del popolo. Al modello classico, che fa perno sugli autori greci e latini per
tesi, stili di razionalità e canoni estetici, e al modello della cultura cristiana, o meglio ebraicocristiana, richiamata per gli aspetti teologici e morali, si vuole ora affiancare (in clima politico) una
terza componente dichiarata autonoma e originaria: la cultura popolare. Il popolo è depositario orale
di una cultura propria (pagana, medievale e barbara); aedi, bardi e trovadori ne sono i cantori; quella
cultura è costitutiva di identità e permette il definirsi di un nuovo soggetto, il popolo, che proprio
nell’800 prende forma di nazione. Si tratta di una tesi romantica maturata soprattutto in clima
antiassolutistico e come espressione di nuova sensibilità (definita “romantica”) mirante a sostenere
progetti nazionali, resa efficace storicamente attraverso una sua opportuna collocazione in età
remota, per lo più medievale, opportunamente ripresa e rivalutata.
«Il primo periodo di elaborazione delle identità culturali nazionali è particolarmente fertile di
“manoscritti autentici” miracolosamente ritrovati dopo secoli di oblio e subito scomparsi: alcuni
divorati dalle fiamme, altri sequestrati entro le mura di un convento spagnolo, rubati da un rivale
invidioso oppure imbarcati su una nave in partenza per le Americhe. […] In realtà la linea di
demarcazione fra le creazioni originali ispirate ai frammenti antichi e la traduzione in lingua
contemporanea di testi antichi è sempre poco chiara per i letterati patrioti che, stimolati dagli
esempi stranieri, si sono attribuiti il compito di illustrate a tinte vivaci il genio creatore del loro
popolo, non ritenendo una frode l’elaborazione di temi non reperibili in fonti troppo recenti o troppo
frammentarie. Al pari dei primi archeologi o anatomisti, essi considerano legittima la ricostruzione
dell’insieme a partire da pochi frammenti, poiché componendo su ispirazione dell’anima nazionale,
non derogano al dovere di autenticità; come Herder ha del resto affermato esplicitamente a
proposito della controversia nell’epopea ossianica. […] Gli studiosi di canti popolari non
pubblicano i materiali bruti raccolti, ma fabbricano un prodotto finito, gradevole e ripulito e
all’occorrenza ci mettono del loro. Lo stesso procedimento viene adottato per le vestigia storiche,
con la prospettiva di riparare gli oltraggi del tempo e di ricostruire, se necessario con materiali
nuovi di zecca, ciò che si crede vi fosse stato in precedenza.» Thiesse 2001 p.100,107,142
3.3. La storia della formazione e costruzione (sempre in fieri) dello Stato nazionale, storia
dell’incontro, come in un ossimoro, tra Stato e Nazione-Popolo negli Stati nazionali, è consegnata
a diverse dinamiche.
3.3.1. A due protagonisti: popolo e sovrano, in un processo tormentato, drammatico o, certamente,
complesso. Osserva Max Weber, con apparente brutalità, ma certo venendo alla sostanza del
processo storico: «Lo stato, al pari delle associazioni politiche che lo hanno preceduto storicamente,
consiste in un rapporto di dominazione di alcuni uomini su altri uomini, il quale poggia sul mezzo
della forza legittima (vale a dire, considerata legittima). Perché esso esista, bisognerà dunque che i
dominati si sottomettano all’autorità cui pretendono i dominatori del momento. […] …formulo
soltanto questa definizione puramente concettuale: lo stato moderno è un’associazione di dominio
in forma di istituzione (anstaltsmässiger Herrschaftsverband), la quale, nell’ambito di un
determinato territorio, ha conseguito il monopolio della violenza fisica legittima come mezzo per
l’esercizio della sovranità, e a tale scopo ne ha concentrato i mezzi materiali nelle mani del suo
9
capo, espropriando quei funzionari dei «ceti» che prima ne disponevano per un loro proprio diritto,
e sostituendovisi con la propria suprema autorità.» (Weber Max 1919 Il lavoro intellettuale come
professione. La politica come professione, Einaudi, Torino 1966, 49, 55)
3.3.2. Un ulteriore elemento, che rende complessa la storia della formazione dello Stato nazionale, è
fornito dalla compresenza storica, nell’età moderna, di due cammini paralleli che convivono senza
incontrarsi: cittadini della nazione (identità nazionali; sommariamente “romanticismo”), cittadini
del mondo (appartenenze cosmopolitiche; sommariamente “illuminismo”)
Tentazioni identitarie degli Stati nazionali che trovano il proprio vertice nella logica politica del
“noi – loro” “amico – nemico” (una contrapposizione che secondo le teorie di Carl Schmitt
costituisce l’essenza del politico moderno).
Affermazione e rivendicazione del concetto di “cittadino del mondo” come obiettivo e diritto
irrinunciabile. Una constatazione (anche in forma di conclusione alla seconda tappa per un
passaggio alla terza). «Nell’Europa del XVIII e del XIX secolo il concetto di «cittadino del
mondo», inteso in questo senso, era di moda. Si dibatteva sull’importanza, la necessità e l’utilità di
un legame e di una compenetrazione tra il cosmopolitismo e la nazione, tra l’universalismo e il
particolarismo. A questo dibattito parteciparono — di nuovo, prima che il nazionalismo si
impossessasse dei cuori e delle menti delle persone — poeti, filosofi, teorici della società e
dell’economia; in breve: tutti i grandi spiriti dell’Europa. In questo modo furono creati e radicati nel
contesto di un’epoca e di una controversia pre-nazionale i fondamenti e le tradizioni intellettuali di
un’Europa cosmopolita, post-nazionale, che oggi occorre riscoprire e rivitalizzare nell’orizzonte
dell’era globale e di fronte e contro il sogno, in ultima analisi di corto respiro, dell’eterna nazione.
[…] La sensibilità e la moralità cosmopolitiche non si producono automaticamente con
l’interconnessione dei mondi, ma in forza dell’esperienza che è ormai impossibile separare la
propria sopravvivenza dalla sopravvivenza di tutti.» (Beck 2002 p.50,54)
3.3.3. Un cammino affiancato. Definirsi “moderno” della cultura e delle istituzioni del cristianesimo
nel contesto del cammino della riforma e il costituirsi dello Stato moderno e della Nazione
identitaria (secondo processi lunghi e frutto di apporti plurimi).
«Foucault vede profilarsi una trasformazione decisiva nei nostri regimi di verità, e con essi delle
modalità di esercizio del potere all’interno della società occidentale: appare cioè una nuova
modulazione della tecnica (antica) dell’esame di coscienza, in cui «il potere e il sapere del prete e
della Chiesa si trovano implicati», e che andrà incontro ad un ulteriore rafforzamento e
perfezionamento in quella fase di «cristianizzazione in profondità» che comincia ad essere
realizzata secondo Foucault a partire dal XVI secolo, epoca in cui si assiste, contemporaneamente,
alla formazione degli stati moderni e al rafforzarsi «dell’inquadramento cristiano dell’esistenza
individuale» attraverso il dispiegarsi «di un immenso dispositivo di discorso ed esame, di analisi e
di controllo» reso possibile dal fatto che ormai «tutto o quasi tutto ciò che ha a che fare con la vita,
l’azione, i pensieri di un individuo» dovrà passare al filtro della confessione. Attraverso l’analisi
della progressiva generalizzazione ed estensione del «diritto d’esame» applicato al foro interiore
della coscienza Foucault avvia una prima delineazione di quella forma di governo delle anime e
delle condotte degli individui destinata a metter capo al fenomeno della «direzione di coscienza» e
che tre anni dopo chiamerà «potere pastorale». Un potere che investe la vita nella sua totalità e fin
nel più infimo dettaglio attraverso la predisposizione di un dispositivo discorsivo all’interno del
quale «tutti i comportamenti, tutte le condotte, tutti i rapporti con gli altri, tutti i pensieri, tutti i
piaceri, tutte le passioni (…) dovranno essere filtrati» e che renderà possibile quel «racconto totale
dell’esistenza» che costituisce per Foucault la parte più segreta delle tecniche d’esame e delle
procedure di medicalizzazione, aurora di tutte le psicologie che si metteranno di lì a poco a
decifrare i misteri dell’anima, ritenendo di poterli identificare nelle leggi del desiderio e nella logica
delle pulsioni, avendo dimenticato (o facendo finta di non sapere) che già la pratica confessionale
aveva delineato quella che Foucault chiama nel 1973 una «anatomia della voluttà», una «cartografia
peccaminosa del corpo», che nelle spire della concupiscenza bracca la verità segreta dell’anima.»
10
Foucault Michel 1970 L’ordine del discorso e altri interventi, Einaudi, Torino 2004, dalla
Postfazione di Mauro Bertani, p 87
Siamo già, forse, nella biopolitica, con la gestione riservata in monopolio delle questioni ultime
(nascita e morte), del disagio (con assistenza e carità), della malattia (con istituti di cura e
detenzione) ad opera della Chiesa in un periodo di concomitante e affiancato, a volte
amministrativamente e politicamente conflittuale, definirsi dello Stato moderno; due istituzioni in
accordo per la gestione e controllo totali dell’uomo. Foucault indica con una sequenza, in crescendo
consequenziale, lo sviluppo di una presenza: diritto d’esame, direzione di coscienza, potere
pastorale. «… è nell’idea e nella pratica di un potere di tipo pastorale che Foucault rinviene, come
si è detto, il modello originario del governo degli uomini. Esso ha un materiale e un punto
d’applicazione: una «molteplicità in movimento»; un telos: fare il bene della molteplicità su cui si
esercita, assicurare «la salvezza del gregge»; una forma: la dedizione, lo zelo, e insomma la «cura»
del pastore che veglia e serve il gregge fino al sacrificio di sé; una modalità («paradossale», la
definisce Foucault) di esercizio: si applica alla molteplicità ma mira ad essere «individualizzante».
[…] «arte di governare gli uomini» che gli stati moderni non faranno che investire in una pratica
politica calcolata e riflessa. […] E attraverso un confronto serrato con l’esperienza greca di rapporto
con la verità, su cui non cesserà di tornare, Foucault comincia a mostrare come nel modello
pastorale cristiano vengano predisposti alcuni schemi di governo delle anime e delle condotte, come
l’istanza dell’«obbedienza pura», della «dipendenza integrale», della «servitù integrale» di cui
studia le primitive occorrenze all’interno della vita cenobitica, che a differenza di ciò che avveniva
per il cittadino greco, non mirano in alcun modo ad assicurare il «dominio di sé», come dice nel
1978, bensì a rendere possibile una sottomissione che fa dunque del processo di
«individualizzazione» un problema capitale, indiscernibile dal problema della verità.» (Bertani 2004
p.88-89)
4. una ipotesi di ripresa (in prospettiva) dello stato-popolo-nazione in una definizione
non epica di sé, ma come comunità definita dalle relazioni etiche.
4.1. Un’etica della memoria che è un’etica della cura.
Come uno sviluppo del concetto di stato-nazione, così come dei concetti politici generali di
“nazione” [“identità”] e di “cosmopolitismo”,“universalismo”, e per una riscrittura delle relazioni
sociali in termini etici, possono operare le osservazioni sull’etica della memoria e della cura,
applicate al concetto di comunità (pur nella natura complessa e delicata, visti i molti abusi del
termine e della cosa, del concetto di comunità [sulla sua plurivalenza storica: Bonomi Aldo 2010
Sotto la pelle dello Stato. Rancore, cura, operosità, Feltrinelli, Milano; Demichelis Lelio 2010
Società o comunità. L’individuo, la libertà, il conflitto, l’empatia, la rete, Carocci, Roma])
Alcune premesse sul tema della memoria etica e della comunità da punti di vista diversificati.
4.1.1. Dal punto di vista della politica come arte della gestione delle relazioni sociali: «Nessun’altra
arte invece, piuttosto e prima dell’arte regia, potrebbe pretendere di affermarsi arte dell’aver cura di
tutta la universale comunità degli uomini, e arte dell’aver il potere su tutto il genere umano»
(Platone, Politico 276 bc)
4.1.2. Dal punto di vista della società intesa come sistema di relazioni costanti: «Comunitarismo.
Sembra allora che una società buona sia quella in cui ciascuno si riconosce con ciascun altro nella
condivisione di una comune appartenenza a una forma di vita, a una tradizione, a una concezione
del bene. E l’identità collettiva è espressa dalla condivisione stabile nel tempo del “bene comune”».
Veca Salvatore 20102 La filosofia politica Laterza, Roma-Bari, 93-94
4.1.3. Dal punto di vista antropologico e della applicazione per analogia di criteri antropologici al
vivere sociale considerato come insieme. La prospettiva riguarda “La forza sociale della memoria”
considerata come processo che permette di costruire identità e permette anche di coglierne i
mutamenti, talora repentini e radicali, legati dunque sì alla memoria, ma anche e forse
maggiormente all’oblio e alle sue forme sociali. (Doni Martino, Migliorati Lorenzo (a cura di) 2010
La forza sociale della memoria. Esperienza, cultura, conflitti, Carocci, Roma.)
11
4.2. «la funzione identificante della memoria»
«Sembrerebbe infatti esserci, tra gli studiosi, un accordo più o meno tacito riguardo la funzione
identificante della memoria.» (Mori Luca A carte scoperte. Memoria collettiva e memoria sociale
nel “flusso” della performance, in Doni 2010 p.26) Le tesi del “cognitivismo” (fina dalle analisi di
F. Brentano) segnalano il ruolo costruttivo e selettivo della percezione e della memoria sulla base
della originaria intenzionalità della coscienza.
4.2.1. Il ruolo fondamentale dell’oblio per la formazione della memoria storica, individuale e
sociale. L’identità che una persona, un gruppo, una società si attribuiscono è risultato di ciò che
conservano nella memoria ma è, e forse in modo più incisivo, formata anche da ciò che si
dimentica; in un oblio non casuale ma (valga l’ossimoro) inconsapevolmente volontario. Parlare
della funzione identificante della memoria è anche parlare di oblio. Il principio da cui parte la tesi è
il seguente: «Non dimentichiamo semplicemente per un “difetto di fabbrica” del cervello:
dimentichiamo perché cambiano i quadri di riferimento. […] Occorre ammettere la matrice
culturale dell’oblio, esattamente come per la memoria: si sta insieme non soltanto perché insieme
ricordiamo i valori e i vincoli che ci identificano, ma anche perché insieme dimentichiamo. Finché
la comunità è omogenea, è omogeneo anche l’oblio che la delimita, e chi insiste a cercare ricordi
sepolti è un intruso che non conosce le buone maniere, o un occidentale post-tradizionalista che non
capisce bene come funzionano le cose “qui da noi”. L’oblio non è dunque il semplice opposto della
memoria, ma è un processo sul quale si costruisce un sistema di identità. […] Quindi al di là degli
sforzi che individualmente si possono investire per coltivare la memoria, questa è in ogni caso
costantemente sotto il controllo sociale. Per cui, qualora emergesse un ricordo non consentito dai
margini sociali della memoria, esso sarebbe custodito in “zone franche”, bandito, oppure
stigmatizzato come bizzarro, eccentrico, accademico. È un processo che vorrei chiamare rimozione
sociale.» (Doni Martino 2010, p.14, 18-19).
4.2.1.1. «Quando ricordiamo troppo, la nostra memoria finisce per ucciderci » aveva cominciato a
dire Hans. «Quanto più ricordiamo e tanto più siamo invasi dalla vita, e alla fine la nostra memoria
diventa la pressione stessa della vita dentro di noi, la pressione intollerabile della vita. » Per
sopravvivere bisogna saper dimenticare, e invece le persone che conservano la memoria, che ogni
giorno invece di dimenticare vedono la loro memoria crescere dentro di loro diventano poi le
vittime della loro memoria. Le parole servono anche per questo, per liquidare ricordi, le parole
servono anche per questo, per annientare i ricordi nella forma di una parola. « Con la parola ci
liberiamo di una quantità di cose che se fossero ricordate finirebbero per annientarci », aveva
continuato Hans. Ad alcuni riesce di trascorrere un’intera esistenza a parlare per dimenticarsi degli
altri uomini, di sé, per dimenticarsi di tutto e per un po’ di tempo, più o meno lungo, si dimenticano
degli altri, di sé, di ogni cosa; loro procedono e parlano sempre in avanti, così Hans, e riescono a
sopravvivere, mentre quelli che da un certo punto in poi cominciano a ricordare e sempre più a
ricordare trovano delle parole che invece di aiutarli a sbrigare la pressione della vita, sono parole
che li crocifiggono. (Gargani G. Aldo 1990 L’altra storia, A.Mondadori, Milano, p. 165)
4.2.2. trauma sociale, memoria / oblio nella forma della coazione a ripetere.
«Nel 1914, Freud scrive un saggio decisivo sull’uso psicoanalitico del ricordo, intitolato Ricordare,
ripetere, rielaborare. L’argomento è il rapporto tra il lavoro dell’analista e le «resistenze di
rimozione» del paziente. L’analista si sforza di individuare il ricordo del trauma generativo del
malessere del paziente, questi per contro fa di tutto per non rivelare il suo nucleo patogeno,
innescando tra sé e la memoria esplicita un meccanismo che diviene uno dei concetti fondamentali
della psicoanalisi: la “coazione a ripetere”. In sintesi, al posto di ricordare, il paziente agisce gli
elementi del ricordo, li mantiene nell’oblio attraverso l’azione. Questi agiti costituiscono una forte
resistenza nei confronti del lavoro analitico. Freud utilizza termini che per noi sono molto
importanti: lavoro e coazione. Sono due termini in eloquente contrapposizione: il “lavoro” è la
paziente attesa dello psicoanalista durante la fase di transfert, nella quale la ripetizione ossessiva si
“trasferisce” dall’ambito puramente solipsistico e patologico a una “scena” aperta. Ma “lavoro” è
12
anche lo sforzo del paziente di accettare la propria sofferenza: «La malattia stessa deve cessare di
essere per lui qualche cosa di esecrabile e diventare piuttosto un degno avversario, una parte del suo
essere che si fonda sopra buoni motivi, e da cui dovranno essere tratti elementi preziosi per la sua
vita ulteriore» (Freud, 1977, p. 358). La coazione a ripetere è dunque l’eterna presentificazione di
un passato traumatico che deve confrontarsi con l’altro per interrompere la propria circolarità.
La nostra ipotesi è questa: se si riesce a individuare nel comportamento sociale una pratica
sintomale dell’oblio, sarà possibile codificare la dimensione sociale del trauma. Occorre dunque
verificare se nelle pratiche sociali quotidiane sussistano dei sintomi paragonabili alla coazione a
ripetere. Tali sintomi sono effettivamente presenti nella vita rurale della Bucovina, e si possono
riconoscere nell’impressionante diffusione di musei etnografici in tutto il territorio. Ogni villaggio,
anche il più piccolo, ha una casa particolare adibita a museo. Nel museo sono raccolti generalmente
oggetti di vita quotidiana, utensili antichi, pizzi, merletti, suppellettili di ogni tipo, senza
necessariamente un’organizzazione catalogale, ma semplicemente allo scopo di non perdere la
memoria... di se stessi. Già, perché i musei rurali bucovini non sono fatti per essere visitati da turisti
(che non ci sono) o da studiosi (che si rivolgono ad altri centri meglio serviti e più forniti), non sono
parte di un “lavoro della memoria” che richiede un confronto con un’alterità irriducibile. Se la
consuetudine coloniale ha innescato nel corso dei primi anni del Novecento una sorta di
museificazione dell’altro (Karp, Lavine, ‘99’; Leghissa, 2005), nei villaggi romeni si coglie al
contrario una forte tensione verso l’auto-museificazione. Questo è un falso movimento della
memoria, perché non produce “lavoro” ma mera ripetizione dell’uguale, sacralizzazione e
ritualizzazione di un’origine trasferita su un livello metastorico, non negoziabile, intangibile e di
fatto intatta. Ma perciò stesso patologica, perché il museo, in generale, non è solo un modo per
rendere visibile qualcosa. Esso è anche un modo per far sparire qualcosa d’altro. Il museo del
villaggio è forse un modo per non rendere più visibile la sparizione del villaggio stesso dalla storia.
Il nucleo di questo processo auto-distruttivo del villaggio per auto-riduzione a reperto archeologico
è, probabilmente, la catena estenuante di pulizie etniche che in questa zona si sono scatenate poco
prima della seconda guerra mondiale, e che hanno visto letteralmente scomparire migliaia di
persone. Il silenzio calato su questi fatti, protratto e coperto dal peso della dittatura nazionalcomunista, nel dopoguerra, ha fatto sì che anche al giorno d’oggi un avventore si imbatta in un
minuscolo museo di provincia dove in bella vista vi sono appese delle camiciole di lino decorate
con la croce uncinata, dono di devote massaie ai membri degli Einsatzgruppen, nei primi anni
Quaranta. Una vera lettera rubata messa in primo piano e mai realmente guardata. Esposizione
senza rimorso, senza “lavoro”, senza pudore, verrebbe da dire, eccesso di evidenza che dà un luogo
paradossale alla mancanza: mera ripetizione di un gesto che è assunto a valore archetipico non già
per il suo contenuto, ma per una lancinante brama di autoconferma. Se questo genere di pratiche si
possono definire coazione a ripetere, allora il trauma della Shoah si può rubricare come elemento
sociale di un disturbo autodistruttivo della memoria culturale.» (Doni Martino 2010, p.14, 19-21).
4.2.2.1. in riepilogo: la sequenza potrebbe essere: trauma, resistenze di rimozione, oblio, coazione a
ripetere come forma di oblio e rimozione. Spiegando: ciò che disturba è conservato come rimosso,
musealizzato e reso innocuo; doppiamente innocuo: a. perché non è cancellato ma conservato,
custodito e ritualmente ripetuto (se fosse cancellato potrebbe sollevare sensi di colpa[?]), b. perché
conservato come rimosso, come consegnato a quei riti e luoghi che lo collocano in luoghi e in
momenti accettati e venerati ma e in quanto ininfluenti sui processi quotidiani, fissati nel tempo
passato e consegnati a stereotipi sommari, accettati e innocui nella loro ricorrenza, ridotti a “reperto
archeologico” da esibire nella sua immota, inutile e confortante, stabilità, ma ripetuta con solenne
ritualità e corteo di gravità e serietà richiesto; “non è una semplice assenza, ma è anzi presenza
ossessiva”; ricordato ma non preso in considerazione, anzi più è ricordato meno viene preso in
considerazione. E il di contro dov’è? Cosa si dovrebbe fare?
4.2.3. «la memoria per legge e la fatica del ricordo»
«La memoria crea luoghi, perché di per sé è fragile ed effimera. Ha bisogno di contesti e simboli di
riconoscimento, per potersi trasmettere e sopravvivere all’inesorabile caducità. L’esperienza
13
etnografica in Bucovina e la ricerca storico-iconologica sul solomonar [vagabondo mendicante cui
si riconosce il controllo delle piogge, delle forze avverse dell’atmosfera perché può dominare “il
drago delle tempeste”] hanno offerto la possibilità di identificare un luogo anche per l’oblio. È un
paradosso, evidentemente, che contraddice il senso comune. Tuttavia il museo del villaggio è
proprio questo: un luogo in cui si coltiva l’oblio, dove si istituzionalizza una coazione a ricordare
tutto fuorché ciò che andrebbe ricordato. Se occorresse una sintesi per questa argomentazione,
potremmo concludere affermando che, quando l’oblio assume una localizzazione fisica e un
riconoscimento sociale, allora si tratta di un sintomo, non già di un lavoro: è all’opera un processo
di rimozio- 21 ne sociale di un trauma, qualcosa che non deve essere reso presente. Ma una simile
conclusione sarebbe forse un po’ troppo affrettata, rispetto alla gradualità e alla complessità delle
vicende umane che caratterizzano i processi di memorizzazione e consolidamento culturale.
Un’altra questione urge ancora, rispetto alla quale non ci si può sottrarre collocando il disagio in un
altrove storico e geografico. Quali sono, oggi, nell’era delle generazioni post-tradizionali, i luoghi
della memoria? Dove stanno le nostre lettere rubate?
Lo sfondo su cui ho inteso inserire la questione dell’oblio è la costruzione simbolica; in tal senso
l’oblio non emerge in quanto componente dell’immagine (e come potrebbe?) ma in quanto rovescio
dell’immagine stessa. Rovescio che, come si è visto, non è una semplice assenza, ma è anzi
presenza ossessiva. Seguendo la pista del trauma sociale, si possono individuare i luoghi dell’oblio,
tanto più se si considera l’ingresso del politico nelle ferite della memoria sociale.
Le leggi 211/2000 e 92/2004 dello Stato italiano istituiscono, la prima, il “giorno della memoria”,
dedicato alle vittime della Shoah, la seconda, per una sorta di ambigua par condicio, il “giorno del
ricordo”, che commemora le stragi nelle foibe per mano delle forze titine. Ora, queste due leggi
dello Stato, da un certo punto di vista, sono rivelatrici di una dinamica non banale della memoria (e
quindi dell’oblio), che è precisamente quanto vorrei far emergere. Che cosa mostra, infatti, una
disposizione normativa così esplicita come questa? Mostra, innanzitutto, un posizionamento politico
e giuridico dello Stato nei confronti di un fatto doloroso, tragico, terribile, che diviene memoria
pubblica. E anzi, tale memoria pubblica è sanzionata in quanto legge, la violazione della quale, in
linea di principio, sarebbe passibile di reato (Melloni, 2008).
È significativo che, dalla seconda guerra mondiale in avanti, in tutto il mondo occidentale si
imponga l’usanza di istituire anniversari e monumenti a ricordo non già di grandi imprese o vittorie,
ma di tragedie e sofferenze collettive. Non si vuole entrare nel merito di queste tendenze, ma
cercarne un senso non immediatamente evidente. Rendere la memoria una legge dello Stato
significa stabilire, per legge, che la memoria è fragile e che quindi va difesa e garantita; significa
che la memoria di per sé non è “spontanea”, non è “naturale”, ma che anzi naturale e spontaneo
sarebbe l’oblio, soprattutto là dove il ricordo è doloroso o traumatico. Se il monumento serviva
come simbolo di unità nazionale o collettiva in virtù della forza attrattiva del potere, il giorno della
memoria non ha nulla di trionfale, anzi è per 22 certi versi emblematico di una cesura storica. Che
però è affrontata talvolta con le stesse modalità dell’esposizione monumentale del trionfalismo.
Ora, è proprio tale cesura storica che ha consentito di rilevare la consistenza sociale dell’oblio. Nel
processo di civilizzazione, la distinzione tra cultura “alta” e tradizione popolare ha fatto sì che il
“popolo” fosse relegato per secoli in un’area semiferina della coscienza collettiva, privo di memoria
e di responsabilità (Brown, 1981). Per questo, durante la costruzione dello Stato moderno, l’élite ha
deciso quanto fosse degno di essere ricordato e quanto non meritasse di essere preso in
considerazione. La Shoah ha interrotto in maniera assolutamente traumatica questa potente
procedura. Nondimeno la memoria di questa tragedia immane e trasversale a qualunque “piano”
sociale rischia di trasformarsi in ritualità istituzionalizzata. Nei suoi dispositivi disciplinari rivolti
alle giovani generazioni, la memoria così “liquefatta” difficilmente attecchisce nelle emozioni e
nelle sensibilità globalizzate. Il crinale sottilissimo su cui si sta incamminando la cultura planetaria
è paradossalmente puntellato da istituzioni che fungono da ricordo di copertura, le quali rischiano di
presidiare una memoria identitaria là dove l’identità è già venuta meno. La nazionalizzazione della
memoria, processo fondamentale nella costruzione dell’età moderna europea e coloniale, collide
14
con una società post-nazionale, in cui la presenza dello Stato è sempre meno avvertita come
qualcosa di legato alla “cosa pubblica”; per questo il rischio è che la memoria sia ridotta a un vano
esercizio di ripetizione dell’eguale, senza riuscire a vedere le lettere rubate degli stermini che
ancora e sempre accadono, proprio sotto l’insegna postmoderna del “mai più questo”.
Un modo per interrompere la macchina della smemoratezza cronica, che stritola molte relazioni
(soprattutto quelle educative) nella catena coattiva del consumo, può essere affrontare il lavoro del
ricordo, re-immaginare la funzione sociale del passaggio per gradi, della pazienza, dello “sporcarsi
le mani”. Queste sono probabilmente le immagini da considerare per preservare la memoria sociale.
Domina oggi una mitologia dell’immediatezza e del livellamento temporale, la quale in ogni caso
sembra essere incapace di sopportare l’oblio, lo scacco della memoria, e per questo la dimensione
temporale della propria esperienza evapora. Il lavoro della scienza sociale affronta giustappunto
questa trincea nichilista, blasonata talvolta da un’istituzionalizzazione tanto più fragile, quanto più
categorica nelle proprie 23 espressioni. La pazienza del ricordo deve essere accompagnata
dall’accettazione dell’oblio. L’oblio mascherato da coazione a ricordare tende a evitare il confronto
con l’altro, che è molto più impegnativo, richiede tempo, investimenti a fondo perduto di saperi e
competenze che sembrano inalienabili, ma che in realtà sono effettivamente di altri, in quanto
destinati ad altri (Bauman, 2003b). In questa prospettiva ha senso parlare di vita sociale dell’oblio,
là dove l’oblio costituisca un munus, un “debito condiviso”, non un’ennesima tensione verso una
semplice presenza senza dimensioni e spessore.» (Doni Martino 2010, p.21-24)
[dunque questa la linea dell’alternativa e dell’uscita, accettare l’oblio, sapere che quei musei del
ricordo sono luoghi dell’oblio, coazioni a ripetere in cui accade la rimozione della memoria o la
memoria come rimozione; la consapevolezza di questa conservazione-oblio mette al centro un
prendere atto di una distanza dell’oggi da allora e quindi una presa in carico e in cura di un lavoro di
memoria attiva.]
In conclusione: siamo di fronte a un doppio doppio della memoria nei processi di identificazione:
Primo doppio: 1. identificazione consegnata alla macchina dell’oblio, nella forma di una
conservazione che è coazione a ripetere, ad archiviare, isolare, rimuovere; 2. identificazione
consegnata alla consapevolezza dei processi di conservazione – oblio e al conseguente “lavoro” di
presa in cura e costituzione di legami civici.
Secondo doppio, che riguarda «la natura socialmente costruita di ciascuna identità. In questo caso,
la memoria si troverebbe a svolgere una funzione ambivalente riguardo ai percorsi identitari. [1.] Da
una parte costituirebbe una risorsa imprescindibile nell’abilitare la loro costruzione, [2.] dall’altra
parte, invece, potrebbe rappresentare un elemento in grado di portare alla coscienza degli attori
l’artificiosità del loro self, finendo con lo svolgere, in questo senso, una funzione destabilizzante.
La valenza identitaria della memoria pare generalmente riconosciuta dalla generalità delle
riflessioni sociologiche. Gli spazi di questo contributo non consentono affatto di inoltrarsi nella
disamina di una produzione scientifica così vasta e articolata; sia sufficiente quindi ricordare
genericamente come le rappresentazioni del passato siano spes-26 so definite nei termini di
complessi dispositivi d’identificazione. 27
Ciascuna elaborazione identitaria, si dice, comporta tanto un ricordo quanto un oblio. L’oblio, del
resto, si configura come un’operazione fondamentale del lavoro della memoria, che coincide non
solo con la costituzione, ma anche con il mantenimento e/o la trasformazione delle identità
individuali e collettive (Namer, 1987, pp. 73-9; Connerton, 2008, p. 53). 27
Salendo bruscamente di prospettiva, il dimenticare rappresenta un processo che si ritrova al centro
anche delle identità nazionali. Se è vero infatti che l’identità di una nazione è sorretta
dall’immaginazione di un’originaria unità etnica, linguistica e culturale, capace di trascendere tutte
le altre forme di appartenenza presenti al proprio interno, allora occorre che dalla “biografia
nazionale” siano sistematicamente espunti tutti quegli episodi capaci, in qualche modo, di mettere
in discussione tale supposta unità (Anderson, 1996). Così, negli Stati Uniti, i conflitti del 1861-65
sono “pedagogicamente” reinterpretati nei termini di una guerra civile e non in quelli, storicamente
più accettabili, di una guerra tra due Stati sovrani; allo stesso modo, in Gran Bretagna, Guglielmo il
15
Conquistatore si ritrova inserito nel ruolo di “padre della patria” e non in quello, forse più consono,
di invasore normanno (ivi, p. 225). Alla rappresentazione collettiva di un passato funzionale al
mantenimento dell’identità, si affianca dunque un momento di amnesia altrettanto collettiva
(Connerton, 2009, p. 49; Misztal, 2003, p. 17).» (Mori Luca in Doni 2010 p.26-28 passim)
4.3. per una accezione costituente della memoria: memoria della cura
Una società che ha smarrito la propria ombra non guarda più a quello che viene dopo e si identifica
in forza di una doppia dimenticanza: dimentica la diversità che era e la diversità che sarà.
4.3.1. una distinzione tra morale ed etica.
«Nella mia visione, essa si fonda a sua volta sulla distinzione fra due tipi di rapporti umani:
relazioni spesse e relazioni sottili. Le relazioni spesse sono fondate su proprietà come quella di
essere genitore, amico, amante, connazionale. Le relazioni spesse sono radicate in un passato
condiviso o legate a una memoria condivisa. Le relazioni sottili, d’altro canto, sono basate sulla
comune appartenenza al genere umano. Le relazioni sottili si fondano anche su un qualche aspetto
particolare dell’essere umani, come l’essere una donna o l’essere malati. Le relazioni spesse in
generale sono quelle che abbiamo con chi ci è vicino e con chi ci è caro. Le relazioni sottili sono in
generale quelle che abbiamo con chi ci è estraneo e lontano. L’etica, nel modo in cui io uso il
termine, ci dice come dovremmo regolare le nostre relazioni spesse; la morale ci dice come
dovremmo regolare le nostre relazioni sottili.» (Margalit Avishai 2004 L’etica della memoria, il
Mulino, Bologna 2006 p. 15)
Un esempio: «Dunque, che cosa si può considerare un esempio di cattiva relazione etica? Trattare il
proprio figlio moralmente ma in un modo che è indistinguibile dal modo in cui si trattano gli
estranei è un esempio di relazione etica cattiva. È morale, ma cattiva. Ossia, eticamente cattiva.»
(Margalit 2004 p. 77) Del resto, trattare una persona solo come proprio figlio e non come persona o
essere umano è moralmente illecito e quindi lo è anche eticamente; è immorale e non etico. Ad una
azione non basta che sia giusta moralmente perché sia giusta eticamente; può essere moralmente
giusta ma eticamente ingiusta, la morale è una condizione necessaria ma non sufficiente per l’etica.
Di contro l’etica, oltre a non essere una condizione necessaria per la morale, non può prescindere
dalla morale; perché una azione possa dirsi etica deve essere morale: ciò che è immorale non può
essere etico.
Lo stesso tema in ripresa nell’opera Margalit Avishai 2010 Sporchi compromessi, il Mulino,
Bologna 2011, p.131-132:«Sulla base della distinzione fra rapporti umani forti e deboli, distinguo
l’etica dalla morale. [e rimanda in nota all’opera L’etica della memoria] L’etica regolamenta i
nostri rapporti forti, la morale i nostri rapporti deboli. In teoria una società può essere etica e
immorale, quando, come nel caso del tribalismo, attribuisce ai rapporti forti una forza vincolante e
al senso di umanità condivisa una forza trascurabile. Infatti, l’etica priva di vincoli morali è
tribalismo. Le Germania nazista ariana fu una società etica nei confronti dei compatrioti tedeschi, e
profondamente immorale verso l’umanità in generale.»
4.3.2. Nazione come comunità di memoria, memoria etica. O l’importanza attribuita a convinzioni
che legano, in qualche modo, tra loro le persone e che entrano a far parte della razionalità pubblica.
«Il rapporto fra una comunità di memoria e una nazione è tale per cui una comunità di memoria
appropriata può contribuire a plasmare una nazione, anziché essere la nazione a plasmare la
comunità di memoria. Una nazione si presta naturalmente a formare una comunità di memoria ma
non perché venga prima in ordine di tempo. Sono i contenuti delle memorie condivise, come
un’origine comune o un passato condiviso, ciò a cui sono interessate le nazioni.» (Margalit 2004 p.
87)
4.3.3. le centralità della cura nelle comunità della memoria etica
«Un lato del triangolo mette in relazione la memoria e la cura, il secondo mette in relazione la cura
e l’etica, e solo allora siamo in grado di mettere in relazione la memoria con l’etica.» (Margalit
16
2004 p 30) «Ma la condizione di sufficienza per fare di una relazione etica una buona relazione
etica è la cura. La cura è il contributo etico alla bontà della relazione.» (Margalit 2004 p 76)
4.4. il problema del multiculturalismo (verso la terza tappa)
«La diversità etnoculturale è storicamente un elemento fondamentale delle società umane; non si
può quindi parlare di una specificità delle società moderne. L’aspetto nuovo consiste piuttosto nel
fatto che si possa affermare, nel quadro di una politica del riconoscimento, l’idea di una necessaria
assunzione da parte dello stato della diversità culturale che caratterizza la sua popolazione.
Tuttavia quest’idea non è un dato di fatto comunemente accettato, e ogni progresso realizzato su
questo fronte ha spesso dovuto misurarsi con forti resistenze. Tale reazione non deve però stupire,
poiché il multiculturalismo ambisce a promuovere un tipo di integrazione politica e sociale che
sotto molti aspetti va contro il modello sul quale sono stati costruiti gli stati-nazione.
Il governo democratico moderno si è infatti sviluppato assumendo per lo più una forma nazionale.
L’istituzione dell’autonomia politica ha richiesto non solo la costituzione di un corpo politico
organizzato sulla base di una volontà generale e comune che permettesse di ridefinire i termini della
cittadinanza — presupponendo che l’obbedienza alla legge significasse emancipazione — ma ha
anche incoraggiato l’affermazione di un principio di omogeneità sociale e politica. L’unità del
corpo politico e, fino a un certo punto, quella del corpo sociale si sono quindi imposte come
condizioni per una possibile cittadinanza democratica. Assumendo le concezioni e le pratiche
contemporanee della cittadinanza, il modello multiculturalista di integrazione rappresenta un vero e
proprio cambiamento di paradigma, di cui bisogna valutare il significato, la portata, il valore e i
rischi. Il multiculturalismo, sostenuto da una rivalutazione delle differenze culturali, si è trovato in
perfetta sintonia — in un mondo globalizzato dove intervengono anche processi di integrazione
regionale — con l’esigenza di fornire una nuova descrizione del legame fra libertà individuale e
cultura di appartenenza. L’obiettivo di questa evoluzione è offrire a ogni individuo la possibilità di
compiere le proprie scelte di vita. Scelte che hanno un significato perché inserite nel determinato
contesto culturale al quale si è legati.» (Savidan Patrick 2009 Il multiculturalismo, il Mulino,
Bologna 2010 p. 7-8)
17