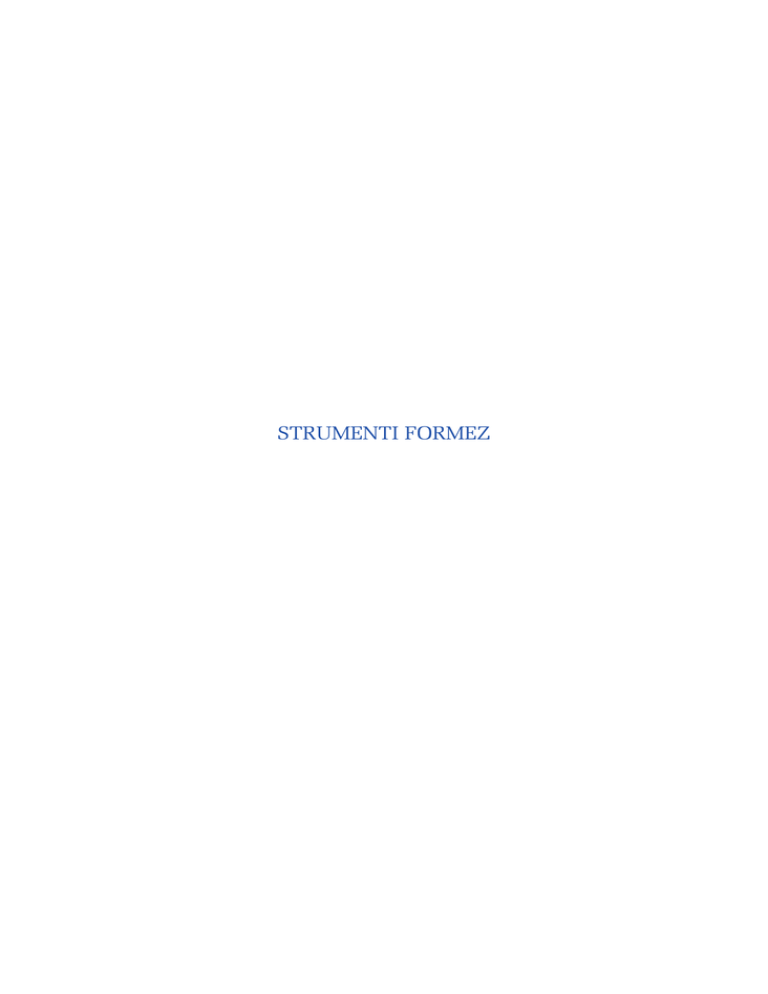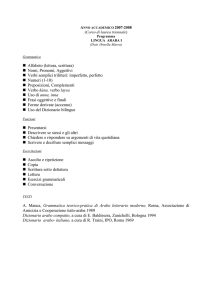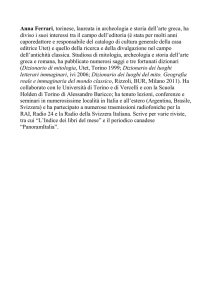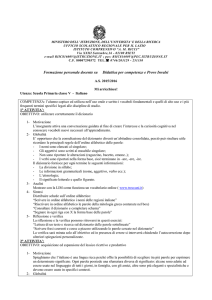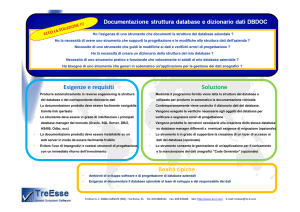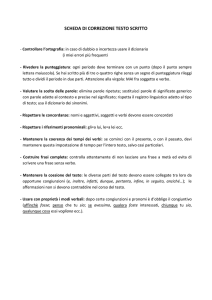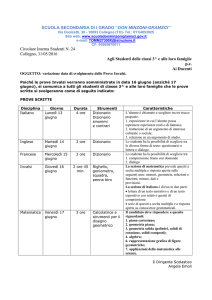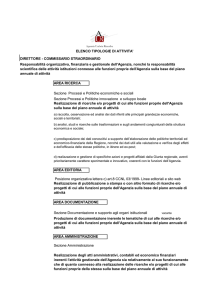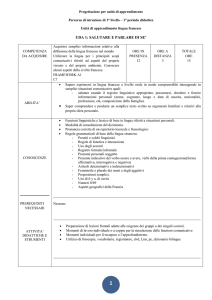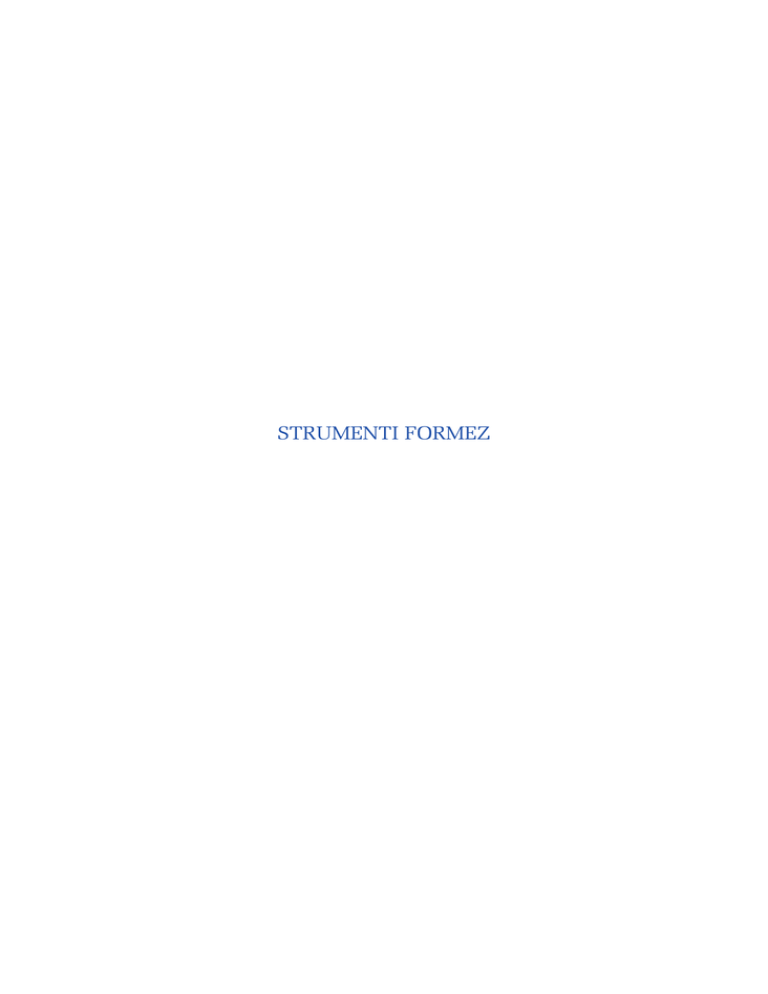
STRUMENTI FORMEZ
I
T
I
l Formez-Centro di Formazione Studi ha
avuto, da sempre, una particolare attenzione
per le iniziative editoriali. Fin dai primissimi
anni di attività si è impegnato nella produzione
e divulgazione di collane e riviste su cui intere
generazioni di funzionari pubblici si sono formate.
N
In seguito al decreto legislativo 285/99, che ha
individuato nel Formez l’Agenzia istituzionale
che sostiene e promuove i processi di
trasformazione del sistema amministrativo
E
italiano, l’attività editoriale del Centro è stata
rilanciata e rinnovata nella veste grafica
e nei contenuti.
Sono state create tre nuove linee editoriali:
M
Quaderni, Strumenti e Azioni di Sistema
per la Pubblica Amministrazione.
In queste collane vengono pubblicati
i risultati delle attività formative e di ricerca
U
svolte dall’Istituto.
Con “Quaderni” si diffondono Rapporti
e riflessioni teoriche su temi innovativi per la P.A.,
mentre con due collane più specialistiche, quali
R
“Strumenti” e “Azioni di Sistema per la Pubblica
Amministrazione”, si mettono a disposizione
strumenti di lavoro o di progettazione per quanti
T
lavorano o si occupano di P.A.
Tutte le pubblicazioni con un breve abstract
S
vengono presentate sul web (www.formez.it).
Carlo Flamment
Presidente Formez
35
COSTRUZIONE E USO
DI UN MODELLO
DI COMPETENZE
Il caso Agenzia delle Entrate
F o r m e z
•
U f f i c i o
S t a m p a
e d
E d i t o r i a
A cura di
Girolamo Pastorello, Direttore del personale Agenzia delle Entrate
Con la collaborazione di
Emanuela Valentini, responsabile Ufficio sviluppo del personale
Agenzia delle Entrate
Cinzia Castelli, Giuseppe Coppola, Rita Femia, Domenico Mastropierro,
funzionari Agenzia delle Entrate
Organizzazione editoriale
Roberta Crudele, Vincenza D’Elia, Paola Pezzuto
Premessa
7
La scelta di pubblicare questo volume nasce da un convincimento: l’obiettivo della
crescita qualitativa delle pubbliche amministrazioni richiede, insieme certo ad altre iniziative, anche la messa a punto di strumenti – validi e affidabili – di rilevazione della qualità
delle prestazioni di lavoro. Se è vero infatti che, a parità di qualità delle persone, è il
modello organizzativo che può fare la differenza, è anche vero che, a parità di modello
organizzativo, è la qualità delle persone, e la motivazione che esse ricavano dal riconoscimento del proprio valore, che può fare la differenza.
Tale convincimento si salda poi con quest’altro: chiusure corporative e proclamazioni di bravura, tutte autoreferenziali, non serviranno a restituire dignità e orgoglio al lavoro
pubblico – che poi è ciò che più sta a cuore a chi fa con passione questo lavoro – ma varranno solo ad alimentare le peggiori accuse da sempre rivolte ai lavoratori pubblici di questo Paese. Che dovrebbero perciò aver interesse a far propria questa massima molto semplice: dimostrare nei propri confronti, e nei confronti dei propri colleghi, lo stesso rigore di
giudizio che tendono in genere a esprimere, come cittadini e utenti, nei confronti del personale di altre amministrazioni pubbliche.
Da questi due convincimenti traggono ispirazione alcune ricerche ed esperienze sviluppatesi in questi anni nell’Agenzia delle Entrate sotto la denominazione di “progetto
Antares”. Nel volume vengono organicamente presentati alcuni dei temi chiave del progetto: la costruzione di un modello di competenze e le linee essenziali di una teoria critica
della valutazione professionale.
Per citare un brano del volume, “un modello di competenze si può molto schematicamente definire un insieme strutturato di conoscenze, capacità e valori che un’organizzazione
chiede e si attende da coloro che vi lavorano per raggiungere al meglio gli scopi per cui essa
esiste. Sottrarsi a una chiara definizione di queste aspettative significa, per un’organizzazione, venir meno ad una delle sue principali responsabilità gestionali. Sicché, sotto questo
aspetto, la differenza tra un’organizzazione e l’altra è, alla fine, solo questa: se le aspettative
siano formulate in modo esplicito, chiaro e organico – e in questo senso prendono appunto la
forma di un ‘modello’ – o se invece rimangano vaghe, mal definite e persino ambigue, consentendo così, se non addirittura favorendo, scelte gestionali opache o, comunque, poco trasparenti, dalle quali è il personale stesso che viene per primo ad esserne danneggiato”.
“Modello di competenze” e “sistema di valutazione” non sono la stessa cosa: il primo
indica una costellazione di aspettative di lavoro, il secondo riguarda le modalità di verifica
della risposta a tali aspettative. Il contenuto delle aspettative è dato dalle competenze cui
8
un’organizzazione attribuisce valore in quanto generatrici di performance elevata. Le aspettative sono formulate dal modello in modo generale (cioè senza riguardo a questa o a quella
singola persona) e astratto (cioè senza riguardo a questo o a quel caso concreto). La verifica
delle aspettative riguarda invece persone particolari in situazioni determinate. Insomma,
con la costruzione di un modello di competenze, un’organizzazione dichiara cosa si attende
in termini di azioni produttive di performance superiore. Con un sistema di valutazione,
l’organizzazione rileva invece con procedure formalizzate se e in quale grado le azioni dei
singoli corrispondano a quelle attese. Una cosa è definire l’intreccio delle competenze
richieste ai componenti di un’organizzazione (qui siamo nell’ambito del “modello di competenze”), un’altra è stabilire se e in quale misura, in che modo, nei riguardi di chi, ad opera
di chi e, infine, con quali effetti, le competenze descritte nel modello debbano formare oggetto di procedure formali di verifica (qui siamo nell’ambito del “sistema di valutazione”). Una
risposta a queste domande non appartiene a un modello di competenze ma a un sistema di
valutazione. Lo snodo tra modello di competenze e sistema di valutazione segna il passaggio dall’ambito dei valori e della cultura dell’organizzazione a quello della normazione del
rapporto di lavoro che non può non essere oggetto del sistema di relazioni sindacali.
Che significa, infine, “teoria critica della valutazione professionale”? Significa un’analisi ragionata dei problemi cui si va incontro (e delle sue possibili soluzioni) quando si
passa dalla tradizionale valutazione indiretta della professionalità (tramite titoli di servizio o prove teoriche o teorico-pratiche) alla valutazione diretta, sul campo, della prestazione di lavoro. I capisaldi di questa teoria critica – che è stata sviluppata attingendo, con
approccio interdisciplinare, a una molteplicità di studi riguardanti in particolare il comportamento organizzativo, la motivazione al lavoro e la valutazione dei processi formativi –
sono l’analisi dei concetti di oggettività, validità e attendibilità della misurazione, l’approfondimento della complessa tematica legata ai fattori distorsivi della valutazione e la
disamina delle strategie gestionali che possono modificare i meccanismi di convenienza
degli attori di un’organizzazione orientandoli virtuosamente verso la veridicità o, come si
potrebbe anche dire, la serietà delle valutazioni. Insomma, una sorta di “minicritica della
ragion valutativa” (se si è disposti a perdonare l’imperdonabile assonanza con il titolo di
ben altre Critiche), concepita come propedeutica a una seria discussione sull’introduzione di sistemi di valutazione della prestazione di lavoro nelle amministrazioni pubbliche.
Questi temi sono analizzati nel volume attingendo alla concreta esperienza organizzativa dell’Agenzia delle Entrate. Nelle nuove procedure di reclutamento dei funzionari dell’Agenzia, che hanno il loro perno nella valutazione sul campo delle competenze
professionali, è da tempo in corso – con affinamenti progressivi suggeriti dall’esperienza
e dalla riflessione sulle criticità incontrate – un’importante applicazione sperimentale di
sistemi di rilevazione e apprezzamento delle prestazioni lavorative.
L’elaborazione che ne è stata fatta può offrire utili spunti di riflessione a chiunque
sia interessato nella propria amministrazione a sviluppare nuove, e più soddisfacenti,
esperienze di autentica valorizzazione del lavoro pubblico.
Carlo Flamment
Presidente Formez
INDICE
PARTE PRIMA
Costruzione di un modello di competenze
1.
Introduzione
2.
Il problema della costruzione di un modello
di competenze
3.
Le origini del concetto di “modello di competenze”
4.
Il modello delle competenze dell’Agenzia delle Entrate
4.1 Definizione di competenza
4.2 Struttura del Dizionario delle competenze
4.3 Contenuti del Dizionario delle competenze
9
11
13
15
17
21
21
23
25
PARTE SECONDA
Uso di un modello di competenze
1.
Lo snodo tra modello di competenze
e sistema di valutazione
2.
Le criticità della valutazione: oggettività e veridicità
3.
L’oggettività del sistema di valutazione
3.1 Perché non bastano le valutazioni “a fiuto”
3.2 L’oggettività dei criteri di valutazione
3.3 La capacità di giudizio degli attori della valutazione
4.
La veridicità delle valutazioni
4.1 La situazione del valutatore
4.2 La situazione del valutato
4.3 La cultura della valutazione
5.
La comunità dei valutanti
31
36
38
39
40
43
45
46
51
52
57
PARTE TERZA
Dizionario delle competenze
61
Competenze intellettive e prestazione di lavoro
1.
Dinamismo intellettivo (Intuito & Costruzione logica)
1.1 Il dinamismo intellettivo come capacità
di individuare e inquadrare “problemi chiave”
1.2 Il dinamismo intellettivo come capacità di strutturare
problemi e di risolverli. Il “Problem IS-Solving”
1.3 La rilevazione del dinamismo intellettivo
Competenze extraintellettive e clima di lavoro
Affidabilità
1.
1.1 Coerenza
1.2 Passione per il lavoro
29
63
63
64
68
73
99
99
99
102
2.
3.
10
4.
Dinamismo realizzativo
2.1 Iniziativa
2.2 Tensione al risultato
2.3 Sviluppo e diffusione del sapere
Dinamismo relazionale
3.1 Orientamento all’altro
3.2 Fare squadra
3.3 Flessibilità
Leadership
4.1 Team building (Organizzazione e sviluppo
di un gruppo)
4.2 Influenza
105
105
106
108
110
111
114
116
117
118
119
APPENDICE
1.
Testare la competenza invece dell’“intelligenza”
2.
I “superior performers” e il concetto di deviazione standard
3.
La distinzione fra competenze e risultati
4.
L’iceberg delle competenze
5.
Il dibattito sulla nozione di “competenza”
6.
Il metodo degli expert panels
7.
Dall’analisi dei singoli comportamenti al disegno
della mappa delle competenze
8.
Linguaggio qualitativo e linguaggio quantitativo
nella descrizione delle competenze
9.
L’equità procedurale
10. I limiti delle casistiche
11. Il dilemma del prigioniero
12. Il valore della medietà e lo spazio della formazione
123
125
127
129
130
131
137
INDICE DEI NOMI
167
138
152
158
159
160
162
PARTE PRIMA
COSTRUZIONE DI UN MODELLO
DI COMPETENZE
11
COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI COMPETENZE
13
Per quanto sia audace esplorare l’ignoto,
lo è ancor di più indagare il noto
Kaspar
1. Introduzione
Cos’è un “modello di competenze”? Cominciare con una definizione rischia di
annoiare immediatamente il lettore, ma eludere questa domanda, senza tentare di darvi
subito una risposta, anche solo provvisoria e sommaria, comporta un rischio peggiore:
quello di ingenerare confusione. Un modello di competenze si può molto schematicamente
definire un insieme strutturato di conoscenze, capacità e valori o, come si può anche dire,
un reticolo organico di sapere, saper fare e saper essere, che un’organizzazione chiede e si
attende da coloro che vi lavorano per raggiungere al meglio gli scopi per cui essa esiste.
Sottrarsi a una chiara definizione di queste aspettative, significa per un’organizzazione venir meno ad una delle sue principali responsabilità gestionali. Sicché, sotto
questo aspetto, la differenza tra un’organizzazione e l’altra è, alla fine, solo questa: se le
aspettative siano formulate in modo esplicito, chiaro e organico – e in questo senso
prendono appunto la forma di un “modello” – o se invece rimangano vaghe, mal definite e persino ambigue, consentendo così, se non addirittura favorendo, scelte di gestione
opache o, comunque, poco trasparenti, dalle quali è il personale stesso che viene per
primo danneggiato.
La domanda di partenza è stata in sostanza questa: “Quali comportamenti è giusto
chiedere al nostro personale, affinché un’istituzione pubblica fondamentale come l’Agenzia delle Entrate dia alla collettività e ai singoli contribuenti il servizio migliore possibile?”. La risposta a tale domanda è generalmente questa: “preparazione, intelligenza,
equilibrio, onestà, voglia di lavorare, spirito collaborativo, iniziativa, capacità di ascolto”. È una risposta che viene data subito da chi vive nella nostra organizzazione e ne condivide con orgoglio la missione, e non è molto dissimile dalla risposta che egli stesso
darebbe se, ad esempio, da paziente, o da familiare di un paziente di un ospedale pubblico, gli venisse chiesto cosa esige dai medici e dagli infermieri che vi lavorano. Ebbene, la
costruzione del modello di competenze è essenzialmente consistita in uno “scavo rifles-
COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI COMPETENZE
14
sivo” e in una elaborazione di queste tipiche espressioni del linguaggio ordinario e del
senso comune. Invece di farne oggetto di avversione snobistica, quasi fossero di per sé
inconsistenti, arbitrarie o grossolane, si è cercato, con il supporto di una metodologia
ampiamente accreditata a livello internazionale, di definirne, svilupparne e strutturarne
la “sapienza valutativa” in esse incapsulata, eliminandone il carattere vago e impressionistico e depurandole da preconcetti e stereotipi (quelli che albergano in ciascuno di noi
e che purtroppo tendono spesso a rafforzarsi quando esercitiamo il ruolo di “capi”).
L’intera operazione può rappresentarsi come una sorta di codificazione ragionata di
saperi e vissuti quotidiani (tali sono i giudizi di esperienza semplici e immediati, e tuttavia
densi di significato, che ricorrono quotidianamente nelle relazioni di lavoro all’interno delle organizzazioni), che ha, tra le sue finalità, anche quella di porre le basi per la costruzione
di un sistema di valutazione quanto più possibile
oggettivo, ove “oggettivo” significa “intersoggettivo”, cioè condiviso dalla comunità dei valutanti.
Termine, quest’ultimo, con il quale ci si intende riferire a tutti i componenti di un’organizzazione, perché, all’interno di essa, tutti continuamente – ne siamo o no consapevoli – valutiamo e siamo valutati.
Di qui il nome – Antares – che si è dato al
modello. È la stella più luminosa della costellazione dello Scorpione. Tanto luminosa, da rivaleggiare
– secondo gli antichi – con il pianeta Marte, intitolato, per la sua colorazione rossastra, al dio della
guerra. E infatti Antares significa anti (contro) Ares,
che era il nome greco del dio della guerra. Ecco
allora perché si è scelto questo nome (Antares =
antagonista di Marte) per il modello descritto in
questo manuale. Tra i suoi intenti vi è quello di dare vita a un grande confronto all’interno dell’organizzazione e con le rappresentanze del personale per costruire un sistema di
rilevamento e valorizzazione dei meriti e delle capacità professionali quanto più possibile obiettivo. E che riesca quindi a sottrarre la valutazione stessa al terreno dello scontro e
del conflitto (cioè al terreno della “guerra”).
L’Agenzia è pienamente cosciente della complessità di tale progetto. E tuttavia c’è
un convincimento forte che sostiene e dà impulso a questa impresa, ed è la consapevolezza che è un falso problema chiedersi se si debbano o no valutare le competenze del personale. Un’organizzazione che abbia il senso della responsabilità gestionale valuterà sempre
e comunque le competenze. Si tratta perciò solo di decidere se debba valutarle informalmente e in modo “clandestino”, con giudizi vaghi e impressionistici – e quindi, se non
errati, incontrollabili – oppure formalmente e in modo trasparente, con giudizi strutturati
e compiutamente definiti nel loro significato, e suscettibili così di verifica obiettiva.
Non sembra esagerato affermare che la seconda opzione – che inizia a prendere forma nella costruzione del modello delineato in questo manuale – è anzitutto una scelta di
civiltà organizzativa.
COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI COMPETENZE
2. Il problema della costruzione di un modello di competenze
Un’organizzazione vive del lavoro di tutti, ma non tutti lavorano allo stesso modo.
Diverse possono essere le ragioni per le quali alcuni lavorano di più e meglio ed altri
meno e meno bene. Chris Argyris, uno dei maggiori studiosi dell’apprendimento organizzativo e della dinamica delle motivazioni umane all’interno delle organizzazioni, ha
scritto che l’apatia e la mancanza d’impegno sul lavoro non sono sempre e semplicemente una questione di pigrizia individuale ma possono rappresentare una reazione di persone normali ad un ambiente anormale (una reazione “salutare”, come l’ha definita lo studioso americano)1.
Per suggerire prognosi con cognizione di causa, bisogna però prima fare diagnosi
ragionevolmente sicure. In che senso possiamo dire che “alcuni lavorano di più e meglio
ed altri meno e meno bene”? Fa sicuramente parte del concetto di “civiltà organizzativa”,
cui si è prima accennato, rendere anzitutto trasparenti i criteri di valutazione del lavoro
in base ai quali compariamo le diverse prestazioni. Proprio qui sta la principale difficoltà
metodologica intrinseca alla costruzione di un modello di competenze. Il problema è
come enucleare definizioni valide e affidabili della “bravura professionale”, andando al
di là di giudizi vaghi e generici, se non arbitrari, o comunque puramente impressionistici
e intuitivi. Perché, se è vero che in un’organizzazione – come, in generale, nella vita –
l’intuizione è preziosa, è anche vero però, stando a quanto diceva un grande leader francese riguardo ai capi, che nulla tradisce più dell’intuizione (come appunto i capi imparano spesso a proprie spese e purtroppo, non di rado, anche a spese delle organizzazioni
che dirigono e delle persone che vi lavorano).
È proprio in questo sforzo di oggettivazione che si traduce la messa a punto di un
“modello di competenze”.
Nel linguaggio della scienza, un modello è una rappresentazione “semplificata”
della realtà. Essendo la realtà “inesauribile” (l’espressione è di Kant) e dovendo noi
cogliere nell’immensa congerie dei fatti esclusivamente quelli significativi ai fini della
spiegazione del problema che ci interessa risolvere, ogni teoria è necessariamente una
“semplificazione”, cioè una astrazione dalla realtà, e se la nostra mente non sapesse compiere questo processo di astrazione noi non faremmo che scattare “fotografie” inutili del
mondo reale, nel senso che esse non aggiungerebbero nulla alla nostra comprensione del
mondo stesso. Sicché l’unica distinzione che va fatta è tutta qui: una buona teoria astrae
in modo utile e significativo, una cattiva teoria semplicemente non ci riesce. E quando
qualcuno ci dice (come spesso capita) “questo può essere vero in teoria ma non in pratica”, basta replicare: “va bene, dimmi com’è in pratica”. È pressoché certo che il nostro
interlocutore non si limiterà ad esporre dei fatti, ma, senza esserne consapevole, enuncerà un’altra teoria, cioè una diversa spiegazione dei fatti.
1 C. Argyris, The individual and organizational structure, in K. Davis e W.G. Scott, Readings in Human Relations, New York, San Francisco, Toronto, London, McGraw-Hill, 1964, pp. 70-78. Argyris ha sviluppato più
a fondo questi concetti in Personality and Organization. The Conflict Between System and the Individual,
New York, Harper & Row, 1957.
15
COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI COMPETENZE
Come si fa però a costruire un “modello della realtà”? Con l’osservazione dei fatti,
si risponde solitamente. La risposta è giusta, ma incompleta. L’osservazione “pura” – che
pone come ideale una mente vergine, sulla quale vanno a incidersi, come su una tavoletta di cera, le percezioni dei fatti – non porta da nessuna parte, perché non fa che restituire la molteplicità irrelata della realtà, cioè il mondo lussureggiante e caotico descritto da
William James in questo brano:
16
“Il contenuto del mondo viene dato ad ognuno di noi secondo un ordine così
estraneo ai nostri interessi soggettivi che a mala pena con uno sforzo dell’immaginazione possiamo figurarci a cosa assomigli. Dobbiamo rompere quell’ordine e, dopo
averne estratto i temi che c’interessano ed averli connessi ad altri molto diversi, che
noi diciamo vi sono ‘legati’, riusciamo a percepire nessi ben definiti di sequenze e
tendenze, a prevedere disposizioni particolari e a prepararci in loro funzione, a godere della semplicità e dell’armonia al posto di ciò che era caos... Mentre parlo e le
mosche ronzano, un gabbiano cattura un pesce alla foce del Rio delle Amazzoni, un
albero cade nella selvaggia regione di Adirondack, un uomo starnuta in Germania, un
cavallo muore in Tartaria e dei gemelli nascono in Francia. Che significa tutto ciò? Il
fatto che questi eventi siano contemporanei gli uni rispetto agli altri e rispetto a un
altro milione di eventi altrettanto slegati forma un legame razionale fra loro, e li unisce in qualcosa che abbia per noi il significato di un mondo? Tuttavia, proprio una
tale contemporaneità collaterale, e nient’altro, costituisce l’ordine reale del mondo. È
un ordine rispetto al quale non abbiamo nulla da fare se non allontanarcene al più
presto possibile. Come ho detto, lo rompiamo quell’ordine: lo rompiamo in storie, e
in arti, e in scienze; e soltanto allora cominciamo a sentirci a nostro agio. Ne facciamo
diecimila di ordini di serie distinti. Rispetto a ognuno di questi, possiamo reagire
come se il resto non esistesse. Scopriamo fra le sue parti relazioni che non si erano
mai presentate ai nostri sensi – relazioni matematiche, tangenti, quadrati, e radici e
funzioni logaritmiche – e a partire dal loro numero infinito assegniamo ad alcune di
esse un ruolo essenziale e normativo e trascuriamo tutte le altre. Essenziali queste
relazioni lo sono, ma solo per i nostri scopi, poiché le altre relazioni sono altrettanto
reali e presenti; e il nostro scopo è semplicemente costruire concetti e prevedere”2.
Ciò che ci consente di andare avanti nell’esplorazione della realtà, senza arrestarci
ad una stupefatta contemplazione di questo variopinto caos che è il mondo, non è quindi
l’osservazione pura ma un’osservazione selettiva dei fatti, e la selezione è operata da ipotesi di un ordine possibile in relazione agli scopi che perseguiamo.
Proviamo ora a calare in questa trama di concetti il problema che abbiamo prima
enunciato: che significa “bravura professionale” nella nostra organizzazione? Come possiamo trovare un ordine fra i diversi, generici e talora contrastanti significati di bravura
professionale che percepiamo nella quotidiana esperienza di lavoro? Quali sono i fattori
2 W. James, The Principles of Psychology, New York, Dover Publications, 1950, vol. 2, p. 635, citato da K. Weick,
Organizzare. La psicologia sociale dei processi organizzativi, trad. it. Torino, ISEDI, 1993, pp. 208-209.
COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI COMPETENZE
che determinano la bravura professionale nelle sue diverse sfaccettature? C’è un filo che
ci ha guidati in questa ricerca e il filo si dipana dalla storia che ora raccontiamo. È una
storia che ci porta un po’ addietro nel tempo, ma che merita di essere narrata per il suo
carattere esemplare e per la ricchezza di riflessioni cui può dare spunto. Invece di affastellare parole, concetti e orientamenti desumibili dalla vasta letteratura riguardante le
competenze organizzative (rischiando così solo di generare confusione nel lettore), conviene analizzare attentamente questa storia, perché se ne possono trarre – senza annoiarsi troppo – gran parte degli elementi necessari per comprendere i termini esatti della problematica affrontata in questo manuale.
3. Le origini del concetto di “modello di competenze”
Agli inizi degli anni ’70, il Dipartimento di Stato americano (l’omologo del nostro
Ministero degli Affari Esteri) era sempre più insoddisfatto delle prove selettive utilizzate
per reclutare i funzionari dell’USIS (United States Information Service) da inviare all’estero. Gli uffici presso cui questi funzionari andavano a lavorare erano – per intenderci –
l’equivalente dei centri di cultura italiana all’estero. Il loro compito era gestire biblioteche, organizzare eventi culturali, tenere conferenze sull’America, stringere legami e
avviare relazioni con le comunità locali allo scopo di far conoscere la cultura e la politica
americana e coagulare consenso attorno ad esse (negli anni della contestazione giovanile
gli uffici dell’USIS erano sistematicamente presi d’assalto dai manifestanti, alcuni dei
quali, peraltro, fra un assalto e l’altro, non disdegnavano di frequentare quegli uffici, che
non di rado avevano biblioteche ben fornite e organizzavano interessanti iniziative culturali). L’insoddisfazione del Dipartimento di Stato nasceva in particolare dal fatto che i
funzionari dimostratisi eccellenti nelle selezioni rivelavano poi, in diversi casi, di non
esserlo affatto nella concreta attività di lavoro e, viceversa, non pochi di coloro per i quali si era predetto, sulla base dell’esito delle selezioni, che non sarebbero stati funzionari
particolarmente brillanti, si rivelavano invece, alla prova dei fatti, molto bravi.
Il Governo americano decise di chiedere una consulenza a David McClelland, uno
psicologo di fama internazionale (McClelland era noto soprattutto per i suoi studi di psicologia organizzativa, dedicati in particolare al tema della motivazione).
Si trattava anzitutto di capire dov’è che fallissero le prove di esame tradizionali e, in
secondo luogo, di trovare tecniche migliori per individuare le capacità professionali e predire performance superiori3. Le prove fino allora utilizzate miravano esclusivamente a
3 La critica che lo studioso americano rivolgeva ai test di abilità intellettiva utilizzati per la selezione professionale era quella di “deficit di validità”, nel senso che non intercettavano, a suo giudizio, le capacità professionali realmente occorrenti per svolgere un lavoro al meglio. Il metodo delle competenze enfatizza
invece, come egli diceva, il criterio della validità. La distinzione fra i concetti di “validità” e “affidabilità”
della valutazione professionale è fondamentale. Se non se ne acquisisce padronanza, è impossibile comprendere pienamente le criticità della valutazione. Questa distinzione viene delineata più avanti (p. 36).
McClelland espose le sue tesi in un famoso articolo del 1973, che, per generale ammissione, rappresenta
l’atto di nascita del cosiddetto “movimento delle competenze” (vedi appendice p. 125).
17
COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI COMPETENZE
18
verificare il possesso di conoscenze di cultura umanistica occidentale e di storia americana, la perfetta conoscenza dell’inglese ed una specializzazione in discipline economiche o
politico-economiche. Per superarle occorreva in genere essere usciti a pieni voti da costose università di élite. Sta di fatto che nel 1970, quando fu dato l’incarico a McClelland,
quasi tutti i funzionari dell’USIS all’estero erano maschi, bianchi e di elevata classe sociale. Ed era però anche un fatto – spiacevole per il Dipartimento americano, perché gettava
un’ombra sulla correttezza della sua politica di selezione – che tra i funzionari più bravi vi
erano spesso proprio le poche donne e i pochi neri in servizio presso gli uffici dell’USIS.
Il compito di McClelland era di rispondere alla domanda: se le prove tradizionali
non predicono il successo nel lavoro, che cosa si deve fare?
Il problema era anzitutto metodologico e McClelland lo affrontò con un approccio
scientifico, basato sul campionamento di gruppi contrapposti. Egli decise di usare un
campione di funzionari di alto valore professionale e un campione di confronto di elementi mediocri. La scelta dei due gruppi campione di superior performers4 (o di best
performers, per usare un sinonimo) e di average performers5 venne affidata al Dipartimento di Stato, nel convincimento che l’Amministrazione fosse comunque in grado di
rilevare chi operava con successo e chi no (che Amministrazione sarebbe mai quella che
non riuscisse neppure a fare questa distinzione?). L’assunto di base è che ci si accorda
più facilmente – come diceva McClelland – su chi è outstanding (fuori dell’ordinario)
piuttosto che su che cosa rende qualcuno outstanding6. E l’indagine dello studioso americano si concentrò appunto sull’individuazione di questo “che cosa”.
Come secondo passo, McClelland sviluppò una tecnica chiamata BEI (Behavioral
Event Interview = Intervista sugli eventi comportamentali) per identificare in modo scientificamente plausibile che cosa facessero i migliori di più o di diverso o con maggiore frequenza rispetto a quelli mediocri7. Ai funzionari venne chiesto di raccontare dettagliatamente che cosa avevano fatto nelle situazioni più critiche incontrate nel loro lavoro8, con
domande del genere: come si arrivò a quella situazione? Chi vi era coinvolto? Che cosa
4 Chi sono i superior performers? Solitamente, nella letteratura che si è formata sulla scia del lavoro di
McClelland si dà di questo termine una definizione di tipo statistico: sono coloro che eseguono performance pari a una deviazione standard al di sopra della performance media, ossia la fascia “top” del 15% dei
componenti di un’organizzazione in una distribuzione normale a 4 fasce (inferiori, medio-inferiori, mediosuperiori, superiori). Il che vuol dire “grosso modo, il livello raggiunto da una persona su 10, in una situazione di lavoro data” (L.M. Spencer e S.M. Spencer, Competenza nel lavoro. Modelli per una performance
superiore, trad. it. Milano, FrancoAngeli, 1995, p. 35. Per brevità, gli autori dell’opera appena menzionata
verranno di seguito citati come “Spencer & Spencer”). La questione è approfondita in appendice a p. 127.
5 Average significa “medio”. Come scrisse McClelland, il gruppo degli average performers era costituito da
coloro che “lavoravano quel tanto che bastava per non essere licenziati”. Si trattava quindi di just average
performers e cioè di “mediocri” più che di “medi”.
6 “People agree more readily on who is outstanding that on what makes them outstanding” (tratto da Identifying competencies with behavioral-event interviews, in «Psychological Science», 1998, 9, p. 338).
7 Come dice il proverbio “una rondine non fa primavera”. Non è un solitario successo che basta a determinare il valore complessivo di una prestazione professionale, né, inversamente, è un singolo fallimento che
può negare o attenuare quel valore.
8 Il senso di questo metodo dovrebbe apparire subito chiaro. Esso prende le distanze dal tradizionale approccio della psicologia organizzativa (che è poi quello comunemente sotteso – con minore o maggiore raffinatezza a seconda dei casi – alla costruzione dei “profili professionali”) consistente nell’eseguire analisi
COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI COMPETENZE
pensò, provò e decise di fare per risolvere quella situazione? Cosa fece effettivamente?
Cosa accadde? Quale fu l’esito dell’episodio?
Le interviste consentirono di raccogliere alcune centinaia di racconti delle situazioni più critiche incontrate da quei giovani funzionari nella loro missione all’estero. Si
trattava a questo punto – e fu il terzo passo del percorso seguito da McClelland – di passare dalla miriade di singoli comportamenti descritti nelle interviste a un raggruppamento per categorie tematiche dei comportamenti stessi9. Ognuna di queste categorie identificava le caratteristiche individuali che distinguevano i due gruppi campione (caratteristiche che non erano invece intercettate dalle prove tradizionali di accesso). Nel caso dei
funzionari dell’USIS tali caratteristiche – che d’ora in poi chiameremo “competenze”
(dandone in seguito una definizione più precisa) – risultarono essere principalmente tre:
• sensibilità personale alle altre culture10;
separate della mansione e della persona, cercando poi di combinarle insieme in un secondo tempo. Come
osserva McClelland, questo approccio può funzionare bene quando si tratta di predire il rendimento scolastico sulla base di test di attitudine allo studio (anche se pure qui la più moderna pedagogia – imperniata
sul concetto di istruzione individualizzata diretta a superare le disuguaglianze di partenza – avrebbe qualcosa da dire), ma si dimostra del tutto inadeguato per predire la performance di valore nelle mansioni più
qualificate. In sostanza, nel metodo delle competenze l’analisi comincia con la persona già nella mansione
(e non presume, come fanno in genere gli esperti che costruiscono i test attitudinali, di sapere già quali
caratteristiche siano necessarie per svolgere bene un certo lavoro) e determina poi, attraverso le interviste
sui comportamenti esplicitati in situazioni non strutturate, quali caratteristiche personali siano associabili
al successo nella mansione. Il ruolo centrale che gioca in questa impostazione il concetto di analisi della
persona già nella mansione appare ancora più chiaro, quando si pensa che originariamente McClelland e i
suoi collaboratori avevano ipotizzato di osservare direttamente sul posto di lavoro i funzionari dei due
diversi campioni, per scoprire cosa facessero i migliori di più o di diverso dai medi. Questa soluzione fu
però ben presto abbandonata perché si rivelò dispendiosa e inefficiente. “Eseguito correttamente, il metodo BEI raccoglie informazione di eventi critici equivalente ai dati dell’osservazione diretta, ma in modo
molto più efficiente. 60-90 minuti di intervista possono in pratica produrre tanti dati utili quanti ne può
fornire una settimana di osservazione intensa o un anno di regolare attività di lavoro” (L.M. Spencer e S.M.
Spencer, Competence at Work. Models for Superior Performance, New York, Wiley, 1993, p. 104. La citazione è tratta dall’edizione originale, poiché la traduzione italiana già menzionata non riporta il capitolo
10 – Designing Competency Studies – in cui compare il passo citato). La tecnica dell’intervista BEI e le sue
differenze dai tradizionali metodi di intervista sono descritte con chiarezza nel cap. 11 (Conducting the
Behavioral Event Interview) dell’opera di Spencer & Spencer appena citata (neanche questo capitolo è
incluso nella traduzione italiana del libro).
9 Come si fa a risalire da tanti singoli comportamenti all’individuazione di poche categorie di comportamenti idonee a spiegare il successo professionale delle persone nell’organizzazione in cui lavorano? In altre
parole: come si arriva a disegnare una “mappa di competenze”? La questione viene esaminata in appendice
a p. 138.
10 Eccone un esempio ripreso, come altri che riporteremo successivamente, dal libro di Spencer & Spencer:
“Quando ero addetto culturale nell’Africa settentrionale, un giorno mi arrivò da Washington l’invito a
proiettare un film su un politico americano che i locali, sapevo, consideravano ostile al loro paese. Ero
sicuro che, se avessi proiettato quel film, il giorno dopo qualche centinaio di studenti di sinistra inferociti
avrebbero appiccato il fuoco alla nostra sede. “Washington pensa che il film sia una gran cosa, ma i locali
lo considereranno offensivo”. Dovevo trovare il modo di proiettare il film, per permettere all’Ambasciata
di confermare a Washington che avevamo obbedito, ma nello stesso tempo non dovevamo offendere i sentimenti di nessuno dei locali… Decisi di far proiettare il film in un giorno festivo, quando nessuno sarebbe
venuto a vederlo”. L’episodio viene così commentato da McClelland: “Questo giovane diplomatico ebbe la
sensibilità sociale di capire come avrebbe reagito la popolazione locale, e seppe anche gestire la situazione
senza contraccolpi per la propria ambasciata”.
19
COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI COMPETENZE
• atteggiamento positivo nei confronti degli altri11;
• rapidità a capire le “relazioni politiche”12.
20
Si trattava di competenze che costituivano doti non scolastiche e che, sulla base di
analisi statistiche, risultarono significativamente più frequenti nei funzionari che collezionavano brillanti successi sul lavoro. Gli average o non riferivano episodi che dimostravano il possesso di queste doti o raccontavano episodi che rivelavano la mancanza di
tali capacità. Per esempio, descrivevano situazioni che avevano portato discredito al proprio ufficio, perché non avevano saputo prevedere le conseguenze “politiche” di una
loro azione (mancanza di sensibilità sociale e senso politico). Era inoltre frequente che le
interviste dei funzionari mediocri contenessero commenti negativi o addirittura razzistici sui “clienti” dei paesi ospitanti.
A scanso di malintesi, va sottolineato che la tesi sostenuta da McClelland non era
quella secondo cui i criteri di selezione dei funzionari dell’USIS sarebbero stati insensati.
Quei criteri erano legati, in effetti, all’analisi delle caratteristiche del compito che i funzionari di cui parliamo erano chiamati a svolgere. Poiché quei giovani dovevano diffondere la
cultura americana nel mondo, non era affatto illogico che la selezione mirasse a verificare
il possesso di tale cultura. L’errore stava nel ritenere che le condizioni necessarie per eseguire un compito equivalessero a quelle necessarie per eseguire un compito in maniera
eccellente. La ricerca di McClelland sottolineava che tale equazione era sbagliata. Per essere un ottimo funzionario dell’USIS all’estero occorrevano quelle altre competenze che
abbiamo prima specificato e che i test tradizionali non intercettavano, essendo perciò chiaro che quelle prove, se pur predicevano una average performance, non avevano pero validità predittiva riguardo alla superior performance. Ricorrendo alla terminologia che studi
successivi avrebbero poi introdotto, una cosa sono le “competenze soglia” (Threshold
Competencies, quelle necessarie per eseguire un compito) e un’altra le “competenze distintive” (Differentiating Competencies, quelle necessarie per eseguire bene un compito)13.
11 Una giovane diplomatica raccontò di essere rimasta amica di alcuni leader studenteschi radicali che avevano minacciato di dar fuoco alla biblioteca dell’USIS in cui lavorava: “Nonostante i guai che ci avevano procurato, conservai sempre sentimenti di amicizia e di rispetto per i leader studenteschi. Stavano acquistando
consapevolezza del loro “essere una nazione” e sapevano che sarebbero diventati la classe dirigente di un
paese radicalmente cambiato. Mi rendevo conto che avevano il diritto di rifiutarci e addirittura di cacciarci, e
rimasi di quell’idea anche se volevano incendiare la mia biblioteca! E glielo dissi; li invitai ad usare i nostri
locali per le loro riunioni. Cercai di convincere gli americani là residenti a venire ad ascoltarli. Conservo buoni rapporti con alcuni di quegli studenti. E non mi hanno ancora bruciato la biblioteca!”. Per apprezzare la
rilevanza di questo comportamento, è assai significativo il raffronto (e qui si vede subito l’utilità del metodo
adottato da McClelland) con il racconto di un funzionario average in una situazione analoga: “Giunsi alla fine
alla conclusione che la gente di quel paese era solo stupida, ottusa e priva di motivazioni. Avevo cercato di
formare classi di inglese, in modo che quei ragazzi potessero impararlo abbastanza per andare a studiare negli
Stati Uniti, che è poi quello che tutti loro dicevano di volere. Ma ben pochi si presentarono. E così alla fine
soppressi le classi. Che puoi fare con gente così?” (Spencer & Spencer, Competence at Work, cit., p. 105).
12 Un funzionario, inviato in missione in un paese africano, raccontò di aver capito subito che “ad avere in
mano la politica petrolifera di quel paese era il nipote dell’amante del vice primo ministro”. E così fece
subito in modo da essere invitato a un party, nel quale poté incontrare questo nipote e cominciare a perorare la causa degli Stati Uniti.
13 “È proprio del citaredo suonare la cetra, mentre è proprio del citaredo di valore suonarla bene”. La citazione, tratta da un’opera di circa 2400 anni fa (Aristotele, Etica nicomachea, 1098a), può sembrare curiosa, se
COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI COMPETENZE
Successive verifiche, basate su nuovi gruppi di controllo e sull’introduzione di
appositi test di misura delle competenze, confermarono che il possesso di quelle competenze distintive da parte dei funzionari USIS consentiva realmente di prevedere esperienze professionali di successo (il banco di prova della scientificità di una teoria è se
essa sia in grado di formulare previsioni che collimano con l’osservazione empirica). E
questo stava appunto a significare che con l’individuazione di quelle tre competenze,
con la loro puntuale descrizione e graduazione in termini di intensità, si riusciva a
costruire un modello, cioè una rappresentazione semplificata della realtà che consentiva
di individuare, nella intricata matassa dei comportamenti messi in atto dai funzionari
intervistati, quelli che effettivamente spiegavano il loro successo professionale e potevano perciò considerarsene la causa.
Di conseguenza, questi comportamenti potevano essere indicati come “modello”
da seguire, ed ecco allora che la parola “modello” assume, nella discussione relativa alle
competenze, non più solo una valenza esplicativa, ma anche prescrittiva, conformemente peraltro all’uso linguistico comune, in cui la parola ricorre in entrambe le accezioni.
Ulteriori ricerche permisero nel corso del tempo di arrivare a una definizione generale di competenza e all’individuazione di un certo numero di competenze a carattere
trasversale, in quanto richieste nella gran parte delle attività professionali.
Già nel 1991 il metodo di mappatura delle competenze era stato utilizzato da oltre
100 ricercatori di 24 paesi e a distanza di trent’anni dalla sua introduzione l’approccio
delle competenze offre un metodo ormai consolidato di gestione delle risorse umane largamente applicabile alla selezione, alla definizione delle prospettive di crescita professionale, alla valutazione della performance e allo sviluppo del personale.
La metodologia messa a punto da McClelland e ulteriormente perfezionata dai suoi
collaboratori viene oggi applicata dalla società internazionale di consulenza Hay Group, che
ha fornito la propria qualificata esperienza per la conduzione degli expert panels che hanno
consentito di definire il modello delle competenze del personale dell’Agenzia delle Entrate.
4. Il modello delle competenze dell’Agenzia delle Entrate
4.1 Definizione di competenza
Muovendo dagli schemi concettuali nati dalla ricerca di McClelland, alla fine del
2002 sono stati costituiti nell’Agenzia delle Entrate alcuni expert panels14 cui ha partecipato personale impegnato con successo nei processi-chiave dell’Agenzia: controllo, servizi al contribuente, consulenza legale e riscossione (expert panels significa letteralmente “gruppi di esperti”).
non addirittura stravagante, nel contesto di una moderna problematica organizzativa, ma sintetizza perfettamente la distinzione cui ci stiamo riferendo.
14 Se il metodo ideato da McClelland per l’individuazione delle competenze era quello della definizione di
gruppi campione contrapposti e dell’intervista BEI ai partecipanti a tali gruppi, perché l’Agenzia delle Entrate ha utilizzato invece il metodo degli expert panels? La questione viene discussa in appendice a p. 137.
21
COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI COMPETENZE
Il lavoro di riflessione negli expert panels
22
Da giudizi vaghi e polisensi (“è bravo”,“è
capace”, ecc.) che qualificano i performers di livello superiore (la luce bianca
che va a rifrangersi sul prisma ottico rappresenta appunto l’intuizione valutativa
indistinta) si passa attraverso la riflessione (il prisma ottico) sugli episodi di best
performance e sui comportamenti che ne
sono causa (letti gli uni e gli altri in contrapposizione alle esperienze di average
performance) alla scomposizione analitica delle competenze (raffigurata dallo
spettro dell’iride).
Ascoltando e dibattendo con gli interessati le esperienze che essi raccontavano, si è
arrivati, con un lavoro di analisi e codifica degli episodi narrati, all’individuazione di
una serie di competenze, raggruppate, a loro volta, in macro categorie, la cui descrizione
si è tradotta nella stesura del Dizionario delle competenze riportato in questo manuale.
Cosa sono le “competenze”? Possiamo a questo punto darne la seguente definizione: le competenze sono categorie di comportamenti15 o, come si potrebbe anche dire,
classi di comportamenti che hanno queste caratteristiche:
• sono causa dei successi di un’organizzazione16;
• sono reali e osservabili in un contesto lavorativo in base a criteri predeterminati (non
si tratta quindi di mere “potenzialità” esposte ad apprezzamenti fortemente soggettivi,
ma di comportamenti effettivi la cui rilevazione è suscettibile di controllo intersoggettivo all’interno di un’organizzazione).
Proprio per la loro dimensione comportamentale e per gli effetti che determinano
sul piano organizzativo, le competenze si definiscono anche “comportamenti organizzativi” o “competenze organizzative”.
Secondo la definizione appena data, le competenze sono un “costrutto organizzativo” e non un “costrutto psicologico”. In sostanza, noi diciamo cos’è una competenza dal
punto di vista organizzativo (è una classe di comportamenti che esprimono performance di
livello superiore), senza però entrare nell’intricata spiegazione di cosa c’è dietro o cosa c’è
15 Per fare un esempio, essere riusciti a prevenire un conflitto sindacale è un comportamento singolo, così
come è un comportamento singolo aver previsto l’insorgere di un problema e avervi dato soluzione tempestivamente. La “categoria” è invece un’entità generale e astratta che ricomprende – sotto una definizione –
questi comportamenti e altri simili. È appunto questa classe di comportamenti che costituisce, nel caso di
specie, la competenza che chiamiamo “iniziativa”.
16 Fra competenze e risultati viene fatta spesso una distinzione analoga a quella fra mezzi e fini. Se i risultati
rappresentano cosa bisogna fare, le competenze indicano come (cioè con quali comportamenti) si riesca a raggiungerli. Questa distinzione si può prestare a qualche malinteso, come evidenziato in appendice a p. 129.
COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI COMPETENZE
sotto dal punto di vista psicologico17. Per riprendere l’esempio già citato, quello che noi
facciamo è dare una chiara definizione di cosa sia “l’iniziativa”, in modo da poter distinguere con sufficiente precisione quali comportamenti vi rientrino e quali no, ma prescindiamo da cosa vi sia “dietro” o “sotto” il senso di iniziativa, psicologicamente parlando. In
questo modo la nostra definizione è neutrale. Vi si può cioè aderire senza dover necessariamente prendere partito in un dibattito complesso e controverso, che esula dagli scopi di
questo manuale (per chi comunque vi abbia interesse, una sintesi succinta del dibattito è
presentata in appendice a p. 131). Il nostro fine è solo quello di approntare una intelaiatura
di concetti essenziali che permettano di assumere, con sufficiente consapevolezza critica,
importanti scelte organizzative, come la rilevazione, la valutazione e lo sviluppo delle
competenze. Insomma, ai fini della costruzione di un modello di competenze – che è il
nostro obiettivo – ciò che veramente importa è enunciare con chiarezza quali comportamenti siano classificabili come “tensione al risultato”, “flessibilità”, “fare squadra”, ecc. e
quali no, affinché le persone sappiano cosa l’organizModel → Self-modelling
zazione si attende da loro e cosa quindi sarà rilevato e
Un modello comportamentale ha, a
valutato, e cosa andrà eventualmente sviluppato laddeterminate condizioni, la capacità di
dove emergano gap rispetto alle aspettative. In sintesi,
attivare un processo di self-modelling.
quando c’è un modello valido (p. 32), chiaramente
riconoscibile e riconosciuto, si possono consapevolmente avviare i processi di apprendimento e di sviluppo legati appunto alla possibilità di seguire quel modello (self-modelling).
4.2 Struttura del Dizionario delle competenze
Dopo questi chiarimenti sulla nozione di “competenza”, si può passare a descrivere l’articolazione del Dizionario delle competenze dell’Agenzia. Il dizionario presenta,
per ciascuna competenza, una descrizione generale e una serie di indicatori comportamentali raggruppati in quattro classi secondo una scala crescente di intensità18.
La descrizione delle competenze assume, laddove queste abbiano in qualche modo
carattere autoesplicativo o siano comunque di più immediata comprensione, la forma di
17 Una spiegazione potrebbe essere questa: dietro o sotto i comportamenti di high performance c’è un insieme
eterogeneo di caratteristiche individuali, come conoscenze, capacità, immagine di sé, motivazioni, valori,
atteggiamenti e tratti, che appartengono ai diversi strati della personalità, formando una sorta di iceberg.
Questa spiegazione viene approfondita in appendice a p. 130. Nel nostro caso “dietro” e “sotto” sono evidentemente espressioni metaforiche. Lasciando il piano della metafora, si tratta di distinguere due aspetti
diversi: da un lato, le competenze intese come “categorie di comportamenti” e, dall’altro, le condizioni
(psicologiche, culturali, ecc.) che si assume debbano esistere (ossia quello che, metaforicamente, designiamo appunto come ciò che sta “dietro” o “sotto” le competenze), affinché una persona adotti comportamenti riconducibili a questa o quella competenza.
18 È evidente qui la differenza rispetto ai sistemi tradizionali di analisi valutativa che abbiamo tutti conosciuto a scuola. In quei sistemi l’insegnante ha a disposizione una scala di voti (ad es. quella in decimi) i cui
punti non hanno un significato preciso, sicché ogni docente li interpreta a modo suo (per citare solo un
esempio: un insegnante utilizza solo una parte dei punti a disposizione, in genere non più di tre o quattro
punti, e a questa gamma limitata corrispondono diverse interpretazioni del valore dei punteggi, sicché il
sette di un insegnante può corrispondere al sei o all’otto di un altro, e questi riferimenti così fluttuanti
determinano notevoli discordanze di giudizio).
23
COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI COMPETENZE
24
una definizione sintetica (così è, ad esempio, nel caso della “Tensione al risultato” o della “Flessibilità”). Per altre competenze (ad esempio, quelle riguardanti la passione per il
lavoro e la coerenza) è sembrato invece troppo ingenuo pensare di poterne racchiudere la
complessità dei contenuti in formule esaustive solo in apparenza, e destinate in realtà a
rivelarsi subito vuote o ambigue non appena poste a raffronto con la concretezza delle
situazioni. In questi casi, perciò, non viene data solo una definizione sintetica, ma sono
anche delineati l’orizzonte di senso o, come si potrebbe anche dire, le chiavi di lettura e
di interpretazione che, nella mutevolezza delle vicende, aiutano, assai più di una semplice definizione, a risolvere le ambiguità e a distinguere quali comportamenti rivelino
effettivamente il possesso di una determinata competenza.
Per quanto riguarda la graduazione delle competenze, gli indicatori comportamentali sono classificati secondo quattro livelli19:
• il primo livello (non ancora adeguato) riguarda comportamenti che non apportano
valore aggiunto all’organizzazione, influenzandone anzi negativamente l’efficacia e
l’efficienza dell’azione20;
• il secondo livello (adeguato) indica i comportamenti che rispondono all’esigenza di
corretto funzionamento dell’attività amministrativa;
• il terzo livello (più che adeguato) indica comportamenti che contribuiscono in modo
ragguardevole al raggiungimento degli obiettivi;
• il quarto livello (eccellente) indica comportamenti non comuni per l’apporto particolarmente qualificato e assai differenziato che danno alla performance collettiva.
Per ciascuna competenza sono inoltre riportati nel manuale alcuni esempi significativi di concreti comportamenti organizzativi, tratti dall’agire quotidiano, che corrispondono ai diversi livelli di intensità. Gli esempi sono frutto di una cernita delle testimonianze raccolte nel corso degli expert panels (non era ovviamente possibile riportarle tutte). Negli episodi comportamentaIl Dizionario delle competenze costituisce
li descritti dalle persone intervistate
lo “strumento di misurazione” delle competenze
confluiscono non di rado più compeCaratteristiche di oggettività
tenze, e la selezione degli episodi stesdi uno strumento di misurazione
si è avvenuta quindi in base alla comé Validità = idoneità dello
strumento a intercettare
petenza che nel singolo caso appariva
le caratteristiche che i suoi
utilizzatori (valutati e valutatori)
essere quella più determinante.
hanno interesse a misurare
Dal punto di vista metodologico è
é Affidabilità = idoneità dello
oggettività =
strumento a fornire ai suoi
centrale il fatto che la graduazione delutilizzatori misurazioni coerenti
intersoggettività
e costanti
l’intensità delle competenze non venga
19 Ad ogni livello di intensità di ciascuna competenza corrisponde uno specifico set di indicatori comportamentali, che non costituiscono però un tutt’uno. Non è necessario quindi che siano tutti compresenti per
classificare una determinata prestazione lavorativa sotto questo o quel livello di intensità di competenza.
20 Come osservano Spencer & Spencer (op. cit., trad. it., p. 46), “I livelli negativi sono utili ai fini dello sviluppo (come esempi di cosa si deve evitare) e qualche volta anche della selezione (sono “segnali d’allarme”
che mettono in discussione l’idoneità del candidato ad una posizione in cui quella competenza è critica)”.
COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI COMPETENZE
operata – come in genere avviene – ricorrendo, un po’ comodamente, al solito ventaglio
di avverbi di modo (ad es. “straordinariamente capace”, “molto capace”, “abbastanza
capace”, ecc.). La graduazione è invece stabilita, individuando, con quanta più accuratezza possibile, comportamenti tipologicamente diversi in corrispondenza di ciascun
grado di intensità. È evidente quale sia il vantaggio che tale approccio offre in termini di
oggettività della mappatura delle competenze21.
In sintesi, le caratteristiche strutturali del Dizionario delle competenze sono tre:
definizione della competenza, indicatori comportamentali e citazione di episodi significativi. Su queste tre caratteristiche si basa l’oggettività del modello, e cioè la sua validità
e affidabilità (i concetti di validità e affidabilità sono analizzati più avanti a p. 36).
4.3 Contenuti del Dizionario delle competenze
Il modello proposto evidenzia le competenze di livello superiore che il personale
dell’Agenzia utilizza per realizzare con efficacia ed efficienza i propri compiti e far fronte alle proprie responsabilità.
In particolare, dall’analisi effettuata è emerso chiaramente che i comportamenti del
performer superiore (il “bravo funzionario”) esprimono:
• integrità professionale;
• passione per il proprio lavoro;
• propensione a migliorare i propri standard;
• orientamento a fornire servizi di qualità al contribuente;
• capacità di lavorare con gli altri;
• flessibilità e volontà di aggiornarsi costantemente.
Nell’esprimere tali caratteristiche, il bravo funzionario manifesta competenze che
si possono suddividere in due grandi categorie: competenze intellettive e competenze
extraintellettive. Le prime comprendono l’intuito e la capacità di costruzione logica.
Operando sinergicamente, esse danno vita al dinamismo intellettivo, inteso come abilità
nell’applicare l’intelligenza alla soluzione concreta dei problemi di lavoro. La seconda
categoria comprende le competenze che investono la sfera della volontà e dei sentimenti.
Sono concettualmente distinte dall’intelligenza, ma non vi si contrappongono: volontà e
sentimenti assumono la configurazione di competente organizzative se e in quanto ne
venga fatto un uso intelligente. Ma vale anche la relazione inversa: l’intelligenza prende
forma e si sviluppa solo se trova un ambiente extraintellettivo ad essa favorevole (per
fare un esempio, imparare è un’abilità tipicamente intellettuale, che non si sviluppa però
se non si ha una spinta – una motivazione, come si suole dire – a praticarla: si impara a
fondo solo ciò cui ci si appassiona).
21 La possibilità di utilizzare, per la rilevazione delle competenze, metodi di tipo quantitativo anziché qualitativo (metodi “qualitativi” sono quelli basati sull’uso del linguaggio ordinario) è discussa in appendice a p. 152.
25
COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI COMPETENZE
26
Sotto l’aspetto della valutazione, la differenza fra competenze intellettive ed extraintellettive è particolarmente importante. Le prime hanno riflessi diretti e immediati sulla
prestazione di lavoro (è superfluo sottolineare quale rilievo abbiano l’uso dell’intelligenza
e la risorsa del sapere in attività tecnicamente così complesse quali sono quelle legate
all’applicazione dei tributi in società socialmente ed economicamente avanzate, tant’è che
il termine knowledge worker, lavoratore della conoscenza, è quanto mai appropriato ai
lavoratori dell’Agenzia), mentre le seconde hanno riflessi indiretti e mediati. In questo
caso, “indiretti” e “mediati” non significa affatto “marginali” o “poco rilevanti”. Competenze come “Tensione al risultato”, “Iniziativa”, “Flessibilità”, capacità di “Fare squadra”,
ecc. (sono queste, come vedremo meglio più avanti, alcune delle competenze extraintellettive) sorreggono e indirizzano la motivazione individuale al lavoro e contribuiscono ad alimentare nell’ufficio e a tenervi vivo un clima organizzativo favorevole alla performance
collettiva. Come tali esse hanno un’importanza determinante: riconoscendone e valutandone l’apporto, si promuove l’interesse e l’impegno dei singoli a farle proprie e a praticarle.
Le competenze sono raggruppate in cinque aggregati omogenei, comprendenti
complessivamente undici competenze. Il termine tecnico inglese che designa tali raggruppamenti è cluster (che nell’uso comune significa appunto un gruppo di cose dello
stesso tipo, come cluster of flowers o cluster of stars). Per comodità espressiva parleremo
allora nel seguito di “cluster di competenze” invece che di “raggruppamento omogeneo
di competenze”.
Cluster delle competenze intellettive
Dinamismo intellettivo. Comprende le competenze Intuito & Costruzione logica,
che riguardano la capacità di combinare intuizione, analisi critica e conoscenze teoriche
nella risoluzione dei problemi di lavoro. In ragione del suo legame diretto e immediato
con la prestazione di lavoro, il dinamismo intellettivo è valutato, anche per motivi di semplicità, in base alle caratteristiche della prestazione eseguita. In altre parole, il comportamento intelligente viene valutato attraverso la verifica del prodotto intelligente.
Cluster delle competenze extraintellettive
– Affidabilità. Comprende la competenza Coerenza, che riguarda l’integrità e la correttezza professionale, e la competenza Passione per il lavoro, che esprime l’attaccamento al proprio mestiere;
– Dinamismo realizzativo. Comprende le seguenti competenze: Iniziativa, intesa come
capacità proattiva di attivarsi autonomamente senza sollecitazioni esterne, Tensione al
risultato, riguardante la capacità di prefiggersi obiettivi non facilmente realizzabili e di
impegnarsi a fondo per raggiungerli, e Sviluppo e diffusione del sapere, che denota
l’attitudine a sviluppare il proprio patrimonio di conoscenze ed esperienze a beneficio
della propria performance lavorativa e di quella dei colleghi;
– Dinamismo relazionale. Comprende le competenze Orientamento all’altro, Fare squadra
e Flessibilità, che riguardano la capacità di interagire, cooperare e lavorare in gruppo;
COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI COMPETENZE
– Leadership. Comprende due competenze: Team building (organizzazione e sviluppo
del gruppo) e Influenza, che riguardano la capacità di guidare gruppi e di esercitare
nel proprio ambiente di lavoro un ruolo trainante con la forza della persuasione.
L’immagine seguente dà una visione d’insieme del modello delle competenze del
personale dell’Agenzia delle Entrate, e dell’integrazione, al suo interno, delle competenze intellettive con quelle extraintellettive.
Modello delle competenze del personale dell’Agenzia delle Entrate
Affidabilità
Dinamismo intellettivo
• Coerenza
• Passione per il lavoro
• Intuito & costruzione logica
Dinamismo realizzativo
• Iniziativa
• Tensione al risultato
• Sviluppo e diffusione del sapere
Dinamismo relazionale
• Orientamento all’altro
• Fare squadra
• Flessibilità
Leadership
• Team building
• Influenza
All’interno del modello vanno poi selezionate le competenze proprie dei diversi
ruoli professionali (ossia le competenze richieste dalle funzioni della specifica posizione
rivestita, ad es. capo area, capo team, ecc.) e va assegnato un peso ai singoli cluster.
Mentre per alcuni ruoli possono quindi essere previste tutte le competenze del
modello generale, per altri le competenze possono essere solo alcune. Analogamente, il
peso dei cluster potrà variare a seconda dei ruoli considerati.
Questa operazione di scelta delle competenze nell’ambito del modello generale e
di assegnazione ad esse di un peso dà luogo al profilo delle competenze di ciascun ruolo
(una sorta di identikit comportamentale per le diverse posizioni funzionali).
In questa sede si omette la descrizione dei profili di competenze dei ruoli professionali dell’Agenzia, poiché avrebbe scarso interesse per il lettore che non faccia parte
dell’Agenzia stessa.
27
PARTE SECONDA
USO DI UN MODELLO
DI COMPETENZE
29
USO DI UN MODELLO DI COMPETENZE
31
1. Lo snodo tra modello di competenze e sistema di valutazione
A che serve un modello di competenze? Individuare le competenze necessarie a
lavorare bene in un determinato contesto organizzativo, può avere più finalità.
Si è già visto come il “movimento delle competenze” abbia storicamente origine
sul terreno della selezione, ma si sia poi esteso all’intero ambito del processo di gestione
delle risorse umane (formazione, sviluppo, remunerazione, piani di carriera). C’è però un
filo che lega tutti questi momenti applicativi di un modello di competenze, ed è il tema
della valutazione e – connesso a questo – il tema della costruzione di un sistema di valutazione. Su questa problematica intendiamo ora concentrare l’attenzione.
Per evitare equivoci, occorre subito osservare che “modello di competenze” e
“sistema di valutazione” non sono la stessa cosa. Il primo indica una costellazione di
aspettative di lavoro, il secondo riguarda le modalità di verifica della risposta a tali
aspettative. Il contenuto delle aspettative è dato dalle competenze cui un’organizzazione attribuisce valore in quanto generatrici di performance elevata. Le aspettative sono
formulate dal modello in modo generale (cioè senza riguardo a questa o a quella singola
persona) e astratto (cioè senza riguardo a questo o a quel caso concreto). La verifica delle
aspettative riguarda invece persone particolari in situazioni determinate. Insomma, con
la costruzione del proprio modello di competenze, un’organizzazione dichiara cosa si
attende in termini di comportamenti produttivi di performance superiore. Con un sistema di valutazione, rileva invece con procedure formalizzate se e in quale grado i comportamenti dei singoli corrispondano a quelle attese. Una cosa è definire l’intreccio delle competenze richieste ai componenti di un’organizzazione (qui siamo nell’ambito del
“modello di competenze”), un’altra è stabilire se, e in quale misura, e in che modo, nei
riguardi di chi e ad opera di chi e con quali effetti, le competenze descritte nel modello
debbano formare oggetto di procedure formali di verifica (qui siamo nell’ambito del
“sistema di valutazione”).
Ad esempio, in un’organizzazione come quella dell’Agenzia delle Entrate, che
svolge funzioni strettamente legate al rispetto di valori fondamentali dell’etica pubblica
(l’adempimento del dovere fiscale), pretendere dagli appartenenti a questa organizzazione comportamenti che denotino “integrità e coerenza” fa necessariamente parte del
modello professionale di un funzionario dell’Agenzia. Cosa diversa però è decidere di
USO DI UN MODELLO DI COMPETENZE
32
fare oggetto di una valutazione formalizzata tali comportamenti, così come manifestati
da questa o quella persona. Ragioni quale, ad esempio, la difficoltà pratica di osservazione di comportamenti come quelli appena indicati, nei loro diversi livelli di intensità,
e le discussioni, non facilmente componibili, che potrebbero di conseguenza accendersi
ove tali comportamenti fossero oggetto di valutazione formale, possono condurre alla
decisione di escludere la rilevazione di tali comportamenti dall’ambito di un sistema di
valutazione.
Potrebbe però a questo punto ritenersi che se un modello di competenze non si
abbina a un sistema di valutazione, il primo è destinato a risultare inefficace. Non è così.
Se una categoria di comportamenti, prevista dal modello di competenze, non trova inserimento nel sistema di valutazione, ciò non significa affatto che quella categoria rimane
priva di rilevanza pratica. Un modello di competenze esplicita la cultura e i valori di
un’organizzazione e questo passaggio dalla dimensione tacita alla dimensione espressa
della vita organizzativa può avere influenza decisiva sulle dinamiche cruciali dell’identità e del senso di appartenenza, che consentono ad un’organizzazione di rimanere vitale
nel tempo e di svilupparsi22.
Condizione essenziale affinché un modello di competenze possa esercitare tale
influenza è quella della validità del modello stesso. Un modello è valido se risponde
alle specifiche esigenze della realtà organizzativa per la quale è stato costruito, ovvero
se riesce a dare forma chiara, coerente e compiuta (e magari, se non proprio avvincente,
almeno non soporifera) alle idee più o meno implicite che le persone stesse, lavorando
giorno per giorno, sviluppano riguardo ai tipi di comportamento più funzionali rispetto
agli obiettivi della propria organizzazione. Questo processo di crescita comune di consapevolezza legato all’introduzione di un modello di competenze può servire a dissipare ambiguità e incoerenze e a superare visioni parziali, riduttive o addirittura sbagliate
nelle concezioni di lavoro maturate dagli appartenenti ad una organizzazione23. In breve: a parità di ogni altra condizione, lavora meglio chi ha una idea migliore di ciò che è
bene fare. Se il modello di competenze proposto riesce a far progredire la qualità dell’autoconsapevolezza, l’atteggiamento cui esso dà impulso non è di difesa o di elusione
(come avviene per adempimenti giudicati pesanti, inutili e burocratici), né di adeguamento passivo ad obblighi sentiti come estrinseci rispetto alle reali esigenze di lavoro,
bensì di adesione attiva a un codice di comportamento cui gli interessati attribuiscono
spontaneamente autentico valore e nel quale quindi possono riconoscersi e trovare
ragioni e motivazione nella propria vita lavorativa. Acquisendo piena conoscenza delle
aspettative della propria organizzazione, il personale può sapere, senza incertezze, dove
22 Per una sintesi delle questioni riguardanti la tematica della cultura organizzativa, si può leggere H.L.
Tosi, M. Pilati, N.P. Mero e J. Rizzo, Comportamento organizzativo, trad. it. Milano, EGEA, 2002, pp.
365-409.
23 In uno studio relativo a un campione di ingegneri impegnati nel lavoro di ottimizzazione dei motori della
Volvo, un ricercatore svedese, Jörgen Sandberg (Interpretare le competenze, in «Sviluppo & Organizzazione», n. 182, novembre/dicembre 2000, pp. 95-107 e 111-114), ha sviluppato l’idea che in una organizzazione possano convivere, più o meno implicitamente, concezioni diverse su cosa debba intendersi per best
performance e best performer (per un approfondimento si può vedere l’appendice a p. 136).
USO DI UN MODELLO DI COMPETENZE
e come dirigere la propria azione, traendo così, dal modello di comportamenti che gli
viene indicato, una duplice motivazione: da un lato, con la gratificazione legata al riconoscimento dei propri punti di forza, la spinta a perseverare nel percorso intrapreso, e
dall’altro, la sollecitazione ad analizzare lucidamente – in un processo di progressivo
miglioramento e sviluppo – quali siano invece i propri punti deboli.
Ma se questo è vero, si pone allora una domanda speculare a quella che è stata prima formulata e che suonava così: senza un sistema di valutazione un modello di competenze non è destinato a rimanere inefficace? La risposta è stata: no, un modello di competenze ha una sua intrinseca efficacia. La questione adesso si ribalta: se un modello di
competenze è in sé efficace, che motivo c’è di accoppiarvi un sistema di valutazione? La
risposta è questa: quando si decide di agganciare una serie di effetti (ad esempio, incrementi retributivi, percorsi formativi o progressioni di carriera) ad una verifica di come le
persone corrispondano al modello loro proposto è necessario che questa verifica sia condotta non “ad occhio”, “a naso” o “a pelle” ma in modo formale con una procedura controllabile da tutti gli interessati.
Ciò anzitutto per ragioni di equità organizzativa. Se si assume che le prestazioni
lavorative dei singoli rispetto al modello indicato non siano tutte uguali, decidere di collegare effetti a questa diversità di prestazioni, comporterà – per ragioni appunto di equità
– una distribuzione diversa di vantaggi, che è necessario però non solo che sia di fatto
equa, ma che venga anche percepita come equa. È infatti generalmente riconosciuto che
un eventuale deficit di equità percepita ha conseguenze negative sulla motivazione al
lavoro (disaffezione e calo dell’impegno lavorativo).
Lo scopo di un sistema di valutazione è fondamentalmente quello di contribuire
a mantenere quanto più elevato possibile in una organizzazione il senso dell’equità
percepita nella distribuzione dei vantaggi legati alla rilevazione e alla verifica del grado di corrispondenza della prestazione lavorativa alle aspettative enunciate dal modello. Quello che occorre tutelare ai fini del sostegno alla motivazione al lavoro non è solo
l’equità sostantiva – ossia la percezione che i propri sforzi e i propri successi vengano
giudicati in maniera equa rispetto a quelli degli altri – ma anche l’equità procedurale.
Una distribuzione di vantaggi, pur se in sé giusta, fatica ad essere percepita come giusta, se non sono percepite come giuste le regole procedurali seguite per la distribuzione dei vantaggi. Il che significa, nell’ambito di una procedura di valutazione, assicurare agli interessati queste tre cose: una compiuta “autopresentazione” (possibilità di
esporre il proprio punto di vista, prima che la decisione valutativa venga adottata), un
genuino “scambio comunicativo” (avere una chiara spiegazione del senso della decisione valutativa ed essere trattati con rispetto e dignità) e una effettiva “influenza decisionale” (ad esempio, la possibilità di attivare un’istanza di appello avverso la decisione valutativa).
In sintesi, nell’apprezzamento della prestazione lavorativa le questioni critiche
sono fondamentalmente due: decidere la valutazione giusta e deciderla nel modo giusto.
La prima questione riguarda l’ambito dell’equità sostantiva, la seconda l’ambito dell’equità procedurale. Ci si può aspettare che quanto più difficile sia misurare la quantità e
la qualità della prestazione lavorativa, tanto maggiori diventino i margini di incertezza
33
USO DI UN MODELLO DI COMPETENZE
34
dell’equità sostantiva, e tanto maggiore diventi allora per gli interessati l’importanza dell’equità procedurale24.
Oltre all’equità organizzativa, c’è un’altra ragione importante che giustifica l’introduzione di un sistema di valutazione ed è quella dell’efficienza organizzativa.
Valutazioni informali, quali quelle che circolano quotidianamente negli uffici, sono
strettamente legate alle fugaci vicende individuali, e non diventano quindi patrimonio conoscitivo comune, utile ad attivare e sostenere processi di apprendimento organizzativo. Un sistema di valutazione contribuisce invece ad arricchire progressivamente la base di conoscenza da cui l’organizzazione può attingere gli elementi valutativi necessari per le scelte gestionali, fra le quali, in particolare, quella riguardante il
conferimento degli incarichi (in questo caso si tratta degli elementi valutativi necessari per “mettere la persona giusta al posto giusto” o, per usare un’espressione inglese
ancora più sintetica, “to match people and job”, cioè “mettere in corrispondenza le
persone e il lavoro”).
Costruire un sistema di valutazione, significa rispondere a queste cinque domande:
• cosa si debba valutare (quali competenze e – oltre alle competenze – quali output dell’attività svolta);
• chi debba essere valutato (tutte le categorie di personale o solo alcune ovvero solo
alcune e soltanto per alcuni mestieri);
• chi debba valutare (il ruolo del dirigente dell’ufficio, lo spazio da attribuire all’autovalutazione, il ruolo degli altri attori, le istanze di garanzia);
• come si debba valutare (procedura, flusso e cadenza della valutazione, ponderazione
prodotti/competenze, livelli valutativi, determinazione dei punteggi, tipo di differenziazione valutativa, vale a dire se ci si debba solo preoccupare di “bloccare i peggiori”
o anche di “promuovere i migliori”, soluzione, quest’ultima, tipica dei sistemi volti a
sostenere strategie efficaci di sviluppo organizzativo);
• perché si debba valutare (effetti della valutazione: selezione, recupero di carenze formative, sviluppo professionale e progressione di carriera, incrementi del salario accessorio, attribuzione di incarichi).
Una risposta puntuale a tutte queste domande richiede un’appropriata normazione
nel quadro del sistema di relazioni sindacali previsto per ciascuna amministrazione pubblica. Lo snodo tra il modello di competenze e il sistema di valutazione segna perciò il passaggio dall’ambito della cultura e dei valori dell’organizzazione a quello della normazione
del rapporto di lavoro. Più e meglio di tante parole, può servire forse la figura seguente a far
comprendere la relazione tra modello di competenze e sistema di valutazione.
24 Sulla questione dell’equità organizzativa, analizzata come parte della questione più generale riguardante la
motivazione al lavoro, si possono consultare A. Grandori, Organizzazione e comportamento economico,
Bologna, il Mulino, 2001, pp. 115-121, H.L. Tosi, M. Pilati, N.P. Mero e J. Rizzo, Comportamento organizzativo, cit., pp. 94-97 e F. Isotta (a cura di), Organizzazione aziendale, Padova, Cedam, 2003, pp. 62-65. L’equità procedurale è destinata ad assumere sempre più rilevanza nei processi di valutazione che hanno luogo nella “economia della conoscenza” (la questione viene approfondita a p. 158 dell’appendice).
USO DI UN MODELLO DI COMPETENZE
Relazione tra modello di competenze e sistema di valutazione
Soggetti valutabili
Sistema di valutazione
• Tutte le categorie di personale
• oppure determinate categorie
• oppure alcune categorie
per determinati mestieri
Modello di
competenze
Valutatori
• Ruolo dell’autovalutazione
Prodotti
Chi
valutare
• Ruolo del dirigente
dell’ufficio
• Ruolo degli altri attori
Insieme
strutturato delle
competenze
richieste
dall’organizzazione
Competenze
che
l’organizzazione
e
le OO.SS.
concordano
di valutare
Cosa
si valuta
Perché
si valuta
• Istanze di garanzia
Chi
valuta
Procedura
Come
si valuta
Ambito della
cultura e dei valori
dell’organizzazione
• Determinazione punteggi
• Ponderazione
prodotti/competenze
• Peso singole competenze
• Livelli valutativi
• Tipo di differenziazione
valutata
• Flusso e cadenza
della valutazione
Effetti
Ambito della normazione
dei rapporti di lavoro
• Selezione
• Formazione
• Sviluppo
• Retribuzione accessoria
• Progressione di carriera
• Affidamento incarichi
Una trattazione analitica dei cinque punti del “pentagono di valutazione” rappresentato nella figura esula dagli scopi di questo manuale. Ciò che di seguito si farà, è
descrivere – sulla scorta anche dell’esperienza maturata dall’Agenzia delle Entrate – i
problemi di fondo dei sistemi di valutazione e presentare un ventaglio di possibili
soluzioni.
Ma prima di affrontare tale questione, poiché si è detto che la questione del sistema
di valutazione si colloca nella cornice della normazione del rapporto di lavoro, può essere utile, come spunto per riflessioni di carattere comparativo tra le diverse amministrazioni, accennare a come il tema della valutazione professionale si inquadri normativamente nello specifico contesto dell’Agenzia delle Entrate.
Sistema di valutazione. Quadro normativo dell’Agenzia delle Entrate
L’art. 18 del regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate è intitolato “Valutazione del personale” e stabilisce quanto segue:
1. L’Agenzia adotta adeguate metodologie per la valutazione periodica delle prestazioni, delle conoscenze professionali e delle capacità dei dipendenti, al fine di
governare, in coerenza con i contratti collettivi, lo sviluppo delle competenze, gli
incentivi economici, le progressioni di carriera e gli interventi formativi.
35
USO DI UN MODELLO DI COMPETENZE
36
2. A tale scopo sono individuati, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali,
metodi e tecniche di valutazione che garantiscano il massimo di efficienza, trasparenza ed oggettività.
Il regolamento di amministrazione dell’Agenzia ha formato oggetto di concertazione sindacale, ma le norme dell’art. 18 vanno raccordate con il successivo
CCNL delle Agenzie fiscali (2001-2005), sottoscritto a maggio del 2004, che prevede espressamente l’utilizzo di metodologie di valutazione dell’attività di lavoro per l’erogazione del trattamento accessorio incentivante e per l’affidamento di
incarichi di elevata professionalità (posizioni organizzative e professionali). Il
nuovo CCNL non prevede invece tale valutazione per i passaggi all’interno delle
aree, anche se stabilisce che i tre criteri espressamente enunciati nel CCNL per
tali passaggi (esperienza professionale, titoli e formazione) siano “integrabili” in
sede di contrattazione integrativa.
Nei fatti, è chiaro che l’estensione dell’ambito applicativo di un sistema di valutazione
è legata – ancor prima che a prescrizioni formali – alla capacità del sistema stesso di corrispondere concretamente ai principi cui si ispira. Nei tirocini per l’assunzione di nuovo personale e nei contratti di formazione e lavoro, l’Agenzia sta sperimentando, con revisioni e
affinamenti progressivi suggeriti dall’esperienza, metodologie di valutazione della prestazione di lavoro, in modo da testarne la validità e l’affidabilità prima di passare – nel quadro
del sistema di relazioni sindacali – alla loro applicazione al personale già in servizio.
2. Le criticità della valutazione: oggettività e veridicità
Quando qualcuno ci dice: “quell’impiegato è bravo”, le domande da porre sono due,
ben distinte fra loro. La prima è se quel tale impiegato sia veramente bravo. La seconda –
preliminare, dal punto di vista logico, alla prima – è cosa voglia intendere il nostro interlocutore quando dice: “bravo”. La prima questione riguarda la veridicità o, come si potrebbe
anche dire, la giustezza delle valutazioni, mentre la seconda riguarda l’oggettività del sistema di valutazione, cioè dei criteri in base ai quali esprimiamo le nostre valutazioni. Quindi, almeno in questo contesto, i sostantivi “veridicità” e “oggettività” e gli aggettivi “vero”
ed “oggettivo” non sono interscambiabili. L’affermazione “Quell’impiegato è bravo” può
essere sicuramente vera, ma è altrettanto indubbio che è soggettiva, poiché, a seconda del
soggetto che valuta, la parola “bravo” può significare cose assai diverse. In qualche modo,
sarebbe come se, per misurare gli oggetti, ci servissimo di un metro che – invece di essere
stabile come il campione di barra metallica conservato a Parigi25 – variasse di lunghezza a
25 A scuola abbiamo tutti appreso che il metro standard fu all’inizio definito pari alla distanza fra due intaccature su una barra di platino e iridio resistente alla ruggine tenuta in una camera blindata con aria condi-
USO DI UN MODELLO DI COMPETENZE
seconda della temperatura della mano che lo utilizza. Chi
direbbe che un metro del genere è “oggettivo”? Se lo fosse, dovremmo allora concludere che possono costituire
una misura oggettiva dello scorrere del tempo anche i
famosi “orologi molli” di Salvator Dalí, raffigurati nel
quadro “La persistenza della memoria”.
In altri termini, quando parliamo di “oggettività”
di giudizio ci riferiamo ai criteri di valutazione (i criteri
che definiscono le caratteristiche che intendiamo valutare ossia che stabiliscono in cosa
consista precisamente la “bravura” professionale). Quando invece parliamo di “veridicità” ci riferiamo alla valutazione concreta (se una persona abbia o no effettivamente, e in
che grado, le caratteristiche specificate dai criteri concordati).
Ma quand’è che i criteri di valutazione possono dirsi “oggettivi”? Quando hanno
due requisiti: validità (o “pertinenza” o anche “appropriatezza”, per usare altre due parole che in questo contesto sono sinonime della prima) e affidabilità (in questo caso, i sinonimi generalmente usati sono “attendibilità” o “univocità”).
Un criterio di valutazione professionale è valido se consente di verificare (si
potrebbe anche dire “intercettare”) le conoscenze e le capacità ritenute pertinenti per la
migliore funzionalità e lo sviluppo di un’organizzazione (“oggettivo” qui significa “pertinente all’oggetto” da valutare). Il modello delle competenze individuate e descritte in
questo manuale si può quindi dire valido se “mappa” realmente le qualità professionali
che servono per far funzionare bene gli uffici. Per citare un altro esempio riferito, questa
volta al mondo della scuola, se si intendesse saggiare le conoscenze di geografia di uno
studente, non sarebbe un criterio di valutazione valido quello di somministrargli un questionario contenente domande di storia.
Un criterio di valutazione è invece affidabile se definisce in maniera sufficientemente univoca come va valutato l’oggetto (la “bravura” professionale), sicché nessuno
dei soggetti che deve utilizzare quel criterio può interpretarlo “a modo suo”. In questo
caso criterio “oggettivo” significa non-soggettivo (cioè criterio non dipendente dalla
particolarità individuale dei singoli) o – per dirla in termini positivi anziché negativi –
inter-soggettivo (cioè criterio sulla cui comprensione e applicazione tutti gli interessati
concordano 26). Per riprendere l’esempio riferito al mondo della scuola, un criterio
valido di valutazione delle conoscenze di geografia di uno studente potrebbe essere
quello di presentargli una cartina muta dell’Italia e di chiedergli di segnare dove si trovi questa o quella città27. Il criterio, però, sarebbe affidabile solo se in quella cartina le
zionata nel laboratorio di Pesi e Misure a Sèvres, presso Parigi. Per ragioni di precisione, dal 1960 la convenzione è mutata e il metro è stato fissato in misura pari a una determinata lunghezza dello spazio percorso dalla luce in un certo intervallo di tempo.
26 L’aspetto dell’intersoggettività è reso molto bene dal termine inglese solitamente usato nella letteratura per
designare l’oggettività di una ricerca: “interrater reliability”, “affidabilità connessa alla concordanza fra i
valutatori” (i rater sono coloro che fanno il rating, cioè i valutatori, e reliability significa “affidabilità”).
27 L’esempio è ripreso da B. Vertecchi, M. La Torre, E. Nardi, Valutazione analogica e istruzione individualizzata, Firenze, La Nuova Italia, 1994, p. 76.
37
USO DI UN MODELLO DI COMPETENZE
38
città cui si riferiscono le domande fossero contrassegnate da cerchietti vuoti, poiché
altrimenti, senza questi punti di riferimento univoci, un valutatore di “manica larga”
potrebbe ritenere esatta la risposta che invece un valutatore di “manica stretta” giudicherebbe non corretta.
In estrema sintesi, l’oggettività riguarda il come si valuta, cioè il passaggio da vaghi
apprezzamenti intuitivi d’insieme, di natura prettamente soggettiva (ad es. “Tizio è bravo”), ad articolati criteri di giudizio condivisi nel loro significato (“bravo” significa eccetera, eccetera) e pertinenti alla realtà da valutare. La veridicità riguarda invece il che cosa
si valuta (una volta che ci accordiamo sul fatto che “bravo” vuol dire esattamente questo
e quello, si tratta di stabilire se Tizio sia effettivamente bravo nel senso che abbiamo convenuto). La differenza fra queste due dimensioni risalta con chiarezza nella diversità delle controversie cui, rispettivamente, possono dare luogo. Per intenderci, una cosa sono le
questioni relative al criterio di misurazione (questo è l’ambito dell’oggettività) e un’altra
le questioni relative alla misurazione ottenuta applicando quel criterio (questo è l’ambito
della veridicità). Possiamo essere tutti d’accordo sull’adozione di un determinato criterio
di misurazione di un certo fenomeno (ad esempio lo scorrere del tempo, che conveniamo
di misurare con uno orologio) e controvertere tuttavia sull’esattezza della singola misurazione. È possibile, ad esempio, che qualcuno dica che il treno Roma-Milano è partito alle
10,20, mentre un altro dica che è partito alle 10,35. In questo caso, si controverte sulla
veridicità della misurazione e non certo sull’oggettività del criterio di misurazione (nessuno mette in dubbio che l’orologio sia un criterio univoco di misurazione del tempo).
Allo stesso modo, possiamo essere d’accordo sul criterio di classificazione (cosa intendiamo esattamente con la parola “bravo”) e poi trovarci invece in disaccordo sulla classificazione concreta (se quell’impiegato sia bravo o no nel senso convenuto28).
Ecco uno specchietto che riassume i concetti appena esposti:
Validità
Affidabilità
}
Oggettività
➥ criteri di valutazione
↔
Veridicità
➥ valutazione
Per evidenti ragioni logiche, affronteremo prima la questione della oggettività del
sistema di valutazione per passare poi a quella della veridicità delle valutazioni.
3. L’oggettività del sistema di valutazione
Quali sono le obiezioni più ricorrenti alla costruzione di un sistema di valutazione
oggettivo? La prima è che cercare l’oggettività sarebbe quasi come inseguire una chimera.
28 Come può sorgere una divergenza di questo tipo? Generalmente il contrasto scaturisce dalla diversità di
informazioni sul comportamento del valutato.
USO DI UN MODELLO DI COMPETENZE
La seconda è che l’oggettività sarebbe tutto sommato inutile (puntarvi significherebbe
solo sprecare tempo e denaro nella messa a punto di sofisticate quanto superflue “macchine valutative”). Iniziamo dall’esame di quest’ultima obiezione.
3.1 Perché non bastano le valutazioni “a fiuto”
“Descrivi l’aroma del caffè”. Con questo curioso esercizio, proposto con l’ingannevole semplicità di cui era maestro, Ludwig Wittgenstein29, uno dei più celebri pensatori del ’900, offre lo spunto per affrontare l’ambivalenza di fondo tipica dell’esperienza valutativa: da un lato, la sua apparente evidenza (cosa c’è di più facilmente
riscontrabile, in qualunque ambiente di lavoro, della condivisione di giudizi come “è
bravo”, “è in gamba”, “è un tipo affidabile”, “ci sa fare” oppure “è un gran rompiscatole”, “meglio perderlo che trovarlo”, “è un peso morto”, e così via?) e, dall’altro, la difficoltà di dare una compiuta e univoca definizione di tali giudizi, passando da asserzioni ellittiche più o meno vaghe e impressionistiche a enunciati ben strutturati. Allo
stesso modo, tutti noi siamo in grado di riconoscere immediatamente l’aroma del caffè,
e tuttavia non siamo capaci di darne una descrizione anche solo appena adeguata alla
natura dell’oggetto (una descrizione, per intenderci, tale da consentire a chi non sa
cosa sia quell’aroma, di riconoscerlo).
Ma è proprio necessario poi questo passaggio dalla conoscenza intuitiva a quella
discorsiva, se la prima funziona così bene? Secondo l’opinione comune tutti sanno, in
una organizzazione, chi è bravo e chi non lo è, e perché quindi introdurre un sistema formale di valutazione, che costa tempo e denaro? In effetti, così come in una comunità di
persone dove si è abituati fin da piccoli a gustare il caffè, non c’è reale possibilità di disaccordo sull’identificazione del profumo di quella bevanda, analogamente nelle organizzazioni si registra in genere un largo consenso (espresso non di rado in forma “colorita”) sui giudizi intorno alle caratteristiche positive o negative di questa o quella persona
(tanto più se è un “capo”). Si potrebbe allora concludere che così come non ha senso
costruire una macchina per il riconoscimento dell’aroma del caffè (sappiamo riconoscerlo perfettamente da soli e sull’identificazione c’è sempre pieno accordo fra tutti) allo
stesso modo potrebbe sembrare solo un’inutile perdita di tempo e di denaro porre mano
alla costruzione di un sistema valutativo.
Tale conclusione è sbagliata, poiché, se fra la situazione valutativa e quella del riconoscimento dell’aroma del caffè vi sono le analogie appena evidenziate, vi sono anche
differenze essenziali: tutti ci intendiamo – praticamente senza possibilità di errore –
quando si tratta di riconoscere l’aroma del caffè, mentre questa intesa completa e immediata non c’è (o almeno non c’è sempre) nelle valutazioni relative alle qualità umane e
professionali di una persona. Oppure, quando l’intesa sembra esservi, essa può rivelarsi,
scavando più a fondo, solo apparente, perché nasconde diversità, anche notevoli, di punti di vista e di prospettive di giudizio.
29 Ricerche filosofiche, trad. it. Torino, Einaudi, 1974, § 610.
39
USO DI UN MODELLO DI COMPETENZE
40
Più in dettaglio, le differenze sono queste:
1) nella valutazione esistono, almeno potenzialmente, controinteressati e questo richiede che la valutazione non solo sia appropriata, ma anche che appaia tale, cioè sorretta
da criteri trasparenti. E se questo non accade – in altri termini, se la valutazione non
appare “obiettiva” – si rischia di dare adito a conflitti che possono, alla fine, minare la
tenuta di un’organizzazione avvelenandone il clima interno;
2) la valutazione anche quando (e talora proprio quando) riscuota consenso nell’ambiente di lavoro può essere condizionata da stereotipi e pregiudizi comuni e risultare
quindi sbagliata. Come a dire che la vox populi non è sempre vox Dei;
3) le valutazioni che circolano a livello informale nell’ambito di una organizzazione
mostrano in genere larga coincidenza di giudizi quando si tratta di riconoscere le punte di eccellenza o le cadute di mediocrità, ma possono fallire o sono comunque non di
rado controverse quando riguardano la fascia intermedia in cui si colloca buona parte
della platea dei valutati.
Dunque, nella valutazione occorre passare dal sapere diffuso (e però anche vago
nella sua fluidità) al sistema (inteso come architettura rigorosa di conoscenze). Con questo passaggio, la conoscenza intuitiva (vale a dire il riconoscimento “a naso” della bravura professionale, analogo alla percezione olfattiva dell’“aroma del caffè”) non viene certo
annullata, bensì viene formalizzata e oggettivata, cioè tradotta in asserzioni strutturate
dal significato chiaro per tutti coloro che appartengono all’organizzazione (l’intuizione
rimane insomma fondamentale, ma va sottoposta a verifica, perché – per ripetere la citazione di p. 15 – se è vero che la grandezza di un capo sta nella sua capacità di intuizione,
è però anche vero che nulla rischia di tradire più dell’intuizione). Il segreto sta nel far
entrare in un circolo virtuoso l’intuizione e l’elaborazione analitica: la prima offre alla
seconda i contenuti – cioè il materiale di esperienza – su cui riflettere, mentre la seconda
verifica criticamente la plausibilità della prima. L’attivazione di questo circolo virtuoso è
l’essenza stessa di un sistema di valutazione. Che potremo definire buono quando confermerà ciò che tutti intuitivamente sanno, e ottimo quando smentirà ciò che tutti intuitivamente credevano di sapere.
3.2 L’oggettività dei criteri di valutazione
“Quella porta è alta 3 metri”, “quel vaso pesa 2 chili”. Sono affermazioni cui ognuno di noi è disposto ad attribuire subito il carattere della oggettività, ma questo non significa necessariamente che si tratti di affermazioni vere, perché sono sempre possibili, e
persino non infrequenti, errori di misurazione. Sebbene “oggettività” e “verità” siano
nozioni correlate, esse concettualmente non coincidono, come abbiamo detto nel paragrafo precedente. Un’affermazione si definisce oggettiva non necessariamente quando è
vera, ma quando si può controllare se sia vera. Se dico che una certa persona era ieri in
ufficio, l’affermazione può rivelarsi falsa, ma è nondimeno sicuramente oggettiva, perché
è possibile controllarne la veridicità da parte di tutti coloro che dispongono delle informazioni e delle conoscenze necessarie per effettuare tale controllo. La nozione di oggetti-
USO DI UN MODELLO DI COMPETENZE
vità è apparentata quindi a quella di possibilità di controllo intersoggettivo e per questo
motivo si può anche affermare che essa si risolve, tout court, nella nozione di intersoggettività30. Detto in altri termini: un criterio di giudizio è oggettivo se qualunque altra
persona, messa al mio posto, finirebbe, applicando quel criterio, con l’esprimere la mia
stessa valutazione. Sicché, non dipendendo quella mia valutazione dalla mia particolare
soggettività (chiunque altro, al mio posto, si esprimerebbe allo stesso modo), si può a giusto titolo sostenere che essa è oggettiva (questo principio di oggettività equivale a quello
che nella scienza galileiana, che è poi la scienza moderna, si chiama il principio di riproducibilità dell’esperimento)31.
Chiarito questo, la domanda da fare è se sia possibile attingere, nel campo delle
valutazioni riguardanti le capacità professionali, lo stesso grado di oggettività che è possibile attingere quando si ha a che fare con lunghezze, pesi e altezze di oggetti. La risposta è in genere: “no”. Perché no? Perché nel campo delle valutazioni relative alle capacità
delle persone non esiste un metro utilizzabile in modo semplice, univoco e incontrovertibile come quello che si utilizza per misurare o pesare oggetti fisico-naturali (lo attestano, ad esempio, in modo eloquente le divergenze degli storici nelle loro ricostruzioni
delle vicende umane).
Quali conseguenze se ne possono ricavare? La più immediata sarebbe quella di
abbandonarsi allo sconforto e alla delusione: visto che non è possibile raggiungere nel
campo che qui ci interessa la stessa oggettività delle scienze fisico-naturali, perché non
rassegnarsi alla soggettività sfrenata dei valutatori? Oppure, per evitare che dilaghi l’arbitrio, perché non espungere dalla realtà delle organizzazioni – o restringervi comunque al
massimo – lo spazio della valutazione?
La prima opzione è disastrosa, perché porta ad annientare il senso di ragionevolezza e di equità indispensabili per la sopravvivenza e lo sviluppo di qualsiasi organizzazione. La seconda è puramente illusoria: la valutazione non può non esservi, perché – come
ognuno sa – la vita organizzativa è in gran parte scambio di valutazioni. Chiunque di noi
valuta in continuazione – più o meno generosamente ricambiato – il collega, il collaboratore o il superiore. Ed è logico che sia così: come potrebbe mai funzionare una qualsiasi
30 Se si ha ben chiara quindi la distinzione fra oggettività e veridicità, dovrebbe risultare altrettanto chiaro
che l’equivalenza tra oggettività e intersoggettività non comporta in alcun modo l’adesione ad una sorta di
“teoria sociale della verità”, secondo la quale sarebbe vero ciò che tutti concordano sia vero. Circa 500 anni
fa tutti o quasi tutti credevano che fosse il sole a girare attorno alla terra, ma questo consenso pressoché
unanime non bastava a qualificare come “vera” quella teoria (come diceva Benedetto Croce, “La folla o il
deserto non aggiungono o tolgono nulla al carattere di verità di un pensiero”). E tuttavia la teoria tolemaica
era sicuramente “oggettiva”, nel senso che esibiva tutta una serie di dati ed argomenti in base ai quali
chiunque poteva controllare se essa fosse o no vera. Se qualcuno avesse allora detto: “Ho la sensazione che
sia la terra a girare attorno al sole”, avrebbe fatto un’affermazione vera, ma soggettiva, priva cioè di elementi utili a controllarne la fondatezza.
31 È proprio in questo senso che una batteria di quesiti a risposta chiusa riguardanti, ad esempio, nozioni di
aritmetica, si definisce prova oggettiva. Qui il termine oggettiva non sta a significare che chi supera quella
prova dimostra con ciò di conoscere veramente l’aritmetica, ma significa invece che chiunque sarà il correttore della prova (purché adeguatamente addestrato) l’esito valutativo sarà sempre lo stesso. L’oggettività,
insomma, consiste nella “eliminazione dell’equazione personale del correttore” (A. Visalberghi, Misurazione e valutazione nel processo educativo, Milano, Edizioni di Comunità, 1955).
41
USO DI UN MODELLO DI COMPETENZE
42
organizzazione se le scelte gestionali (a cominciare da quelle più importanti come l’affidamento degli incarichi) non si basassero su una valutazione, seppure informale, delle
capacità professionali degli interessati? Insomma, ci si può illudere di “abrogare” le valutazioni per eliminare il rischio dell’arbitrio, ma si finisce così solo per renderle “clandestine” e quindi meno controllabili e potenzialmente ancora più insidiose nella loro eventuale arbitrarietà.
Come uscire da questa impasse? Aristotele diceva che è proprio della persona
esperta richiedere in ciascun genere di ricerca tanta precisione quanta ne permette la
natura dell’argomento32. Non comprendere questo significa cadere – nel nostro ambito di
ricerca – in quella forma di superstizione chiamata “quantofrenia”, che è in definitiva la
peggiore forma possibile di soggettività, perché spaccia e mistifica (se ne abbia o no
coscienza) come scientificamente oggettivo ciò che appartiene esclusivamente alla soggettività dell’osservatore valutante (il termine “quantofrenia” è di Pitirim A. Sorokin,
sociologo russo, naturalizzato americano, che fu tra i primi, negli anni ’20 del secolo
scorso, a introdurre nella sociologia metodi di analisi quantitativa, avendo però chiara
consapevolezza delle cautele con cui tali metodi vanno applicati ai fenomeni psicosociali, pena l’insensatezza delle conclusioni cui si perviene33).
Il senso di queste osservazioni (che andrebbero certo articolate assai più di quanto non sia possibile in questa sede) è mostrare quanto sia sbagliato e fuorviante, nel
campo di cui ci stiamo occupando, cedere all’alternativa dogmatica del “tutto o niente”. Nel nostro caso – ripetiamolo ancora una volta perché serve a fissare un punto chiave – chi rimane prigioniero di quell’alternativa ragiona (o sragiona) così: poiché non
possiamo raggiungere nel campo della valutazione delle capacità professionali la stessa
oggettività conseguibile nel mondo fisico-naturale, allora tanto vale arrendersi alla soggettività incontrastata del “capo” (opzione questa destinata a distruggere equità e condivisione nei giudizi valutativi) oppure eliminare in radice la valutazione dell’attività
delle persone e delle loro competenze (opzione, questa, che – se non fosse impossibile
– sarebbe ugualmente distruttiva poiché azzererebbe il fondamento della razionalità
organizzativa). Questo “nichilismo della perfezione” – come lo si potrebbe anche chiamare – sbarra l’accesso a possibili vie mediane, che invece esistono e sono fruttuosamente percorribili.
Quali sono queste vie intermedie? In primo luogo, varrebbe forse la pena di riflettere se, dopo tutto, sia proprio un gran male il fatto che gli uomini non si possano valutare
così come si misurano o si pesano tavoli, vasi e porte. Infatti, se, per un verso, potrebbe
sembrare un bel sogno quello di valutare le persone con la stessa semplicità ed univocità
32 Etica nicomachea, 1094b, 25 e poi anche 1094b, 12 e 1098a, 27.
33 Mode ed utopie nella sociologia moderna e scienze collegate, trad. it. Firenze, Editrice Universitaria G.
Barbera, 1965, pp. 109-174. L’epigrafe del capitolo dedicato alla “quantofrenia” è una frase del grande fisico austriaco Erwin Schrödinger, premio Nobel, che suona così: “La vita è troppo complicata per essere pienamente accessibile alla matematica”. Naturalmente, bisogna mettere in conto che in un paese di cultura
umanistico-letteraria come l’Italia queste affermazioni, o altre consimili, possano essere strumentalmente
utilizzate per giustificare la retorica irrazionalista. Un approfondimento sull’uso del linguaggio quantitativo nelle scienze si trova in appendice a p. 152.
USO DI UN MODELLO DI COMPETENZE
con cui si misurano gli oggetti, dall’altro, quel sogno potrebbe anche celare l’incubo di
un mondo in cui gli uomini stessi sono stati ormai ridotti a oggetti. Ma non è su questa
critica radicale (per qualcuno, forse, di sapore un po’ letterario) che si vuole qui insistere.
La pratica valutativa impone l’abbandono di ogni radicalismo e l’adesione a un sano spirito pragmatico.
Qual è dunque il punto? Il nodo della questione può essere spiegato con un semplice esempio. Supponiamo che si debbano valutare le doti di leadership di un comandante
di unità da combattimento. Se il criterio di giudizio fosse espresso così: “la leadership si
esprime nella capacità di guidare gli uomini”, il criterio sarebbe sicuramente soggettivo,
poiché costituirebbe un metro privo di sufficiente univocità. Le misurazioni rischierebbero di essere significativamente diverse a seconda delle convinzioni dei valutatori
riguardo a quella condotta chiamata “guidare uomini”. Quali connotati dovrebbe avere
tale condotta? È un autentico comandante chi sa piegare con la forza e le minacce i soldati alla propria volontà o piuttosto colui che sa esercitare una sapiente opera di convincimento riguardo alla giustezza delle proprie scelte? O è l’una e l’altra cosa (e altre ancora)
a seconda delle circostanze? In relazione al significato e al valore che attribuiamo alla
nozione di “guida di uomini”, muterà il nostro giudizio.
Ma se cominciamo a specificare meglio quel concetto, dicendo, ad esempio, che il
comportamento del vero leader militare è di essere in prima fila davanti ai suoi uomini
sul campo di battaglia, ecco che si dà avvio alla costruzione di una “metrica” grazie alla
quale i margini di interpretazione soggettiva del valutatore si vanno restringendo e il giudizio diviene sempre più oggettivo, nel senso che si rende indipendente dal fatto che sia
questo o quel soggetto, con la sua particolare individualità, a pronunciarlo. Così come
noi diciamo che l’affermazione: “quel tavolo è lungo 1,5 metri” è oggettiva, perché si
basa su un metro di giudizio univoco (il che non esclude, come più volte detto, che si
possa poi essere in disaccordo sulla concreta misurazione).
È appunto in questa direzione che si è proceduto nella costruzione del modello
delle competenze del personale dell’Agenzia delle Entrate (vedi al riguardo il paragrafo 4
della parte prima).
3.3 La capacità di giudizio degli attori della valutazione
Nell’attività di misurazione ciò che conta non è solo il metro che si utilizza, ma
anche il modo in cui lo si utilizza. In altre parole, non basta solo preoccuparsi dell’oggettività del metro di valutazione, ma occorre anche preoccuparsi – se così si può dire – dell’oggettività del soggetto utilizzatore del metro. Questo secondo aspetto viene spesso trascurato perché l’uso delle unità di misura più ricorrenti è radicato da sempre nella nostra
“forma di vita”, e non ci viene più in mente che quell’uso presuppone il possesso di adeguate conoscenze ed abilità pratiche per maneggiare come si deve quelle unità di misura.
Ad esempio, per misurare correttamente la lunghezza di un tavolo, non basta solo disporre di un metro, ma occorre, ad esempio, avere anche imparato che la fettuccia che si
adopera come metro va utilizzata stendendola bene sul piano, esattamente lungo il bordo
del lato che intendiamo misurare.
43
USO DI UN MODELLO DI COMPETENZE
44
Bisogna quindi distinguere tra maggiore o minore complessità delle conoscenze e
delle abilità necessarie per maneggiare un metro. Sotto tale profilo vi è grande differenza
fra la semplice misurazione della lunghezza di un tavolo e il discernimento delle capacità di una persona.
Nel sentiero stretto che ha come meta quella di arrivare a valutazioni sui comportamenti organizzativi condivise e aderenti alla realtà si può sicuramente fare molta strada
enucleando indicatori comportamentali sempre più idonei a “disambiguare” le situazioni valutative (la parola “disambiguare”, ormai entrata nell’uso, significa eliminare o
ridurre i margini di ambiguità di una situazione; il termine è sicuramente brutto, ma efficace dal punto di vista espressivo)34. E tuttavia non basta solo questo. Tra l’enunciazione
di una regola astratta (qual è pur sempre un indicatore comportamentale) e la sua applicazione alla realtà vi è inevitabilmente uno scarto per via dell’impossibilità di racchiudere in formule esaustive la varietà dei casi reali, e dato che questo scarto non è eliminabile
cercando di rendere sempre più minuziosa la regola di giudizio35, la soluzione non può
stare soltanto nell’affinare la regola di giudizio, ma occorre anche affinare la mente di
coloro che applicano la regola (sia valutati che valutatori), cioè affinare quella che solitamente si chiama la “capacità di giudizio”.
Questa capacità si coltiva sia con la riflessione autonoma che con la riflessione
guidata su casi esemplari di applicazione di regole valutative. In altre parole, occorre
educarsi a riflettere insieme – specie con riferimento a situazioni emblematiche – sui
giudizi positivi o negativi che formuliamo di continuo su situazioni e persone, abituandosi ad esplicitarne meglio il senso e a ponderarne la plausibilità. Un po’ come nella
comunità dei sommelier, dove la grande concordia di giudizi che si riscontra nella valutazione della qualità dei vini degustati dipende dal fatto che l’analisi delle caratteristiche organolettiche si ispira a canoni cui dà forma concreta e omogeneità applicativa il
lungo e paziente apprendistato collettivo cui i sommelier si sottopongono per affinare il
proprio gusto.
34 Questo percorso di progressivo scioglimento dell’ambiguità dei criteri di misurazione si ritrova, del resto,
anche nel campo delle scienze naturali, dove non è vero che le misurazioni sono tutte assolutamente univoche, come mostrano le controversie non infrequenti nella comunità scientifica. La scala Mercalli non ha,
per le sue caratteristiche empiriche, la stessa oggettività del sistema metrico decimale, ma non di meno è
generalmente accettata nel mondo scientifico, perché quel che conta alla fine è se il criterio di misurazione
impiegato sia o no utile per gli scopi che si perseguono. In altri termini, l’oggettività assoluta è un non senso come l’esattezza assoluta. Per citare ancora Wittgenstein: “Ciò che è inesatto non raggiunge il suo scopo
così perfettamente come ciò che è più esatto. Dunque tutto dipende da che cosa chiamiamo ‘lo scopo’. È
inesatto non dare la distanza dal sole fino al metro? E non dare al falegname la larghezza del tavolo fino al
millesimo di millimetro?” (Ricerche filosofiche, cit., § 88). Ritornando all’esempio della graduazione dell’intensità sismica, fu a suo tempo proposta, in alternativa alla scala Mercalli e alle sue connotazioni empiriche, una scala che si presentava come più “oggettiva” poggiando sul valore dell’accelerazione massima
che l’urto sismico imprime allo strato terrestre. Venne però osservato che il valore dell’accelerazione massima è, nella pratica, di difficile ricerca, sicché le descrizioni empirico-qualitative di Mercalli (che differiscono quindi da quelle “quantitative”, tipiche delle scienze naturali, espresse in valori numerici) rimangono ancor oggi, specie ai gradi più elevati della sua scala, quelle più pratiche e funzionali ai fini della misurazione dei fenomeni sismici.
35 Le ragioni di questa affermazione sono spiegate in appendice a p. 159.
USO DI UN MODELLO DI COMPETENZE
Quali ostacoli si incontrano nel corso di questo processo di apprendimento? In
altri termini: cos’è che solitamente può fare velo alla capacità di giudizio?
La psicologia del lavoro dedica ampio spazio a questa tematica. Particolare attenzione va prestata agli errori di giudizio (nella letteratura si ritrovano, ad esempio, il filtro
della “prima impressione”, l’effetto alone, le proiezioni, le associazioni da “personalità
implicita”, gli stereotipi) e ai cosiddetti “errori di attribuzione causale”, quali le distorsioni determinate dalla chiusura nel self-serving (tendenza a percepirsi comunque in
maniera favorevole, attribuendo generalmente a se stessi il merito del successo e a fattori
esterni, invece, la causa dell’insuccesso) cui corrisponde una resistenza, più o meno forte, all’apertura verso un genuino feedback da parte degli altri (siano essi capi, colleghi,
collaboratori o utenti dell’ufficio)36.
Il colloquio di valutazione, se da un lato può servire a correggere tali errori, dall’altro è la sede tipica in cui questi errori si manifestano. Appropriati interventi formativi riguardo alla dinamica e alla conduzione dei colloqui in contesti organizzativi possono perciò rivelarsi molto utili per migliorare la capacità di giudizio degli attori della
valutazione.
4. La veridicità delle valutazioni
Abbiamo finora parlato dei punti critici relativi all’oggettività del sistema di valutazione. Dobbiamo ora affrontare l’altra criticità, ossia quella della “giustezza” o “veridicità” delle valutazioni.
La domanda che bisogna a questo punto porsi è la seguente: quali sono le cause
che possono compromettere o, comunque, limitare la veridicità di una valutazione? La
prima è la carenza o la non accuratezza delle informazioni che supportano la valutazione. In questo caso si sbaglia a valutare per errore dovuto a informazioni difettose o inadeguate. La seconda causa è la presenza di interessi che, seppure comprensibili sotto il
profilo psicologico e gestionale, spingono sia il valutatore che i valutati ad esprimere
valutazioni non rispondenti alla realtà (il caso tipico è quello di valutazioni “gonfiate”37). In questo caso, si sbaglia a valutare per interesse (cioè perché non conviene essere sinceri).
La prima causa è assai importante, ma, dal punto di vista concettuale, non richiede
una analisi molto diffusa. Le cose da fare sono fondamentalmente due:
36 Molto utile può essere in proposito la lettura della sintetica panoramica delineata nel capitolo “Atteggiamenti, percezioni e giudizio” contenuto in H.L. Tosi, M. Pilati, N.P. Mero e J. Rizzo, Comportamento organizzativo, cit., pp. 26-49.
37 L’esperienza dimostra che il rischio di valutazioni discriminatorie (cioè di valutazioni che selezionino iniquamente) è in gran parte un falso problema. Il rischio vero è quello di valutazioni appiattite tutte verso
l’alto, poiché il dirigente, da un lato, ha un interesse forte a non “inimicarsi” i suoi collaboratori ed anzi a
svolgere nei loro confronti una sorta di azione di patronage, e, dall’altro – per sottrarsi alla fatica di gestire
conflitti e di motivare bene le proprie decisioni – tende a non assumersi la responsabilità di distinguere fra
chi lavora bene e chi no.
45
USO DI UN MODELLO DI COMPETENZE
a) poiché per valutare occorre anzitutto conoscere, bisogna costruire la procedura di
valutazione dando un ruolo adeguato a chi può avere conoscenza diretta delle competenze degli interessati;
b) occorre sviluppare un sistema informativo di raccolta e selezione delle informazioni
utili per il processo valutativo.
46
Un esame assai più ampio richiede invece la trattazione dell’altra causa. Preliminarmente, si può affermare che l’efficacia di un sistema di valutazione non dipende dalla formulazione di generici appelli alle “buone intenzioni” degli attori del
sistema, ma dalla coerenza dei suoi congegni rispetto agli scopi da raggiungere e dalla loro praticabilità. In parole povere, il segreto è cercare di far lavorare, per così dire,
l’egoismo dei singoli per fini sociali, suscitando, negli stessi attori, interessi contrari
a quelli da cui essi, per altro verso, sono mossi e che contrastano con i fini voluti dall’organizzazione.
Si tratta ora di analizzare quali siano gli interessi che tendono a pregiudicare la
veridicità dei risultati del sistema di valutazione. Questi interessi si ritrovano proprio nei
protagonisti del sistema di valutazione, e cioè sia nei valutatori che nei valutati. Cercheremo anzitutto di individuarne la natura e la dinamica e di prospettare possibili soluzioni che valgano a controbilanciare gli interessi in gioco e a modificare i “meccanismi di
convenienza” degli attori del sistema.
4.1 La situazione del valutatore
La valutazione “organizzativa” (quella cioè cui si assiste all’interno delle organizzazioni) presenta una sua tipica peculiarità: nella figura del valutatore viene a sommarsi,
al ruolo del capo, un altro ruolo che gli è potenzialmente antagonista, quello del giudice.
L’antagonismo sta nel fatto che mentre in un processo colui che è soggetto a valutazione
(l’imputato) non ricopre il ruolo di assistente del giudice, in un’organizzazione i valutati
sono coloro senza la cui collaborazione il capo nulla, o quasi nulla, può fare.
E se il raffronto con la valutazione giudiziaria può apparire improprio, perché il
giudice non valuta competenze professionali, la questione appena prospettata non cambia, nei suoi termini essenziali, se si fa il confronto con un’altra situazione valutativa che
ci è assai familiare e che presenta evidenti analogie con quella che ha come teatro il posto
di lavoro. Ci riferiamo alla valutazione scolastica, nella quale si tratta anche lì, come nella valutazione on the job, di apprezzare capacità e attitudini. Ebbene, se si può affermare,
seppure con qualche forzatura, che un insegnante, per fare il suo mestiere, non ha bisogno dei suoi allievi, godendo così, sotto questo aspetto, di ampia libertà per quanto
riguarda la valutazione dei suoi studenti, molto diversa è invece la situazione del capo,
che riesce a fare ben poco se non può contare sul sostegno delle persone che gli sono affidate (c’è perfino chi dice, probabilmente non a torto, che il capo in qualche misura viene
formato dai suoi collaboratori).
Cosa comporta questa differenza? La valutazione, soprattutto quando è negativa,
ma non solo in quel caso (anche chi è stato valutato positivamente tende a dolersi di
USO DI UN MODELLO DI COMPETENZE
essere stato eventualmente valutato meno bene del collega) rischia di peggiorare le relazioni di lavoro fra il capo e i propri collaboratori. Questo spiega perché i dirigenti, se da
un lato si lamentano spesso di avere scarso potere di valutazione, quando poi ne viene
loro concesso un po’, si guardano bene dall’utilizzarlo (come capitava nei vecchi rapporti informativi, ove il 105 – che era il punteggio più alto – non si negava pressoché a
nessuno), e ripiegano sulle valutazioni indifferenziate (potremmo dire “a pioggia”), per
evitare appunto di creare conflitti difficili da gestire. Si può deprecare quanto si vuole
questo stato di cose e trarne magari motivo di rimprovero per i dirigenti che danno così
scarsa prova di coraggio e di fermezza, ma è un fatto che anche nel mondo delle aziende
i capi, per le ragioni relazionali appena evidenziate, tendono in genere a dare valutazioni generose, ed essendo quindi quasi tutti i dipendenti giudicati ottimi, prima o poi tutti ottengono la promozione con la conseguenza che la vera discriminante diviene alla
fine l’anzianità.
Il problema è allora questo: come esercitare in modo rigoroso il proprio ruolo di
valutatore con il minimo possibile di “danni collaterali”, cioè di conflitti.
In termini di principio, la soluzione è chiara: il traguardo della valutazione – traguardo non sempre facile a raggiungersi, ma neppure inattingibile se c’è un impegno
autentico, senza riserve mentali, ad un serio esercizio di reciproco ascolto – è la condivisione dei giudizi, cioè la convergenza progressiva fra autovalutazione ed eterovalutazione, vale a dire la sintonia fra come io – lavoratore – valuto me stesso e come l’altro –
il capo – valuta me. In una organizzazione ideale, l’autovalutazione di tutti i valutati
coincide con l’eterovalutazione dei rispettivi valutatori e questa coincidenza non è collusiva o opportunistica (cioè non risponde a una logica di scambio di favori) ma è fondata sulla verità delle cose. In altri termini, il conflitto non sorge necessariamente quando la valutazione è negativa (può insorgere anche, come tutti sanno, quando essa è positiva ma non nella misura che l’interessato ritiene giusta), ma sorge quando la valutazione viene percepita come ingiusta in quanto non suffragata dai fatti. A scuola un brutto
voto non suscitava sentimenti di rivolta quando si capiva che era giusto (e anzi il fatto
di percepire che era meritato finiva per rafforzare l’immagine di serietà e competenza
dell’insegnante).
Non esiste però solo la criticità rappresentata dal divario o peggio dal conflitto fra
auto ed eterovalutazione, tra il “valutarsi” e il “farsi valutare”. Oltre a questa c’è pure la
criticità del potenziale conflitto fra più eterovalutazioni. In altre parole, anche laddove
auto ed eterovalutazione coincidano o tendano a coincidere, il valutatore può venirsi a
trovare nel dilemma se la propria valutazione, pur condivisa dal valutato, non possa
ingiustamente penalizzare quest’ultimo, nel caso in cui comportamenti analoghi a quelli
messi in atto dal valutato vengano apprezzati diversamente da un altro valutatore (l’ipotesi classica è che vengano apprezzati più benignamente). È anche questa una vicenda
che l’esperienza scolastica ci ha reso subito familiare. Chiunque di noi ricorderà forse di
aver fatto almeno una volta al proprio insegnante un discorso del genere: “Riconosco che
il brutto voto che lei mi dato al compito in classe è giusto, perché rispecchia sicuramente
la qualità modesta della mia prova. Ma tenga presente che un mio amico nella classe
accanto ha preso dal suo insegnante, per un elaborato di qualità analoga, un voto assai
47
USO DI UN MODELLO DI COMPETENZE
48
superiore al mio”. Ciò che rimproveravamo al nostro insegnante era un tipico caso di
valutazione “giusta”, ma non “equa”. Dov’è la differenza fra questi due termini, che sembrano essere semplicemente sinonimi? Così come “risposta giusta” significa “risposta
esatta” (in questa accezione, la parola “giusto” ha scarsa o nessuna parentela con “giustizia” o “equità” ed è apparentata invece a “giustezza”), allo stesso modo una “valutazione
giusta” è una valutazione “esatta”, “veritiera”, cioè che “corrisponde alla realtà” (ed è lo
stesso interessato a riconoscerlo, dopo aver visto la correzione della sua prestazione). Nel
caso appena citato, la valutazione, seppure “giusta”, non è però “equa”, perché non corrisponde a quella attribuita ad altri per analoga prestazione.
In una situazione del genere – che assomiglia a quella descritta nel famoso “dilemma del prigioniero” (illustrato in appendice a p. 160) – l’effetto finale è che i valutatori,
non potendo fare affidamento – o non essendo sicuri di poter fare affidamento – sulla
“capacità di tenuta” dei colleghi rispetto alle spinte che portano a “far lievitare” le valutazioni, vanno tutti ad attestarsi su giudizi ampiamente favorevoli. E si riproduce così –
nel conflitto reale o atteso fra eterovalutazioni (le valutazioni dei diversi capi) – quello
stesso appiattimento generale sui livelli massimi della valutazione, che – come abbiamo
visto – è anche l’esito ricorrente del conflitto fra auto ed eterovalutazione.
Un rimedio cui solitamente si fa ricorso, ma che si rivela per lo più poco produttivo, è quello dell’appello generico alla responsabilità dei valutatori, sollecitandoli,
magari anche con reprimende, ad esprimere giudizi più aderenti alla realtà. È una
soluzione moralistica (l’appello alle “buone intenzioni”) che ben difficilmente sortisce effetto.
Esistono accorgimenti più efficaci per modificare la “dinamica di interessi” dei
valutatori, in modo da attenuarne, se non proprio eliminarne, l’incidenza negativa sulla
veracità delle valutazioni? Ne possiamo immaginare almeno cinque, diretti a funzionare
come contrappesi rispetto alla dinamica appena descritta. In sostanza, si tratta di attivare
nel valutatore interessi di forza tale da neutralizzare (o almeno bilanciare) la sua tendenza a formulare giudizi prevalentemente appiattiti sui livelli massimi.
Collegare il sistema di valutazione del personale
a quello di assegnazione degli obiettivi al dirigente
Che significa collegare il sistema di valutazione delle prestazioni con quello di
pianificazione del lavoro e di controllo di gestione? In pratica, l’idea è che la programmazione degli obiettivi non deve tener conto solo della ripartizione delle risorse
umane per qualifica giuridica di inquadramento (come avviene oggi), ma anche della
qualità professionale delle risorse quale emerge dal sistema di valutazione. In questo
modo, l’eventuale propensione del dirigente a formulare valutazioni troppo sbilanciate verso l’alto troverebbe un limite nella consapevolezza che così facendo egli rischierebbe di vedersi assegnati obiettivi troppo superiori alle forze reali del proprio ufficio,
e di trovarsi inoltre escluso dall’assegnazione di nuovo personale, avendo egli attestato, con i suoi stessi giudizi, la condizione fortunata di essere circondato da collaboratori tutti ottimi.
USO DI UN MODELLO DI COMPETENZE
Collegare il sistema di valutazione del personale
al sistema di valutazione dei dirigenti
Contrariamente a quanto talora si crede, e come invece si legge spesso in letteratuvalutare le prestazioni dei collaboratori è fra le cose che i manager meno amano. E
non contribuirebbe probabilmente ad accrescere questo amore, l’introduzione del principio secondo cui il dirigente che valuta i suoi collaboratori deve, a sua volta, essere valutato per come dimostra di saperli valutare. Nondimeno il principio è giusto e sarebbe
sbagliato vedervi una forma di condizionamento psicologico del dirigente, tale da poterlo indurre a valutazioni volte comunque ad accontentare tutti (perché se tutti sono contenti, nessuno ricorre e manca allora l’occasione per sindacare le scelte valutative del
dirigente). Ciò che si chiede a un dirigente – e che fa parte del contenuto della sua
responsabilità – non è evitare valutazioni potenzialmente conflittuali, ma esprimere
valutazioni giuste, il che significa, da un lato, riconoscere e apprezzare il lavoro ben fatto
e, dall’altro aiutare gli interessati – con rispetto e senza ledere la dignità di nessuno – a
capire cosa è bene migliorare (non si fa autentica azione di sviluppo, se, essendo obiettivamente diverse le capacità, e diversi i meriti e l’impegno delle persone, tutti sono però
ritenuti ugualmente bravi).
È evidente il peso del lavoro di valutazione, se ci si impegna a farlo seriamente
(ma anche per questo – e anzi particolarmente per questo – si viene retribuiti). Anzitutto, occorre dedicare tempo e attenzione alla raccolta
Promemoria per il valutatore
e al trattamento delle informazioni, in modo da pervenire a valutazioni ben motivate o comunque ben
Valutare bene implica la fatica di spiegare, spiegare e spiegare. Accettare di
motivabili. La conoscenza dei fatti richiede poi autosottoporsi a questa fatica non è un atto
riflessione, perché è soggetta agli errori di osservadi generosità, ma un atto dovuto: il dirizione cui si accennato a p. 44 ed è influenzata da
gente è pagato anche per questo.
una istanza quasi naturale di attenzione selettiva che
spinge il supervisore a notare soprattutto ciò che va male nel lavoro che osserva e a non
soffermarsi invece ciò su che va bene, trascurando così di darne riconoscimento e merito agli interessati (con effetti demotivanti di non lieve momento). Occorre infine spiegare bene agli interessati perché si ritenga di dover adottare una certa decisione valutativa
piuttosto che un’altra e occorre prendersi tutto il tempo che serve per queste spiegazioni. È tempo comunque speso bene, perché può evitare incomprensioni e rancori e
risparmiare onerosi strascichi di contenzioso. Per quanto la retorica possa finire per falsare tutto, resta comunque vero che le persone sono la risorsa organizzativa più preziosa, e fra le condizioni essenziali di motivazione e valorizzazione di questa risorsa c’è la
capacità di dare un adeguato feedback (sul tema cruciale del feedback vedi più diffusamente p. 53). Valutazioni “d’istinto” non sono difendibili e non possono quindi essere
accettate. Non le accetterebbe per sé il valutatore, quando è egli stesso a dover essere
valutato, né può egli pensare – per un elementare principio di reciprocità – che possano
accettarle le persone di cui ha la responsabilità di valutare l’operato. L’ausilio del sistera38,
38 Ad esempio, H.L. Tosi, M. Pilati, N.P. Mero e J. Rizzo, Comportamento organizzativo, cit., p. 336.
49
USO DI UN MODELLO DI COMPETENZE
50
ma di valutazione è anzitutto nel richiamo all’obbligo di obiettivare con dati e citazione
di episodi significativi i propri giudizi, andando al di là delle semplici, e non di rado
fallaci, impressioni.
Per agevolare il compito della valutazione, si possono seguire alcuni accorgimenti
utili a mantenere le decisioni valutative su un piano di realismo. Indicazioni di questo tipo
vengono definite eurismi negli studi di organizzazione che riprendono costrutti delle
scienze cognitive: l’eurisma è una regola cognitiva che può facilitare la soluzione di problemi complessi, qual è, per l’appunto, quello della valutazione di prestazioni professionali
non riducibili a schemi di azione semplici e routinari. Nel nostro caso, un’indicazione euristica (ovvero un “eurisma”) di buon senso, potrebbe essere questa: “In assenza di elementi
negativi di giudizio o di elementi di giudizio particolarmente positivi, si può senz’altro
valutare la prestazione della persona come ‘adeguata’ al ruolo ricoperto”. Questa regola
risponde a considerazioni di buon senso e semplifica non poco il lavoro di valutazione.
La statistica come bussola di serietà
Se i parametri di giudizio sono vaghi e generici, il vincolo della cosiddetta “curva
normale” o “gaussiana” di distribuzione statistica dei dati, può servire ad evitare slittamenti generalizzati verso l’alto dei giudizi oppure difformità di valutazione ingiustificate
tra i diversi valutatori (in pratica, tale criterio viene in genere applicato, prevedendo, ad
esempio, che le prestazioni eccellenti o anche quelle significativamente superiori alla
media non possano superare una quota dell’x% del totale delle persone da valutare). Un
modello di competenze ha però anche lo scopo di oggettivare quanto più possibile i criteri di valutazione, sicché il vincolo rigido della gaussiana può in questo caso determinare
distorsioni valutative, precludendo forzatamente l’inserimento nelle fasce di giudizio
superiori di persone che magari lo meriterebbero in base ai criteri prestabiliti. Adoperato
tuttavia come bussola, il riferimento alla gaussiana può rivelarsi assai utile per segnalare
l’eventualità di atteggiamenti lassisti o, viceversa, indebitamente severi nei giudizi. Sul
valutatore ricadrebbe l’onere di motivare le valutazioni che lo hanno condotto a una distribuzione di giudizi sensibilmente difforme dalla curva normale39.
Pubblicità delle valutazioni
Qualunque capo tiene ad essere riconosciuto come valutatore serio. Questa motivazione verrebbe ad essere rafforzata se si prevedesse la possibilità di rendere pubblica in
forma aggregata, a livello di ogni ufficio, la distribuzione delle valutazioni per le diverse
fasce di giudizio.
39 La curva normale assomiglia graficamente a una campana (vedi appendice, p. 164). Un modello di curva
più rispondente alla specifica realtà dell’Agenzia delle Entrate potrebbe essere costruito effettuando periodicamente (a titolo indicativo ogni tre anni) valutazioni a controllo incrociato particolarmente accurate e
rigorose (prevedendo, ad esempio, assessment da parte di esperti esterni e anche valutazioni a 360°) su un
campione significativo di uffici. Sulla base di tali valutazioni si costruirebbe, per il periodo di riferimento,
la curva di distribuzione “normale” delle valutazioni all’interno dell’Agenzia.
USO DI UN MODELLO DI COMPETENZE
Bonus di selettività valutativa
Ciò che può indurre il valutatore ad allentare lo standard di serietà delle sue valutazioni è la comprensibile preoccupazione di non penalizzare i propri collaboratori
rispetto a quelli di altri colleghi che non dovessero dar prova di analoga serietà di giudizio. Tale preoccupazione può essere contrastata prevedendo retribuzioni di risultato
superiori a quelle ordinarie a favore di coloro che operino presso uffici ove si registri –
data appunto la serietà del valutatore – un indice elevato di selettività valutativa.
4.2 La situazione del valutato
Così come occorre incidere, con adeguati accorgimenti, sulla dinamica degli interessi da cui è mosso il valutatore, analogamente occorre controbilanciare la pressione del
valutato ad acquisire sempre e comunque giudizi ampiamente favorevoli. Quali meccanismi si possono a tale scopo utilizzare?
Gli esperti sconsigliano in genere, almeno nella fase iniziale, di prevedere un
impatto significativo della valutazione delle competenze professionali sulle politiche
retributive, nel presupposto che, eliminando o riducendo tale impatto, scemerebbe –
scusando il bisticcio di parole – “l’interesse degli interessati” ad avere valutazioni più
che positive, al di là dei loro effettivi meriti40. La tesi appare plausibile, ma bisognerebbe
ricordare l’esperienza già citata dei rapporti informativi, che non avevano impatto retributivo e che, ciò nonostante, si concludevano quasi sempre con l’attribuzione del fatidico 105. Non è detto quindi che se si sterilizzano, per così dire, i riflessi retributivi della
valutazione delle competenze, si elimina o si attenua la pressione ad avere giudizi lusinghieri dal proprio capo (la pressione può anzi persino rafforzarsi, perché nel caso di cui
parliamo il dipendente potrebbe far presente al superiore che “non gli costa nulla” dare
un giudizio favorevole, e il superiore, dal canto suo, si chiederebbe quale convenienza
avrebbe mai a negare tale giudizio, quando appunto “non gli costa nulla”, e il rigore
rischierebbe alla fin fine di apparire solo un’inutile cattiveria).
Continuando ad esplorare il repertorio dei possibili accorgimenti utili a fronteggiare
il problema di cui ci stiamo occupando, importante è sicuramente la considerazione che il
riconoscimento di meriti e capacità non può dare luogo solo ad onori (benefici economici
e di carriera) ma deve anche implicare oneri. Chi è stato valutato in maniera particolarmente positiva deve quindi di buon grado accettare standard qualitativi e quantitativi di
lavoro in linea con le competenze riconosciutegli (questa ipotesi fa da pendant a quella
prima prospettata per l’assegnazione degli obiettivi ai valutatori nel caso in cui essi
ammettano, con le valutazioni che esprimono, di beneficiare della collaborazione di
impiegati tutti o quasi tutti molto bravi). In sostanza, questa soluzione farebbe da pendant
40 Per una disamina delle questioni connesse alla retribuzione delle competenze si può vedere Spencer &
Spencer, trad. it., op. cit., pp. 287-299 e U. Capucci (a cura di), Business, strategia, competenze, Milano,
Guerini e Associati, 1999, pp. 171-190. Vedi anche l’interessante articolo di G.D. Klein, La retribuzione
fondata sulle conoscenze: l’analisi di un’esperienza di successo, in «Problemi di gestione», Formez, 1999,
vol. XXI, n. 6, pp. 57-74.
51
USO DI UN MODELLO DI COMPETENZE
52
a quella già prospettata per il valutatore: si tratterebbe di collegare il sistema di valutazione del personale al sistema di assegnazione degli obiettivi all’ufficio. Il personale non
avrebbe più interesse a valutazioni gonfiate, perché si vedrebbe gonfiare gli obiettivi dell’ufficio in cui lavora.
Insomma, si tratta di rendere manifesto agli interessati che giudizi non aderenti
alle loro reali capacità professionali finiscono per essere controproducenti, anche perché
determinano la loro esclusione da percorsi formativi utili a colmare i loro gap e a favorire
così il loro effettivo sviluppo professionale (perciò, chi tenta di sopravvalutarsi dimostra
alla fine la stessa intelligenza dello struzzo che – secondo un luogo comune – vorrebbe
far sparire le proprie difficoltà nascondendo la testa sotto la sabbia).
4.3 La cultura della valutazione
Per favorire la veridicità delle valutazioni, non basta attivare contrappesi agli
interessi dei valutatori e dei valutati che spingono a esprimere valutazioni non serie.
Occorre anche lavorare sulla “cultura della valutazione”. I punti che vanno qui fissati
sono quattro.
1. Un sistema di valutazione può dare valore alle persone (può valorizzarle) solo se ha
valore, cioè se aiuta a produrre valutazioni serie. La veridicità delle valutazioni – cioè
la loro rispondenza all’effettivo valore della prestazione resa e delle competenze
dimostrate – è essenziale affinché un sistema di valutazione possa dirsi “serio”. In
estrema sintesi, si può anzi dire che un buon sistema di valutazione è un sistema che è
oggettivo nei criteri cui s’impronta e serio nelle valutazioni cui dà luogo. Bisogna far
capire il valore della serietà: far parte di un’organizzazione seria crea orgoglio professionale, che è il cemento più forte di un’organizzazione (sempreché sia accompagnato
da almeno un pizzico di senso critico e – perché no – da una sana capacità di autoironia). Ma non è solo una questione di orgoglio, è anche una questione di convenienza.
Le organizzazioni pubbliche che hanno fama di serietà anche nelle valutazioni interne
guadagnano, nell’opinione pubblica, prestigio e credibilità, che legittimano la richiesta di trattamenti adeguati per i propri dipendenti.
2. Occorre sviluppare una “cultura della diversità” non individualistica. La mentalità
dominante nelle pubbliche amministrazioni guarda con sospetto tutto ciò che tende al
riconoscimento della diversità dei meriti, quasi fosse una colpa ammettere che qualcuno è più bravo di un altro e merita perciò più di altri. È importante convincersi che
la valorizzazione del merito non va necessariamente concepita secondo un’ottica
individualistica indirizzata solo e principalmente a beneficio dei diretti interessati
(cioè delle persone che dimostrino capacità professionali più marcate). Non offrire
specifiche opportunità ai più bravi dà luogo ad uno spreco di talento che non può non
ricadere negativamente sul progresso culturale e professionale dell’organizzazione
nel suo complesso, impoverendola. Non favorire l’emergere, il consolidamento e il
riconoscimento di competenze di punta significa alla fine privare tutti gli altri di preziose ricadute di conoscenze e di capacità che, nelle organizzazioni vive e vitali,
avviano dinamiche virtuose di apprendimento, di crescita e di emulazione positiva.
USO DI UN MODELLO DI COMPETENZE
3. Medietà non vuol dire mediocrità. Guardando al funzionamento complessivo di una
grande organizzazione, non contano solo le competenze di punta. La prestazione più
importante e significativa è probabilmente proprio quella normale. Non sono pochi
“eccellenti” a fare una buona organizzazione, bensì una maggioranza di persone capaci, volenterose e oneste, che rappresentano esempi di professionalità perfettamente
adeguata al compito e assicurano così il rispetto e il mantenimento degli standard
quantitativi e qualitativi su cui si regge l’organizzazione stessa. Questi colleghi rappresentano la media ma purtroppo, più o meno inconsapevolmente, siamo portati a
ritenere che “medio” equivalga a “mediocre”, mentre tra i due termini c’è una differenza sostanziale, poiché, diversamente dal “medio”, il “mediocre” non apporta alcun
valore aggiunto all’organizzazione. Confondendo queste due categorie, i giudizi finiscono sempre per addensarsi nelle categorie elevate (“medio-superiore” ed “eccellente”). Dobbiamo superare questa distorsione: non c’è bisogno di incassare un giudizio
ultra favorevole per vedere riconosciuto il proprio impegno, sicché un sana considerazione del valore della medietà41 è il correttivo indispensabile della “sindrome da
eccellenza”, tendenza tipica, e assolutamente irrealistica, dei sistemi di valutazione
interna, ad attestarsi tutti (valutatori e valutati) sui livelli di giudizio massimi. Con
questo appiattimento, il sistema non genera più informazioni utili dal punto di vista
gestionale, né – avendo perso qualunque serietà – è suscettibile di promuovere efficaci azioni di sviluppo. Un sistema valutativo poco serio, rende poco seria l’organizzazione che lo applica, svilendo il senso di appartenenza ad essa (per convincersene
basterà ricordare che, da studenti, a nessuno piaceva far parte di una scuola dove a
tutti si regalavano voti eccellenti e brillanti promozioni). Insomma, ci si può chiedere
se un’obiettiva verifica e una genuina presa di coscienza di cosa si è realmente fatto e
di cosa si è realmente dimostrato di saper fare siano un momento necessario del processo di sviluppo personale. Ma un’eventuale risposta negativa difficilmente potrebbe
essere considerata meritevole di discussione.
4. È importante saper dare e ricevere il giusto feedback. Un’immagine positiva di sé è
indispensabile per lavorare bene e con entusiasmo, fino a che però non si cade nella
trappola dell’autoinganno, che svia ogni tentativo di seria autovalutazione, spingendoci a dare maggior peso a tutto ciò che conferma un’immagine di noi non rispondente alla realtà. In qualsiasi organizzazione non cessa di stupire lo spettacolo quotidiano di persone che, con toni anche saccenti, accampano pretese a riconoscimenti di ogni genere (incarichi, incentivi economici, ecc.), facendo valere meriti e capacità che soltanto loro riescono a vedere in se stessi e che, tutt’al più, ritengono di
poter comprovare in base al possesso di titoli formali cui non corrispondono reali
competenze professionali. È un leit-motiv (peraltro giustissimo) che un sistema di
valutazione ha, tra le sue finalità essenziali, quella dello sviluppo delle persone,
che significa anzitutto superare il gap fra la prestazione attesa e quella effettivamente resa. Ma il gap più arduo da colmare è in primo luogo quello costituito dalla
41 Tale considerazione potrebbe trasformarsi, con una buona dose di intelligenza ed arguzia espositiva, in una
sorta di “elogio della medietà”. Il tema è sviluppato in appendice a p. 162.
53
USO DI UN MODELLO DI COMPETENZE
distanza fra la percezione di sé, del proprio valore, e la percezione che possono
averne le persone con cui quotidianamente interagiamo sul posto di lavoro. Cos’è
che può salvarci dall’autoinganno? Il feedback degli altri, che non è facile però né
dare, né ricevere.
54
Secondo gli autori di una recente opera dedicata alla leadership, tra i maggiori
ostacoli che si frappongono al feedback vi è un malinteso senso di gentilezza. Vale la
pena riportare per intero il brano, che ha come titolo: “Che cosa c’è di sbagliato
nell’‘essere gentili’?”.
Che cosa c’è di sbagliato nell’“essere gentili”?
Il proprietario di un bistrò parigino, col grembiule bianco e il cappello da chef
stava sulla porta del suo locale ad accogliere i clienti. Una coppia, entrando, gli
chiese sorridendo se fosse lui il proprietario.
“Sì”, rispose lo chef.
I due avventori diedero una rapida occhiata in giro: l’ambiente, gli allestimenti
e l’assortimento dei piatti in bella vista erano magnifici. Si rivolsero allora al
ristoratore dicendo: “È un posto fantastico: grande atmosfera e cibo sopraffino!”. A quel commento il loro interlocutore osservò: “Aspettate di aver cenato
per dirlo!”.
Essendo il proprietario del bistrò, lo chef non disdegnava certo l’approvazione,
però voleva che fosse autentica e non un semplice atto di gentilezza. Allo stesso
modo nelle organizzazioni, è possibile che nel dare un feedback la gente cerchi
di essere gentile, invece di muovere osservazioni utili e precise. Vittime di questo
atteggiamento sono soprattutto i leader.
Per anni alcuni studiosi del comportamento hanno sostenuto che il feedback sulle prestazioni non dovesse avere contenuto valutativo e andasse depurato di
qualsiasi elemento di positività o negatività. In tal modo, dicevano, lo si sarebbe
reso più digeribile e quindi più utile. Privato del suo potenziale offensivo, il feedback sarebbe stato meglio accettato dai destinatari.
D’altra parte, tale neutralizzazione di fatto diminuisce l’utilità del feedback,
come è stato dimostrato da uno studio realizzato al Massachusetts Institute of
Technology (MIT). Una cauta e non compromettente neutralità spoglia il feedback di importanti contenuti emozionali. Lo studio fu condotto su studenti che
partecipavano a un MBA, nel corso di un modulo sul comportamento delle organizzazioni. Ai partecipanti fu chiesto di indicare un obiettivo di cambiamento
cui dedicarsi nelle 15 settimane di corso che sarebbero seguite. Ogni settimana
gli studenti si riunivano in gruppo, nel corso delle lezioni, per ricevere un riscontro dei loro progressi. Al termine di ogni lezione, a ciascuno veniva chiesto di
indicare i tre feedback più utili che aveva ricevuto.
USO DI UN MODELLO DI COMPETENZE
Contrariamente all’opinione prevalente a quei tempi, emerse che il feedback giudicato più utile era quello valutativo, ossia quello in cui le persone avevano ricevuto apertamente indicazioni specifiche sull’adeguatezza o meno del loro comportamento. Questi risultati trovano una giustificazione. Tutti sappiamo infatti,
più o meno consciamente, che gli altri osservano e giudicano il nostro comportamento. È quindi naturale che la maggior parte di noi preferisca conoscere la versione integrale di questo giudizio, piuttosto che quella edulcorata. Mitigando il
loro feedback o cercando di essere garbati per non turbarci, gli altri non ci rendono un favore, ed anzi ci privano in realtà di informazioni essenziali al nostro
miglioramento.
Tratto da: D. Goleman, R.E. Boyatzis, A. McKee, Essere leader, trad. it. Milano, Rizzoli, 2002,
p. 166
Dire – e dirsi – la verità (e questo fa inevitabilmente parte del feedback) è talora
impossibile senza procurare qualche ferita (se non altro al proprio narcisismo). Il punto è
come aprire, insieme a ferite talora inevitabili, anche il cammino verso la guarigione,
cioè verso una più autentica comprensione di sé e del proprio valore. Riuscire a fare questo, evitando l’“imprigionamento delle relazioni produttive in quelle affettive”42, significa dare ai propri collaboratori un buon feedback, che è forse il compito più difficile di un
capo. Un buon feedback si caratterizza per il fatto di essere:
• costruttivo (dice alle persone come possono migliorare, le incoraggia di continuo a
migliorare e ne rafforza l’autostima per tutto ciò che di buono fanno e sanno fare);
• specifico (si rivolge con chiarezza ad aspetti ben determinati della prestazione di lavoro);
• tempestivo (interviene subito dopo l’accaduto, quando le questioni in gioco sono ancora rilevanti e ben chiare a ognuno);
• continuativo (non è intermittente, ma viene dato giorno per giorno);
• propositivo (trova il suo scopo non nella volontà di ferire e di abbattere gli animi, ma
nell’intenzione di migliorare la performance);
• appropriato (il tipo di feedback, lo stile con il quale viene comunicato, il tempo e l’occasione devono essere appropriati alla persona e alla situazione).
Si è appena detto che dare e ricevere feedback è tutt’altro che facile. Lo scambio
riesce quando entrambi riescono a “mettersi nei panni dell’altro”. Cosa significa questo
operativamente?
Quando si ha il compito di dare feedback, è importante comprendere il punto di
vista dell’altro, aprirsi alle questioni che egli pone e assicurarsi che i messaggi che vengono dati siano compresi. Per un capo è cruciale concepire il proprio ruolo di “datore” di
42 A. Grandori, Organizzazione e comportamento economico, cit., p. 172.
55
USO DI UN MODELLO DI COMPETENZE
56
feedback come parte di un ruolo più ampio, che è quello di coaching43 (coach = allenatore). Gli aspetti principali del coaching sono questi:
• individuare bene e focalizzare con cura cosa ci si attende dai collaboratori;
• spiegare, dandone dimostrazione concreta, come le cose vadano fatte;
• fornire supporto e dare rinforzi di tipo positivo (non limitarsi cioè alle “legnate”);
• indicare la direzione da seguire, consentendo però alle persone di trovare la strada a
loro più adatta;
• comprendere le diverse modalità di apprendimento delle persone ed essere disponibili
a modificare il proprio stile di coaching per adattarlo allo stile altrui di apprendimento;
• mostrare alle persone gli strumenti che possano aiutarle ad imparare da sé;
• dare alle persone le capacità e i mezzi per monitorare e verificare la propria performance;
• dare responsabilità alle persone e metterle in condizione di sentirsi realmente responsabili;
• incoraggiare le persone e dare loro la possibilità di acquisire credito per i propri successi;
• celebrare i successi;
• saper trasformare gli errori, e la comprensione degli errori, in una delle vie elettive di
apprendimento, facendone buon uso per migliorare la performance (procedere by trial
and error – per tentativi ed errori – è la strada maestra del progresso scientifico);
• dare opportunità di sviluppo;
• verificare ciò che le persone sono riuscite ad apprendere grazie alle opportunità di sviluppo di cui hanno potuto fruire.
Quando invece si tratta di ricevere feedback, è importante ascoltare bene che cosa
l’altro dice e capire:
• perché ci viene dato quel feedback;
• che cosa significa quel feedback;
• quale validità riveste per noi nella situazione in cui ci troviamo;
• quali azioni dobbiamo impegnarci a compiere a seguito di quel feedback.
Concludendo, il punto è come dare e ricevere feedback senza farne una affermazione di potere e un motivo di lacerazione del tessuto organizzativo, trasformandolo, al contrario, in uno strumento essenziale di coesione e di crescita di un gruppo. È un lavoro
molto delicato e impegnativo, che forse giustifica da solo almeno la metà della retribuzione del dirigente. La difficoltà maggiore si può forse riassumere in questa formula:
come far riconoscere alle persone i propri limiti senza che esse si sentano limitate. Il
capo che riesce a far questo si colloca esattamente – per usare una terminologia da economisti – nell’ideale punto di incrocio fra la curva del feedback valutativo e quella del
coaching.
43 Il concetto secondo cui il feedback valutativo fa parte del lavoro di coaching proprio del capo è stato sviluppato riprendendo le considerazioni svolte al riguardo nel New Performance Management System dell’Agenzia fiscale della Nuova Zelanda.
USO DI UN MODELLO DI COMPETENZE
5. La comunità dei valutanti
Avere criteri di giudizio comuni, intenderli allo stesso modo e applicarli in maniera analoga, così che una determinata prestazione lavorativa possa ricevere valutazione
uniforme quale che sia il valutatore. Realizzare tali condizioni significa dare vita a quella
che abbiamo già chiamato “comunità dei valutanti” (intendendo per valutanti, come già
accennato a p. 14, sia i valutatori che i valutati).
In cosa consiste, più precisamente, tale comunità? Consiste nella formazione di un
sentire e di un pensare comune riguardo ai comportamenti cui si decide di attribuire valore nella e per l’organizzazione di cui si fa parte. In altre parole, è certamente vero che un
sistema di valutazione è condiviso in quanto è oggettivo, ma è altrettanto vero che è oggettivo in quanto è condiviso. E la condivisione – cioè il sentire e il pensare comune – prende forma elaborando dialetticamente (ossia attraverso un confronto fra tutti gli interessati,
valutatori e valutati44) la comune esperienza di vita nell’organizzazione, in modo da:
• definire precisi indicatori comportamentali che chiariscano – rendendolo così condivisibile – il significato di giudizi valutativi di uso comune (“è bravo”, “è intelligente”,
“è preparato”, “è equilibrato”, “sa trattare con le persone”, “sa imporsi”, ecc.);
• dare applicazione omogenea ai significati attribuiti ai diversi giudizi valutativi (in
questo consiste l’equità della valutazione).
In sintesi: non basta che tutti utilizzino lo stesso metro di giudizio, ma occorre
anche che tutti imparino ad utilizzarlo nello stesso modo.
Come avviene per tutti i codici comportamentali (giuridici, etici, religiosi, sociali,
ecc.), la prassi e il training continuo che si accompagna alla riflessione sul loro uso, contribuiscono a rafforzare la comprensione comune delle regole di comportamento e ne
rendono così più omogenea l’applicazione.
La meta ideale di questo processo di apprendimento collettivo è, appunto, una
comunità di valutanti dove la condivisione dei giudizi sia piena e totale. In questa comunità ideale il valutatore non ha la preoccupazione di dover gestire conflitti, perché può
contare sulla percezione sobria e realistica che il valutato ha delle proprie abilità, né il
valutato ha da guardarsi dal valutatore, poiché ha fiducia nella sua capacità di giudizio.
Quanto è lontana questa meta? La domanda è sbagliata e come tale può avere solo
risposte sbagliate. La comunità ideale dei valutanti non va concepita come la stazione
più o meno lontana di un tragitto più o meno lungo da percorrere. È piuttosto un ideale
regolativo, un orizzonte – se si vuole usare una metafora – che come tale non si tocca
mai, ma “è sempre lì” e costituisce il contesto perenne di riferimento e di senso della
nostra esperienza valutativa. Insomma, non si tratta di “raggiungere l’orizzonte” (l’e-
44 Nella realtà organizzativa, i ruoli di “valutatore” e “valutato” non sono fissi ma si invertono in continuazione. Sul piano informale i capi (anche se non ne sono sempre consapevoli) sono continuamente oggetto
di valutazione da parte dei loro collaboratori, e lo saranno anche sul piano formale con l’introduzione della valutazione a 360° dei dirigenti. La “reciprocità” delle valutazioni è una condizione essenziale per lo
sviluppo della “comunità dei valutanti”.
57
USO DI UN MODELLO DI COMPETENZE
58
spressione è in se stessa priva di significato) ma di “tenerlo aperto” passo dopo passo. E
come? Favorendo tutte le iniziative che sostengano il processo di apprendimento collettivo prima descritto. E fra queste iniziative non possono mancare quelle volte a dare ai
valutati garanzie concrete riguardo all’equità dei valutatori.
La pratica della valutazione fa crescere un’organizzazione solo se c’è fiducia nella
capacità dei valutatori di discernere bene meriti e attitudini. Le organizzazioni sindacali
tendono sempre ad esprimere forti perplessità al riguardo e sono appunto queste riserve
sulla credibilità dei valutatori che generalmente motivano le resistenze sindacali all’introduzione di sistemi interni di valutazione.
Quali meccanismi possono servire a sostenere la fiducia nell’equità delle valutazioni? Una soluzione efficace (anche per la sua valenza simbolica) potrebbe essere quella
di costituire un nucleo di valutatori esperti, scelti fra i dirigenti con riconosciuta fama di
rigore, equilibrio ed autorevolezza. Questo nucleo verrebbe creato con un’apposita selezione e con adeguate azioni formative, avvalendosi anche dell’aiuto di specialisti della
materia (in particolare, esperti in assessment attitudinale, con il compito di aiutare a
individuare, con criteri oggettivi, i dirigenti che abbiano maggiori potenzialità per svolgere bene il ruolo in questione).
Ad uno di questi “valutatori scelti” il valutato avrebbe facoltà di rimettere fin dall’inizio la valutazione del proprio operato qualora egli ritenesse che il valutatore diretto
non sia dotato di sufficiente senso di “obiettività” per esprimere su di lui un giudizio
equilibrato. Non c’è da temere che questo atto di “sfiducia” possa essere operato alla leggera, poiché rischierebbe di ritorcersi sull’interessato, ove la valutazione degli esperti
non dovesse risultare a lui favorevole. È vero, tuttavia, che questo meccanismo di garanzia potrebbe essere interpretato dai dirigenti come una manifestazione di generalizzata
sfiducia nei propri confronti. Ma l’argomento è rovesciabile. La possibilità di azionare
quel meccanismo può essere la prova del nove della credibilità di un dirigente, credibilità che è invece solo presunta senza la previsione di quella forma di garanzia. Il valutato
che non opta per un valutatore esterno – e si può ritenere che questa sarà la situazione di
gran lunga più frequente – dimostrerà con ciò stesso che il dirigente gode di fiducia nel
proprio ufficio, rafforzandone così il prestigio e l’autorevolezza.
La soluzione appena prospettata, oltre a costituire per i dirigenti un segnale forte
dell’importanza della propria credibilità come valutatori, rappresenta la conseguenza
logica di un principio. Quello secondo cui la valutazione non è un obbligo cui si è
costretti a soggiacere, ma anzitutto un diritto da far valere. Il diritto, appunto, ad una
valutazione giusta (nel senso di “corretta”, “aderente alla realtà”, come già detto a p. 48)
ed equa dei propri meriti e delle proprie capacità45.
45 Può sembrare curioso parlare di un “diritto alla valutazione”, e in effetti così è se s’inquadra il discorso in
una prospettiva di tipo giudiziario (sarebbe appunto stravagante qualificare un “diritto” il fatto di dover
essere assoggettati a un verdetto). Ma un’organizzazione non è come un’aula di tribunale, dove, sfortunatamente, può capitare che ci si venga a trovare per rispondere di qualche imputazione. È il luogo dove si sceglie di trascorrere la maggior parte della propria vita spendendo energie assieme ad altre persone in funzione di una causa comune, e la circostanza che il proprio lavoro non formi oggetto di valutazione viene vis-
USO DI UN MODELLO DI COMPETENZE
Quanto tempo occorre perché possa mettere radici e svilupparsi il processo di
apprendimento che trasforma gradatamente un’organizzazione da un semplice “aggregato
di valutanti” in una “comunità di valutanti”? Sarebbe ingenuo aspettarsi tempi brevi, data
anche l’estensione della platea dei soggetti interessati in un’organizzazione complessa e
articolata come quella dell’Agenzia delle Entrate. Ma il tempo che potrà occorrere non
può comunque costituire un alibi per non iniziare il cammino o ritardare la partenza.
Si racconta (non si sa se la storia sia vera, ma è comunque illuminante come “parabola organizzativa”) che una mattina, attraversando Parigi (tornava dal trionfo di Austerlitz), Napoleone vide in un giardino un albero maestoso pieno di fiori bellissimi. “È stupendo!”, esclamò rivolgendosi al maestro nell’arte dei giardini che lo accompagnava
spesso nei suoi viaggi, e aggiunse: “Voglio che alberi di quel tipo siano piantati lungo i
principali viali di Parigi”. “Ma Sire”, obiettò il giardiniere, “Quell’albero appartiene a
una specie rara che impiega quasi trent’anni a fare i fiori!”. Rispose l’imperatore: “E allora non bisogna assolutamente perdere tempo. Comincia a piantarne i primi già questo
pomeriggio!”.
suta tutt’altro che positivamente (come accadrebbe invece se si trattasse di “scampare a un giudizio”). La
persona che ha un minimo di amor proprio finisce per trarne il convincimento che in quello che egli fa la
sua organizzazione trova ben poco, o addirittura nulla, meritevole di considerazione.
59
PARTE TERZA
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
61
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
Competenze intellettive
e prestazione di lavoro
63
1. Dinamismo intellettivo (Intuito & Costruzione logica)
Il dinamismo intellettivo esprime l’intelligenza pratica, cioè la capacità di combinare insieme analisi critica e intuizione nella quotidianità delle situazioni di lavoro.
L’analisi critica è la facoltà stessa del raziocinio, vista, in negativo, come capacità
di evitare vizi e fallacie logiche e, in positivo, come capacità di produrre prove e inferenze valide e pertinenti.
L’intuizione è l’attitudine a identificare rapidamente, sulla scorta anche di dettagli
apparentemente secondari, l’aspetto chiave di una situazione complessa, orientando di
colpo, nella direzione giusta, la ricerca di elementi risolutivi di questioni che analisi
magari lunghe e metodiche non erano fino ad allora riuscite a sciogliere. D’altra parte, è
proprio la sistematicità dell’analisi che, generalmente, prepara il terreno alla repentina
sintesi dell’intuizione (finendo questa per apparire, nell’opinione comune, una visione
improvvisa – un lampo, come suole dirsi – nella quale vanno a incastrarsi, come d’incanto, le tessere di un puzzle attorno al quale ci si era a lungo affannati). Contrapporre, dunque, la prima alla seconda – cioè l’analisi critica all’intuizione – è sicuramente sbagliato,
perché esse operano in sinergia e sono l’una complementare all’altra.
Attitudine al ragionamento e creatività di pensiero, seppure concettualmente
distinte, si presentano in concreto strettamente intrecciate, tant’è che nell’uso linguistico
comune (e a questi usi fa richiamo questo manuale per estrarne la verità che solitamente
essi contengono) affermare che una persona è intelligente significa sia che ha capacità di
analisi logica, sia che sa “tirare fuori” (o che spesso le “vengono in mente”) buone idee
quando servono. E questo è vero ancor più nell’ambito delle professioni tecniche intellettuali (quali sono quelle dell’Agenzia) ove la capacità intuitiva ha pregio solo se congiunta a una robusta capacità argomentativa.
Per questa ragione, si è ritenuto opportuno (evitando così inutili complicazioni)
considerare insieme in questa sede, sotto l’unica categoria di “dinamismo intellettivo” o
di “Intuito & Costruzione logica”, entrambe le competenze intellettive appena enunciate,
che invece in altri sistemi di valutazione vengono talora distinte (si parla in tal caso di
“pensiero analitico” per designare, grosso modo, la capacità di ragionamento logico e di
“pensiero concettuale” per designare l’intuizione, approdando, nella descrizione dei
diversi gradi di intensità di queste competenze, a sottili distinzioni che probabilmente
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
64
sono apprezzabili solo da uno psicologo cognitivista). Pertanto, in questo manuale le
parole “dinamismo intellettivo”, “competenze intellettive”, “Intuito & Costruzione logica” sono praticamente sinonime.
In sintesi, il dinamismo intellettivo è la capacità di attingere al patrimonio delle
proprie conoscenze tecniche e di utilizzarle al momento opportuno per l’identificazione,
la messa a fuoco e la soluzione dei problemi. L’intelligenza orientata all’azione – che è un
altro possibile nome del dinamismo intellettivo – traccia le alternative utili a superare
eventuali impasse, aprendo la strada a scelte innovative.
Il dinamismo intellettivo ha riflessi diretti e immediati sulla prestazione di lavoro
e perciò il modo più semplice e oggettivo di valutarlo è quello di analizzare i risultati cui
dà luogo. In sostanza, invece di pretendere di valutare in se stesso il comportamento
intelligente (che ha una fenomenologia piuttosto varia e complessa, all’interno della quale è ben difficile istituire graduatorie chiare e univoche di “intensità di intelligenza”), si
valuta il risultato intelligente con appositi indicatori che saranno analiticamente illustrati più avanti (ad esempio, chiarezza e congruenza della soluzione).
Sia pure per rapidi tratti (cercando però di evitare banali e sommarie semplificazioni), è importante comunque comprendere – sia per chi deve produrre risultati, sia per
chi deve valutarli – in cosa consista il comportamento intelligente (a questa analisi sono
dedicati i primi due paragrafi seguenti). Acquisirne una più lucida consapevolezza non
basta sicuramente a garantirne la pratica, ma può forse, in qualche modo, ispirarla. Così
come studiando la logica non si ha alcuna garanzia di fare ragionamenti logici, ma se ne
può trarre notevole giovamento per costruire dimostrazioni plausibili ed evitare errori
nella pratica argomentativa.
1.1 Il dinamismo intellettivo come capacità di individuare
e inquadrare “problemi chiave”
“Intelligente e professionalmente preparato” sono i due termini che nel linguaggio valutativo comune descrivono sinteticamente il funzionario dotato di elevato
“dinamismo intellettivo”. Domanda: è possibile esplicitare il senso di questi termini (in
particolare di quello relativo all’aspetto della “intelligenza”), superando l’impressionismo soggettivo, le opinioni incerte e destrutturate, gli stereotipi, la vaghezza di giudizio, quando non il vero e proprio pregiudizio e arbitrio del valutatore? E si può fare
questo senza cadere in artificiose e complicate concettualizzazioni, solo apparentemente esatte e destinate invece, nella loro astrattezza, a rimanere sterili enunciazioni prive
di effetti pratici?
In altri termini, la questione cruciale è se sia possibile puntare in questo campo ad
una “oggettività intelligente”, cioè ad una oggettività che abbia, al tempo stesso, le caratteristiche della pertinenza e della praticabilità, di seguito descritte:
• pertinenza significa che si vanno a intercettare reali manifestazioni di intelligenza sul
posto di lavoro (non hanno, ad esempio, questa caratteristica di pertinenza taluni meccanismi paraconcorsuali di tipo tradizionale che, invece di rilevare i reali meriti
espressi on the job, si traducono in un conteggio formalistico di “titoli culturali” o di
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
“titoli di servizio” che non trovano corrispondenza nella manifestazione di effettive
capacità professionali sul luogo di lavoro);
• praticabilità significa che si vanno a rilevare queste concrete manifestazioni di intelligenza professionale con strumenti di misurazione attendibili e tuttavia il più possibile
semplici, senza virtuosismi tecnici.
È evidente che il compito appena prospettato è particolarmente arduo. Affrontarlo
richiederà quindi uno spazio considerevolmente più ampio di quello che verrà dedicato
all’analisi delle altre competenze.
Tralasciando per il momento il tema della “preparazione professionale”, di cui si
parlerà più avanti a proposito della competenza “sviluppo e diffusione del sapere”, si
tratta ora di articolare il concetto di “intelligenza”, visto come comportamento cardine
della vita organizzativa. A questo riguardo, proviamo anzitutto a immaginare una persona che riesca a selezionare e identificare (comunemente si dice: “afferrare”) nel continuum di per sé indistinto (per non dire caotico) dell’esperienza – vale a dire nel groviglio
delle situazioni in cui opera e nella valanga di dati da cui è quotidianamente sommersa –
i “veri problemi” o, come anche di solito li si definisce, i “problemi reali”, i “problemi
chiave” o le “questioni cruciali”, quelle cioè dalla cui soluzione dipende la riuscita del
proprio lavoro e, in una prospettiva più vasta, il successo della propria organizzazione. E
proviamo poi a immaginare che quella persona – nell’atto stesso in cui riesca a individuare, nella concreta situazione di lavoro, il “problema vero” – riesca anche a darne con
chiarezza una formulazione nuova e diversa che ne agevoli la soluzione, sfuggendo alla
trappola di “fossilizzarsi” (per usare un termine ricorrente) su “questioni false”, su “questioni apparenti” o su “questioni male impostate”, che sviano l’attenzione e indirizzano
il processo decisionale lungo piste sbagliate o infruttuose.
Ebbene, questa sequenza di comportamenti – che prende avvio dalla percezione,
prima vaga e poi sempre più nitida, che nell’intreccio degli elementi noti qualcosa “non
quadri”46, a dispetto magari dell’opinione dei tanti che nella sequenza dei fatti osservati
non scorgono nulla di strano o di problematico – costituisce la prima e decisiva concatenazione di mosse di un attore dotato di “intelligenza pratica”47.
46 La percezione che qualcosa “non quadri” è l’essenza stessa di un problema cognitivo, che, in definitiva,
altro non è se non il venire alla luce, nella mente dell’osservatore, di un contrasto – prima inavvertito – fra
due o più assunzioni teoriche oppure fra un’assunzione teorica e ciò che chiamiamo “realtà”.
47 In una strategia è cruciale la “selezione” del problema da cui si decide di prendere le mosse. Il successo
delle imprese giapponesi negli anni ’80 fu essenzialmente dovuto ad uno spostamento del problema chiave. Passò in secondo piano la questione, che prima appariva fondamentale: “come soddisfare i bisogni
attuali del cliente” e prese forma invece, fino ad occupare la scena, una domanda diversa: “come andare
incontro ai bisogni latenti del cliente”, i bisogni, cioè, della cui soddisfazione il cliente stesso non ha finora
mai fruito, perché non li ha neppure ancora avvertiti. Come disse anni addietro un alto dirigente della
General Motors: “Non si sarebbe mai arrivati alla produzione della Mazda Miata soltanto con le ricerche di
mercato. È stato necessario un grande salto creativo per capire cosa avrebbe potuto volere il cliente” (citato
da Peter M. Senge, Il nuovo lavoro del leader. Costruire l’apprendimento nelle organizzazioni, in Leadership, a cura di G.P. Quaglino, Milano, Raffaello Cortina, 1999, p. 33). È in accordo con queste esperienze
l’espressione comune che definisce “intelligente” la persona di mente duttile che “afferra” rapidamente
problemi inediti e cruciali.
65
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
66
Entrano qui in gioco almeno quattro fattori, tra loro variamente combinati: intuizione, senso critico, padronanza linguistica e “intelligenza emotiva”.
1. L’intuizione non ha – contrariamente all’opinione comune – nulla di magico o misterioso, ed esprime piuttosto l’abilità tipica della persona esperta (l’intuizione del principiante si dimostra, non di rado, una semplice “alzata di ingegno”, quando non si confonde – per usare un termine più icastico – con la “sparata”) di riconoscere rapidamente, nel mutevole e confuso caleidoscopio delle situazioni del presente, schemi di azione e di pensiero pazientemente costruiti ed affinati nel corso di una lunga
esperienza48. Come osservava Raimond Poincaré (eminente statista francese del ’900),
l’ispirazione – cioè la soluzione improvvisa, d’emblée, di problemi assillanti rimasti a
lungo aperti – viene solo alle menti preparate49, e la storia della creatività scientifica
sta a testimoniarlo. Ma sarebbe sbagliato vedere nella dinamica dell’intuizione così
intesa un processo di apprendimento solo ed esclusivamente adattivo (che è comunque
quello statisticamente più significativo e che perciò sarebbe ingenuo e sbagliato snobbare, data la vasta incidenza che esso ha in pratica in ogni organizzazione, fosse anche
quella a più elevato tasso di creatività). Il fatto è che il presente non è mai pura ripetizione, e l’intuito rivela allora i suoi tratti di originalità e creatività autentica50, nel
cogliere, per un verso, le analogie nascoste con il passato (quelle che in genere vengono
trascurate o cadono al di là del campo di percezione comune), liberandosi, per un altro
verso, dall’attrazione esercitata dalle somiglianze apparenti o dagli usi consueti51. Si
48 “Intuizione” deriva dal latino “intueor” che significa “vedo” (l’origine etimologica della parola è più evidente nel corrispondente vocabolo inglese “insight”, ove sight è appunto l’atto del vedere). Ciò che si
“vede” è il passato traslato e rimodellato (più o meno originalmente) nel presente. Ed è appunto il riconoscimento nel presente di schemi e repertori di conoscenze già appresi in precedenza e sistematizzati (di
solito chiamati “chunks”, letteralmente “grossi pezzi”) che spiega – come ha osservato Herbert Simon – il
tratto tipico di “rapidità” che caratterizza la risposta intuitiva rispetto alla lentezza e alla fatica della riflessione e del calcolo, che si trovano invece a dover affrontare una configurazione “vergine” di elementi o di
fenomeni non dissodata in precedenza (vedi Herbert A. Simon, Razionalità e non razionalità nei processi
decisionali, in «Problemi di gestione», Formez, 1997, vol. XX, supplemento al n. 6, pp. 239-260; il titolo
originale dell’articolo è: Making Management Decision: The Role of Intuition and Emotion).
49 Citato in Herbert A. Simon, La ragione nelle vicende umane, trad. it. Bologna, il Mulino, 1984, p. 60.
50 Da sottolineare qui il termine “autentico”, di contro al chiacchiericcio di moda sulla innovazione creativa,
che in realtà – quando si guardano le cose senza il velo della retorica “novista” – è abbastanza rara.
51 È famoso il caso della 3M, una multinazionale americana della chimica, nei cui laboratori si cerca di mettere a punto colle sempre migliori, rispondenti a questi due parametri: tenuta e rapidità di essiccazione. Un
giorno venne prodotta per sbaglio una colla che non si asciugava mai, e quindi permetteva di appiccicare e
staccare gli oggetti molte volte. A giudizio unanime, la si sarebbe quindi definita una colla pessima. Ma
una segretaria ebbe l’idea di usarla per una funzione alternativa: attaccare promemoria su superfici lisce.
Nacquero così i post-it, quei foglietti, generalmente gialli, che servono per appiccicare appunti. Il fatto che
la colla non s’induriva si rivelò un vantaggio insospettato, consentendo di staccare, spostare e facilmente
sostituire appunti. La segretaria si era defocalizzata dalla funzione abituale e aveva ideato un uso alternativo. Non dissimile, ma per nulla nota, è l’origine della registrazione informatica in tempo reale degli atti del
registro. Questa innovazione si deve a un operatore di front-line dell’Ufficio di Roma 5 dell’Agenzia delle
Entrate, cui è venuta in mente l’idea di utilizzare per lo scopo appena detto una particolare funzionalità
della procedura informatica di registrazione degli atti, funzionalità che era stata in realtà progettata a tutt’altro fine. Illustrare qui i dettagli della scoperta porterebbe via troppo tempo. Quel che conta è che anche
in questo caso vi è stata una felice intuizione che ha intravisto (“intuire” è “vedere”) in una determinata
situazione possibilità e alternative trascurate o sfuggite alla considerazione comune.
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
modificano in questo modo schemi consolidati (che guidano e orientano comunque il
pensiero e la ricerca dell’esperto), attivando un processo che va dal mero adattamento
(comunque mai passivo) degli schemi stessi fino, in certi casi, alla loro reinvenzione
(l’esperto è tale non solo perché può e sa utilizzare vasti e collaudati repertori di saperi
accumulati e organizzati nel tempo, ma anche perché è capace di forgiarne e strutturarne via via di nuovi). Esiste insomma un uso adattivo ed uno creativo (o generativo) dell’intuizione. Generalmente, fra l’uno e l’altro non c’è salto, ma passaggio più o meno
graduale;
2. Il senso critico è l’abilità nel mettere in atto strategie di controllo e di falsificazione
delle ipotesi di partenza. La trappola che il senso critico punta a neutralizzare è quella
di fissarsi sulle assunzioni iniziali e di cercarne a tutti i costi conferme (il meccanismo di fissazione, ben studiato dalla psicologia cognitivista, è all’origine degli errori o
delle illusioni concettuali, così comuni nella vita pratica, da cui scaturiscono, a loro
volta, decisioni sbagliate), trascurando i casi e gli indizi che potrebbero invalidarle (è
tipico del giurista, dell’avvocato e dell’investigatore di non eccelsa vaglia – per non
dire mediocre – sforzarsi solo di trovare pezze d’appoggio alla tesi sostenuta, evitando
di immaginare seri casi falsificanti della propria impostazione, e di confrontarsi con
essi). Se, da un lato, l’intuizione alimenta l’attitudine all’esplorazione e la duttilità
nella ricerca, il senso critico guida l’indagine, mettendo a fuoco le ipotesi da vagliare,
ed evitando così che essa proceda alla cieca o sulla base di impostazioni rigide e di
atteggiamenti pregiudiziali.
3. Quale ruolo ha nella strutturazione dei problemi la padronanza linguistica? Stabilire
una equivalenza perfetta tra il pensiero e il linguaggio è sicuramente eccessivo (è comune esperienza quella di dovere spesso faticare per riuscire ad esprimere appropriatamente ciò che si agita nella mente, il che vuol dire che c’è uno scarto fra quello che – pur
confusamente – pensiamo, e quello che riusciamo, almeno inizialmente, a verbalizzare:
uno scarto, appunto, fra pensiero e linguaggio, che, oltre ad essere comprovato da questa
difficoltà di traduzione interna da pensieri a parole, è dimostrato anche da un altro fatto,
comunissimo, costituito dalla traduzione di parole da una lingua all’altra, operazione,
questa, assolutamente inspiegabile se non si presupponesse un contenuto di pensiero in
qualche modo comune alla lingua di partenza e a quella di arrivo, e che non costituisce
quindi – né con l’una né con l’altra – un tutt’uno indistinguibile e inseparabile). Ma se
tutto questo è vero, è altrettanto vero che il linguaggio non è un semplice rivestimento
esteriore, un involucro di un pensiero già in sé formato (fino a che non riusciamo ad
esprimere quello che abbiamo in testa, il contenuto mentale, lungi dall’essere in sé ben
definito, è invece – come abbiamo appena notato – confuso, tanto da trarne una sensazione di disagio). In poche parole, la sostanza intima del pensiero si plasma nell’atto
stesso in cui il linguaggio vi dà forma e la conclusione è che il dinamismo intellettivo è
fortemente condizionato dalla competenza linguistica. Questo vale certamente nella
individuazione iniziale del problema, così come vale nelle successive fasi della sua
messa a fuoco e della strutturazione delle possibili soluzioni.
4. La competenza intellettiva non è una monade senza porte, né finestre. L’intuito e il
senso critico hanno una stretta interrelazione con le competenze extraintellettive,
67
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
68
come la tensione al risultato, l’iniziativa, l’orientamento all’altro e la passione per il
lavoro. Queste competenze, che esprimono la dimensione emozionale della vita
organizzativa (rappresentano l’intelligenza emotiva, per citare un’espressione ormai
entrata nell’uso comune), contribuiscono alla selezione dei problemi che formeranno
oggetto del pensiero analitico. In particolare, giocano qui la tensione al risultato e la
passione per il lavoro, che infondono la motivazione e l’energia necessarie per
affrontare l’onere gravoso dell’impresa cognitiva (cercare dati, verificarli, organizzarli sistematicamente, ecc. è faticoso, e non sono quindi attività compatibili con la
pigrizia che non ama “la fatica del pensiero”). E gioca inoltre l’orientamento all’altro,
che suscita e alimenta la “sensibilità dialogica” o “dialettica”, indispensabile per
porsi – nella costruzione del discorso e nell’articolazione dei suoi snodi – le
“domande giuste”, quelle cioè mirate a prevenire possibili problemi, preoccupazioni
ed obiezioni dell’interlocutore (sia egli il capo, il collega, il collaboratore o l’utente).
Di fatto, il bravo funzionario con elevato dinamismo intellettivo è quello che non si
fa sorprendere – o si fa sorprendere di rado – con osservazioni del tipo: “Ma come è
possibile che non ti è venuto in mente che …”, “Come hai fatto a trascurare il fatto
che …”, “Non hai pensato che scrivendo così, avresti indotto in errore o in equivoco
chi legge o ti saresti attirato queste critiche…”, ecc.52.
1.2 Il dinamismo intellettivo come capacità di strutturare problemi
e di risolverli. Il “Problem IS-Solving”
Alla fase iniziale (e decisiva) di individuazione del “vero” problema, seguono
quella della sua strutturazione (esplicitazione dei termini costitutivi del problema, organizzazione logica dei loro rapporti interni e definizione delle loro relazioni esterne con il
contesto di riferimento) e infine la fase della sua soluzione. Se, nella prima fase, è dominante l’intuizione (nel senso prima specificato), nelle altre esercita un ruolo preponderante la capacità di costruzione concettuale (e quindi anche linguistica) del discorso e di
ordinamento gerarchico dei pensieri53. Solitamente ci si riferisce alla competenza intellettiva utilizzando l’espressione inglese Problem Solving. Ma abbiamo visto che non conta solo il Solving, ma anche – e ancor prima – contano le operazioni di Identifying (individuazione) e Structuring (strutturazione) del problema. Sicché il neologismo Problem
52 Enumerare queste eventuali osservazioni critiche (almeno le principali), stabilirne la frequenza nel tempo
e graduarle in ragione della loro significatività (per l’importanza e la delicatezza della questione trattata,
per la rilevanza dell’interlocutore, ecc.), prendendone nota in una sorta di “diario di bordo”, rappresenta
certo per il valutatore, almeno all’inizio, un esercizio faticoso (l’abitudine però ne alleggerirà via via il
peso), e tuttavia proficuo, perché le annotazioni costituiscono (anche in un eventuale contenzioso) attendibili misuratori, seppure in negativo, del dinamismo intellettivo. Ribaltando in positivo il concetto, si può
affermare che il funzionario valido sotto l’aspetto intellettuale è quello i cui prodotti sono soggetti a basso
o nullo riciclo di lavorazione, elemento, questo, su cui si tornerà più avanti (p. 79).
53 Il concetto di “gerarchia logica” non si riferisce a un’idea di razionalità aprioristica e astratta (che è un non
sense, perché la razionalità è per sua natura strumentale), ma all’esigenza di un ordine espositivo dei concetti adeguato a far comprendere il più agevolmente possibile allo specifico interlocutore cui il testo è
diretto il senso di ciò che si vuole affermare.
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
IS-Solving, se pure suona strano, non sarebbe affatto inappropriato a rappresentare più
compiutamente nella sua complessità il dinamismo intellettivo.
Attenzione particolare va posta al concetto di “strutturazione” di un problema 54,
ricordando il detto ricorrente secondo cui la soluzione di un problema sta in larga
misura nel modo in cui lo si rappresenta. Di fatto, l’analisi delle grandi innovazioni
scientifiche e tecnologiche mostra chiaramente che esse appaiono quando elementi che
erano già ampiamente noti vengono riconfigurati o ricombinati (cioè, appunto, strutturati) in un modo nuovo e inedito. Quali forme assume questa strutturazione o ristrutturazione concettuale di un problema? Molto varie, e non è questa la sede per tentarne
una catalogazione. Ma per indicare qualche criterio valido a misurare la natura e la portata di questo fondamentale processo intellettivo, basterà qui osservare che la nostra
esperienza conoscitiva consiste essenzialmente – ne siamo o no consapevoli – nell’ordinare in classi (“classificare”, come si dice normalmente, o anche “categorizzare”) gli
oggetti che percepiamo (oggetto va preso in questo contesto in senso lato, in quanto
include eventi, situazioni, rapporti tra persone, modelli di comportamento, eccetera). Il
punto però è che la stessa entità può essere concepita come appartenente a classi diverse. Un cubo di legno rosso55 si può considerare un componente della classe di tutti gli
oggetti rossi, della classe dei cubi, della classe degli oggetti di legno, della classe dei
giocattoli, eccetera. Dipende in gran parte non da presunte “verità ultime, immutabili e
oggettive” ma dalle circostanze contingenti e dalle opinioni storicamente dominanti il
fatto di prendere in considerazione, trascurare, preferire, temere, ecc. una attribuzione
di appartenenza di classe fra le tante possibili. Ma una volta che l’opinione dei più
abbia deciso che qualcosa ha un particolare significato o valore e si deve quindi inquadrare in una classe piuttosto che in un’altra, è molto difficile accettare (e far accettare)
che questo “qualcosa” venga invece fatto appartenere ad una classe diversa anche se
ugualmente valida. Nel superamento di questa difficoltà sta l’impresa o innovazione
intellettiva rappresentata dalla strutturazione o ristrutturazione di un problema, che in
genere si risolve appunto nello spostamento o cambiamento di “classe di appartenenza” di un oggetto nel senso lato prima descritto. E l’innovazione intellettiva apre, a sua
volta, la strada all’innovazione organizzativa (ciò già di per sé giustificherebbe lo spazio che in questo manuale viene dato all’analisi del dinamismo intellettivo), come
appare ad esempio in quella scelta decisiva di “cambio di classe di appartenenza” che
si effettua quando un oggetto (una data situazione) viene spostata dalla classe dei “vincoli” a quella delle “opportunità”56.
54 Herbert A. Simon, Le scienze dell’artificiale, trad. it. Bologna, il Mulino, 1988, p. 164.
55 L’esempio è ripreso da P. Watzlawick, J.H. Weakland, R. Fish, Change. Sulla formazione e la soluzione dei
problemi, trad. it. Roma, Astrolabio, 1974, p. 106.
56 Esemplare, a questo proposito, il caso dell’IKEA, azienda svedese leader mondiale nell’arredamento domestico, la cui idea di business si fondava in origine su una formula già abbastanza innovativa (la vendita per
posta), ma che non era certo sofisticata come sarebbe poi diventata in seguito. In larga misura, il progetto di
business finale emerse dall’aver affrontato e gestito le avversità (cioè eventi inclusi nella classe dei “vincoli”, per riprendere l’ordine di concetti esposto nel testo). Poiché il sistema di fornitura dei mobili esistente
69
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
FOCUS: la ristrutturazione di un problema come chiave della sua soluzione
70
Sono molteplici gli esperimenti della ricerca cognitivista che dimostrano come la
soluzione di un problema (specie se complesso) possa talora scaturire o sia fortemente facilitata non dall’acquisizione di nuovi dati ed elementi, ma da un’opportuna ricombinazione o da una diversa rappresentazione di quelli già noti. Proprio
questo è ciò che si chiama “riformulazione del problema” (definita talora, nel linguaggio corrente, “colpo di genio”). Il vantaggio che ne deriva può essere, ad esempio, quello di mettere in luce – grazie alla “rotazione prospettica” operata – un isomorfismo di base fra il problema in esame ed altri problemi già affrontati in passato
e della cui soluzione ormai si dispone. Un altro vantaggio (ma la casistica è assai
varia) derivante dalla riformulazione di un problema può essere quello di dissolvere la gabbia di vincoli o di condizioni che il problema sembrava presentare (ma che
in realtà non aveva) nella precedente prospettazione. Un caso del genere è costituito dal cosiddetto problema dei 9 punti (che è una versione più sofisticata del celebre problema dell’uovo di Colombo). Consiste nel collegare i 9 punti sotto rappresentati con quattro linee rette senza sollevare la matita dal foglio:
• • •
• • •
• • •
I punti, così come disposti, sembrano raffigurare un quadrato e questa rappresentazione, cui inconsapevolmente soggiace l’osservatore, induce a ritenere che la
soluzione si debba trovare tracciando le linee senza uscire dal quadrato stesso.
Condizione, questa, che non è affatto richiesta dal problema e che tuttavia le persone alle prese con esso finiscono per autoimporsi, precludendosi così la possibilità di arrivare alla soluzione. Che è invece abbastanza facile, una volta sgombrato
il campo da quella presupposizione non necessaria (la soluzione del problema è
riportata più avanti).
in Svezia metteva con le spalle al muro le aziende che producevano per l’IKEA, Ingvar Kamprad, il fondatore dell’azienda, dovette rivolgersi a dei produttori stranieri, scoprendo così i benefici del subappalto e
del conferimento sistematico delle attività a dei contesti di produzione a basso costo (nella definizione del
problema di business dell’IKEA, questo fu il primo salto dalla classe dei vincoli a quella delle opportunità). Ma non finì qui. Si racconta che quando venne aperto il primo magazzino IKEA, alla periferia di Stoccolma, la fila di clienti era così lunga che l’azienda perse il controllo della situazione e la folla fece irruzione all’interno per impossessarsi direttamente dei mobili esposti. Quell’evento venne poi riclassificato creativamente e portò al trasferimento sistematico delle attività ai clienti. Oggi l’IKEA reclamizza nel catalogo
la sua business idea come divisione specifica del lavoro fra l’azienda e il cliente (il caso è descritto da
Richard Normann nel libro Ridisegnare l’impresa. Quando la mappa cambia il paesaggio, trad. it. Milano,
Etas, 2002, p. 72).
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
Ecco un altro caso: il problema del treno e del gabbiano, cui si riferisce l’immagine di seguito riprodotta57.
71
100 miglia orarie
25 miglia orarie
25 miglia orarie
50 miglia
Due stazioni di una linea ferroviaria della costa orientale dell’Australia distano
fra loro 50 miglia. È un giorno di sabato del 1927. Alle 14 due treni partono dalle
due stazioni l’uno in direzione dell’altro. Nell’istante in cui i due treni partono,
un gabbiano spicca il volo dal primo treno verso il secondo. Quando il gabbiano
raggiunge il secondo treno, torna indietro verso il primo e continua così finché i
treni non si incontrano. Se entrambi i treni viaggiano a 25 miglia all’ora (la velocità è modesta e questo consentirà ai macchinisti di frenare in tempo, evitando lo
scontro fatale) e il gabbiano a 100 miglia all’ora, qual è la distanza percorsa dal
gabbiano nel momento in cui i due treni si incontrano?
Soluzione del problema del treno e del gabbiano
Come tutti i problemi reali, il problema appena esposto contiene una serie di dettagli suscettibili di sviare o focalizzare “inopportunamente” l’attenzione, nel senso che possono condurre a impostare la questione in modo tale da renderne subito assai difficoltosa o persino impossibile la soluzione. A parte alcuni dettagli
non significativi di cui è facile sbarazzarsi subito (come la linea ferroviaria costiera, il fatto che sia in Australia, la partenza dei treni il sabato, ecc.), l’elemento
“stregante” è rappresentato dal movimento di andirivieni del gabbiano da un treno all’altro che tende a far immaginare la soluzione del problema come il risultato di una complicata sommatoria dei tanti tratti di andata e ritorno che il gabbia-
57 Il problema è ripreso, con qualche variazione solo nella forma narrativa, da J.M. Darley, S. Glucksberg, R.
A. Kinchla, Fondamenti di Psicologia, trad. it. Bologna, il Mulino, 1998, p. 222. Nello stesso testo viene
descritto il problema dei 9 punti (p. 226), che è anche illustrato in P. Watzlawick, J.H. Weakland, R. Fish,
Change. Sulla formazione e la soluzione dei problemi, cit., p. 41.
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
72
no compie fino a che i treni non si incontrano. Un calcolo del genere appare
quanto mai arduo, considerato che i tratti da sommare non sono uguali, ma via
via più piccoli mano a mano che i treni si avvicinano.
Quale potrebbe essere una riformulazione del problema utile a facilitarne la soluzione? Un suggerimento che viene dall’euristica è quello di intervenire sul cosiddetto stato iniziale del problema (euristica significa “metodologia di ricerca di
soluzioni”; deriva dalla parola greca “heurísko” ‘trovo’. La mossa decisiva sta nel
trasformare così la domanda di partenza: non più “qual è la distanza percorsa dal
gabbiano?” ma “per quanto tempo volerà il gabbiano?”. Evidentemente volerà
fino al momento in cui i treni si incontrano. E quando si incontreranno i treni? Se
entrambi hanno un’identica velocità – 25 miglia all’ora – e la distanza fra le due
stazioni è in tutto 50 miglia, è chiaro che passerà un’ora prima che i treni si
incontrino a mezza strada: il treno A in un’ora avrà percorso 25 miglia e così
anche il treno B. Sommati insieme i due tratti fanno 50 miglia, che è per l’appunto la distanza fra le due stazioni. Ebbene: se i due treni viaggeranno in tutto per
un’ora prima di incontrarsi, anche il gabbiano volerà per un’ora e poiché egli vola
alla velocità di 100 miglia all’ora, la distanza percorsa dal gabbiano quando i treni
si incontreranno sarà proprio 100 miglia. Riformulando la domanda iniziale, la
soluzione è diventata molto facile. Qualcuno ha detto che per capire che una
risposta è sbagliata non occorre un’intelligenza eccezionale, ma per capire che è
sbagliata una domanda ci vuole una mente creativa. Claude Lévi-Strauss, il grande antropologo francese, affermava che “lo scienziato non è l’uomo che fornisce
le vere risposte. È quello che pone le vere domande”.
1
4
2
Soluzione del problema dei 9 punti
3
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
1.3 La rilevazione del dinamismo intellettivo
Criteri di rilevazione
Nel processo che per comodità di sintesi abbiamo denominato con il neologismo
Problem IS-Solving, la competenza intellettiva si può analizzare con sufficiente oggettività mediante criteri che individuino i diversi aspetti significativi dei prodotti tipici dei
processi lavorativi in cui si è impegnati (risposte a quesiti, relazioni, appunti, note, verbali di verifica, motivazioni di atti quali ad esempio quelli di accertamento, ecc.). I criteri
da applicare sono tre: chiarezza ed efficacia, congruenza, innovatività.
Chiarezza ed efficacia
Cosa significhi “chiarezza” sembrerebbe domanda futile, tanto ne appare evidente
il senso. E parrebbe, del resto, paradossale che ad essere oscura sia proprio la nozione di
ciò che debba intendersi con la parola “chiaro”. Ma, ammesso che questo sia vero (forse,
però, nulla è più vago e sfuggente di ciò che appare ovvio), come si fa ad oggettivare e
“misurare” il concetto di chiarezza, almeno nel contesto di una organizzazione? Una
definizione operativa di chiarezza, calibrata sulla pratica degli uffici, può essere questa:
un testo è chiaro se il lettore cui è rivolto non vi inciampa ad ogni piè sospinto e non è
costretto perciò ad interromperne in continuazione la lettura, per chiedersi, fra lo smarrito e l’irritato, cosa l’autore abbia “voluto dire”. Se il numero delle interruzioni (cui spesso si accompagna l’apposizione energica di un punto interrogativo accanto ai paragrafi
d’inciampo) è nullo o è ridotto, il testo è molto chiaro o comunque abbastanza chiaro. Se
il numero è invece alto, il testo è oscuro. In altri termini, come criterio oggettivo di misurazione della chiarezza, si potrebbe introdurre il concetto di frequenza di stop di lettura,
che sono le “oscurità” in cui inciampa il lettore scorrendo il testo58.
Ma perché viene fatto riferimento, nella definizione di chiarezza appena data, al
concetto di “lettore cui il testo è rivolto”? Perché non c’è un testo chiaro in assoluto. La
sua comprensibilità dipende dalla situazione specifica del destinatario, e cioè anzitutto
dalle conoscenze di cui questi dispone, ma anche dagli interessi da cui è mosso, dai punti di vista che lo influenzano, dalle questioni che lo preoccupano. Prefiggersi l’obiettivo
della chiarezza significa preliminarmente – se ne abbia o no consapevolezza – formulare
58 Volendo fornire un’indicazione solo a titolo orientativo, si potrebbe aggiungere che, se non più del 5% dei
testi prodotti dal valutato presenta stop di lettura, la sua prestazione di lavoro è assai apprezzabile sotto il
profilo della chiarezza comunicativa. Naturalmente, è possibile che il testo che io, valutato, considero
chiaro come acqua di sorgente (la capacità di autocritica è una difficile conquista personale) può sembrare
invece oscuro all’altro che lo legge (nella specie, al mio valutatore). Tutto questo però non inficia l’oggettività della valutazione, se deve intendersi per oggettività ciò che è suscettibile di controllo intersoggettivo.
E qui la possibilità di tale controllo c’è sicuramente. L’eventuale controversia sulla chiarezza del testo prodotto viene infatti ad ancorarsi ad una evidenza perfettamente controllabile da altri soggetti qual è appunto
ciò che il capo ha contrassegnato come “stop di lettura”. Sarà cura del valutatore, per corroborare i propri
giudizi, raccogliere un campione significativo di tali evidenze. Dopo di che, siccome non è lui solo a valutare, in caso di contenzioso si stabilirà, con le previste procedure di riesame della valutazione, chi ha torto
e chi ha ragione.
73
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
74
una presupposizione su che cosa il destinatario del messaggio sappia già (o possa già
sapere) sui contenuti di quel messaggio o sappia già farne. Si dice che i grandi giornalisti
americani crescevano ad una scuola dura che aveva, tra le sue regole essenziali, quella di
scrivere “pensando al lattaio dell’Ohio”59. La regola comportava una chiara opzione di
fronte ad una scelta che è in ultimo etica: decidere su chi deve gravare prevalentemente
il peso della fatica del pensiero. Sul lettore, obbligandolo ad addossarsi la fatica di comprendere, o invece sull’autore, impegnandolo a caricarsi della fatica di spiegare (si sa,
anche se talora lo si dimentica, che è molto facile essere oscuri e complicati, mentre è
molto difficile – cioè assai oneroso in termini cognitivi – essere chiari e semplici60). Certo quella regola era enfatica e, a pensarci bene, persino improponibile. Seguendola alla
lettera, gli articoli di quei giornalisti avrebbero dovuto avere un taglio troppo elementare
per l’opinione colta cui pure si rivolgevano. Oppure avrebbero dovuto contenere – per
far capire tutto al lattaio – chiose e spiegazioni di ogni genere, finendo così per risultare
pesanti e noiosi (cosa che nessun giornalista di razza è disposto ad accettare). E tuttavia
l’ideale regolativo di chiarezza predicato da quella scuola funzionava. Ne sono testimonianza articoli di straordinaria bravura, che affrontavano con acume e profondità argomenti complessi e importanti e, al tempo stesso, venivano unanimemente giudicati
modelli di prosa cristallina. Un giudizio analogo circondava e circonda gli scritti di Hans
59 Il motto: “Cerco di scrivere in modo che mi possa capire anche un lattaio dell’Ohio” era di Webb Miller, un
giornalista dell’United Press, una delle più grandi agenzie di stampa del mondo. Miller è famoso per un
suo articolo, che ebbe risonanza vastissima, sulla spietata repressione da parte della polizia coloniale
inglese di una manifestazione non violenta organizzata in India dal movimento di Gandhi. Il 21 maggio
1932, mentre Gandhi era in carcere, presso le saline di Dhrasana duemilacinquecento manifestanti guidati
da una donna, Sarojini Naidu (era una poetessa cui Gandhi aveva affidato la direzione del movimento
mentre era in carcere), si avvicinarono pacificamente alla polizia. D’improvviso, a un ordine secco, schiere
di poliziotti si gettarono sui manifestanti e cominciarono a colpirli con manganelli rivestiti di acciaio. “Da
dove mi trovavo” – scrisse Webb Miller – “udivo il suono tremendo dei randelli sulle teste non protette. La
folla dei dimostranti in attesa guardava la scena, gemendo e trattenendo il respiro, sentendo su di sé ogni
singolo colpo. Quelli caduti a terra giacevano privi di sensi o si torcevano con il cranio fratturato e le spalle
spezzate. Quelli ancora incolumi, senza rompere i ranghi, continuarono silenziosamente ad avanzare finché furono tutti abbattuti. Marciavano compatti, a testa alta, senza l’incoraggiamento della musica e degli
applausi e senza alcuna possibilità di potersi sottrarre a gravi ferite e forse alla morte. La polizia arrivava a
ondate e metodicamente colpiva una colonna dopo l’altra. Non ci fu battaglia, né lotta, essi avanzavano
semplicemente fino a quando cadevano. La polizia cominciò a prendere selvaggiamente a calci gli uomini
seduti per terra, colpendoli all’addome e ai testicoli. Alle undici del mattino il caldo era arrivato a 46 gradi
e l’assalto si placò”.
Miller andò nell’ospedale dove erano ricoverati i feriti, molti ancora privi di sensi, altri che si torcevano
dal dolore: ne contò 320, due erano morti. Le autorità inglesi vinsero la “battaglia” ma la storia di quell’episodio fece il giro del mondo, perché Miller scrisse un servizio che fu ripreso da oltre mille giornali in America e all’estero. La violenza della polizia inglese sollevò l’indignazione generale, persino in Inghilterra. In
tutte le regioni dell’India riaccese il risentimento più profondo e rese ancora più determinata la lotta per
l’indipendenza. Alla fine i vincitori risultarono i perdenti e gli sconfitti vinsero. Dietro quella vittoria c’era
stato anche il lavoro onesto e coscienzioso di Webb Miller, il giornalista che scriveva pensando a come farsi capire anche da un lattaio dell’Ohio.
60 C’è una frase di Galileo, riportata in epigrafe alla prefazione del Manuale di scrittura amministrativa dell’Agenzia delle Entrate, che dice così: “Parlare oscuramente lo sa fare ognuno, ma chiaro, pochissimi”.
Il manuale è pubblicato nel sito web dell’Agenzia: http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/
Documentazione/Pubblicazioni/Le+guide+dell%27Agenzia/Guide+anni+precedenti/2005/scrittura+
amministrativa.
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
Kelsen, considerato da molti il più grande giurista di tutti i tempi. Riusciva ad esprimere
con grande nitidezza concetti ardui e difficili rendendoli comprensibili anche a un pubblico di non specialisti. Se ne può trarre un secondo criterio di misurazione della chiarezza. Quando l’argomento affrontato è complesso, e ciò nonostante l’autore, senza concessioni e sconti sul piano del rigore e della precisione, riesce a farsi capire anche da lettori non specialisti, allora questo è un segno di grande chiarezza61.
Passiamo ora alla nozione di “efficacia”. La domanda è se essa coincida o no con la
“chiarezza”. Ad una prima analisi le due parole sembrerebbero equivalenti, quasi a formare una semplice endiadi. Se lo scopo dell’autore è infatti quello di riuscire a far capire
al lettore ciò che intende comunicargli, un testo chiaro raggiunge sicuramente tale scopo
e quindi, in questo senso, è efficace. Ma si può anche sostenere che l’efficacia è qualcosa
di più rispetto alla chiarezza. Un testo è chiaro se non fa inciampare il lettore e lo lascia
procedere spedito sino alla fine. È efficace se riesce ad “avvincerlo” subito e a catturarne
l’attenzione sino al termine della lettura. In un certo senso, la chiarezza è la comprensibilità vista in negativo (assenza di fattori di ostacolo alla comprensione), l’efficacia è la
comprensibilità vista in positivo (presenza di fattori di rinforzo della comprensione). A
parità di chiarezza, un testo efficace impegna per meno tempo la risorsa scarsa dell’attenzione del lettore, ma viene compreso più rapidamente e riesce a rimanere impresso assai
più a lungo nella memoria. Se si afferma, ad esempio, che nelle famiglie i contrasti tra
fratelli sono quasi sempre più accesi di quanto non siano quelli fra estranei, si formula
un enunciato sicuramente chiaro (che, ovviamente, potrà essere o no condiviso a seconda dei punti di vista). Ma se poi si citasse, in alternativa o anche in aggiunta, il detto di
Totò secondo cui “i parenti sono come le scarpe: più sono stretti e più fanno male”, ecco
che l’enunciato, oltre ad essere chiaro, sarebbe anche assai efficace, per come riesce a
calamitare l’attenzione di chi ascolta e a rimanervi impresso. Non si insisterà mai abbastanza sull’importanza che assume in un’organizzazione la capacità di comunicare con
incisività (in questo contesto tale parola è un sinonimo di “efficacia”). Il bene più scarso
è alla fine proprio il tempo, e quello dei capi lo è ancora di più. Il funzionario bravo è
quello che riesce a comunicare economizzando al massimo e col maggiore beneficio possibile la limitata “risorsa di attenzione” di cui il proprio capo dispone62.
Si può apprendere a comunicare con chiarezza ed efficacia? Sicuramente sì, senza
per questo voler negare l’influenza di possibili predisposizioni individuali (ma Flaubert
diceva che il lavoro di uno scrittore è solo per il 10% ispirazione e per il restante 90% è
sudore). In un’amministrazione pubblica il registro comunicativo è quello dell’informa-
61 In un contesto organizzativo, questo significa che un testo è molto chiaro se il valutatore, pur sapendone
molto meno, nello specifico argomento, del funzionario che lo ha redatto riesce lo stesso a seguire agevolmente il filo dell’esposizione, senza essere costretto a ricostruirselo tutto da sé, mettendo mano all’intera
documentazione contenuta nel fascicolo.
62 Si è appena detto che l’efficacia è qualcosa di più della chiarezza. È possibile che a volte sia qualcosa di
meno? In altri termini: si può essere efficaci senza essere chiari? Purtroppo sì. Il messaggio di imbonimento
(ai più diversi fini) e la prosa oracolare, che spesso riescono a fare straordinaria presa sui destinatari, stanno a dimostrarlo. Fortunatamente si tratta di forme di comunicazione interdette alle amministrazioni pubbliche (che non è detto, tuttavia, rispettino sempre tale divieto).
75
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
76
zione e della argomentazione, che richiedono essenzialmente conoscenza e capacità di
apprendere e ragionare, qualità fortunatamente assai più diffuse e comuni di quanto non
sia, ad esempio, la disposizione all’inventio letteraria, indispensabile per altri registri
comunicativi, quali la narrativa, la poesia, ecc. (anche se pure queste forme espressive
sono almeno in parte suscettibili di apprendimento, come dimostra, ad esempio, l’esistenza di scuole di scrittura creativa). Si tratta di praticare, individualmente e collettivamente, un lavoro paziente e metodico di affinamento della scrittura, confrontandosi con
le best practice (i testi additabili come modelli di chiarezza e di efficacia) e le worst practice (le pratiche comunicative oscure, astruse e farraginose).
Denotano un marcato orientamento alla chiarezza e all’efficacia:
• l’attenzione ad evitare costruzioni di frasi goffe, pesanti, sgraziate e maldestre, che
denotano l’assenza più o meno grave di scioltezza espressiva ed urtano la sensibilità
del lettore attento ed esigente (rientra, ovviamente, nel canone appena indicato anche
il rispetto delle regole grammaticali e sintattiche, la cui osservanza costituisce il requisito minimo della scorrevolezza discorsiva);
• la ricerca della ricchezza e della brillantezza espressiva (importante, a questo riguardo,
è l’uso intelligente delle metafore, che può aiutare a rappresentare le cose con immediatezza ed espressione vivida), senza indulgere a leziosità, divagazioni ed abbellimenti discorsivi, ed evitando tecnicismi ed espressioni burocratiche non strettamente
necessari nel contesto di riferimento;
• lo sforzo di capire quale sia, nella specifica questione affrontata, lo stato delle conoscenze del destinatario del testo (tale elemento è indispensabile per stabilire dove
occorre insistere e dove si può invece sorvolare) e di comprenderne il punto di vista,
gli interessi, i possibili interrogativi e le attese, in modo da prevenire fraintendimenti e
dirigere opportunamente l’attenzione del lettore sui punti cui si annette maggiore rilevanza, facendogli capire subito “dove si vuole andare a parare”;
• la cura attenta del ritmo e dei tempi nella modulazione del flusso informativo e nella
scansione del percorso argomentativo, evitando di abbondare, là dove occorre invece
sfrondare, e di tirare invece via frettolosamente, là dove, al contrario, occorre soffermarsi (due sono gli errori da cui occorre specialmente guardarsi: un affastellamento di
dettagli che, nello specifica situazione comunicativa, sono inutili e irrilevanti e producono solo l’effetto di stancare il lettore sovraccaricandone la memoria di lavoro e
sviandone l’attenzione oppure un’omissione di spiegazioni e di particolari che, nel
contesto comunicativo, sono invece indispensabili al destinatario o servono comunque ad agevolargli la comprensione del testo)63.
63 Come per ogni altra caratteristica, anche la chiarezza e l’efficacia sono descrivibili, oltre che in positivo,
anche in negativo, nel senso che accanto alle manifestazioni della presenza di tali qualità, si possono evidenziare anche quelle della loro assenza. In questo senso un testo privo di chiarezza e di efficacia si caratterizza per l’inconfondibile “effetto melassa” generato al suo interno dal goffo affastellamento di concetti
mal definiti o solo appena abbozzati, che denotano scarsa padronanza della materia o comunque povertà di
riflessione.
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
Congruenza
È un’ampia categoria valutativa che riguarda il processo di combinazione del
raziocinio e delle conoscenze, ossia il processo mediante il quale la logica viene applicata alle conoscenze di cui si dispone. Comprende giudizi di uso comune come “illogico” oppure “poco sensato” oppure ancora “sbagliato”. In sostanza, quando si parla di
“congruenza”, ci si riferisce sia alla “défaillance” sotto il profilo strettamente logico
(l’esempio più vistoso è la contraddizione), che allo “strafalcione” sotto il profilo conoscitivo (tipico indice di un difetto di sapere tecnico). Come si è più volte osservato, il
metodo utilizzato nella costruzione del modello Antares non è quello di “inventare”
categorie valutative, ma semmai di “scoprirle”, cioè di far emergere dall’esperienza quotidiana, scavandovi dentro con l’analisi e la riflessione, categorie valutative già di fatto
praticate e che richiedono però di essere depurate da connotazioni meramente soggettive nella loro genericità, approssimazione ed ambiguità (è il concetto di “codificazione
di saperi e vissuti quotidiani” cui si è fatto riferimento nella introduzione a p. 14). Non
appena si incomincia questo “scavo riflessivo”, appare subito evidente che quando si
afferma, molto sbrigativamente, che il concetto di “bravura professionale” è fatalmente
soggettivo, l’indicatore “congruenza” sta lì a dimostrare che quell’affermazione contraddice la quotidiana esperienza di lavoro. Un accertamento fiscale ben costruito e argomentato, che ha ottime probabilità di resistere in sede contenziosa, si distingue nettamente da un accertamento mal motivato che gli stessi interessati si vergognano di andare a difendere in commissione tributaria.
Riassumendo, ragionare in modo congruente significa:
a) in negativo, evitare incoerenze logiche nell’argomentazione o comunque affermazioni
che – pur senza costituire vere e proprie contraddizioni – risultino però scarsamente
plausibili in termini di ragionevolezza (ad es. le generalizzazioni indebite o le affermazioni arbitrarie) oppure – sic et simpliciter – errate in quanto contrastanti con dati o
nozioni di comune evidenza o che si sarebbe comunque tenuti a sapere per il ruolo
ricoperto;
b) in positivo, produrre prove e inferenze valide e pertinenti. In altre parole, costruire
dimostrazioni che “filino” sotto il profilo logico e che siano appropriate alle questioni
in esame.
La “congruenza” non va ovviamente confusa con la “chiarezza”: quest’ultima
significa comunicare in modo tale da far capire subito quello che si vuole dire. Se poi
quello che si dice è anche congruente, è questione diversa64.
64 È opinione comune che la scarsa chiarezza serva spesso, se non a celare l’illogicità o l’inconsistenza del
proprio discorso, quanto meno a premunirsi dal rischio che qualcuno possa agevolmente scorgervi pecche
di tal genere. Per questa ragione, nelle organizzazioni che premiano a fatti e non a parole l’assunzione (non
temeraria ma responsabile) di rischi e il coraggio (senza l’una e l’altro non v’è possibilità di autentica innovazione), l’abitudine alla chiarezza è un comportamento che merita sempre e comunque di essere apprezzato e incoraggiato.
77
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
Espressioni significative di “congruenza” nei diversi tipi di attività
Nelle attività tecnicamente più complesse, una delle espressioni più apprezzabili
di congruenza è l’organicità e la completezza dell’output, mentre nelle altre attività ciò
che in genere fa la differenza è l’accuratezza del lavoro. Analizziamo più in dettaglio
questi subindicatori.
78
• Organicità e completezza
Nei lavori di maggiore complessità (ad esempio, nell’interpretazione di norme
fiscali o nella redazione di atti di accertamento di particolare rilevanza), l’indicatore
“congruenza” raggiunge valori elevati se il prodotto nella sua impostazione complessiva
presenta caratteristiche significative di organicità e completezza o, per usare termini concettualmente affini, di sistematicità e di profondità. In un testo, queste caratteristiche
sono rilevabili nell’impianto complessivo del discorso (essenziale è la strutturazione
nitida dei problemi affrontati), nell’ordine di successione delle parti che lo compongono,
che non deve presentare “salti logici”, “omissioni o cortocircuiti argomentativi”, “ripetizioni” non giustificate da esigenze comunicative di ridondanza65, nella esaustività della
trattazione, che affronta e approfondisce tutti gli aspetti rilevanti delle questioni che
andavano esaminate, soppesando, con rigore e scrupolo critico, punti di forza e di debolezza delle diverse tesi in gioco. La completezza del prodotto è un indice significativo
dell’elevata competenza tecnica e della padronanza del mestiere.
Per citare invece esempi in negativo, difetta di completezza un lavoro in cui – più o
meno bellamente e abilmente – si è trascurato, ad esempio, di prendere in considerazione
obiezioni significative alle proprie tesi. Rivelano, inoltre, carenza di completezza le semplificazioni banali e le analisi superficiali (ne costituiscono esempio i documenti in cui galleggiano come relitti – cioè senza precise relazioni tra loro – concetti vaghi, generici, sfocati o
solo appena abbozzati). Proseguendo nell’inventario dei difetti, denotano assenza di organicità eventuali bilanciamenti maldestri delle diverse componenti del discorso (viene dato
spazio prevalente o comunque eccessivo ad argomenti o considerazioni che ne meriterebbero invece di meno nell’economia del discorso stesso), loop logici, cioè andirivieni che fanno
perdere il filo del discorso, imbrogliandone l’ordito e stordendo il lettore, che avverte una
sensazione penosa di “confusione” e di “mancanza di lucidità” (un prodotto che difetta gravemente di organicità e sistematicità è quello che solitamente viene definito “un guazzabuglio senza capo, né coda”). C’è una coppia di aggettivi che inquadra bene la contrapposizione fra ciò che è organico e sistematico e ciò che non lo è: compatto versus sfilacciato.
• Accuratezza
Un’elevata “congruenza” si manifesta anche nella particolare accuratezza del lavoro,
cioè nella precisione e nella cura dei dettagli (assenza di errori, sbavature o imprecisioni,
65 In testi che affrontano argomenti complessi o poco noti, la ripetizione opportunamente cadenzata e distanziata dei punti chiave del discorso serve a rendere più agevole la comprensione e l’assimilazione dei concetti; le ripetizioni invece non necessarie, oltre ad essere talora anche “brutte”, frastornano la mente del
destinatario che non capisce se l’autore stia dicendo – inutilmente – sempre la stessa cosa o se stia invece
tentando di enunciare – male – qualcos’altro.
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
che, per quanto non essenziali, possono trasmettere nel destinatario un’impressione negativa di sommarietà, approssimazione e perfino sciattezza nel modo di lavorare). L’accuratezza è particolarmente importante nelle attività che, seppure non presentino profili di considerevole complessità tecnica, assumono grande rilevanza per l’ampiezza della platea dei
destinatari (sono tali, ad esempio, in misura significativa, le attività di front-office e di
back-office svolte dagli uffici locali). In queste attività, insomma, la maggiore o minore congruenza si rileva fondamentalmente attraverso la maggiore o minore accuratezza con cui il
lavoro è stato eseguito. Senza timore di esagerare, si può tranquillamente sostenere che dall’accuratezza con cui sono svolte tali attività dipende molto l’immagine di efficienza dei
servizi dell’Agenzia.
Innovatività
Riguarda la dimensione “creativa” del pensiero e sta a significare che il prodotto è
caratterizzato da elementi significativi di novità (nelle ipotesi sostenute, nelle argomentazioni svolte, nelle conclusioni finali, ecc.) rispetto a precedenti soluzioni. Mentre la
chiarezza e la congruenza sono requisiti necessari del prodotto, non ha senso pretendere
sempre che l’output sia anche innovativo. L’innovatività opera quindi solo in positivo. In
altre parole, se il prodotto presenta caratteristiche significative di innovatività, viene ad
esserne ulteriormente valorizzata la prestazione. In caso contrario non se ne tiene conto.
Indicatore sintetico di qualità
Accanto ai criteri analitici di rilevazione qualitativa sopra descritti, c’è un indicatore
sintetico della qualità di un prodotto, ed è quello del riciclo di lavorazione (vi si è fatto già
cenno a p. 68). Così come in una fabbrica l’indicatore di un lavoro mal fatto è la necessità di
ricicli di lavorazione del prodotto, così, negli uffici, una pratica fatta male è quella che
richiede anch’essa “ricicli di lavorazione”, e cioè riscritture e rimaneggiamenti più o meno
estesi, sia dal punto di vista del contenuto che dal punto di vista della nitidezza espositiva (a
quest’ultimo proposito, il Manuale di scrittura amministrativa dell’Agenzia delle Entrate
offre chiari e oggettivi criteri di cosa sia un atto o un documento ben scritto). Dalla frequenza
dei ricicli di lavorazione, e da quanto sono estesi e profondi, dipende la maggiore o minore
qualità del prodotto. Il concetto di “riciclo di lavorazione” consente di trasformare apprezzamenti qualitativi in dati quantitativi, rafforzando l’oggettività del processo valutativo.
Il fattore “complessità del lavoro”
Come analizzare la complessità del lavoro
Nell’esaminare la competenza intellettiva, ci si potrebbe chiedere se gli indicatori
sopra specificati non debbano contare di più, quanto più complesso è il lavoro da svolgere. Un’ipotesi potrebbe, ad esempio, essere quella di moltiplicare il punteggio della prestazione lavorativa per un coefficiente di complessità a più livelli (ad esempio, basso,
medio, alto, molto alto), stabilito in ragione delle singole tipologie di prodotto e del contesto di lavoro, in modo tale che la chiarezza e l’efficacia, la congruenza e l’innovatività
79
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
80
del prodotto finiscano per valere di più, quanto maggiore è la complessità del lavoro proprio della funzione ricoperta.
L’ipotesi può sembrare a prima vista plausibile, ma, a rifletterci un po’, ci si accorge
che non lo è affatto. Essa infatti equivale a sostenere che, se un alunno di una scuola elementare prende, ad esempio, 9 per un dettato senza errori, allora uno studente di un
liceo dovrebbe, in proporzione, prendere almeno 18 per una traduzione da una lingua
straniera anch’essa priva di errori (immaginando, in questo caso, che il rapporto di complessità fra un dettato e una traduzione sia di 1 a 2). In realtà, non c’è nessun bisogno di
adottare scale valutative diverse in ragione della complessità del compito da eseguire. Si
può tranquillamente dare 9 sia all’alunno della scuola elementare che allo studente del
liceo (come del resto si è fatto sempre), senza per questo creare alcuna ingiustizia o
incongruenza. L’identità del voto sta a significare che l’alunno e lo studente sono entrambi molto bravi, ma si tratta di due manifestazioni di bravura che hanno significato ed
effetti diversi, perché diversa è la posizione in cui si trovano gli interessati (una cosa è
frequentare una scuola elementare, un’altra è frequentare un liceo).
L’ipotesi prima prospettata (modificare il calcolo del punteggio della prestazione
lavorativa in funzione della complessità dei compiti propri del ruolo ricoperto) non può
essere quindi accolta. Essa, oltre a complicare la procedura di valutazione della prestazione di lavoro, presenta un’incoerenza di fondo, poiché tende a mischiare l’aspetto della valutazione della prestazione eseguita (cioè la valutazione di come si è eseguito il proprio compito), con quello della prestazione richiesta (cioè la valutazione del cosa va fatto, ovvero del compito da eseguire in relazione alla specifica posizione ricoperta). Si tratta di due aspetti che vanno invece tenuti distinti.
Una soluzione che non incorra negli inconvenienti appena accennati e che, al tempo stesso, dia adeguato riconoscimento alla bravura di chi esegue lavori complessi, può
essere questa:
a) stabilire che, nel calcolo del punteggio della prestazione di lavoro, va attribuito un
peso maggiore all’aspetto qualitativo della prestazione rispetto a quello quantitativo
(la qualità è tanto più importante, quanto più complesso è il lavoro da svolgere);
b) prevedere che la prestazione qualitativamente superiore comporta per l’interessato vantaggi suppletivi, sia in termini retributivi che di sviluppo professionale, quando venga
resa in posizioni che comportano lo svolgimento di attività di lavoro ad alta complessità.
Come definire la complessità del lavoro
Nei discorsi che riguardano la classificazione dell’attività di lavoro, “complesso” e
“complessità” sono sicuramente fra i termini più ricorrenti. Per la loro importanza, è
bene cercare di dare a questi termini un significato meno sfuggente di quello che normalmente hanno. Come al solito, seguendo l’impostazione metodologica del manuale, non si
tratta di “inventare” nuovi significati forzando l’uso linguistico ordinario, ma di far
emergere, grazie all’analisi riflessiva, significati già di fatto da sempre praticati.
Per fare questo, conviene partire dall’affermazione comune secondo cui lavorare è,
essenzialmente, risolvere problemi di lavoro. Del resto, è proprio attorno al concetto di “pro-
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
blema” che si è dipanata tutta la riflessione sul dinamismo intellettivo svolta nelle pagine
precedenti. Ora, qual è una classificazione molto ricorrente dei problemi di lavoro? Quella fra
problemi di routine e problemi non di routine. Un problema non di routine è un problema
per cui non vi sono (o vi sono soltanto in misura non determinante per il caso in esame) soluzioni standard, cioè soluzioni che possono essere ricavate da “precedenti” consolidati (da
questo punto di vista, i problemi di routine si potrebbero anche definire problemi standard).
Ora, se è vero che tutto ciò che non è routine è complesso, sarebbe sbagliato credere che sia invece semplice tutto ciò che è routinario. Una cosa, infatti, è la routine di una
catena di montaggio in una fabbrica di bulloni e un’altra è la routine di una sala operatoria in un centro di trapianti di cuore. In entrambi i casi si applicano routine ben collaudate e sperimentate, ma una differenza c’è, ed anche notevole. Nel secondo caso si tratta
infatti, a differenza del primo, di routine che presuppongono un processo di apprendimento lungo e gravoso e la cui esecuzione richiede profonda concentrazione e notevole
impegno mentale (ma anche grande controllo della manualità nel caso di alcune professioni come quella del musicista o del chirurgo).
In altre parole, le routine non sono tutte uguali. Nell’Agenzia delle Entrate ce ne
sono di facili e di difficili, e la difficoltà è connessa:
• al tipo, all’ampiezza e alla profondità del know-how di cui occorre aver padronanza
per eseguire le routine stesse (know in inglese significa “sapere”, mentre how significa
“come”, sicché know-how – parola che non ha un preciso corrispettivo in italiano – è
la capacità di applicare operativamente il proprio sapere);
• allo sforzo mentale occorrente per l’esecuzione di quelle routine.
Abbiamo a questo punto due coppie di concetti – facile/difficile e standard/non
standard – che ci consentono una prima rappresentazione d’insieme della nozione di
“complessità del lavoro”.
Quadrante della complessità del lavoro
+
Difficile
Know-how
Difficile
Non standard
++
Facile
Standard
--
Facile
Non standard
-+
Facile
Impegno
intellettivo
Difficile
Standard
+-
– Standard
Non standard +
Capacità ideativa & abilità
argomentativa
81
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
Se, per brevità, denominiamo la coppia di concetti “standard/non standard” come
“varianza” e passiamo dal piano grafico a quello dell’analisi discorsiva, la complessità
del lavoro può essere vista come l’effetto combinato di due variabili, fra loro collegate,
della prestazione lavorativa:
• varianza dei compiti;
• difficoltà dei compiti.
82
Varianza dei compiti
Un lavoro complesso può essere considerato, in primo luogo, come un lavoro
caratterizzato da “varianza dei compiti”. L’espressione non sta a indicare “compiti di
contenuto vario” (un lavoro non diventa complesso per il fatto che comprende tante
attività, ma tutte semplici). Compiti che hanno la caratteristica della “varianza” sono
quelli in cui è vario il modo di darvi esecuzione, nel senso che questa non è predeterminata, né predeterminabile mediante schemi rigidi, ma prende di volta in volta forma
concreta solo grazie ad uno sforzo di inventiva e di originalità più o meno intenso.
Come sinonimo di “varianza di compiti” si usa talora, in questo contesto, anche l’espressione “incertezza dei compiti”, che – analogamente – non sta a significare “compiti di contenuto incerto” (vale a dire che non si sa bene cosa siano), bensì compiti di cui è
incerto il modo di darvi esecuzione, nel senso che non è mai perfettamente tracciato, né
tracciabile a priori – risultando così, per l’appunto, “incerto” – il percorso da compiere
per la loro attuazione. Il compito, ad esempio, di definire politiche generali in questa o
in quella materia è in sé concettualmente chiaro, ma assume concreta determinatezza
solo attraverso una elaborazione intellettuale che non si risolve, né si può risolvere, in
operazioni di tipo “copia e incolla”.
Volendo mettere ulteriormente a fuoco il concetto, si potrebbe partire da un’immagine, quella dell’organizzazione come una scala, più o meno lunga, in cima alla quale si
definiscono indirizzi e linee guida generali, che, scendendo di gradino in gradino, si vanno sempre più dettagliando, fino ad arrivare, giunti in fondo alla scala, al gradino dove ci
si limita alla più o meno meccanica esecuzione di semplici routine o di ordini elementari. In cima alla scala la varianza dei compiti, nel senso appena detto, è massima,
mentre alla base è minima.
Per quanto questa visione possa
risentire della tradizionale concezione
dell’organizzazione come piramide gerarchica, è un fatto che, a seconda dei ruoli
ricoperti, significativamente assai diverso può essere lo “spazio di varianza” da
gestire. Non c’è dubbio – per usare un’altra metafora dopo quella della scala – che
anche il solo limitarsi a seguire segnali
indicatori ben precisi non sarà mai un’o-
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
perazione puramente passiva: in un sentiero, seppure ben tracciato, ci possono ugualmente essere buche da evitare, sassi da scansare, terreno sdrucciolevole da aggirare, ecc.
Tutt’altra cosa è però costruire e piantare cartelli e segnali indicatori in un ambiente per
nulla stabile e caratterizzato anzi da elevata turbolenza, qual è quello in cui in genere si
muovono gli interpreti e gli operatori del diritto tributario.
In breve, c’è varianza quando gli output richiesti dal ruolo (atti, provvedimenti,
contratti, pareri, stesura di rapporti, relazioni ed appunti, ecc.) o la dinamica della loro
produzione non sono routinari o comunque lo sono solo limitatamente e non in modo
rilevante (invece di output “routinario”, si può anche dire – sono tutti sinonimi ricorrenti – “standardizzabile”, “proceduralizzabile”, “predeterminabile”, “strutturabile”, ecc.).
Un lavoro ad alta varianza (o incertezza) è un lavoro per il quale l’organizzazione pretende dal titolare del ruolo elevata autonomia di pensiero, con la conseguente impossibilità
per l’interessato di agire come semplice esecutore66.
Indicativamente, si possono distinguere nell’Agenzia delle Entrate quattro livelli
crescenti di varianza dei compiti:
• esecuzione di istruzioni semplici;
• attuazione di procedure operative;
• applicazione di norme (quella che i giuristi chiamano “sussunzione” di casi sotto una
regola di cui è stato previamente chiarito il significato);
• attività di:
– interpretazione di norme (“sussunzione” di casi sotto una regola di cui occorre invece ancora chiarire il significato67 in relazione alle fattispecie concrete rispetto alle
quali occorre provvedere);
– partecipazione al processo di “fabbricazione” delle norme;
– produzione di direttive e istruzioni generali;
– investigazione operativa nei campi d’indagine non di routine.
66 La nozione di “varianza dei compiti” corrisponde a quella che nella metodologia Hay di pesatura delle
posizioni viene definita Thinking Environment (Thinking = pensiero e Environment = ambiente), ossia il
contesto entro cui è chiamato ad operare il pensiero. Dalle caratteristiche del Thinking Environment dipende, a sua volta, la Freedom to Think (libertà del pensiero). Il concetto è che in relazione alla tipologia di
compiti che fanno carico all’interessato nell’ambiente in cui egli opera, l’organizzazione esige da lui, in
misura più o meno intensa, capacità di elaborazione intellettuale e quindi Freedom to Think. Il termine
“libertà” non deve qui indurre in equivoci. La “libertà” non è un capriccio che viene graziosamente concesso al titolare del ruolo, ma una responsabilità di cui egli deve farsi carico. La “libertà del pensiero” si
risolve nell’imperativo: “Non chiedermi ad ogni passo cosa devi fare e come devi muoverti! Sei tu che devi
stabilirlo, sforzandoti di pensare”. Nelle vecchie organizzazioni basate su automatismi burocratici si era
soliti dire: “Non sei pagato per pensare!”. La “varianza dei compiti” comporta invece che si venga appunto
“pagati per pensare”.
67 Chiarire il significato di una norma significa essenzialmente risolverne gli eventuali elementi di ambiguità
e vaghezza, delucidando il reticolo di obblighi, divieti, permessi e facoltà che vi sono connessi nelle diverse situazioni in cui la norma stessa si applica (obbligo = cosa si deve fare; divieto = cosa non si deve fare;
facoltà = cosa si può fare; permesso = cosa si può non fare). Usando la terminologia dei giuristi, lo si può
chiamare il “reticolo deontico” (derivato dal greco “deon” = dovere. Si parla anche di “logica deontica” per
indicare quella parte della logica che analizza gli enunciati normativi che esprimono appunto l’obbligo, il
divieto, il permesso o la facoltà di compiere determinate azioni).
83
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
84
Quanto più elevata è la varianza dei compiti, tanto maggiore è la “sfida intellettiva”68 cui deve far fronte l’interessato e quindi l’abilità ideativa e la capacità di invenzione argomentativa di cui deve dar prova. Il concetto di varianza dei compiti riguarda i
contenuti oggettivi della prestazione richiesta, mentre il concetto di sfida intellettiva
riguarda l’aspetto soggettivo della prestazione eseguita, e cioè le conoscenze e capacità
che il soggetto deve possedere ed esprimere per eseguire al meglio la prestazione attesa.
C’è sfida intellettiva laddove vi siano attività nelle quali, come si dice in gergo,
“mancano i precedenti” o è molto limitata la possibilità di farvi ricorso (non ci sono – o
sono poco significativi nell’economia complessiva del lavoro – passaggi procedurali che è
possibile ripetere meccanicamente o con qualche minima variazione, e ci sono invece
sempre nuove obiezioni da affrontare, nuovi dati di fatto da interpretare, nuovi rapporti
concettuali da istituire, ecc.). In altri termini, non ci sono soluzioni predeterminate (“belle
e pronte”) da mutuare o da adattare con minime variazioni, ma ci sono invece soluzioni
da inventare o da assemblare con interventi modificativi rilevanti. I giudizi che generalmente segnalano l’incapacità di qualcuno a svolgere attività di questo tipo sono: “Di fronte
alla novità si perde” o “È capace solo di riempire stampati” o anche “Se non lo si imbocca,
si blocca” o ancora “Cammina con i paraocchi”, ecc. Le attività dove non funziona o funziona male il richiamo al precedente sono quelle ove sorgono problemi che non hanno
“the right answer” (per usare l’efficace formula della metodologia Hay), cioè che non hanno “una e una sola risposta giusta”, ma ammettono più alternative, di ognuna delle quali
occorre soppesare pro e contro, senza possibilità di individuarne una che massimizzi tutti
i vantaggi e minimizzi tutti gli svantaggi (tale sarebbe appunto “the right answer”).
Come si affronta la sfida intellettiva? In una organizzazione – e tanto più in una
organizzazione pubblica – non è consentita l’adozione di scelte arbitrarie, ma è richiesta
una costruzione argomentata della soluzione del singolo caso. Tale costruzione è ciò che
generalmente si chiama “motivazione” (il termine è qui usato in senso ampio: non designa solo la motivazione di un provvedimento, ma, più in generale, la dimensione argomentativa di un atto o di una condotta). Un’attività intellettualmente sfidante è quella in
cui non ci si può adagiare su schemi precostituiti, ma neppure sono consentite decisioni
arbitrarie. L’unica scelta consentita – anzi obbligata, data l’impossibilità di sfruttare
comodamente un qualche precedente – è quella di “ragionare bene con la propria testa”.
In generale, comportano un’elevata sfida intellettiva le attività per le quali sono
richieste un alto livello di competenza linguistica e di abilità argomentativa, qualità, queste, che tipicamente si combinano nella capacità di elaborare motivazioni calibrate sulla
peculiarità del singolo caso (rientra, ad esempio, fra tali attività, come già detto, l’interpretazione normativa, per la quale è richiesta, oltre ad una solida e approfondita preparazione, una notevole capacità di “tradurre pensieri per iscritto”, abilità, questa, ove il
mero ricorso al precedente non è di significativo ausilio ed anzi porta non di rado a soluzioni “posticce”).
68 Nella metodologia Hay di pesatura delle posizioni “sfida intellettiva” corrisponde a Thinking Challenge
(challenge = sfida).
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
Difficoltà dei compiti
Alta “varianza dei compiti” significa generalmente anche elevata complessità del
lavoro69. Questo vuole forse dire che, nei lavori connotati invece da minore varianza dei
compiti, il pensiero non possa, inevitabilmente, fare altro che “girare al minimo”? No.
C’è routine e routine. Una cosa – come abbiamo prima detto – è la routine di una catena
di montaggio in una fabbrica di bulloni e un’altra è la routine di una sala operatoria in un
centro di trapianti cardiaci.
Ma ancora prima di approfondire ulteriormente la distinzione fra il concetto di
“varianza” dei compiti e quello di “difficoltà” dei compiti, conviene chiedersi: che utilità c’è a fare questa distinzione? I due termini servono a distinguere i diversi tipi di complessità delle funzioni dell’Agenzia, consentendo, di riflesso, di mettere meglio a fuoco
le caratteristiche professionali dei mestieri correlati a quelle funzioni.
Compiti ad alta varianza sono quelli che pongono problemi la cui soluzione non
può essere cercata – o può esserlo solo in misura limitata – in un repertorio consolidato
di “precedenti”. La soluzione, per essere efficace ed appropriata, deve avere connotazioni originali, che richiedono all’operatore abilità inventiva ed attitudine a costruire risposte intelligentemente calibrate – nella delucidazione dei problemi e nell’argomentazione
con cui vi si dà soluzione – sulle specificità delle questioni affrontate. In sostanza, laddove c’è varianza, non ci si può affidare a routine consolidate.
Viceversa, vi possono essere in generale compiti di elevata difficoltà dove però
non c’è alta varianza perché ci si basa proprio su routine ben collaudate e sperimentate. E dove è allora il difficile? La difficoltà sta nel fatto che l’apprendimento di queste
routine è considerevolmente gravoso (si pensi al training – fatto di studio meticoloso e
di rigorosa disciplina – cui si sottopone un violinista per eseguire alla perfezione un
pezzo musicale o, per riprendere l’esempio di prima, un chirurgo per eseguire con la
massima precisione possibile un determinato tipo di intervento operatorio) e la loro
esecuzione richiede elevata concentrazione e sforzo mentale. Esaminiamo distintamente queste due componenti della difficoltà dei compiti: il know-how e l’impegno
intellettivo.
In ogni lavoro il “fare” ha come sua condizione un “sapere” e un “saper fare”. Il
loro intreccio è ciò che si chiama know-how. Generalmente, tanto maggiore è la varianza da gestire, tanto più elevato è il know-how richiesto. Bisogna distinguere tra il
know-how di base (che funge da requisito di accesso alla posizione ricoperta ed è legato
al possesso di un determinato livello di istruzione scolastica o universitaria) e il
know-how di lavoro (che identifica il bagaglio di specifica conoscenza tecnica acquisibile solo on the job e che è necessario per svolgere bene il ruolo rivestito). La distinzione
69 In assoluto non si può escludere che vi siano attività semplici ma con notevole varianza nei modi in cui
possono essere realizzate. Presenta, ad esempio, queste caratteristiche un’attività di tipo artigianale che,
seppure semplice, in quanto richieda un limitato know-how, abbia però, come fattori principali di competitività, l’inventiva e la fantasia nella realizzazione dei prodotti. Si tratta tuttavia di una possibilità che non
ha concreto riscontro nei mestieri dell’Agenzia delle Entrate.
85
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
86
fra know-how di base e know-how di lavoro è importante poiché, a parità di know-how
di base, vi può essere, tra i diversi ruoli di una medesima area d’inquadramento, una
differenziazione significativa in termini di conoscenze di cui è necessario impadronirsi
sul posto di lavoro per interpretare al meglio il proprio ruolo (può essere richiesta l’acquisizione di variegate conoscenze tecniche per gestire ruoli connotati da polivalenza
professionale, quali quelli legati all’attività di informazione ed assistenza, oppure l’acquisizione di approfondite conoscenze specialistiche per gestire, ad esempio, processi
come quello della riscossione).
Come si valuta la complessità del know-how richiesto (sia quello di base che quello di lavoro)? Analizzando le caratteristiche del percorso di apprendimento necessario
per acquisirlo e mantenerlo aggiornato. Un know-how elevato (vale a dire specializzazione tecnica approfondita o vastità interdisciplinare del sapere) è correlato a un percorso di apprendimento lungo e cognitivamente oneroso, per via dello studio, dell’applicazione, dell’esperienza e del costante aggiornamento richiesti per raggiungere la
padronanza del mestiere.
L’acquisizione e la crescita della polivalenza richiedono un know-how che si acquista con un training impegnativo, così come impegnativo – e spesso anche molto impegnativo – è il processo di apprendimento per acquisire un adeguato sapere specialistico
in materie tecnicamente ardue.
Passiamo ora all’impegno intellettivo. Esistono nell’Agenzia attività a ridotta
varianza e tuttavia di significativa difficoltà? La risposta è sì, e per individuarle può
essere utile servirsi di una metafora. Comporre un puzzle è un’attività totalmente predeterminata nella soluzione e priva quindi di varianza nel senso sopra specificato. E tuttavia una cosa è comporre un puzzle di 10 pezzi, un’altra è comporne uno di 100 e un’altra ancora comporne uno di 1000. In tutti e tre i
casi, c’è un modo, ed uno solo, di comporre il
puzzle (varianza, dunque, pari a zero), ma essi ciò
nonostante presentano una grande differenza, poiché l’incastro di un gran numero di pezzi richiede
un forte impegno intellettivo. Ecco allora – per
riprendere i concetti prima esposti – che possono
esistere lavori a bassa varianza di compiti che però
comportano notevole impegno mentale. Sintetizzando, si potrebbe dire, sia pure un po’ sommariamente, che mentre le attività ad alta varianza e
intellettualmente sfidanti sono, nell’Agenzia, quelle tipiche delle professionalità specialistiche che richiedono una preparazione di base di tipo universitario, le attività a
varianza meno elevata, ma tali da comportare comunque un grado consistente di impegno intellettivo, sono quelle che non richiedono, per il loro adeguato svolgimento, una
preparazione di quel tipo.
L’impegno intellettivo è correlato all’intensità del lavoro intellettuale richiesto
per costruire i ragionamenti necessari a risolvere le questioni di lavoro proprie del ruolo
ricoperto. L’intensità dello sforzo può dipendere dalla molteplicità degli elementi da
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
combinare (come nell’esempio del puzzle prima citato), dalla difficoltà intrinseca dei
concetti che occorre padroneggiare (in questo caso, si va da nozioni elementari di comune esperienza a nozioni più sofisticate la cui acquisizione richiede lunghi e impegnativi
percorsi di apprendimento), dalle risorse di attenzione e di memoria che occorre mobilitare, dalla ramificazione più o meno folta dell’albero logico lungo il quale si snoda la
concatenazione dei diversi aspetti di un problema e dei suoi elementi risolutivi (un
esempio al riguardo, tratto dall’ingegneria del software, è la corretta nidificazione degli
if-then-else in un programma informatico, operazione, questa, che, pur non avendo
alcuna parentela con le attività che abbiamo definito incerte, può nondimeno risultare
mentalmente assai estenuante).
Del resto, a parità di area di varianza, il lavoro del pensiero può essere più o meno
difficoltoso, a seconda appunto della maggiore o minore complicatezza delle situazioni
da affrontare all’interno di quell’area. In altre parole, assumendo che l’area di varianza
di compiti in cui due persone sono chiamate ad operare sia la stessa – ad esempio quella
dell’interpretazione normativa che presenta, comparativamente ad altre aree di compiti,
elevata varianza – le situazioni non per questo sarebbero per forza identiche in termini
di complessità del lavoro, proprio perché vi possono essere normative che presentano –
rispetto ad altre – possibilità assai maggiori di combinazione di norme in fase applicativa (il caso tipico è quello della normativa fiscale, specie in determinati ambiti come il
reddito d’impresa).
Prima di passare oltre, proviamo a serrare, in un quadro d’insieme, i concetti
appena enucleati. Nelle funzioni in cui esistono aree di varianza, c’è anche sfida
intellettiva, che può variare di intensità a seconda della “natura del terreno” compreso, per così dire, nell’area di varianza. Più il terreno è “accidentato” (scarsità dei precedenti, normative instabili, eterogeneità delle fattispecie applicative), maggiore è il
lavoro che il pensiero deve compiere per individuare bene i problemi e approntare
soluzioni efficaci. Ma il pensiero può essere chiamato al lavoro anche quando l’area
di varianza è ridotta e ridotta è pure, di conseguenza, la sfida intellettiva. Come
mostra lo studio della matematica, un problema difficile da risolvere non è necessariamente un problema incerto per il quale non vi è una regola precostituita di decisione. Sommare due numeri interi (5+7) e risolvere un’equazione di secondo grado sono
in entrambi casi esecuzione di un calcolo, cioè un’attività priva di varianza. Nondimeno però le due operazioni sono molto diverse dal punto di vista dell’impegno intellettivo richiesto (la prima operazione può essere eseguita da un bambino, mentre
occorre un lungo apprendimento per arrivare a calcolare un’equazione di secondo
grado). Analogamente, esaminare una dichiarazione dei redditi può essere, a parità di
grado di varianza (generalmente basso), un lavoro molto semplice in un caso (es.
dichiarazione di un lavoratore dipendente che possieda solo la casa in cui abita ed
esponga come unico onere deducibile gli interessi sul relativo mutuo), mentre in un
altro caso può risultare intellettualmente impegnativo (es. dichiarazione sempre di un
lavoratore dipendente che però possieda diversi fabbricati e abbia anche redditi di
altra natura, oltre a numerose tipologie di oneri deducibili, alcune delle quali poco
frequenti).
87
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
Conclusioni
88
Volendo riassumere la tematica qui illustrata, i concetti essenziali da cui occorre
partire per descrivere la complessità del lavoro sono due: il tipo di prestazione lavorativa
che l’organizzazione richiede al proprio personale e il tipo di capacità cognitive necessarie per far fronte a tale richiesta. Il primo concetto riguarda la dimensione oggettiva del
lavoro (ciò che va fatto, ossia i contenuti della prestazione richiesta), mentre il secondo
riguarda la dimensione soggettiva del lavoro (la natura della performance intellettiva che
deve saper esprimere la persona per eseguire la prestazione richiesta). Ragionando
secondo la dimensione oggettiva, possiamo differenziare la complessità del lavoro (e correlativamente i mestieri che raggruppano i diversi tipi di attività lavorativa) in base alla
varianza e alla difficoltà dei compiti da eseguire. Ragionando, invece, secondo la dimensione soggettiva, possiamo distinguere nel “lavoro del pensiero” in cui deve cimentarsi il
personale dell’Agenzia due diversi aspetti: uno è la sfida intellettiva, che ha come paradigmi l’invenzione argomentativa e la brillantezza investigativa, e l’altro è l’impegno
intellettivo, che ha, come modelli concettuali di riferimento, l’impostazione logica di
“formule di calcolo” e la loro applicazione metodica (rispondere a quesiti fiscali non elementari, assemblando con ordine i diversi elementi di risposta attinti da un’ampia banca
dati, è una tipica espressione di “impegno intellettivo” nel senso appena detto). Se la prima forma di attività intellettuale esprime “intelligenza creativa”, la seconda esprime
“intelligenza combinatoria”.
Schematizzando, i nessi fra la dimensione oggettiva e quella soggettiva della complessità del compito sono questi:
dimensione oggettiva
varianza dei compiti
difficoltà dei compiti
↔
↔
dimensione soggettiva
sfida intellettiva
impegno intellettivo
La combinazione delle variabili sopra descritte secondo “dosaggi” diversi (non ci
sono lavori dove tutto è “varianza” o dove tutto è routine, né – dove c’è routine – i compiti sono tutti facili e nessuno difficile, ma c’è sempre un mix di tutte queste componenti) concorre a determinare la configurazione e la rilevanza del singolo ruolo professionale
(ciò che chiamiamo “mestiere”) e, di riflesso, concorre all’individuazione e alla pesatura
delle competenze occorrenti per esercitare quel ruolo.
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
Si riportano di seguito alcuni esempi di comportamenti che hanno dato luogo a
prestazioni significative di dinamismo intellettivo (Intuito & Costruzione logica).
Esempio 1
Indicatori rilevati di abilità intellettiva: congruenza (completezza e accuratezza)
e innovatività
89
Consulenza legale
“Una società svizzera aveva immobili in Italia, ma non una sede nel nostro Paese.
Le era stato notificato un avviso di accertamento per svariati miliardi che la
società aveva contestato dichiarando di non avere domicilio in Italia.
Dovevo dimostrare che la notifica in Italia non fosse nulla, come eccepito dal
contribuente e che la società avesse domicilio nel nostro Paese.
Non era un caso standard, mancavano i precedenti. Non c’erano indirizzi, non
avevo punti di riferimento.
Ho trovato nell’archivio storico una vecchia dichiarazione con cui la società anni
prima aveva chiesto il codice fiscale con domicilio in Italia, ho consultato l’Anagrafe tributaria e lì ho trovato l’informazione.
Ho anche ricercato dottrina, normativa e giurisprudenza, ecc. Ho analizzato le
informazioni e le ho sintetizzate. Ho combinato norme diverse, dovevo fare un
collegamento complesso, non univoco e neppure immediato.
In questo modo sono riuscito a contrastare vittoriosamente l’eccezione sollevata
dalla società sulla nullità della notifica in Italia”.
Esempio 2
Indicatori rilevati di abilità intellettiva: congruenza (completezza e accuratezza)
Controllo
“Mi occupo di contribuenti che operano nel settore del commercio al dettaglio. Stavo facendo un controllo sulla posizione di una società con una contabilità formalmente corretta che dichiarava un reddito molto basso negli ultimi
anni.
Ho verificato l’ubicazione del negozio: era in centro, le vetrine davano sulla strada principale, il negozio era nuovo ed esponeva marche famose. Ho analizzato il
reddito dichiarato nei diversi anni per capire se c’erano stati episodi particolari.
Ho fatto delle interrogazioni sui beni immobili, sui rapporti con altri soggetti e
sul numero dei soci, per vedere quante persone vivessero grazie a quella attività.
Valutando questi elementi ho concluso che i dati dichiarati da quel contribuente
non erano in sintonia con la situazione che avevo rilevato”.
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
Esempio 3
Indicatori rilevati di abilità intellettiva: congruenza (completezza e accuratezza)
90
Controllo
“Stavo facendo una verifica ad una pasticceria artigianale. Formalmente quadrava tutto. Ho trovato a bilancio numerosi imballaggi il cui valore era molto
alto. In magazzino ho appurato che gli imballaggi erano molto ingombranti. Ho
pensato di confrontarli con il numero di viaggi fatti dall’autocarro di cui si serviva la ditta.
Le fatture recenti relative agli imballaggi erano state emesse da un fornitore con il
contratto della tentata vendita. Sulle fatture c’era la targa dell’autocarro del fornitore. Ho telefonato alla motorizzazione ad una impiegata che avevo conosciuto
in occasione di una precedente verifica. Avevo conservato il suo numero di telefono per mantenere un contatto interno in grado di farmi evitare perdite di tempo. Attraverso la targa dell’autocarro sono riuscita a risalire alla sua portata, stabilendo che non era congruente con il numero di viaggi effettuati per quella ditta.
A questo punto ho pensato di eseguire un’indagine presso la ditta fornitrice di
imballi e ho riscontrato che non esisteva. Si trattava di un soggetto evasore totale
che vendeva fatture false. La pasticceria invece aveva dedotto costi di imballo
superiori a quelli effettivamente sostenuti”.
Esempio 4
Indicatori rilevati di abilità intellettiva: congruenza (completezza e accuratezza)
e innovatività
Controllo
“Ci fu una segnalazione della Prefettura riguardo a un centro di attrazione polisportivo che dichiarava lo svolgimento di attività non lucrative. In ufficio non
c’erano elementi disponibili per l’avvio della verifica, sicché ho pensato bene di
iniziare con un accesso. Ho visto che figuravano 5 società anziché un’associazione: una era la polisportiva, una gestiva la piscina, una il bar, una il campo di calcetto, una i campi da tennis. La polisportiva si faceva pagare dalle società gli
affitti di pertinenza. Ho pensato di estendere le ricerche anche alle altre società.
Ho cercato poi di individuare gli elementi comuni alle varie attività perché la
documentazione che avevo acquisito per ognuna era insufficiente e la metodologia in uso non mi forniva indicazioni per casi come questo. Non potevo desumere
il volume d’affari. Quindi ho cercato di fare una ricostruzione unitaria partendo
dai consumi dell’energia elettrica per arrivare ai consumi relativi a tutti gli
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
impianti. Sono andato all’ENEL per indagare sui Kw/h. Ho raccolto gli orari di
apertura degli impianti per capire a cosa fosse collegato il consumo dell’energia
e come si correlasse al numero di clienti. Ho calcolato quanto consumava la
piscina, per scorporare poi questo consumo dal consumo totale. Ho somministrato dei questionari agli istruttori per conoscere il loro stipendio e per rilevare il
numero di allievi per ogni turno e per ogni vasca. Ero a conoscenza dei prezzi
medi per allievo, dovevo solo capire quante persone frequentavano gli impianti
poiché loro avevano buttato tutte le matrici relative. Ho dedotto il numero medio
di allievi per vasca e per turno e ho stabilito il numero degli allievi. Ho proceduto
in questo modo anche per le altre attività, riuscendo così estendere la verifica a
tutto il centro polisportivo”.
Si apprende non solo dall’osservazione di esempi virtuosi, ma anche dalla riflessione su comportamenti che virtuosi non sono. Nella galleria che stiamo percorrendo,
non sta male quindi, accanto a ritratti di bravura professionale, qualche “cammeo” di
performance tutt’altro che brillante. La vicenda di seguito descritta riguarda un verificatore, che, per ovvie ragioni di riservatezza, viene qui identificato (con notevole sforzo di
fantasia) con lo pseudonimo “Verdi”.
Esempio 5
Controllo
Verdi è stato distaccato presso la Direzione regionale per svolgere verifiche di
rilevanti dimensioni. Tale attività non ha prodotto risultati lusinghieri: la verifica
da lui eseguita come capo nucleo nei confronti della soc. … era affetta da macroscopici errori di impostazione dei rilievi, di calcolo e di procedimenti applicati
(quali: uso di medie aritmetiche, anziché ponderate). Errori che hanno comportato la necessità di un supplemento di indagini da parte di altri verificatori e in
seguito, stante l’impossibilità di mutare totalmente l’impostazione della verifica,
l’abbandono da parte dell’Ufficio della pretesa di circa un miliardo e mezzo di
lire per ognuna delle annualità verificate che emergevano dalle conclusioni originarie. In buona sostanza il controllo dell’Ufficio, sulla base della verifica che evidenziava rilievi per circa 3 miliardi di imponibile, si è concluso per adesione con
una maggiore imposta di poche decine di milioni.
Nello stesso anno Verdi ha eseguito anche alcune verifiche a piccole imprese,
ugualmente conclusesi con risultati deludenti.
L’anno successivo è stato impegnato nella verifica di un soggetto di grandi
dimensioni (S.p.A. …), con esiti molto modesti. Le altre verifiche che ha eseguito
91
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
nell’anno hanno riguardato soggetti di piccole dimensioni. Neanch’esse hanno
dato significativi risultati.
In base a questi precedenti negativi non sono state più affidate a Verdi, dall’anno
…, verifiche di grandi dimensioni. Attualmente esegue solo verifiche a soggetti di
piccoli dimensioni sotto la costante vigilanza del capo team controlli.
92
L’episodio di seguito riportato descrive i momenti iniziali di una verifica. Nella descrizione non viene detto quali siano state le conclusioni della verifica stessa, né
quali ne siano state le motivazioni, sicché non si è di fronte, in questo caso, a comportamenti sfociati in un prodotto suscettibile di valutazione. L’interesse dell’episodio (ed
è solo questa la ragione che ne ha determinato l’inclusione nel manuale) è quello di
rappresentare un atteggiamento di apertura alla ricerca e all’esplorazione, che rivela
attitudine a coniugare intuizione e costruzione logica.
Esempio 6
Controllo
“Quando arrivo in azienda non guardo solo le carte e la contabilità, ma ascolto
anzitutto il contribuente. Perché ciò che mi dice all’inizio non lo ripeterà più:
quelle sono informazioni molto preziose. Incontro il titolare e cerco di farmi spiegare il contesto in cui opera: questo non è scritto nelle procedure standard.
Faccio un giro in azienda e, curiosando qui e lì, provo a capire il processo produttivo oppure le modalità di commercializzazione. In quel caso feci domande
del tipo: ‘Dove ha acquistato il filato? Ha solo un fornitore?’ Le informazioni raccolte dovevano trovare riscontro nelle fatture. Di solito quando inizio la verifica
non so esattamente quali domande farò. Mi nascono dentro spontaneamente
guardandomi intorno in azienda”.
Esempio 7
Riscrittura di un testo
Il brigadiere è davanti alla macchina per scrivere. L’interrogato, seduto
davanti a lui, risponde alle domande un po’ balbettando, ma attento a dire
tutto quel che ha da dire nel modo più preciso e senza una parola di troppo:
«Stamattina presto andavo in cantina ad accendere la stufa e ho trovato
tutti quei fiaschi di vino dietro la cassa del carbone. Ne ho preso uno per
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
bermelo a cena. Non ne sapevo niente che la bottiglieria di sopra era stata
scassinata».
Impassibile, il brigadiere batte veloce sui tasti la sua fedele trascrizione.
«Il sottoscritto, essendosi recato nelle prime ore antimeridiane nei locali dello scantinato per eseguire l’avviamento dell’impianto termico, dichiara d’essere casualmente incorso nel rinvenimento di un quantitativo di prodotti
vinicoli, situati in posizione retrostante al recipiente adibito al contenimento
del combustibile, e di aver effettuato l’asportazione di uno dei detti articoli
nell’intento di consumarlo durante il pasto pomeridiano, non essendo a
conoscenza dell’avvenuta effrazione dell’esercizio soprastante.»
È evidente che l’episodio sopra riportato non è accaduto negli uffici finanziari.
Non è neppure accaduto negli uffici di Polizia, né in una stazione dei carabinieri.
È una invenzione narrativa di Italo Calvino (ma si sa che le autentiche invenzioni
narrative sono più reali della realtà, nel senso che ne esprimono il senso profondo). Il grande scrittore raccontò quarant’anni fa questa storia in un articolo apparso su un quotidiano dell’epoca (Il Giorno, 3 febbraio 1965). Il suo intento era
attaccare quella che lui chiamava l’antilingua, termine, questo, che costituiva il
titolo stesso dell’articolo. Cos’è l’antilingua?
Questa era la spiegazione che ne dava Calvino:
Ogni giorno, soprattutto da cent’anni a questa parte, per un processo ormai
automatico, centinaia di migliaia di nostri concittadini traducono mentalmente, con la velocità di macchine elettroniche, la lingua italiana in un’antilingua inesistente. Avvocati, funzionari, ministeri e consigli di amministrazione, giornali e telegiornali scrivono, pensano, parlano nell’antilingua.
Caratteristica principale dell’antilingua è quello che definirei il «terrore
semantico», cioè la fuga di fronte a ogni vocabolo che abbia di per se stesso
un significato, come se «fiasco», «stufa», «carbone» fossero parole oscene,
come se «andare» «trovare» «sapere» indicassero azioni turpi.
Nell’antilingua i significati sono costantemente allontanati, relegati in fondo
a una prospettiva di vocaboli che di per sé non vogliono dire niente o vogliono dire qualcosa di vago e sfuggente.
È ben difficile contestare la fondatezza di questa analisi, ma, senza voler minimamente mancare di rispetto all’autorità di Calvino, bisognerebbe chiedersi se,
coniando il termine “antilingua” e dandogli il significato che vi ha dato, lo scrittore abbia veramente centrato il problema o ne abbia invece colto solo una parte, e
forse neppure quella più significativa. In fin dei conti, se il guaio fosse solo quello
che gli impiegati pubblici traducono, veloci come macchine elettroniche, dalla
lingua all’antilingua, la cosa non sarebbe al giorno d’oggi tanto grave, perché esistono ormai macchine elettroniche – assai più potenti di quelle dell’epoca in cui
scriveva Calvino e molto più veloci degli impiegati pubblici – che sistemerebbero
tutto all’istante, ritraducendo egregiamente (ci sono già software di questo tipo)
93
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
94
dall’antilingua alla lingua (trasformando, ad esempio, in un batter d’occhio la frase “eseguire l’avviamento dell’impianto termico” in “accendere la stufa”).
In realtà, il registro più importante e delicato della comunicazione istituzionale
non è tanto quello descrittivo, bensì quello argomentativo. Il punto critico,
insomma, non è la rappresentazione naturalistica di oggetti (fiaschi, stufe, carbone, ecc.), ma la costruzione logica di concetti (diritti, obblighi, facoltà, scelte discrezionali di opportunità, ecc.). È in questa seconda operazione che è difficile –
e lo è tanto più quanto più complessi sono i concetti in gioco – dare prova di
chiarezza, efficacia, congruenza e completezza. E i computer, in questo caso, danno ben poco aiuto.
Nei corsi di affinamento della qualità della scrittura amministrativa, un esercizio
ricorrente è quello di partire da un testo pressoché impresentabile per oscurità e
difetto di logica, bersagliarlo poi con notazioni pungenti, così come si trafiggeva
il saracino nelle giostre medievali, e riscriverlo infine di sana pianta. Qui, invece,
attingendo sempre alla pratica degli uffici, si fa un esercizio un po’ diverso, ma
forse ancora più utile, perché più aderente all’esperienza reale, ove, fortunatamente, “l’aborto linguistico” non è poi così frequente. Si prende un testo di discreta fattura e si cerca di migliorarne ulteriormente la tessitura (il lettore, ovviamente, potrà cimentarsi in altre riscritture, poiché il processo di miglioramento
linguistico non ha di per sé mai fine, e solo considerazioni di economia di tempo
e di fatica vi pongono di volta in volta termine). È un testo di una certa importanza, trattandosi di una direttiva del Direttore dell’Agenzia ai Direttori regionali in
materia di relazioni sindacali.
Versione originaria
Interventi sul testo
Versione finale
Lo scrivente ha già avuto modo, in
occasione della riunione dei Direttori regionali del 4 dicembre scorso, di sottolineare l’importanza di
corrette relazioni con le organizzazioni sindacali, a tutti i livelli, a partire dal posto di lavoro.
• Viene eliminato il burocratico
“Lo scrivente”, sostituendolo
con il pronome in prima persona.
In più occasioni, e da ultimo proprio in apertura della riunione del 4
dicembre scorso, ho ritenuto
necessario sottolineare l’importanza di corrette relazioni con le organizzazioni sindacali a tutti i livelli, sia
a quello centrale e regionale, che
a quello locale del singolo ufficio.
• Nella versione originaria si legge: “in occasione della riunione
dei Direttori regionali del 4
dicembre scorso”. La direttiva è
già indirizzata però ai Direttori
regionali che sanno perciò perfettamente di essere loro i partecipanti a quella riunione. È un
difetto, seppure lieve, di accuratezza, che può essere eliminato dicendo semplicemente:
“in occasione della riunione del
4 dicembre scorso”.
• Invece di “lo scrivente ha già
avuto modo di sottolineare” viene detto, con espressione più
forte: “ho ritenuto necessario
sottolineare”.
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
Versione originaria
Interventi sul testo
Versione finale
• Viene rimarcato che l’importanza di corrette relazioni sindacali
è stata evidenziata dal Direttore
dell’Agenzia in più occasioni e
non solo nella riunione del 4
dicembre (da questo punto di
vista la versione originaria della
direttiva difetta di completezza).
95
• Si sottolinea ancora di più l’importanza di corrette relazioni sindacali, rimarcando che il richiamo a tale principio è avvenuto
“proprio in apertura” della riunione con i Direttori regionali (e
quindi in testa a tutti gli argomenti all’ordine del giorno).
• Si enfatizza la rilevanza di corrette relazioni sindacali “a tutti i
livelli”, specificando tali livelli
uno per uno. Viene inoltre eliminata la frase “a partire dal
posto di lavoro”, perché la correttezza delle relazioni sindacali
non deve partire solo “dal basso” (cioè dal singolo posto di
lavoro), ma è anche – e, forse,
soprattutto – questione di “buoni esempi dall’alto”.
A tal proposito, preme innanzitutto
ricordare quanto la capacità di
coinvolgere le risorse umane assegnate al dirigente assuma particolare rilevanza in una pubblica
amministrazione come la nostra,
investita da ormai più di dieci anni
da un costante processo di riforma
organizzativa. Questa capacità è
ancor più rilevante nell’attuale
fase, ancora iniziale, di trasformazione da branca di un Ministero in
Ente pubblico dotato di quell’ampia autonomia che con coerenza
rivendichiamo quale condizione
per il pieno raggiungimento degli
obiettivi posti dal Governo.
• Viene eliminato lo stilema, un
po’ consunto e burocratico, “A
tal proposito, preme anzitutto
ricordare…”.
• La versione originaria sviluppa a
questo punto, per ben due
paragrafi, il concetto dell’importanza della capacità del dirigente di coinvolgere le risorse
umane affidategli. Il concetto è
in sé condivisibile però non è
ben contestualizzato. In altre
parole, non viene spiegato
bene che legame vi sia tra tale
concetto e quello della necessità di corrette relazioni sindacali.
C’è qui un difetto di congruenza
al quale se ne aggiunge subito
dopo un altro, quando si accenna al legame fra “la capacità
del dirigente di coinvolgere le
risorse umane” e il tema dell’autonomia dell’Agenzia. Anche qui
si rischia di “andarsene per la
tangente”, ingenerando nel lettore l’impressione che il richiamo
all’autonomia dell’Agenzia sia
ormai una stucchevole “clausola di rito” che immancabilmente
I risultati assai positivi raggiunti dall’Agenzia delle Entrate già dal suo
primo anno di attivazione non
sarebbero stati possibili senza l’ampia e convinta partecipazione del
personale alle attività di missione e
al processo di cambiamento
organizzativo culminato nell’istituzione dell’Agenzia.
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
Versione originaria
Interventi sul testo
Versione finale
ricorre ogni volta che si parla di
Agenzie fiscali. Meglio quindi
espungere questo concetto e
impostare così la strategia argomentativa della direttiva:
– mettere in evidenza i positivi
risultati raggiunti dall’Agenzia
fin dal suo primo anno di
attivazione;
– sottolineare il fatto che il raggiungimento dei risultati è
dipeso dalla convinta partecipazione del personale al
processo di riforma;
– concludere dicendo che
questa partecipazione presuppone, a sua volta, un
buon clima di relazioni sindacali (il personale annette molta importanza alla costruttività
delle relazioni sindacali, come è testimoniato, fra l’altro,
dall’alta affluenza alle elezioni
delle RSU).
96
• La strategia argomentativa appena delineata trova articolazione nella nuova versione, nella quale si inizia appunto a
descrivere con semplicità e nitidezza il nesso fra i risultati raggiunti dall’Agenzia e la partecipazione del personale.
• La versione originaria presenta
inoltre difetti di efficacia stilistica. Alcuni passaggi, invece di
attrarre l’attenzione del lettore,
rischiano di smorzarla o persino
di ingenerare fastidio. Il paragrafo a fianco riprodotto della
versione originaria presenta, ad
esempio, toni stentorei (“Ente
pubblico dotato di quell’ampia
autonomia che con coerenza
rivendichiamo quale condizione...”) che rischiano di rendere
troppo enfatica la direttiva, che
già solo per il suo contenuto è
esposta a questo rischio.
Si tratta di un profondo processo di
riforma che è stato possibile portare avanti e che potrà continuare
ad essere sostenuto solo attraverso
l’ampia condivisione da parte del
personale degli obiettivi di trasformazione in una struttura sempre
più capace di dare risposte in termini di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.
Il concetto che la direttiva deve a
questo punto esprimere è che la
partecipazione del personale al
processo di riforma trova corrispondenza nel forte sostegno dato dalle
OOSS all’avvio del progetto “Agenzie fiscali”. Questo sostegno – così
importante per il successo della
riforma – non viene invece focalizzato nella versione originaria, che
Nel rilevare questo, è giusto riconoscere il forte sostegno dato dalle
organizzazioni sindacali al progetto di riforma dell’Amministrazione
finanziaria. Tale appoggio è stato
determinante – in considerazione
anche delle resistenze opposte da
altre parti – per consentire, prima, il
varo delle Agenzie fiscali in sede
legislativa e, poi, la concreta atti-
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
Versione originaria
Interventi sul testo
Versione finale
sotto questo aspetto presenta perciò un difetto di completezza e di
congruenza (in una nota che tende
a rimarcare l’importanza di corrette
e costruttive relazioni sindacali, non
può mancare una forte sottolineatura del ruolo svolto dalle OOSS per il
varo e l’attuazione della riforma).
vazione delle nuove strutture, nel
cui ordinamento le forze sindacali
hanno visto, oltre che la possibilità
di dare una più efficace risposta in
termini di servizio ai singoli contribuenti e alla collettività, un’importante e inedita opportunità di valorizzazione delle risorse interne.
La partecipazione assai elevata
del personale dell’Agenzia alle
recenti elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie testimonia
l’importanza del ruolo della rappresentanza sindacale sul posto di
lavoro e dell’interesse che il personale attribuisce al pieno utilizzo
degli strumenti di partecipazione
disciplinati dalla contrattazione
collettiva.
D’altra parte, l’elevatissima partecipazione del personale dell’Agenzia alle recenti elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
testimonia l’importanza del ruolo
della rappresentanza sindacale sul
posto di lavoro e dell’interesse che
il personale attribuisce al pieno utilizzo degli strumenti di partecipazione regolati dalla contrattazione
collettiva.
In questo quadro sembra abbastanza evidente che il sottolineare
l’importanza di corrette relazioni
sindacali non intende essere un
formale richiamo al rispetto di
regole già sancite da norme di
carattere giuridico e contrattuale,
ma vuole bensì essere un’indicazione verso una reale e piena condivisione dell’obiettivo di relazioni
sindacali che, a partire dal posto
di lavoro, divengano uno strumento effettivo per il coinvolgimento
pieno del personale, attraverso le
varie forme già definite dalla normativa legislativa e contrattuale.
È ovvio che il raggiungimento degli
obiettivi sopra esposti, trattandosi di
relazioni sindacali, richiede comportamenti coerenti al rispettivo
ruolo da ambedue le parti. Tanto
più sarà possibile pretendere comportamenti adeguati dalle controparti, quanto più noi stessi avremo
adottato comportamenti corretti e
coerenti col ruolo rivestito.
• Dalla versione originaria, ove i
verbi sono in terza persona
(“sembra abbastanza evidente
che il sottolineare …non intende essere” ecc.), si passa, nella
nuova versione, all’uso di verbi
in prima persona (“non intendo…ma voglio”). L’espressione
ne risulta ben più incisiva (prima
era appesantita anche dal goffo infinito “il sottolineare”).
• È reso con maggiore chiarezza
il concetto che le relazioni sindacali devono essere interpretate e vissute dalla dirigenza
non come un fastidioso adempimento, ma come uno strumento di coinvolgimento del
personale nei processi di cambiamento.
In questo quadro, non intendo quindi semplicemente rivolgere un invito
formale al rispetto di regole sancite
da norme legislative e da disposizioni contrattuali, ma voglio sottolineare che il mantenimento e lo sviluppo – nella naturale distinzione dei
ruoli – di corrette e costruttive relazioni con le rappresentanze sindacali costituisce, ancor più che un
doveroso adempimento di prescrizioni normative, una manifestazione
essenziale da parte della dirigenza
di autentica sensibilità e attenzione
per l’importanza del coinvolgimento
pieno del personale nei processi di
cambiamento in atto.
Nella versione originaria si omette
di sottolineare l’importanza del
ruolo dei sindacati non solo per
l’avvio della riforma ma anche per
la sua continuazione. L’inserimento
di questo concetto è importante
per la completezza della direttiva.
Così come è stato nella fase di
progettazione e di avvio della riforma, allo stesso modo non può
mancare per la prosecuzione e il
successo dell’opera intrapresa l’adesione del personale e delle forze che lo rappresentano.
Nella versione finale si esprime con
maggiore scorrevolezza e concisione il concetto della reciprocità che
deve informare le relazioni sindacali. I dirigenti si lamentano spesso
della scarsa “affidabilità” della parte sindacale. Si può però pretendere senso di responsabilità dalla controparte solo se si è disposti a dare
per primi prova di responsabilità.
Tanto più sarà possibile richiedere
alla controparte sindacale comportamenti all’altezza del ruolo rivestito, quanto più noi stessi sapremo
concretamente dare prova di consapevolezza e responsabilità nel
ruolo di parte pubblica.
97
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
Competenze extraintellettive
e clima di lavoro
99
1. Affidabilità
Il termine affidabilità include diverse caratteristiche. La prima – richiesta a chiunque
lavori nell’Agenzia delle Entrate – è l’onestà personale e, congiunta a questa, la correttezza
professionale. Non meno importante è il grado di coinvolgimento nel proprio lavoro.
La persona affidabile tiene fede agli impegni lavorativi che assume e mette in atto
comportamenti chiari e trasparenti in coerenza con i valori dell’Agenzia. È disposta ad
investire risorse ed energia nel lavoro, trasmettendo entusiasmo e “contagiando” anche i
colleghi. Il suo apporto è costante e spesso è al di sopra di quanto richiesto.
Le competenze che esprimono queste caratteristiche sono “Coerenza” e “Passione
per il lavoro”.
1.1 Coerenza
Alla domanda: “Perché pagare le tasse?”, la risposta è in genere: “Per finanziare i
servizi sociali”. È una risposta ineccepibile ma incompleta. Non sono solo i diritti sociali
(istruzione, salute, ecc.) che dipendono dal pagamento delle imposte, ma anche i diritti
di libertà (come osservano due giuristi americani in una loro recente opera dal titolo eloquente70, cosa ne sarebbe della proprietà privata, della libertà di parola, di associazione,
di movimento, ecc. se, per citare un esempio, non vi fossero efficienti – e quindi costose
– forze dell’ordine a garantirne il rispetto?). Se quindi si deve esigere coerenza e integrità
da ogni funzionario pubblico, a maggior ragione occorre esigerle da chi vigila sull’osservanza di un dovere da cui dipende la libertà di tutti. Non a caso, se a un bravo direttore
di un ufficio tributario fosse chiesto di riassumere in quattro parole i tratti che vorrebbe
che i suoi funzionari avessero, risponderebbe quasi sicuramente: “intelligente, preparato
e lavoratore”, ma prima ancora è certo che direbbe: “onesto”.
Come si può descrivere questa qualità e come la si può valutare? Una definizione
di “coerenza” potrebbe essere questa: disposizione ad agire in accordo con i valori e i
70 S. Holmes e C.R. Sunstein, Il costo dei diritti. Perché la libertà dipende dalle tasse, trad. it. Bologna, il
Mulino, 2000.
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
100
principi della propria organizzazione, anche (e soprattutto) quando ciò comporti sacrifici personali. Intesa in questo senso, la coerenza coincide con l’integrità professionale e la
“lealtà istituzionale”.
Più difficile è il discorso relativo ai criteri operativi di valutazione di questa competenza. Sarebbe troppo ingenuo, se non ipocrita, ignorare che ci si muove qui su un terreno
scivoloso. Che cosa, di quella costellazione di atteggiamenti in cui si esprime la coerenza
personale, si può realisticamente andare a sondare con qualche sicurezza? Almeno due
tipi di comportamenti, di cui alcuni negativi (quelli, cioè, che è bene che non siano posti
in essere) e altri positivi (quelli, cioè, che è bene invece che siano posti in essere).
In negativo la caratteristica della coerenza è evidenziata dall’assenza di comportamenti che diano luogo (o siano suscettibili di dare luogo) a conflitti di interesse e a situazioni di incompatibilità. Il regolamento volto a tutelare l’indipendenza e l’autonomia tecnica del personale delle Agenzie fiscali (D.P.R. 16 gennaio 2002, n. 18) introduce a questo
riguardo disposizioni ancora più rigorose di quelle vigenti per la generalità dei dipendenti pubblici e fissa due principi di ampia portata. Il primo stabilisce che “il dipendente salvaguarda l’immagine e la credibilità dell’Agenzia di appartenenza e delle funzioni
istituzionali a questa demandate, evitando ogni possibile condizionamento dell’attività
di servizio”. Il secondo dispone che “il dipendente evita le attività che possono condurre
a conflitti di interesse con l’Agenzia di appartenenza e che possono interferire con la sua
capacità di adottare decisioni imparziali”.
Nell’ambito dell’altra classe di comportamenti – quelli positivi – occorre distinguere tra i comportamenti relativi ai rapporti con l’esterno e quelli invece relativi ai rapporti
interni. Nel primo caso, il comportamento richiesto consiste nel tenere rapporti con i
contribuenti ispirati alla più scrupolosa correttezza. Nel mondo anglosassone si usano a
questo proposito le parole fair play e fair game (entrambe collegate al sostantivo fairness), traducibili grosso modo in italiano con “gioco leale” o “gioco pulito”. Il loro significato si lascia forse più facilmente afferrare ex contrario riflettendo sul termine opposto
“gioco sporco”, che sta a designare comportamenti o tattiche che, senza formalmente violare una specifica norma giuridica, vengono più o meno subdolamente adottati per impedire o rendere comunque gravosi alla controparte l’esercizio dei suoi diritti o la messa a
frutto di opportunità riconosciutele dall’ordinamento. In questo senso la “correttezza”
sta a denotare uno stile di condotta che va al di là della mera osservanza legalistica di
questa o quella norma e indica piuttosto un atteggiamento complessivo di leale rispetto,
sia nella lettera che nello spirito, dei diritti e degli interessi dei contribuenti, nei cui confronti l’esercizio dell’autorità non deve mai assumere nessuna delle connotazioni che,
pur non ricadendo sotto un espresso divieto di legge, possono essere sintomatiche di un
“abuso di posizione di potere”. Non è superfluo sottolineare che il comportamento che
abbiamo chiamato fair play o “gioco leale” va adottato nei riguardi della generalità degli
interessati, senza favoritismi nei riguardi di qualcuno o, viceversa, vessazioni nei confronti di altri, e in questa caratterizzazione semantica (riassumibile come “avversione
allo spirito di parte”) la nozione di coerenza va ad apparentarsi a quelle di “imparzialità”
e di “neutralità”, tipiche del tradizionale linguaggio amministrativo (è questo uno dei
casi in cui “tradizionale” non significa “obsoleto”).
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
Quanto invece ai rapporti interni, che legano il dipendente alla propria organizzazione, la valutazione della coerenza va commisurata all’entità dei sacrifici compiuti o
che si è disposti a compiere nell’interesse dell’istituzione. Questo comporta anzitutto
capacità di resistenza a indebite sollecitazioni interne o esterne al proprio ambiente di
lavoro e, specularmente, netta avversione a farsi tramite o ispiratori di tali sollecitazioni
per tornaconto personale.
Gli elementi appena descritti sono indicatori diretti della coerenza, ma vi sono
anche indicatori di tipo indiretto. Uno è l’attitudine a comunicare le proprie idee in modo
aperto e ad agire con autenticità e trasparenza anche quando considerazioni opportunistiche indurrebbero ad atteggiamenti meno franchi. Un altro indicatore è la refrattarietà ad
assumere atteggiamenti caratteristici di un tipo di persona che nel linguaggio comune viene solitamente descritto con un termine attinto al repertorio degli strumenti orchestrali:
“il trombone”. L’espressione viene qui usata in un’accezione specifica che non ha a che
fare con la dimensione psicologica del carattere, ma con la valutazione etica del comportamento organizzativo. In altri termini, il comportamento che si vuole stigmatizzare con
quella parola non è semplicemente quello di esagerare o enfatizzare le proprie capacità,
ma è quello di attribuire a se stessi meriti che non si hanno e di negarli ad altri cui andrebbero invece riconosciuti. Praticato abitualmente, tale comportamento è tra i più deleteri,
perché ostacola l’affermazione del senso di equità in un’organizzazione, e proprio per
questo motivo assume particolare rilevanza sotto il profilo della coerenza e dell’integrità.
Indicatori
A. Non è un modello di coerenza. Dimostra di essere permeabile a pressioni esterne e a indebite sollecitazioni. Intraprende azioni che possono danneggiare l’immagine o gli interessi
dell’Agenzia. Antepone i propri interessi a quelli dell’organizzazione di cui fa parte. Utilizza la sua posizione di autorità per ottenere vantaggi. Non mantiene gli impegni presi.
B. Si uniforma alle regole. Segue le procedure e si attiene alle regole deontologiche dell’Agenzia evitando situazioni di conflitto di interessi e di incompatibilità. Rispetta gli
impegni assunti, portando a termine il lavoro nei tempi concordati.
C. Agisce lealmente. Non esita ad assumersi la responsabilità dei propri atti senza scaricarla su altri. Dà prova di autentica correttezza nell’applicazione delle norme, fornendo, ad esempio, al contribuente le informazioni giuste che gli consentono di ottenere
benefici fiscali o di evitare errori.
D. È un modello di coerenza. Non bada solo alla propria condotta personale, ma si preoccupa che anche il proprio ambiente di lavoro sia permeato dei principi e dei valori
della propria organizzazione. Mostra la determinazione necessaria per assumere decisioni “scomode”. Evita e contrasta atteggiamenti e comportamenti collusivi con gli
interlocutori. Non si fa intimorire ed è pronto ad affrontare un contrasto anche forte
con la controparte quando vede posti in discussione i principi cui si ispira. Quando è
necessario, antepone le esigenze dell’ufficio a quelle personali e anche alle preferenze
professionali (assume, ad esempio, incarichi gravosi o non particolarmente gratificanti quando lo richiedono le strategie aziendali).
101
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
Di seguito sono riportati gli esempi relativi alla competenza Coerenza.
Esempio 1
Livello C della competenza Coerenza
102
Servizi al contribuente
“In un caso di compravendita di terreni mi è capitato che nell’atto di cessione era
stata dimenticata, per colpa del notaio o del contribuente, la frase che invocava i
benefici fiscali concessi dalla legge. In questi casi l’impiegato dovrebbe segnalare
al contribuente questa dimenticanza e rappresentargli i benefici cui ha diritto.
Alcuni miei colleghi sono legati a formalismi burocratici di vecchio stampo e quindi si asterrebbero sempre dal ricordare ai contribuenti quali siano le opportunità e
i benefici accordati loro dalla legge, ritenendo che ciò rappresenti un danno per
l’Amministrazione. Io invece credo che l’impiegato debba dare un buon servizio al
contribuente, e questo significa anche fornirgli sempre l’informazione giusta”.
Esempio 2
Livello D della competenza Coerenza
Controllo
“Stavo facendo una verifica ad un contribuente ed erano emersi elementi piuttosto
gravi. Stavo per emettere l’atto di accertamento quando venne a trovarmi un personaggio assai influente, parente del contribuente, per informarsi sulla pratica. Si è
presentato in modo arrogante e dopo che gli avevo spiegato la situazione ha cercato
di convincermi con vari argomenti che non era opportuno proseguire nell’emissione dell’accertamento. Avrei potuto forse agevolmente cavarmela, dicendo a quel
signore che la questione era delicata e che avrebbe dovuto perciò rivolgersi al direttore. Ma non volevo dargli un’impressione di remissività: se uno fa vedere che tiene
dritta la schiena, non difende solo la propria immagine, ma anche quella dell’ufficio di cui fa parte. Sono stato perciò molto deciso nel mantenere la mia posizione e
a un certo punto, visto che non desisteva, ho posto fine all’incontro dicendogli a
brutto muso che ero in possesso di elementi sicuri che mi obbligavano, salvo a venire meno ai miei doveri, ad emettere l’atto di accertamento”.
1.2 Passione per il lavoro
“È un gran lavoratore”. Solitamente è questa l’espressione che nel linguaggio
comune designa le persone animate da “passione per il lavoro”. Si tratta di una caratteristica personale che può essere valutata su due dimensioni. La prima è l’intensità dell’energia che si è disposti a spendere, giorno per giorno, nel proprio lavoro. La seconda è la
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
natura della motivazione che dà impulso, sorregge e accompagna l’impegno personale. Il
dato caratteristico è rappresentato qui dal fatto che la motivazione al lavoro si trasforma
da estrinseca in intrinseca. In altri termini, chi ha passione per il proprio lavoro, si riconosce facilmente perché vuole dare sempre di più, al di là dello stretto dovere, e trova,
nella propria attività, sempre nuovi interessi e stimoli, traendo soddisfazione da quello
che fa, più ancora che da quello che riceve per ciò che fa.
L’autentica passione per il lavoro non si traduce in un attivismo caotico, né va confusa con l’effimero entusiasmo. Esprime, al contrario, un forte senso di autodisciplina e
di perseveranza, che aiuta a non disperdere le energie personali e a focalizzarle sulla
meta da raggiungere, prendendo a cuore i problemi, senza mai demordere fino a che non
siano stati risolti.
La si può considerare una “metacompetenza” o una competenza di base (basic
competence), poiché si ritrova, come “energia motrice”, nei livelli alti di tutte le altre
competenze. È difficile sopravvalutarne l’importanza per la vita di un’organizzazione. La
possibilità stessa del cambiamento dipende, in larga misura, dalla presenza di persone
che, con la loro passione professionale, riescono a “contagiare” gli altri e a suscitare in
loro la voglia di impegnarsi.
Indicatori
A. Lavora svogliatamente. Cerca di fare meno del minimo indispensabile. È più attento
all’orologio che al lavoro che svolge. Quando si avvicina la fine della giornata, “molla
la penna” o la tastiera del computer qualunque cosa stia facendo e si precipita davanti
al tornello ad aspettare che scocchi l’ora di uscita. Evita scrupolosamente di farsi
coinvolgere in attività che teme possano rivelarsi impegnative e rifugge le novità, specie quando richiedano applicazione. I prodotti deI suo lavoro rivelano superficialità
ed approssimazione nell’approccio ai problemi e sono spesso inficiati da errori, causati da sviste e distrazioni, che costringono il supervisore a onerosi interventi di
aggiustamento, quando non a veri e propri rifacimenti.
B. Esegue quanto richiesto. Esegue disciplinatamente quanto gli è assegnato senza però
mostrare particolare coinvolgimento: non approfondisce la logica di ciò che gli viene
chiesto e non ha quindi capacità autocorrettiva (questa capacità si rivela, ad esempio,
nell’attitudine ad integrare o ad adattare, in funzione della mutevolezza delle circostanze, le prescrizioni ricevute). I prodotti o il servizio offerti soddisfano comunque
gli standard normali di qualità e di accuratezza.
C. Va oltre quanto richiesto. Sollecitato dal desiderio di fare, “non stacca” fino a quando
non ha portato a termine il lavoro. Quando si trova di fronte ad un’emergenza si attiva
autonomamente senza aspettare “ordini dall’alto”. Sa mantenere elevati e costanti
standard di accuratezza nel lavoro, anche quando il carattere seriale delle attività tende a ridurre il livello di attenzione. Propone spontaneamente di fermarsi oltre l’orario
quando lo richiedano le esigenze di servizio, senza aspettare che sia il superiore a
chiederglielo. È pronto ad assumere carichi di lavoro aggiuntivi per sostituire colleghi
momentaneamente assenti.
103
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
104
D. Lavora con entusiasmo. Dà prova di grande dedizione nel risolvere i problemi di lavoro,
dimostrando un impegno che eccede di gran lunga quello ordinario. Ha un vivo senso
dell’urgenza e delle priorità, che lo spingono a dedicarsi “anima e corpo” alle questioni
fino a quando non sono state risolte. È curioso, sta sempre con le “antenne dritte”, anche
al di fuori dell’ambiente di ufficio, pronto a cogliere tutti i segnali, anche deboli, che
possano avere un impatto positivo sul proprio lavoro (ad esempio, se fa il verificatore
non lesina sforzi nel cercare indizi utili ad aprire nuovi e fruttuosi filoni di indagine).
Promuove innovazioni nei processi lavorativi, ne sperimenta la validità e se ne fa promotore presso i colleghi. Ricerca sempre nuove opportunità e occasioni di miglioramento, sforzandosi di apprendere dall’esperienza altrui e da quella personale, che sa analizzare con determinazione e schiettezza senza cercare scuse per i propri eventuali insuccessi. Rivede in modo critico il proprio operato per evitare di ripetere gli errori.
Di seguito sono riportati alcuni esempi relativi alla competenza Passione per il lavoro.
Esempio 1
Livello C della competenza Passione per il lavoro
Controllo
“Mi è capitato di lavorare in momenti successivi su casi di segnalazione di residenti
all’estero che però, in base a circostanze specifiche, erano residenti fiscalmente in
Italia. La prima volta ho lavorato in modo superficiale ed ho ricopiato il verbale
riportandone acriticamente la motivazione: davo per scontato che il lavoro fosse
stato fatto bene. Quando il contribuente si è presentato in ufficio per l’accertamento
con adesione, mi sono reso conto di quanto eravamo stati approssimativi. Non avevamo infatti considerato diversi elementi importanti. In seguito, in un caso analogo
(si trattava di un contribuente con residenza a Montecarlo) ho letto riga per riga il
verbale e gli allegati, ho fatto una ricerca su Internet e ho trovato ulteriori elementi
sulla posizione fiscale del contribuente non inseriti nel verbale. Per esempio, mi
sono accorto che tutti gli accrediti bancari avvenivano su una banca di Roma e mi
sono allora chiesto: ‘Se abita a Montecarlo, perché tutti i soldi sono accreditati a
Roma?’. Alle motivazioni ho aggiunto anche questi nuovi elementi grazie ai quali
sono arrivato ad un atto di accertamento decisamente più completo del primo, che
ha consentito di formulare una proposta di adesione assai migliore per l’ufficio”.
Esempio 2
Livello D della competenza Passione per il lavoro
Controllo
“Stavo facendo una verifica in un noto ristorante della città. Vado in cucina dove
trovo lo chef che lavorava la pasta all’uovo. Vedo sul tagliere 10 gusci di uova con
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
1,5 kg di farina. Il ristorante dichiarava che con quegli ingredienti faceva 10 porzioni di pasta all’uovo. Il fatto mi ha molto incuriosito e ho voluto provare anch’io.
Sono andato al supermercato, ho comprato 1,5 kg di farina e 10 uova. Sono tornato a casa e, con qualche fatica, ho impastato il tutto. Alla fine, lo spettacolo della
cucina a soqquadro era desolante e ancora più desolante era lì, in mezzo alla cucina, mia moglie che urlava imbestialita. Ma ho potuto concludere che con quella
farina il ristorante faceva molti più pasti di quelli dichiarati (18 invece di 10) e
quindi avrebbe dovuto fatturare assai più di quanto aveva dichiarato.”
2. Dinamismo realizzativo
Nel Dinamismo realizzativo sono raggruppate le competenze che consentono al personale, nella quotidianità delle situazioni di lavoro, di giungere a risultati significativi sia sotto
il profilo quantitativo che sotto quello qualitativo. Il cluster comprende tre competenze: l’Iniziativa, la Tensione al risultato e lo Sviluppo e il trasferimento del sapere. La prima esprime la “proattività”, cioè l’attitudine ad agire autonomamente senza sollecitazioni esterne. La
seconda costituisce un intreccio di motivazione e capacità: motivazione a perseguire obiettivi non facilmente realizzabili e capacità di impegnarsi a fondo per raggiungerli. La terza
denota l’attitudine e la determinazione a sviluppare il proprio patrimonio di conoscenze ed
esperienze a beneficio della propria performance lavorativa e di quella dei colleghi.
2.1 Iniziativa
C’è un termine che non è di uso comune ma serve molto bene a riassumere le caratteristiche di una persona dotata di spirito d’iniziativa: “autopropulsivo”. L’iniziativa è
appunto la capacità “proattiva” di attivarsi autonomamente senza aspettare di essere sollecitati. Implica il desiderio di cercare comunque soluzioni, anche attraverso strade mai
percorse. Caratteristica tipica dell’iniziativa è la tendenza ad anticipare gli eventi per
coglierne le opportunità, senza farsi intimorire dai rischi che vi sono collegati.
Indicatori
A. Non prende iniziative. Agisce solo su richiesta esterna e fa solo ciò che gli viene
espressamente richiesto. Trova scuse per non prendere iniziative e si limita per lo più
a sterili recriminazioni (per esempio, incolpa la burocrazia, il “sistema”, la mancanza
di risorse, la scarsa cooperazione altrui, ecc.).
B. Si attiva autonomamente a fronte di un problema o di una scadenza. Quando si trova
in situazioni di emergenza e criticità non aspetta impulsi esterni e sollecitazioni, ma
reagisce prontamente, assumendo le necessarie iniziative.
105
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
106
C. Previene le criticità. Cerca, per quanto gli è possibile, di prevenire le situazioni di
emergenza (ad esempio, picchi di lavoro) adottando per tempo gli opportuni accorgimenti. Quando gli imprevisti si accumulano, non si scoraggia, ma persevera e fa ripetuti tentativi per superare gli ostacoli. Si ingegna con le risorse che ha a disposizione,
senza accampare mai scuse o alibi per l’inazione o l’attesa passiva degli eventi.
D. Opera sistematicamente in modo proattivo. Dimostra una radicata abitudine a riflettere criticamente sulle proprie esperienze, per trarre lezioni dal passato, con l’obiettivo
di anticipare gli eventi, evitando di farsi sorprendere impreparato e di ripetere errori
eventualmente commessi in precedenza. Guarda al futuro più che come fonte di
incertezze e rischi da cui cautelarsi, come sfida a cogliere nuove opportunità e a cercare soluzioni inedite, che non tiene gelosamente per sé, ma è pronto a proporre ad altri.
Di seguito sono riportati alcuni esempi relativi alla competenza Iniziativa.
Esempio 1
Livello B della competenza Iniziativa
Controllo
“Eravamo in periodo di scadenze e c’erano degli atti da notificare. Non c’era il
messo comunale e quindi ho preso la mia macchina e sono andato personalmente a notificarli.”
Esempio 2
Livello C della competenza Iniziativa
Controllo
“Stavo facendo una verifica in un’azienda. L’impiegato addetto all’amministrazione non era in grado di calcolare, con il software della contabilità, i saldi del
magazzino.
Gli ho chiesto di mettermi in contatto con la ditta che aveva fornito il programma
di contabilità, ma questa aveva chiuso. Ho chiamato la Camera di Commercio per
avere i nominativi dei titolari della ditta, li ho rintracciati e contattati e mi sono
fatto spiegare quale era il modo per stampare i mastri di conto di ogni prodotto”.
2.2 Tensione al risultato
Esprime la motivazione a lavorare sodo e bene e a stabilire propri standard realistici ma sfidanti, con l’obiettivo di migliorare il livello quantitativo e qualitativo della prestazione ed accrescere la soddisfazione dei contribuenti e del “cliente interno”.
Indice sicuro del possesso di questa competenza è la capacità di improntare la propria azione a criteri di proficuità, bilanciando costi e benefici. Tra le diverse “competenze
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
d’azione”, è, generalmente, quella che più influisce sull’utilizzo appropriato delle capacità
intellettive, poiché esercita un ruolo decisivo nell’orientare l’attenzione sugli aspetti più
importanti di una situazione critica, evitando che la riflessione si disperda senza costrutto
in una miriade di aspetti secondari, con effetti pregiudizievoli sul piano dell’efficienza (è
tipico, ad esempio, di analisi mal indirizzate sotto il profilo della tensione al risultato finale, l’attivazione di dispendiose e improduttive iniziative di controllo).
107
Indicatori
A. Non è all’altezza del proprio compito. Lavora in modo disattento, discontinuo e
approssimativo. Tutto ciò che realizza richiede normalmente rifacimenti e integrazioni. È lento e lascia che le pratiche si accumulino. Non mette mai nulla di nuovo nel
suo lavoro, ed anzi respinge per principio le novità senza tentare mai di sperimentarle
(“tanto non funziona”, “chi me lo fa fare” ecc.). La mancanza di tensione al risultato si
coglie talora anche nel tempo sproporzionato che dedica a dettagli insignificanti o
comunque di scarso peso, perdendo di vista il senso complessivo del lavoro e l’esigenza di assicurare soddisfacenti livelli di servizio e di produttività.
B. Si attiene agli standard. Si uniforma agli standard definiti e agli aspetti formali. Punta
solo a raggiungere i risultati che gli vengono strettamente richiesti. L’accuratezza con
cui lavora è quella minima prescritta.
C. Migliora le modalità di lavoro. È attento alle implicazioni che le proprie decisioni
comportano in termini di costi e di consumo di risorse. Si pone obiettivi di miglioramento. Promuove nuove modalità di lavoro, superando abitudini consolidate poco
produttive. Sa gestire il suo tempo e fissa le priorità in un’ottica di efficienza.
D. Si pone obiettivi sfidanti. La metafora sportiva che più si attaglia al suo modo di agire
è quella dell’atleta di salto in alto che si mette continuamente alla prova alzando sempre più l’asticella. Si prefigge obiettivi che richiedono grande impegno e non risparmia sforzi per realizzarli, conseguendo risultati eccellenti. Pianifica la sua attività in
una prospettiva temporale non limitata al breve periodo. Si assume fino in fondo la
responsabilità delle proprie scelte. Giudica il proprio lavoro con obiettività, raffrontandolo a quello dei colleghi e traendo dal confronto spunti per migliorare.
Di seguito sono riportati alcuni esempi relativi alla competenza Tensione al risultato.
Esempio 1
Livello C della competenza Tensione al risultato
Controllo
“Disponevamo di una metodologia di controllo consolidata, che non mi sembrava
però completa e che, soprattutto, era, a mio avviso, poco efficace per le difficoltà di
comprensione cui dava luogo. Ne erano prova i riscontri negativi in termini di effi-
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
cacia/efficienza. Ho preso perciò il manuale e mi sono messa a riscriverlo, prefiggendomi due obiettivi: rendere più chiara e comprensibile la metodologia ed eventualmente arricchirla di nuovi elementi di controllo. Ho iniziato dalla riscrittura,
perché la comprensibilità mi sembrava l’elemento prioritario”.
108
Esempio 2
Livello D della competenza Tensione al risultato
Consulenza giuridica
Una persona dichiarava il domicilio a Montecarlo ma era stato accertato che
risiedeva in Italia. L’ufficio gli aveva notificato un atto di accertamento. Il contribuente si era dichiarato disponibile ad un accertamento con adesione e calcolammo perciò una percentuale forfetaria dei costi che abbattesse i ricavi per
quanto riguardava le imposte dirette. Proponemmo un abbattimento nella misura del 30%, perché risultava equo in base all’indagine svolta. Per l’IVA, invece, il
versamento con autofattura era stato regolarmente effettuato da chi per legge ha
questo obbligo (cioè da chi riceve la prestazione). Il team di controllo voleva però
procedere ad un accertamento anche per l’IVA. Ho caldamente consigliato di
non farlo, assumendomene tutta la responsabilità, perché mancava a mio avviso
il presupposto, avendo l’Agenzia già riscosso la quota spettante.
Di fatto, si sarebbe determinata una doppia imposizione, con la conseguenza
pressoché certa di un lungo contenzioso, che, con ogni probabilità, avremmo perso, rimettendoci le spese in base al principio della soccombenza. La determinazione con cui ho affermato, senza la minima titubanza, che mi sarei preso tutta
la responsabilità delle conseguenze di quello che proponevo ha indotto i colleghi
a seguire il mio consiglio”.
2.3 Sviluppo e diffusione del sapere
È l’attitudine a sviluppare il proprio patrimonio di conoscenze ed esperienze a
beneficio della propria performance lavorativa e di quella degli stessi colleghi, nei cui
confronti ci si adopera attivamente per mettere in comune l’acquisizione del sapere e
favorire così l’apprendimento organizzativo.
Questa competenza si coglie nei comportamenti che:
• manifestano un forte desiderio personale di crescere professionalmente attraverso lo
studio e l’aggiornamento continuo;
• esprimono una lucida e schietta consapevolezza delle proprie carenze formative;
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
• denotano una seria intenzione di colmare le proprie lacune ed ampliare il proprio
bagaglio professionale;
• tendono a diffondere nell’ambiente di lavoro le conoscenze acquisite.
Considerati nel loro insieme, tali comportamenti consentono di distinguere tra la
persona professionalmente preparata e quella che solitamente si definisce un “topo di
biblioteca”. È la finalizzazione della crescita del sapere che distingue l’una dall’altra. La
prima si differenzia dalla seconda per due motivi: a) sviluppa le proprie conoscenze per
utilizzarle come strumenti di lavoro; b) tende a capitalizzare ciò che apprende a beneficio dei colleghi e dell’organizzazione nel suo complesso.
Indicatori
A. Si accontenta di quello che sa. Le conoscenze che utilizza sono generalmente poche,
insufficienti e non aggiornate. Ne risente visibilmente la qualità e l’affidabilità del suo
lavoro. Ritiene sufficiente il livello di conoscenza raggiunto senza chiedersi se le proprie conoscenze siano adeguate al ruolo che svolge. Considera le iniziative di formazione a cui deve partecipare più come una “pausa lavorativa” che un’occasione di
apprendimento. In sintesi, è la persona cronicamente impreparata: quando la si interroga su qualche questione di lavoro, risponde quasi sempre in modo confuso e
approssimativo; messa alle strette, cerca di cavarsela prendendo tempo, che si guarda
però dall’utilizzare per aggiornarsi un po’.
B. Ha un livello di conoscenza sufficiente per svolgere il lavoro. Integra le proprie conoscenze con l’utilizzo dei mezzi e degli strumenti informativi che l’Agenzia mette a
disposizione per l’aggiornamento. Partecipa attivamente e proficuamente alle iniziative formative dell’Agenzia.
C. Ha un bagaglio professionale ampio e aggiornato che applica per migliorare l’efficacia
del proprio lavoro. Le sue conoscenze gli consentono di risolvere anche problemi
complessi e nuovi e quando gli si chiedono informazioni specifiche sulle materie di
cui si occupa (ad esempio: cosa prevede esattamente quella norma? Come si applica
in questo caso?) la risposta è sempre precisa e completa. Dedica tempo e risorse personali all’aggiornamento, per esempio acquistando libri, consultando quotidianamente
l’Intranet, abbonandosi a riviste del settore, ecc.
D. È l’esperto cui i colleghi si rivolgono. Non limita il suo studio ad alcuni aspetti della
propria attività (ad esempio, quelli che di volta in volta rivestono maggiore urgenza), ma lo estende a discipline e argomenti che gli consentono di avere una visione
più ampia e completa delle problematiche di lavoro. La vasta preparazione e la cura
che dedica all’aggiornamento e all’ampliamento delle proprio sapere ne fanno “l’esperto” dell’ufficio e il punto di riferimento dei colleghi per le problematiche più
complesse.
Di seguito sono riportati alcuni esempi relativi alla competenza Sviluppo e diffusione del sapere.
109
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
Esempio 1
Livello C della competenza Sviluppo e diffusione del sapere
110
Segreteria
“A seguito di una riorganizzazione della struttura operativa nella quale lavoro,
la nuova assegnazione richiedeva una conoscenza dei programmi Word ed
Excel maggiore di quella che avevo. Ho seguito con interesse i corsi organizzati
ed ora riesco a sfruttare le potenzialità dei due programmi e gestisco i documenti in modo più razionale e proficuo. Ho già chiesto di partecipare ai corsi
avanzati”.
Esempio 2
Livello C della competenza Sviluppo e diffusione del sapere
Controllo
“Prima quando non sapevo qualcosa cercavo di cavarmela chiedendo ai colleghi. È inutile nasconderlo: non mi piaceva sgobbare sui libri. Adesso, invece, studio a fondo i singoli casi e, prima di consultarmi con altri, mi impegno a cercare
da solo le soluzioni, riuscendo a gestire il mio lavoro autonomamente. Spesso
consulto testi specialistici per approfondire le materie che tratto e apprendere le
novità del settore in cui lavoro”.
3. Dinamismo relazionale
Le competenze raggruppate in questo cluster sono quelle legate alla relazione e
hanno impatto immediato sulla qualità e sull’efficacia del rapporto interpersonale. La
capacità di costruire relazioni positive e quella di comporre conflitti sono fondamentali sia per creare le condizioni più favorevoli ad un proficuo scambio comunicativo nei
rapporti con i contribuenti, sia per instaurare un clima interno sereno, senza il quale il
lavoro di gruppo e, in più in generale, la cooperazione stentano a produrre effetti significativi. Il dinamismo relazionale interagisce con quello cognitivo, dal momento che
l’attitudine a porsi in modo non conflittuale nel rapporto con gli altri e con il mondo
esterno influenza molto la capacità di comprendere pienamente la realtà circostante e i
suoi mutamenti. Alla base del dinamismo relazionale si ritrova sempre un atteggiamento di fiducia e di sicurezza in se stessi, indispensabile per mettersi in gioco nel
confronto con gli interlocutori, ed essere pronti a riconoscere, in un aperto scambio
dialettico, la validità delle posizioni degli altri senza rinunciare a portare avanti le proprie tesi.
Il cluster comprende tre competenze: Orientamento all’altro, Fare squadra e
Flessibilità.
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
3.1 Orientamento all’altro
“È una persona che sa ascoltare e capire” oppure “è un tipo che si fa in quattro per aiutarti”. Sono queste, di solito, le espressioni che nel linguaggio comune designano “l’orientamento all’altro”. Lo si può definire come la capacità di stabilire relazioni costruttive con gli
altri (contribuenti, colleghi, ecc.), cercando seriamente di comprenderne il punto di vista.
Richiede un paziente lavoro su se stessi in una duplice direzione: sviluppo dell’autocontrollo e affinamento della sensibilità interpersonale.
L’autocontrollo è necessario per evitare di farsi influenzare oltre misura dalle emozioni negative degli altri, precludendosi la possibilità di valutare obiettivamente la situazione e di trovare vie di sbocco al conflitto.
La sensibilità interpersonale è la disposizione ad ascoltare e a porsi in sintonia con
i pensieri, i sentimenti e le preoccupazioni degli altri.
Nel rapporto con i contribuenti – che rappresenta il campo tipico di azione della
competenza in esame – le due dimensioni appena delineate (l’una di interdizione dei propri impeti emotivi e l’altra di apertura ai sentimenti e alle idee altrui) appaiono strettamente intrecciate: l’autocontrollo serve ad impedire che i sentimenti negativi di ansia e di
ira che il contribuente non di rado manifesta nel suo primo approccio all’ufficio inneschino negli operatori reazioni conflittuali destinate ad allontanare la soluzione dei problemi,
se non addirittura a precluderla. La sensibilità interpersonale consente invece di captare e
interpretare le preoccupazioni e le esigenze dei contribuenti, andando anche al di là della
loro formulazione espressa (inevitabilmente non sempre chiara, dato il tecnicismo della
materia). Costituiscono espressione di tale atteggiamento l’attitudine ad adattare lo stile di
comunicazione alla tipologia degli interlocutori (consulente, piccolo imprenditore, pensionato ecc.) e, più in generale, l’impegno forte nell’attività di assistenza e informazione.
Indicatori
A. Si pone in modo brusco, arrogante o indisponente, come colui che detiene un “potere
indiscusso” (e indiscutibile). Considera il contribuente come una fonte di “fastidi”
inevitabili e non mostra alcuna disponibilità a comprenderne i problemi e a dare una
mano per risolverli. Reagisce all’irritazione del contribuente aggredendolo. In generale, non pone attenzione a quanto gli altri affermano, né tanto meno ai sentimenti che
essi provano. Questa difficoltà ad entrare in relazione con l’altro, lo induce a lavorare
quasi esclusivamente “sulle carte”, evitando il più possibile il contatto diretto con gli
interlocutori. Non si preoccupa di appurare se le informazioni che richiede al contribuente non siano già in possesso dell’Agenzia.
B. Opera in maniera professionalmente corretta. Ascolta e dà informazioni esaurienti,
fornendo, ad esempio, chiarimenti e spiegazioni precise sui modelli da compilare. Si
dimostra rispettoso delle opinioni degli altri e disponibile a prenderne in esame senza
preconcetti le argomentazioni.
C. Profonde impegno nel servizio. Assiste il contribuente, fino ad occuparsi personalmente dei suoi problemi (ad esempio, invece di costringerlo a cercare informazioni
111
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
112
disseminate tra più uffici, telefona direttamente ai colleghi per acquisire quelle notizie e le comunica poi all’interessato). È prodigo di spiegazioni e motiva sempre chiaramente le proprie richieste, senza trincerarsi dietro criptiche citazioni normative.
Adegua il proprio comportamento e lo stile di comunicazione alle caratteristiche dell’interlocutore, utilizzando modi e termini appropriati. Ascolta con attenzione le
ragioni del contribuente, senza atteggiamenti di saccenza, e laddove non sia in grado
di fornire compiuta risposta alle sue domande o alle sue osservazioni, non lo liquida
frettolosamente, ma si assume l’impegno (che poi onora) di approfondire la questione
e di comunicargli rapidamente la soluzione.
D. Si mette dalla parte dell’altro. Eccelle nella sensibilità interpersonale: coglie subito
le preoccupazioni che stanno alla base dei comportamenti altrui e ne comprende
intimamente le ragioni, anche al di là della formulazione, non sempre chiara e precisa, che riescono a darne gli stessi interessati. Sa interpretare anche i “bisogni latenti”
dei contribuenti e fornisce servizi non esplicitamente richiesti. È ineccepibile nell’autocontrollo e ne dà dimostrazione pratica riuscendo, per esempio, ad evitare la
tipica trappola emotiva consistente nel trasformare l’irritazione o la rabbia del contribuente in un’occasione di risentita affermazione della propria autorità (ad esempio,
fa “sbollire” un contribuente in preda all’ira, senza farne una questione di leso prestigio personale).
Di seguito sono riportati alcuni esempi relativi alla competenza Orientamento
all’altro.
Esempio 1
Livello B della competenza Orientamento all’altro
Controllo
“Entrato nell’azienda, mostrai il tesserino e la lettera d’incarico dell’ufficio in
modo che la parte sapesse che ero autorizzato, qual era il motivo della verifica e
quali erano gli anni da sottoporre a verifica. Illustrai le modalità, i tempi della verifica e i momenti in cui avrei avuto bisogno della presenza del titolare dell’attività
sottoposta a verifica, dichiarandomi disponibile a fornire ulteriori chiarimenti”.
Esempio 2
Livello C della competenza Orientamento all’altro
Servizi al contribuente
“Venti giorni fa è arrivato un contribuente con una cartella relativa a una tassazione separata. Era convinto di non doverla pagare. Ho pensato che dovevo mettere il
contribuente in condizione di comprendere il motivo per il quale doveva pagare
quell’importo e gli ho illustrato in ordine i singoli passaggi. Ho cercato le informa-
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
zioni sul terminale, le ho stampate e le ho mostrate al contribuente. Gli ho spiegato
che si trattava di un conguaglio d’imposta, perché l’importo trattenuto dal datore di
lavoro era inferiore al dovuto. Per spiegarmi ho fatto ricorso ad un esempio pratico:
‘Ha presente la bolletta del gas? Il cliente versa degli acconti e poi alla fine dell’anno, se ha consumato di più, deve pagare un conguaglio. Lo stesso accade con le
trattenute fatte dal datore di lavoro che sono dei versamenti in acconto’. Il contribuente si è convinto ed ha accettato visibilmente soddisfatto la mia risposta”.
Esempio 3
Livello C della competenza Orientamento all’altro
Servizi al contribuente
“Il contribuente si presentò senza la cartella. Gli chiesi: ‘Di che anno è?’. Risposta:
‘L’ho ricevuta di recente’. ‘E cosa c’è scritto?’ ‘Non me lo ricordo’. Come inizio, non
era male… Pensai allora di chiedergli: ‘Di che colore è?’ Di solito i contribuenti si
ricordano del colore e in effetti se lo ricordava anche quel contribuente. Il colore mi
fece pensare agli atti del registro. ‘Di quanti fogli è formata la cartella?’ ‘Un solo
foglio.’ Il numero di fogli è indicativo della natura dell’avviso. Poteva essere un avviso di mora, perché, ad esempio, la correttiva ha un numero di fogli maggiore.
Quindi gli chiesi: ‘Ha ricevuto altre cartelle di recente?’ ‘No’. La risposta non mi
convinse perché le informazioni sembravano in contrasto tra loro.
Ho fatto delle interrogazioni. Ebbi la conferma di ciò che pensavo: era un avviso
di mora originato da una cartella relativa a una vecchia compravendita della
quale il contribuente non si ricordava più.
Stampai quello che appariva sul video e glielo consegnai, spiegandogli di cosa si
trattava”.
Esempio 4
Livello D della competenza Orientamento all’altro
Servizi al contribuente
“Un giorno è arrivata in ufficio una contribuente agitata e molto nervosa. Mi
sono avvicinata e le ho chiesto se potevo aiutarla. Risposta: ‘Ho poco tempo a
disposizione e devo prendere mio figlio all’uscita di scuola. Qui c’è una lunga
fila e non riuscirò sicuramente a fare in tempo!’. La vedevo sempre più agitata.
Ho cercato di calmarla un po’ dicendole: ‘Può passare avanti, se gli altri davanti
a lei sono d’accordo.’ Nessuno però ha accettato di cederle il proprio posto nella
fila. Sentivo che dovevo fare di tutto per aiutarla. ‘Mi lasci l’atto ed il suo numero
di prenotazione. Ci penso io. Torni all’ora di chiusura e vedrà che la sua pratica
sarà pronta.’ Quando la coda si esaurì, chiesi alla mia collega di sbrigare la pratica. La contribuente rimase molto sorpresa: ‘Non me lo sarei mai aspettato. Lei
ha fatto per me qualcosa che nulla e nessuno la obbligava a fare’ ”.
113
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
3.2 Fare squadra
114
È la capacità di instaurare un rapporto permanente di collaborazione stretta con i
propri colleghi in funzione di obiettivi comuni. Nelle organizzazioni il lavoro di gruppo
(inteso non come soluzione transitoria ed occasionale limitata a particolari evenienze, ma
come “mattone” dell’edificio organizzativo) non è stato sempre considerato con favore e
lo si è anzi guardato a lungo con sospetto, nella convinzione che potesse solo attivare meccanismi di deresponsabilizzazione (“un lavoro di cui tutti sono responsabili, è un lavoro
di cui nessuno più è responsabile”). Per molto tempo questo modello organizzativo ha
avuto applicazione stabile ed estesa solo in miniera, dove la vita di ognuno è legata all’efficienza della squadra di cui fa parte e ai legami di solidarietà che la cementano (ed è
infatti proprio dal lavoro in miniera che ha preso avvio in letteratura, attorno agli anni ’40
del ’900, una riflessione approfondita sui presupposti e sulle dinamiche del lavoro di
gruppo, come modalità fondamentale di prestazione dell’attività lavorativa). Oggi, il lavoro di team si va progressivamente affermando come la soluzione più efficace per lo svolgimento di funzioni che hanno elevata complessità, forte varianza e stretta interdipendenza
(tali sono, per lo più, le funzioni legate alla prestazione di servizi che richiedono il concorso coordinato di conoscenze altamente specialistiche e in continua evoluzione). Un
team non vive, né tanto meno riesce a funzionare bene, se abbandonato alla spontaneità
delle sue dinamiche interne. Da questo punto di vista, lavorare in team (che non è, giova
ripeterlo, il convergere episodico di individualità che, terminato il compito, riprendono
poi ognuna la propria strada) è tutt’altro che facile e “naturale” e, per certi versi presenta
anzi difficoltà analoghe a quelle della quadratura di un cerchio. In altri termini, occorre
che ciascuno dei componenti del gruppo accetti come compito proprio quello di disciplinare spinte contrapposte o comunque potenzialmente divergenti, senza però soffocare le
energie di nessuno ed anzi assicurandone il pieno sviluppo. Cosa comporta tutto questo?
Dare spazio ai talenti individuali, spegnendo però sul nascere eventuali competizioni
destinate a corrodere lo spirito di gruppo. Richiamare, quando occorre, la necessità del
rispetto degli obblighi comuni, evitando però di alimentare l’istinto gregario. Favorire lo
scambio aperto di esperienze e conoscenze, senza però mai smarrire, nella discussione,
l’urgenza ineludibile del momento decisionale. Coniugare, insomma, autonomia individuale e senso di appartenenza. In termini di comportamenti organizzativi, sono queste le
condizioni che consentono ai componenti di un gruppo di operare efficacemente insieme.
Indicatori
A. Fa il “solista”. Preferisce lavorare da solo. Ritiene che lavorare con gli altri, soprattutto se più inesperti di lui, determini solo una perdita di tempo. Si limita a fare ciò che è
di sua stretta competenza. È piuttosto geloso delle proprie conoscenze e tiene per sé
informazioni che potrebbero invece essere utili anche ai colleghi. Chiede o dà aiuto
agli altri solo se è inevitabile. Può capitare che manifesti in modo non appropriato
opinioni diverse da quelle del collega anche davanti al contribuente, senza preoccuparsi dell’impatto negativo che ciò può avere per l’immagine dell’Agenzia.
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
B. Collabora. Ha un atteggiamento positivo verso il lavoro di gruppo (per esempio, aiuta
i colleghi in difficoltà). Di fronte ai contribuenti, tende sempre a sottolineare le posizioni su cui concordano i componenti del team e se deve evidenziare eventuali divergenze interne, lo fa comunque con toni misurati, spiegando come la diversità dei punti di vista sia obiettivamente giustificata dall’opinabilità della materia. Mette in comune le informazioni di cui dispone e mantiene aggiornati i colleghi.
C. Fa lavoro di squadra. Agisce in sintonia con i colleghi, concordando con loro piani di
azione e sollecitandone il contributo. Partecipa attivamente con il proprio lavoro e
con la propria esperienza al raggiungimento degli obiettivi del gruppo. Offre spontaneamente il proprio aiuto, senza aspettare che i colleghi glielo chiedano. Si confronta
con i componenti del team mettendo a disposizione informazioni e conoscenze per
sviluppare insieme nuove idee e realizzare progetti.
D. Fa da punto di riferimento nel gruppo. È convinto che il singolo possa vincere solo
insieme alla squadra e, di conseguenza, fa di tutto per formarla. Instaura un rapporto
di fiducia con i colleghi, cerca un approccio comune alle situazioni, difende le posizioni del gruppo, favorisce lo scambio sistematico delle informazioni all’interno della
squadra, promuove la ricomposizione dei diversi punti di vista tra i colleghi con l’intento sia di rendere più efficace l’azione comune, sia di trasmettere all’esterno un’immagine di unità e di coesione tale da rafforzare il prestigio del gruppo.
Di seguito sono riportati alcuni esempi relativi alla competenza Fare squadra.
Esempio 1
Livello B della competenza Fare squadra
Consulenza giuridica
“Un collega impegnato in un accertamento riguardante una cessione di azienda
fatta da un minore, mi chiede: ‘Non so dove trovare riferimenti normativi per
questo caso. Cerchiamo di vedere insieme cosa possiamo fare’. Non avevo la
risposta pronta. Abbiamo letto il TU, il codice commentato, il manuale di diritto
civile. Abbiamo collegato due norme ed elaborato insieme la soluzione. Andrà
dal suo capo con la nostra proposta. Mi ha ringraziato, era soddisfatto”.
Esempio 2
Livello C della competenza Fare squadra
Controllo
“Se sono in verifica con un collega meno esperto devo fargli capire il motivo di
certe scelte e di determinati comportamenti. Spendere un po’ di tempo per trasferire conoscenze non allunga invano i tempi di lavoro: non sono geloso di quel-
115
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
116
lo che so. Non penso mai che un collega meno esperto possa dire stupidaggini,
qualsiasi idea può essere utile.
Quindi tutto il lavoro viene fatto insieme e c’è un effettivo scambio di informazioni. Bisogna dare un’immagine di coesione e di unitarietà di fronte al contribuente, stando bene attenti ad evitare che chi guarda dall’esterno pensi che il
gioco prevalente nel nostro gruppo sia quello di gareggiare a chi è più bravo”.
3.3 Flessibilità
Nel linguaggio comune, una persona flessibile è quella che “si sa adattare” alle circostanze. L’espressione può essere accettata, purché non le si dia una connotazione di
“adeguamento passivo” o, peggio, “camaleontico” alle dinamiche del cambiamento. In
un contesto organizzativo in evoluzione, la flessibilità esprime piuttosto la versatilità a
lavorare in differenti situazioni o con diverse persone o gruppi, nella convinzione di
ampliare così il proprio bagaglio professionale e di acquisire, fino a rendersene padroni,
nuovi e più produttivi schemi di organizzazione del lavoro (rientrano, ad esempio, fra
questi schemi l’integrazione delle professionalità nel lavoro di team e lo sviluppo della
polifunzionalità nelle attività di base). Oltre alla capacità di comprendere le logiche
secondo cui evolvono le situazioni, la flessibilità implica anche una disponibilità di fondo ad apprezzare – senza preclusioni e rigidità – differenti o contrastanti prospettazioni
di un problema, mostrandosi aperti al confronto e pronti a riconoscere la validità delle
tesi altrui, invece di arroccarsi in atteggiamenti di difesa ad oltranza delle proprie tesi
quando queste vengono poste in discussione con argomenti convincenti.
Indicatori
A. È avverso ai cambiamenti. Rimane caparbiamente attaccato alle proprie idee anche
contro l’evidenza dei fatti e non fa alcuno sforzo per comprendere punti di vista diversi dal suo. È restio ad assumere nuovi compiti. È ostile ai cambiamenti che vede come
una minaccia al proprio consolidato modo di lavorare.
B. Si uniforma al cambiamento. Avverte il cambiamento come una necessità dettata dal
mutare delle situazioni e alla quale non può sottrarsi. È comunque disponibile a confrontarsi apertamente, senza preconcetti e pregiudizi, con nuove idee e a prendere in
seria considerazione la possibilità di modificare schemi e atteggiamenti consolidati.
Nelle trasformazioni in atto, l’aspetto cui presta maggiore attenzione non è però tanto
quello della comprensione delle logiche sottostanti, ma, piuttosto quello della conformità estrinseca alle prescrizioni e alle procedure, che non gli sembrano mai abbastanza “chiare e precise”.
C. Accoglie con favore il cambiamento. Vive positivamente la trasformazione dei compiti e degli schemi di lavoro, interpretandoli, in primo luogo, come una risposta all’esi-
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
genza di migliorare i servizi nell’interesse della collettività, e, in secondo luogo, come
una preziosa opportunità di arricchimento professionale. Nell’applicazione delle
regole e delle procedure, dà prova di duttilità, evitando inutili formalismi e cavilli
burocratici e adottando, fra più opzioni tutte legittime, quella meglio rispondente agli
obiettivi da perseguire e più ragionevole ed equilibrata sotto il profilo della ponderazione degli interessi in gioco.
D. Promuove il cambiamento. Modifica i propri programmi adattandoli all’evoluzione
del contesto. Coinvolge i colleghi per facilitare la diffusione del cambiamento, senza
scoraggiarsi di fronte ad ostacoli e imprevisti. Promuove nuove soluzioni operative
volte a favorire la trasformazione dei modelli organizzativi e degli schemi di lavoro.
Mostra forte propensione al cambiamento, senza però cadere in atteggiamenti acritici
che eludono le difficoltà ed evitano il necessario confronto con persone di diverso
orientamento e approccio rispetto ai processi di trasformazione in atto.
Di seguito è riportato un esempio relativo alla competenza Flessibilità.
Esempio 1
Livello C della competenza Flessibilità
Riscossione
“Stavo lavorando su un fallimento, quando mi sono resa conto che mancavano
diversi dati.
A questo punto ho contattato il curatore che ci ha aiutato a ricostruire molti dati.
Ho deciso di convocarlo informalmente, evitando di seguire l’iter procedurale
classico (la formalizzazione ufficiale dell’atto) che avrebbe sicuramente allungato i tempi se il curatore lo avesse impugnato. Questa scelta mi ha consentito di
accorciare il procedimento e di emettere un atto che ha avuto buon fine”.
4. Leadership
Per leadership si intende qui la capacità di pianificare e coordinare l’attività di un
gruppo di persone per raggiungere gli obiettivi assegnati. Il leader può anche non avere un
potere gerarchico. L’autorità che gli è riconosciuta deriva principalmente dalla sua autorevolezza, cioè dalle sue riconosciute capacità di gestione, dalla sicurezza che dimostra di avere
dentro di sé e che sa infondere negli altri nelle situazioni critiche, dall’abbinamento, infine,
di un elevato livello di conoscenza tecnico-professionale con l’attitudine a trasferirla e diffonderla nei colleghi e, più in particolare, nei componenti del gruppo che gli è stato affidato.
I comportamenti tipici di questo cluster trovano analitica descrizione nelle competenze Team building (Organizzazione e sviluppo di un gruppo) e Influenza.
117
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
4.1 Team building (Organizzazione e sviluppo di un gruppo)
118
È la capacità di guidare un gruppo e di indirizzarne l’azione al raggiungimento
degli obiettivi. In termini di “saper fare”, i tratti che denotano in modo caratteristico il
possesso di tale capacità sono:
• saper pianificare, organizzare e monitorare il lavoro del gruppo, mantenendone e rafforzandone la coesione interna;
• saper svolgere un paziente e metodico lavoro di diffusione delle conoscenze all’interno del gruppo, sviluppandone la professionalità.
Di seguito vengono descritti gli indicatori comportamentali relativi ai diversi livelli di intensità della competenza in questione. In estrema sintesi, il livello A si distingue
essenzialmente da quello B, per il fatto che mentre nel primo le risorse del gruppo non
vengono utilizzate (le potenzialità del gruppo sono come “sprecate”), nel secondo sono
invece impiegate, seppure senza sfruttarle totalmente. Nel livello C vi è un’utilizzazione
ottimale o comunque più che soddisfacente del gruppo (in termini matematici, si direbbe
che si “saturano” le capacità attuali del gruppo), mentre nel livello D il gruppo viene portato, per così dire, “al di là di se stesso”, nel senso che si va oltre la meta di utilizzarlo
appieno nel suo attuale valore, e si punta invece ad accrescere in misura significativa tale
valore (in questa prospettiva, il teamleader eccellente è quello che consegna al suo successore un team molto più motivato ed efficiente di quello che gli era stato affidato).
Indicatori
A. Non sa gestire il gruppo. Non ha abilità organizzativa. Non definisce piani d’azione per il
gruppo, né individua in modo chiaro le priorità; oppure le cambia inopinatamente, senza
adeguata motivazione e senza considerare le implicazioni delle sue scelte sulle attività
del gruppo, che viene ad esserne disorientato. Non si preoccupa di verificare se il livello
delle conoscenze del gruppo è sufficiente a svolgere con efficacia i compiti assegnati.
B. Sa gestire il gruppo. Propone al gruppo obiettivi chiari e ne organizza l’azione definendone le priorità. Si accerta che il gruppo possieda le informazioni e le conoscenze
sufficienti per agire in modo corretto ed efficace.
C. Ottimizza le attività del gruppo. Intraprende azioni specifiche per accrescere quanto
più possibile il livello di operatività del gruppo. Per esempio, pianifica in modo molto
accurato le attività, assegna compiti calibrati rispetto alle capacità dei singoli, fornisce
strumenti e risorse per l’organizzazione del lavoro, attiva iniziative di formazione,
curandone anche personalmente lo svolgimento.
D. Fa crescere il gruppo, curandone il clima interno. È attento ai fattori che possono
favorire o compromettere l’armonia tra i componenti del gruppo. Facilita e promuove
lo scambio di informazioni e di conoscenze all’interno del gruppo e tiene abitualmente riunioni per comunicare l’andamento delle attività e dei risultati. Ricerca attivamente il contributo di tutti per migliorare l’efficacia del gruppo e valorizzare le competenze di ciascuno.
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
Di seguito sono riportati alcuni esempi relativi alla competenza Team building.
Esempio 1
Livello C della competenza Team building
“Ho pensato di fornire ulteriori elementi affinché gli operatori si potessero sentire più preparati per rispondere ai quesiti durante il periodo delle dichiarazioni.
Nelle ore che precedono il servizio ho fatto un lavoro di lettura del modello unico. È scritto in modo molto tecnico e ho capito che dava luogo a difficoltà di
comprensione. Ho chiesto: volete che lo leggiamo insieme? Sono stati contenti,
hanno imparato tanta nuova terminologia. Alla fine mi hanno ringraziato”.
(Team leader di un call center)
Esempio 2
Livello D della competenza Team building
“Ho messo nella stessa stanza persone che provenivano dalle IIDD con altre provenienti dall’IVA perché potessero imparare le une dalle altre. Io per primo, che
provengo dal mondo IVA, mi sono messo in stanza con un collega che veniva
dalle IIDD. Questo però non bastava per assicurare un’efficace organizzazione
interna del gruppo. In passato il funzionario faceva l’accertamento a mano e lo
passava al terminalista che lo inseriva a sistema. Oggi il funzionario deve farlo
da solo e se non ha perciò familiarità con un computer il lavoro si blocca. Mi
sono quindi messo a fianco di persone che non conoscevano il computer e ho
insegnato loro ad usarlo”. (Capo del team legale di un ufficio locale)
4.2 Influenza
È la capacità di sostenere con successo le proprie tesi e di convincere gli interlocutori della loro fondatezza. L’influenza è un aspetto importante della leadership, dal
momento che la possibilità di ottenere dagli altri sostegno e collaborazione dipende in
larga misura dalla propria capacità di persuasione. Questa competenza attinge sia alla
ricchezza dell’emotività che alle risorse dell’intelligenza. Sotto il primo aspetto è richiesta, infatti, una sensibilità particolare (la si chiama talora “empatia”) per riuscire a percepire, magari da dettagli apparentemente poco significativi, quali siano le preoccupazioni
e le esigenze (non sempre chiaramente esplicitate) da cui l’interlocutore è mosso, in
modo da selezionare di conseguenza i canali comunicativi e il linguaggio più appropriati
al contesto della discussione. Sempre sotto l’aspetto emotivo, è indispensabile inoltre
forza di carattere e autocontrollo, per mantenere calma e sicura l’esposizione del proprio
punto di vista, specie quando incontra opposizioni più o meno forti.
119
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
120
Per quanto invece riguarda il versante più strettamente intellettuale, la capacità di
convincere richiede attitudine ad argomentare la propria posizione in modo chiaro e coerente e a controbattere tempestivamente con ragionamenti validi e pertinenti le altrui obiezioni.
Nella graduazione della competenza in esame occorre quindi tenere al tempo stesso conto di due fattori:
• maggiore o minore sensibilità e padronanza emotiva richieste per far fronte all’ambiguità, all’imprevedibilità e allo stress propri della situazione in cui deve esercitarsi lo
sforzo di convinzione degli interlocutori;
• maggiore o minore complessità intellettuale degli argomenti che, nel contesto di riferimento, è necessario produrre per convincere gli interessati.
Indicatori
A. Non è capace di convincere. Ha difficoltà a sostenere una tesi e ad argomentarne con
chiarezza e con tratto sicuro i punti salienti. Può essere, ad esempio, prolisso, pedante
o troppo assertorio nell’esposizione, indisponendo l’interlocutore, oppure si presenta
in modo titubante e mostra poca convinzione nelle proprie opinioni. In definitiva,
non sa con-vincere e riesce solo a vincere, quando può eventualmente appellarsi al
ruolo formale rivestito.
B. In situazioni normali sa convincere. Nelle situazioni che non presentano particolare
complessità per le variabili in gioco e nelle quali il confronto con gli interlocutori si
evolve in modo abbastanza conforme alle previsioni iniziali, senza assumere forte
coloritura emotiva, riesce a produrre argomenti chiari e plausibili, che trovano il consenso degli interessati.
C. Ha buone capacità dialettiche. Riesce in genere a prevedere le mosse dell’interlocutore
e ne tiene conto nell’elaborazione e nello svolgimento delle proprie argomentazioni.
Non rimane comunque smarrito di fronte a obiezioni non previste, anche laddove investano questioni complesse, ma reagisce prontamente, sfoderando argomenti persuasivi.
D. Attua strategie di persuasività. Programma e mette in atto, anche in situazioni di particolare complessità, più iniziative coordinate, volte, nel loro insieme, a influenzare e
convincere gli interessati. Sa rapportarsi ad una molteplicità, anche assai eterogenea, di
interlocutori diversi, mostrando notevole abilità nella scelta e nella modulazione dello
stile comunicativo e degli schemi argomentativi per persuadere coloro che ha di fronte.
Di seguito sono riportati alcuni esempi relativi alla competenza Influenza.
Esempio 1
Livello C della competenza Influenza
Consulenza giuridica
“Nel corso di un’udienza l’avvocato del contribuente ha eccepito il vizio della
mancata costituzione in giudizio dell’ufficio. Il momento era delicato, perché
DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
l’ufficio in effetti non si era fino allora costituito e la posizione dell’Amministrazione appariva a quel punto compromessa. Ma ho avuto la prontezza di sfruttare
il fatto che la parte aveva chiesto la pubblica udienza. Sono intervenuto al dibattimento sostenendo che, secondo la normativa vigente, chi è presente in aula può
parlare. Facendo poi appello alle mie conoscenze ho aggiunto: ‘L’ufficio può
costituirsi anche in udienza: è un principio di diritto civile applicabile anche al
processo tributario’ ”.
Esempio 2
Livello D della competenza Influenza
Servizi al contribuente
“Nel mio ufficio c’erano cinque sportelli dedicati a cinque servizi diversi. Quattro su cinque avevano un flusso contenuto di contribuenti mentre uno aveva
sempre persone in coda. La situazione era insostenibile: presso uno sportello si
lavorava senza tregua, negli altri c’erano parecchi tempi morti. Ho segnalato al
Capo Area questa criticità.
Sapevo che non sarebbe stato facile parlare di polifunzionalità, cioè della possibilità di distribuire tutte le attività su più sportelli, perché da parte degli operatori c’era la paura di dover svolgere compiti nuovi e quindi di sbagliare. Bisognava
superare le resistenze interne.
Dopo i corsi, al momento dell’avvio dello sportello polifunzionale, ho coinvolto il
collega che tra i cinque addetti allo sportello mi sembrava più convinto della
bontà dell’operazione. Gli dissi: ‘Domani facciamo in questo modo: apriamo
quattro sportelli su cinque e tu parti con quello polifunzionale. Ognuno degli
altri quattro colleghi liberi osserverà a turno come lavori. Vorrei che si capisse
che il lavoro allo sportello polifunzionale è fattibile e che variare attività durante
la giornata può rappresentare un arricchimento professionale’. Il giorno dopo
abbiamo fatto come concordato e, pure in un momento di picco d’affluenza, ho
notato che gli altri colleghi che hanno ruotato come osservatori sembravano
meno intimoriti. Ho continuato l’esperimento per una settimana e al termine,
alla mia richiesta di aprire a turno uno sportello polifunzionale, nessuno si è
tirato indietro”.
121
APPENDICE
123
APPENDICE
125
1. Testare la competenza invece dell’“intelligenza”*
L’avvio del cosiddetto “Movimento delle competenze” viene generalmente fatto
risalire ad un famoso articolo di McClelland del 1973, dal titolo Testing for Competence
Rather Than for “Intelligence”, che si può tradurre: Testare la competenza invece
dell’“intelligenza”. È da notare che nel titolo dell’articolo la parola “intelligenza” è riportata fra virgolette, poiché McClelland intendeva riferirsi non all’intelligenza in sé, ma
all’intelligenza quale pretendevano di misurare i tradizionali test di abilità intellettiva.
Leggendo l’articolo, si incontrano di continuo frasi come “predict (predire) la performance superiore” e “individuare predictors (indicatori) di performance superiore”. Le
parole predict e predictors, e altre simili, costituiscono tipiche espressioni di una ricerca
che ambisce ad essere scientificamente valida, dal momento che la validità di una teoria
scientifica risiede appunto nella sua capacità di prevedere, sulla base di determinate ipotesi esplicative, un certo corso di eventi.
L’articolo apparve sulla rivista American Psychologist (1973, n. 1, pp. 1-14), pubblicata dall’Associazione degli psicologi americani. Quasi venti anni dopo, la stessa
rivista (1991, n. 10, pp. 1012-1024) pubblicò un articolo dal titolo A Reconsideration of
Testing for Competence Rather Than for Intelligence, di Gerald V. Barrett e Robert L.
Depinet, nel quale gli autori, dopo aver riconosciuto la vasta adesione che aveva nel
frattempo avuto l’impostazione di McClelland, la sottoponevano ad una analisi fortemente critica, riaffermando la tesi che i tradizionali test di abilità intellettiva rappresentavano i migliori predittori del successo nel lavoro e non davano luogo a discriminazioni a danno delle minoranze, delle donne e dei ceti sociali meno abbienti. Tre anni dopo,
sempre in quella rivista (1994, n. 1), apparvero le risposte di Boyatzis (Rendering Unto
Competence the Things That Are Competent, pp. 64-66) e dello stesso McClelland (The
Knowledge-Testing-Educational Complex Strikes Back, pp. 66-69), assieme alla controreplica di Barrett (Empirical Data Say it All, pp. 69-71). Per il suo elevato tecnicismo,
non avrebbe senso dibattere ulteriormente in questa sede una problematica – peraltro
solo collaterale all’oggetto principale di questo manuale – qual è quella del valore pre-
* Vengono qui approfonditi temi trattati a p. 17.
APPENDICE
126
dittivo che i cosiddetti test d’intelligenza hanno rispetto al successo delle prestazioni di
lavoro (problematica invece molto viva negli Stati Uniti, dove quei test hanno da tantissimo tempo una enorme rilevanza sociale che in Italia non hanno mai avuto). Di sfuggita
si può qui solo osservare che, secondo un’opinione comune – banale quanto si vuole,
ma non per questo meno vera –, il più bravo chirurgo di un ospedale (per citare solo un
esempio) difficilmente potrà anche esserne il miglior direttore (non di rado, anzi, si
rivela un mediocre se non un pessimo direttore ospedaliero), poiché, come si dice, si
tratta di mestieri molto diversi. È indubbio che occorrono elevate capacità intellettive
per svolgere sia l’uno che l’altro mestiere, ma ci deve essere allora qualcos’altro che
spiega perché un eccellente chirurgo è spesso incompetente per il lavoro di direttore
sanitario. Ebbene, come possono cogliere questo “qualcos’altro” test puntati solo a rilevare l’“intelligenza”?
Può essere utile, infine, una precisazione terminologica. In inglese esistono due
vocaboli – “competence” e “competency” – al posto dell’unico vocabolo italiano “competenza”. Nell’uso comune, queste due parole inglesi hanno lo stesso significato (l’unica
differenza è che competence è più frequente
di competency). Nell’approccio di McClelCompetency (competencies) → Competence
land, il termine competency ha invece un
significato tecnico: è una categoria di comportamenti dai quali dipende il giudizio se la persona abbia o no competence nel lavoro
(Competence at Work è appunto il titolo del libro di Spencer & Spencer più volte citato,
che non si chiama infatti “Competency at Work”, mentre il Dizionario generale delle
competenze contenuto in quel libro si chiama “Competency Dictionary” e non “Competence Dictionary”). La competency – o, più precisamente, un insieme di competencies
(che è il plurale di competency, mentre il plurale di competence è competences) – è la
causa della competence lavorativa. In una sua intervista, McClelland spiega così la cosa:
“‘Competency’ è un termine che abbiamo introdotto in sostituzione della parola più breve: ‘skill’ (capacità). Negli Stati Uniti si può frequentare un istituto tecnico professionale
per imparare il mestiere di addetto a una stazione di servizio. Si apprende a svitare tappi,
mettere la benzina, e così via. Ma in base alle mie osservazioni, tutto questo è relativamente poco importante per determinare quanto spesso un automobilista si fermerà a una
stazione di servizio. È più importante che l’operatore sorrida al cliente o abbia invece un
fare accigliato. Così abbiamo sviluppato una competency chiamata ‘orientamento al
customer service’, che copre un ampio spettro di modalità di ‘being nice to customers’
(‘essere gentili con i clienti’). La chiamammo una ‘competency’ perché è ovviamente
qualcosa di più che delle semplici ‘skills’. Essa copre una varietà di tipi di azioni, ognuno dei quali è incluso nella definizione che nel dizionario si dà di quella particolare
competency. Ci sono specifici comportamenti behind (dietro) ogni competency e sono
tutti suscettibili di osservazione”71.
71 L’intervista fu rilasciata da McClelland nel 1997, l’anno prima della sua morte. Il testo completo è consultabile su Internet: http://competencyandei.com/Interview-with-David-McClelland.
APPENDICE
2. I “superior performers” e il concetto di deviazione standard*
Nella letteratura la nozione di superior performers è collegata al concetto statistico
di deviazione standard. I superior performers sono coloro che eseguono performance
pari a una deviazione standard al di sopra della
La statistica
performance media, collocandosi quindi – in
una distribuzione normale a 4 fasce (inferiori,
Sai ched’è la statistica? È na cosa
che serve pe’ fa’ un conto in generale
medio-inferiori, medio-superiori, superiori) –
de la gente che nasce, che sta male
nella fascia “top” del 15% dei componenti di
che more, che va in carcere e che spòsa.
Ma pe’ me la statistica curiosa
un’organizzazione. La nozione di deviazione
è dove c’entra la percentuale,
standard può essere resa facilmente comprensipe’ via che, lì, la media è sempre eguale
bile ricordando il noto apologo di Trilussa
puro co’ la persona bisognosa.
Me spiego: da li conti che si fanno
secondo cui se una persona mangia due polli e
secondo le statistiche d’adesso
una non ne mangia nessuno, per la statistica
risurta che te tocca un pollo all’anno:
conterebbe solo questo: che le due persone hane, se nun entra ne le spese tue,
t’entra ne la statistica lo stesso
no mediamente mangiato un pollo a testa. L’eperché c’è un antro che ne magna due.
quivoco non sarebbe possibile se, insieme alla
Trilussa
media, fosse anche indicata una misura della
dispersione rispetto alla media, una misura cioè
di quanto, mediamente, i valori dati si discostino dalla loro media. In statistica, la misura
generalmente utilizzata per calcolare la dispersione di una serie di valori rispetto alla
media è appunto la deviazione standard72.
* Vengono qui approfonditi temi trattati a p. 18.
72 La deviazione standard (indicata con la lettera greca σ, cioè sigma minuscolo) è uguale alla radice quadrata
della media aritmetica della somma dei quadrati degli scarti dei valori dalla media. Sentendo questa formula, e ancor più leggendo come si scrive:
è possibile che il lettore non avvezzo alle tecniche statistiche sia tentato dallo stesso atteggiamento cui
desiderava abbandonarsi il maresciallo Göring quando sentiva parlare di “cultura”: mettere mano alla fondina della pistola. Riflettendoci un po’ sopra, la cosa è però alla fine meno complicata di quanto potrebbe
sembrare, e del resto il concetto di deviazione standard è di uso diffusissimo nei sistemi di valutazione,
sicché vale la pena dedicarvi uno sforzo minimo per acquisirne sufficiente padronanza. Se abbiamo 3 valori – ad esempio 3, 4 e 8 – la loro media aritmetica è 5. Di quanto si scostano mediamente questi tre valori
dalla media? Rispetto a 5 (che è appunto la media) 3 ha uno scarto di 2, 4 uno scarto di 1 e 8, infine, uno
scarto di 3 (è chiaro che bisogna tenere qui conto solo dei valori assoluti, poiché altrimenti la loro somma –
cioè +2, +1, -3 – non potrebbe che dare 0). Se sommiamo questi tre scarti (2+1+3) e dividiamo la somma per
3, otteniamo uno scostamento medio di 2 (in statistica si chiama “scostamento semplice medio”). Gli statistici, però, invece di sommare gli scarti semplici dei valori dalla media, preferiscono sommare i quadrati
degli scarti dalla media. Nel nostro caso la somma degli scarti sarebbe: 22+12+32 = 14. Dopo di che si divide
la somma per 3 e se ne estrae la radice quadrata: il risultato è 2,16. Questa è la deviazione standard e il calcolo che abbiamo appena fatto altro non è che l’applicazione della formula – apparentemente tanto astrusa
– riportata all’inizio di questa nota. Ma perché gli statistici preferiscono sommare i quadrati degli scarti
dalla media, anziché gli scarti semplici? Con l’operazione di elevamento al quadrato degli scarti, l’effetto
matematico è di amplificare notevolmente il peso degli eventuali valori anomali in una distribuzione di
dati (valori anomali sono quelli che si discostano molto dalla media aritmetica e quindi dalla netta maggioranza dei valori della distribuzione stessa), facendo così spostare verso di essi l’indice di variabilità. Di
127
APPENDICE
128
Se è concettualmente chiara la nozione di superior performers, potrebbe però sembrare un punto debole della ricerca di McClelland il fatto che egli abbia demandato
all’Amministrazione il compito di individuare in concreto il campione dei superior performers. In altre parole, chi ci dice che l’Amministrazione non potesse sbagliare in questa opera di individuazione, segnalando come superior performer chi in realtà non lo era
e omettendo invece di segnalare persone che lo erano veramente? Naturalmente, l’errore
singolo è sempre possibile, ma – a parte la considerazione che non si vede chi potesse
mai ritenersi abilitato a fare quella scelta in alternativa all’Amministrazione – McClelland non ha lavorato con singoli superior performers, ma con gruppi statisticamente
significativi73, che non comprendevano solo persone caratterizzate da elevata performance, ma anche average performers. Va inoltre osservato che il metodo dell’intervista
BEI stabilisce che gli intervistatori non debbano conoscere a quale campione appartenga
la persona intervistata, proprio per evitare condizionamenti di giudizio nello svolgimento dell’intervista e nella sua successiva codifica74.
Un metodo di individuazione delle competenze che prescinde da una previa individuazione di best performers e di average performers è quello dell’analisi funzionale,
che ha però l’inconveniente di individuare solo le competenze soglia, ma non le competenze distintive (quelle cioè che spiegano la performance superiore). Si tratta quindi di
un metodo che, se ha il vantaggio di non richiedere una individuazione a priori dei bravi
e dei meno bravi, ha però il torto di non consentire questa individuazione neanche a
posteriori. La questione viene meglio chiarita a p. 131.
Un altro approccio, molto originale, che non richiede di individuare preventivamente un campione di best performers è quello di un ricercatore svedese, Jörgen Sandberg, che ha fatto uno studio presso gli stabilimenti Volvo coinvolgendo un gruppo di
ingegneri impegnati nel lavoro di ottimizzazione dei motori. Intervistando un campione
significativo di questi ingegneri, Sandberg scopre che essi non hanno la stessa concezione
conseguenza, la deviazione standard assume valori tanto più elevati dello scostamento semplice medio,
quanto maggiore è lo scarto tra i valori anomali della distribuzione e la media aritmetica. In sostanza, la
deviazione standard è – rispetto allo scostamento semplice medio – un indice di variabilità che meglio rappresenta l’esistenza di valori anomali all’interno di una distribuzione. Nell’esempio che abbiamo fatto, la
deviazione standard è 2,16, e quindi è di pochissimo superiore allo scostamento semplice medio. La forbice tenderebbe a crescere, e di molto, quanto più fosse anomala la distribuzione dei dati.
Torniamo ora all’apologo di Trilussa. Lì, se facciamo i conti, la deviazione standard è 1. Domanda: 1 è un
valore basso o elevato? Dare una risposta in assoluto non avrebbe senso: essa dipende, evidentemente, dal
valore della media da cui ci si discosta. Poiché in quel caso la media è anch’essa pari a 1, una deviazione
standard uguale a 1 sta a significare che i due valori posti a raffronto (due polli e zero polli) hanno uno
scarto in più o in meno rispetto alla loro media che è uguale a ben il 100% della media stessa (in statistica
il rapporto fra deviazione standard e media aritmetica si chiama “coefficiente di variazione”). Si tratta
quindi di una deviazione standard notevolmente alta. Ecco allora spiegato l’equivoco in cui cade Trilussa.
Non è affatto vero che la statistica assimila indebitamente situazioni diverse, perché la statistica non lavora
solo con il concetto di media, ma anche con quello di dispersione rispetto alla media. La situazione A in
cui due italiani mangiano effettivamente ognuno il proprio pollo e la situazione B in cui un italiano mangia due polli e l’altro nessuno, sono sì uguali sotto l’aspetto della media aritmetica (è 1 in entrambi i casi),
ma non lo sono affatto sotto l’aspetto della deviazione standard (è 0 nel primo caso e 1 nel secondo).
73 I criteri sono dettagliatamente esposti da Spencer & Spencer, op. cit., p. 97 dell’edizione originale.
74 Si tratta del procedimento del doppio cieco, in cui il ricercatore direttamente a contatto con il soggetto non
è a conoscenza (al pari del soggetto stesso) del gruppo sperimentale cui il soggetto è assegnato.
APPENDICE
di lavoro. In altre parole, alcuni di loro ritengono che “ottimizzare bene” i motori richieda
un ottimizzatore con determinate caratteristiche (conoscenze, capacità e altri attributi),
mentre altri ingegneri del gruppo campione ritengono che il “bravo ottimizzatore” ne debba avere delle altre. Scavando più in profondità, Sandberg ritiene di poter arrivare alla
conclusione che le concezioni di lavoro sottese all’attività degli ingegneri intervistati sono
fondamentalmente tre (lo studio di Sandberg viene meglio analizzato più avanti). Domanda: qual è la concezione migliore? La questione è cruciale, poiché Sandberg parte dall’assunto implicito che chi ha la concezione di lavoro migliore realizzerà anche la performance migliore (assunto sicuramente problematico, poiché non spiega come mai a parità di
concezione di lavoro, le performance possano poi essere molto diverse), e sarà quindi
anche il best performer. Come risponde Sandberg a questa domanda? Con l’ipotesi della
“inclusività” delle concezioni di lavoro: la concezione migliore è quella che incorpora le
altre, come in una specie di matrioska. La conclusione lascia perplessi. In primo luogo, va
notato che quando Sandberg cerca un riscontro empirico della sua ipotesi, non fa altro che
ricorrere alla classica peer evaluation, cioè alla “valutazione dei colleghi”. Ma se è la valutazione di persone competenti (in questo caso non i capi, ma i colleghi) a dover alla fine
stabilire chi è più bravo, che problema c’è a partire fin dall’inizio con questa valutazione,
sia pure sottoponendola poi al vaglio critico della riflessione negli expert panels? In
secondo luogo: è proprio vero che fra le diverse concezioni di lavoro in una organizzazione è sempre possibile trovare questo magico rapporto di inclusività o non si tratta invece
spesso di concezioni in conflitto fra le quali occorre scegliere per individuare qual è quella migliore ai fini della performance superiore? E se è così, perché non partire dal dato
empirico dell’esistenza di best performers (siano essi individuati da capi, colleghi o clienti, o attraverso un mix di queste fonti di giudizio), sia pure – è bene ripeterlo – con la successiva revisione critica ad opera degli expert panels?
3. La distinzione fra competenze e risultati*
Fra competenze e risultati viene fatta spesso una distinzione analoga a quella fra
mezzi e fini. Se i risultati rappresentano cosa bisogna fare, le competenze indicano come
(cioè con quali comportamenti) si riesca a raggiungerli. Questa distinzione può dare luogo
a un duplice malinteso. Il primo è di pensare che ciò che conta è alla fine sono solo i risultati, sicché il discorso sulle competenze avrebbe, tutto sommato, importanza solo secondaria. Il secondo malinteso – corollario del primo – è che, assumendo come essenziali solo i
risultati e avendo le competenze caratteristiche meno tangibili (e quindi meno “oggettive”)
dei risultati, occorrerebbe limitarsi alla considerazione di questi ultimi, evitando di soffermarsi sulle competenze. I malintesi nascono dal fatto che non si tiene conto della distinzione fra risultati a breve e risultati a medio e lungo termine. Prestare attenzione alle competenze, significa focalizzare l’aspetto chiave della continuità e del miglioramento progressivo dei risultati: “Se, per esempio, hai venduto e acquisito un ordine, hai un sicuro
* Vengono qui approfonditi temi trattati a p. 22.
129
APPENDICE
130
risultato, che finisce nel tuo budget e che ti rende felice. Ma la domanda però è: ‘come’ hai
venduto. Qui si aprono altre domande: il cliente è soddisfatto? Il cliente continuerà ad
essere soddisfatto? Il cliente saprà adoperare bene ciò che ha acquistato? Gli hai venduto
ciò che gli serve davvero, o solo ciò che ti ha chiesto? E poi: hai accumulato conoscenza e
competenza sul suo processo di acquisto, sulla tua argomentazione di vendita, sulla qualità del tuo processo di vendita? E poi la tua vendita ha utilizzato il prodotto a magazzino?
Ha utilizzato una standardizzazione a monte, per customizzare a valle? Ha ridotto lo spreco del tuo assortimento? Gli ha ‘venduto’ – oltre al prodotto, alla sua prestazione, alla sua
funzione d’uso – anche una relazione affidabile, una integrità? Così la tua azione ha prodotto, oltre a un risultato visibile, una pluralità di effetti secondari che – nel tempo – costituiranno un patrimonio: il valore sta qui” (U. Capucci, La generazione di valore nella
società della conoscenza, in FOR, Rivista per la formazione, FrancoAngeli, n. 62, gennaiomarzo 2005, p. 7). Insomma, se si allarga lo sguardo oltre l’arco del breve periodo, si può
dire che le competenze sono in qualche modo esse stesse risultati. La distinzione netta fra
il cosa e il come viene quindi a sfumare, e le competenze si affermano come il reale valore
di un’organizzazione nel tempo. Peraltro, in termini teorici più generali, la distinzione
tranchant fra azione (comportamento) e risultato si presenta problematica, poiché un
risultato si qualifica in un senso piuttosto che in un altro a seconda di come qualifichiamo
l’azione che gli è correlata. Per citare un caso immediatamente comprensibile, la “morte di
un individuo” è qualificabile come evento-risultato “omicidio” se l’azione era volta, ad
esempio, ad impadronirsi dei beni del defunto, mentre è qualificabile come “difesa legittima” se il comportamento che ha determinato la morte era di difesa da un’aggressione. In
ogni caso, è opportuno qui ricordare che nel modello delle competenze dell’Agenzia, le
competenze riconducibili al “dinamismo intellettivo” non sono rilevate attraverso comportamenti, ma, per ragioni di semplicità, attraverso il loro output (vedi p. 26).
4. L’iceberg delle competenze*
Cosa c’è “dietro” o “sotto” i comportamenti generatori di superior performance? In
questa direzione ha scavato un filone di
studi che ha avuto larga risonanza anche
presso il vasto pubblico. Ne sono esponenti autori (alcuni dei quali allievi dello stesso McClelland), come Richard Boyatzis,
Spencer & Spencer e Daniel Goleman,
noto, quest’ultimo, per le sue brillanti opere divulgative sulla cosiddetta “intelligenza emotiva” (non mancano però i critici75
* Vengono qui approfonditi temi trattati a p. 23.
75 Tra i più recenti si può vedere E.A. Locke, Why emotional intelligence is an invalid concept, in «Journal of
Organizational Behavior», 26 (4), June 2005, pp. 425-431.
APPENDICE
che contestano la scientificità di tale concetto). La domanda di partenza è stata all’incirca
questa: cosa consente ad una certa persona, piuttosto che a un’altra, di mettere in atto
comportamenti che generano prestazioni lavorative di livello superiore? La risposta
sarebbe, secondo Spencer & Spencer, nell’iceberg delle competenze. Nello strato di
superfice della personalità, vi sarebbero conoscenze e capacità (in inglese, skills), poi,
più giù, sotto il pelo dell’acqua, la comprensione di sé (self-concept), che include gli
atteggiamenti, i valori e l’immagine di sé e, infine, nello strato più profondo (la core personality), le motivazioni e i tratti. Secondo questo approccio, non basterebbe dire che le
competenze sono i comportamenti tipici del best performer in un determinato lavoro.
Bisognerebbe piuttosto dire che sono le caratteristiche individuali che stanno sotto a
quei comportamenti. Precisamente, le competenze sarebbero underlying characteristics
of an individual (caratteristiche “sottostanti” di un individuo o, per usare dei sinonimi,
soggiacenti o sottese) che causano – e quindi consentono di predire – una outstanding
performance on the job (una prestazione lavorativa fuori del comune). In italiano
“underlying characteristics of an individual” viene solitamente tradotto con l’espressione “caratteristiche intrinseche di un individuo”. Probabilmente è l’unica traduzione
accettabile nella nostra lingua, che ha però il difetto di non rendere la radice “sotto” del
vocabolo inglese, che nel caso di specie ha un preciso valore semantico, come mostra
l’immagine dell’iceberg.
C’è anche da osservare che quell’immagine può intuitivamente servire a porre l’accento sulle difficoltà che si possono incontrare nei processi di formazione e sviluppo
delle competenze. In essa, però, vengono affastellati aspetti troppo diversi ai fini di una
soddisfacente spiegazione e previsione dei comportamenti. È importante, ad esempio,
distinguere se una persona non ha una buona performance per mancanza di conoscenze
e capacità (migliorabili con la formazione) o per carenza di motivazione (in questo caso,
non si tratterebbe tanto di attivare processi di formazione, ma piuttosto di ricorrere a
incentivi, sia materiali che immateriali). Su questo punto vedi A. Grandori, Organizzazione e comportamento economico, cit., pp. 92-93.
5. Il dibattito sulla nozione di “competenza”*
Viene generalmente riconosciuto che l’approccio alle competenze scaturito dal
lavoro pionieristico di McClelland ha il vantaggio del saldo ancoraggio a dati empirici: si
parte dall’evidenza che esistono in un’organizzazione best performers e average performers e si risale per via induttiva, utilizzando strumenti tipici dell’indagine scientifica
come i gruppi di controllo, alla enucleazione delle caratteristiche predittive di superior
performance. Tra gli svantaggi viene, di contro, sottolineato la “staticità” dell’approccio e
cioè il fatto che sarebbe rivolto al passato invece che orientato al futuro: se un’organizzazione è in fase di cambiamento, mettere a fuoco le caratteristiche del best performer di
ieri dirà ben poco delle qualità del “bravo di domani” ed è invece proprio questo che ci
* Vengono qui approfonditi temi trattati a p. 23 e a p. 32.
131
APPENDICE
132
interesserebbe sapere, se l’organizzazione ha in mente di “cambiare pelle”. Nel caso delle
amministrazioni pubbliche il passaggio topico potrebbe essere quello della trasformazione da una “amministrazione burocratica” ad una “imprenditiva” – per usare la contrapposizione resa popolare dal celebre libro di Osborne e Gaebler dal titolo Reinventing
Government76 pubblicato agli inizi degli anni ’90 e da cui trasse ispirazione il programma di riforma dell’amministrazione federale americana lanciato dalla Presidenza Clinton
all’inizio del suo primo mandato – oppure il cambiamento dell’organizzazione del lavoro, come, ad esempio, il passaggio da rigide segmentazioni di attività specialistiche a
lavorazioni per processi e da modalità di trattazione individuale delle pratiche al lavoro
per team (entrambe le trasformazioni sono intervenute fra la fine degli anni ’90 e i primi
anni del 2000 nell’Agenzia delle Entrate, con la soppressione della miriade di vecchi
uffici frammentati per specializzazione d’imposta – imposte dirette, IVA e registro – e la
creazione di nuovi uffici unificati, articolati al loro interno nei due grandi processi del
servizio ai contribuenti e del controllo fiscale e basati su modalità di lavoro che privilegiano la polivalenza e l’integrazione in team).
Quale sarebbe allora la soluzione più appropriata nel caso di strutture che non
siano già consolidate nel loro modello organizzativo ma si trovino in fase di forte cambiamento? C’è un filone di studi, ben rappresentato nel mondo della consulenza, secondo il quale l’approccio giusto non sarebbe, in una evenienza del genere, quello induttivo
messo a punto da McClelland e dai suoi collaboratori (definito, in questo filone di studi,
un po’ riduttivamente – e con una sfumatura negativa – “psicologico-individuale”).
L’approccio giusto sarebbe invece quello di ricavare per deduzione dalle caratteristiche
del nuovo business aziendale e dalla sua strategia le competenze che le persone devono
avere (questo approccio – definito dai suoi fautori “strategico-organizzativo”, termine
che, già solo per la sua risonanza molto più suggestiva di quella del termine “psicologico-individuale”, tende ad imporsi subito al lettore – trae origine dalle pubblicazioni di
due autori, G. Hamel e C.K. Prahalad, sulla “Core Competence of the Corporation”,
ovvero sulla “competenza distintiva delle aziende”, come è stato tradotto in italiano).
Ad esempio, se l’azienda opera in un business in cui la competizione si gioca sulla continua innovazione di prodotto, si potrebbe dedurre che una capacità organizzativa chiave è la capacità dell’organizzazione di produrre innovazione, il che porterebbe ad identificare, tra le competenze importanti delle persone, la creatività, la capacità di tenersi
aggiornati a livello di eccellenza tecnologica, l’orientamento allo scambio di know-how
ecc. (Performance Improvement, a cura di E. Oggioni e A. Rolandi, Milano, Etaslibri,
1998, p. 15). Questo approccio sembra convincente, ma sembrava assai convincente
anche la politica di selezione che il Dipartimento di Stato seguiva per il reclutamento
dei funzionari da inviare all’estero presso gli uffici dell’USIS. Se il business di questi
uffici era la diffusione della cultura americana all’estero, perché non dedurre che la
competenza-chiave di quei funzionari dovesse essere la perfetta conoscenza della lingua e della cultura americana? L’analisi induttiva di McClelland dimostrò che quella
76 Il libro è stato tradotto in italiano con il titolo Dirigere e governare (Milano, Garzanti, 1995). La prefazione
all’edizione italiana è di Sabino Cassese.
APPENDICE
conoscenza era una “competenza soglia”, ma non una “competenza distintiva” per realizzare performance eccellenti. Il dubbio, quindi, è che il cosiddetto approccio “strategico-organizzativo” costituisca, metodologicamente, una riproposizione, sotto nuove forme, dell’approccio tradizionale che crede di poter dedurre dalle caratteristiche funzionali di un job le caratteristiche ideali della persona che deve eseguire quel job77. Tale
approccio rischia di mettere in luce solo le caratteristiche minime per svolgere un lavoro, cioè le caratteristiche di un average performer, e di fallire invece nella messa a fuoco
delle caratteristiche del best performer.
In sintesi, le osservazioni che si possono qui fare sono tre.
La prima, di carattere generale, è che l’approccio “psicologico-individuale” e quello “strategico-organizzativo” operano su piani radicalmente diversi, in quanto rispondono a esigenze diverse, sicché va considerato comunque con cautela il tentativo di ricondurli sul terreno di un’unica problematica. Il primo approccio mira a spiegare le differenze di performance fra una persona e l’altra all’interno di una organizzazione, mentre il
secondo mira invece a spiegare le differenze di performance fra un’organizzazione e l’altra (in altri termini, l’eventuale “vantaggio competitivo” di un’impresa rispetto a un’altra), tant’è che propone una definizione di “competenza distintiva” che va al di là del raffronto tra le competenze delle singole persone appartenenti ad una medesima realtà
aziendale: “Le competenze distintive rappresentano ciò che l’azienda ha appreso collettivamente soprattutto sul come coordinare le diverse capacità produttive e integrare differenti correnti tecnologiche” (G. Hamel e C.K. Prahalad, La competenza distintiva delle
aziende, in «Harvard Espansione», 1990, n. 49, p. 10). Per chiarire ulteriormente il proprio pensiero, gli autori appena citati proseguono così: “se, quando si parla di competenze, si parla di armonizzare differenti correnti tecnologiche, si parla anche dell’organizzazione del lavoro”. È evidente che un confronto fra le differenze tra le persone in termini
di competenze si può fare solo a parità di organizzazione del lavoro, poiché altrimenti si
mescolano in modo scriteriato cose diverse (attribuendo, ad esempio, alla bravura delle
persone ciò che va attribuito alla bontà del modello organizzativo). Peraltro, proprio perché focalizza la questione del “vantaggio competitivo”, l’approccio “strategico-organizzativo” è calibrato sul mondo delle imprese, più che su quello delle amministrazioni
77 Nell’intervista già citata, McClelland ricorda ad esempio il caso di una compagnia petrolifera che aveva
commissionato un modello di competenze per i suoi strateghi di business. In base all’analisi funzionale, il
compito principale di quelle persone sembrava essere la pianificazione. I consulenti incaricati di predisporre il modello proposero quindi una lista di competenze essenziali, che includevano il “pensiero concettuale” e il “ragionamento deduttivo”. Ma le interviste BEI – che erano state separatamente richieste a
McClelland dalla società petrolifera – rivelarono che una competenza fino allora insospettata (l’influenza)
era molto importante per distinguere gli outstanding dagli average performers. I migliori strateghi di business ritenevano infatti che il loro lavoro fosse ben più che scrivere un buon piano strategico. Era anche
importante che la dirigenza di vertice comprendesse il piano e fosse preparata ad adottarlo. Conseguentemente, i più bravi si assicuravano che i propri dirigenti fossero coinvolti nelle decisioni già nella prima
fase di elaborazione del piano. I meno bravi non afferravano questo punto, né i consulenti l’avevano colto.
Come concludeva McClelland, con l’analisi funzionale “the danger is that you leave things out” (“c’è il
pericolo di tralasciare qualcosa”). Per citare un altro esempio, il tipico slogan “chi lavora in R&D [Research
and Development] deve essere creativo” risulterebbe “ampiamente smentito da una realtà di Ricerca in cui
la creatività non risultava affatto tra le competenze distintive, ma soltanto tra quelle ‘di soglia’” (Performance Improvement, a cura di E. Oggioni e A. Rolandi, cit., p. 19).
133
APPENDICE
134
pubbliche, riguardo alle quali solo in senso molto lato si può parlare di concorrenza (può
essere invece interessante notare che la ricerca pionieristica di McClelland ha origine
proprio nell’ambito di amministrazioni pubbliche: prima il Dipartimento di Stato degli
Stati Uniti – esperienza questa che abbiamo già ampiamente raccontato – e poi la Civil
Service Commission, cioè la Commissione del pubblico impiego, del Massachusetts).
La seconda osservazione è che l’approccio “strategico-organizzativo” funziona per
l’individuazione delle competenze delle persone solo se non è interamente deduttivo
ed utilizza quindi – grazie anche ad operazioni di benchmarking – la base empirica
costituita dalle best performances rilevabili in aziende di successo nel business di riferimento. In altri termini, le competenze-chiave necessarie ad un’azienda che sta trasformando la sua missione vengono induttivamente ricavate, se non dai best performers di
quell’azienda (perché questo significherebbe guardare al passato), dai best performers
di aziende già affermatesi come leader nel nuovo business (attingendo ai modelli di
competenze di tali aziende).
La terza e ultima osservazione è che un modello di competenze ha rilevanza pratica solo se non si riduce a indicazioni assai generiche su cosa le persone dovrebbero fare,
ma riesce a formulare, con un linguaggio chiaro e condiviso e ben orientato al saper fare,
una descrizione analiticamente graduata dei comportamenti da seguire o da evitare
(insomma una scala sufficientemente univoca di comportamenti osservabili). Solo una
descrizione di questo tipo può infatti soddisfare le condizioni di validità ed affidabilità
di un modello di competenze, indispensabili come base di una valutazione oggettiva delle competenze. Questa è, a sua volta, necessaria per promuovere efficaci processi di sviluppo delle competenze (se non si stabilisce quali siano i miei punti di forza e quali quelli di debolezza come si fa a potenziare ulteriormente i primi e a lavorare sui secondi per
migliorarli?). Tutto ciò, peraltro, è riconosciuto dagli stessi fautori dell’approccio strategico-organizzativo, i quali sottolineano che “il passaggio più delicato della metodologia
[di individuazione delle competenze] è la definizione del grading”, cioè la costruzione
della scala su cui si misura la “bravura” in una certa competenza. E la definizione del
grading (graduazione) richiede “il contributo diretto della linea, che aiuta a individuare i
comportamenti reali che ‘fanno la differenza’, attraverso l’esperienza diretta e l’osservazione dei ‘più bravi’” (Business, strategia, competenze, a cura di U. Capucci, cit., pp.
102-104). Ma in questo modo non si finisce per riprendere i costrutti fondamentali del
cosiddetto approccio “psicologico-individuale” rispetto al quale si intendevano invece
marcare le distanze? Questa domanda appare ancora più legittima quando, nell’opera
appena citata (pp. 71-72), si legge una definizione di competenza del tutto analoga a
quella dell’approccio “psicologico-individuale”: un “aggregato” di conoscenze e capacità
che sono definite attraverso il comportamento osservabile e sono strettamente collegate
alla performance eccellente desiderata. L’autore aggiunge che la performance eccellente è
quella richiesta “dal business, dalla strategia competitiva e dai suoi fattori critici di successo”, ma anche nell’approccio “psicologico-individuale” è l’organizzazione e non certo l’individuo che stabilisce cosa debba intendersi per prestazione eccellente. Nella
vicenda dei funzionari USIS, per citarla ancora una volta, fu il Dipartimento di Stato che
individuò, in base appunto alla sua idea di best performance, chi fossero “i più bravi”.
APPENDICE
Nel dibattito va anche ricordata la posizione, assai autorevole (A. Grandori,
Organizzazione e comportamento economico, cit., pp. 95-99), secondo cui bisognerebbe “sviluppare un’analisi delle competenze più dinamica e generativa, rispetto all’approccio suggerito nei modelli di gestione delle risorse umane” (l’autrice si riferisce, in
particolare, ai contributi di R.E. Boyatzis e di Spencer & Spencer). Tale approccio,
infatti, “nulla dice su quali altre combinazioni di competenze sarebbero state possibili
e forse più efficaci, né su quali altri comportamenti si sarebbero potuti generare con le
stesse competenze”. L’idea alternativa è “di partire dalle competenze stesse e dalle particolari combinazioni in cui si presentano negli attori che le posseggono. Il fatto che le
risorse siano incorporate nelle persone in modo scarsamente divisibile, rende spesso le
risorse di fatto a disposizione più ricche di potenzialità rispetto ai particolari servizi
per cui sono state selezionate. Sono le competenze possedute dagli attori, e ancor più
le combinazioni possibili con le competenze di altri, che possono aiutare a definire
compiti interessanti, piuttosto che viceversa. Si pensi ad esempio a docenti di una
scuola di management. Un’analisi delle competenze di tipo generativo non dovrebbe
partire dalle richieste dei compiti generici del docente, né da quelle specifiche di corsi
e prodotti esistenti. Dovrebbe ricercare soprattutto competenze possedute ma finora
non applicate, o non applicate in combinazione con altre complementari. Una mappatura di questo tipo potrebbe portare a scoprire che, per esempio, qualcuno custodisce
competenze, diciamo, di metodi quantitativi di analisi reticolare, e qualcun altro di
analisi reticolare dell’organizzazione che, se combinate, potrebbero generare un nuovo
corso di valore”.
Insomma, più che guardare al best performer reale bisognerebbe immaginare il best
performer ideale (la persona che – sollecitata ad esprimere competenze fino allora solo
potenziali o a combinarle in maniera inedita con le competenze di altri – riesce a produrre comportamenti ancora più efficaci di quelli espressi da coloro che sono considerati
attualmente “i più bravi”). Sono spunti di riflessione importanti ai fini di una progettazione “generativa” dell’organizzazione. Non bastano però per generare un modello di
competenze valido e affidabile per i processi di rilevazione, valutazione, remunerazione
e sviluppo delle competenze. Per costruire un modello che abbia quelle caratteristiche
occorre una base empirica – cioè fattuale e non solo immaginata – di casi di best performance e si può disporre di una base del genere solo quando il best performer concepito
come ideale non è più solo nell’immaginazione generativa, ma è divenuto reale, e cioè
solo quando la nuova situazione organizzativa progettata è stata effettivamente generata
ed è divenuta operativa. Con il che rientra alla fine in gioco l’approccio esperienziale
“suggerito nei modelli di gestione delle risorse umane”.
Per concludere, un’impostazione molto interessante, che riguarda sempre il tema
della definizione di “competenza”, ma che sembra finora rimasta abbastanza isolata, è
quella delineata da un ricercatore svedese, Jörgen Sandberg (Interpretare le competenze, in «Sviluppo & Organizzazione», n. 182, novembre/dicembre 2000, pp. 95-107 e
111-114), in uno studio su un campione di ingegneri impegnati nel lavoro di ottimizzazione dei motori della Volvo (vi si è già accennato a p. 128). In questo studio viene
approfonditamente analizzata l’idea che in una organizzazione possano convivere, più
135
APPENDICE
136
o meno implicitamente, concezioni diverse su cosa debba intendersi per best performance e best performer. Nel campione esaminato, Sandberg individua tre diverse concezioni: “ottimizzare qualità separate”, “ottimizzare qualità interagenti” e “ottimizzare
dal punto di vista del cliente”. È da
notare che ognuna di queste concezioni interpreta a suo modo le conoscenze e le capacità – Sandberg le
chiama “attributi” – necessarie per
svolgere il lavoro richiesto (ad es.
conoscenza del motore, conoscenza
dei sistemi di monitoraggio, capacità
di autoapprendimento, capacità di
cooperazione, ecc). Per proseguire
nell’esempio, mentre nel contesto della concezione “ottimizzare qualità interagenti”
l’attributo “capacità di autoapprendimento” significa “accrescere la conoscenza dei
nessi tra le qualità di un motore”, nel contesto della concezione “ottimizzare dal punto
di vista del cliente” l’attributo “capacità di autoapprendimento” significa avere “senso
pratico del motore” e cioè accrescere la conoscenza della relazione tra desideri del
cliente e motori. Di conseguenza, gli attributi non sono context-free, non sono cose o
oggetti a sé stanti, descrivibili in sé e per sé e che, come pezzi del gioco del Meccano,
produrrebbero diverse forme di competenza a seconda di come si aggregano e si “montano” tra loro (questa visione meccanica delle competenze, Sandberg la chiama “oggettivistica” o “razionalistica”), ma sono “situazionali”, cioè acquisiscono un particolare
significato a seconda della concezione del lavoro in cui vanno a inserirsi. Ora, è proprio dalla diversità delle concezioni di lavoro che dipende la diversità di competenza
(ovvero ciò che fa la differenza tra i più bravi e i meno bravi), poiché queste concezioni
non hanno pari valenza, ma presentano un ordinamento gerarchico, in termini di maggiore o minore “inclusività” dell’una rispetto all’altra. In altre parole, le concezioni
sono come cerchi concentrici. È più “inclusiva” una concezione che, per ognuno dei
diversi attributi necessari per svolgere il compito assegnato, rivela una visione più
ampia e organica del lavoro, risultando così complessivamente più efficace per gli scopi che l’organizzazione persegue (quindi la concezione “ottimizzare dal punto di vista
del cliente” è superiore a quella “ottimizzare qualità separate”, poiché la prima comprende tutti gli attributi della seconda, nel significato che assumono nell’ambito di
quest’ultima, mentre non vale l’inverso). La funzione di un modello di competenze –
che si costruisce appunto attraverso l’interpretazione e la discussione sistematica delle
diverse concezioni del lavoro e degli attributi che vi ineriscono – è di rendere esplicita
la gerarchia di concezioni. Con l’esplicitazione di tale gerarchia, il modello può attivare un processo di cambiamenti nella concezione del lavoro, che, a sua volta, facilita lo
sviluppo di competenza nell’organizzazione. Come scrive Sandberg, “i tre distinti
modi di concepire l’ottimizzazione rappresentano tre differenti forme di competenza”.
Differenti, nel senso appunto di sovraordinate l’una all’altra. Semplificando molto, lo
studio di Sandberg costituisce uno sviluppo assai interessante della intuizione comu-
APPENDICE
ne secondo cui è la “mentalità” con cui si fa una cosa che determina alla fine la qualità
di ciò che si fa78.
Negli expert panels con cui è stato costruito il modello delle competenze dell’Agenzia si è svolto un lavoro di riflessione (vedi p. 21) che ha non poche affinità con l’approccio interpretativo di Sandberg. Fra le domande che venivano rivolte ai funzionari
esperti che partecipavano ai panels, ricorrevano spesso proprio quelle del tipo che Sandberg poneva al suo gruppo di ingegneri ottimizzatori dei motori Volvo (ad es.: chi è
secondo te il “bravo” verificatore? In cosa consiste una verifica fiscale fatta bene?). Piuttosto, è da osservare che le risposte non hanno messo in luce solo concezioni via via più
inclusive, ma anche concezioni fra loro contrastanti e fra le quali bisognava quindi scegliere se si voleva spiegare cos’è che determina la superior performance (lo studio di
Sandberg è stato analizzato sotto questo particolare profilo a p. 128). Anche queste scelte
hanno portato alla configurazione del modello delle competenze dell’Agenzia.
6. Il metodo degli expert panels*
L’expert panel è uno dei metodi utilizzabili per sviluppare modelli di competenze.
L’intervista BEI è considerata un metodo più accurato, ma ha il serio inconveniente di
essere notevolmente lungo e costoso, sicché viene generalmente impiegato per individuare competenze relative a un numero limitato di posizioni di particolare rilevanza. Tenuto
conto invece della molteplicità di figure professionali da coinvolgere nella costruzione
del modello delle competenze dell’Agenzia, si è ritenuto, d’accordo con i consulenti
dell’Hay Group, che l’expert panel fosse allo scopo la tecnica più conveniente da seguire,
anche grazie al fatto che il modello generale delle competenze delineato nel libro di Spencer & Spencer già menzionato forniva comunque molto materiale utile per la definizione
del modello dell’Agenzia. Una panoramica dei metodi di raccolta dei dati occorrenti per
la costruzione di un modello di competenze si può trovare nell’edizione originale del
libro di Spencer & Spencer più volte citato, pp. 97-104 (cap. 10 intitolato Designing Competency Studies, non incluso nella traduzione italiana).
Per onestà intellettuale non si può comunque passare sotto silenzio l’osservazione
di Spencer & Spencer secondo cui gli expert panels avrebbero un grado di accuratezza di
circa il 50% inferiore rispetto alle interviste BEI. In particolare, gli esperti partecipanti ai
panels individuerebbero competenze che nel 25% dei casi non troverebbero riscontro
nelle interviste BEI, mentre non riuscirebbero, di contro, a captare – in un altro 25% di
casi – le competenze che sarebbero intercettate dalle interviste BEI. Le ragioni di questa
parziale defaillance del metodo degli expert panels sarebbero due.
78 Peraltro, nell’approfondire tale intuizione, lo studioso svedese scomoda – probabilmente senza reale
necessità – l’etica della comunicazione universale di Apel e, ancor più vistosamente, la fenomenologia di
Husserl, richiamando il postulato che “persona e mondo siano inestricabilmente legati dall’esperienza del
mondo vissuta dalle persone”. Non è escluso che vi sia qui una eccessiva semplificazione fino al fraintendimento di complesse posizioni filosofiche, così come equivoca sembra essere la contrapposizione che
Sandberg istituisce fra “approccio razionalistico” e “approccio interpretativo” al tema delle competenze.
* Vengono qui approfonditi temi trattati a p. 21.
137
APPENDICE
138
Gli expert panels tenderebbero a dare ingresso ai “Folklore or Motherhood Items”
(“Motherhood” significa letteralmente “maternità” e “Items” significa in questo contesto
“temi”. “Motherhood Items” non ha un preciso corrispondente in italiano: si può approssimativamente tradurre con “concetti familiari”), cioè a costrutti che sono in realtà solo
filiazione dei pregiudizi e delle concezioni tradizionali che vivono in tutte le organizzazioni79. Ovviamente, luoghi comuni e stereotipi privi di reale fondamento non mancano
mai in ogni organizzazione, rendendo non di rado controintuitive verità la cui acquisizione sarebbe di grande beneficio (per un caso molto interessante vedi p. 144). Tuttavia c’è un
altro pregiudizio – sottile ma ugualmente ingiustificato e dannoso – ed è il pregiudizio che
vede ovunque solo pregiudizi. Gli expert panels servono certo al vaglio critico dei Folklore
or Motherhood Items, ma anche ad evitare che prevalga il pregiudizio appena accennato.
Se i Folklore or Motherhood Items indurrebbero a individuare competenze in realtà
non rilevanti, c’è un secondo fattore che avrebbe l’effetto opposto: precludere l’individuazione di competenze che sono invece rilevanti. Questo fattore è il “Lack Psycological
or Technical Vocabulary” (“carenza di vocabolario tecnico o psicologico”)80. Anche questa criticità, però, sembra tutt’altro che insuperabile. L’inserimento negli expert panels di
validi consulenti esterni (e proprio questo è avvenuto con gli expert panels in cui è stato
elaborato il modello dell’Agenzia delle Entrate e a cui hanno dato il proprio supporto
tecnico qualificati consulenti dell’Hay Group) può apportare quel valore aggiunto di tecnicalità che consente di superare la “carenza di vocabolario tecnico o psicologico”.
In conclusione, benché il senso critico sia sempre salutare, non sembra che in questo caso giustifichi un eccessivo scetticismo nei confronti del metodo degli expert panels,
che rimane comunque, per le ragioni precedentemente illustrate, quello più conveniente
per la costruzione di un modello di competenze che abbia ad oggetto vaste popolazioni
professionali. Si è poi già osservato che la parte più difficile del lavoro di costruzione del
modello delle competenze dell’Agenzia non è stata tanto l’individuazione delle competenze, ma la specificazione degli indicatori comportamentali di ciascuna competenza.
Ebbene, decisivo è stato a questo riguardo proprio il contributo degli expert panels.
7. Dall’analisi dei singoli comportamenti al disegno della mappa
delle competenze*
Come si arriva, partendo dalla rilevazione di singoli comportamenti, a disegnare la
mappa delle competenze di una organizzazione? Con il metodo induttivo di McClelland,
79 Spencer & Spencer accennano ad esempio al “coraggio morale” che nelle organizzazioni militari i massimi
comandanti indicano spesso come un requisito tipico dei buoni ufficiali. Le interviste BEI relative a
migliaia di episodi critici descritti da ufficiali della Marina e dell’Esercito avrebbero invece rivelato che le
decisioni con cui in genere hanno a che fare gli ufficiali riguardano temi gestionali e non ardue questioni
etiche, sicché le competenze veramente critiche sarebbero quelle manageriali e non quelle etiche.
80 Spencer & Spencer fanno ad esempio riferimento alla capacità di suscitare immagini tattili e visive (“eliciting imagery”). Competenza, questa, che sarebbe distintiva degli ottimi venditori di tessuti, i quali – ad
avviso degli autori appena menzionati – pensano in termini di colori e di natura dei tessuti.
* Vengono qui approfonditi temi trattati a p. 19.
APPENDICE
il veicolo che consente questo percorso è l’intervista BEI. Le tappe del tragitto sono
essenzialmente due:
• una prima strutturazione di dati che si compie già nel corso delle interviste BEI;
• una elaborazione dei dati acquisiti con le interviste che avviene successivamente alle
interviste stesse e che si compie grazie ad una analisi di tipo contrastivo.
Esaminiamo con cura questi due distinti momenti.
7.1 Strutturazione dell’intervista BEI
Nell’intervista BEI, come già accennato, non si chiedono “racconti liberi”, ma racconti strutturati secondo una griglia ben precisa, riportata di seguito in lingua originale,
per fissare meglio i concetti:
• “What was the situation?” (Qual era la situazione?)
• “Who was involved?” (Chi era coinvolto?)
• “What did you think about, feel, want to accomplish?” (Cosa pensavi, sentivi o intendevi fare?)
• “What did you do or say?” (Cosa hai fatto o detto?)
• “What was the outcome – what happened?” (Qual è stato il risultato, cosa è accaduto?)
Chiedendo di conoscere, insieme ai fatti accaduti e alle persone coinvolte, i pensieri,
i sentimenti e le volizioni che accompagnavano quei fatti e che avevano come oggetto quelle persone, il materiale grezzo e spesso ambivalente degli accadimenti riceve un primo fondamentale inquadramento. Si risale dai singoli comportamenti alle categorie di comportamenti (che sono appunto le competenze) attraverso la messa a fuoco degli schemi concettuali (Thought patterns), dei modi di sentire e delle motivazioni (ciò che sta dietro alle singole volizioni) dei protagonisti dei comportamenti raccontati nelle interviste. L’assunto di
base è che il comportamento organizzativo si caratterizza per la sua intenzionalità81 e l’intenzione è determinata dai pensieri, sentimenti e motivazioni degli interessati.
7.2 Analisi contrastiva nell’intervista BEI:
somiglianze e differenze significative
L’elaborazione successiva alle interviste BEI consiste essenzialmente in una complessa analisi di tipo contrastivo che si può così schematizzare:
81 “Un comportamento senza intenzione (intent) non definisce una competenza. Un esempio è il cosiddetto
management by walking around (aggirarsi per gli uffici). Se non sappiamo perché il manager si aggira per
gli uffici, non è possibile dire se dimostra una competenza. L’intenzione del manager potrebbe essere indifferentemente desiderio di scacciare la noia, di sgranchirsi le gambe, di controllare la qualità del lavoro o di
‘farsi vedere dalla truppa’” (Spencer & Spencer, op. cit., trad. it., p. 35). Dare rilievo alla “intenzione” del
comportamento non significa dare spazio a intuizioni incontrollabili. Nella semplice osservazione diretta,
l’intenzione del comportamento, quando non la si può immediatamente inferire dal comportamento stesso
(ove questo sia in concreto suscettibile di più letture), la si ricava dall’analisi del contesto (come avviene,
del resto, per qualunque altro tipo di comportamento e non solo per quello organizzativo).
139
APPENDICE
Episodi di insuccesso
Episodi di successo
Þ
Þ
Þ
Þ Þ
Þ
Þ Þ
Episodi di successo
Gruppo degli average performers
Þ Þ
Gruppo dei best performers
Þ Þ
Episodi di insuccesso
140
Per vedere come l’analisi concretamente funzioni, può essere utile ragionare su un
caso concreto. Rievocando la storia dei funzionari dell’USIS all’estero, si è già accennato
a quel giovane che, inviato in missione in un paese africano, raccontò di aver capito subito che “ad avere in mano la politica petrolifera di quel paese era il nipote dell’amante del
vice primo ministro”. Egli, di conseguenza, cercò subito di farsi invitare a un party, nel
quale poté incontrare quel nipote e cominciare a perorare la causa degli Stati Uniti. È da
un episodio come questo, e da altri simili, raffrontati con altri dissimili, che McClelland
ritenne di poter inferire che la competenza di cui aveva dato prova quel funzionario era
la “rapidità a capire le relazioni politiche”. Se si va però più a fondo con il ragionamento,
ci si accorge che quell’inferenza non era affatto scontata. La verità è che i casi della vita
possono presentare innumerevoli somiglianze o diversità a seconda del punto di vista da
cui li si osserva. Se si andassero, ad esempio, ad esaminare gli altri episodi rilevati da
McClelland nei quali anche si manifestava, a suo avviso, la “rapidità a capire le relazioni
politiche”, si sarebbero magari potuti trovare altri tipi di somiglianza fra quegli episodi,
oppure anche, per altri aspetti, diversità assai forti. Se, ad esempio, un altro funzionario
o, magari anche lo stesso funzionario, avesse raccontato che in un altro episodio era
riuscito a mettere a segno un altro grosso successo grazie al fatto che aveva individuato
l’amante di un altro importante uomo di potere, perché non concludere che la competenza mobilitata da quel giovane era la “sensibilità a captare relazioni affettive extraconiugali”? Si potrebbe ribattere che questa particolare somiglianza nei casi esaminati non era
rilevante (“non c’entrava”, come si usa dire). Ma allora, ciò che bisogna cercare non è una
qualsivoglia somiglianza (se ne possono trovare a iosa nelle situazioni concrete poste a
raffronto), bensì una somiglianza rilevante. E, analogamente, le differenze che contano
sono solo quelle rilevanti. Ma rilevanti rispetto a che? Rispetto allo scopo perseguito che
è quello di trovare in tutti i casi posti a raffronto un elemento che possa individuarsi
come causa dei successi riscontrati. Il criterio di somiglianza e di diversità non è passivamente desunto dai casi osservati (da essi potrebbero infatti ad uguale titolo desumersi
altri n criteri di somiglianza e di diversità), ma è introdotto dal ricercatore come ipotesi
esplicativa. In sostanza, osservando questo o quell’episodio il ricercatore concepisce,
con un “salto intuitivo”, la categoria “rapidità a capire le relazioni politiche” e poi mette
alla prova l’efficacia esplicativa di tale categoria, verificando se essa permette di assimilare casi fra loro diversi per tanti altri aspetti o, viceversa, di differenziare casi fra loro
simili per tanti altri aspetti. Ad esempio, somiglianze rilevanti fra comportamenti di successo di più best performers o dello stesso best performer possono indicare competenze
distintive di performance superiore, così come possono indicarlo differenze rilevanti fra
comportamenti di successo di best performers e comportamenti di insuccesso di average
APPENDICE
performers82. Mentre somiglianze rilevanti fra comportamenti di successo di best performers e di average performers possono denotare competenze soglia (per la distinzione fra
questi due tipi di competenze vedi p. 20).
Insomma, l’analisi contrastiva serve a favorire la formulazione di ipotesi circa le
competenze che generano performance superiore. Se la verifica dell’ipotesi ha successo,
il ricercatore si sente legittimato a inserire – sia pure provvisoriamente e con riserva di
altre convalide – quella categoria nel modello di competenze che sta costruendo. Insomma, la verità è questa: più che limitarci passivamente a trovare casi simili o dissimili, noi
in realtà – con quell’atteggiamento attivo chiamato “invenzione di ipotesi” – li assimiliamo o li differenziamo83. Tutto questo spiega perché l’analisi tematica degli episodi cui
faceva riferimento McClelland, ben lungi dall’essere una meccanica fotografia della realtà, è “la parte più difficile e creativa del processo di analisi delle competenze”, per citare
le parole di Spencer & Spencer tratte dall’opera più volte citata (Thematic analysis is the
most difficult and creative part of the competency analysis process)84. Difficult significa
appunto che non si tratta di trovare semplici somiglianze o differenze, ma solo quelle
significative, per cogliere le quali non funzionano semplici regole meccaniche, né tanto
meno basta limitarsi alla mera “osservazione dei fatti” (ammesso che possa esistere un
comportamento passivo del genere). Creative significa che occorre inventiva per afferrare
le somiglianze (o le differenze) rilevanti.
Come qualcuno ha detto, le buone intuizioni vengono solo a menti ben preparate
ad accoglierle (o, meglio, a “generarle”). L’ingegnosa analisi contrastiva ideata da McClelland con lo strumento dell’intervista BEI serviva appunto a facilitare il concepimento di
buone intuizioni. Se la metafora può servire, il metodo appena descritto funziona come
un disegno a chiaroscuro, che mira a evidenziare il rilievo plastico delle cose attraverso
il contrasto di luci (nel nostro caso i “comportamenti produttivi di successo”) ed ombre
(nel nostro caso, “assenza di comportamenti che producono successo” e “presenza di
comportamenti che causano insuccesso”).
7.3 Criteri guida
Il principio di semplicità e il principio di scopo
Chiarito che il disegno della mappa delle competenze è un lavoro difficile e creativo, anzi the most difficult and creative part di tutto il lavoro, è opportuno però chiedersi,
visto che le energie non sono illimitate, se c’è qualcosa che possa rendere quel lavoro un
po’ meno difficile e un po’ meno faticosamente creativo. La risposta è sì ad entrambe le
82 Si può qui ricordare il caso del funzionario USIS che aveva fallito nell’organizzare corsi di inglese per gli
studenti del paese straniero in cui lavorava (vedi p. 20).
83 Appunto per favorire la ricerca volta a cogliere il carattere di rilevanza sia delle somiglianze che delle differenze, l’intervista BEI si focalizza non su episodi ordinari, ma – come dice già la sua denominazione – su
episodi critici (di successo o di insuccesso). Per la precisione la procedura BEI chiede a un soggetto di
descrivere, sotto forma di racconto breve, tre grossi successi e tre grossi fallimenti.
84 La citazione è tratta dal cap. 12 (p. 135), che porta il titolo Developing a Competency Model, non riportato
nell’edizione italiana.
141
APPENDICE
142
domande e quanto verrà detto di seguito – a volte con vere e proprie indicazioni di metodo, a volte con suggerimenti pratici che hanno più che altro la natura di consigli – cercherà di darne dimostrazione.
La tracciatura delle competenze è guidata, come qualunque altra ricerca che aspira
ad essere scientifica, da un principio di minimo o di semplicità, che viene spesso enunciato
con il cosiddetto “rasoio di Occam”: “Entia non sunt multiplicanda sine necessitate”.
Come a dire: “se una cosa può avere una spiegazione più semplice, perché cercarne una
più complicata?” (Guglielmo di Occam era un filosofo inglese, appartenente all’ordine
francescano, vissuto tra la fine del ’200 e gli inizi del ’300).
Questo comporta che un modello di competenze deve includere il numero minimo
di competenze utili a spiegare la performance di successo. Tuttavia, come diceva Einstein, una teoria deve essere la più semplice possibile, senza però divenire semplicistica.
Riprendendo il rasoio di Occam, gli enti non vanno moltiplicati senza necessità, ma questo di converso significa che, quando necessità invece c’è, non occorre esitare troppo a
moltiplicarli. È evidente, ad esempio, che si potrebbe definire un modello con un’unica
competenza: quella formata dalla classe di tutti i comportamenti che hanno effetti positivi sulla performance. Un modello siffatto sarebbe semplicissimo, ma a che servirebbe?
La domanda mette sulla giusta strada. Una spiegazione deve essere la più semplice possibile, ma deve però tenere distinto ciò che va distinto. E la distinzione obbedisce
a un principio di scopo. Insieme a un principio di minimo ciò che ci deve guidare nella
costruzione di un modello di competenze è un principio di scopo. Una classificazione
di comportamenti dipende dagli scopi per cui la facciamo. Stabilire se un risultato brillante è dipeso da una intelligente soluzione sotto l’aspetto concettuale o da una salda
capacità di leadership in un momento di grave incertezza è una distinzione di cui un
modello di competenze non può non tenere conto, perché l’uno e l’altro tipo di comportamento mobilitano conoscenze e capacità diverse, che – in base a cognizioni comuni –
vanno selezionate, apprese e sviluppate con azioni assai diverse. E fra gli scopi essenziali di un modello di competenze c’è appunto la selezione, l’apprendimento e lo sviluppo – attraverso appropriate azioni valutative – delle conoscenze e capacità che servono all’organizzazione.
Se il principio di minimo spinge a ridurre quanto più possibile il numero delle
competenze e gli indicatori utili a individuarle, il principio di scopo obbliga a non contrarre tale numero fino al punto da sacrificare distinzioni che vanno invece fatte in relazione agli scopi che il modello persegue. Sulla realizzazione più o meno felice dell’equilibrio fra questi due principi si giudica la validità e l’affidabilità di un modello e quindi
della mappatura di competenze definita da una organizzazione. Ciò può stabilirlo solo il
banco di prova dell’esperienza, e quindi la verifica empirica del funzionamento del
modello, che può indicare le correzioni e gli affinamenti da apportare.
Suggerimenti pratici
Ecco alcuni consigli che possono servire nell’operazione di equilibratura cui si è
appena fatto cenno.
APPENDICE
Il primo è quello di evitare di affannarsi a reinventare la ruota, ovvero a scoprire
ciò che da altri è stato già scoperto, spesso faticosamente. Ragioni di convenienza e ragioni etiche di rispetto del lavoro altrui, spingono a dedicare adeguata attenzione a ciò che,
con impegno e ingegno, è stato fatto prima di noi e per noi. Anche questa – per riprendere il titolo del bel libro di Arthur Lovejoy, un insigne storico delle idee – è la “grande
catena dell’essere” che lega fra loro gli uomini e le generazioni.
Bisogna quindi tenere anzitutto conto della letteratura che si è da molti anni accumulata su questa materia, e questo spiega lo sforzo che si fa in questo manuale di riassumerne, quanto più chiaramente possibile, i principali filoni.
Richiamandoci ancora al principio di minimo, cominciamo con il dire che qua e là
si leggono a volte indicazioni semplicistiche di numeri “magici”, ad esempio le competenze individuate non devono essere meno di X e non più di Y. Più plausibile ci sembra
invece l’affermazione che le competenze da individuare ed inserire nel modello sono tutte quelle a cui l’organizzazione e le persone che vi lavorano attribuiscono rilevanza –
esplicitamente o, come più spesso capita, implicitamente – siano poi esse tre, cinque,
sette ecc. Se gli interessati danno importanza, ad esempio, ad una categoria di comportamenti del dirigente configurabile come “autocontrollo” e si accerta che tale competenza
serve realmente al buon dirigente, non ha senso escluderla dal modello perché altrimenti
il numero delle competenze diverrebbe “troppo elevato”. E quel che si è detto dell’autocontrollo si può dire per ogni altra categoria di comportamenti che dovesse anch’essa
risultare importante nel contesto organizzativo in cui si opera.
Richiamandosi a un importante studio di Boyatzis85 del 1982, che aveva per primo enunciato una definizione generale di competenza ed era anche riuscito a individuare una serie di competenze “generiche”, cioè ricorrenti nelle più diverse organizzazioni, Spencer & Spencer hanno analizzato i dati con cui erano stati costruiti in precedenza circa 300 modelli specifici di competenze ed elaborando questo materiale hanno
definito un modello di 20 competenze generali86, con circa 360 indicatori comportamentali (ogni competenza è corredata, oltre che di una definizione, di un set di indicatori comportamentali da 3 a 6), raggruppate in 6 grandi cluster (competenze di realizzazione e operative, competenze di assistenza e di servizio, competenze di influenza,
competenze manageriali, competenze cognitive, competenze di efficacia personale).
Tale modello è quello più affermato a livello internazionale e ha preso forma nel dizionario contenuto nella classica opera pubblicata dai due autori nel 1993 e più volte citata in questo manuale. Il modello Antares dell’Agenzia delle Entrate comprende 11
competenze, articolate in 5 cluster e corredate complessivamente di circa 300 indicatori comportamentali.
85 R.E. Boyatzis, The Competent Manager: A Model For Effective Performance, New York, Wiley, 1982.
86 Esse coprono, secondo gli autori, l’80-95% delle caratteristiche distintive della performance superiore nella maggior parte delle mansioni osservate. A queste 20 competenze, si aggiunge un altro gruppo di competenze particolari, alcune più comuni, come il saper scrivere e il non aver paura di risultare poco simpatici
(low fear of rejection), altre più insolite, come la competenza giuridica, il sense of humour e la riservatezza.
All’analisi di queste competenze, Spencer & Spencer dedicano, per la loro minore incidenza, non più di
una pagina rispetto alle 64 dedicate alla disamina delle altre 20 competenze generali.
143
APPENDICE
144
Alcune di tali competenze riprendono, mentre altre sintetizzano, competenze già
descritte nel dizionario generale di Spencer & Spencer (solitamente questo Dizionario
viene chiamato “Dizionario McBer” – e così lo citeremo d’ora in poi – dal nome della
società di consulenza presso cui lavoravano i due studiosi87), apportando però gli adattamenti e le “personalizzazioni” occorrenti in funzione della realtà specifica dell’Agenzia.
Alcune categorie, come “Sviluppo e trasferimento del sapere” e “Passione per il lavoro”,
sono invece specifiche di Antares.
In pratica, il punto critico nella costruzione del modello dell’Agenzia (e lo stesso
vale ovviamente per qualunque organizzazione che intendesse elaborare un proprio
modello di competenze) non è stato tanto quello della enucleazione delle competenze (il
repertorio fornito da Boyatzis e Spencer & Spencer è abbastanza completo, almeno per
quello che si è potuto sperimentare in relazione alla concreta realtà dell’organizzazione),
quanto piuttosto lo sforzo di adattamento degli indicatori di tali competenze. Volendo
sintetizzare molto, non si andrebbe lontano dal vero affermando che l’impegno richiesto
per la definizione di un modello è per il 10% individuazione delle competenze richieste
per il lavoro che si fa nella specifica organizzazione in cui si lavora, e per il 90% definizione degli indicatori comportamentali destinati a graduare con la maggiore oggettività possibile l’intensità delle competenze in relazione alla concreta realtà organizzativa – al “vissuto”, potremmo dire – degli uffici cui il modello è riferito. Mentre nell’individuazione delle
competenze il Dizionario McBer aiuta molto, nella descrizione dei rispettivi indicatori
comportamentali aiuta invece molto meno. Di fatto, negli indicatori comportamentali del
Dizionario Antares si troverà ben poco degli indicatori comportamentali del Dizionario
McBer, perché suonavano astratti e avulsi dalle situazioni tipiche degli uffici dell’Agenzia. È a questa esigenza di tuning che devono appunto rispondere gli expert panels.
È perciò di fondamentale importanza curare bene la composizione di questi gruppi. Al loro interno, è essenziale che vi siano figure che possano somigliare a dei Postcogs.
Chi sarebbero costoro? Il lettore che ha visto Minority Report (se ne parlerà più avanti a p.
157) sa che i Precogs (abbreviazione di Precognitive Thinkers 88) sono in quel film individui sensitivi che prevedono eventi futuri e, precisamente, gli omicidi che saranno commessi. I Postcogs dovrebbero essere figure assai meno inquietanti, ma non meno utili:
Postcognitive Thinkers, persone capaci di riflettere su esperienze passate e ricorrenti e di
estrarne, grazie appunto all’acuta capacità riflessiva di cui sono dotati, il significato che
racchiudono in termini di competenze. Generalmente, queste figure non abbondano: le
persone che lavorano hanno spesso ricche esperienze da narrare, ma a questa ricchezza
di esperienza vissuta non è frequente che si abbini un’analoga ricchezza di autoriflessione. I Postcogs hanno questa particolare abilità – denominiamola pure, se vogliamo,
“competenza” – di abbinare esperienza e riflessione sull’esperienza89. Quali caratteristiche deve avere questa riflessione?
87 La società venne fondata da McClelland e da David Berlew (McBer è appunto l’acronimo dei due soci fondatori). La società McBer è poi confluita negli anni ’90 nell’Hay Group.
88 Thinkers significa letteralmente “pensatori”.
89 Un esempio emblematico di Postcog potrebbe essere Sherwood F. Moran, leggendario maggiore dei Marines
che, durante l’ultima guerra mondiale, si occupò della formazione dei militari incaricati di interrogare i pri-
APPENDICE
Almeno due: cura del linguaggio e attenzione agli scopi cui deve essere finalizzato il
dizionario che descrive la mappa delle competenze. Il linguaggio in cui si deve esprimere
la riflessione deve essere vicino a quello comunemente accettato nella vita pratica degli
uffici (e quindi occorre tenersi alla larga da certo gergo consulenziale). Quanto agli scopi,
il dizionario deve poter servire come base oggettiva per la rilevazione e la valutazione dei
comportamenti, e deve quindi individuare comportamenti facilmente osservabili.
In questa prospettiva, proviamo ora a dare alcune indicazioni ancora più concrete,
che possano valere come suggerimenti pratici.
Si è già detto che, nell’individuazione delle competenze del modello Antares, si
sono in gran parte riprese le categorie del Dizionario McBer, introducendo, però, alcune
innovazioni significative. Può essere utile darne qui conto, per acquisire confidenza con
i tipi di problemi concretamente connessi al disegno di una mappa di competenze. La
principale innovazione riguarda il cosiddetto dinamismo intellettivo, cioè – in estrema
sintesi – la capacità di applicare l’intelligenza ai problemi pratici. Nel Dizionario McBer
si distinguono al riguardo due categorie di pensiero: quello analitico (Analytical Thinking) e quello concettuale (Conceptual Thinking), per designare grosso modo, con il primo termine, la capacità di ragionamento logico e, con il secondo, la creatività intellettuale. Le distinzioni fra questi due ambiti e, soprattutto, l’individuazione dei diversi gradi
di intensità dà luogo però a distinzioni troppo sottili per gli scopi pratici cui il Dizionario
s’ispira, che identificano come prioritaria l’esigenza della comprensibilità. Il Dizionario
deve servire per un vasto pubblico come base sufficientemente oggettiva per la rilevazione e valutazione dei comportamenti. Le descrizioni devono essere perciò comprensibili
da chiunque (sia pure con un po’ di formazione) e non solo da psicologi cognitivisti.
Ecco, per fare solo un esempio, come nel Dizionario McBer vengono graduati i
livelli bassi dell’Analytical Thinking:
1. Scompone i problemi: Scompone meccanicamente i problemi operativi in elenchi elementari di compiti o di attività, cui non viene assegnato un ordine particolare o una
graduazione di importanza (A, D, B, C, …).
2. Individua le relazioni di base: Scompone i problemi insiti in una situazione, aggregandone in blocchi le parti costitutive. Collega le parti con nessi semplici e unidirezionali
del tipo “A conduce a B” oppure “se…allora” oppure ancora “questi sono i pro e questi i contro”. Ordina le componenti di un problema secondo criteri di rilevanza.
gionieri giapponesi. Uomo di raffinata sensibilità e profondo conoscitore della lingua e della cultura giapponese, Moran, distillando in un linguaggio semplice e avvincente una ricca riflessione sulla propria esperienza umana e professionale, tracciò, in un rapporto datato 17 luglio 1943 e indirizzato alla direzione dell’intelligence dei Marines, una sorta di “modello di competenze”, abbastanza controintuitivo, del bravo addetto
all’interrogatorio di prigionieri giapponesi. Il 17 luglio 2003, 60 anni dopo, l’associazione del corpo dei
Marines che riunisce gli interpreti e gli addetti a interrogatori ha reso pubblico quel rapporto (lo si può leggere su Internet all’indirizzo: http://www.bigstory.us/downloads/Tort-SFMoran_on_interrogation_1943_
familyproof_.pdf). La pubblicazione del rapporto è però passata del tutto inosservata, soprattutto da parte di
quelle che vengono comunemente denominate “Autorità competenti”. Circa 6 mesi dopo sono accaduti ad
Abu Ghraib i gravi fatti che hanno avuto risonanza mondiale. I comandi americani stanno ora rivedendo il
modello delle competenze dell’addetto agli interrogatori. È possibile che, in quest’opera di revisione, il
“modello Moran”, che ha funzionato molto bene con prigionieri fortemente ideologizzati quali erano i soldati dell’impero del Sol Levante, venga assunto come punto di riferimento.
145
APPENDICE
146
È facile intuire quale possa essere per gli appartenenti ad una organizzazione – che
non sia appunto un’associazione di psicologi cognitivisti – la facilità a maneggiare indicatori di questo tipo.
Nel Dizionario delle competenze organizzative dei dirigenti dell’Agenzia delle Entrate (il Dizionario è la base del sistema di valutazione Sirio), si sono perciò fatte due scelte:
• Sono state unificate le categorie del “Pensiero analitico” e “Pensiero concettuale” nell’unica categoria del “Pensiero ideativo”, che esprime l’attitudine a coniugare rigoroso
raziocinio e libera creatività mentale. Questo in base all’assunto che capacità di ragionamento e creatività di pensiero, seppure concettualmente distinte, si presentano in
concreto strettamente intrecciate, tant’è che nell’uso linguistico comune (e a questi usi
occorre sempre rifarsi per estrarne criticamente la verità che di solito essi contengono)
affermare che una persona è intelligente significa sia che ha capacità di analisi logica,
sia che sa “tirare fuori” (o che spesso le “vengono in mente”) buone idee quando servono. E ciò è vero ancor più nell’ambito delle professioni tecniche intellettuali (quali
sono quelle dell’Agenzia delle Entrate) ove la capacità intuitiva ha pregio solo se congiunta a una robusta capacità argomentativa.
• Sono stati individuati indicatori di intensità di competenza assai più vicini alla concreta esperienza delle persone e quindi assai meglio utilizzabili da tutti gli attori interessati (valutati e valutatori). Per consentire un utile raffronto, ecco qual è ad esempio,
nel manuale Sirio, il set di indicatori del grado più basso di Pensiero ideativo:
– Argomentare non è il suo forte: La tecnica che utilizza per identificare i problemi,
articolarli e risolverli si fonda quasi esclusivamente sul ricorso alla tradizione e al
“precedente”, e laddove il precedente non basta o non è utile, dà l’impressione di
essere disorientato e di non avere più risorse. Difficilmente riesce a percepire i “falsi
problemi”, specie quando s’impongono alla riflessione per abitudine o per tradizione, e quanto ai veri problemi raramente riesce a darne una prospettazione, se non
originale, almeno utile a facilitarne la soluzione. Coglie con difficoltà le implicazioni concettuali delle questioni che affronta e stenta ad inserirle in un quadro esplicativo più ampio. Tende a smarrirsi nei dettagli, senza riuscire a mettere a fuoco ordinatamente gli elementi essenziali di un problema. Il suo modo di pensare, di argomentare, di inquadrare i problemi e di trovare soluzioni difetta di “visuale strategica”. Anche se tratta da lungo tempo le materie di cui si occupa, l’approccio scarsamente critico con il quale le affronta spiega perché dia in genere la percezione di
muoversi al loro interno un po’ spaesato, come rivelano l’incongruenza non infrequente delle decisioni che adotta e l’insufficiente accuratezza tecnica dei prodotti
del suo ufficio, che necessitano abbastanza spesso di estesi “ricicli di lavorazione”
sotto il profilo qualitativo.
Nel Dizionario delle competenze Antares (che riguarda non i dirigenti ma i funzionari) si è adottata una soluzione pratica ancora più semplice, in funzione dell’osservabilità dei comportamenti. Il dinamismo intellettivo viene descritto per quello che è (e
anche con ricchezza espositiva, poiché in un’organizzazione di knowledge workers qual
è l’Agenzia delle Entrate questa competenza è essenziale), ma viene rilevato attraverso
APPENDICE
indicatori delle caratteristiche più significative dell’output generato (chiarezza ed efficacia della scrittura, congruenza, ecc. vedi p. 73 e ss.).
Oltre al richiamo ai dizionari di competenze già elaborati, vi sono altri due tipi di
ausilio utili a rendere meno difficile la messa a punto di un modello di competenze.
Il primo è rappresentato dagli schemi di codifica in uso, più o meno impliciti e più
o meno ricorrenti, che in ogni organizzazione servono a tipizzare i comportamenti sui
quali vi è larga condivisione per quanto concerne i loro effetti negativi o positivi sulla
performance (ecco alcuni esempi di tali schemi: “pensa solo a coprirsi le spalle”, “si
preoccupa esclusivamente della sua carriera”, “va al nocciolo dei problemi e s’ingegna a
risolverli”, “è sempre pronto ad assumersi le proprie responsabilità”, ecc.). Come si è
accennato, uno degli assunti di base di McClelland era che la gente si accorda più facilmente su chi è outstanding (fuori del comune) piuttosto che su che cosa rende qualcuno
outstanding. In realtà, però, questo accordo non di rado c’è e le spiegazioni che lo motivano sono spesso plausibili, anche se possono richiedere affinamenti o correzioni, e rappresentano comunque – per il fatto che sono alimentate da molte e ripetute esperienze –
una fonte importante da cui trarre ipotesi per il difficult and creative lavoro di classificazione che sta alla base di un modello di competenze.
Infine, può essere utile accennare – sempre in una prospettiva di suggerimenti pratici –
ad alcune tipiche perplessità nelle quali pressoché inevitabilmente ci si imbatte quando si
costruiscono e si applicano categorie di comportamenti. Possiamo sintetizzarle così: intersezioni, ridondanze e ambivalenze. È opportuno esaminarle, anche per rendersi conto che esse
non sono necessariamente indice di difetti di costruzione di un modello di competenze.
Intersezioni
Per lo più, le competenze si presentano intrecciate fra loro. Quando l’intreccio è
particolarmente stretto, esse generalmente fanno parte di un unico cluster. Questo aspetto viene trattato con accuratezza nel Dizionario generale delle competenze sviluppato
nell’opera di Spencer & Spencer. Per ognuna delle 20 competenze sono analizzati i rapporti (links) con le altre competenze (un solo esempio fra i tanti riportati nel Dizionario:
“l’orientamento al cliente è supportato dalla ricerca delle informazioni e dalla sensibilità
interpersonale. Lo spirito d’iniziativa è talmente implicito nell’orientamento al cliente
che le scale B (sforzo) delle due competenze sono praticamente identiche”90). Si potranno forse intravedere qui possibili motivi di confusione, ma si tratta piuttosto di indicazioni che mostrano la dinamica viva e la sinergia delle competenze, e questo serve a renderne più accurato il processo di valutazione e a favorirne lo sviluppo.
Ridondanze
Una competenza o alcuni suoi indicatori possono apparire ridondanti, nel senso
che descrivono comportamenti che, se non proprio identici, sembrano però presentare
90 Spencer & Spencer, op. cit., trad. it., p. 68.
147
APPENDICE
148
forti affinità con quelli già descritti in altre competenze o in qualcuno dei rispettivi indicatori. La ridondanza può segnalare una insufficiente applicazione del principio di minimo prima enunciato. In altre parole, può indicare la necessità di procedere ad accorpamenti di classificazioni, per eliminare inutili “doppioni”. Un certo grado di ridondanza
nella individuazione delle competenze può però considerarsi fisiologico, quando ad
esempio l’enucleazione di una categoria a sé stante per la classificazione di comportamenti, che potrebbero in astratto anche ricondursi sotto un’unica categoria, è giustificata
dalla particolare rilevanza che si intende così attribuire a quei comportamenti.
Ambivalenze
Se, con riferimento a un sistema classificatorio, “ridondanza” significa presenza
nel sistema di elementi di per sé non strettamente necessari, “ambivalenza” significa che
elementi del sistema possono di per sé trovare più di una classificazione. Ad esempio, la
competenza “Sviluppo e trasferimento del sapere” presente nel modello Antares potrebbe essere in teoria classificata sia nel dinamismo cognitivo (riguarda infatti sicuramente
la dimensione della conoscenza professionale), ma anche nel dinamismo realizzativo
(certamente è una competenza che contribuisce a “fare risultato”), come pure nella leadership (è un buon capo chi sa trasmettere conoscenza ai propri collaboratori per arricchirne la professionalità). Qual è la classificazione giusta? La risposta è che ognuna di
queste classificazioni può essere giusta a seconda degli scopi perseguiti. Nel caso specifico la scelta potrebbe dipendere dall’interesse che ha l’organizzazione a porre l’accento su
una classificazione piuttosto che su un’altra. Se, ad esempio, si vuole sottolineare la finalizzazione dell’accrescimento della conoscenza al miglioramento della performance
individuale e collettiva, la classificazione “giusta” sarà quella dell’inserimento di quella
competenza nel cluster del dinamismo realizzativo, e questa è appunto la scelta che è
stata fatta con Antares.
Così come nella costruzione, anche nell’applicazione di un modello di competenze
possono presentarsi ambivalenze, nel senso che può sorgere il dubbio se un determinato
comportamento vada classificato in un modo piuttosto che un altro. A questo proposito
Spencer & Spencer scrivono quanto segue: “I comportamenti competenti possono essere
ispirati da una o più motivazioni, anche in combinazione. Per esempio, l’intenzione di
sviluppare la skill di un subordinato e di prepararlo ad una promozione potrebbe essere
motivata dal desiderio di potere (‘voglio avere un effetto su di lui’), dall’orientamento al
risultato (‘Se riuscisse a far bene X, Y e Z, risparmierei tot ore o dollari’) o dal desiderio
di rapporti cordiali (‘Se lo sviluppo e lo promuovo, me ne sarà riconoscente, mi stimerà’)
o da una combinazione di queste motivazioni”91.
91 Spencer & Spencer, op. cit., trad. it., p. 46. È da notare che gli autori stanno qui alludendo a quelle che,
secondo McClelland, sono le tre fondamentali motivazioni del comportamento manageriale: need (“bisogno”) for Power, bisogno di influenzare gli altri, need for Achievement, bisogno di riuscita, need for Affiliation, bisogno di avere il consenso altrui. Per inciso, è facile fraintendere il significato di queste tre motivazioni, come rileva lo stesso McClelland, quando scrive, ad esempio, che la “power motivation” non si riferisce a un “dictatorial behavior” ma “al desiderio di avere un impatto, di essere forte e influente”. McClel-
APPENDICE
Come risolvere queste ambivalenze di tipo applicativo? La prima cosa da sottolineare è che non ci troviamo in casi come questi di fronte a situazioni di singolare stranezza, ma a evenienze normali nell’applicazione di codici comportamentali, evenienze cui
si viene addestrati fin da bambini. Le prassi e le consuetudini che si sviluppano con l’esperienza consentono alle persone di acquisire padronanza di tecniche efficaci di interpretazione dei comportamenti, tecniche, cioè, utili a gestire e risolvere le inevitabili
ambiguità.
C’è da aggiungere che se questo vale per l’immenso territorio del comportamento
umano – territorio tutt’altro che sconosciuto, dal momento che la sua esplorazione costituisce forse l’occupazione prevalente della gente sotto qualunque latitudine – vale anche
per il comportamento organizzativo, che è una provincia relativamente assai piccola di
quello sconfinato continente. Pur essendo anch’essa molto battuta, poiché il lavoro è fra le
principali esperienze della vita, sarebbe irrealistico affermare che in quella provincia tutto
è sempre chiaramente catalogabile. Le sfumature non mancano e non è sempre facile
coglierle, e labili sono anche talora le linee di demarcazione fra una categoria di comportamenti e l’altra. Con questo intendiamo dire che un certo grado di ambivalenza può considerarsi fisiologico in un modello di competenze, come in qualunque altro modello comportamentale, ma intendiamo anche dire che le persone acquisiscono – magari a livello di
conoscenza tacita – una buona padronanza delle tecniche di gestione delle ambivalenze.
L’episodio, ad esempio, appena citato da Spencer & Spencer è un caso in cui l’inquadramento di un comportamento in una categoria piuttosto che in un’altra dipende dall’intenzione dell’attore, e questa si legge non con particolari doti “sensitive” ma con il confronto
aperto fra gli attori della valutazione, tenendo conto del contesto del comportamento.
E siccome gli esempi sono sempre utili, eccone un altro, tratto questa volta dall’applicazione pratica del sistema di valutazione dei dirigenti dell’Agenzia. Nella sua relazione sull’attività svolta, un ispettore riferì che il personale di uno degli uffici ispezionati non aveva l’anno prima beneficiato del premio di produzione perché risultava che gli
obiettivi non erano stati raggiunti al livello concordato. L’ispettore si accorse però che la
mancata percezione del premio era dipesa non da una bassa performance dei dipendenti,
che avevano invece lavorato bene, ma da un’errata applicazione delle norme di consuntivazione che aveva portato ad escludere dal computo alcuni output che si sarebbero invece dovuti includere nel rendiconto. L’ispettore diede in quel caso chiare istruzioni su
come andasse fatta la consuntivazione e si preoccupò pure che nell’ufficio si svolgesse
un po’ di formazione degli addetti per evitare che l’errore si ripetesse in futuro. Grazie
all’intervento dell’ispettore, il personale ebbe i soldi che si era guadagnato.
land distingue, in particolare, il potere “socializzato” – che è l’influenza esercitata per realizzare un qualche bene comune più grande di quello proprio o per rafforzare (empower) gli altri: far sentire gli altri forti,
“make others feel strong” – dal potere “personale”, che è l’influenza esercitata per ambizione personale: far
sentire agli altri che si è forti, “make others feel he or she is strong”. Per una chiara e concisa presentazione
di questi concetti si può vedere H.L. Tosi, M. Pilati, N.P. Mero e J. Rizzo, Comportamento organizzativo,
cit., pp. 70-71. Un’esposizione assai più ampia e ricca di esemplificazioni si trova in un articolo dello stesso McClelland pubblicato nel 1976, dal titolo Power is the Great Motivator, ristampato in un numero speciale della «Harvard Business Review», January 2003, pp. 117-126.
149
APPENDICE
150
Sotto quale competenza va classificato questo comportamento? Il valutatore di prima istanza ritenne che il comportamento in questione manifestasse forte “assertività”
(una tipica competenza richiesta agli ispettori), che è la capacità di far rispettare le regole
“costi quel che costi”, e quindi anche a prezzo di sacrifici personali (in altre parole, l’assertività è la capacità di dire “no”, quando è giusto dire “no”, pur essendo magari “impopolare”). In effetti, l’ispettore aveva in quel caso provveduto a far applicare correttamente
le regole in materia di consuntivazione, ma se si va a guardare la sua intenzione come
appariva in modo trasparente da tutto il contesto e come l’interessato stesso la dichiarava
nella descrizione dell’episodio (la mancata corresponsione del premio di produttività
“non rendeva giustizia dell’attività accertatrice dell’ufficio”) era chiaro che non si trattava in quel caso di una manifestazione di “assertività” (a chi o a cosa l’ispettore aveva
inteso dire “no”?), ma dell’espressione di capacità manageriali, come la propensione a
sostenere la motivazione al lavoro dei collaboratori (cosa demotiva di più del non ricevere ciò che si è acquisito titolo ad avere con impegno e applicazione?). È appunto in questo senso che venne corretta la valutazione – come chiedeva l’interessato – in sede di
valutazione di seconda istanza.
Se ben costruito, un dizionario delle competenze dovrebbe agevolare la classificazione dei comportamenti sotto il profilo dell’intenzione che li muove. La definizione di
una competenza ha infatti lo scopo di precisarne con chiarezza qual è la finalità (la ratio,
direbbero i giuristi), ossia l’intenzione fondamentale che lega i comportamenti da ricomprendere in una stessa categoria.
Tutto semplice dunque? No, la costruzione di un modello di competenze o il disegno di una mappa delle competenze, che sono due nomi diversi per la stessa cosa, rimangono un lavoro very difficult and creative. Come però abbiamo visto, la conoscenza dell’esperienza altrui e la riflessione sull’esperienza propria possono facilitare non poco
questo lavoro.
Non resta che un’ultima considerazione. È stato osservato che un limite delle classificazioni delle competenze è che “l’elenco potrebbe continuare in linea di principio
all’infinito. In effetti, un rigonfiamento delle ‘liste’ di oggetti, fino a perdere potere predittivo in quanto tipologie, è un limite ricorrente e probabilmente intrinseco a tutte le
tipologie basate sui contenuti – delle competenze come dei bisogni, dei tratti culturali, o
degli obiettivi”. E ancora: “Le classi delle competenze sono proliferate fino a raggiungere
le svariate decine, basandosi su distinzioni molto generali e di base fra tipi di capacità e
di stili cognitivi – capacità analitiche e operative, tecniche e sociali, professionali e
manageriali, ecc.”92.
Si tratta di una critica che non può essere passata sotto silenzio, anche per la sua
autorevolezza. Come già accennato, il modello generale delle competenze delineato, sulla scia di Boyatzis, da Spencer & Spencer contiene 20 competenze (che coprono però un
universo di circa 300 organizzazioni anche molto diverse fra loro). Di questo modello –
che è un punto di riferimento nella letteratura internazionale – si è tenuto conto nell’A-
92 Tutte queste citazioni sono tratte da A. Grandori, op. cit., pp. 94-95.
APPENDICE
genzia delle Entrate sia per la costruzione del sistema Sirio (riguardante le competenze
dei dirigenti) sia per la costruzione di Antares. Il numero di competenze di Sirio e Antares è, peraltro, assai più contenuto del modello Spencer & Spencer, e non c’è piena
sovrapposizione di contenuti neanche fra Sirio e Antares. Di fatto, ogni organizzazione
ha una sua classificazione di competenze e in letteratura sono stati proposti altri modelli
di classificazione93. Non v’è dubbio che un quadro del genere può trasmettere un’impressione di “erraticità” nelle classificazioni delle competenze. Ma è proprio fondata
questa impressione?
In verità, quando si vanno ad analizzare attentamente le diverse categorie di classificazione, ci si accorge che i nomi variano, ma la sostanza spesso è molto simile. È indubbio invece che assai diversi possono essere gli indicatori comportamentali delle competenze, ma è giusto che sia così per le ragioni precedentemente illustrate (in particolare
quella relativa all’esigenza di “personalizzazione”). Ciò che potrebbe quindi sembrare di
primo acchito “erraticità”, dovrebbe forse più propriamente definirsi “storicità” o – per
usare un termine più vicino alle moderne teorie dell’organizzazione – “contingenza” dei
modelli delle competenze rispetto alla peculiarità delle situazioni organizzative in cui
vanno a calarsi. Insomma, il ritaglio delle competenze nel variopinto tessuto dei comportamenti organizzativi è un’operazione che ha margini di libertà anche ampi, che non
sono però arbitrari, essendo determinati dalle variabili della situazione in cui si opera e
dagli scopi che in quel contesto si perseguono.
Un modello di competenze mira, in definitiva, ad esplicitare (tutte e solo) le categorie di comportamenti che in una data organizzazione sono realmente funzionali alla
superior performance. In questa operazione le domande chiave sono due:
• gli interessati si “riconoscono” nelle categorie individuate dal modello? In altri termini: le condividono pienamente o ritengono che qualche categoria, a loro avviso necessaria, è stata invece dimenticata o che, al contrario, qualcuna che compare nel modello
è superflua o addirittura non pertinente alla missione aziendale?
• è stato effettuato (in primo luogo negli expert panels) un vaglio critico della condivisione del modello da parte degli interessati? In altre parole: è stato analizzato l’effettivo rapporto di causalità fra le competenze ipotizzate nel modello e la performance dell’organizzazione, in modo da verificare se la mancata condivisione dipenda da errori
od omissioni dei costruttori del modello o, invece, dai “Folklore or Motherhood Items”
degli appartenenti all’organizzazione?
Dalla risposta a queste domande dipende la validazione del modello. Se il modello
è validato, il numero e la configurazione delle competenze in cui esso concretamente si
articola non dovrebbe essere più un problema. La questione vera, insomma, non è l’e-
93 Un quadro sinottico dei principali modelli si trova in L.M. Spencer, The Economic Value of Emotional
Intelligence Competencies and EIC-Based HR Programs. Questo lavoro costituisce il capitolo IV di C. Cherniss e D. Goleman, The Emotionally Intelligent Workplace: How to Select for, Measure and Improve Emotional Intelligence in Individuals, Groups and Organizations, San Francisco, Jossey-Bass/Wiley, 2001. Lo
studio di Spencer è consultabile su Internet al seguente indirizzo: http://www.eiconsortium.org/
research/economic_value_of_ei.htm.
151
APPENDICE
stensione della mappa di competenze, ma la sua adeguatezza alla conformazione del territorio cui si riferisce. Se il modello è validato, si potrà pure ritenere che le classi di comportamenti individuate siano troppe o troppo poche, ma ciò non è imputabile al modello
bensì alla natura e alla complessità dell’organizzazione. Questa, però, è un’altra storia.
152
8. Linguaggio qualitativo e linguaggio quantitativo nella descrizione
delle competenze*
8.1 Il linguaggio qualitativo
Così come la regolazione dei comportamenti, la descrizione delle competenze (che
sono categorie di comportamenti) può essere effettuata con due tecniche molto diverse,
ognuna delle quali presenta pregi e difetti. La prima (tipica, ad esempio, degli ordinamenti giuridici dell’Europa continentale) è quella di usare definizioni generali e astratte, mentre la seconda è quella di individuare casi emblematici – individuali e concreti – da utilizzare come precedenti dotati di autorità (questa tecnica è tipica, invece, degli ordinamenti
giuridici anglosassoni). Antares cerca di combinare entrambe le tecniche nell’intento di
rendere quanto più chiari e univoci possibile i criteri di rilevazione delle competenze.
Tutte e due le tecniche presentano poi la criticità tipica dei codici comportamentali,
che è però al tempo stesso il “segreto” della potenza di questi codici: l’utilizzazione del
linguaggio ordinario, di per sé caratterizzato (al contrario dei linguaggi artificiali come
quello del calcolo matematico) da grande plasticità espressiva. Questa plasticità, infatti,
ha come suo naturale risvolto un margine di elasticità semantica che, se per un verso può
a volte dare adito ad ambiguità (e questo è appunto l’aspetto critico cui si è appena accennato), dall’altro, però, permette di ricondurre casi nuovi nelle fattispecie codificate (e qui
sta la potenza dei codici comportamentali, cioè la capacità di “abbracciare” l’inesauribilità dei casi reali). Le prassi che maturano con l’applicazione delle regole rendono poi possibile una gestione efficace dei casi ambigui. Nel definire le singole competenze, il Dizionario Antares fornisce chiavi di lettura che consentono di individuare affinità o analogie
idonee a inquadrare, con sufficiente univocità, nelle fattispecie espressamente descritte le
situazioni non immediatamente riconducibili a quelle stesse fattispecie.
Occorre aggiungere che il carattere analitico degli indicatori comportamentali specificati in un modello di competenze consente di tracciare una fondamentale distinzione: quella fra rilevazione e valutazione dei comportamenti. Una cosa è rilevare fatti e
comportamenti (Tizio ha fatto questo o quello e ha adottato questo o quel comportamento), altro è valutare fatti e comportamenti, dove valutare significa “attribuirvi un valore”.
Il compito dei dirigenti sarà solo quello di rilevare fatti e comportamenti, mentre il valore da attribuire a quanto si è rilevato non sarà compito dei dirigenti (che sotto questo
aspetto dovrebbero propriamente qualificarsi come “rilevatori” piuttosto che come
“valutatori”), ma del sistema di valutazione. Ad esempio, un comportamento suscettibile
* Vengono qui approfonditi temi trattati a p. 25 e a p. 42.
APPENDICE
di essere rilevato potrebbe essere quello della disponibilità del dipendente a sostenere
temporaneamente un carico di lavoro aggiuntivo per sostituire il collega assente. Se a
questo comportamento dovrà poi essere o no attribuito un particolare valore ai fini, ad
esempio, dell’apprezzamento – per la retribuzione accessoria – del grado di impegno nel
lavoro, sarà il sistema di valutazione a stabilirlo. Se vi attribuirà valore, quel comportamento conterà ai fini della valutazione complessiva. In caso contrario, sarà irrilevante e
quindi non dovrà essere rilevato dal dirigente. Questa distinzione fra rilevazione e valutazione è molto importante per l’oggettività dei giudizi.
In letteratura le scale di valutazione legate alla descrizione dei comportamenti sono
denominate BARS (Behaviorally Anchored Rating Scales = “scale di valutazione ancorate
a comportamenti”). Il loro maggiore pregio è di assicurare la massima oggettività possibile
nella formulazione dei giudizi. Lo svantaggio è nella laboriosità dello sviluppo di queste
scale. Impegnativa è anche la loro manutenzione evolutiva, necessaria per mantenerne nel
tempo la validità (cioè la capacità di intercettare i comportamenti organizzativi significativi) e l’affidabilità (cioè l’univocità applicativa, che comporta affinamenti o modifiche agli
indicatori comportamentali per superare ambiguità o incertezze eventualmente emerse
nella concreta esperienza valutativa). Questo processo di manutenzione evolutiva richiede un forte coinvolgimento della linea operativa. A tale scopo, nella fase di applicazione
del sistema valutativo, si può prevedere una procedura di autovalutazione strutturata, grazie alla quale gli interessati possano proporre, per i diversi gradi di intensità delle competenze, altri indicatori comportamentali in aggiunta o a modifica di quelli già previsti, così
da rendere quanto più rigorosa e univoca possibile la rilevazione delle competenze stesse.
L’importanza di avere “behavioural anchors” che definiscano in dettaglio ogni competenza è stata sottolineata da McClelland nell’intervista rilasciata nel 1997 (è stata già citata a
p. 126), nel corso della quale egli dice: “Imprese come queste [McClelland si sta riferendo
a imprese che non hanno fatto un lavoro di chiara definizione delle competenze] potranno
dire a qualcuno che ha un basso punteggio nella leadership. Ma quando gli interessati
chiedono cosa ciò significhi, tutto quello che viene loro detto è che, qualunque cosa s’intenda per leadership, lì vanno male (you’re low in it)”.
8.2 Il linguaggio quantitativo
È pensabile una descrizione delle competenze basata su un linguaggio quantitativo? Se si tratta solo di pensarla (e non anche di chiedersi se ciò che si pensa sia realizzabile) la risposta è sì.
Occorrerebbe passare da descrizioni di comportamenti affidate al linguaggio ordinario (queste descrizioni si chiamano “qualitative”) a descrizioni formulate in linguaggio
matematico (descrizioni, quindi, “quantitative”)94. In estrema sintesi, si tratterebbe di
94 “L’affermazione che una sbarra di ferro aumenta di lunghezza, quando è riscaldata, è un’affermazione qualitativa. L’affermazione che una sbarra di ferro aumenta la sua lunghezza di una certa quantità, quando è
riscaldata a una certa temperatura, è un’affermazione quantitativa” (R. Carnap, I fondamenti filosofici della
fisica, Milano, il Saggiatore, 1971, pp. 343-344).
153
APPENDICE
154
sostituire i numeri (che non siano però semplicemente numeri con valore nominale o ordinale) alle parole. Un salto del genere si è compiuto, quattro secoli fa, nel campo delle scienze della natura, con il passaggio dalla fisica qualitativa di Aristotele alla fisica quantitativa
di Galileo, basata appunto sul linguaggio matematico. La logica e il senso di questo cambiamento – per il quale non è, una volta tanto, sprecato l’aggettivo “epocale”, poiché è all’origine di ciò che chiamiamo “il mondo moderno” – trovano chiara spiegazione nell’ultima
opera pubblicata da Rudolf Carnap, uno dei maggiori studiosi di logica e di filosofia della
scienza del ’900 (dopo l’avvento del nazismo, Carnap emigrò nel 1935 dalla Germania negli
Stati Uniti e in quel paese insegnò nelle Università di Chicago e di California, fino alla morte avvenuta nel 1970). Il brano che riportiamo qui di seguito è di ammirevole chiarezza.
“I concetti quantitativi non sono forniti dalla natura, ma derivano dalla nostra
abitudine di applicare i numeri ai fenomeni naturali. Quali sono i vantaggi di questa
operazione? Se le grandezze quantitative fossero fornite dalla natura, potremmo
rispondere a questa domanda come si risponderebbe alla domanda: quali sono i vantaggi dei colori? La natura potrebbe non avere i colori, ma è piacevole vederli: sono
semplicemente una parte della natura e non possiamo farci nulla. La situazione non è
la stessa nei confronti dei concetti quantitativi: essi fanno parte del nostro linguaggio e
non della natura. Siamo noi che li introduciamo, ed è, quindi,
legittimo chiederci perché li introduciamo. Perché affrontiamo
tutte le difficoltà inerenti alla formulazione di regole e postulati complicati, che ci permettono di avere grandezze che possono essere misurate su scale numeriche?
È stato detto più volte che i grandi progressi della scienza, specialmente in questi ultimi secoli, non ci sarebbero stati
senza l’impiego del metodo quantitativo (esso fu introdotto in
maniera precisa per la prima volta da Galileo naturalmente altri lo usarono prima di
lui, ma fu Galileo che ne diede per primo le regole esplicite)95. Ogni qual volta possibile, il fisico cerca di introdurre concetti quantitativi. Nell’ultimo decennio altri settori della scienza hanno seguito lo stesso cammino. Non dubitiamo che questo sia vantaggioso, ma è bene sapere più precisamente dove si trovano questi vantaggi.
95 “Questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico l’universo), non si
può intendere se prima non s’impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne’ quali è scritto. Egli è
scritto in lingua matematica, e i caratteri sono triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i quali
mezi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro
laberinto”. Come risulta chiaro da questa famosa citazione, tratta da Il Saggiatore, i concetti quantitativi
sono, secondo Galileo, nella natura e l’uomo può solo cercare di scoprirli. Nel brano che abbiamo invece
sopra riportato, Carnap sembra dire che i concetti quantitativi non sono nella natura, ma è l’uomo che ve
l’introduce per i propri scopi. La contrapposizione non potrebbe sembrare più netta. Tuttavia, Carnap si è
sempre opposto all’idea che la scienza sia una pura convenzione umana. Come stanno le cose? È facile
intuire che la questione evocata è fra quelle più importanti della storia del pensiero. Il lettore curioso non
potrà ovviamente trovare in questo manuale nessuna indicazione per una possibile risposta. Se però ne ha
voglia, troverà invece nella lettura del libro di Carnap qui citato un eccellente viatico per un affascinante
viaggio nel cuore della questione.
APPENDICE
Innanzitutto – anche se si tratta solo di un vantaggio minore – si ha un aumento
dell’efficienza del nostro vocabolario. Prima che sia introdotto un concetto quantitativo
occorre usare dozzine di termini o di aggettivi qualitativi diversi per descrivere i vari
stati possibili di un oggetto rispetto a una data grandezza. Ad esempio, senza il concetto
di temperatura, dovremmo parlare delle cose in termini di ‘molto caldo’, ‘caldo’, ‘tiepido’, ‘freddino’, ‘freddo’, ‘molto freddo’, e così via. Questi concetti sono quelli che abbiamo chiamato classificatori. Se avessimo un centinaio di questi termini, probabilmente
non sarebbe necessario, almeno per gli scopi normali, introdurre il concetto quantitativo di temperatura. Invece di dire, ‘Oggi ci sono 25°’, avremmo un aggettivo opportuno
per indicare tale temperatura, ne avremmo un altro per indicare 26°, e così via.
Che cosa ci sarebbe di sbagliato in tutto questo? Innanzitutto dovremmo fare un
grandissimo sforzo di memoria. Dovremmo non solo conoscere un gran numero di
aggettivi diversi, ma anche ricordare il loro ordine in modo da sapere immediatamente se un certo termine sulla scala è più alto o più basso di un altro. Introducendo,
invece, il solo concetto di temperatura, che collega ai numeri gli stati di un corpo,
dobbiamo ricordare un solo termine: l’ordine di grandezza è, infatti, immediatamente
fornito dall’ordine dei numeri. Naturalmente, occorre prima memorizzare i numeri,
ma una volta fatto questo possiamo applicare i numeri a qualsiasi grandezza quantitativa. In caso contrario dovremmo memorizzare un diverso insieme di aggettivi per
ogni grandezza e, in ciascun caso, dovremmo anche memorizzare il loro ordine specifico. E questi sono solo due vantaggi secondari del metodo quantitativo!
Il vantaggio principale, come abbiamo visto nei capitoli precedenti, è il fatto
che i concetti quantitativi ci permettono di formulare legge quantitative. Queste leggi
sono enormemente più potenti sia per spiegare i fenomeni noti, sia per prevedere
nuovi fenomeni. Anche con un ricchissimo linguaggio qualitativo, che caricherebbe
la nostra memoria con centinaia di aggettivi qualificativi, incontreremmo gravi difficoltà anche nella formulazione delle leggi più semplici.
Supponiamo, ad esempio, di essere in una situazione sperimentale in cui si
osserva che una certa grandezza M dipende da una certa altra grandezza P […] Più
specificatamente, supponiamo che M si riferisca alle qualità termiche, e che P si riferisca ai colori. Una legge che collegasse queste due qualità sarebbe costituita da un
insieme di cinquanta frasi condizionali del tipo: ‘Se l’oggetto è molto, molto, molto
caldo’, naturalmente ci sarebbe un aggettivo per esprimere questo concetto ‘allora è
rosso brillante’. In verità, l’italiano dispone di un gran numero di aggettivi per i colori, ma questo è il solo settore di qualità per il quale abbiamo tanti aggettivi. Per molte
altre grandezze della fisica vi è una notevole scarsità di aggettivi nel linguaggio
quantitativo. Una legge espressa in un linguaggio quantitativo è molto più breve e
molto più semplice dell’ingombrante espressione che sarebbe necessaria, se tentassimo di esprimere la stessa legge in termini qualitativi. Invece di un’equazione semplice e compatta, avremo dozzine di proposizioni ‘se... allora’ ciascuna delle quali
accoppia un predicato di una classe a un predicato dell’altra.
155
APPENDICE
156
Il più importante vantaggio della legge quantitativa non è, però, la sua brevità, ma
l’uso che se ne può fare. Quando si dispone di una legge in forma numerica, è possibile
impiegare quella potente parte della logica deduttiva che chiamiamo matematica e, con
essa, fare delle previsioni. Naturalmente, anche nel linguaggio qualitativo può essere
impiegata la logica deduttiva per fare delle previsioni. Dalla premessa: ‘Questo corpo è
molto, molto, molto caldo’ potremmo dedurre la previsione: ‘Questo corpo sarà rosso
brillante’. Ma la procedura sarebbe ingombrante rispetto ai metodi di deduzione potenti
ed efficienti che fanno parte della matematica. È questo il maggior vantaggio del metodo
quantitativo: ci permette di formulare le leggi sotto forma di funzioni matematiche,
mediante le quali è possibile fare previsioni nel modo più preciso ed efficiente.
Questi vantaggi sono così grandi, che nessuno oggi si azzarderebbe a proporre ai
fisici di abbandonare il linguaggio quantitativo e di tornare al linguaggio qualitativo
prescientifico. Però, ai primordi della scienza, quando Galileo calcolava la velocità
con la quale una sfera rotola su un piano inclinato e il periodo di un pendolo, molti
probabilmente si chiedevano: ‘Che ci verrà di buono da tutto questo? In che modo ci
servirà nella vita di ogni giorno? Non mi interesserà mai ciò che accade ai piccoli corpi sferici quando rotolano lungo una guida. È pur vero che i piselli sbucciati rotolano
su una tavola inclinata, ma che valore ha il calcolo della loro accelerazione esatta?
Quale uso pratico può avere questa nozione?’.
Oggi nessuno parla in questi termini, poiché tutti usiamo moltissimi strumenti
complicati – automobili, frigoriferi, televisori – che sappiamo non esisterebbero, se la
fisica non si fosse sviluppata come scienza quantitativa. Ho un amico che sosteneva che
lo sviluppo della scienza quantitativa è deplorevole, perché porta alla meccanizzazione
della vita: gli ho replicato che se voleva essere coerente con le sue opinioni non avrebbe
mai dovuto usare né un aereo né un’automobile né un telefono. L’abbandono della
scienza quantitativa significherebbe l’abbandono di tutte le comodità che sono i prodotti della tecnologia moderna: non credo che molti accetterebbero questo sacrificio”96.
A che scopo la trascrizione di questo lungo brano? Oltre al desiderio di comunicare il
piacere di una straordinaria abilità divulgativa di temi assai complessi e di fondamentale
importanza culturale, l’intento è di portare fino in fondo un esperimento mentale. Per saggiare pienamente l’utilità di uno strumento di cui già disponiamo (nel nostro caso le scale
BARS), può servire immaginare qualche altro strumento che possa in teoria apparire ancora più utile al nostro scopo. Se l’esperimento riesce, siamo contenti di aver trovato una
soluzione migliore. Se fallisce siano ancora più contenti dello strumento che già abbiamo,
poiché, essendoci sforzati di esplorarne i limiti, possiamo ora apprezzarne meglio l’utilità.
Ebbene, ipotizzare una svolta dal qualitativo al quantitativo – come quella cui si è
assistito nella fisica – anche nell’ambito di cui ci stiamo occupando (che rientra nel campo più vasto delle scienze comportamentali), richiederebbe la scoperta di una legge che
96 R. Carnap, op. cit., pp. 136-140.
APPENDICE
leghi comportamenti organizzativi e stati psicosomatici. Per capirci, una legge che stabilisca, ad esempio, che comportamenti, ripetuti e intensi, di leadership generino tracce
stabili a livello psicosomatico di modo che possano essere rilevate con opportune tecniche (rilevazione di parametri biochimici, registrazione dell’attività elettromagnetica di
determinate aree cerebrali, ecc.). Sicché, per rilevare le competenze non siano più necessarie “classificazioni comportamentali”, ma bastino appunto misurazioni psicosomatiche. Un po’ come, per rilevare la febbre, non si fa ricorso a descrizioni di “comportamenti febbrili”, ma ci si affida alla scala numerica di un termometro. Potremmo così andare al
di là delle semplici comparazioni qualitative (Giorgio ha più leadership di Mario) e stabilire precisi rapporti di comparazione quantitativa (Giorgio ha un una volta e mezzo di
leadership più di Mario).
È chiaro che questa ipotesi è pura fantascienza, ma nella sua bizzarria (che scaturisce evidentemente dal “riduzionismo fisiologico” che sembra sottendere l’ipotesi stessa)
può servire a mettere meglio a fuoco il senso del problema che stiamo qui affrontando.
In un film di fantascienza di qualche anno fa, Minority Report97, il tema era quello
della previsione scientifica di comportamenti futuri (in particolare, di comportamenti
criminosi). Nell’ipotesi appena accennata, il tema sarebbe invece quello della rilevazione
scientifica di comportamenti già posti in essere.
Quale potrebbe essere il senso di Minority Report? Con la spettacolarità del grande
cinema di Hollywood, il film di Spielberg propone questioni eterne, come quella del
libero arbitrio, riformulate sullo sfondo attuale degli angosciosi problemi di sicurezza
collettiva, obbligando lo spettatore a interrogarsi sulla possibilità di farvi fronte con azioni preventive efficaci e, al tempo stesso, moralmente e giuridicamente accettabili.
Un senso assai più modesto ha invece l’ipotesi di tecnologie che rilevino le competenze, come i termometri la febbre, e il senso è questo: mostrare che nel campo dei comportamenti umani è ben difficile immaginare la fine dei concetti classificatori. Se abbiamo la sensazione che una persona sia sfebbrata, ma, mettendole il termometro, ci accorgiamo che segna 37,5°, non abbiamo difficoltà a dare subito ragione al termometro. Ma se
registreremo invece un contrasto fra ciò che indicano, ad esempio, i parametri biochimici
e ciò che invece indicano le consuete classificazioni dei comportamenti, a quale istanza
daremo ragione? Se la misurazione dell’intensità di attivazione di una determinata zona
del cervello sembrerà indicare che ci troviamo di fronte a un “grande leader”, mentre la
normale rilevazione dei comportamenti dovesse denotare una capacità di leadership
assai modesta, a quale criterio daremo prevalenza?98.
97 Il film è ambientato in un futuro lontano (anche se non troppo lontano: il 2054) nel quale uno speciale corpo di polizia – la sezione Precrimine – arresta gli autori degli omicidi prima che questi vengano commessi.
Ciò grazie a sofisticate strumentazioni che sfruttano le misteriose capacità sensitive di tre individui chiamati Precogs (abbreviativo di Precognitive Thinkers).
98 Del resto, un’eventuale, futuribile scala quantitativa della leadership (come di ogni altra competenza)
richiederebbe comunque classificazioni comportamentali per definire i valori estremi della scala stessa, un
po’ come nella scala centigrada della temperatura il valore zero è quello dell’acqua che congela, mentre il
valore 100 è quello dell’acqua che bolle. Inoltre, poiché non sembra plausibile che l’intensità delle competenze possa costituire un continuum come il calore o un’altra grandezza fisico-naturale, dovremmo comunque definire classificazioni comportamentali cui agganciare i gradi intermedi della nostra ipotetica scala
157
APPENDICE
9. L’equità procedurale*
158
Nell’economia della conoscenza – e quindi nel mondo delle organizzazioni in cui il
lavoro è basato sulla conoscenza – il principio dell’equità procedurale ha un’importanza
difficile da sopravvalutare. W. Chan Kim e Renée Mauborgne, due studiosi che insegnano
entrambi all’INSEAD – European Institute of Business Administration, scuola aziendale
di fama internazionale che ha sede a Fontainebleau in Francia, argomentano con chiarezza questa tesi citando alcuni significativi casi aziendali (Fair Process: Managing in the
Knowledge Economy, in «Harward Business Review», January 2003, pp. 127-136).
Nel 1992 la Volkswagen, in un momento di forte espansione, decise, accompagnandola con generosi aumenti retributivi, una parziale revisione dei processi di lavoro per
rendere più efficiente la fabbrica di Puebla in Messico, determinante per la penetrazione
nel grande mercato americano. Contraddicendo clamorosamente le aspettative degli stessi sindacati, la riorganizzazione suscitò forti proteste da parte dei lavoratori. Le perdite
che la produzione subì furono gravissime e la prospettiva di forti incrementi della vendita di auto negli Stati Uniti venne sconvolta. Tutto questo perché le ragioni della riorganizzazione non erano state spiegate con chiarezza alle maestranze, che persero fiducia
nel management, benché le modifiche introdotte fossero in sé favorevoli ai lavoratori.
Al contrario, la Siemens-Nixdorf, qualche anno dopo, nel 1994, in una fase di gravissima crisi produttiva, varò un piano aziendale che comportava forti sacrifici per il
personale, ma che gli interessati accettarono, partecipando attivamente al processo di
riorganizzazione. A differenza dei dirigenti della Volkswagen, quelli della Siemens-Nixdorf, a cominciare dall’amministratore delegato, si impegnarono in un capillare lavoro di
spiegazione delle finalità e dei contenuti del piano di ristrutturazione, sollecitando dagli
interessati – sia dirigenti di base che impiegati – modifiche o proposte migliorative. In
appena due anni, la Siemens-Nixdorf condusse in porto una trasformazione che entrò
nella storia dell’industria europea e riportò in attivo il bilancio dell’impresa. Gli impiegati si erano gettati a capofitto nel processo di riorganizzazione (parteciparono a iniziati-
*
quantitativa delle competenze. Non rimane che ripetere che nel campo dei comportamenti umani è ben
difficile immaginare la fine dei concetti classificatori e la loro sostituzione con concetti quantitativi. Se,
nella sua controversia con Newton, sappiamo ormai che Goethe aveva torto nel ritenere che la natura dei
colori dovesse essere studiata, per una migliore conoscenza scientifica, con il metodo qualitativo anziché
con quello quantitativo (Goethe scrisse un grande trattato sui colori, che considerò spesso più importante
della sua intera opera poetica), nella spiegazione del comportamento sociale il linguaggio comune resta –
pur con i suoi (o grazie anche ai suoi?) noti problemi di incertezza, polisemia e circolarità – lo strumento di
analisi più potente e raffinato: “Si tratta di un sistema molto potente, che abbraccia una gran quantità di
tipi di fenomeni sociali e individuali ed è di notevole sottigliezza e raffinatezza. Il suo livello attuale di
sofisticazione è il prodotto di un lungo processo storico, durante il quale esso è stato influenzato in parte
dai bisogni pratici della vita sociale, e in parte dal bisogno di esprimere le sottigliezze dell’interazione
umana, bisogno avvertito da drammaturghi, romanzieri, poeti, avvocati, medici, insegnanti e altre persone
impegnate in attività pratiche. Pensiamo che il linguaggio ordinario e il suo sistema concettuale costituiscano degli strumenti scientifici molto più raffinati di qualsiasi terminologia prodotta a priori e ad hoc
dagli psicologi, sebbene, ovviamente, un vocabolario psicologico molto sofisticato possa essere prodotto
dagli stessi processi che hanno prodotto il linguaggio ordinario” (R. Harré e P.F. Secord, La spiegazione del
comportamento sociale, trad. it. Bologna, il Mulino, 1977, pp. 191-192).
Vengono qui approfonditi temi trattati a p. 34.
APPENDICE
ve di formazione anche dopo l’orario di lavoro, spesso fino a mezzanotte), poiché avevano ritenuto – come osservano Kim e Mauborgne – che il processo avviato dall’azienda
fosse un fair process (fair significa equo, corretto, come nella nota espressione fair play).
Cos’è un fair process? Tre cose, rispondono gli autori appena menzionati: Engagement (coinvolgimento), Explanation (spiegazione) ed Expectation clarity (chiarezza di
aspettative). Engagement significa acquisizione del punto di vista degli interessati nella
formazione delle decisioni organizzative. Explanation significa spiegazione dei motivi
delle decisioni prese e dei loro contenuti. Expectation clarity significa che, una volta
adottata una decisione, vengono ben chiarite e comprese le aspettative che vi sono connesse (nuove regole, nuovi obiettivi, chi è responsabile di che cosa, ecc. in modo da
minimizzare il political jockeying – come a dire: i “giochi di potere” – e i favoritismi). Il
fair process – sottolineano Kim e Mauborgne – non significa “decision by consensus”
(decisione consensuale). Non consiste, in altre parole, nel prefiggersi lo scopo dell’armonia o della conquista dell’appoggio della gente attraverso compromessi. Il suo grande
vantaggio è di dare vita alla cooperazione volontaria, non per ciò che le decisioni aziendali assunte prevedono (può trattarsi anche di decisioni spiacevoli), ma per il modo in
cui le decisioni vengono prese, poiché le persone ne traggono la percezione del rispetto e
della considerazione delle proprie opinioni, e quindi della propria intelligenza. Questa
percezione crea un clima di fiducia e la fiducia, a sua volta, suscita la “voluntary cooperation”, che catalizza iniziative e sprigiona idee, generando risposte che vanno persino al
di là delle aspettative. Se questo è vero, la conclusione cui pervengono gli autori non è
poi così enfatica: l’esperienza dimostra il “tremendous (enorme) power of fair process –
fairness (equità) in the process of making and executing decisions. Fair process profoundly influences attitudes (atteggiamenti) and behavior critical (comportamento critico) to high performance”. A questo “tremendous” potere corrisponde il pesante “price of
Unfairness”. La violazione della procedural justice scatena, per contrappasso, la retributive justice. La perdita di fiducia nel management spinge il personale “a politiche che
sono minuziosamente dettagliate, rigide e spesso soffocanti sotto il profilo amministrativo”, fino magari a rigettare decisioni cruciali per la competitività dell’impresa, pur se
vantaggiose per gli stessi lavoratori. “Such is the emotional power that unfair process
can provoke” (“Tale è la potenza emotiva che l’unfair process può scatenare”).
10. I limiti delle casistiche*
Pensare che si possa chiarire una regola enunciando un’ulteriore regola esplicativa
della prima, conduce a un regresso all’infinito, che, peraltro, non porta ad una sempre
maggiore chiarezza, perché, come sapevano bene i giuristi romani, se una norma è troppo
dettagliata la sua applicazione tende a complicarsi invece che risultare più semplice.
Questo succede perché le norme servono a regolare casi futuri e se le si appesantisce con
troppi dettagli riferiti a singole fattispecie concrete diventa più difficoltosa la possibilità
* Vengono qui approfonditi temi trattati a p. 44.
159
APPENDICE
160
di adattarle, in fase di applicazione, all’imprevedibile e innumerevole combinazione di
casi che si possono presentare in futuro.
Lo scarto tra regola astratta di giudizio (la norma) e la concreta formulazione del singolo giudizio (l’applicazione della norma) è ben illustrato in questo brano di Kant: “Se l’intelletto in generale vien definito la facoltà delle regole, la capacità di giudizio è la facoltà di
sussumere sotto regole, cioè di distinguere se qualche cosa stia o no sotto una regola data
(casus datae legis) ... Se [l’intelletto] volesse poi indicare in maniera generale, come si debba sussumere sotto queste regole, distinguere cioè se qualcosa vi rientri o no, questo non
potrebbe avvenire altrimenti che, ancora, mediante una regola. Ma questa, appunto perché
regola, esige da capo un ammaestramento della capacità di giudizio; e così si vede che l’intelletto bensì è capace di istruirsi e di munirsi con regole, ma la capacità di giudizio è un
talento particolare, che non si può insegnare, ma soltanto esercitare. Quindi il giudizio è
l’elemento specifico del così detto ingegno naturale, al cui difetto nessuna scuola può supplire; perciò, per quanto a un intelletto limitato questa possa somministrare e, per così dire,
innestare in grande abbondanza regole tolte dalla scienza altrui, la capacità tuttavia di servirsene rettamente deve appartenere allo stesso scolaro; e non c’è regola che si possa suggerire a tale scopo, la quale, in mancanza d’un tal dono di natura, sia sicura dall’abuso. Quindi un medico, un giudice, un uomo di Stato può avere nella testa molte belle regole patologiche, giuridiche, politiche, tanto da poterne essere egli stesso un profondo maestro, e tuttavia all’applicazione sbagliare facilmente, o perché manchi di capacità di giudizio naturale (sebbene non manchi di intelletto) e comprenda bensì l’universale in abstracto, ma non
sappia decidere se un caso particolare in concreto vi rientri, o anche per non essere stato
sufficientemente indirizzato a un tal giudizio mediante esempi e casi pratici”. Dopo il passo citato Kant aggiunge in nota che “il difetto di capacità di giudizio è propriamente quello
che si chiama grulleria, difetto a cui non c’è modo di arrecare rimedio. Una testa ottusa o
limitata, alla quale non manchi altro che un conveniente grado di intelletto e dei suoi concetti, si può bene armare mediante l’insegnamento fino a farne magari un dotto. Ma, poiché
in tal caso di solito avviene che si sia sempre in difetto di quello (di Secunda Petri), non è
punto raro il caso di uomini assai dotti, i quali nell’uso della loro scienza lascino spesso
scorgere quel tal difetto, che non si lascia mai correggere”. La Secunda Petri è la facoltà del
giudizio, così detta scherzosamente da Kant con allusione alla II parte della Logica di Pietro
Ramo (1512-1572), che tratta appunto della facoltà del giudizio. I brani qui citati di Kant
sono tratti dalla Critica della ragion pura (Introduzione al libro secondo).
11. Il dilemma del prigioniero*
Il “dilemma del prigioniero” illustra, nel linguaggio della teoria dei giochi, questo
fondamentale problema: il bisogno di cooperazione nella vita sociale e la possibilità che
tale bisogno abbia il sopravvento sulle tendenze egoistiche. In un carcere sono rinchiusi,
in due celle isolate, e quindi senza la possibilità di comunicare fra loro, i prigionieri Neri
* Vengono qui approfonditi temi trattati a p. 48.
APPENDICE
e Bianchi, fortemente sospettati di aver commesso una rapina a mano armata. Il giudice
istruttore interroga separatamente ciascuno di essi, e fa loro un discorso che pone
entrambi di fronte a questo dilemma: confessare o non confessare?
Il giudice dice a Neri: “Non ho ancora la prova che tu, insieme al tuo socio, siate gli
autori della rapina, ma ciò che so di entrambi è sufficiente per mandarvi in galera un
anno per possesso illegale di armi da fuoco. Tieni conto tuttavia che il reato più grave di
cui sei incolpato prevede una pena di 10 anni. Ora, se tu ti dichiari colpevole di questo
reato e il tuo compagno invece non confesserà, farò un patto con te: te la caverai con una
condanna a 3 mesi di carcere, mentre il tuo complice passerà in carcere 10 anni. Se invece confessate entrambi sarete tutti e due condannati a 5 anni di carcere”. Cosa dovrebbe
fare Neri? Confessare subito e beneficiare così – sempreché l’altro non confessi – di una
pena assai mite di tre mesi di detenzione? Oppure non confessare, augurandosi sempre
che anche l’altro non confessi, e farsi così tutt’al più un anno di carcere? Ma attenzione!
Neri deve anche considerare che se non confessa e confessa invece Bianchi, una condanna a 10 anni non gliela toglie nessuno. Meglio allora confessare subito ed essere così condannato – se anche Bianchi confessa – tutt’al più a 5 anni.
Il dilemma del prigioniero
Confessa
NERI
Non confessa
5 anni
10 anni
Confessa
Gioco non cooperativo:
scelta sub-ottimale
5 anni
3 mesi
BIANCHI
Non
confessa
3 mesi
10 anni
1 anno
1 anno
Gioco cooperativo:
scelta ottimale
Niente di più facile che anche Bianchi arrivi alle stesse conclusioni e si precipiti
così pure lui a confessare. Il risultato è che tutti e due dovranno stare in carcere 5 anni,
mentre, se non avessero confessato, sarebbero entrambi usciti di prigione dopo solo un
anno. Morale della favola: quando entrambi i prigionieri agiscono egoisticamente, perché
non si fidano l’uno dell’altro, il dilemma: “confessare o non confessare?” viene sciolto
adottando un comportamento (la confessione) che li porta entrambi a una lunga pena
detentiva. Nel corso del tempo, il dilemma del prigioniero ha avuto numerose versioni.
Una di queste, di stampo “popolare”, si ritrova nel film A beautiful mind dedicato alla
vita di John Nash, matematico americano, premio Nobel. Chi ha visto il film ricorderà
forse l’episodio in cui il protagonista, mentre si trova in un bar con alcuni compagni di
161
APPENDICE
162
università, descrive loro, per spiegare i principi della sua teoria, una scenetta in cui quattro giovanotti si contendono l’amore di una splendida ragazza circondata da quattro amiche. La competizione che ingaggiano li vede tutti e quattro miseramente perdenti. Cooperando le cose vanno molto meglio…
Analogamente, finiscono per adottare una scelta che non è certo la migliore in
assoluto (è una scelta “subottimale”, nel linguaggio degli economisti), i valutatori che
non possono fidarsi (o non ritengono di potersi fidare) l’uno dell’altro. In questo caso, la
scelta subottimale è quella dell’indiscriminata attribuzione a tutti i valutati del giudizio
più favorevole possibile. I valutatori avrebbero interesse a una valutazione “giusta” (cioè
“aderente alla realtà” e rispondente quindi al valore reale delle persone), perché questa
può servire a motivare chi lavora di più e meglio. Ma poiché colui che valuta teme che il
collega possa dare valutazioni tutte “gonfiate”, il suo timore è che la propria valutazione,
benché “giusta”, finisca per non essere “equa”, in quanto suscettibile di penalizzare un
proprio collaboratore che in un altro ufficio sarebbe magari, per la stessa prestazione di
lavoro, valutato assai più generosamente. Il risultato è che ognuno rinuncia allora tout
court alla serietà della valutazione, dando a tutti, indifferentemente, giudizi ottimi. Che
si può fare per evitare questo esito?
Come abbiamo visto, il dilemma del prigioniero avrebbe una soluzione tutta diversa
e assai più favorevole per entrambi i prigionieri, se essi scegliessero di cooperare, vale a
dire di non confessare. Ma occorre fidarsi l’uno dell’altro! Si tratta allora di apprestare
meccanismi di garanzia che sorreggano la fiducia reciproca dei valutatori, trasformandola
– se non proprio da “azzardo” in “certezza” – quanto meno da “azzardo” in “rischio calcolato” o, ancora meglio, in “affidamento ragionevole”. Tali meccanismi devono riguardare
sia l’aspetto dell’oggettività del sistema di valutazione (ancorare le valutazioni a criteri di
giudizio sufficientemente univoci, in modo tale che ognuno possa ragionevolmente attendersi che il collega valuterà una determinata prestazione di lavoro analogamente a come
egli la valuta) che quello della veridicità delle valutazioni (ideare “contrappesi” che depotenzino la tendenza dei valutatori ad esprimere, nei confronti dei propri collaboratori,
valutazioni irrealistiche, in modo tale che ciascuno possa ragionevolmente attendersi che
il collega “non giocherà al rialzo” nell’esprimere le sue valutazioni).
12. Il valore della medietà e lo spazio della formazione*
Potrebbe sembrare incoerente parlare del valore positivo della medietà, quando
invece, nell’approccio di McClelland e dei suoi continuatori, le competenze costituiscono
ciò che i più bravi fanno di differente oppure meglio o di più rispetto agli altri (e cioè presenza/assenza, grado di frequenza e livello di intensità di determinati comportamenti).
L’incoerenza non c’è.
In primo luogo, i medi non sono i just average performers di cui parlava McClelland (“coloro che fanno quel tanto che basta per non essere licenziati”, “people who did
* Vengono qui approfonditi temi trattati a p. 53.
APPENDICE
their jobs just well enough not to get fired” ), ma sono persone che svolgono adeguatamente e onestamente il proprio lavoro. In secondo luogo, i medi sono coloro che eseguono una prestazione di (apprezzabile) valore medio, e non coloro che sono predestinati a
poter eseguire solo una prestazione di quel tipo, come se fosse loro precluso lo spazio per
ulteriori miglioramenti99.
Se, partendo dall’esperienza di best performers, si arriva a delineare un modello di
best performance, l’intento non è di cristallizzare, nel numero e nella composizione, la
categoria di coloro che attualmente eseguono ottime prestazioni. L’intenzione è invece
dinamica: definire un modello che possa valere come chiaro punto di riferimento per tutti coloro (non importa a quale categoria attualmente appartengano) che sono attivamente
interessati a migliorare e sviluppare le proprie capacità.
Fare un “elogio della medietà” non significa quindi porsi come obiettivo quello di
congelare un’organizzazione nel suo attuale livello di medietà. Al contrario, un onesto
riconoscimento della realtà di tale livello costituisce la premessa necessaria per la definizione e il perseguimento di un obiettivo veramente strategico di formazione: trasformare
un’eventuale diffusa “mediocrità” (area di performance medio-inferiore) in una estesa
“medietà” e una consistente quota di quest’ultima in una larga “medio-superiorità”. Le
dimensioni prospettiche di questo programma formativo si possono facilmente intuire
partendo dal grafico seguente che descrive la distribuzione statistica dei dati riguardanti
il valore che, in una popolazione sufficientemente numerosa, una determinata variabile
(ad es. la competenza professionale) tende ad assumere in assenza di interventi espliciti
volti ad imprimere a quella variabile caratteristiche migliorative.
La distribuzione gaussiana raffigurata nel grafico seguente è suddivisa in 5 fasce:
quella centrale C presenta la frequenza più affollata (38% dei casi) e corrisponde a risul99 Nel suo celebre articolo del 1973, McClelland parlando della necessità di costruire test che riflettano i cambiamenti derivanti da ciò che gli individui apprendono, fa questo esempio: “Se l’eccellenza per un agente di polizia è in parte espressa mediante un atteggiamento imparziale verso tutti i gruppi minoritari, si potrebbe utilizzare per la selezione un test sulla imparzialità (o sulla mancanza di etnocentrismo), che dovrebbe riflettere la
crescita in questa dimensione così come il poliziotto la sviluppa sul lavoro dopo il suo reclutamento. Uno dei
più nascosti pregiudizi della psicologia, derivato dal concetto di attitudine immodificabile ed innata, è che
qualunque tratto, come il pregiudizio razziale, non è modificabile con l’educazione. Chi nasce bigotto rimarrà
per sempre bigotto. Non esiste nessuna solida evidenza che questo tratto o qualunque altro tratto umano non
possa essere modificato” (McClelland, Testing for Competence Rather than for “Intelligence”, p. 8). Per quanto
la contrapposizione fra i sostenitori dell’origine genetica di alcuni tratti del comportamento umano, come in
particolare l’intelligenza, e quelli che ne danno una spiegazione riferita all’ambiente continui ad essere piuttosto aspra, né gli uni, né gli altri pretendono che tutta la vicenda possa essere interpretata in chiave genetica o
ambientale. In altre parole, “da entrambe le posizioni si riconosce che in una certa misura le rispettive teorie
non sono in grado di spiegare le variazioni che si riscontrano in questi tratti comportamentali. E questo è un
punto particolarmente importante sotto l’aspetto formativo. Se si ammette infatti che il livello attitudinale possa essere almeno in parte modificato, si lascia aperta la via a un intervento esplicito che si proponga di ottenere
questo risultato” (B. Vertecchi, Le parole della scuola, Milano, La Nuova Italia, 2002, p. 47). C’è, ovviamente,
un problema fondamentale di costi, poiché, per dirla con le parole di un direttore del personale americano, “È
possibile insegnare a un tacchino ad arrampicarsi sugli alberi, ma è più facile assumere uno scoiattolo” (Spencer & Spencer, op. cit., trad. it., p. 33). Tuttavia, una volta che le assunzioni sono state fatte, bisogna sempre
attentamente considerare non solo quali siano i costi della formazione, ma anche quali siano i costi connessi
all’eventuale rinuncia a miglioramenti di prestazione lavorativa resi possibili da appropriate azioni formative.
Per un’analisi della convenienza economica dei programmi di sviluppo delle competenze, si può vedere L.M.
Spencer, The Economic Value of Emotional Intelligence Competencies and EIC-Based HR Programs, cit.
163
APPENDICE
tati medi; le fasce B e D (24% dei casi ciascuna) corrispondono rispettivamente a risultati
medio-inferiori e medio-superiori; infine le fasce estreme A ed E (7% ciascuna) comprendono la prima i risultati peggiori e l’altra i migliori.
Distribuzione pentenaria normale
%
40
media
7
7
164
in ciascuna
fascia
30
rientrano i
punteggi
20
compresi
nell'intervallo
di una
deviazione
10
standard
0
B
A
C
D
E
fascia
38%
7%
7%
24%
Nei modelli più avanzati di mastery learning (apprendimento per la padronanza),
si ipotizza che efficaci programmi di formazione individualizzata (che non significa
“individuale”) possano spostare la distribuzione dei dati dalla classica curva normale a
campana ad una curva a j, così chiamata perché asimmetrica, con frequenze più elevate
in corrispondenza dei risultati migliori (B. Vertecchi, Decisione didattica e valutazione,
Firenze, La Nuova Italia, 1993, pp. 297-300).
Distribuzione a j
70
60
50
40
30
20
10
0
A
B
C
D
E
Bisogna poi sempre ricordare la comune verità – appresa fin dalle prime esperienze scolastiche – secondo la quale il concetto di media non è assoluto ma relativo (l’abilità
APPENDICE
media di un gruppo è la media di quel gruppo: una cosa è essere “medi” in una classe di
“brocchi”, un’altra è essere “medi” in una classe di “bravi”) e non è statico ma dinamico:
crescendo il livello complessivo di abilità di un gruppo, vi aumenta anche il valore
medio di abilità, sicché è tutt’altro che incongruo fare, ad esempio, confronti tra due
organizzazioni, giungendo alla conclusione che in una organizzazione vi sono, a differenza che nell’altra, elementi medi di “buon livello”. In effetti, ciò che fa grande una
grande organizzazione non sono poche punte di eccellenza ma il raggiungimento di elevati standard medi100.
In conclusione, l’apprezzamento del valore della medietà non è deterministico in
almeno due sensi:
• all’interno di un gruppo è sempre possibile (o almeno non lo si può mai escludere a
priori) che con adeguate azioni formative sia possibile elevare la fascia dei mediosuperiori e ridurre, correlativamente, quella dei medi, spostando la composizione del
gruppo da una distribuzione a campana dell’abilità professionale a una distribuzione a
j. In sintesi, questo significa ridurre sensibilmente la percentuale dei medi e far crescere di riflesso la percentuale dei medio-superiori ovvero – per dirla ancora più semplicemente – far diventare maggioranza i “bravi”;
• anche assumendo che la consistenza percentuale dei medi e dei medio-superiori non
possa significativamente cambiare, si può sempre puntare, grazie alla formazione, ad
elevare il livello di professionalità dei medi, ed è proprio questa crescita complessiva
dei medi che può costituire il vantaggio competitivo di un’organizzazione rispetto
all’altra (negli anni ’80 una delle principali differenze tra una fabbrica di auto europea
e una giapponese stava proprio nella capacità media di lavoro degli addetti). In questa
ipotesi, non cambierebbe molto, all’interno dell’organizzazione, il rapporto quantitativo fra medi e medio-superiori, ma, in assoluto, i medi raggiungerebbero un livello di
professionalità significativamente maggiore rispetto al livello precedente o rispetto al
livello di professionalità dei medi di un’altra organizzazione.
100 Questa considerazione di semplice buon senso, tratta dall’esperienza comune, sembrerebbe addirittura
poter assumere una cifra interpretativa più profonda alla luce della teoria dell’evoluzione: “Qualsiasi collettività può giovarsi, al suo interno, di una piccola percentuale di individui con caratteristiche estreme,
ovvero ‘vicini alla punta della coda’: ma è necessario che questi individui non siano troppo numerosi. È
dunque un bene che vi siano dei creativi, e magari anche taluni individui molto creativi, e magari anche
qualcuno così creativo da essere visionario; ma un qualsiasi gruppo diventa caotico se le persone con queste caratteristiche sono più che pochissime. Oppure possiamo supporre che una tribù, o un villaggio, tragga vantaggio dalla presenza di una certa percentuale di coraggiosi entusiasti; però andrà verso il baratro se
le persone pronte a entusiasmarsi non sono controbilanciate da un numero adeguato di persone più caute
e pensose, e magari da pochissime persone (non troppe!) estremamente caute e pensose. E così via.
101 Peraltro, la curva di Gauss testimonia che l’evoluzione stessa delle specie – e dei gruppi – ha operato in
modo tale da distribuire sempre in proporzioni accettabili il rapporto fra medietà ed eccezionalità. Schematizzando, possiamo ritenere che le società con troppi individui banali si siano estinte non meno facilmente di quelle con troppi individui originali” (G. Jervis, Prime lezioni di psicologia, Bari, Laterza, 2000,
pp. 130-131). Considerazioni del genere – che in sé sono tutt’altro che implausibili – vanno tuttavia
accolte sempre con qualche cautela, poiché nella “psicologia evoluzionistica” si manifesta a volte questa
tendenza: “il semplice fatto di poter concepire un’interpretazione adattiva di un dato fenomeno comportamentale diventa la ragione prima per sospettarne un’origine genetica” (H. Allen Orr, Favolistica darwiniana, in «La Rivista dei Libri», n. 9, 2005, p. 18).
165
Indice dei nomi
167
A
Allen Orr, H.; 165
Apel, K.O.; 137
Argyris, C.; 15
Aristotele; 20; 42; 154
Glucksberg, S.; 71
Goethe, J.W.; 158
Goleman, D.; 55; 130; 151
Göring, H.; 127
Grandori, A.; 34; 55; 131; 135; 150
H
B
Barrett, G.V.; 125
Berlew, D.; 144
Boyatzis, R.E.; 55; 125; 130; 135; 143; 144; 150
Hamel, G.; 132; 133
Harré, R.; 158
Hay Group; 21; 137; 138; 144
Holmes, S.; 99
Husserl, E.; 137
C
I
Calvino, I.; 93
Capucci, U.; 51; 130; 134
Carnap, R.; 153; 154; 156
Cassese, S.; 132
Cherniss, C.; 151
Clinton, B.; 132
Croce, B.; 41
Isotta, F.; 34
J
James, W.; 16
Jervis, G.; 165
D
K
Dalí, S.; 37
Darley, J.M.; 71
Davis, K.; 15
Depinet, R.L.; 125
F
Kamprad, I.; 70
Kant, I.; 15; 160
Kaspar; 13
Kelsen, H.; 75
Kim, W.C.; 158; 159
Kinchla, R.A.; 71
Klein, G.D.; 51
Fish, R.; 69; 71
L
G
Gaebler, T.; 132
Galilei, G.; 74; 154; 156
Gandhi, M.; 74
La Torre, M.; 37
Lévi-Strauss, C.; 72
Locke, E.A.; 130
Lovejoy, A.; 143
INDICE DEI NOMI
M
168
Mauborgne, R.; 158; 159
McBer; 144; 145
McClelland, D.; 17; 18; 19; 20; 21; 125; 126;
128; 130; 131; 132; 133; 134; 138; 140;
141; 144; 147; 148; 149; 153; 162; 163
McKee, A.; 55
Mero, N.P.; 32; 34; 45; 49; 149
Miller, W.; 74
Moran, S.F.; 144; 145
N
Naidu, S.; 74
Napoleone; 59
Nardi, E.; 37
Nash, J.; 161
Newton, I.; 158
Normann, R.; 70
S
Sandberg, J.; 32; 128; 129; 135; 136; 137
Schrödinger, E.; 40
Scott, W.G.; 15
Secord, P.F.; 158
Senge, P.M.; 65
Simon, H.A.; 66; 69
Sorokin, P.A.; 42
Spencer, L.M.; 151; 163
Spencer, L.M. & Spencer, S.M.; 18; 19; 24; 51;
126; 128; 130; 131; 135; 137; 138; 139;
141; 143; 144; 147; 148; 149; 150; 151;
163
Spielberg, S.; 157
Sunstein, C.R.; 99
T
O
Tosi, H.L.; 32; 34; 45; 49; 149
Totò; 75
Trilussa; 127; 128
Occam, G. di; 142
Oggioni, E.; 132; 133
Osborne, D.; 132
V
P
Vertecchi, B.; 37; 163; 164
Visalberghi, A.; 41
Pilati, M.; 32; 34; 45; 49; 149
Poincaré, R.; 66
Prahalad, C.K.; 132; 133
W
R
Ramo, P.; 160
Rizzo, J.; 32; 34; 45; 49; 149
Rolandi, A.; 132; 133
Watzlawick, P.; 69; 71
Weakland, J.H.; 69; 71
Weick, K.; 16
Wittgenstein, L.; 39; 44
Le collane del Formez
171
Quaderni
1.
2.
Quarto rapporto nazionale
sulla formazione nella P.A. –
Lo scenario della formazione
nel sistema delle autonomie locali
10. Integrazione dell’offerta formativa –
La normativa nazionale
(maggio 2001)
11. Sesto rapporto nazionale
sulla formazione nella P.A. –
Lo scenario della formazione
nel sistema delle autonomie locali
La riforma del welfare
e le nuove competenze
delle amministrazioni
regionali e locali
(giugno 2001)
3.
Patti territoriali e agenzie di sviluppo
(aprile 2003)
(maggio 2003)
12. L’Amministrazione liberale –
Appunti di lavoro
(giugno 2003)
(giugno 2001)
4.
Il ruolo delle agenzie locali
nello sviluppo territoriale
13. La valorizzazione sostenibile
delle montagne
(giugno 2003)
(luglio 2001)
5.
Comuni e imprese –
56 esperienze di Sportello Unico
(ottobre 2001)
6.
Progetto Officina –
Sviluppo locale
e eccellenza professionale
14. Governare lo sviluppo locale –
Le aree protette marine
della Sardegna
(giugno 2003)
15. Le Agenzie di Sviluppo al Centro Nord –
Strategie di rete e comunità professionali
(giugno 2003)
(febbraio 2002)
16. Contabilità ambientale negli enti locali
7.
Quinto rapporto nazionale
sulla formazione nella P.A. –
Lo scenario della formazione
nel sistema delle autonomie locali
(giugno 2003)
17. Le Agende 21 Locali
(giugno 2003)
(maggio 2002)
8.
Lezioni sul nuovo ordinamento
amministrativo italiano
18. Integrazione dell’offerta formativa –
Normativa regionale
(luglio 2003)
(ottobre 2002)
9.
Le Province nell’attuazione
del piano di e-government
(novembre 2002)
19. Piani di azione e politiche
di innovazione –
Il caso dello Sportello Unico
(dicembre 2003)
20. Le autonomie locali nelle regioni
a Statuto speciale e nelle
Province Autonome
34. Scenari per il ‘buon governo’
delle Regioni
(aprile 2005)
(marzo 2004)
21. La Pubblica Amministrazione
e il sistema delle imprese –
Rapporto di ricerca
172
35. Qualità nei Servizi per l’Impiego –
Sistemi locali e nuovi strumenti
di rilevazione
(aprile 2005)
(marzo 2004)
22. La comunicazione pubblica –
Linee operative
(giugno 2004)
36. Ottavo rapporto nazionale
sulla formazione nella P.A. –
Lo scenario della formazione
nel sistema delle autonomie locali
(luglio 2005)
23. La semplificazione amministrativa
nelle regioni
(giugno 2004)
24. Settimo rapporto nazionale
sulla formazione nella P.A. –
Lo scenario della formazione
nel sistema delle autonomie locali
37. L’empowerment degli Sportelli unici
(settembre 2005)
38. Note e commenti sul sistema
amministrativo italiano/2004
(3 voll.)
(ottobre 2005)
(luglio 2004)
25. La formazione nella P.A. che cambia –
L’esperienza del Ministero dell’Ambiente
39. Autonomia tributaria
e federalismo fiscale
(novembre 2005)
(luglio 2004)
26. L’attrattività dei territori nelle politiche di
internazionalizzazione
(ottobre 2004)
27. La governance dell’internazionalizzazione
produttiva – Il Laboratorio
(ottobre 2004)
28. La governance dell’internazionalizzazione
produttiva – L’Osservatorio
(ottobre 2004)
29. La comunicazione interna
nella P.A. regionale e locale
(novembre 2004)
40. Nuovi profili di accountability
nelle P.A.
(2 voll.)
(novembre 2005)
41. Il governo della salute – Regionalismi
e diritti di cittadinanza
(dicembre 2005)
42. Autonomia regionale e unità
della Repubblica
(dicembre 2005)
43. La contrattazione integrativa
nei comparti della P.A. –
Quadriennio 2001/2004
(febbraio 2006)
30. La public governance in Europa
(7 voll.)
(dicembre 2004)
31. Nuovi soggetti della governance esterna
44. Sostenibilità urbana e decentramento –
La Rete dei Municipi di Roma
per Agenda 21 Locale
(febbraio 2006)
(dicembre 2004)
32. L’analisi di impatto della regolazione
in dieci Paesi dell’Unione europea
45. Scenari e tendenze
della formazione pubblica
(marzo 2006)
(gennaio 2005)
33. Le risorse culturali – Studi di fattibilità
ed esperienze di gestione
(gennaio 2005)
46. I livelli essenziali delle prestazioni –
Questioni preliminari e ipotesi
di definizione
(giugno 2006)
47. Nono rapporto nazionale
sulla formazione nella P.A. – Lo scenario
della formazione nel sistema
delle autonomie locali
50. La semplificazione tra Stato, Regioni
e Autonomie locali – Il caso
della legge 241
(novembre 2006)
(luglio 2006)
48. L’amministrazione per sportelli
(ottobre 2006)
49. I confronti di performance tra Comuni
come strumento di apprendimento
51. Note e commenti sul sistema
amministrativo italiano in contesto
internazionale. 2006
(3 voll.)
(dicembre 2006)
(ottobre 2006)
Strumenti
1.
Il contenzioso nel lavoro pubblico
(maggio 2001)
2.
Modello e strumenti di valutazione
e monitoraggio dei corsi RIPAM
(luglio 2001)
3.
Appunti di programmazione, bilancio
e contabilità per gli enti locali
(gennaio 2002)
4.
Project Cycle Management –
Manuale per la formazione
(marzo 2002)
5.
Il governo elettronico – Rassegna
nazionale e internazionale
(marzo 2002)
6.
Il governo delle aree protette
(aprile 2002)
7.
Il contenzioso nel lavoro pubblico –
L’arbitrato
(aprile 2002)
8.
Common Assessment Framework –
Uno strumento di autovalutazione
per le pubbliche amministrazioni
(giugno 2002)
9.
Il controllo di gestione
negli enti locali
(luglio 2002)
10. Comunità di pratiche,
apprendimento e professionali –
Una metodologia per la progettazione
(dicembre 2002)
11. Modello e strumenti web-based
di valutazione e monitoraggio
dei corsi RIPAM
(marzo 2003)
12. L’impresa artigiana e lo Sportello
Unico per le attività produttive
(marzo 2003)
13. Programmazione e realizzazione
di progetti pubblici locali – Un sistema
di monitoraggio degli interventi
(giugno 2003)
14. Manuale per il responsabile
dello Sportello Unico –
Regione Lombardia
(giugno 2003)
15. Manuale per il responsabile
dello Sportello Unico –
Regione Emilia-Romagna
(settembre 2003)
16. Il sistema normativo
della protezione civile
(novembre 2003)
17. Il ruolo delle Province
in materia di viabilità
(febbraio 2004)
18. Investimenti pubblici
e processo decisionale
(maggio 2004)
19. Manuale per il responsabile
dello Sportello Unico –
Regione Campania
(maggio 2004)
173
20. Manuale per il responsabile
dello Sportello Unico –
Regione del Veneto
28. La Governance locale –
Linee guida per le Province
(novembre 2005)
(giugno 2004)
21. Il contratto di servizio – Elementi
per la redazione e la gestione
29. La governance locale – Linee guida
per le Comunità montane
(dicembre 2005)
(luglio 2004)
174
22. Guida alla progettazione
dell’offerta formativa integrata
(luglio 2004)
30. Le garanzie nel sistema locale
delle comunicazioni: le deleghe
ai Co.Re.Com. – Linee guida
per le materie delegate
(dicembre 2005)
23. Programmazione e gestione
della formazione – Il sistema Informal
(novembre 2004)
24. Manuale per il responsabile
dello Sportello Unico –
Regione Piemonte
(dicembre 2004)
25. La Governance locale –
Linee guida per i Comuni
(agosto 2005)
26. Il lavoro coordinato e continuativo
nella P.A. – Linee guida
31. Manuale per il responsabile
dello Sportello unico –
Regione Lazio
(dicembre 2005)
32. Le misure del cambiamento
nella P.A. – Indicatori di performance
(febbraio 2006)
33. La governance locale – Strumenti
e buone pratiche
(3 voll.)
(maggio 2006)
(settembre 2005)
27. La finanza di progetto –
Esperienze a confronto
34. Scenari della riforma
dell’Unione europea
(ottobre 2005)
(dicembre 2006)
Azioni di Sistema per la Pubblica Amministrazione
1.
Sportello Unico e servizi
alle imprese – Le azioni delle Regioni
6.
(novembre 2002)
2.
L’impatto economico
dello Sportello Unico
(agosto 2003)
7.
(novembre 2002)
3.
Scambio di innovazioni
tra amministrazioni
Il Bilancio di Competenze –
Una proposta per la Pubblica
Amministrazione
(giugno 2003)
5.
Progetti integrati e sviluppo
territoriale – Regioni Obiettivo 1
(luglio 2003)
Le politiche di incentivazione
del personale nella P.A.
(agosto 2003)
8.
(aprile 2003)
4.
L’attuazione della riforma
del welfare locale (2 voll.)
Lo sviluppo delle risorse umane –
Casi di sistemi premianti
(agosto 2003)
9.
Lo Sportello Unico e le politiche
regionali per le imprese
(dicembre 2003)
10. Modelli di gestione
per i Progetti Integrati Territoriali
(dicembre 2003)
11. Governance e sviluppo territoriale
(dicembre 2003)
20. Percorsi evolutivi dei Piani di Zona –
Analisi di sfondo
(novembre 2004)
12. Le competenze delle Agenzie
di sviluppo – Sperimentazione
in Calabria e Sardegna
(dicembre 2003)
13. Il partenariato socioeconomico
nei progetti integrati territoriali
(dicembre 2003)
14. Apprendimento e cambiamento
organizzativo nella P.A. –
Tre casi europei a confronto
(aprile 2004)
15. L’esperienza dei PIT – Studi di caso
(aprile 2004)
21. Riforma del welfare e gestione
dei servizi sociali –
Quadro normativo e strumenti di lavoro
(dicembre 2004)
175
22. Lo sviluppo dei sistemi turistici locali –
Regioni Obiettivo 1
(dicembre 2004)
23. Gli osservatori provinciali sociali
(febbraio 2005)
24. Strategie di utilizzo del marketplace
nelle amministrazioni pubbliche
(marzo 2005)
16. La formazione continua nella P.A. –
L’esperienza del Progetto Gymnasium
(aprile 2004)
17. Flessibilità e lavoro pubblico –
Manuale operativo
(maggio 2004)
18. Gestione delle procedure
telematiche di acquisto nelle P.A. –
Linee guida sul marketplace
25. Sviluppo territoriale Agenzie
e Pubblica Amministrazione –
Interpretazioni e pratiche innovative
(maggio 2005)
26. La programmazione sanitaria –
Metodologie e strumenti di valutazione
per le Regioni e le aziende sanitarie
(giugno 2005)
(maggio 2004)
19. Sistemi informativi
per i progetti integrati territoriali
(luglio 2004)
27. Dai sistemi di qualità alla qualità
di sitema – La domanda-offerta
di formazione per la P.A.
(dicembre 2006)
Formez
Ufficio Stampa ed Editoria
via Salaria 226, 00198 Roma
tel. +39 06 85330783
[email protected]
Formez
Centro di Formazione Studi
Presidenza e Direzione Generale
via Salaria 229, 00199 Roma
tel. 06 84891
www.formez.it
Stampa Società Tipografica Romana S.r.l. - Pomezia (Roma)
Finito di stampare nel mese di febbraio 2007
Pubblicazione non in vendita