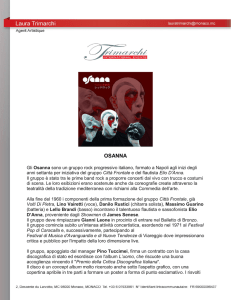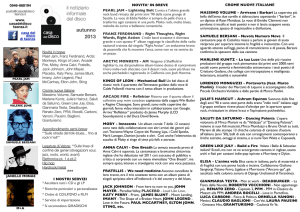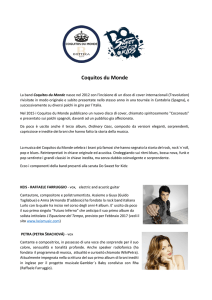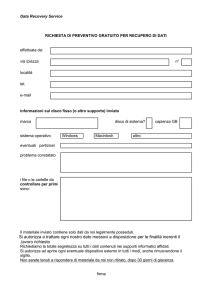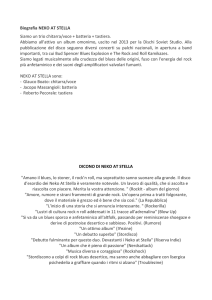digital magazine febbraio 2010
Lightspeed
Champion
Costruzioni
in
Sincrono
Barn Owl
N.64
DâM Funk
Field Music
Gun Club
3-D parte terza
—Waste Lands
Agent Side Grinder // Get Well Soon // The Please
Million Young // Bologna Violenta // Dataschock
64
Sentireascoltare n.
La casa editrice Odoya e SentireAscoltare presentano:
Turn On
PJ HARVEY
Musica.Maschere.Vita
Un libro di Stefano Solventi
La sua musica è una sferzata misteriosa e misteriosamente liberatoria.
Un’ossessione blues sbocciata nella culla del Dorset, cresciuta tra inquietudini adolescenziali e una incontenibile brama di mondo. Quando infine
è esplosa, lo ha fatto col piglio travolgente dei predestinati. Dei suoi primi
quaranta anni, Polly Jean Harvey ne ha dedicati venti a tracciare una
parabola fatta di musica, maschere e vita.
240 pagine
Volume illustrato
euro 15,00
p. 4
Agent Side Grinder
5
Get Well Soon
6
The Please
7
Million Young
Tune In
8
Bologna Violenta
12
Dam Funk
10
Dataschock
15
Field Music
Drop Out
18
Barn Owl
26
Lightspeed Champion
Recensioni
CONCEPT ALBUM
Adam Green, Claudio Rocchetti, Magnetic Fields, Richard Skelton...
Rearview Mirror
Un libro di Daniele Follero
Introduzione Franco Fabbri
Nata sull’onda della rivoluzione musicale di fine anni Sessanta, la pratica
del concept album ha accompagnato la maturità del rock, scrivendo un
capitolo importantissimo nella storia della popular music. I dischi “a tema”
continuano ancora oggi a rappresentare un affascinante mezzo espressivo,
anche negli ambienti del pop da classifica. I recenti concept album dei Green Day sono la testimonianza più lampante di un filo rosso che, partendo
da Frank Sinatra, tiene insieme Sgt. Pepper’s dei Beatles, Tommy degli Who,
The Dark Side of the Moon e The Wall dei Pink Floyd, le storie d’amore di
Claudio Baglioni arrivando fino ai Dream Theater e al brit-pop.
226 pagine
Volume illustrato
32
euro 15,00
42
Gun Club, Frank Zappa, Morphine, Matt Elliott...
Rubriche
78
Gimme Some Inches
80
Re-boot
94
Giant Steps
95
Classic Album
96
La Sera della Prima
Direttore: Edoardo Bridda
Direttore Responsabile: Antonello Comunale
Ufficio Stampa: Teresa Greco
www.odoya.it
www.sentireascoltare.com
Coordinamento: Gaspare Caliri
Progetto Grafico
e
Impaginazione: Nicolas Campagnari
Redazione: Gaspare Caliri, Nicolas Campagnari, Antonello Comunale, Teresa Greco, Stefano Pifferi, Stefano Solventi.
Hanno
collaborato:
Leonardo Amico, Gianni Avella, Luca Barachetti, Salvatore Borrelli, Marco Braggion,
Luca Colnaghi, Gabriele Marino, Francesca Marongiu, Andrea Napoli, Massimo Padalino, Giulio Pasquali, Aldo
In tutte le librerie
Romanelli, Costanza Salvi, Giancarlo Turra, Fabrizio Zampighi.
Guida
In
2
spirituale:
copertina:
Adriano Trauber (1966-2004)
Lightspeed Champion
Get Well
Soon
—La Neo Wave in
chiave svedese—
—L’arte del
malessere—
A detta di alcuni, la risposta
europea ai Cold Cave arriva da
Stoccolma
Un concept orchestrato intorno
al dominio sulle passioni, una
liricità estrema e tanto chamber
pop per il ritorno di Konstantin
Gropper
“R
I
n giro per il web può capitare di leggere di come
Agent Side Grinder sia la controparte svedese dei
Cold Cave e, con i dovuti distinguo, è tutto sommato
vero. L’annosa competizione USA-Europa non sembra
perdere smalto e il gruppo di Stoccolma, come il quartetto di Philadelphia, è alfiere del rinato interesse per le
sonorità wave, post-punk ed early industrial, non senza alcune differenze. Mentre il gruppo di Wesley Eisold,
dopo un inizio tanto oscuro quanto fulmineo, ha svoltato
in direzione pop, guadagnandosi un contratto con Matador, oltre che l’interesse delle testate musicali internazionali, gli svedesi di Kristoffer Grip sono rimasti accasati
presso l’olandese Enfant Terrible, label guida della scena
electro e minimal synth europea. Il che, se non li ha resi
celebri, non ha impedito loro di sfornare ottimi lavori.
Nel 2008, per l’etichetta di Utrecht pubblicano un
esordio che getta sul piatto tutti i dadi: basso secco e
corposo, elettronica groovy, una voce in pieno stile wave
che cita tanto Peter Murphy quanto Jim Morrison. I brani sono cavalcate di media lunghezza che insistono su
4
trame robotiche dallo spiccato sapore proto industriale.
Asse che ritroviamo sostanzialmente immutato a poco
più di un anno di distanza nei due nuovi ellepì. Il primo,
meno diretto e maggiormente elaborato, Irish Recording
Tape a proseguiree sulle coordinate del debutto e il secondo, la vera sorpresa, The Transatlantic Tape Project. Il
nome deriva dall’effettivo scambio di master tape avvenuto per tutto il 2009 tra la Svezia e gli Stati Uniti, dove
per un anno ha soggiornato uno dei membri e consta di
sette sorprendenti episodi strumentali dai nomi cifrati.
Una sorta di musica elettronica da camera.
Proprio per la natura ambientale della musica (ottima come colonna sonora per un film di David Lynch)
il gruppo sta lavorando alla realizzazione di una parte
visiva che, nel prossimo futuro, darà vita ad una performance che speriamo tocchi anche il suolo italiano.
Andrea Napoli
Turn On
Turn On
Agent
Side
Grinder
est now, weary head you’ll get well soon”, dell’arte del malessere e del rimettersi in sesto: sin
dall’incipit dell’esordio pubblicato nel 2008 (Rest Now,
Weary Head) si intuisce la ragion d’essere di Get Well
Soon. Dietro al moniker troviamo il multistrumentista
tedesco Konstantin Gropper, due album all’attivo, il
secondo dei quali, Vexations, in uscita su City Slang a
fine gennaio.
Strano connubio il suo tra classica e pop, malinconia
e statement filosofico-esistenziali, senza ovvie classificazioni. I consueti studi classici alle spalle, cominciati da
bambino con il violoncello, mentre in casa si respira un
ambiente favorevole, complice il padre insegnante di musica, fino all’affrancamento da adolescente dalla classica
e la formazione di band influenzate da punk e grunge.
Insomma il tipico percorso indie che fa sì che il Nostro,
dopo la scuola, si dedichi completamente alla musica, prima solo elettronica. Segue la nascita della creatura Get
Well Soon a inizi 2000 e l’apprendistato tra live e l’uscita di 4 EP, fino all’esordio, Rest Now, Weary Head. Pop,
elettronica, folk e classica amalgamati con gusto estetico impeccabile e sensibilità indie, tra tentazioni klezmer tipicamente Beirut, malinconie assortite di marca
Leonard Cohen e Thom Yorke, un’impronta DIY e
un’atmosfera che risente della classica ma senza essere
preponderante nell’economia generale. Il disco ha successo in Europa e Gropper si imbarca in un tour con
una band assemblata all’uopo. In contemporanea la composizione di colonne sonore per film (l’ultimo Palermo
Shooting di Wim Wenders).
Il secondo album, Vexations (da un pezzo al piano di
Eric Satie che fa da leitmotiv) cambia d’atmosfera; c’è il
ripiegamento da “quiete dopo la tempesta”, una riflessione
sul bisogno umano di socialità e insieme di isolamento.
Un concept sullo stoicismo e il dominio sulle passioni,
da Seneca a Sartre, con una struttura elaborata; è stato
concepito in un paio di mesi, come rivela l’autore e poi
registrato con un quartetto d’archi e una sezione fiati,
per un risultato che lo ha soddisfatto interamente (“il
disco suona come volevo e non come un’accumulazione di
inadeguatezze”). I soliti ingredienti sono spinti di più verso un pop orchestrale compatto che procede per accumulazione, senza risultare barocco. Una liricità estrema
lo pervade mentre concettualmente vengono sviluppati
i temi sui quali Gropper si è concentrato, in una sorta di
“lyric patchwork” che termina con un senso di speranza e
calma. Beirut, Cohen, Ennio Morricone e tanta musica
da film dentro. Una bella conferma.
Teresa Greco
5
C
onverrete che con un nome così andarci prevenuti
è legittimo, se non scontato. Il carrozzone indiefichetto è lì, dietro l’angolo e di gruppi che iniziano col
The (e magari finiscono con la -s) se ne hanno piene le
scatole da un bel po’. E invece, come al solito, a giudicare
il regalo dalla scatola ci si sbaglia eccome. The Please,
trio e moltitudine lombardo, è infatti una piacevole sorpresa.
Nascosti dietro una cortina di originali nom de plume
– pieni zeppi di bislacchi riferimenti a musicisti, scrittori,
artisti in generale – troviamo Mattia Airoldi aka Louis Lenmar Moons, Luca Piazza aka O.J. Plaza e Marco Gilioli aka
William Thelonious Coleridge IV, allegramente impegnati a
scambiarsi voci, chitarre, basso, organo, glockenspiel, theremin, grandpiano, tastiere e chi più ne ha più ne metta.
Considerando che ad accompagnarli c’è una altrettanto
sterminata messe di ospiti – a violino, violoncello, tromba,
trombone, batterie e percussioni – anch’essi tutti rigorosamente sotto pseudonimo, capirete che orchestrazione
e respiro ampio sono prerogativa del progetto. Roba che
si ripropone anche in sede live, dove The Please muta
pelle a seconda delle situazioni contingenti, come ci dice
Mattia Airoldi: Ci giostriamo dalla formazione base in tre ("
lo zoccolo duro") fino a quella completa in nove, passando
anche per fasi intermedie (quattro o cinque elementi).
6
Million
Young
—Piaceri nichilisti—
—Passionate music
dreamer—
Pop raffinato, sensibilità
crepuscolare ed eleganti sermoni
nichilisti orchestrati da un trio di
ventenni lombardi, coi piedi ben
piantati in terra d'Albione.
Due EP e a breve un nuovo album.
Mike Diaz è il nuovo uomo del
glo-fi
Classico l’apprendistato nell’underground rock a
botta di demo e concerti, mentre è roba di questi giorni
l’esordio ufficiale maturo e dal doppio titolo, enigmatico
il primo, programmatico il secondo. E’ltica – Sermon
Your Nihilism, mette in scena un concentrato di raffinata eleganza rock alla maniera di Tindersticks e Nick
Cave, capace di richiamare il Lou Reed solista più sentimentale come degli Arcade Fire meno banali, schizzi
di americana e aperture verso un pop orchestrato e variopinto. Questo nonostante tra le influenze dichiarate
del gruppo ci siano esperienze diverse come Beatles,
Sigur Rós e Motorpsycho.
Musica umbratile e chiaroscurale, romantica e ricercata, fuori tempo e insieme classica, quella di The Please,
in cui orchestrazioni e respiro ampio si manifestano sia
per i riferimenti che per gli arrangiamenti. Ben piantati nella terra d’Albione, i primi, equilibrati e sofisticati
i secondi. Dopotutto l’album è da subito pretenzioso,
in quanto concept incentrato – sempre nelle parole del
cantante – sulla fine del mondo (che noi ci aspettiamo nel
2012, già da tempi non sospetti) e sulla rinascita. Se questa è la rinascita, allora speriamo che sto mondo finisca
presto.
Stefano Pifferi
P
Turn On
the
please
ochi mesi fa Mike Diaz partiva con l'avventura glo
senza rendersene troppo conto. Aveva reso disponibile sul myspace, un eppì (Sunndreamm EP) in free
downloading aspettando cosa sarebbe successo. Di
lì appresso la gente "ha iniziato a fare paragoni " e a
snocciolare le etichette che tutti sappiamo: dreamwave,
chillwave e appunto glo fi, le solite perle del rosario che
la blogosfera sta tutt'ora mandando a memoria. A quel
punto non ha potuto che accettare il fatto: cresciuto a
pane DNTEL e Radio Dept. nella sua Coral Springs,
tra tastierine e sequencer è approdato alle stesse epifanie '80 dei colleghi in un mix di chilling e dancing.
Il nuovo Be So True EP declina perfettamente quel
“beach-going da set notturno ” che Washed Out,
amico e mentore, (gli) ha indicato. Diaz non fa mistero
dell'influenza di Ernest Young, i due si sono conosciuti di
persona l'estate scorsa scoprendo di avere tantissimo in
comune; cosa che non ci sorprende affatto vista l'età, il
contesto d'origine (la provincia), il setting familiare e il
metodo compositivo viene di conseguenza: “Quando mi
metto a scrivere un pezzo scavo intorno ai suoni finché non
trovo qualcosa che mi piace. C’è sicuramente qualcosa di
nostalgico nei synth Casio. Durante i Novanta i miei genitori
ascoltavano (e ascoltano) Michael Jacskon, Bowie e i Queen
in rotazione continua. Penso di aver vissuto gli '80 attraverso
loro”.
Dunque ancora fonti sonore mai vissute che finiscono nell'archeologia di un'osmosi/playback, caratteristiche
più volte analizzate, comune denominatore di una nostalgia '00 attualizzata alle istanze dancefloor. Inevitabile
che nella nostra chiacchierata gli chiedessimo di Ibiza.
“Non ci sono mai stato. Ci andrò sicuro perché mi piace scrivere musica con cui la gente si può muovere. Quando si parla
di dance la gente pensa il più delle volte ai Justice. Eppure
tutto il mondo chill è altrettanto importante per la dance. Diciamo che sono per sonorità à la ‘I Want To Rock With You’ di
Michael Jackson e mi piace sperimentare con strutture che
non necessariamente riconducono al 4 in cassa dritta. Prendi
gli Animal Collective la gente impazzisce quando mettono
‘Fireworks’”. Gli Animal Collective sono sicuramente
dei catalizzatori generazionali, eppure con un classe '88
come Diaz c'è già un piccolo scarto a profilarsi all'orizzonte.
Il nuovo album sarà pronto probabilmente tra Aprile
e Giugno; nel frattempo qualche remix e un tour sulla
costa Est degli Stati Uniti. “Il mio passaporto è nella cassetta della posta e se tutto andrà bene tornerò in città molto
tardi quest’anno”. Buon viaggio Mike.
Marco Braggion
7
Turn On
Bologna
Violenta
—Grindcore
necrologico—
Il b-movie sonoro di Nicola
Manzan
E
qualcuno ora ha anche vergato il necrologio. Sardonico, angosciante, deleterio per le nostre orecchie.
Ma non più di quanto lo sia stato il soggetto della cui
morte Nicola Manzan aka Bologna Violenta dà il triste annuncio: il caro vecchio occidente la cui deficienza
(morale, estetica, semplicemente umana) viene sbeffeggiata in ventitré cluster grindcore che inframezzate da
brevi testi recitati diventano il radiodramma cinematico
di un'apocalisse senza trionfo. Il Nuovissimo Mondo
8
(sottotitolo: Dramma in XXIII atti sulla sorte del mondo e sul declino del genere umano) continua dunque
l'innamoramento verso il cinema italiano “minore” del
polistrumentista emiliano, passione che già dall'acronimo sceltosi per le sue esperienze in solitaria espone un
immaginario preciso da cui attingere: «Nel 2005 stavo
attraversando un periodo non proprio felice: arrivato
a Bologna da un paio d'anni mi ero ritrovato con tutti
i sogni infranti e soprattutto sempre più lontano dagli
obiettivi che mi ero proposto di raggiungere. Ad un certo punto mi è venuta voglia di fare un disco estremo,
volevo sentire della musica che non avesse i difetti che
hanno anche i dischi migliori, che fosse insomma “perfetta” per i miei gusti e che soprattutto mi desse il coraggio di andare al lavoro ogni mattina alle 4.30. Visto che
di b-movies ne ho sempre visti parecchi (mi ha sempre
appassionato ciò che è fuori dalla “normalità”), ho pensato che fosse una cosa simpatica omaggiare sia la città
di Bologna che un certo modo di fare cinema in Italia,
ormai passato, che però secondo me è legato a doppio
filo con certa musica più o meno estrema. Così, giorno
dopo giorno è nato il primo disco, con ventisei tracce da
ventisei secondi l’una».
Uscito sotterraneamente nel 2006 per la SK records,
il debutto di Bologna Violenta (con titolo identico alla
ragione sociale) getta le basi ad una poetica di bordo
capace di destrutturare i due poli entro cui si muove (da
una parte l'immaginario b-movie italiano di registi come
Umberto Lenzi e Ruggero Deodato o di compositori come Riz Ortolani e Franco Micalizzi, dall'altra il
grind alla Naked City) e di convogliare il tutto verso
composizioni brevilinee e stilettanti, trapanature uditive che passo dopo passo (tre ep e la partecipazione a
varie compilation dopo l'esordio) si fanno corrosive penetrazioni della coscienza. Così nell'ultimo lavoro uscito
per l'etichetta Bar La Muerte di Bruno Dorella, che
prende a prestito la poetica dei mondo-movies come
“Mondo Cane” e la mischia ad un grind di volta in volta
sporcato (da folk, lounge, techno): «La prima volta che
vidi Mondo Cane fu parecchi anni fa, lo davano in tv di
notte. Quello che mi è piaciuto dei mondo-movies è che
ad un certo punto sorge spontanea la domanda se noi
“civilissimi occidentali” siamo davvero più evoluti di altri
popoli. Questa domanda viene fatta nascere attraverso
l’uso di tematiche shockanti e la creazione di contrasti
forzati mescolando realtà, ricostruzione e finzione, tutte
caratteristiche adatte al disco che volevo fare, in cui ci
fosse una visione diversa del mondo odierno, che non
è solo quello della tv, quello che i media ci vogliono far
credere, pieno di lustrini e convenzionale buonismo». E
accanto a ciò anche una riflessione antropologica che
supera ogni barriera pur di concentrarsi sul crollo: «A
livello concettuale mi sono avvalso poi dell’aiuto della
dottoressa Emanuela Masia che con i suoi studi antropologici e la sua passione per i mondo-movies è riuscita
a rendere più chiaro il mio pensiero sull’uomo e a dare
una forma più solida al concept del disco, che in sostanza
vuole raccontare la realtà dell’essere umano occidentale,
che ritengo più o meno sull’orlo di un baratro che si è
“costruito” da solo».
Tuttavia Nicola Manzan non è solo Bologna Violenta
ma anche un musicista, violinista in primis, che disco altrui dopo disco altrui si è guadagnato un saldo riconoscimento nel micromondo indipendente italiano e non
solo (Baustelle, Alessandro Grazian, Non Voglio
Che Clara, addirittura Ligabue, e ultimo solo in ordine cronologico l'ingresso nella line-up de Il Teatro degli Orrori). «Negli ultimi anni ho lavorato molto come
musicista per altri artisti, portandomi a casa una certa
esperienza di studio. Non è sempre facile, non sempre
mi piacciono i pezzi su cui devo registrare, ma spesso
la componente umana va a colmare certe differenze di
gusto». Come ad esempio nell'incontro con un altro
musicista di lusso, leggi alla voce PJ Harvey: «Un’esperienza che ricordo sempre con grande piacere è stata la
registrazione dei violini nel disco di Giovanni Ferrario Headquarter Delirium, mi sono ritrovato a lavorare con un artista che non mi chiedeva solo “note fatte
bene, a tempo e intonate”, ma pretendeva che ci fosse
una forte dose di “sentimento” in quel che suonavo. E’
una richiesta abbastanza comune (e giusta) da parte degli
artisti, ma in questo caso ho sentito che qualcosa si è
davvero smosso nel mio animo». E se quello di Bologna
Violenta è un punto di vista atipico sulla modernità in
necrosi, quello di Nicola Manzan lo è sull'indipendenza
nostrana in continua ricerca di sbocchi: «Mi sono fatto
l’idea che in Italia ci siano molte realtà che funzionano
bene, dei gruppi molto validi, delle etichette che lavorano tanto, ma spesso quello che manca è una visione
realistica di come stanno le cose, ovvero che non ci sono
soldi, che non si può mirare esclusivamente al successo (anche se pochi hanno il coraggio di ammettere che
puntano a quello), che spesso le cose più semplici sono
le più efficaci, e che le idee che vengono dal cuore sono
più importanti delle idee dei produttori o dei manager».
Punto di vista frutto di tante esperienze, e quindi inevitabile. Sperando che non sia questo il soggetto del prossimo necrologio.
Luca Barachetti
9
Turn On
Datashock
—Intemperanze
sciamaniche—
La risposta europea al sottobosco
dronico californiano
T
edesca, vieppiù francese, Saarlouis, tristemente nota
per le contese che succedettero alla grande guerra,
è una cittadina che di gente insolita ne ha ospitata: Bill
Kouligas dei Family Battle Snake, Britney Gould dei
Caldera Lakes, Lucas Crane dei Time Life e Wooden wand & the Vanishing Voice, Black to Comm...
Tutti a pellegrinare dentro e fuori il quartier-generale
di un oscuro collettivo di droners (o freak psichedelici)
chiamato Datashock, improvvisatori più o meno involontari i cui vestiti potranno anche ricordare il sottobosco americano (Skaters, Emeralds, Pocahaunted)
ma siamo lontani da quelle spiagge. Per Datashock piut10
tosto il primo paragone (e discrimine) è la terra, anzi,
il carbone. Il sottosuolo minerario è il perfetto setting
per una risposta black al blue statunitense: suoni che si
dipanano in dedali mentali, stratificazioni vocali su griglie
multidimensionali, circuit-bent e surfate scurissime da saletta B-Movie, orbite accanto a buchi neri.
Punto fermo in uno stream prodotto da macchine
analogiche e strumenti scordati sembra essere l'artigianato attorno a lavori che, da sempre, vanno letteralmente a ruba. "La R è la mia lettera preferita. Il cd-R ci permette
di dare un nome ad un disco e dipingerlo direttamente; il CD
dargli un nome e firmare un contratto ma preferiamo i vinili
e le cassette. Le etichette ideali sono quelle gestite con amore
che rispondono alle mail molto velocemente. Ai Datashock
piace bere birra, mangiare cibo gratuito; siamo sempre nervosi prima dei live set così beviamo di più. E' pura beatitudine
quando la nostra ballerina si schianta sul palco nei picchi dei
nostri set".
Pascal Hector, membro attivo dal 2004 e portavoce
della band, nei set dei tedeschi è l'unico punto fermo di
un crocevia chimico fatto dei fragorosi shock acusmatici di Acidulle o delle temperie sacrali del più solare
di Unitled Symbol, un portale quest'ultimo di fragranze
smeraldo, arabeschi invernali e cianfrusaglierie meccani-
che. "Ogni suono dovrebbe avere un rumore ed ogni rumore
un suono dentro. Non c'è differenza. La similitudine tra questi
due mondi mi viene spesso in treno o quando sento gli echin
ella doccia. Ci piacciono le urla della gente o i droni delle
macchine nelle strade innevate, Fleetwood mac, Funkadelic,
Talk talk, Eddie Murphy, i Jesus & Mary Chain".
Nella carrellata iniziale citavamo, Black to Comm,
ovvero Marc Richter. Richter utilizza software per rendere sarcastici ed innaturali i propri suoni, i Datashock
invece possiedono quel piglio manifatturiero da bottega
alchemica. L'accostamento non sarà immediato, eppure
le due realtà dialogano divinamente: hanno prodotto un
disco assieme su Ikuissus e Alphabet 1968 del primo
sembra un'elaborazione compressa (e in versione digitale) di un set dei secondi.
Tra le altre collaborazioni da segnalare c'è sicuramente il sorprendente incontro tra il collettivo, Aidan
Baker e Leah Buckareff (ovvero i Nadja) nel 12" su
Meudiademorte. 93 copie hand made dove la messinscena sufi, l'iterazione ripetitiva e la carica nervosa spingono
su versanti di cui di drone c'è pochissimo. Basta prendere
un disco a caso, Rambo Wikinger, per capire quanto i
Datashock siano distanti dalle modalità dei Sunn O))).
E' forest-drone: una via non troppo dissimile da un ipotetico incontro tra Svarte Greiner, le musiche di INLAND EMPIRE e gruppi della scena finlandese quali ES
o Kemialliset Ystävät. Ritualismo ed ancora ritualismo,
musica macabra (o per funerali), musica comunque intesa
come allucinazione timbrica, lugubre e densa di colori,
oceani, deliri. "La foresta spaventa al buio ma è fantastica
da percorrere in estate, vorrei saperne di più su come trovare
i funghi allucinogeni. Mi eccitò osservare una volpe morta
nella foresta". Da queste parti gli strumenti non contano,
conta la coralità psicoacustica: "Usiamo alcune loopstations, pedali, anche cheap, poiché non abbiamo denaro. Non
sono comparabili con l'Apollo della Nasa ma ci permettono di
andare sullo spazio lo stesso!".
E' come una processione laico-liturgica, la loro musica massimalista, spregiudicata e libera come nelle due
traccie di Pox ice cream, una piccola istantanea che cattura quel rito sciamanico e soprannaturale che sono i
Datashock.
Salvatore Borrelli
11
P
Tune-In
Dâm-Funk
—I've been standing strong for
the FUNK all along—
Il debutto del guru boogie-funk è un disco visionario e dissennato. Ce lo siamo fatti
raccontare dall'uomo... via Facebook.
Testo: Gabriele Marino
12
er Damon Riddick il 2009 è stato un anno importante: quello del debutto solista sulla lunga
distanza e di flirt veloci - ma assai significativi
- con due dei nomi "giusti". Debutto sulla lunghissima distanza, un progetto esagerato, un album composto da
cinque dodici pollici, usciti prima come release digitali (a
partire da luglio) e poi fisicamente riversati su doppio cd
(a novembre) e quintuplo vinile in cofanetto (da gennaio
2010; prezzo per soli collezionisti, 50 bigliettoni). Collaborazioni che lo hanno proposto coolissimo outsider della scena indie (il remix di Summertime Clothes per i "veterani" Animal Collective) e di quella elettronica (la
co-produzione di Tell Me What You Want From Me sul primo long della nuova sensazione Hudson Mohawke).
Già da qualche anno però la musica di Dam - da sempre
accasato alla Stones Throw del funkfreak Peanut Butter
Wolf, e dove sennò - si è inserita nel filone delle musiche
post-hiphop più interessanti dei Duemila (e si veda la sua
Kill Dat nel megamixone preparato da 2tall e compagni):
mosca bianca tra le musiche ritmiche d'oggi, e orgogliosa
di questa alterità, priva com'è di campioni e rigorosamente analogica (tutta synth e drum machine, zero laptop). Segnali tecnici questi di un'estetica radicale e rigorosa, assai
lontana dal meticciato post-moderno in cui ci troviamo
immersi, e che possiamo benissimo etichettare - fuori dal
semplice gioco di parole - come "modernariato modernista". Un'estetica tanto preziosa quanto fragile.
Il primo volume del progetto Toeachizown, LAtrik, lo
avevamo accolto per quello che era: l'esaltante esposizione
di una visione più unica che rara, la (ri)scoperta di un suono
primitivamente futurista (nel senso in cui questo ossimoro
è applicabile alla prima techno detroitiana). Rimandiamo alla
rece di quel primo mini per inquadrare musicalmente le
coordinate della "cosa" Dam-Funk in tutto il suo splendore. Le successive uscite ci hanno tutte deluso, quali più (il
buco nero di ripetitività del quarto, Hood), quali meno (le
gemme sparse tra secondo, terzo e quinto volume, Fly, Life
e Sky rispettivamente).Vogliamo fare le pulci a Dam perché
la sua è una musica veramente aliena, e che merita attenzione, capace di regalare - a chi ha le orecchie per sentirla e
ascoltarla - momenti di goduria puri come diamanti grezzi.
Lui però non deve perdersi (più...) in un bicchiere d'acqua,
non deve disperdere la freschezza della formula, non deve
banalizzare la propria visione.
L'estrema rigidità produttiva e compositiva - autoimposta - del boogie-funk così inteso (leggi anche: l'autismo-nerdismo old skool del signor Riddick) deve essere
accompagnata da ispirazione melodica e gestione controllatissima delle stutture, ma questo è avvenuto soltanto per
un pugno di tracce (magiche, con un grip al quale non si
sfugge), mentre nelle tante altre l'uomo ha pensato bene
di stendere tappeti sonori per i suoi sdilinquimenti synth,
slow-trax per club rallentati da alcol e ganja.
Del resto è vero anche che la musica di Dam non è
per tutti: bisogna "starci dentro" per apprezzarne il tiro.
E' un trip, ma i trip, per quanto belli, intensi o particolari
possano essere, è bene che durino per un tempo limitato. Fuor di metafora, speriamo che Dam sforni dischi
su dischi, esplorando ancora questo suono tutto suo, ma
speriamo anche che lui abbia la lucidità di prendersi tutto il tempo necessario per confezionarli e cesellarli a
dovere: che abbassi il livello di megalomania insomma.
Il rischio, altrimenti, è quello di sprecare un talento per
certi versi unico, animato dalla passione bruciante - da
vero invasato - di chi vive con un unico scopo al mondo:
il funk. Non glielo perdoneremmo.
L' intervista ...
via
Facebook
Sul più celebre dei social network, Dam-Funk non ha solo
una fan page dedicata, ma anche la propria pagina personale,
da "comune mortale". Lo abbiamo "aggiunto", spiegandogli
che anche in Sicilia conosciamo e apprezziamo il suo suono,
e lui ci ha "accettato".Volevamo approfittarne e così l'abbiamo subito buttata sull'intervista veloce via chat. Nessuna risposta. Gli abbiamo inviato allora una manciata di domande,
così per rompere il ghiaccio (e forse rompendo non solo
quello...). Avevamo provato a contattare altri artisti ST in
passato, venendo sempre sistematicamente "rassicurati" sul
fatto che non ci sarebbe stato troppo da attendere per le
risposte, semplicemente perché non sarebbero mai arrivate:
«gli artisti non rilasciano interviste» (tutti come influenzati
dal morbo Madlib-iano). Il nostro gesto insomma era tutto fuorché animato da una qualche speranza concreta. Ma
passano due settimane e ci vediamo costretti a ringraziare
l'effetto anti-by-pass facebookiano per un feedback davvero
inaspettato, noi comunque - già di nostro - perfettamente
"integrati", e adesso più che mai. Ecco allora la nostra intervista all'uomo via Effe-bì.
La tua è una musica profondamente notturna,
soundtrack perfetta per un club nello spazio a
metà strada tra passato e futuro black. E' orgogliosamente fuori dal mucchio, radicale, appassionata. E ascoltandola si è subito in grado di dire
"Questo è Dam". Merito del tuo suono, di una
elettronica analogica figlia degli anni Ottanta.
Non pensi però che questo stile tanto particolare (solo synth e drum machine) possa un giorno
risultare inadeguato, limitante?
Grazie per la descrizione che fai della mia musica. Per
quanto riguarda la domanda... No, non credo che le mie
siano scelte limitanti, semplicemente perché sono anni
che le porto avanti. Il mondo ha cominciato solo adesso
13
a conoscere il mio suono, ma è un suono che è nato a
Pasadena (California) quando ero ancora un ragazzino.
Non è una questione di "moda", come per tanti altri tizi
saltati sul carrozzone di questi tempi. E' tutta la vita che
io porto avanti il FUNK. Non è una moda per me: lo
è per i tanti produttori che lo stanno scoprendo solo
adesso e che, "probabilmente", scopriranno qualcos'altro
di qui a un paio d'anni. Questo suono per me è vero e
reale, e lo sarà sempre.
Com'è stare nella crew Stones Throw? Peanut
Butter Wolf ama alla follia il tuo stile nu-funkOttanta...
E' un vero piacere e un onore. PBW è il motivo
principale per cui ho deciso di unirmi alla
ST. Io e lui siamo prima di ogni altra
cosa due amici e due maniaci del
vinile. Lui ha sempre condiviso con me questa "visione".
E io apprezzo davvero tanto quello che sta facendo
per il funk in questi tempi
di grande creatività musicale.
Dimmi i tuoi cinque
dischi da isola deserta.
Così su due piedi, direi:
Prince - 17 Days; Slave con
Steve Arrington - Just a Touch
of Love; Todd Rundgren - Hideaway; Junie Morrison - Super Spirit;
Prefab Sprout - Bearpark.
Che roba metti nei tuoi dj-set? "Merda
funk" Ottanta? Remixi o editi mai live?
Mi piace condividere con gli altri rarità Boogie-Funk, di
quelle che spaccano, di quelle che oggi come oggi non
ti capiterà mai di sentire in un club o a un party. Non
remixo né edito live, ogni tanto mi metto a cantare sulle
strumentali di certi pezzi, se sono nel giusto mood. Nessun trick né altre merdate. Quello che mi interessa è
fare decollare la festa. Non mi interessa altro.
Che artisti ti piacciono oggi? Gente come i Sa-Ra
ti interessa?
I Sa-Ra sono fighi, ma io adesso sono completamente
buttato su cose come: Nite Jewel, FunkinEven, Theo Parrish, SFV Acid, Nicky B (aka Nibby), GOSUB, Hawthorne
Headhunters (con I Ced, Proh Mic, Black Spade & Coultrain), JimiJames, RED, e tutti quei suoni nuovi e progressivi che cercano di mantenere intatto il senso del Funk.
Puoi dirmi qualcosa del tuo feat su Butter di Hudson Mohawke?
E' stato divertente. Mi piace lavorare con alcune di que14
ste "giovani leve". Auguro tutto il bene del mondo a
quanti riescono a diventare "dei nomi" semplicemente
decidendo di condividere la loro creatività col resto del
mondo.
Il tuo è un debutto esagerato per dimensioni e
ambizione. Quando hai avuto chiaro in mente il
concept che ci sta dietro? Quando hai finito i pezzi? Come hai lavorato? E adesso, che farai?
Per realizzare Toeachizown ci sono voluti quasi due anni
di lavoro. Ne sono molto orgoglioso. E' proprio il tipo
di disco che io e i miei amici - con cui sono cresciuto
nella zona ovest di Pasadena - volevamo sentire quando
andavamo in giro. Ecco, io l'ho fatto questo disco, per la
gioia di tutti. Spero che col passare del tempo (degli anni, se necessario), anche il
resto del mondo riesca a "entrarci dentro". Il disco è così com'è
perché io l'ho voluto così:
pezzi lunghi, strumentali,
voci strafatte, canzoni vere
e proprie sparse qui e lì,
strumenti analogici, canzoni suonate tutte d'un fiato
e non semplicemente tagliate, ricucite, campionate,
rivoltate. Non è neppure un
disco "retrò": io non faccio
roba retrò, altri artisti fanno
retrò! La mia è una continuazione dello stile funk che si è estinto
precocemente a causa dell'emersione e
del dominio dell'hip-hop, pompato dalle major, dagli Ottanta fino ad oggi. E' un disco che cerca di
colmare la distanza tra vecchio e nuovo, e spero che se
ne accorgano tutti.
Il mio prossimo progetto è un album che ST pubblicherà
col titolo di Adolescent Funk, sarà una raccolta di registrazioni casalinghe realizzate su musicassetta quando ero
un ragazzo. Wolf ha sentito alcune di queste cose, nastri
che io avevo chiuso dentro vecchie scatole di scarpe,
ma che mi ero sempre portato appresso nei miei spostamenti nei dintorni di L.A., e ha deciso che le avrebbe
pubblicate. Perché no, ho detto io! Inoltre ci sono nuove
collaborazioni con Nite Jewel (il progetto si chiamerà
Nite-Funk) e la produzione del nuovo EP di Steve Arrington (degli Slave), che uscirà sempre su ST nel 2010.
Il 2009 è stato un anno molto positivo per la mia musica,
per il Modern-Funk, e in generale per tutte le musiche
funk-based. Non vedo l'ora che cominci questo 2010,
sperando che sia un buon anno di musica per tutti noi.
Tune-In —Pop Fields Forever
Field music
Il segreto del pop è entrare in testa e restarci il più a lungo possibile fresco e arguto.
Dall’Inghilterra , i fratelli Brewis offrono un personale contributo alla causa
Testo: Giancarlo Turra
U
na volta, prima del crossover
culturale spinto e della globalizzazione, eravamo sicuri dell’esistenza di un retaggio sonoro. Una tradizione
storica che grossomodo i gruppi seguivano
da questa e da quella parte dell’Atlantico.
Qualcosa di più sottile della contrapposizione ottusa - assai diffusa in Italia... - tra
britannici e americani, tra rock e pop, sostanza e apparenza. Non che vi fossero anche queste componenti in gioco, beninteso,
solo che ci è sempre parso un modo riduttivo e semplicistico di sistemare la faccenda. Il retaggio, allora, finiva per diventare un
appoggiarsi a dei modelli perché da qualche
parte si deve pur trovare un punto di partenza. Così siamo caduti un pò tutti, prima
o poi, nello stereotipo in base al quale in
Inghilterra c’è la cultura del pop e della canzone come comunicatore sociale; dall’altra
parte dell’Oceano, invece, trovi solidità delle radici e concretezza, chi il rock and roll lo
ha inventato partendo da blues e country.
Fin qui tutto bene, non fosse che i Beatles si nutrivano a Stax e Motown, a Buddy Holly e cabaret. E quello amalgamarono
in qualcosa di unico che s’è fatto a sua vol15
ta esemplare. La casistica è infinita, anche sulla direttrice inversa: evidente l’influenza dell’ugola dandy droide
di Bryan Ferry su David Byrne e Tom Verlaine; i
Byrds elettrificarono il folk in tutta risposta all’invasione del beat britannico… Potremmo andare avanti all’infinito nel mostrare che la musica rock più significativa
s’è sviluppata reagendo a qualcosa di precedente o già
esistente, nondimeno tenendone conto. Nei Fall senti il
garage-punk e il kraut-rock, laddove certi titoli escogitati
da Mark E. Smith paiono uscire da un LP dei Van Der
Graaf Generator. In questo eterno presente caotico e
senza più riferimenti precisi, poi, le cose sono ancor più
confuse e i cinque decenni di storia sonora a disposizione si affastellano nella mente di chi compone canzoni.
Tra un clone dei Talking Heads e uno dei Gang Of
Four, talvolta salta fuori anche qualcosa di significativo, che attrae l’attenzione senza mezzucci e che resta
nell’aria per più di un ascolto di prammatica. Gente che i
clichè li straccia e ricompone, gente come i Field Music,
capaci di far coabitare - con arguzia e abiti spesso sottratti a un Andy Partridge meno astioso - strutture di
stampo “progressivo” con una melodia dritta al punto e
compatta. In una scena come quella albionica, più di altre
legata alla “sensazione del momento”, i fratelli Brewis vivono da amabili mosche bianche: “Il nostro primo amore
musicale furono i Led Zeppelin, ma mentre crescevo mi rendevo conto che mi vergognavo di ciò che mi piaceva. C’erano
elementi che criticavo, come l’autoindulgenza e il sessismo,
tuttavia sarebbe stato un errore ignorarne i pregi. Quando
cominciai a scrivere in me c’era la convinzione di oppormi
alla mitologia rock, ai suoi clichè. Anche se, a dirla tutta, mi
piacciono i luoghi comuni: se li inserisci in un contest differente possono essere una gran cosa. Gruppi come i Roxy Music
li hanno trasformati in qualcos’altro”.
Idee chiare, ancor più se si pensa a una vicenda breve
ma ricca e eloquente di questi ragazzi poco pretenziosi. Ben più che il solito rock emulativo di fattura anche
buona, il loro. Una forma inquadrabile ma pure sfuggente
quanto più è personale, e non sono queste forse prerogative da grande gruppo? E’ in provincia, a Sunderland,
che la faccenda inizia, dentro al cuore di un centro medio come fu la Swindon che tenne in incubazione giustappunto gli XTC. Non si tratta di un caso fortuito,
semmai dell’effetto benefico di uno sguardo colmo di
sardonica rivalsa e distacco creativo, che osserva le
mode dall’esterno e le interpreta. Lì, nel 2004, il progetto prende corpo attorno a David e Peter Brewis - al
tempo anche nei valenti compaesani Futureheads - e
Andrew Moore, tastierista elegante quanto misurato.
Un paio di singoli fungono da antipasto al disco d’esordio pubblicato nell’agosto dell’anno seguente, ovvero in
16
piena “nuova wave” parte terza, dalla quale si prendono
le distanze per guardare più in là.
In Field Music (Memphis Industries; 7,4/10) respiri l’aria delle grandi altezze, dell’orizzonte prog che ha
spezzato le gambe ai più e ne esce indenne. Sapienza di
scegliere i giusti referenti, ovvero più Canterbury che
Genesis o Gentle Giant; un “minimalismo complesso” che consente di rimanere indenni al tempo invece
d’incrinarsi per le troppe rughe. Composizioni deliziose come la brevissima Shorter Shorter (direbbe il suo in
Skylarking…) e l’articolata If Only The Moon Were Up
(nervosismi al te delle cinque), il valzer qui svolazzante
e là fratturato Luck is A Fine Thing e la soffice It’s Not The
Only Way To Feel Happy brillano e attraversano i decenni
a volo radente per comprenderne il significato. E’ music
hall kinksiano attraverso la lente grigio fumo di Drums
And Wires, corde secche e una pronuncia leggermente
e fieramente “local”, una ritmica impastata che disturba
ugole e arrangiamenti angelici (Tell Me Keep Me); sono le
memorie Steely Dan nel cassetto del giovane Paddy
MacAloon ma senza eccessi di saccarosio (Pieces). Un
gioco eccitante di contropiedi e mistificazione, nel quale
fai bene a non distrarti, metti che ti perdi qualcosa di
importante come un jazz bucolico (Got To Get The Nerve)
o un’armonia magistrale (Like When You Meet Someone
Else).
Manna che fa il paio con la raccolta di lati B e outtakes Write Your Own History (Memphis Industries,
2006; 7,0/10), tuttavia il progresso si chiama Tones Of
Town (Memphis Industries, 2007; 7,8/10), una dozzina di
mattoni lego assemblati con perizia ancor più pronunciata e dove sparisce il poco fiatone notato al debutto.
Incastri strumentali di rara perfezione e un piglio più aggressivo (Give It Lose It Take It: Joe Jackson in gita nei ’70;
Working To Work: la cartolina spedita al ritorno), singoli
perfetti in un mondo parallelo (A House Is Not A Home)
e aperture magiche per grazia e sorpresa (In Context, Sit
Tight). Il brano omonimo ancheggia e sferza e Kingston
ferma l’orologio a centoquindici secondi d’incanto; Place
Yourself è il pezzo che Colin Moulding e Ray Davies
non caveranno più dal cilindro, A Gap Has Appeared gestisce una sensazionale sfoglia di melanconica innodia col
polso dei consumati songwriters. Splendore che preannunciava l’ascesa all’olimpo degli ascoltatori più avveduti
- troppo sottili per le "masse indie", i ragazzi... - e invece la formazione si trovava sull’orlo dello scioglimento.
In un’intervista alla BBC dell’aprile 2007 dichiarano di
volersi dividere una volta completati gli impegni promozionali, tra l’altro rifiutando (saggiamente) un tour di
supporto ai populisti Snow Patrol. La frase era nondimeno sibillina: “In sostanza ci va di fare cose che non sono
classificabili come 'il gruppo indie Field Music'. Per un po’ non
saremo una band, ma non ci fermiamo perché, con un conto
in banca intestato con quel nominativo, andremo avanti come
una società. E’ ora di andare a fare un po’ di lavoro vero”.
Viene subito in mente la concezione lydoniana, i PiL
azienda e non complesso pop: questo è un agire consapevolmente al di là delle barriere. L’ipotesi di una separazione rientra in tutta fretta a favore della provvidenziale pausa di riflessione; quella che nel rapporto solido
riporta la voglia di stare assieme e in quello traballante
rappresenta l’ultima goccia. David Brewis pubblica Sea
From Shore (Memphis Industries, 2008; 6,7/10) con
l'alias School of Language e il fratellino replica tramite
il progetto The Week That Was (Memphis Industries,
2008; 6,5/10), entrambe diversificazioni del prodotto che,
nel discreto risultato complessivo, non esaltano né offrono epifanie circa la chimica interna ai Field Music. Avranno valore in retrospettiva, raccontandosi ora d’aria utile
a un ensemble sovraccarico di riguadagnare il sorriso:
“L’intervallo ci ha dato tempo di capire cosa volevamo fare e
il modo migliore per farlo. Volevamo una chance lontana dai
Field Music e dalle attese che avevano creato, non volevamo
allontanarci l’uno dall’altro. Eravamo al punto dove avremmo
potuto aumentare il nostro successo: c’erano attese e pressioni, perciò ci ha fatto bene distanziarci e ripensare la band.
Tornare per fare ciò che davvero volevamo”.
Disastro scappato con orgoglio e chiarezza di vedute,
per una volta nessuno schianto nel passaggio dall’indipendenza al livello superiore. Anzi, il passaggio non c'è
proprio e così si porta a casa intatta la pelle. cora che
permette di spazzare via le nuvole grigie con stile, affidato ai venti brani del corposo Measure. Qualcosa che,
per comodità ma azzeccandoci, etichetti come il loro
English Settlement per la mescolanza tra acustico ed
elettrico, la varietà di atmosfere e una riconoscibilità autoriale che non viene mai meno. Andatosene Moore, i
Brewis reagiscono con maturità, spostando l’asse sugli
intrecci di chitarre (persino del fraseggiare blues, seppur
alterato) e intarsiando con archi lievi e qualche tastiera un suono trasversale. Atemporale, anche, e generato
da un’eccitazione programmatica salda eppure mai prevaricatrice: “Desideravamo ridefinire l’album doppio come
qualcosa di molto vario. Abbiamo preso in considerazione le
maniere per uscire dalle restrizioni, e la via migliore era fare
qualcosa di voluminoso. Gli altri dischi posseggono la coerenza e le preoccupazioni di quando scrivi canzoni a stretto
contatto; con Measure, invece, ci siamo sentiti più liberi e
credo che si avverta”. Una bolla pop a lento rilascio, i Field
Music, in cui scorgi il riassunto degli “anni zero”: ironia
e passione, intelligenza e critica, distacco e certezze. C’è
tutto quello che occorre per iniziare un nuovo decennio,
casomai non lo si fosse capito.
17
Barn Owl
—Waste Lands
Drop Out
Jon Porras e Evan Caminiti, gli
ultimi sopravvisuti nelle terre
desolate d'America. Musiche per la
fine dei tempi.
Testo: Antonello Comunale
C
e lo stanno dicendo in tanti, da Cormac McCarthy a Roland
Emmerich. L’apocalisse è dietro l’angolo e se state aspettando
il 2012 per sincronizzarvi con la fine di tutte le cose, bisogna
non farsi cogliere impreparati e avere la presenza di mettere sul
piatto la soundtrack giusta. I Barn Owl sono la palestra perfetta per stirare
i tendini delle ansie e delle paure più arcane. Il sound ideale per mettere in
scena il teatrino trascendentale con l’umanità al posto delle marionette, li
dove diventiamo tutti leggenda in mezzo al caos e il videogame post-Richard
Matheson si rivela per il diletto metafisico che è sempre stato. I Barn Owl
in tutto questo ci sguazzano come due teenager vergini in un sexy-shop di
Amsterdam. “Da che ho memoria ho sempre avuto un serie ricorrente di sogni (incubi?) apocalittici che mi hanno fatto compagnia divenendo una parte molto intima
di me”, mi dice Evan Caminiti, in un misto tra il serio e il faceto che fa bene al
cuore. Al giorno d’oggi c’è una tale quantità di musica da “fine dei tempi” che
nemmeno ci si fa più attenzione. Ci stiamo vaccinando giorno dopo giorno
e arriveremo puntuali all’appuntamento con un’idea già ben chiara in testa di
18
19
di andare dietro al tipo di suono che potrebbe evocare una certa immagine o un determinato umore. Quando capita cosi
vado avanti per ore e ore incessantemente. Poi certo, quando componiamo una piece dei Barn Owl abbiamo un buon livello
di improvvisazione da cui tracciamo le linee principali”. Jon la spiega in maniera più asciutta, del resto lui è il recluso della
situazione laddove Evan gioca un po’ la parte dell’uomo deputato alle pubbliche relazioni: “Non c’è una regola precisa.
Alcune idee nascono così buone che tutto viene creato in maniera quasi automatica, altre volte ci giriamo talmente tanto
attorno che riusciamo a quadrare solo dopo molto tempo. Penso che la cosa principale nel nostro modo di produrre musica
stia nel fatto che due menti diverse si coalizzano, o per meglio dire, entrano in connessione per raggiungere un unico obiettivo.
Questa è la chiave dei Barn Owl”.
L’alchimia tra i due è fondamentale, come del resto avviene in tutte le formazioni a forte grado di democrazia tra
le parti, per cui ad un certo punto uno influenza l’altro e viceversa, in un costante processo di scambio e ricerca. “Ci
siamo sempre influenzati a vicenda, scambiandoci musica, idee e opinioni. La cosa divertente è vedere come siamo poi passati
attraverso diverse fasi. Ricordo un periodo in cui ero molto dentro al vecchio blues e ascoltavo e riascoltavo incessantemente
gli album di Mississippi John Hurt, mentre poi l’anno seguente mi sono interessato molto al black metal andando alla ricerca
del materiale più strano che potessi trovare. E in tutto questo pellegrinaggio cultural-musicale, abbiamo sempre continuato a
suonare e a desiderare sempre lo stesso sound, sempre alla stessa maniera, entrambi”. Ma a questo punto com’è il suono
dei Barn Owl?
D alle
cosa sia la fine. Quando erano gli anni
’90, potevi star li a notare come NIN
e derivati giocassero con l’estremo
e lo portassero nel mondo svuotato
e plastificato della musica popolare,
perché altrimenti ti toccava scendere negli antri metal e venire a patti
con la solita sequela di satanismi da
fumetto, che non spostano più nemmeno un capello, al punto che il vecchio Eddie degli Iron Maiden ormai
lo fanno in serie, come bambolotto
della notte per i bimbi del nuovo millennio. I Barn Owl tutto questo lo
sanno. Si muovono sul solco tracciato da Dylan Carlson andando alla
ricerca dell’om perfetto, quello che
evocherà i quattro cavalieri e finalmente la faremo finita. Paragonati agli
altri grandi doom-droners di questi
anni, i Sunn O))), il duo di San Francisco ne esce fuori a testa più che
alta. Porras e Caminiti si dedicano
alla sceneggiatura laddove O’Malley
e soci, con il passare del tempo, si
sono concentrati sempre di più sulla
scenografia.
Evan Caminiti è un ragazzotto
della Bay Area dal fascino sui generis,
cresciuto a pane e metal che si trova
ad un certo punto a frequentare la
20
classe di American Indian Science alla
San Francisco State University insieme ad un altro sbandato e sbarbato
geek di nome Jon Porras. Stesso profilo e visione d’insieme: sguardo perso, capello lungo, barba incolta, quattro stracci addosso messi su giusto
per un primordiale senso del pudore,
una comune passione per i Sabbath
e il metal in generale. Due nerd in
piena regola, che a vederli da lontano
li si potrebbe scambiare persino per
fratelli, un equivoco in cui spesso si
cade come sentenzia lo stesso Evan:
“Ci incontrammo in una classe mentre
frequentavamo l’Università a San Francisco, subito dopo esserci trasferiti qui.
Cominciammo a collaborare in maniera
quasi istintiva perché le nostre idee semplicemente collimavano alla perfezione.
Anche da un punto di vista estetico, con
i capelli lunghi e tutto il resto ci trovammo in sintonia al punto che spesso la
gente vedendoci insieme ci scambiava
per fratelli”.
Il passo dalla pacca sulle spalle alla
costituzione dei Barn Owl in entità
musicale effettiva è breve. Ai tempi del college entrambi militavano
in metal bands senza arte né parte,
ma in qualche modo questo comune idioma delle origini ha codificato
un certo umore nella musica dei due:
“L’approccio metal all’inizio è stato importante per prendere confidenza con
il lato tecnico della musica. Sai com’è,
con tutto quell’attenzione che in genere si pone sulle scale e quant’altro. Poi
abbiamo in qualche modo lasciato tutto
alle spalle quando abbiamo preso confidenza con noi stessi e tra di noi si è creato come un linguaggio istintivo. Il fatto
che adorassimo Black Sabbath e Earth
è stata come una sorta di collante da
cui si è generato tutto il resto”. E qui sta
il punto. Come compone musica una
band che ora come ora si colloca nel
miglior solco del drone revival anni
2000?
Non tutto nasce dall’improvvisazione come ci spiega Evan “Hmmm,
beh, è abbastanza difficile da spiegare.
Un certo tipo di suono comincia a ronzarmi in testa come fosse un’idea che
nasce dal nulla, ma altre volte posso
strimpellare la chitarra per ore, mettendo insieme pezzo su pezzo gradualmente. Spesso comincio a suonare cercando
nostre bocche una luce infinita
I due esordiscono nel 2007 sull’etichetta di cdr Foxglove, dalla quale poi Brad Rose erigerà la Digitalis Industries.
Disco di debutto, senza titolo, limitato a 100 copie, zero liner notes. Tutto secondo i dettami non scritti della weird
culture anni 2000. A farla da padrone è la tradizione americana, nella fattispecie del vecchio blues scarnificato e elettrificato dei 12 minuti di The Buffalo Queen: fingerpicking febbrile ma non iper-tecnico, distorsione intesa come fondale
desolato, finale epico dove si arriva a lambire la solistica metal, per poi virare tutto in un drone apocalittico.
Tutto quello che c’è da sapere sulle diverse gradazioni che la musica dei Barn Owl può assumere, sta già tutto qui.
Il resto del disco infatti gioca di rimandi. C’è il blues delle origini che salta fuori dalle note di Red River Raag, il doom
western di Snow Swamp, il raga psichedelico su fingerpicking e ululati alla luna di The Twirling Tusks Of The Mouth Of
God. La faccenda è già sufficientemente chiara, se ne accorgono in pochi, ovviamente, ma non finisce l’anno che i due
mandano in stampa Bridge To The Clouds, prima per conto proprio poi per i tipi della Not Not Fun. A tutti gli effetti
il secondo album, un vero e proprio sequel dell’omonimo. Un altro parto post blues, dove il mito americano viene riletto in un misto tra devozione e rivolta. Diamond Cloud è una ballata country a tutti gli effetti, ma calata in una tenebra
lo-fi che la scarnifica fino ai limiti, così come molto lo-fi è lo psych-blues di Absent Afternoon che avrebbe fatto la gioia
21
di Matt Valentine. Molto più alieno
per la musica dei due, il drone ambient di Golden Forest su cui la chitarra si innesta come corredo senza
prendere il sopravvento.
La svolta della maturità arriva
quindi nel 2008 con un disco tanto
denso e pesante quanto avvincente.
è il turno di From Our Mouths A
Perpetual Light che viene dato alle
stampe prima in vinile per Not Not
Fun e poi in comodo cd da Digitalis.
Un bel passo in avanti nella musica dei
due, che lasciano il solco blues in sottofondo portando in superficie tutto
il nerbo doom. Il disco della svolta
dei Barn Owl nasce nel nulla sulle
coordinate atemporali di Voice Of The
Other, congegno oscuro e opprimente, che cala subito un velo di tenebra
al suono di una distorsione che tende
fino allo spasimo le note, inscenando
un drone apocalittico come se ne
sentono pochi. La maestria dei due
qui si cimenta anche nella resa panoramica d’ambiente, con le wastelands di Lotus Cloud, The Stones Speak
Through The Fire, The White Mountain
Filled With Light. Passo claudicante e
malfermo, distorsioni sparse a mò di
pioggia acida che cala sul solco di una
Monument Valley perduta per sempre. Non mancano gli accenti psichedelici delle orientaleggianti frasi di
chitarra di Road To Bardo, Mouths Of
Light e Teonanacatl con zibaldone di
echi abissali tramutati in lunghissimi
Om tibetani che sembrano arrivare
direttamente dall’aldilà. L’apoteosi la
si raggiunge con la wilderness desolata di The Last Parade, esempio perfetto di apocalyptic rock evocato sulle
vestigia del vecchio classico suono
americano.
Da qui in avanti, Jon e Evan, giocano di fino limando la formula e
giovandosi di un fan base che ha ormai il suo nutrito numero di adepti.
L’immediatamente successivo Raft
Of Serpents, edito per Root Strata,
snocciola altrettanti corridori dro22
ner-doom da manuale: Eternal Tower è praticamente un'unica nota di chitarra,
rimodulata di continuo per mimare una passeggiata nel deserto più disperato,
da qui anche gli accenti twang del finale, con un Evan Caminiti sempre più
padrone del proprio linguaggio chitarristico. Non mancano i passaggi esotici
e spesso si va a collidere con certa trance californiana più dispersa (Savage
Republic, Red Temple Spirits, Drowning Pool). Nel frattempo i due si
tolgono anche lo sfizio di condividere uno split Lp con il veterano Tom
Carter, pubblicato nel 2008 da Blackest Rainbow, in cui non sfigurano affatto
e per una volta tanto suonano assai più eterei e meno abrasivi del maestro
texano.
è quindi il turno della consacrazione definitiva che avviene con il disco del
2009 su Root Strata, The Conjurer. Sorta di seguito non dichiarato di Hex
degli Earth, l’album si cala devotamente in un panorama desertico da anto-
logia del suono americano, al punto
che la chitarra non può che mimare
il taglio western di un twang da anfetamina, come sentenzia senza imbarazzo lo stesso Evan: “Quando stavo
scrivendo le parti di chitarra di The
Conjurer stavo fancendo un bel po’ di
riflessione sui deserti e gli spazi desolati,
i panorami vasti, e così ho pensato che
le immagini che avevo in testa sarebbero state veicolate meglio da un sound
western twang fuso con l’umore lento
e oppressivo del doom. è il suono del
vento attraverso le praterie, dei passi infinitamente lenti attraverso la sabbia…
è veramente una questione visiva per
me. Per altro, in termini di ispirazione
musicale ricordo che stavo ascoltando
molto Sandy Bull, Popol Vuh e i raga di
Pandit Pran Nath e Ali Akbar Khan. In
più il drumming sperso di Chad Collins
ha contribuito non poco a creare tutto
questo immaginario, perché di solito noi
suoniamo come un duo e l’aggiunta di
un terzo elemento ritmico ha cambiato
un bel po’ la nostra musica”.
Tutto chiaro. The Conjurer
è come la versione live dei Barn
Owl, impegnati nella creazione di
un viaggio narrativo-visivo, a mo’ di
soundtrack immaginaria. L’ispirazione dei due “è alquanto ovvia, perché
abbiamo una ossessione per il deserto.
C’è qualcosa in quello spazio, la sua vastità, il fatto di realizzare di essere così
piccoli nello schema dell’universo, che è
davvero intrigante e finanche spirituale.
In aggiunta, è così diverso dall’ambiente
cittadino in cui spendiamo la maggior
parte del tempo. è come un paradiso
salvifico, un deserto in cui puoi rifoggiarti nella tua mente, un posto che risuona
e dove la musica ti può portare senza
che il tuo corpo si muova”. Quanto alla
resa dal vivo del duo californiano,
un documento limitato a 250 copie
ed intitolato Transfiguration appare come bonus sfizio a corredo del
tour di metà anno, riproponendo un
concerto tenuto a Vancouver, l’anno
precedente. I due hanno così il primo
documento live a tutti gli effetti, in cui quello che prevale è il taglio distorto
della chitarra in un lunghissimo mantra di 21 minuti e passa. Il
deser to parla al tramonto
Evan e Jon, quasi da subito decidono di non limitarsi alla sola attività dei Barn
Owl. Due personalità così forti vanno quasi istintivamente alla ricerca di una
propria valvola di sfogo artistica, che funzioni senza la mediazione di nessuno.
Per quanto i due siano accomunati da un’unica visione condivisa, evidentemente, ogni tanto bisogna ritirarsi a coltivare il proprio orticello. Evan parte
subito con le proprie trasmissioni soliste, inizialmente con il moniker Ek Caminiti, e poi semplicemente con il proprio nome di battesimo. Buried Light
è il primo prodotto musicale in proprio, nel formato di cassetta limitata a
88 copie per Digitalis Limited. Un esperimento di drone ambient abbastanza
campato in aria. Il suo forte è la chitarra, infatti quando la imbraccia per arpeggiare sul secondo lato il discorso cambia.
L’esperimento ambient lascia il tempo che trova e Evan decide di prendere
di petto la questione solista con i due dischi del 2008. Digging Into The Void,
su Students Of Decay, che alterna alla perfezione fingerpicking esoterico e
rantoli blues in perenne distorsione doom. Un taglio alieno, ma descrittivo,
quello della sei corde di Evan, che non fa mistero di allinearsi alla tradizione
dei grandi maestri. “Negli ultimi mesi sto ascoltando molto Roy Montgomery. Se
parliamo di tecnica e di modo di suonare la chitarra, sono stato influenzato soprattutto da Neil Young e Keiji Haino. Anche John Fahey e Robert Fripp, in particolare le
collaborazioni con Brian Eno. Una grande parte di quello che influenza i miei dischi
solisti è ovviamente parte del suono dei Barn Owl, ma con l’ultimo disco, Psychic
Mud Shrine, ho messo molta più attenzione alla filigrana del suono. Due parole
che possono rendere bene quello che cercavo di ottenere con la mia musica sono
fatiscenza e luce”.
L’ultimo disco, edito da Digitalis, tra i suoi pregi vanta infatti un’inedita
attenzione per la profondità del suono. Un sound iper-distorto e stiracchiato
che richiama alla mente il disco solista di Alan Sparhawk o certe momenti
di Steven R. Smith. Quindi blues ridotti all’osso e deturpati da una distor-
23
sione che si sintonizza in direzione
dell’eternità.
Jon Porras, invece, decide di nascondersi dietro un moniker campestre per i suoi excursus solitari: Elm,
ovvero olmo. Se Evan è il visionario
della sei corde che traghetta il sound
dei Barn Owl verso i territori più
scuri ed opprimenti, Jon invece è il
trait d’union tra la tradizione blues
e l’estasi metafisica, con una marcata
propensione per la panoramica degli
spazi aperti. “Gli spazi vasti e aperti
sono una vera fonte di ispirazione. Una
buona porzione di Nemcatacoa è stata registrata appena siamo tornati da
un tour attraverso il southwest. è stata
un’esperienza che ha avuto un forte impatto su di me, è stata la prima volta
che ho guidato attraverso quella parte
del territorio americano e ho potuto
vedere direttamente tutto il panorama
che ha ispirato così tanto della romantica idea del west. Mentre guidavamo
attraverso il New Mexico su fino al
Nevada, potevo buttare un occhio alla
cartina e vedere che stavamo passando
posti chiamati come ‘Devil’s Playground’
‘Red Rock’ o ‘Black Plateau’ e questo mi
ha fatto pensare alle storie dimenticate
di quei posti e al perché avessero quei
nomi. Ma quando ci penso sono veramente ispirato anche dalla vastità delle
zone di costa. Guardare un mare infinito
in un giorno grigio può portare gli stessi sentimenti dello stare di fronte alle
aperte, aride pianure”.
La discografia di Elm diventa quindi una cartina al tornasole per l’estasi più romantica e dark, al punto che
lavori come Bxogonoas, Woven Into
Light e Nemcatacoa sarebbero la
colonna sonora perfetta per un qualunque quadro di Friedriech. Dalle
vertiginosi nebulose doom di brani
come Dawn Unveils The Golden Thread, Blackened Horizon, Trails Lined With
Turquoise And Silk, On Golden Wings
alle elegie più desolate e scure, come
Long Winter's Howl, Rising Smoke Woods, In the shadow of Red Rock, Elm
24
balla un’ultima danza sulle ceneri della cultura Americana, evocando spiriti
e demoni senza tempo. Bxogonoas ad
esempio è la parola usata dalla popolazione muisca della Colombia per
descrivere il mistero del tempo, mentre Nemcatacoa è una delle divinità
azteche della civiltà pre-colombiana.
E senza tempo è la qualità di una musica fatta con pochi mezzi: una chitarra, un quattro piste, due pedali e via
ad evocare l’infinito.
A corredo di un quadro già sufficientemente articolato, tra band madre e progetti solisti, per Jon e Evan si
innestano i progetti collaterali. Esperimenti estemporanei o veri e propri
progetti paralleli con pari dignità. Tra
questi ultimi sicuramente gli Higuma, ovvero Evan e la sua compagna
Lisa Mcgee. Un primo disco per Root
Strata, intitolato Haze Valley, che si
muove lungo le classiche coordinate
improvvisate, tra chitarre lisergiche e
ugole di sirena.Tutto abbastanza nella
norma, salvo il salto di qualità con il
nuovissimo Den Of Spirits edito in
questi giorni per Digitalis Vinyl, che
definisce a tal punto la formula da
rivaleggiare con i Barn Owl stessi.
Assai meno maturi sono poi i progetti denominati Hanging Thief e
Portraits, che sembrano più che altro un divertissement estemporaneo,
come in parte rivelano Evan e Jon
stessi: “Gli Hanging Thief sono saltati
fuori dopo una jam session spontanea
mentre stavamo con Brad e Eden Rose
a Tulsa. Una cosa del tutto analoga è accaduta per i Portraits, un progetto del
tipo ensemble, con Jefre e Maxwell di
Root Strata più un po’ di amici di San
Francisco. Quando dico ensemble, intendo proprio un grande ensemble. L’ultima volta che abbiamo suonato avevamo qualcosa come 43 archi sul palco
in mezzo a noi. Andremo in studio per
registrare un disco questo stesso mese”.
D roner - doom : L a F in A bsolue D u M onde
I Barn Owl eccellono in un territorio assai affollato di questi tempi. Senza mettersi a scomodare tutta la brigata più propriamente metal e il vecchio adagio “Doom Or Be Doomed” di Cathedral e soci, esiste una nutrita folla di formazioni che sul modello di Earth
2, provano a far coesistere musica eterna e riff sabbatthiani. Che ci sia tutto questo “doom”
e tutto questo “drone”, in gradazioni ovviamente variabili, nella musica degli anni 2000 è
fuori di dubbio, al punto che spesso viene il sospetto che sia anche troppo facile attaccare
la spina, buttare giù una nota sostenuta, rinvigorirla per ottenere l’effetto “bordone” con
qualche pro-tool ed ecco che le valanghe di cdr più o meno esoterici ci sommergono. Di
contro gli Earth di Dylan Carlson partiti con il nuovo corso di Hex sono fermi al passo
con un disco scialbo come The Bees Made Honey In The Lion's Skull.
Per rintracciare qualcosa di realmente valido in questo campo bisogna scomodare i tipi
di Not Not Fun, ovvero i Robedoor di Alex e Britt Brown, che sono partiti dal modello
“drone-horror” dei Double Leopards per poi rinvigorire il discorso con tutta un’estetica propria, a forte ascendenza metal, per lo meno in termini di immaginario estetico.
O ancora i Nadja di Aidan Baker e gli Jesu di Justin K. Broadrick, due formazioni che
assieme ai nipponici Boris rappresentano il momento più classicamente metal del nostro
discorso. Si tratta infatti di formazioni dal taglio metal tout cout che provano a muoversi
su coordinate laterali e quindi a lavorare di bordoni e drone music. Dei Sunn O))) si è
già detto e il discorso lo potremmo chiudere anche qui se non arrivassero i suoni europei
del doom-acustico made in Norvegia di Svarte Greiner e soci (Elegi, Xela, Anduin) che coniugano un certo gusto apocalittico con la tradizione classica, l’elettronica e le
soundtrack da film. Forse il parto più innovativo da molto tempo a questa parte nel settore
delle musiche horror, finito però presto con l’andare troppo dietro al modello originario
dei vecchi Current 93.
Xela partito dal glitch è arrivato ad una soluzione ibrida che mimava estetica horror
e elettronica vintage, salvo poi andare dietro ad un taglio ambient-drone sul modello di
Nurse With Wound un po’ troppo derivativo. Il suo è un esempio perfetto di come
spesso l’originalità stia nelle soluzioni meticcie e sporche, piuttosto che nei parti definitivi.
Discorso del tutto simile quello di Svarte Greiner e Elegi che però si sono mossi in
maniera più subdola, evitando di dare alle stampe documenti che suonassero propriamente risolutivi, in modo che con loro il discorso rimanga tutt’ora aperto a nuovi sviluppi.
L’americano Anduin, che si allinea al modello Type / Miasmah e viene per questo inserito
nel novero del suono europeo, gioca con l’elettronica inscenando corridoi noir nella vena
del Badalamenti più sospeso e tenebroso, da qui anche l’efficacia “di settore” dell’ultimo
Abandoned In Sleep.
I Barn Owl in tutto questo scenario sono gli unici che partiti dal blues delle origini
sono arrivati a lambire la musica eterna, con un afflato mistico visionario che è proprio dei
grandi. Il fatto che ancorino le loro escursioni alla fonte mitica del suono americano non
fa altro che aumentare l’efficacia d’insieme di una musica che si candida a rappresentare la
quintessenza di questi anni. A chiederglielo i due nerd nemmeno stanno a pensarci più di
tanto: “We just plug in and go for it” mi rispondono.
25
Lightspeed
champion
—Costruzioni in sincrono
Drop Out
Lightspeed Champion ritorna con
un album che spiazza. Ne abbiamo
parlato con lui, eclettico indie nerd
perfezionista, smontando una
contraddizione solo apparente su
cui avevamo voglia di indagare.
Testo: Teresa Greco
26
C
he cosa ha a che fare la costruzione
programmata fin nei minimi dettagli di
due album assai differenti l’uno dall’altro negli ultimi tre anni, con un indaffarato nerd inglese nero di 24 anni, dall’aria svagatissima e autoironica e dagli impossibili capelli afro?
La domanda sorge immediata riflettendo su questo
contrasto – solo apparente – che emerge ad una
prima analisi. Si parla naturalmente di Devonté
‘Dev’ Hynes e del suo progetto Lightspeed
Champion, balzato sulla bocca dell’indie pop più
chiacchierato all’inizio del 2008 con il folgorante
primo album Falling Off The Lavender Bridge e
che è fresco di pubblicazione del secondo, Life is
Sweet! Nice To Meet You, sempre su Domino.
La storia di Hynes, come ogni vicenda di un
certo peso che si rispetti, viene da più lontano, in
questo caso dalla Londra dei primi anni del nuovo millennio, dove troviamo tre amici d’infanzia
(Rory Attwell, Sam Mehran e Dev Hynes, quest’ultimo nato nel 1985 a Houston, Texas ma cresciuto in Inghilterra, nell’Essex) che si danno da fare
mettendo su compulsivamente una band dietro
27
l’altra, con le influenze più disparate, che vanno dall’indie pop rock alle
contaminazioni hip hop, crossover e punk, fino a formare nel 2004 i Test
Icicles, sorta di gruppo dance punk nurave subito messo sotto contratto
dall’accorta Domino; l’esordio For Screening Purposes Only, un album
abbastanza ben accolto in ambito indie, risale al 2005, sotto la produzione
di James Ford (Simian Mobile Disco). Solo pochi mesi dopo però, a inizi
2006, il gruppo splitta, con la motivazione, addotta dallo stesso Hynes nel
corso di un’intervista al NME di “non essere abbastanza interessati al tipo
di musica che stavano facendo”… frase che fa capire come la band fosse in
naturale evoluzione e che quello era solo uno step da diciottenni lungo un
percorso più articolato. E che fa anche intuire poi gli orizzonti dello stesso
Hynes, già avanti mentalmente rispetto al suo e all’altrui presente prossimo.
Infatti dopo brevi collaborazioni con l’amico Rory Attwell, Dev prende il
largo e da buon conoscitore dell’ambiente, comincia a mettere a frutto la
connection ancora aperta con la Domino.
Il Nostro allora all’alba del 2006 si ritrova più o meno da dove era partito,
a raccogliere i cocci della breve esperienza Test Icicles, mentre si dedica anima e corpo allo studio di un nuovo progetto. Afflitto da problemi intestinali e
intolleranze alimentari sin da quando aveva 13 anni (come da lui dichiarato)
quindi più o meno impossibilitato a bere e fare stravizi nei pub working class
dell’Essex nativo, non è difficile perciò immaginarlo nerd onnivoro e compulsivo della rete, con le mani in pasta in mille direzioni, quali in effetti era ed
è. I suoi orizzonti sono allora già ben oltre l’Albione indie pop e wave del
momento; come capita un po’ a tutti i genietti dotati, il suo range di influenze
è talmente eclettico da permettergli di spaziare ampiamente, come poi in
effetti succederà, ben oltre quel panorama ristretto dell’indie. Da una parte
troviamo i consueti studi classici dell’infanzia (nel suo caso piano, violoncello
e basso), poi i disparati interessi da adolescente ribelle tutto chitarre e percussioni, associati al nerdismo di cui sopra, e a una passione per i fumetti (che
disegna) e la scrittura, il tutto contribuisce a formarne un quadro sfaccettato
e poliedrico. Così capita che insospettati altri interessi lo riportino alla terra
di nascita, vale a dire gli Stati Uniti.
Si trasferisce infatti armi e bagagli a New York con l’intenzione di perfezionare il famoso progetto a cui sta pensando. Qui si rivela un’altra passione,
quella per l’Americana e anche l’esplicitazione della sua vena musicale più
melodico-intimistica. Comincia a frequentare Mike Mogis, vale a dire il produttore attivo in area Saddle Creek e collaboratore di Bright Eyes alias Mr
Conor Oberst. I pezzi scritti insieme a Mogis diventeranno il fatidico primo
album, Falling Off The Lavender Bridge (uscito nel gennaio 2008), che i due
vanno a registrare in quel di Omaha, Nebraska, il cuore di quel suono. Non
mancano alle session altri personaggi topici, quali Nate Walcott (Bright Eyes),
Clark Baechle, batterista dei Faint, Emmy The Great e membri di Tilly And
The Wall e Cursive. “Mike Mogis non è stato un produttore impositivo e che
forniva idee, in realtà mi ha lasciato libero di fare le cose a modo mio, e così eventuali errori presenti nel primo disco sono dovuti al suo non intervento, piuttosto che
a me!” – rivela nel corso dell’intervista.
Il primo step del percorso di Lightspeed Champion è così compiuto.
Stupisce, osservando la sua storia a posteriori, di come ogni passo di Dev sia
perfettamente calcolato. Ogni mossa tracciata conseguentemente seguendo
un’idea ben precisa e declinata. Di come sia scientemente programmato ogni
disco e ogni scelta conseguente di sound e collaboratori, un disegno razionale
28
che segue certamente le passioni del
momento, ma razionalizzate e incanalate in un percorso preciso e netto.
Nel corso dell’intervista Hynes scioglie finalmente il nodo sul contrasto
rilevato tra ragione e impulsività: “In
realtà io sono un perfezionista e voglio
che ogni cosa sia fatta nei minimi dettagli e nel migliore dei modi, ma al tempo
stesso non sono uno capace di aspettare
e credo molto anche nell’immediatezza;
da qui il mio blog e tutte le attività instant che faccio a partire dal web”.
Un perfezionista estremo quindi,
e così ogni cosa ha un senso. Tornan-
do al primo album, si rivelerà vincente la scelta di genere e produttore.
Nel gennaio 2008 sul mondo indie
si abbatte così inaspettato il ciclone
Lightspeed Champion, che diventa immediatamente, attraverso un
rapido tam tam mediatico, un vero
e proprio “caso”. Falling Off The
Lavender Bridge è album di songwriting indie folk pop di ispirazione
Americana, riccamente arrangiato e
prodotto, che riflette tutta la ricchezza melodica e compositiva di Hynes,
novello Conor Oberst, Okkervil
River o Elvis Costello (a quest’ul-
timo assomiglia parecchio per tono
di voce oltre che per alcune scelte
stilistiche). L’esordio rivela una vivacità compositiva che già allora poteva fare venire in mente uno eclettico
come Patrick Wolf, a cui poi si sarebbe avvicinato. Un’ispirazione che
si abbevera alle fonti citate e che al
tempo stesso le rinfresca con un talento compositivo non comune. Se
a questo si va ad aggiungere la personalità frizzante e scoppiettante del
personaggio, una vivacità intellettuale
e un’autoironia contagiosa, si capisce
come l’esplosione del “fenomeno”
Lightspeed Champion si sia potuta
verificare in un tempo relativamente
breve. Il web ha poi amplificato i molti progetti di Dev attraverso la presenza attiva come blogger (lightspeedchampion.com), proprio da qui è
stata resa nota la sua passione per la
scrittura e i comics (il moniker scelto deriva da una serie di strisce che
disegnava da teenager sui quaderni di
matematica…); ha infatti autopubblicato subito dopo l’uscita del primo
disco un libretto di suoi fumetti, I'm
Asleep - Comics, Photographs and Illustrations, e a giugno 2009 è uscito il li29
bro Punk Fiction: An Anthology of Short Stories Inspired by Punk, che contiene una
sua short story di sci-fi, mentre a breve è prevista una antologia di racconti
brevi. L’altra uscita ufficiale è un contributo di Dev a una raccolta di comics
appena pubblicata del collettivo Cntrl.Alt.Shift. “Scrivere musica è un processo
abbastanza veloce e mi diverto a farlo, sui fumetti ci passo invece molto tempo e
non è una cosa facile e immediata come l’altra, ma ugualmente gratificante”. Su
web ha anche messo a disposizione alcuni progetti estemporanei con vari
demo da scaricare e interi album che ha coverizzato, alla maniera di un Beck.
Recentemente ha anche esposto sue foto in una galleria di Soho. Altra cosa
insospettata che viene fuori è la sua passione per l’hip hop commerciale e le
varie rivalità fra le fazioni rivali (2Pac / Biggie, Eminem…), di cui ha persino
scritto su Wikipedia, correggendo alcuni errori negli articoli presenti! Insomma il ragazzo si dà da fare e pure parecchio.
Nell’intervallo tra primo e secondo album, ci sono stati la consacrazione
e un tour promozionale, che lo ha portato anche dalle nostre parti.Visto alla
casa 139 di Milano a fine gennaio 2008, è apparso frizzante e all’altezza di ogni
aspettativa suscitata. Come dovrebbe essere ogni indie act che si rispetti, fresco e intenso ma non banale. Come conseguenza del tour si è verificato poi
per Dev un problema alla gola, poi risolto, che lo ha lasciato quasi senza voce
e il definitivo trasferimento da Londra a New York.
E finalmente il seguito, rivelatosi una conferma, e che ci fornisce l’occasione per una chiacchierata con Hynes: Life is Sweet! Nice To Meet You (in
spazio recensioni) pubblicato a febbraio, sempre su Domino era disco molto
atteso, considerate le notizie che circolavano già da qualche mese. Ancora
un cambio alla produzione, pur rimanendo in terra americana: questa volta
in cabina di regia siede il quotato Ben Allen (Gnarls Barkley e Animal
Collective tra gli altri). “Con Ben ci siamo trovati su un terreno comune di stessi
gusti musicali, e poi il mio primo album era tra i suoi preferiti del 2008! In genere
entro in studio quando i pezzi sono del tutto pronti, come questa volta, cosicché
abbiamo registrato in soli nove giorni. Ho di solito un punto di vista molto preciso
e anche perAllen è così, infatti ci sono stati alcuni momenti di tensione tra noi poi
risolti, lui sa come ottenere canzoni incredibili”.
Allen ha accontentato la voglia del Nostro di suono americano, anche se
è cambiato molto il punto di vista di Hynes, ora è il pop a tutto campo la
sua area di investigazione musicale, piuttosto che il folk di area USA, anche
se di quest’ultimo qualcosa è rimasta qua e là sotterraneamente nel disco.
In Life is Sweet! Nice To Meet You non c’è traccia di scrittura per chitarra
acustica, come nel primo, prevale infatti quella piano e synth, in un contesto
di chitarre dal suono pulito e al solito suoni estremamente curati. “Per questo
album volevo che tutto suonasse esagerato, mi sono prefissato di aggiungere quanti
più elementi potevo quasi fino allo sfinimento, ed ho cercato di evocare le emozioni
che esprimevano alcuni artisti solisti che ho sempre amato, perché lavorando da
soli potevano fare tutto quel che volevano, tipo Todd Rundgren e Serge Gainsbourg,
due tra i miei preferiti in assoluto.Volevo solo una voce maschile e voci maschili nei
cori, questo tipo di aspetto macho artificiale maschile che amo, tipo West Side Story.
Mentre componevo poi stavo ascoltando alcuni pezzi di classica che ho amato in
passato e nello stesso tempo scrivevo arrangiamenti per orchestre, così ho cercato
di usare questo tipo di formula adattandolo al disco”.
Questo spiega l’accumulo di elementi e la loro giustapposizione. Siamo
ora così in pieno trip Settanta, soprattutto inglese, lo si nota da certe chitarre frequenti con tanto di assoli, come in Middle Of The Heart (“il finale
30
di chitarra è volutamente esagerato, è
venuta così live, si adatta perfettamente alla conclusione dell’album”), dalle
inflessioni powerpop, si veda Faculty
Of Fears (“lo ammetto, sono un grande
fan del powerpop e dei Weezer, anche
se quest’ultimi non c’entrano molto qui;
è Todd Rundgren piuttosto un altro dei
miei eroi, di cui ho coverizzato l’intero
A Wizard, A True Star, uno dei miei album preferiti dei 70”), da un songwriting che ricorda alcune cose del primo David Bowie (periodo Hunky
Dory). Senza farsi mancare le incursioni nel guitar pop e nella wave,
si veda il singolo Marlene o la nota
Madame Van Damme (veniva eseguita
live negli anni scorsi, con il titolo di
The Prostitute/The Escort Song).
Altro elemento importante nel
disco è quello teatrale e glam, inteso
anche in senso lato. “Musical e teatro
sono due tra le mie influenze da sempre, la prima cosa vista in quell’ambito
è stata il Libro della giungla; mi piace il
musical perché si passa con disinvoltura
da un genere all’altro, cosa che a me
piace fare da sempre”. Non mancano
in questo trionfo dell’accumulo anche intermezzi vocali simil operistici
di marca Sparks e Queen (“sono un
grande fan dei Queen, c’è chi ha visto
loro influenze nel pezzo The Big Guns
Of Highsmith e in altri, ed è vero; anche
se non avevo in mente il gruppo quando ho scritto l’album, come influenza
inconscia è venuta fuori ugualmente")
che lo avvicinano stilisticamente a
uno come Patrick Wolf (“conosco
Patrick, siamo anche amici, entrambi
mettiamo noi stessi come interlocutori
della nostra musica, non compiacendo
nessuno”). In realtà Hynes si rifà soprattutto a un’idea totale di musical,
non a caso ha citato Andrew Lloyd
Weber tra le sue influenze, il compositore autore di musical quali Jesus
Christ Superstar, Evita, Cats e Il fantasma dell'opera. Songwriting adulto,
accumulo di elementi, musical, pop,
powerpop e suono Settanta, influssi
di classica (“Michael Nyman è un altro
da cui sono stato influenzato per questo
disco”) il tutto tenuto insieme da una
produzione e un suono tipicamente
americani, questo in estrema sintesi
Life is Sweet! Nice To Meet You.
Sul processo compositivo in sé
Dev dice in generale che tutto quello che fa è una sorta di esperimento
e che i testi vengono solo per ultimi
(“scrivo prima la melodia, poi la struttura e poi dopo gli arrangiamenti vengono rapidamente le lyrics”), mentre
è molto importante in questo caso
quello che hanno rappresentato; “si
parla di uscire allo scoperto, è un anno
e mezzo che sono andato via da Londra per NY e questo trasloco mi faceva
paura all’inizio, quindi ci ho scritto su
dei pezzi che parlano anche del senso
terapeutico del muoversi, fino ad arrivare a stare sufficientemente bene da
poter dire buongiorno alla gente - si
veda il titolo dell’album, ndr – senza più
nascondersi, come ho fatto in passato.
Il disco è anche un omaggio a Londra,
sto bene solo ora che me ne sono andato via e così tendo a ricordarne solo
le cose positive. L’album è quindi una
sorta di diario che è venuto come un
flusso di coscienza, certe volte capendo
solo dopo il significato di certi testi che
avevo scritto”. Un modo quindi per
esorcizzare alcune paure e in questo
caso riuscire a superarle.
E intanto, perché non riesce proprio a star fermo, il Nostro ha messo su anche un side project tra un
album di Lighspeed Champion e l’altro: come Blood Orange (myspace.
com/bloodorangeforever) dovrebbe
uscire qualcosa a breve; si tratta di
una one man band tra lo fi, black funk
e ritmi dub. Un personaggio a tutto
tondo Dev Hynes, che in fondo, come
ci ha rivelato, fa solo le canzoni che
vuole sentire, magari quelle ascoltate
a mesi di distanza e che riprende con
procedimento non del tutto conscio,
sia nella musica che nei testi. Ci piace
perché ha personalità e talento.
31
Recensioni
AA. VV. - Twisted Cabaret Vol. 1
(Volvox Music, Gennaio 2010)
G enere : vaudeville / pop - cabaret
Twisted Cabaret Vol. 1: un esperimento che si vuole eclettico (quanto meno nella scelta mediale: compila
musicale nel CD, più una raccolta di videoclip nel DVD)
teso a repertoriare un certo mondo musicale di stile goliardico, grottesco a volte, cabarettistico - ma nel senso
originario del Cabaret Voltaire zurighese, e quindi filodada - compiuto dalla Volvox Music.
I Residents non potevano mancare (con The Dying Oilman e con il video di Harry The Head); eppure, e neanche
questo ci stupisce, dipingono ormai paesaggi senza nessun interesse. Un freak show ambientato nella grafica
3d da videogioco metà Novanta. La sorpresa è semmai
Beguine di De Kift, band olandese vicina a The Ex; surreali associazioni automatiche e paranoiche, divertenti in
primis, con un video che eleggiamo a migliore del lotto.
Certo, tutto questo materiale ci farebbe fare il solito
collegamento, se dovessimo descrivere un elemento alla
volta, separato dal contesto del progetto: il vaudeville.
E quindi, probabilmente, anche solo per anzianità, sono
tutti figli dei Residents, questi neo-vaudevilliani. Alcuni
apertamente, e superando a destra (da restauratori) i
maestri-occhio, come i Dresden Dolls, oppure Marcella And The Forget Me Nots (che giocano sull’asse
comico-surreale-horror-gotico-antan) - ma anche Little
Annie, forse? Altri sono più intelligenti, e giocano con la
cultura di oggi - i cigni di Aranos (nel video di Julio Cruz),
correlativo oggettivo della resistenza della bellezza all’inquinamento, oppure il già citato teatrino quotidian-surreale di De Kift, o, infine, le atmosfere voodoo-circensi
dei Little White Rabbits Still Bleed Red di Muncie
Mayhem (Who’s Got The Maya). E che sia la libertà di associazione di mondi la macro-chiave di interpretazione,
la scelta curatoriale? Se sì, la apprezziamo.(6.6/10)
Gaspare Caliri
AA. VV. - Fabric Presents Elevator
Music Vol. 1 (Fabric, Gennaio 2010)
G enere : UK bas s , chillstep
Il brainstorming in casa Fabric accosta alle uscite mensili una nuova compilation stranamente unmixed. Elevator
32
— cd&lp
Music, secondo i boss del locale, raccoglie(rà?) la crema
del suono bass dance britannico. Data la mole di tracce,
meteore, innamoramenti e mode che passano sotto la
consolle dei DJ britannici, il tentativo di catalogazione è
più che mai appropriato.
Nelle sedici track sembra che il club della capitale UK
stia orientandosi verso un pubblico adult che apprezza le
derive del suono dubstep ma che ne gode pure gli aspetti off da party privati. Guizzi d'adrenalina giovanilistica
per il trentenne che cerca momenti d'escapismo sonico
controllato vestiti (cosa più importante) di coolness da
ostentare senza riserve.
L’ascensione ricalca il periodo di massimo splendore della !K7, quando gli idoli erano Kruder & Dorfmeister
e la città era Vienna. Oggi mutatis mutandis ci si sposta
un po’ più in su, ci si toglie di dosso il chill e si pompa
il cocktail con lo stepfloor. I nuovi party saranno quindi
farciti di dance caraibico-tribale (Sing With Us, Drums In
The Deep), houstep mescolata con le tastierine F Comm
(Pistol In Your Pocket), qualche ricordo progressivo mescolato con il tiro ‘n’bass (The Moth, Melvin Blue), il bbreakin’ d’obbligo (siamo pur sempre a Londra, no?) e per
chiudere con il botto singoli che colano acido dalle menti di Martyn, Caspa & Rusko e Starkey.
Se vi eravate persi qualche puntata: senza passare dal
via andate direttamente sull’ascensore del Fabric. Coniugare lo step con il chill, chi l’avrebbe mai detto? Culto
istantaneo.(7.4/10)
Marco Braggion
AA. VV. - Pop Ambient 2010
(Kompakt, Gennaio 2010)
G enere : electro ambient
Decimo anniversario per la compilation che come ogni
gennaio spunta fuori dagli scaffali di casa Kompakt facendo il punto sulle sonorità ambient kraute dell’etichetta di
Wolfgang Voigt. Già specializzato con lo storico progetto GAS, il boss sforna una sequenza che, a differenza
dei numeri precedenti, tende a posizionarsi sul melodico,
testimoniando gusto classico (Orb, DJ Koze e lo stesso
Voigt) e illustri sconosciuti.
Le atmosfere dell’ambient da Colonia si purificano rispetto alle performance dei soundmakers berlinesi tanto
highlight
Adam Green - Minor Love (Rough Trade, Gennaio 2010)
G enere : songwriting
Il newyorkese sarcastico e sempre sopra le righe, che detesta la figura del cantautore confessionale e
passa di citazione in citazione giocando con il suo songwriting ad effetto, sembra essere arrivato ad un
punto di svolta. Alla soglia dei trent’anni e con l’ennesimo album in uscita, Minor Love, riesce laddove
non era arrivato completamente finora.Vale a dire a scrivere l’album compatto e finalmente adeguato alle
sue possibilità espressive.
Intendiamoci, il piglio ironico e il mood sbarazzino ci sono tutti, quello che
sembra essere cambiata è l’attitudine e la scrittura si è fatta più coerente
e sicura, senza troppo sbavature. Minor Love è quindi un compendio del
suo songwriting, che oscilla tra i numi tutelari Lou Reed, Leonard Cohen, Burt Bacharach, Jonathan Richman, a spasso tra decenni di musica
americana , senza dimenticare il country rock e persino la ballata in odore di
acido psych (Bathing Bird), facendo anche simpaticamente il verso al miglior
Beck soul funk in Lockout.
Insomma il ragazzino impertinente che abbiamo imparato a conoscere un
bel po’ di tempo fa con i Moldy Peaches è cresciuto. Sempre senza prendersi troppo sul serio, speriamo
a lungo.(7.2/10)
Teresa Greco
che scompaiono la contaminazione con il bass inglese o
con la techno nordeuropea. La dichiarazione è un’altra,
quasi un controaltare per il dub rarefatto dei guru del
dub Hard Wax: less is, again, more. E anche se si tolgono
elementi non ci si dimentica per fortuna di quello più importante. L’anima. Quella resta, magari frozen, ma c’è. Un
bel regalo che allieterà i soundscapes invernali.(7/10)
più caldi spiccano Jazzsteppa, Cotti, Rush, Mrk1 ed
Eskmo. Il disco spazia dall’electrostep in acido (Playtime’s
Over) al bass più tirato (Freedom), dall’ardkore zombyano di Dubcore all’ambient-goa di Cheddar. Una compilation ben mixata che ci fa conoscere una nuova etichetta,
ma che non aggiunge molto alla media delle produzioni
mesh-step d’albione. Solo per aficionados.(6/10)
Marco Braggion
Marco Braggion
AA. VV./Studio Rockers - Studio
Rockers At The Controls (Studio
Rockers, Novembre 2009)
G enere : raggastep dub
Tony Thorpe (aka The Moody Boyz) è il boss di casa
Studio Rockers. L’etichetta, fondata 3 anni fa dal ragazzo
Wall Of Sound e curatore del Meltdown Festival in combutta con i Massive Attack, comprende un roaster di
amanti delle roots dub e delle tensioni -step. Fra i nomi
AFCGT - AFCGT (Sub Pop, Gennaio
2010)
G enere : A vant psych punk
Sempre più spesso il passato si reinventa. I gruppi si riformano o si riciclano. Più raramente esperienze distanti, ma non opposte, trovano il modo di dar vita ad una
nuova fragorosa creatura. Succede oggi con gli AFCGT,
combo formato da due gruppi di Seattle, rispettivamente
gli A Frames (già un album su Sub Pop) e i Climax
33
Golden Twins, dei quali sono la naturale unione anche
a livello di acronimo scelto.
L'attitudine al rock tellurico di scuola Skin Graft / AmRep
dei primi si accosta al lato dronico e concreto dei secondi (com'è d'obbligo nei 2.1). Spesso però non avviene
una fusione completa, ma piuttosto una giustapposizione
dei rispettivi stili. Così tribali cavalcate psych (Two Legged Dog) vengono affiancate a divagazioni raga-ambient
(Nacht); e garage mathematico (New Punk, New Punk 27)
a strazianti collage di suoni rubati ad un aeroporto nel
panico (Reasonably Nautical).
Il risultato (uscito solo in digitale e in LP con un 7 pollici
bonus allegato) non è né organico né d'immediata assimilazione. E se questo può inizialmente lasciare perplessi, ci pensa la maestria dei cinque a fare da garante e a
generare visioni vorticose come i caleidoscopi delle loro
copertine.(7.3/10)
Andrea Napoli
Agent Side Grinder - Irish
Recording Tape (Enfant Terrible,
Novembre 2009)
G enere : N eo W ave
Sempre per l'olandese Enfant Terrible (e in seguito a
un primo lavoro del 2008), gli Agent Side Grinder
tornano con ben due album, entrambi realizzati con un
membro del gruppo momentaneamente trasferitosi negli Stati Uniti.
Irish Recording Tape riprende da dove l'omonimo debutto si era interrotto: massicci dosaggi di wave elettronica (Die To Live, Black Vein), basso che pulsa dritto sulle
tempie (The Screams), incursioni industriali a redarguire
chi pensa di averci preso confidenza (Pulse). La composizione si fa meno immediata e più ponderata; la conoscenza della materia trattata e la capacità di rielaborarla
in chiave personale restano immutate.(7.1/10)
Andrea Napoli
Agent Side Grinder - The
Transatlantic Tape Project
(Enfant Terrible, Novembre 2009)
G enere : A mbient / I ndustrial S oundtrack
Il secondo tomo del nuovo capito ASG si chiama The
Transatlantic Tape Project e mostra il lato più sperimentale
e compositivo della band di Stoccolma. Frutto del fitto
scambio di idee tra Svezia e Stati Uniti, il secondo ellepì
tesse trame sonore ammalianti e avvolgenti.
Sette paragrafi dai nomi criptici a mescolare psichedelia
sixties, ambient mutante e muzak industriale. Cabaret
Voltaire, Eno e Velvet Underground, tutto sapientemente rielaborato per dar vita ad una soundtrack da
34
viaggio lento e meditativo, proprio come nella splendida
cover.(7.3/10)
Andrea Napoli
Album Leaf (The) - A Chorus of
Storytellers (Sub Pop, Febbraio
2010)
G enere : I ndie , post , chamber
L'ex post-rocker Jimmy LaValle ce l'aveva fatto credere:
dopo aver inciso il nuovo album di The Album Leaf alla
solita maniera, e con l'aiuto dei sodali Jon Sigur Rós Birgisson (al missaggio) e Ryan
Hadlock (fonico del Bear
Creek Studio), ha iniziato a
sbandierare, già tre mesi fa,
che non sarebbe più stato
solo, lasciando indendere
una svolta importante.
L'etichetta è montata a
cavallo aggiungendo "fondamentali" ai cambiamenti
profilati da A Chorus of Storytellers, album che si è
avvalso dell'aiuto di un'intera band come non accadeva
dai tempi dei Tristeza. I ragazzi sono quelli del supergruppo Magnetic Morning che ha seguito LaValle anche nello scorso tour (tra i quali troviamo vecchie conoscenze quali Sam Fogarino degli Interpol e uno degli
Swervedriver) ma il loro coinvolgimento non è stato
sostanziale. LaValle era solo quando ha portato le comuni session ai soliti studi di Washington dove ha sfornato
un master non dissimile dai consueti standard.
Rispetto al bello e (a questo punto) autoconclusivo Into
the Blue Again, la nuova prova si caratterizza per un
immobilismo quasi imbarazzante, una prova cristallizzante più che cristallina, pietra tombale sopra a un mondo
sonoro tanto faticosamente sintetizzato nei lavori precedenti.
La lunga gestazione poi non ha giovato: un blocco dello
scrittore ha costretto il chitarrista, che nel frattempo si
è sposato, a tardarne l'uscita. L'attacco - e le modalità - di
uno dei brani più riusciti dell'album, Falling From The Sun,
ricordano più Casiotone For The Painfully Alone
che non lui che a quelle strategie del cuore ha contribuito prima di tutti, quando altrove è la solita cartolina di
post, Islanda e Morr Music.
Doveva, anzi voleva, essere il miglior album di Album Leaf
ma lo è soltanto per una produzione e un professionismo
ineccepibili. Gli arrangiamenti chamber - e adult - à la
Mùm (Stand Still), così melodiosamente impeccabili, ne
evidenziano ancor più l'inutile esercizio di stile. (5/10)
Edoardo Bridda
Alva Noto - Xerrox Vol.2 (Raster
Noton DE, Gennaio 2009)
G enere : elettronica
Seconda uscita di cinque, quelle che si attendono per la
serie di Xerrox ed un Alva Noto come sempre pronto
ad immortalare geometrie del suono. A tre anni dal primo volume e ad uno dagli interstizi astratti per inserti
e rumore di Unitxt la poetica è sempre quella; impatto sonoro e riflessioni estreme su materia e frequenze
ed una ricerca di classicità che sembra essere diventata
una priorità per lui e gente come William Basinski o
Fennesz peculiarità condivise con quest’ultimo anche
in ambito di un passato d’innovazione attorno all'ossimoro glitch.
Differentemente dallo Xerrox Vol.1 che presentava anche
stampanti nude e crude al lavoro, nel Vol. 2 il boss della Raster Norton ci presenta quel classico fare dronato
con vaghi ma pregnanti accenti cameristici (Monophaser
1) e ancor più calcolati e aleatori tocchi cinematografici
(Sora).
Un solidificarsi di materiale in campioni che partono
da registrazioni fatte con
Stephen O'Malley e Michael Nyman e che attraverso i domini d’elettronica
in micro-sintesi arrivano a
confluire con sinergia sottile oggetti artificiali che vanno a toccare prima l’ambient
astratta e granulare (Soma) o a risuonare in paragon di
virtù agli scritti di Russell Haswell e Florian Hecker
per fisicità e appello al rumore (Meta Phaser).
Ma il noise è un'alchimia usata con parsimonia e non la
colata lavica di gente più arrembante come Ben Frost.
Ed è un classico gioco di generazioni e di percorsi dunque. Niente di così diverso dalla versione digital di epopee come quelle dei Neubauten.(7.5/10)
Sara Bracco
Ambrogio Sparagna/Orchestra
Popolare Italiana - Taranta
d'amore (Parco della Musica
Records, Novembre 2009)
G enere : musica popol are
Diventata nell'ultimo decennio autentico fenomeno di
massa - con l'annessa retorica “sole-mare-vento” che ha
reso il Salento una sorta di Shark El-Sheik di chi addita con disprezzo coloro che a Sharm el Sheik ci vanno
davvero - la taranta rischia di perdere per strada tutta
quella densità antropologica di tradizione e cultura che
le ha permesso di superare numerosi secoli e altrettan-
te barriere. Serve dunque difenderla, ma meglio ancora
darle nuova vita, per via contaminatoria o prestandosi ad
un'operazione come quella che compiono Ambrogio
Sparagna e l'Orchestra Popolare Italiana dell'Auditorium Parco della Musica di Roma in questo Taranta
d'amore. Ovvero contaminare sì, ma non con musiche
contemporanee, bensì mescolando tradizioni che fra i
secoli dal centro Italia all'estremo sud hanno trovato nel
ritmo ternario della taranta un comune filo rosso, aggiungendovi poi brani nuovi e autografi.
L'esito è un humus ben poco imbalsamo nelle stagnazioni filologiche ma fecondo di tracce al contempo viscerali
ed eleganti, che aggiungono alla tensione terrigna d'origine l'imponenza energica di un ensemble numeroso e
perfetto nell'esecuzione. Applauso dunque a Sparagna
per il lavoro in fase di adattamento di spunti in nuce
molto diversi fra loro (strambotti, pizziche, canti popolari romani e tanto altro) come di scrittura di nuove
canzoni del tutto omogenee al resto (splendida Libera
nos a malo). E applauso ai venti elementi dell'Orchestra
tra zampogne, organetti, mandolini, chitarre battenti, ghironde, ciaramelle, tamburelli, violini e voci (di alcuni dei
migliori cantanti popolari italiani: su tutti impossibile non
segnalare la voce pastorale di Raffaello Simeoni).
Se c'è qualcosa da sostenere contro l'istituzionalizzazione da pro loco e il trionfo della didascalia da cartolina è
proprio una pratica di futuro antico come questa. Ancor
di più se realizzata a livelli così alti.(7.7/10)
Luca Barachetti
Angus & Julia Stone - And The Boys
ep (Capitol, Gennaio 2010)
G enere : folk pop
Australiani di Sydney, i due fratelli Angus e Julia Stone
tornano a quasi due anni dal debutto lungo A Book
Like This. Se per marzo è previsto il successore Down
The Way, il qui presente singolo And The Boys ep
ci offre un antipasto degno di menzione. Sembra proprio che la delicatezza folk del duo abbia acquisito quel
preziosismo indolenzito, quella profondità trepida, quella
sottigliezza inesplicabile che fa la differenza tra un popfolk innocuo e uno che ti lascia l'impronta sul cuore.
Tre i pezzi in programma: una title-track tesa e illanguidita dove Julia sembra una El Perro Del Mar ipnotizzata
Joanna Newsom (o viceversa), una Change che vede
Angus nei panni del troubadur di velluto (anche un po'
sdrucito, il che non è male), infine quella Take You Away
che s'adagia con una certa convenzionalità su una crema
d'archi ma struggendosi in bello stile. Segnali di maturità
che presto troveranno conferma o smentita.(7/10)
Stefano Solventi
35
Aoki Takamasa - Ununtrium/RNRhythm-Variations (Raster Noton
DE, Gennaio 2010)
G enere : P ost -T echno
Ancora tavole periodiche, elementi primari e deframmentazioni post-techno per la serie Unun su RasterNoton, del cui lotto finora brilla di originalità (teorica e
non) Grischa Lichtenberger.
Stavolta tocca ai beat incasellati di Aoki Takamasa che
sorreggono pattern a costanti alvanotiane perdurando
così fino alla fine. Quattro movimenti sostanzialmente
somiglianti sia nei titoli (delle RN progressive) che negli
effetti.
Le ritmiche si scompongono come extrasistoli incattivite
e dentro qualche pattern iniziale riecheggia prepotentemente lo spettro di Akufen. Dei frattali marini dei due
Silicom non è rimasto niente, soltanto qualche scossone
granulare qua e là.
Spiccare di genio con suoni così inflazionati è piuttosto
impossibile.(5.5/10)
Salvatore Borrelli
Badara Seck - Farafrique (Officine
Meccaniche, Novembre 2009)
G enere : etno - world
Il problema a monte è parlare di “musica africana” riferendosi a un continente esteso tre volte l'Europa e difficilmente pareggiabile per molteplicità di culture e tradizioni musicali. Come se un americano parlasse di musica
europea riferendosi indistintamente a un rebetico greco
o a una humppa finlandese. E colpisce che a farlo sia
un griot quale Badara Seck, senegalese musicalmente
trapiantato in Italia, già collaboratore fra gli altri di Massimo Ranieri, Morgan e Raiz, ora all'esordio con la
produzione di Mauro Pagani.
Farafrique potrebbe essere un discreto disco di brani
tradizionali kora, percussioni e voce - che voce: fuori dal
tempo, spiritata soul senza esserlo, odorante memoria e
sangue - se non si fosse pensato bene di infilarci qua e
là indigeribili grumi tipo world andata a male di ritmiche
elettroniche, tastierame assortito (addirittura un finto
flauto di pan in Djamu) e batterie standard ad edulcorare impianti ritmici tanto complessi quanto affascinanti
(Visa). Due brani li produce Roberto Vernetti, che tratta la title-track e Mamadou Faye quasi come se fossero
due pezzi dei La Crus e il risultato è la più agghiacciante
cartolina tipo tramonto africano di synth crepuscolari e
fondale di cori watussi.
Meglio il resto, a partire da una Malì Senegal dove Seck
incontra lo ngoni e la voce del maliano Baba Sissoko
- e allora si sente che la musica africana non esiste se
36
non nella testa di chi la considera una brodaglia esoticamente indistinta - fino ad una Here Nanà in travolgente
crescendo rotatorio di kora e battiti. Ma bisognerebbe
avere molto più rispetto ed essere molto più rigorosi
quando si ha tra le mani un simile patrimonio. Altrimenti
è meglio che ognuno stia a casa propria.(5/10)
Luca Barachetti
Badly Drawn Boy - Is There Nothing
We Could Do? (Discograph, Gennaio
2010)
G enere : soundtrack autorale
Quattro anni sono passati da quel Born In The UK
che sancì lo smarrirsi di un'ispirazione avviatasi ad inizio
millennio con slancio forse anche eccessivo. Fatto sta
che il ragazzo disegnato male aveva fatto di tutto per
smentire le enormi aspettative suscitate da The Hour
Of Bewilderbeast e dalla OST di About A Boy, sfornando altri tre lavori velleitari, frenetici, confusionari,
scentrati. Presuntuosi, ecco. Il risultato - il brutto - è che
in tutti questi anni non ci è mancato troppo, il caro Damon. Nossignori.
Va detto altresì che, se proprio doveva tornare, lo ha
fatto in modo quanto meno
dignitoso. A fari bassi. Con
la scusa di una colonna sonora per il film TV inglese
The Fattest Man In Britain.
Per la quale ha sfornato un
pugno di melodie imbronciate, senza guizzi, cercando di
circoscrivere una dignitosa trepidazione. La title track
sbocconcella cartoline Elliott Smith; Welcome Me To
Your World è un'accademica malinconia per piano che innesca una marcia incendiata di tromba, tastiere e corni.
Tra le tipiche frattaglie ambientali da soundtrack, spuntano altre ballatine senza infamia ma soprattutto poca
lode come Just Look At Us Now e la solenne Ill Carry On,
benedetta da una misurata orchestrazione d'archi.
Badly Drawn Boy è tornato, ma non per stupire. (5.8/10)
Stefano Solventi
Bibi Tanga/Selenites (The) - Dunya
(Nat Geo Music, Gennaio 2010)
G enere : etno - funk & pop
Bibi Tanga, cantante e bassista nativo di Bangui (capitale
della Repubblica Centrafricana), parigino d'adozione, è
sulla scena da almeno dieci anni: prima solista, con l'afrofunk di Le Vent Qui Souffle (2000; prodotto nel giro della
Malka Family), poi in coppia col produttore Le Pro-
highlight
Brian Jonestown Massacre - Who Killed Sgt. Pepper? (A., Gennaio
2010)
G enere : psych - shoegaze - rock
Anton Newcombe come non l’avete mai sentito. Oppure sì, se seguite le peripezie di quella che è l’ultima,
vera, riottosa rockstar del mondo. Perché se lo seguite, come merita, sapete benissimo che è uno che
non si culla sugli allori, anzi, quando ti aspetti il deja-vu ecco che lui sterza a 180° e parte per l’ennesima,
sorprendente tangente.
Già chiedersi chi ha ucciso il sergente Pepper significa giocare con la Storia della musica, ma nell’album n.
11 (o abbiamo perso il conto?) Anton i conti li fa sul serio con la sua storia.
Con la psichedelia - neo-sixties o acida e imbastardita, che sia - che da qualche lustro ne è segno caratteristico e che in un capolavoro come My Bloody
Underground si faceva esplicito omaggio e palese manifestazione alle versioni/
visioni più sporche e malate di quel suono. Ma anche con tutte quelle influenze sonore che finora erano rimaste a covare sotto la cenere.
Da un lato una evidente aggressività post-punk da agitatore sonoro quale è
(l’omaggio-rendition di She’s Lost Control in This Is The One Thing We Did Not
Want To Have Happen), che forse trova la sua ragione d’essere nella matrice europea dell’album: metà islandese, metà berlinese nella registrazione/composizione e pienamente
europeo nella formazione (di rilievo in mezzo a uno stuolo di musicisti francesi, tedeschi, islandesi, l’ex
Spacemen 3 e Spiritualized, Will Carruthers). Dall’altro, novità delle novità, una neanche tanto latente
propensione per ritmi e sonorità nere: di matrice hip-hop old-skool, limitrofi alla house tribaloide, reminiscente di industrial mesh-up alla Kevin Martin (roba tipo The Bug e Techno-Animal, per capirsi).
Who Killed Sgt. Pepper? ipotizza un immaginario ponte tra ’60, ’80 e ’90 che frulla mantra e trip da ecstasy,
scorie radioattive e wall of sound classicamente shoegaze in un collage meno estremo, sporco e riottoso
rispetto al precedente ma plastico e sintetico. Come poteva suonare un gruppo psichedelico nell’Hacienda semi-house della Madchester dei bei tempi. Ipotesi e possibilità di nuovi percorsi in cui, alla maniera di
un famoso album di Spacemen 3, emerge una grossa e lapalissiana verità: Mr. Anton Alfred Newcombe è
grande e le droghe sono il suo profeta.(7.3/10)
Stefano Pifferi
fesseur Inlassable (Yellow Gauze, 2007). Arriva però
soltanto adesso al debutto internazionale, sempre affiancato dal Professore, assieme ai nuovi compagni Arnaud
Biscay (batteria), Rico Kerridge (chitarra) e Arthur
Simonini (tastiere, violino).
Il sottoscritto è generalmente diffidente verso i progetti
world sponsorizzati e pompati (Bibi fa parte del WOMAD
di Peter Gabriel e il disco esce nientemeno per National Geographic), sempre a rischio di giocare di ruffianeria
e pigiare sull'esotismo facile. Ma qui abbiamo un prodotto ispirato.
Cantato in inglese e in sango, cadenza leggermente rappata, un falsetto che ha come modello Curtis Mayfield,
brani generosi, che alternano alla predominanza funky e
funk (e samba-funk, nella trascinante title-track) atmosfere trip-hop, frammenti di tradizione africana (su tempi
dispari, Pasi), cantautorato folkie, misterioso slo-reggae
(Gospel Singers) ed episodi jazzati e bluesy (Bon Jour...),
fino allo scatenato funky-disco finale (ripescaggio dall'album del 2007). Bibi sa il fatto suo.(7.3/10)
Gabriele Marino
Boston Spaceships - Zero To 99
(Guided By Voices Inc., Ottobre
2009)
G enere : low - fi rock
Tranquilli, non si tratta dell’ennesima sensazione sulla
quale Pitchfork sta per sbavare. Le “navi spaziali” bostoniane sono l’ennesima creatura di Robert Pollard, noto
(?) ai più per aver guidato i padrini del low-fi Guided By
Voices. Facce conosciute lo affiancano (basti quel Chris
Slusarenko da parecchio fidato suo pard) in un’impresa
che diremmo seria e anzi la più seria dalla fine dei GBV.
Decollata nell’estate 2008, è proseguita con un tour,
37
l’esordio buono Brown Submarine e un paio di 7”.
Il solito profluvio creativo di un artigiano sconclusionato
e geniale, brontolerete. Sì e no, perché dopo una replica persuasiva come The Planets Are Blasted, il “difficile terzo disco” edito lo
scorso anno e distribuito
solo ora nel nostro paese
possiede scrittura solida e
policroma come non accadeva da anni. Immutato il
quadro, dal timbro vocale
tra McCartney e Stipe
alle canzoni che, come figlie
di Television Personalities statunitensi, arrivano da un
universo parallelo nel quale il folk-rock dei ’60 s’è fuso
con new wave e punk, saltando tutto quanto di deprecabile v’era in mezzo eccetto il power pop meno banale.
Valore superiore alla media e apici assoluti in Radical Amazement e Question Girl All Right, Go Inside e Exploding Anthills;
la novità una propensione all’acida acusticheria che in Return To Your Ship e Godless recapita barrettiani gioiellini. Se
interessati, sappiate che sono pronti un mini e il quarto 33
giri e oggi che autoprodursi dischi è più facile che mai, chi
fermerà Robert? Noi no di certo.(7/10)
Giancarlo Turra
Brain - Brainstorm (Semai,
Gennaio 2010)
G enere : H ip - hop
Francesco Spatafora, classe '83, bolognese di genitori calabresi, è Brain dei Fuoco Negli Occhi, crew accasata
presso La Grande Onda di Zannello/Piotta e con due
dischi all'attivo. In grande spolvero la bravura dell'MC
nel costruire rime strapiene di trick, autoreferenziali ma
comunicative (no al nonsense, pochissimo slang), a tratti
veramente eccezionali, esposte con un flow velocissimo
ma perfettamente intellegibile, timbro pulito e cadenza
mai caricata, quasi parlata. Le basi sono un po' il punto
debole della faccenda, con tastierine e call&response un
po' troppo simili a tanta roba che si trova in giro (e che
non ha la fortuna di servire un rapping così valido). Le
migliori sono ancorate ad un asciutto (electro)funk.
Un buon debutto solista, in una scena difficile com'è
quella del rap italiano.(6.4/10)
Gabriele Marino
Brilliants At Breakfast (The)
- Romy's Garden (Seahorse
Recordings, Dicembre 2009)
G enere : post - rock / psichedelia
Come NON rinnovare un genere come il post-rock ce
38
lo insegnano i palermitani The Brilliants At Breakfast. Con
una serie di luoghi comuni mascherati dai soliti arpeggi,
qualche riferimento a un grunge svogliato, un campionario di morbidezze altalenanti su grassetti in overdrive
e un mood che gioca con una psichedelia narcotica ma
elementare. Materiale che già alla terza traccia ha dato
tutto, lasciando trasparire pochi motivi di interesse che
giustifichino un ulteriore ascolto.
Dalla débâcle non si salva quasi nulla - forse la sola title
track -, tanto che viene da chiedersi che cosa abbia trovato nella band in questione uno navigato come Paolo
Messere con la sua Seahorse. Forse una creatività grezza e qualche input da perfezionare, di cui noi, tuttavia,
non possiamo accontentarci.(4.5/10)
Fabrizio Zampighi
Chicago Underground Duo - Boca
Negra (Thrill Jockey, Gennaio
2010)
G enere : free - jazz
Cos’è che ci portano in regalo, questa volta, Rob Mazurek e Chad Taylor? Ciò che ci aspettiamo, ovviamente,
è quella mirabile resa di un humus culturale che ci ha
sempre affascinato, come se un gruppo potesse ritrarre
una città, il suo stato di salute, le sue interiora, il suo
sottobosco musicale. E come sta Obama-ianissima Chicago, oggi? Ecco che forse questa non diventa più la sede
ideale per rispondere, dato che né Mazurek, né Taylor
sono più a Chicago. Il primo si è trasferito a São Paul,
nel paese della moglie, il secondo è ormai residente a
NYC. Allora perché chiamarsi ancora Chicago Underground Duo?
Probabilmente per l’affiatamento. Green Ants fa le prove
generali, e si chiude con la contrattazione tra tromba
e batteria: da entità autonome, indipendenti, free tra di
loro, a coese, in un muro finale. Left Hand Of Darkness
è un viaggio teneramente psichedelico, pieno di echi di
Nanà Vasconcelos, specie delle sue collaborazioni con
Don Cherry. Sembra dunque che ormai le influenze di
Mazurek la facciano da padrone. Anche se in realtà Boca
Negra parla un esplicito linguaggio free, più vicino a New
York, piuttosto che a Chicago. Dopo le meraviglie di São
Paulo, ci sembra che Mazurek - e Taylor - ci vogliano rendere astigmatici. E confondere i confini tra Sao Paulo e
Chicago, in prima istanza, e quindi tra queste e NYC.
Certo, non mancano prospettive fuori dal jazz - in Laughing With The Sun e Roots And Shooting Stars, e in Vergence,
che chiude con le solite connessioni post. Però in generale Boca Negra è un disco chiuso, cioè sempre liberatorio, come tutto il free, ma meno aperto a prospettive
diverse, anzi, meno capace di aprire prospettive, di far
highlight
Claudio Rocchetti - The Carpenter (Boring Machines, Gennaio
2010)
G enere : coll ages sonori
Non si offenderà Rocchetti se gli diamo del carpentiere, giocando un po’ col titolo del comeback. Dopotutto di complimento si tratta, visto che più che artista lo consideriamo un vero e proprio artigiano della
musica. Uno che intarsia suoni più o meno rumorosi, più o meno abrasivi, più o meno disturbanti con la
cura e l’attenzione dei vecchi incisori.
Costruisce, Rocchetti. Usando strumenti e strumentazione noti, dà forma
all’ignoto fluire della sua musica, crea collages e pastiche in cui convivono
naturalmente, senza screzi né titubanza, accenni di ritmi techno e ambient
glaciale, horror soundtrack e drones estatici, mozzichi di contemporanea
e malinconia tardo-adolescenziale, incrinature materiche e atmosfere mesmeriche... Aspetti noti, eppure mai come in The Carpenter l’equilibrio e
l'amalgama degli input antitetici è stato reso in modo così personale.
E c'è un lavoro di squadra dietro: la crème de la crème dell’Italia più off: Giuseppe Ielasi masterizza, Lorenzo Senni e Be Invisible Now! vanno di grafica e layout, Stefano Pilia,
Jukka Reverberi, Beatrice Martini, Margareth Kammarer suonano qua e là, Boring Machines e Wallace
producono in cd, Presto! e Holidays in vinile. Sopra tutto e tutti c'è però il Rocchetti musicista, oggigiorno
simile solo a se stesso. Non un pregio da poco.(7.5/10)
Stefano Pifferi
intuire la grandezza di nuove possibilità, di nuove opzioni
- sensazione che ha sempre reso grandi i dischi con Mazurek. C’è un grado come di “compiutezza” in più, nella
chiarezza dei riferimenti, certo nello stile ultrapersonale
che ormai riconosceremmo tra mille, nella Chicago Underground che non sta più a Chicago…(7.4/10)
Gaspare Caliri
Circulasione Totale Orchestra
- Bandwidth (Rune Grammofon,
Gennaio 2010)
G enere : avant jazz
Frode Gjerstad è uno che sa tirare le fila. Norvegese,
sassofonista e clarinettista, è un caposaldo della scena
impro europea nonché da un quarto di secolo leader
dell'ensemble Circulasione Totale Orchestra, quindici
(più o meno) rappresentanti del miglior jazz internazionale chiamati ad unire le forze in questo progetto tra i
più compositi che abbiano mai calpestato le scene.
Più difficile è tirare le fila del qui presente Bandwidth,
triplo album che esplora, dilata, sincretizza, indaga e ipotizza sprezzando ogni senso del limite, riducendo l'ascoltatore in bilico tra sfinimento ed incanto. Tribalismi sclerotizzati e trasfigurazioni latine, perturbazioni electro e
particelle post-bop, libere intersezioni di ance, vibrafono,
chitarra elettrica e un impressionante lavoro percussivo
a cura dei tre pesi massimi Paal Nilssen-Love, Hamid
Drake e Morten J. Olsen.
E' un lavoro meravigliosamente dispersivo, deliziosamente scentrato, formidabilmente indefinibile.(7.3/10)
Stefano Solventi
Delphic - Alcolyte (Polydor,
Gennaio 2010)
G enere : I ndie , dance
L'idea della provetta da laboratorio ti ronza per tutta
la durata dell'album e non ti lascia neppure quando capisci che la maliconia nordica dei Delphic è la copia di
quella (autentica) dei New Order. L'album cola come
una glassa indie-dance imbottita di prozac. La ragnatela
di rimandi a Klaxons (il ritornello di Doubt), Underworld (This Momentary) Bloc Party (il remember house di Counterpoint) è facile, servita con cura e nondimeno
pervasa da certe pose "da grande sfoggio d'umanita" à la
Killers.
Saremo anche nel post nu-rave, eppure la sensazione
che si voglia a tutti i costi far sfondare fenomeni che
uniscono la cameretta alla pista da ballo è più di una
intuizione dell'ultim'ora. Si punta troppo su una presunta
generazione fatta della somma di rave e reminiscenze
39
Ottanta. Può darsi, per esempio, che internet non sia
stato soltanto una Fabbrica di Cioccolato illegale. Che
la globalizzazione mediatica non si sia fermata a cose
tipo Future Sound Of London. Che nei 2010 ci si aspetti
qualcosa di diverso del revival delle Converse.
Inoltre è naturale che, più il tempo passa, e più le aspettative vengano tradite, salvo poi il ritorno immediato d'investimento dato dalle classifiche. Se prima sbancavano i
Klaxons e lo scorso anno ci si provava con i Big Pink,
ora si spingono i Delphic. E poco rimane. (5/10)
Edoardo Bridda
Doozer (The) - Great Explorers
(Pickled Egg, Febbraio 2010)
G enere : psych folk
Tempo di sophomore album per The Doozer, strano
tipo originario di Cambridge. Come si evince dal titolo,
si tratta di un bel viaggetto nelle stralunate terre del folk
psych d'antan. Il Virgilio del caso, invisibile ma tangibilissimo, è l'illustre concittadino Syd Barrett, o meglio il
di lui spirito, che aleggia in ogni inflessione balzana, nelle
marcette flosce, tra gli organi caliginosi e lo strumming
sparuto delle chitarrine.
Una devozione itinerante che lungo la strada incrocia altri spiriti affini come ovviamente i Robyn Hitchcock e i
Julian Cope nella versione più frugale ma non per questo meno sciroccata (sentitevi Public Transport o l'iniziale
Nothing Like The Hero). Una
bizzarra solennità (Brother
Lazarus) risponde a certo estro bucolico (i Belle
And Sebastian in pieno
trip anfetaminico di God
Does not Need Light), ma si
fa preferire di gran lunga il
piglio erratico e insidioso
d'una Decisive Mind, che spedisce i primi Floyd dalle parti
dei Jefferson Starship.
Il tipo in questione non è solo un bislacco, nel tempo
libero collabora con tipetti quali Alasdair Roberts e
Animal Collective. In ogni caso, a questo punto ne
sapete abbastanza per esservi fatti un'idea di cosa aspettarvi. (6.6/10)
Stefano Solventi
Elisa Luu - Ipo // 13 (Ipologica,
Dicembre 2009)
G enere : elettronica
Se il primo dei tre brani del vinile non si discostano molto dal Luke Vibert prima maniera, o dalle fascinazioni bbreaking di casa Ninja Tune (D_G), quando s'ascolta
40
Unexpected Attraction si ha la netta impressione che la
ragazza non ci sia soltanto con la tecnica, ma pure con
l’anima analogica che guarda al kraut e ai Dntel ambient
(Unexpected Attraction).
Si discosta dalle prove precedenti, Elisa Luu. Il nuovo
EP, imbevuto in una sorta di nostalgia pop, si muove al
confine tra ambient e glitch, bbreaking e visione. E con
la chiusa Popolar Hit a mescolare frammenti minimal e
ricordi Morr si capisce poure che tra gli 8 bit c’è ancora
spazio per un po’ di romance.
Il giusto compromesso dell’elettronica italo tra melodia
ed effetti, yin e yang. Carriera in salita.(7/10)
Marco Braggion
Eluvium - Similes (Temporary
Residence, Febbraio 2010)
G enere : P op ambient
Matthew Cooper cambia spesso registro tra un disco e
l'altro. Dall'esordio del 2003 con Lambient Material, fino
a quest’ultimo Similes, ha quasi sempre spostato il baricentro.
E’ come se Eluvium esordisse ad ogni capitolo, aggiungendo o limando piccoli dettagli di uno stile che si direbbe tutto suo: un'ambient elettronica tastieristica dai
ricami neoclassici.
In Similes c’è la sua voce ed attorno ad essa un completo restyling degli arrangiamenti, ora incasellati e non
più fluttuanti e magmatici. Una voce che ricorda molto
(e forse troppo) l'ultimo soprendente David Sylvian.
Del resto, Eluvium ha sempre toccato con largo ritardo tematiche precorse da altri: la cifratura pianistica alla
Sylvain Chauveau, i cui Le Livre Noir Du Capitalisme
e Nocturne Impalpable del 2000-2001, già contenevano l’essenza dagli affreschi neo-espressionisti di An
accidental memory in the case of death del 2004;
così come le distorsioni auree di Talk amongst the
trees erano figlie (e sfiguravano) al confronto di quelle
di un Tim Hecker.
Similes inizia con la frondosa quiete di Leaves eclipse the
light, prosegue sui tralicci pianistici della scintillante The
motion makes me last, e tocca la buona combinazione di
pause nella garbata Weird Creatures, fino alla lunghissima
coda di Cease to know, la parte più monotona ed estesa
del disco, e segno che le canzoni non reggono; l’altra
metà il disco sconfina in un ambient da sala d’attesa, innocua e per questo obliabile.
Se fin'ora si potevano sprecare consonanze con Peter Broderick, Gregor Samsa, Max Richter, le note
dell’ultimo Eluvium sono come lo zucchero nel caffé
(tanto zucchero).(5/10)
Salvatore Borrelli
Endorgan - Endorgan (Toxo
Records, Dicembre 2009)
G enere : P ost -M erzbow
Parte con una guerra sfrenata il 3” degli Endorgan,
uscito in contemporanea con l'esprdio parallelo dei
Weltraum sulla loro Toxo Records.
Sintetizzatori da elettronica d'assalto e chitarre preparate con intento massacratorio da coagulare con cangiante combinazione di assalti organizzati per una nuova
forma di rumore totale. Sfrontatezze merzbowniane su
canovacci-trabocchetto dove l'interruzione e l'attesa disegnano interlinee discombaciate ma quasi zen.
Nelle macerie annunciate - e dentro questi suoni che
non hanno più niente della loro origine - sembra si stia
preparando un processo in contumacia alla logica come
noi la conosciamo. Se arrivate alla terza ed ultima traccia
vi sembrerà di udire un riff: si tratta di uno scherzo.
Esperienza dolente Endorgan, ferraglia, elettroastatica e
alienazione; fine del piacere connesso all'oggetto sonoro... ponte verso apocalissi prossime.(7/10)
Salvatore Borrelli
Entourage - Prisma (Seahorse
Recordings, Gennaio 2010)
G enere : grunge / noise / post - rock
Giusti i tempi, il suono e in generale la scrittura. Eppure
l'impressione è che nel disco d'esordio dei messinesi Entourage si sia ricorso a un rassicurante campionario di
suoni ampiamente contestualizzati. Materiale che va dal
grunge/hard del duo Soundgarden/Alice In Chains
di Boom - uno degli episodi migliori di questo Prisma
assieme a Age - alle ballate elettriche Verdena prima
maniera di Lettere moderne, al post-rock onirico di Yoga.
Un fine Novanta americano, per una formazione attiva dal 2001 che ha visto le chitarre urticanti di Seattle
defluire nelle geometrie cerebrali di band come i Tortoise in un tripudio di inner spaces e disagio da cartolina. Passioni giovanili vissute tra bassi possenti, batterie
stratificate, sei corde compresse e una buona capacità di
rielaborazione che garantisce a questo esordio impatto
e convinzione.(6.6/10)
Fabrizio Zampighi
Farmer Dave Scher - Flash
Forward To The Good Times
(Kemado, Gennaio 2010)
G enere : psych - folk & pop - rock
Un piccolo grande sogno (pop) americano. ''Farmer''
Dave Scher, venditore ambulante di noccioline a Venice Beach, fonda assieme ad alcuni amici i Beachwood
Sparks. Da qui, nel corso dei Duemila, di collaborazio-
ne in collaborazione, si costruisce una carriera parallela
come strumentista e produttore al servizio di una pletora di nomi prestigiosi, dagli Interpol a sua maestà Elvis
Costello. Questo è il suo primo disco da solista, uscito
negli USA ad agosto 2009, distribuito solo adesso da noi
via Audioglobe.
Dave è estroso e ironico, con un cantato quasi sempre
sopra le righe, e mostra tutta la sua conoscenza e la sua
passione per gli arrangiamenti kitsch-sofisticati di Bacharach, l'american classic rock di JJ Cale, il cantautorato ironico di Randy Newman, l'r'n'b Motown e il
surf dei Beach Boys, su una base comunque figlia dello
psych-folk westcoastiano. Maggior pregio: i due instant
tormentoni posti in apertura, Bab'lone Nights e You Pick
Me Up. Difetto più evidente: i pezzi psyck-pop-folk si assomigliano un po' tutti.(7/10)
Gabriele Marino
Feeling Of Love (The) - Ok Judge
Revival (Kill Shaman, Gennaio
2010)
G enere : S ynth G arage -B lues
I Feeling Of Love sono, assieme a Cheveu e Crash
Normal, la punta di diamante dell'avant-garage d'oltralpe. Quella che qualcuno chiama pure glue wave, tanto
per non farsi mancare l'ennesimo opinabile nomignolo.
Inizialmente un progetto (semi) solista del cantante/chitarrista Guillaume, i TFOL rilasciano Petit Tu Es Un Hit per
la Yakisakana nel 2008 non facendo mistero dell'amore
per Gories, Doo Rag e
il Jon Spencer più ruvido. Nel lasso di tempo
che intercorre tra il primo e il secondo disco, la
formazione si allarga a tre
membri, con un synth a
dare il groove che mancava
in precedenza. Ne esce un
sound rinnovato: ancora intriganti ipnosi blues (Young Jesus) potenziate dalla line-up attuale (Night Cold Dance) ed
ancora isterismi di casa (Better Than A Dog Detective). Poi
una novità: metà dell'album occupato da tracce più lente,
soffuse, non meno paranoiche o demenziali. Beyond The
Dirt, Going Back To The Nineties, Leader Of The Cops e God
Willing guardano indietro al passato dei Velvet Underground prima e Monochrome Set dopo. Acquisto a
scatola chiusa.(7.3/10)
Andrea Napoli
41
Feldmann - Imaginary Bridge
(Macaco Records, Maggio 2009)
G enere : folk / blues
Un ponte immaginario. Quello che lega il folk astratto
dell'esordio del gruppo Watering Trees all'elettro-folkblues psicologico, onirico ed estremamente razionale
che si ascolta in Imaginary Bridge; quello che fa da punto
di congiunzione tra il Cesare Basile che di quel primo disco fu collaboratore illustre e lo Hugo Race produttore di questo (all'opera, in passato, anche nel Closet
Meraviglia dello stesso Basile); quello che richiama la scena musicale catanese nelle persone di Marta Collica
e degli stessi Tazio “Tellaro” Iacobacci e Massimo
“Loma” Ferrarotti titolari della ragione sociale; quello che parte dalla Sicilia e finisce a mezz'aria, sospeso
tra fermi immagine di un John Lee Hooker mano nella
mano ai Tunng e con un vecchio cappello da cow-boy
in testa.
Perché in questo consiste la formula del duo siciliano:
chitarre acustiche essenziali su ammiccamenti da bottleneck in acido (In The Water), grezze basi elettroniche su
riff smozzicati (Share Your Time), ballads eteree e intimiste (Hour Of Need). Materiale ricettivo ma spietato, nei
confronti di una tradizione americana (Miss I Don't Care)
resa algida da linee melodiche che sono elaborati sussurri - Hugo Race docet - in bilico tra psichedelia e spolverate di jazz. Si perde in immediatezza e sintesi rispetto
agli esordi, si gioca con gli spazi vuoti, ma si guadagna in
pulizia, ordine e raffinatezza, nell'ottica di un prodotto
destinato a svettare nel panorama delle produzioni indipendenti. A patto che non gli chiediate di recuperare
quelli che del blues sono da sempre i tratti distintivi: fascino terreno e indole popolare.(7.2/10)
Fabrizio Zampighi
Fine Arts Showcase - Dolophine
Smile (Adrian, Aprile 2009)
G enere : indie pop
Suscita comprensione Gustaf Kjellvander, cantante e
autore di questa band svedese: per seguire la fidanzata si
trasferiva da Malmö a Londra, dove lei lo scaricava. A seconda del carattere, la maggior parte di noi incapperebbe in una depressione cronica o si abbandonerebbe a un
devastante turbinio di socialità estrema. Gustaf decideva
invece di tornare a casa a scrivere canzoni per esorcizzare l’accaduto, usandole come lettino dello psicanalista.
Ulteriore tassello di un mosaico che nella storia conta
precedenti eccezionali, questo ennesimo viaggio all’interno di un cuore spezzato risulterà particolarmente
gradito a chi si ciba di indie-pop chitarristico anni ’80.
Stilemi Sarah e/o Creation in versione leggera, polaroid
42
scattate dagli Echo & The Bunnymen sotto la pioggia
oceanica e ammiccamenti malinconici a Railway Children e Orange Juice ultimo modello compongono un
piatto diverso dal solito stucchevole paciugo indiesfiga,
che scorre senza particolari picchi ma nemmeno incappa
in esagerazioni melodrammatiche e autoreferenzialità.
Per tutti gli altri, possederlo o meno dipende da quanto
romanticismo gli scorre nelle vene, ma soprattutto dalle
loro recenti vicende sentimentali.(6.6/10)
Giancarlo Turra
Flying Lotus - A Decade of Flying
Lotus (Self Released, Dicembre
2009)
G enere : glitch - hop - tronica
Per festeggiare i dieci di attività (e noi, da bravi italiani, lo
consideriamo ancora un "giovane produttore"), Steven
Ellison aka Flying Lotus ha deciso di fare un bel regalo
di natale a tutti i suoi fan: quaranta minuti di inediti, materiali vecchi e cose più nuove, che altrimenti non avrebbero mai visto la luce. Abbozzi, appunti, spunti e schizzi
accanto a momenti invece perfettamente compiuti, il
tutto mixato ad arte dall'amico Gaslamp Killer (del
giro lotusiano Brainfeeder).
E' uno zibaldone di ambient polverosa, funk, soul,
hip-hop (di marca Madlib
ma soprattutto Dilla), perfino latin, techno desiccata
- che è praticamente dubstep-grime - e ovviamente
wonky, con quei tronicismi
ectoplasmici che spiegano alla perfezione da dove è venuto fuori Nosaj Thing: uno bravo, ma il cui esordio
non è certo il capolavoro descritto da Pitchfork. Il tutto è
incrostato da quella patina bluesy, notturna e (tattilmente) tra la concrezione e l'amniotico che è il marchio di
fabbrica del nostro dopo il capolavoro Los Angeles.
Un golosissimo antipasto di quello che è uno dei dischi
più attesi - almeno da queste parti - del 2010, in arrivo
sulla solita Warp ad aprile, titolo che è tutto un programma: Cosmogramma.(7.3/10)
Gabriele Marino
Forest Fire - Survival (Catbird
Records, Luglio 2009)
G enere : folk
I Forest Fire sono quattro ragazzi residenti in luoghi
sparsi degli States che pare abbiano ascoltato in vita loro
solo i Velvet Underground e lì siano rimasti. Nulla di
male, eppure le nove canzoni di Survival paiono l'esito
highlight
Emily Jane White - Victorian America (Talitres Records, Gennaio
2010)
G enere : folk rock
La ragazza californiana è cresciuta. Puoi quasi toccare la densità del suo songwriting. Che è folk, che si
lascia sottilmente sedurre dal blues, che pesca dai bauli e rosicchia i bordi delle fotografie ingiallite, cercando linfa nell'incedere da troubadour e facendosi un bell'infuso di radici
inestricabili (appalachi, europee...). L'onda neanche troppo lunga del prewar
folk l'ha trovata ricettiva sì, ma non passiva.
L'impressione è che si sia trovata bene con la calligrafia di una Joanna Newsom, ma solo perché complemento importante di un percorso narrativo che
desidera esplorare un patrimonio più ampio, ovvero più diretto e terreno.
Vedi infatti come la title track stemperi suggestioni da camera e cremosità
country, vecchi merletti e front porch. Proprio così: da una parte una The
Country Life che manda mollemente a braccetto Alela Diane con Lucinda
Williams, dall'altra una Ghost Of A Horse che colleziona palpiti in una scenografia orchestral/cinematica.
Con solennità, sì, ma senza mai perdere una franca tenerezza da folksinger indolenzita.
Non potrebbe essere altrimenti con quella voce da sorella morigerata di Cat Power. Comunque capace in Red Dress di spurgare inquietudine composita vagamente PJ Harvey mentre l'organo impazza in
fregola crimsoniana. Un album che impone Emily Jane White tra le più importanti songwriter del momento.(7.4/10)
Stefano Solventi
di una devozione più che un disco vero e proprio. Una
devozione virata folk inacidato e caracollante in I make
windows; votata al calco vocale in Fortune teller (Mark Thresher è più Lou Reed di quanto Lou Reed non sia Lou
Reed oggi); riconvertita al femminile nell'ugola angelicata
di Natalie Stormann nell'apice della mattutina Sunshine
city; infusa di elettricità umorale nell'istantanea Promise. E solo saltuariamente spruzzata da sentori Beatles
(Through my gloves, Steer me) e nient'altro.
I quattro si sono trovati di tanto in tanto tra New York
e Portland per registrare queste nove tracce. Probabilmente è stata soprattutto una rimpatriata tra amici, ma
non era forse così necessario sigillarla su disco.(5.3/10)
che sposa trance e cosmica in un sol colpo, Stereo vale
sicuramente una menzione particolare. Sul lato opposto,
Extinction esplora galassie sempre più scure muovendo
tra kraut e drone music. Più in generale se le preferenze del produttore francese cadono spesso su una nazi
techno a diverse velocità (e onde radioattive sempre più
nefaste), si rimane sempre sui bordi giusti senza cedere
nelle facili banalità del caso.
Attivo da più di dici anni anche sotto il nome di Electronicat, Bigot è sicuramente il rocker del noise analogico,
l'anti intellettule da appuntarsi al petto nel club di fiducia.
Poi è semplice ed efficace come un Neu! 2 all'inferno, che
volete di più? (6.7/10)
Luca Barachetti
Edoardo Bridda
Fred Bigot - Mono / Stereo (Holy
Mountain, Novembre 2009)
G enere : A nalog noise , techno
Galactic - Ya-Ka-May (ANTI-,
Febbraio 2010)
G enere : meticciato funk
Se avete nostalgia del lato più grezzo (leggete noise
analogico spinto) e tecnoide della produzione dei Pan
Sonic, oppure siete in cerca di un Mika Vainio senza
troppe visioni tubolari indotte da frequenze paranoidi,
Fred Bigot potrebbe essere un'idea, non formidabile, ma
frequentabile e forse persino geniale.
Con gli oscillatori appalla e un loop metallico modulato
I Galactic di Stanton Moore proseguono nella direzione già indicata da Ruckus, strumentale prodotto da
Dan The Automator, e soprattutto da From the Corner
to the Block, disco in cui avevano ospitato alcuni rapper
più o meno di culto (vedi il Mr. Lif del giro Definitive
Jux).
Qui ospitano nomi storici e astri nascenti della scena
43
di New Orleans, provenienti tanto dal jazz, dal funk e
dalle brass band, quanto dal bounce (il rap aggressivo e
appiccicoso che va tanto forte da quelle parti). Alcuni
pezzi spaccano senza appello, su tutti il Prince che rifà
Stevie Wonder (o viceversa?) di Bacchus, assieme alla
leggenda vivente Allen Toussaint (non è un caso che i
nostri siano cresciuti a pane e Meters), e il languido e
torbido funkblues sottopelle di Speak His Mind, col veterano Walter "Wolfman" Washington.
Il resto si divide tra ottima routine funk & dintorni (per
dire, nella jamesbrowniana You Don't Know si sente quel
grassume funk che spesso manca alla Breakestra), con
in più la carta dell'ospite di lusso (Irma Thomas, Big
Chief Bo Dollis), e pezzi rappati che sono invece la
parte debole del disco, abbastanza confusi, a tratti francamente tamarri, come alla rincorsa a-tutti-i-costi dello
stile bounce (che, per inciso, scopre sorpendenti affinità
con certe sfumature ragga-grime).
Sprazzi di goduria funk da gestire meglio.(6.6/10)
Gabriele Marino
Georgia Anne Muldrow - Early
(Animatedcartunes, Novembre
2009)
G enere : soul
Un 2009 positivamente prolifico - la raccolta di produzioni a nome Ms. One, il secondo album Umsindo (bellissimo, ma che pure lasciava sperare qualcosa di più), lo
spigoloso Holy Smokes del compagno di vita Dudley
Perkins (da lei musicato) - Georgia vuole chiuderlo in
bellezza, pubblicando dieci pezzi scritti e registrati secoli
fa, primissimi anni Duemila, quando aveva tra i diciassette
e i diciannove anni.
Si tratta di ballad voce, piano & batteria totalmente immerse in un mood soulful (con punte praticamente gospel) sonnacchioso, fragrante e pulviscolare, come un
raggio di sole mattutino che filtra dalle finestre attraverso le tende. Una early Georgia già sorprendentemente
matura nell'interpretazione vocale (già padrona dei suoi
sbilenchi saliscendi), influenzata dalla Badu - e questo lo
sapevamo - ma soprattutto da Lauryn Hill, concentrata
sulla forma-canzone e su testi generosamente naif, poco
interessata invece a trick
produttivi, meno dispersiva
di quanto non sia oggi, più
asciutta, anche se necessariamente meno decisiva e
attuale (e non perché i pezzi abbiano ormai quasi dieci
anni). Nondimeno, una Georgia affascinante.
44
Disco dichiaratamente minore (artigianale, domestico,
acerbo), che illumina - se mai ce ne fosse stato bisogno,
vedi il capolavoro Roses su Umsindo - il lato squisitamente cantautoriale della donna. Ma, soprattutto, un disco
con alcuni pezzi di una bellezza abbagliante. In arrivo,
tanto per non smentirsi in prolificità anche per il 2010,
un Kings Ballad annunciato come il suo disco "più pop"
di sempre.(7.3/10)
Gabriele Marino
Gigi - Maintenant (Tomlab DE,
Dicembre 2009)
G enere : pop
Nick Krgovch è persona che ci accorgiamo di conoscere
non appena citiamo No Kid e P:ano, le band di cui fa
parte. E, in qualche modo, Mainteinant si basa su una
familiarità, sul sentito dire, in un certo senso sulla vanità
dell’ascoltatore: si nutre cioè della schiera di ospiti che
accoglie nei brani, da Owen Pallett a Rose Melberg,
da Zac Pennington a Karl Blau.
Nick ha deciso di dedicare i ritagli dei suoi ultimi quattro anni per confezionare un raffinatissimo omaggio nello stile dell’originale - al Back To Mono Box Set,
cioè alla famigerata raccolta di produzioni pop ad opera
Phil Spector dai primi Sessanta. Per questo motivo ha
chiamato a raccolta amici cantanti e musicisti, aiutato da
Colin Stewart per produzione, registrazione e missaggio.
Mainteinant, a nome Gigi, ne è il risultato, nello spirito
dei grandi dischi di pop orchestrale fuori dal tempo.
Per l’ennesima volta, ci troviamo a ripetere la stessa formula, che prima o poi diventerà un nucleo concettuale
su cui organizzare una lettura a scala più ampia: l’etichetta di musica indie-pop collettiva. Eppure in un modo diverso - e probabilmente più banale - da quello più volte
sottolineato, negli ultimi mesi: il respiro di queste canzoni prende aria dai polmoni degli ospiti, che portano la
propria personalità, appunto, diventandone quasi gueststar. Lo sentiamo in Dreams Of Romance, nell’ingombro
del timbro del leader dei Parenthetical Girls, come
nelle peculiarità arrangiative “alla Karl Blau” di Strolling
Past The Old Graveyard. Eppure lo spirito pop, della citazione del maestro, prevale sull’autorialità: la missione
“spectoriana” è fissa nella mente, ed è questo il nucleo
collettivo della faccenda, che ci dice qualcosa sul mondo dell’indie, sulla sua ricerca, sui suoi riferimenti. Tutto
dentro a un banchetto sofisticato, dove si mangia e beve
bene, ma non ci si ubriaca.(6.5/10)
Gaspare Caliri
Gioacchino Turù/Vanessa V. - Il
crollo della stufa centrale (From
Scratch, Settembre 2009)
G enere : anti - pop
Di questi due dovremmo dire che non stanno bene. Che
hanno esagerato, chissà se col cattolicesimo o le droghe,
alla fine gli effetti sono gli stessi. E che si sono chiusi in
casa a scrivere canzoni degenerate come loro ma che,
comunque sia, noi non siamo abbastanza reazionari per
togliere il disco dal lettore dopo due tracce. Perché l'anti-pop è un gioco bello finché dura poco, altrimenti è la
standardizzazione della follia, la rottura che cannoneggia
gli attributi, il demenziale che si fa all'istante derivativo.
Quando non sai se sia cialtroneria o genio ma in fondo non te ne frega niente, visto che alla traccia quattro
hai già capito cosa succederà fino alla quindici. Eppure a
Gioacchino Turù e Vanessa V. le idee non mancano.
Lui fa la figura del fuori di testa, ma meno che ai tempi
di C'è chi è morto sul Tagadà, di cui questo disco
riprende alcune tracce. Lei sembra soprattutto assecondarlo, per darci a intendere allo stesso modo che il TSO
non le servirebbe a niente. Il resto è un prontuario di
tastierame volutamente scarso, beat ridotto ad ossa di
gomma, ritmiche elementari, melodie anche, e ovviamente una voce sguaiata, anzi due, per testi tra il lirico da
cameretta e lo sboccato comico da camerata manicomiale. Lego lagher come Tricarico che si fa produrre
da Casiotone For The Painfully Alone. Marco Prandi e Yann Tiersen in trip 8 bit. Manovale ovvero Rino
Gaetano ai tempi del fallimento del multiculturalismo.
Spongebob legge Magret mentre Beck violenta quattro
accordi blues con variegati scaracchi elettronici. E Merenda con gli Altro in techno spolpata.
Ma che noia, non le canzoni in sé - lo ripetiamo: le idee
non mancano - ma proprio l'estetica che ci sta a monte
e che imbriglia tutto in un forzato bordello psichiatricodomestico-sessuale che non fa ne ridere ne piangere. A
parte due tracce che potrebbero aprire un futuro favorevole alla poesia e contro la stupidità - Tagliati i seni immersa in synth fluidiformi e il Daniele Brusaschetto
crepuscolarizzato di Libreria museo brucia - qui per ora si
gioca solo alla sinapsi malandata. E narcolettica.(5.7/10)
Luca Barachetti
Grievous Angel - Dusk +
Blackdown Vs. Grievous Angel Margins Music: Redux (Keysound,
Novembre 2009)
G enere : world - step
Grievous Angel, su richiesta esplicita via telefonata notturna, riprende in mano e dà nuova vita al disco del 2008
dei boss di casa Keysound Rec. In mancanza di definizioni
migliori, avevamo bollato la sorgente del remix con il tag
expat-step, per sottolineare la definizione di una possibile alterità che fuggiva dal dubstep primigenio, strettamente intessuto nel suburbio sonico londinese, verso
lidi di contaminazione con suoni world.
Il ritorno sulle coordinate extra UK da parte del produttore di Sheffield mescola i suoni dei due archeologi
e li innesta con il beat laserizzato e pulsante del south
end. Un trattamento che
ci riporta al movimento e
toglie quella patina di intellettualismo che probabilmente cercava riferimenti
inesistenti. Il world-step
remixato senza esagerare (come spesso fa invece
Toddla T) si ascolta senza
problemi e la bilancia non pende mai verso l’acido o verso il banghra. Un concept remiscelato seguendo le orme
di padri nobili del calibro di Coldcut o Bill Laswell. Meglio dell’originale.(7.3/10)
Marco Braggion
Grouper/Roy Montgomery - Split
(Self Released, Gennaio 2010)
G enere : drone soundscapes
Gli split ep devono piacere parecchio a Liz Harris se
è vero che quest’ultimo parto condiviso con il buon
vecchio Roy Montgomery si va ad aggiungere ad altre collaborazioni avute in passato con Xiu Xiu, Inca
Ore, Pumice, City Center e Xela. Una vera promiscua la bella Liz, ma quest’ultimo lavoro in particolare
desta maggiore interesse, non foss’altro cje per sentire
di nuovo la chitarra di Montgomery all’opera. La sorpresa amara sopraggiunge però subito quando si capisce
che la traccia che occupa tutto il primo lato del 12” altro
non è che un’altra variazione dello stesso brano presente sulla mitica antologia Harmony Of The Spheres,
ovvero un’altra variazione live di Fantasia On A Theme By
Sandy Bull.
Quanto a Grouper, quello che mette sul secondo lato di
questo split è l’intero ep denominato Vessel che raccoglie le sue ultimissime composizioni. Tolta la prima e l’ultima traccia che hanno un eccessivo profilo di corredo
nel loro taglio strumentale, l’interesse è tutto per le due
canzoni vere e proprie: Vessel e Hold The Way. Due “song”
effettive che testimoniamo lo stato dell’arte della musicista di Portland, che sembra ormai arrivata ad un’asciuttezza rarefatta e suggestiva, a tratti quasi liturgica, con
più di qualche venatura medioevale. Difatti entrambe le
45
highlight
Field Music - Measure (Memphis Industries, Febbraio 2010)
G enere : pure pop
Una vicenda non lunga quella dei fratelli Brewis, però ricca di eventi e dimostrazioni di talento. Due i
dischi che - in particolare Tones Of Town - li segnalavano discendenti della stirpe pop britannica di alto lignaggio, che risale agli Albarn e ai Partridge, a Beatles e Zombies. Superlativi per una volta spesi a ragion
veduta e in mezzo una pausa necessaria, tre anni spesi a ripensarsi come gruppo e autori, tirando il fiato
con progetti paralleli carini ma non destinati a restare. Sospettavi che ci fosse
qualcos’altro, un confondere le carte preparando il terzo disco risolutore.
Che affrontano come hanno affrontato il recente passato: a testa alta e mente sgombra, più del solito liberi di infilare se stessi in un cesto (colmo: ben
venti) di canzoni. Secondo logica, queste restituiscono l’importanza del momento nell’aspetto misurato tuttavia prezioso, nella loro essenza policroma.
Va difatti benissimo allorché - causa la defezione del tastierista Andrew
Moore - fanno leva sulle chitarre e asciugano le strutture, ché la sagacia
compositiva appartiene a un English Settlement (Choosing Numbers, Curves Of
The Needle) corretto da Drums And Wires: ecco una perfetta Clear Water e la meditativa You And I; ecco una
Each Time Is A New Time che apre surrealismi blues-rock alla dolcezza e le acrobazie di pieni e vuoti in All
You’d Ever Need To Say.
Quanto il passo sia sicuro, però, lo comprovano gli episodi in cui si osa come la sublime title-track, saltellare tra Albi Bianchi e archi, acusticherie e prati estivi; come Precious Plans, profumo di Aztec Camera
fanciulli che sostituiscono il santino di Arthur Lee con Brian Wilson; come l’inquietudine notturna
che avvolge Lights Up. Ed è solo la punta di un iceberg contro cui siete invitati a naufragare in allegria per
centellinare ogni dettaglio. Metamorfosi matura e sublime che rimane modesta solo nel porgersi, degna di
artisti che “non furono fatti per questi tempi”.(7.5/10)
Giancarlo Turra
canzoni hanno il piglio del lied romantico, tra riverberi
centellinati e canto mai così pulito e rifinito. Due capolavori, soprattutto Hold The Way che va di pari passo con
il suggestivo video: canto lunare su un tessuto bianco e
nero innevato e impalpabile e con un tappeto di frasi
oniriche di un Rhodes che sembra arrivare direttamente
da Carnival Of Souls.(7/10)
Antonello Comunale
Higuma - Den Of Spirits (Digitalis,
Gennaio 2010)
G enere : drone apocalypse
Da una costola dei Barn Owl si staccano gli Higuma, ovvero Evan Caminiti e Lisa McGee, già avvistati un paio di
anni orsono con il promettente Haze Valley e che ora
danno alle stampe il secondo album per la nicchia in vinile
della Digitalis Industries. Titolo e copertina (artwork di
Evan stesso che richiama “l’Isola dei Morti” di Bocklin…)
fanno capire subito che aria tira da queste parti, qualcosa
di ovviamente assimilabile alla band primaria, ma con il
suo profilo ben netto e delineato. Ergo un nuovo rosa46
rio di apocalypse drones da ultimatum alla terra, che non
prende prigionieri se non gli spiriti: l’ambient congelata di
Glacial Tongues, prepara il terreno dell’excursus soprannaturale di The Ocelot, un ritmo tribale alla Natural Snow
Buildings con vocal drones e chitarre riverberate in
delay cosmico. Musica che oscilla tra la stasi instabile di
Hexed and Vexed e la liturgia eterna di Hathor’s Dance, tributi impalpabili ai mantra ascetici dei Popol Vuh. Da qui
l’avveniristica passeggiata krautedelica di Sun Crown, tra le
migliori cose ascoltate negli ultimi anni nel settore drone
e derivati, a cui si aggiunge l’irreale stasi armonica di Are
You Nobody Too? in lenta e pigra processione per aprire
finalmente un prezioso scrigno di rapimento cosmico. Gli
Higuma sono usciti dallo stato larvale e si sono trasformati in una splendida farfalla.(7.5/10)
Antonello Comunale
Hikobusha - Dinosauri
(Motherfuckart, Gennaio 2010)
G enere : wave / trip - hop / canzone d ' autore
Hikobusha, ovvero “vivere con la morte dentro”. Soprat-
tutto dalle parti di Hiroshima e Nagasaki. A trascinarci in questo esordio della band di Davide Gammon
Scheriani, Stefano Maurizio, Strix Silverii, Antonio Colombini e Paolo Zangara - già Lo.Mo - , una
new-wave “patternizzata” trip-hop che aspira evidentemente a conquistare lo spessore autoriale di certa tradizione autoctona. Uno scenario decadente e conflittuale
come non se ne sentivano da un pezzo, figlio di ruvidezze oscure à la Portishead e di una Mute Records ante
litteram, dei Depeche Mode meno avventurosi e dei
La Crus. Da quest'ultimi i Nostri ereditano approccio
serioso e aspirazioni colte, col pallino di aggiornarle di
qualche anno e di farle star
dentro ai canoni di un rock
che non disdegna la chitarra elettrica.
Le cose migliori si ascoltano quando a prendere il
sopravvento sono la canzone d'autore (Terra di risa e
sgomento) e il trip hop (Libero arbitrio), mondi piacevolmente - e inaspettatamente
- confinanti tra cui la new wave fa un po' da collante.
Per una scrittura dettagliata che perde smalto quando si
addentra in un citazionismo di forma (Scarafaggio Elvis,
La danza delle ossa) e si esalta nelle parentesi meno
convenzionali (Malastreada, Il sapere del sangue, Angelo tra
noi).
Un disco dai buoni contenuti dove è soprattutto la parte
suonata a emergere. Il che significa che forse non tutti gli
obiettivi di partenza sono stati raggiunti.(6.8/10)
Fabrizio Zampighi
HiM - ん (HipHipHip, Gennaio
2010)
G enere : afro post - rock
Continua a circumnavigare il globo musicale Doug
Sharin/HiM, con una regolarità impressionante per quello che dovrebbe essere (o almeno era) un progetto collaterale. L’ex batterista di June Of 44, Codeine, Rex e
mille altri ancora stavolta approda sulle rive del lontano
oriente con ん, titolo al limite del mistico visto che in giapponese suona come qualcosa di simile a
hmmmm.
Sorta di esclamazione di piacere che ci ritroviamo inconsciamente a imitare all’attacco di Creode: dubbone
plastico, mobile e iper-ritmico (a dar man forte a Sharin
c’è il percussionista nippo Shinpei Okaya) impreziosito
egregiamente dalla voce di Ikuko Harada. In due parole, come un afrobeat alle pendici del monte Fuji. Sensazione reiterata, stavolta senza propulsione ritmica, nella
sensualissima Other Echoes, haiku delicato e sospeso che
certifica lo spostamento dell’interesse di HiM verso il
Giappone, dove guarda caso il grosso delle composizioni
è stato registrato. Le basi solide del suono HiM sono
e restano però sempre alla convergenza tra post-rock
strumentale di gran classe e afro-beat potente e cangiante e le suggestioni orientali fornite dai numerosi ospiti
dagli occhi a mandorla non fanno che screziarlo ancor di
più e fornire un ulteriore piacevole tassello al vagabondaggio di Sharin.(7/10)
Stefano Pifferi
Hot Chip - One Life Stand
(Parlophone, Febbraio 2010)
G enere : electropop tamarro
Giunti al quarto disco, in quest'incredibile mix di maturità e svendita, gli Hot Chip quasi non li riconosci.
Piuttosto che alle solite wave, hanno deciso di calcare
fino in fondo una propria via agli Ottanta sia cercando
di guardare quelli "contro" del maestro Robert Wyatt
sia mettendo il naso in qualche anfratto mutant disco
(One Life Stand) o early house (We Have Love). Sulla carta
soltanto applausi, ma che succede quando dal coraggio di
osare si passa alla voglia di strafare abbracciando un immaginario che va da certo Jimmy Sommerville, passando
per l'imprescindibile Antony degli Hercules Love Affair (We Have Love), approdando persino ai lidi più bonari (I Feel Better, Brothers) della puerile estetica Killers?
E' il risultato terribile di un album dal nerbo comunque
salvifico avvitato com'è attorno a un (white) soul pop
funzionante quando i ragazzi ci si affidano completamente (il grandioso singolo Alley Cats, l'ispirata Keep Quiet),
diverte quando giocano la carta nerd (il vocoder cartoon della rockisch Hand Me Down Your Love con un bell'inserto da lacrimuccia); e fallimentare nel resto dei casi, ad
esempio nella kitsch disco krauta di Thieves In The Night,
nel citato buonismo natalizio di Brothers; pur salvandosi
in corner con la superballatona blues da accendini (Slush
con alla batteria Charles Hayward dei This Heat).
Una classe ancora papabile e viva dopotutto.(6.5/10)
Edoardo Bridda
Idlewild - Post Electric Blues
(Cooking Vinyl UK, Gennaio 2010)
G enere : folk rock
Sempre più imbevuti d'America gli scozzesi Idlewild, fanno con questo Post Electric Blues un deciso salto nei
lanscapes sonici d'oltreoceano, ferma restando l'irruenza
intrigante e innodica che li contraddistingue. Mai come
oggi sono sembrati una costola ora soffice ((The Night
Will) Bring You Back to Life) e ora scoppiettante (Dreams
47
highlight
Get Well Soon - Vexations (City Slang, Gennaio 2010)
G enere : songwriting , pop orchestrale
Dietro al moniker Get Well Soon troviamo una vecchia conoscenza, ovvero il tedesco Konstantin Gropper, due album all’attivo su City Slang compreso Vexations. Fatto il botto in Europa nel 2008 con l’esordio
Rest Now,Weary Head, un connubio tra pop orchestrale, elettronica, folk e classica, con un’impronta di
artigianato fortemente DIY, il multistrumentista si ripresenta con un sophomore album concettualmente elaborato, un concept sullo stoicismo.
I cambiamenti dal punto di vista musicale ci sono e sono evidenti: dalla relativa solarità musicale precedente si passa ad una struttura piuttosto sofisticata basata su pop orchestrale e influssi classici, ampiamente arrangiata
e registrata con un quartetto d’archi e una sezione fiati. Gli ingredienti alla
base della musica di Get Well Soon ci sono tutti, in Vexations vengono
spinti maggiormente verso orchestrazioni compatte che procedono per accumulazione, senza per questo essere sovrabbondanti, con il consueto gusto
estetico impeccabile e una spiccata sensibilità indie.
Rimangono qua e là le tentazioni klezmer tipicamente Beirut, una sensibilità melodica vicina a Leonard
Cohen ma anche a Thom Yorke e a Patrick Wolf, con l’influsso di tanta musica da film, da Ennio
Morricone in giù; Gropper è infatti anche compositore di colonne sonore, l’ultima alla quale ha collaborato è infatti Palermo Shooting di Wim Wenders (2008).
In sostanza registriamo l'album come un ritorno significativo per il tedesco, una promessa già mantenuta.(7.3/10)
Teresa Greco
Of Nothing) dei R.E.M., per non dire di come cavalchino la voglia di ballatone (Take Me Back to the Islands) e
persino AOR in odor di power pop (Post Electric, Younger
Than America).
Ma è un forzare le redini e infatti accadono strane distorsioni stilistico/geografiche, come lo Springsteen altezza Human Touch mischiato alla baldanza Codlplay
di Readers & Writers, oppure i palpiti Jackson Browne
pennellati da tremori U2 della conclusiva Take Me Back
In Time. Un ibrido non del tutto risolto, incoerente ma
entusiasta, prevedibile ma generoso. In fondo, può andare
bene così.(6.2/10)
Stefano Solventi
Irrepressibles (The) - Mirror
Mirror (V2 Music, Febbraio 2010)
G enere : O peretta pop
Sulla scia dei Wild Beasts, e più in generale giù per la
china di uno dei vizietti rock preferiti (l'operetta), il debutto dei londinesi Irrepressibles aggrega (esasperandoli) i modelli più prossimi prendendo dell'Antony le pose
più branderburghesi e del principino Patrick Wolf la
prosopopea in costume.
Guardandoli in faccia questi quattro ragazzi sepolti sotto
48
dita di trucco e banchetti seicenteschi, capisci che non
sarà facile addentrarsi negli innumerevoli cambi d'abito
à la Phantom Of The Opera. Jamie McDermott ha dalla
sua un'attenzione particolare al giovane Scott Walker
e riesce a condire il menù con una punta di Tony Hadley
con il Jeff Buckely più lirico. Eppure, troppo debitrice
delle intuizioni di Antony, la sua musica necessita ancora
di una performance visiva che aggiunga peso. Il sound
non basta, e quando convince abbiamo pop song appena
sufficienti (Nuclear Skies).(6.4/10)
Edoardo Bridda
Jack Rose - Luck in the Valley
(Thrill Jockey, Febbraio 2010)
G enere : fingerpicking
Ebbi modo d’incontrarlo Jack Rose. Uno squallido organizzatore, durante quel tour, l’aveva abbandonato sugli appennini tosco-emiliani a piedi, e con la chitarra sulle spalle.
Jack se l’era fatte tutte quelle vallate per suonare la sera
stessa. Nonostante le gambe gli duolessero, le mani scivolavano sullo strumento con la stessa soprendente lentezza
di un treno dell’Alabama degli anni trenta visto dagli occhi
di un bambino di colore. Era inconfondibile quello stile
blues pieno di tecnica mai così discretamente nascosta.
Morire a 38 anni improvvisamente è qualcosa a cui non
ci si abitua. Lasciare un’eredità nell’olimpo dei chitarristi
visionari è un dono che solo pochi illuminati possiedono.
Il Jack Rose che conobbi si muoveva come un guerriero
solitario nella notte, impugnava la chitarra come un’arma segreta. Sapeva di essere al centro di una trappola:
le distese infinite dei campi di grano di John Fahey, e
le combinazioni misticheggianti di Robbie Basho. Jack
Rose si trovava nel loro mezzo come in una bufera: li mescolava, utilizzava le ritmiche del primo sulle scale raga
del secondo, ma la sua musica si privava del misticismo
dei suoi padri spirituali
In Luck in the valley avviene
proprio questo incontro
combinatorio, ora Fahey
(ma senza punteggiatura
scandita), ora Basho (ma
senza rimandi religiosi).
Uno stile di lente progressioni, a volte irregolari, perlopiù sanguigne, sempre precise e filologicamente corrette.
Luck in the valley non sembra il disco di uno che sapeva
di morire, non è un epitaffio, e nemmeno un compendio
definitivo. Era ed è semplicemente un altro disco di Jack
Rose, che anche stavolta, slittava un pizzico più in là, verso una forma più cangiante ma comunque attenta alla
riscoperta della prewar folk music, con lo stesso piglio
catalogativo di Harry Smith o di Alan Lomax (c'è
anche una cover di Blind Blake).
Diviso esattamente in due ambiti, che azzardando, si potrebbero ritenere forse frutto di una scelta della Thrill
Jockey più che del Rose: uno freak-free-folk paganeggiante (e quindi sulla stessa via di molti episodi recenti di
Sir Richard Bishop), l’altro hillbilly e country (e queste
sembrano più delle sessioni, registrate quasi amatorialmente, che veri e propri brani concepiti per convivere
con la parte più solitaria dell’opera). È dunque lecito
pensare Luck in the Valley come l'incontro di due ossature, le stesse che Rose divideva in proprio e con i Pelt,
due modi d’intendere il lavoro sullo strumento, quello
sommesso e solitario, e quello festoso e corale. Sarebbe
inutile citare un brano in particolare, visto la differenza
degli episodi scritti in 9 mesi durante i quali si svolse
l’ultimo grande tour di Jack Rose.(7.5/10)
Salvatore Borrelli
Jaga Jazzist - One-Armed Bandit
(Ninja Tune, Febbraio 2010)
G enere : post jazz
Che l’elettronica di stampo ‘90 non fosse più in cima
alle preferenze del combo norvegese lo si era intuito
dal precedente What We Must. In fondo, tante cose sono
accadute dal debutto ad oggi e la consapevolezza di quel
jazz espresso sin dalla ragione sociale, ora trascende
Aphex Twin armonizzandosi alla composizione europea
con un pizzico di afro-beat.
A dircelo è Lars Horntveth, uno con tanta musica in corpo da poterne vendere che definisce One-Armed Bandit
come una crasi tra Fela Kuti e Wagner. Premessa credibile di una album che offre tanto altro come dei Weather Report proiettati su marte (Banafleur Overalt ) o
dei Motorpsycho più forbiti (Book Of Glass).
Grazie anche a John McEntire, c’è sicuramente una
nuova, diversa, veduta prospettica e il minimalismo portato nel combo da Horntveth, palese in brani come
Toccata (palesemente ispirata dal Reich di Music for 18
Musicians) e Touch Of Evil, dà quel contributo in più per
la quadratura del cerchio. Una big bang mai così totale.(7.3/10)
Gianni Avella
Jean Binta Breeze - Eena Me
Corner (Arroyo, Gennaio 2010)
G enere : dub poetry
Potrebbe sembrare un azzardo consigliare ai non specialisti in materia un disco come questo. Non lo è, in ragione del fatto che per un’ora, la calda voce della cinquantatreenne poetessa di Kingston scorre agile e intensa
su basi minimali epperò solidissime, frutto dell’incontro
tra due generazioni di produttori. Di due mondi, per di
più, essendo le menti musicali dietro l’operazione il mito
vivente Dennis Bovell - tondo, magnetico e sensuale il
suo basso - e il pisano Marzio Aricò a/k/a Prudo.
Più giovane, questi porta in dote l’asciuttezza di talune
declinazioni del verbo dub secondo la techno, allestendo
trame sonore attorno alla potenza evocativa di parole e storie (i testi sono riportati integralmente e tradotti nella nostra lingua, rimarcando l’impegno profuso
nell’operazione) con lo scopo, centrato, di fondersi con
essa. Di accentuarla, anche, e aggiungere un tassello il
più possibile attuale (magari tramite l’epidermica Mother
Africa) a un aspetto importante della musica in levare.
E’ un lavoro per niente monotono, allora, costruito di
volta in volta attorno a sottintesi e atmosfere suggerite più che sovrimposte (Grandfather’s Dreams) oppure
a un’elettronica lanciata in rifrazione contro la propria
immagine (Dawn).
A raffinatezze che si aprono rigogliose (Mermaids), a profondità degli incastri (Aid Travels With A Bomb) e dell’insieme (Third World Blues). Non ci si rende conto che il
punto d’inizio siano state le registrazioni “nude e crude”
49
della Breeze tale è il calore umano che promana dal disco (apice una fluviale Testament che fonde con fierezza
antico e moderno) ed è paradosso tra i più azzeccati.
La presenza di un bel pezzo del nostro paese, poi, ce ne
rende ancor più appagati.(7/10)
Giancarlo Turra
Josh Rouse - El Turista (Bedroom
Classics, Marzo 2010)
G enere : pop da cartolina
Ne succedono di cose strane: songwriter di buon successo e discrete capacità, Josh Rouse ha deciso di cantare un album di brani in spagnolo. Nulla di particolarmente sconvolgente, non fosse che il ragazzo è nato in
Nebraska e il disco viaggia
leggero e solare su una confusione sonora che con i
nostri cugini più a ovest ha
poco a che vedere. Josh si è
trasferito a Valencia con la
moglie iberica cinque anni
fa, di conseguenza un titolo
come “il turista” restituisce
l’osservazione dall’esterno di una cultura più che l’immersione al sui interno. Aggiungete il fatto che alcune
tracce sono state incise a Nashville e l’idea ha preso corpo a Brooklyn ed ecco comporsi un mosaico spontaneo
ma, soprattutto, casuale.
Senza la “progettualità” di un David Byrne, manca qualcosa che tenga assieme ironia a passo di afro-cubana e
clonazioni del Paul Simon “etnico” anni ‘70, la regolamentare bossanova jazzy e il pop glassato d’archi. Risultato in ogni caso gradevole che - con l’eccezione di un
paio di ottimi azzardi come il traditional Cotton Eye Joe
riletto alla Burt Bacharach e una Don't Act Tough tesa
e leggiadra - riflette l’estemporaneo svago dei villaggi vacanze. Quell’impressione che, al di là del recinto che ci
tiene al sicuro, le cose siano poco confortanti ma vive. El
Turista diverte per i trentasei minuti che dura; dopo di
che, se ne esce dalla stanza che manco t’accorgi. Chiamala, se vuoi, eccentrica tappezzeria.(6.5/10)
Giancarlo Turra
Kabyzdoh Obtruhamchi/
Michael Jantz - Bouts-Rimûs
(Sturmundrugs, Dicembre 2009)
G enere : psych
Weird flowers, strange fruits è il motto rivelatorio della
Sturmundrugs, nuova etichetta di Donato Epiro. E mai
frase fu più azzeccata, almeno a giudicare dalla prima
uscita. Ad inaugurare la label salentina è, infatti, la colla50
borazione a distanza tra Michael Jantz (a.k.a. Black Eagle Child) e Kabyzdoh Obtruhamchi, nom de plume del
russo Sergey Kozlov.
In un’unica, lunga traccia da oltre un’ora suddivisa in 6
movimenti ed incastonata in una bellissima edizione fatta
a mano, Bouts-Rimûs muove da una sorta di psichedelia d’accatto - slanci mediorientali e suggestioni psych-folk su un qualcosa vagamente simile a Sun Araw,
Magic Lantern et similia - per arrivare ad una specie
di rituale pagano, orgiastico e devastato nel finale, prima
di spegnersi in un freak-folk arabeggiante ed evocativo.
Nel mezzo ci si incanala, di volta in volta, verso droning
rituale, percussivismo acceso di matrice industriale e
psichedelia folkish sommessa, senza perdere il bandolo
della matassa né il fluire magmatico della musica.
Un vero e proprio tour de force da alterazione dello
stato di coscienza.(6.9/10)
Stefano Pifferi
Kitty Solaris - My Home Is My Disco
(Macaco Records, Febbraio 2010)
G enere : indie
Con un titolo My Home Is My Disco ti aspetteresti come
minimo un'elettronica in stile berlinese. E invece Kitty
Solaris, bionda artista tedesca con una terna di produzioni alle spalle, è quanto di più lontano ci possa essere dagli
algidi patterns di un laptop. Anche perché l'immaginario a
cui si ispira pone solide basi nella new york stradaiola dei
Velvet Underground, nei Novanta alternativi di P. J.
Harvey e in una vena pop minimale da loser. Fusione di
stili che scova mezze luci e obliquità tra chitarre elettriche pulite, bassi, vibrafoni, batterie da home recording e
tastiere, per dar vita a un indie rock della porta accanto
capace di piccole ruvidezze (la Harvey di Kisses Lift Me
Up) come di certe Sunday Morning più intimiste.
Un disco che funziona al di là dei voluti limiti formali,
grazie anche a un apprezzabile basso profilo.(6.8/10)
Fabrizio Zampighi
Local Natives - Gorilla Manor
(Infectious, Febbraio 2010)
G enere : wave art folk
Quintetto texano - da Silver Lake - al debutto, i Local
Natives s'infilano agili e oserei dire soavi tra i solchi
weird folk e tribal-wave che informano tante propaggini
alternative d'oggidì, col merito di sfuggire ad entrambe
le categorie abbozzando un pop evoluto che dovrebbe
fare la gioia di tutte le playlist meno banali. Possiedono una affabilità cristallina patinata di esotismi (sintetici
e non) che viene naturale far risalire al post-punk più
abboccato, pur sempre covando però una trepidazione
percussiva che rimanda ai nonni Talking Heads (di cui
non a caso rileggono Warning Sign) via Grizzly Bear,
cui si aggiunge spesso un pizzico di enfasi Arcade Fire
(sentire il singolo Airplane per credere).
Pure scomodando link variegati e vieppiù nobili (dai Beach Boys strattonati Go-Betweens di World News al
Patrick Wolf ingentilito Rufus Wainwright di Stranger Things, passando per i CSN&Y in fregola soul di
Cards And Quarters e da una Sun Hands che sembra quasi
i Tears For Fears in bilico tra languore e acidità) non
danno l'idea di volersi spingere troppo avanti sul terreno
della ricerca, della sintesi di cose nuove. Il loro è pop
appunto che si mantiene aperto a molte possibilità (in
virtù del grande futuro dietro le spalle) ma alla larga dagli
azzardi sperimentali.
In un certo senso, mi sembrano la controparte statunitense dei britannici Friendly Fires, aspirazioni MTV
(versante Brand New) comprese.(6.8/10)
Stefano Solventi
Los Campesinos! - Romance Is
Boring (Arts & Crafts, Gennaio
2010)
G enere : I ndie P op
Per la nuova prova lunga i Los Campesinos! hanno
registrato a Stamford, nel Connecticut, proprio in mezzo
alla tournée americana che li ha visti coinvolti la scorsa primavera. Nel frattempo Gareth (sorella di Kim) ha
sostituito il dimissionario Aleks alle tastiere (e voce) e
l'album è stato completato
a giugno sotto la supervisione dell'ingegnere e produttore John Goodmanson
(Blonde Redhead, Death Cab For Cutie...).
L'entusiasmo della tournée,
e l'euforia ingenerata dalle webzine statunitensi, è
papabile nella febbrile intensità di molte tracce del lavoro. I ragazzi sono gasati e, proprio grazie allo scafato
produttore, possono vantare una formula tecnicamente avvincente: (twee)indie pop intarsiato d'angoli math
e detriti di hardcore. Rispetto alle chitarre grezze del
recente passato è un bello scarto, specie se tutt'attorno
l'arricchimento delle tessiture e delle dinamiche è stato
operato in modalità simili ai compagni d'etichetta Most
Serene Republic, ovvero aumentando la dose di contagiosa verietà delle soluzioni prog-pop.
Differentemente da ...And The Ever Expanding Universe
dei ragazzi dell'Ontario, Romance Is Boring (terzo sforzo
dopo Hold On Now,Youngster e We are Beautiful,
We are Doomed) è qualcosa di affilato, contagioso e
convincente; un condensato dei citati Broken Social
Scene dalle scariche punky Architecture in Helsinki,
per il quale non si può che presentare lodi e proverbiali
frecciatine da sovrabbondanza, quella sì imprescindibile
ai prodotti Arts & Crafts.
Piacerà molto agli amanti delle coralità canadesi. Troverà
sicuramente chi ne criticherà la presa delle singole canzoni (ma attenzione a The Sea Is A Good Place To Think O
The Future, i ragazzi già puntano agli Arcade Fire); di
certo, la carica e l'efficace stratificazione funzionano a
dovere e tengono ben rette le figure dei ragazzi di Cardiff, anche a rispetto una mia proverbiale diffidenza per il
Canadian Pop.(7/10)
Edoardo Bridda
Madlib - Madlib Medicine Show #1:
Before the Verdict (Stones Throw,
Gennaio 2010)
G enere : HIP-HOP
E' iniziata l'invasione, è cominciato il Medicine Show. Con
quel tanto della metafora patologica e del fare da imbonitore che questo titolo evoca e che calza ora più che
mai a Madlib.
Il primo volume di questo Mind Fusion "firmato" e allargato è una selecta rappusissima, coi soliti squarci funksoul
madlibiani e la sua ossessione per Melvin Van Peebles e
Galt MacDermot a condire. 17 pezzi tra produzioni nuove, ripescaggi e soprattutto remix - che sono però preview - dall'attesissimo ritorno di Guilty Simpson (di
cui avevamo già un ottimo indizio, il 12" Coroners Music).
Inutile tentare troppo la via della filologia. Soprattutto,
inutile rimproverare Mad per l'autoriciclo. Perché qui c'è
ispirazione. Mad recupera All Caps da Madvillain (Life
Goes By), e quella base è bella dovunque la metti; si autocita campionando Love Leaks Out dei Residents (in
Yikes); espone una preziosa reliquia dilliana (dall'epoca
Jaylib) ed è subito boom bap wonky, ma soprattutto è
un pezzo che spacca. E spacca pure la cupa rendition di
Ode to the Ghetto, come del resto il 90% dei rappati qui
presenti.
Pezzi come sempre dilaniati da zapping interni e da brusche cesure, che destabilizzano l'ascolto, scompaginandolo; suono stratificato e granuloso come sappiamo, più
cattivo dell'ultimo Mad, vicino alla sensazione di minaccia
imminente che comunicano certo Quas e le cose con
Doom (fa eccezione il quadretto tutto pop e cuoricini
di I Must Love You). Non è un capolavoro, ma un ottimo disco underground
hip-hop, e dopo un 2009 deludente (il capolavoro Beat
Konducta Vol. 5-6 era uscito su vinile già a metà 2008),
51
possiamo dire che Madlib è tornato. Un must per tutti i
madlibiani e, soprattutto, lo si sarà capito, per quelli più
rappusi.Vediamo come saranno i prossimi MS: già annunciati un mix di roba brasiliana e un BK in Africa.(7.3/10)
Gabriele Marino
Mamuthones - Sator (Boring
Machines, Gennaio 2010)
G enere : kosmische
Avevamo apprezzato i primi vagiti dell’entità Mamuthones in The First Born, collaborazione con Fabio Orsi
targata A Silent Place, 2008, e ora Sator conferma la
bontà del progetto. Dietro il nome preso in prestito dal
folklore sardo si cela Alessio Gastaldello, cofondatore e
transfuga dei Jennifer Gentle, multistrumentista abile
e dall'armamentario di tutto rispetto: rhodes, farfisa, fingerpiano, flauti, chitarre, percussioni, rumori e quant’altro.
Prendendo il nome dalla più misteriosa delle incisioni
romane, l’album non può che essere un monolite nero
(come da splendido packaging): musiche ipnotiche e inquietanti, kraute e cosmiche di default, liquide e ossianiche, sempre ammantate
da una coltre di sinistri rimandi a tessiture criptiche
e trance-inducing nonché
spesso guidate da un tribalismo sciamanico da foresta
nera. È pregno di spiritualità, Sator, e ci si meraviglierebbe del contrario, viste le
premesse. Quella di Mamuthones è però una spiritualità
atavica (e pre-umana) che è anche in grado di giocare
con la réverie, con stati di (in)coscienza alterati, con dinamiche vuoto/pieno non banali, con slanci chiesastici
che si fondono insieme ad un forte immaginario pagano.
Un album che fluttua, privo di vincoli e restrizioni di genere, attraverso un magma di musiche ancestrali e misteriose perse nei meandri del passato dell’uomo, proprio
come ad una antichità infinita - grado zero della civiltà
- rimanda il nome stesso scelto per il progetto. Se Dio
fosse pagano, questa sarebbe la colonna sonora della sua
esistenza.(7.3/10)
Stefano Pifferi
Mangia Margot - Maddalena, Maria
(Autoprodotto, Settembre 2009)
G enere : impro / jazzcore
Da Malo, provincia di Vicenza, i Mangia Margot, gruppo
nato nel 2003 come trio prog estremo, nel 2007 asciugatosi a duo (Andrea Colbacchi-Luca Brunello) e votatosi a
52
quella miscela impro-noise-math-jazzcore che l'organico
(basso-batteria, senza voce) e i compagni di palco degli
ultimi tempi (Zu, oVo, Talibam; ma anche i conterranei
Eterea) possono facilmente lasciare intuire.
In questa prima prova ufficiale - lasciando da parte il
concept anti-omofobia che ci sarebbe dietro ai titoli troviamo cinque miniature tutte costruite sulla giustapposizione di piccole cellule ritmico-timbriche, con un
esito finale collagistico (in tal senso figlio del loro passato prog) che li avvicina - e non è un caso - ai Testadeporcu di Diego D'Agata. Jazzcore, fonti del jazzcore
e dintorni, tra funk distorto, thrash metal, tribalismi industrial, cupezze alla Primus e alla Whirlwind Heat,
appiccicosità alla Sabot e cinetismi (nelle rullate) che
guardano ai Lightning Bolt. Ma anche un paio di deviazioni - strutturalmente - disco.
Per quanto la formula sia abusatissima, i Margot se la
cavano bene, con momenti ottimi soprattutto nel bilanciare le atmosfere e i cambi di registro. Andrebbe meglio
concentrandosi un po' più sulla composizione e un po'
meno sul solo montaggio.(6.4/10)
Gabriele Marino
Marco Rovelli - LibertAria
(Comitato della memoria della
Spezia, Giugno 2009)
G enere : combat - rock
Di Marco Rovelli bisognerebbe leggere prima di tutto
i libri, tre negli ultimi anni (“Lager Italiani” e “Lavorare
uccide” per Rizzoli; “Servi” per Feltrinelli), fondamentali
nel loro lavoro di inchiesta e analisi biopolitica per capire la laida situazione italiana. E solo poi bisognerebbe
accedere alla musica, che oltre a nascere direttamente
dai libri ne fa da contraltare emozionale, mostrando l'ex
Les Anarchistes per quello che è, ovvero non solo un
cantautore e non solo un intellettuale, ma l'unione delle
due cose insieme sul filo teso della scrittura. LibertAria corre deciso sui binari di un combat-rock muscoloso, che aggira i proclami inoltrandosi nella memoria e
nell'attualità e che si nutre di letture e letteratura. Più
Yo Yo Mundi (presenti come ospiti insieme, tra gli altri,
a Daniele Sepe) che Modena City Ramblers, più
Billy Bragg che Manu Chao, ma inspessiti in elettricità talvolta al limite noise primi Marlene Kuntz, e la
collaborazione in fase di scrittura dei testi di Maurizio
Maggiani, Wu Ming 2, Erri De Luca e Roberto Saviano.
Rovelli usa la voce con accento popolare, caricando di
un senso ulteriore un songwriting che se ha un difetto
è quello di una densità che rischia di travolgere per la
quantità di riferimenti e per risultati non sempre del tutto a fuoco. Ma è appassionato, rigoroso, vitale. E scrive
canzoni realmente di dissenso, che invece di provare a
convincere inchiodano ognuno alle proprie responsabilità.(6.3/10)
Luca Barachetti
Martin Rev - Stigmata (Blast First
Petite, Novembre 2009)
G enere : synth - orchestral - pop
È strano di come in Martin Rev la dimensione performativa sia ineludibile (quando non necessaria). Strano
e quasi paradossale, data la consueta performance: lui
immobile nei suoi grandi occhiali, in piedi sul palco. Affianco il synth con preset e sample pronto per essere
percosso (in duo) oppure, semplicemente lanciato (in
solo). Gli sporadici interventi al microfono, poi, svelano
una voce flebile: prima ci cantava i bubblegum favoriti a
mo’ di American Graffitti ridotti all’osso, ora se ne viene
fuori con quest’opera o operetta spettrale che sembra
una presa in giro dei Settanta dei progger più deleteri.
Curioso poi come i live Rev-iani si basino sulla presenza
scenica e non sull’accatastamento di tastiere sul palco.
E il fatto, la presenza, risulta fondamentale pure nell’austerità del nuovo lavoro del Suicide in solo: la presenza
(di uno assente come lui) ad assurgere a unico valore.
In cuffia l’effetto non cambia. Lo percepiamo dentro ai
riff medio-bassi degli archi sintetici che danno forma
e sostanza a Stigmata, agli inserti più esplicitamente
elettronici (Sinbad's Voyage), a quelli midi-atizzati (Paradisio), ai sussurri di gola, che
punteggiano come un’intonazione spettrale il ritmo
senza percussioni delle
tracce.
Tolto questo la musica si
presenta come una collezione di bozzetti digitalmente orchestrali, mai
sinfonici, anti-ouverture verrebbe da dire, appunti arrangiativi che si creano e come sono nati si spengono.
Sono impalabili e gli assomigliano e di converso gli fanno
gioco. Lui così fuori da tutto, così vulnerabile e menefreghista. Così personaggio. Proprio questa curiosa e
impenetrabile personalità ci spinge a un insperato apprezzamento.(6.5/10)
Gaspare Caliri, Edoardo Bridda
Massive Attack - Heligoland
(Virgin, Febbraio 2010)
G enere : trip hop
Era la contaminazione a rendere il suono dei Massive
Attack un classico. Soul e hip-hop prima, rock e elet-
tronica poi. E la comodità dei critici di chiamarlo triphop. Oggi, sette anni dopo il controverso (ma appunto
controvertibile) 100th Window, il duo di Bristol tenta
la carta del (nuovo) capolavoro con risultati, diciamolo
subito, non lusinghieri. Autoriflessivi e rococò, Del Naja e il ritrovato Daddy
G utilizzano vecchi e nuovi amici per ribadire le cristallizzate sonorità che li resero celebri con il primo a tentare di smarcarsi inutilmente da Mezzanine (vedi Atlas Air
o l’inutile plagio di Karmacoma che è Rush Minute) e il
secondo a giacere sullo sfondo come un fantasma. Della
buona tensione respirata nelle tracce dell'eppì Splitting
The Atom e.p. c'è poco o nulla, come poco s'aggiunge
parlando dei classici feat.: il dub e solidale Horace Andy
(Girl I Love You), la solita monolitica Hope Sandoval (Paradise Circus), e il discreto ma di certo non originale Guy
Garvey degli Elbow (l'electro glitch radioheadiano di
Flat Of The Blade).
Il passato è ancora caldo e potente. Le intuizioni di Burial (si parla di un remix per lui a proposito) e, meglio
ancora, King Midas Sound sono lì a dimostrarlo, eppure era chiaro già tanto tempo fa che il balletto degli
ospiti avrebbe portato verso una rapida senescenza.
Heligoland salirà con qualche ascolto senza che la prima impressione venga messa in discussione. I Portishead di Third sono davvero lontani da quest'isola e i Massive Attack definitivamente storicizzati.(5.5/10)
Marco Braggion
Mavis - Mavis Presents (!K7,
Febbraio 2010)
G enere : lounge trip - hop
Ashley Beedle non è uno che sta fermo davanti allo
specchi a cantarsi quanto è bravo. Tutt’la più se ne sta
alzato la notte con l’amico e collaboratore Darren
Morris ad ascoltare Mavis Staples (ecco spiegato il
nome del progetto) e gli Staples Singers, da sempre
loro prediletti, e vi scova la scintilla per realizzare un
disco. Magari gli ci vogliono tre anni per arrivarci e il
risultato è lontano dalla perfezione, però nel frattempo
si è messo in discussione, ha sudato attorno a un’idea.
Nello specifico, quella di chiamare attorno a sé alcuni
cantanti cui affidare una traccia ritmica da remixare fino
a ottenere brani diversi e confacenti partendo da una
radice comune.
Che è la medesima o quasi per Kurt Wagner dei Lambchop in perfetti abiti da crooner (Gangs Of Rome vale
gli Air migliori) dell’usuale e per il consumato marpione
Edwyn Collins (un gradino sotto, Feeling Lucky), viceversa muta in istantanea modernista dal ghetto tramite
la lezione bristoliana con la Revolution donata a Candi
53
highlight
Lightspeed Champion - Life is Sweet! Nice to Meet You (Domino,
Febbraio 2010)
G enere : indie pop
Life is Sweet! Nice To Meet You era disco parecchio atteso, dopo tutto l’hype suscitato a inizi 2008
dall’esordio Falling Off The Lavender Bridge, una quadratura del cerchio indie pop come non si sentiva da tempo, indice di un talento non proprio ordinario.
L’ex-Test Icicle Dev Hynes, preso il moniker Lightspeed Champion si era all’epoca abbeverato alle fonti americane di Omaha, Nebraska, presso la corte di Mike Mogis, vale a dire l’area Saddle Creek/Bright
Eyes, confezionando un album di songwriting indie folk pop.
Per il seguito, ancora produzione americana, questa volta con il quotato Ben
Allen (Gnarls Barkley e Animal Collective), che ha ben assecondato la
voglia di suono americano del Nostro; alla base dell’album c’è questa volta
una scrittura per piano e synth (mentre nel precedente era la chitarra acustica), tenendo comunque conto delle chitarre dal suono pulito, e di arrangiamenti curati. Non manca un’attitudine prettamente inglese che viene fuori
nelle inflessioni ’70 pop rock soprattutto delle chitarre, come in Faculty of Fears, e in certe ballad dal tono powerpop magniloquente (Middle Of The Heart,
un David Bowie periodo Hunky Dory, ma anche un Todd Rundgren); in influenze di teatro musicale
e lirico (The Big Guns of Highsmith che sa di glam seventies con tanto di intermezzi simil operistici Sparks
e Queen o se si preferisce il più attuale Patrick Wolf), non facendosi mancare un suono wave con una
base countreggiante sotto (Madame Van Damme) e in generale un sottotesto di folk a stelle e strisce.
Un’attitudine giocosa e un po’ sopra le righe viene fuori qua e là, un andare oltre i generi guardandoli
appena dal di fuori e come dissacrandoli con affetto, segno questo di una continua evoluzione. L’eclettismo non manca di certo a uno come Hynes e salutiamo allora il suo ritorno con tutto l’entusiasmo del
caso.(7.4/10)
Teresa Greco
Staton, in cremoso babà grazie alla sventolona Sarah
Cracknell di When I Walk With You e bella reinvenzione
pop orchestrale con Ed Harcourt (Puzzles & Riddles).
Il rischio di un’operazione di tal fatta, nondimeno, sta nel
livello medio dei partecipanti: non tutti sono assi e, tra
buoni panchinari o giovani di discrete speranze, un paio
di fiacche interpretazioni arrivano in un battibaleno. Vorremmo però spezzare una lancia in favore del cast e non
paia una contraddizione: scommettere su facce nuove rimane un gesto coraggioso e pazienza se non tutti ripagano come Disa - da Reykjavik: si sente - o la sudafricana
Cherilyn MacNeil. Quel che si ascolta è infine un po’
fuori dal tempo, un po’ retro e un po’ attuale. (6.8/10)
Giancarlo Turra
Mayer Hawthorne - Soul With
A Hole Vol. 1 (Stones Throw,
Febbraio 2010)
G enere : vintage soul
I 45 mix ideati dalla Stones Throw li si potrebbe consi54
derare variazioni negroidi del verbo Nuggets: se il primo
volume Yo! 45 Raps griffato PBW e J Rocc raccoglieva
chicche sparse di oldschool hip hop, la nuova collana Soul
With A Hole inaugura il versante vintage soul. Roba da vinyl
junkies che ancora una volta attinge dal commovente formato 45 giri. Dato il tema, questa volta a selezionare non
poteva essere che Mayer Hawthorne che troviamo alle
prese con ventiquattro episodi passando in rassegna eminenze oscure mai oltre il formato singolo (Erroll Gaye
And The Imaginations, The Dynamic Tints e culti assoluti
tipo Dee Dee Warwick, sorella maggiore della blasonata Dionne, Sly, Slick And Wicked).Nomi per lo più sconosciuti ma che sottobanco hanno influito sia sul talento di
Hawthorne (in tal proposito, ascoltare All On A Sunny Day
di Deon Jackson e la si paragoni a One Track Mind del
Nostro) che sulla cultura soul in generale.
Il missato è assai naïf. L'uomo sfuma una traccia nell’altra
con pochi artifici se non quello base d'incastrare tutto a
tempo. Funziona però. (6.5/10)
Gianni Avella
Midlake - The Courage of Others
(Bella Union, Febbraio 2010)
G enere : prog folk
Dopo il debutto al crocevia tra Radiohead e Grandaddy, i Midlake, continuando sulla scia del precedente The Trials of Van Occupanther, fugando ogni dubbio sul
loro peso specifico. Più che della maturità, The Courage
Of Others è il disco di una consapevolezza fatta di Hatfield and the North e Jethro Tull coniugati all’epico
Neil Young (quello di Harvest).
L'efficace tecnica mutuata dai trascorsi jazz, e una produzione che manda a memoria i migliori ’70, permette alla
band di muoversi tra folk ora agresti (la delicata Fortune) ora drammatici (i Radiohead travestiti da Strawbs di
Bring Down, The Horn), e tutto scorre alla maniera di un
tempo, sullo stile dei migliori Camel (Small Mountain) e
degli stessi Hatfield (In The Ground).
Anche visti i recenti e interoluctori Guillemots, più che
imitatori, i Midlake rappresentano gli spontanei discepoli
di una gloriosa tradizione.(7/10)
Gianni Avella
Million Young - Be So True EP
(Arcade Sound Ltd., Gennaio 2010)
G enere : E lectro glo - fi
A breve distanza dal Sunndreamm EP di qualche mese fa
(scaricabile gratuitamente dal myspace) il ragazzo milionario dalla Florida approda al formato fisico sulla breve
distanza e lo fa a suon di glo-fi e la giusta dose di nostalgia senza cedere troppo alle tentazioni emulatorie.
Mike Diaz ingrossa il sound d'input elettronici e riesce
ad aumentare il ritmo come avevano fatto i Delorean
(Cynthia) con una strizzatina d’occhio agli '80 più plastici (Soft Denial), il bel soul robotico che ricorda Darkel
e la francia più gloss-downtempo di Sebastien Tellier
(Mien, Pilfer) e, per concludere, il doveroso slalom tra
ambient à la Boards Of Canada e bbreaking (Day We
Met).
Il miniculto glo espande e allarga le vedute insinuandosi
con eleganza in altri generi, una nuova bella promessa
che potrebbe fare a gara - per voce e attitudine - con
quei romanticoni dei Kings Of Convenience.(7/10)
Marco Braggion
Mimmo Locasciulli - Idra (Hobo,
Aprile 2009)
G enere : canzone d ' autore
In clamoroso ritardo e facendone pubblica ammenda recuperiamo questo lavoro di Mimmo Locasciulli, il diciassettesimo di una carriera a latere rispetto ad altri della
sua generazione ma non priva di passaggi essenziali. E il
motivo di tale recupero è che uno di questi passaggi essenziali è proprio Idra, disco in cui il songwriter abruzzese
se ne va a New York in compagnia del fido Greg Cohen
ad incontrare tipi del tutto raccomandabili come Marc
Ribot e Joey Baron, insomma quanta grazia. Locasciulli
di suo tira fuori qui almeno
nove canzoni (su dieci della
tracklist) di pari bellezza e
intensità, i raccomandabili
(e con loro un Gabriele
Mirabassi e uno Stefano Di Battista a tenere
egregiamente testa) infarciscono il tutto di spremiture
blues-jazz che instillano rumorismi trattenuti ma efficaci o
squarci evocativi che hai voglia ad avercene.;
E allora viste le premesse non rimangono che da elencare i risultati, tutti molto tradizionali, ovvio, ma anche tutti
pieni di idee, vibrazioni. Il blues lineare e metronomico
di Scuro, organo a tirare le fila, sax inquieto, Ribot che fa
Ribot (soprattutto nella versione Marc 'n' Roll in chiusura); la title-track malinconica e aurorale, ovvero come
parlare di immigrazione lievemente e senza sociologie
d'accatto. La svisata Ardecore del ritornello popolaresco di Senza un addio, e poi ancora una trafila di ballad
classiche ma sostanziose e vive - come raramente ormai
ne arrivano da penne italiane nate dal sessanta indietro
(vero Fossati, Guccini, De Gregori?) - dove a variare è
alla fine solo la direzione musicale intrapresa: latineggiante e smaltata dai piatti di un Baron totalizzante in Passato
presente, vestita ad occasione da archi cinematici in Benvenuta, crepuscolare con gocce di glockenspiel e sax ad
attraversare il cielo come un fascio di luce in L'attesa,
palpitante di mandolini in Lucy, infine nuda nel pianovoce
da brividi de Il bambino e il destino.;
Che altro dire? Niente, se non che di Locasciulli così in
lucore ce ne vorrebbero di più, visto che qualche verso
di questi brani potreste portarvelo dietro, proprio per
la vita («Tutti aspettano di salvarsi / come si aspetta in
una stazione / come si tratta dentro a un mercato / dove
il prezzo è già scontato»), e che canzoni così preziose
e del tutto meditate, anche da chi le ha suonate, giustificano anche un recupero ad anno concluso, che tanto
quello appena iniziato non ce le farà certamente dimenticare.(7.8/10)
Luca Barachetti
Moltheni - Ingrediente Novus (La
Tempesta Records, Novembre 2009)
G enere : canzone d ' autore
Sei dischi in studio in dieci anni. L'esordio con il pop
55
radiofonico - ma strambo quanto basta per farlo emergere dalla massa (anche sanremese) - di Natura in replay, sotto l'ombra ingombrante di Carmen Consoli
(la produzione era di Francesco Virlinzi) e con il riferimento Afterhours ben presente. Poi l'urlo elettrico, grunge fuori tempo massimo però viscerale come
pochi, di Fiducia nel nulla migliore, con Chris Stamey e Jefferson Holt (Sneakers, R.E.M.) in cabina di
regia. Dunque l'accasamento indie su La Tempesta Dischi
per quello Splendore Terrore che doveva essere una
parentesi, dilatata e ieratica, e che invece è stato l'inizio di un nuovo percorso all'insegna di un pop sempre
più strettamente imparentato col folk, in primis il New
Weird d'oltreoceano (Toilette Memoria, l'altra punta massima nel decennio percorso), certo non privo di
qualche momento di stanca
(Io non sono come te
ep), ma anche capace di
singoli episodi dalla caratura altissima all'interno di un
percorso recentemente di
nuovo in ricerca (I segreti
del corallo, uscito l'anno
scorso). Un percorso che
ora per Moltheni pare arrestarsi, dalle ultime dichiarazioni addirittura in modo definitivo, con questa antologia
in formato audio e video.
Diciassette i brani presi da ciascun lavoro pubblicato
e risuonati per intero, di questi due inediti: Petalo, già
eseguita più volte negli scorsi tour, che lo riporta alle
rotondità pop-rock degli esordi ma con vestiti meno
iperlucidi, e Per carità di stato, invettiva sull'Italia retrograda e immobile che sembra anticipare la decisione di
dire basta. Quindi altre quindici canzoni con cui fare i
conti, tra ospitate importanti (Mauro Pagani, Enrico
Gabrielli che arrangia gli archi) e qualche recupero di
pregio, come una Nutriente rifatta cameristica e il cameo
spargi asfalto di Vasco Brondi aka Le luci della centrale elettrica su Zona monumentale, sorta di dichiarazione
di discendenza del ferrarese dal marchigiano in quanto
ad urgenza espressiva e lavoro sul linguaggio - a tal proposito: senza loro due due e pochi altri il nostro cantautorato si ritroverebbe oggi di qualche passo indietro, sarebbe ora di accorgersene in modo chiaro ed evidente.
Nel dvd invece le riprese di due stralci di concerti, uno
elettrico (piuttosto bello) e uno acustico (sicuramente
meno diretto), alcuni videoclip (peccato manchino quelli
del primo disco) e un corto dall'ambientazione bucolica
parecchio suggestiva. Nel complesso, insomma, un riassunto ottimo per i neofiti ma che regalerà soddisfazioni
anche ai fans della prima ora.
56
Qualche anno fa, tour di Fiducia nel nulla migliore,
alla fine di un concerto - elettrico, molto elettrico, uno
spiritual di feedback e parole tirate in gola - andai a conoscere Moltheni, la scaletta in mano per fargliela firmare. Lui non me la firmò, ma scrisse in fondo alla track-list
“Moltheni sta male”. Capii solo qualche anno dopo che
non era una bizzarria da artista, ma la sua firma, quella
vera, onesta e impellente anche a rischio di risultare eccessiva. Perché Moltheni è da sempre così. Uno che sa
scrivere canzoni e le scrive perché ne ha bisogno. Uno
che sale sul palco e sputa senza troppi giri di parole, ma
attraverso i densi filtri metaforici delle sue liriche, le ferite che prima o poi tutti riceviamo e ci portiamo in dote.
«Capra realtà, nutriti con la mia erba»: dispiace, e molto,
se deciderà davvero di chiudere qui.(7.2/10)
Luca Barachetti
Motorpsycho - Heavy Metal Fruit
(Stickman, Gennaio 2010)
G enere : hard / psichedelia
Eclettici come pochi, prolifici quando non letteralmente
incontenibili - quasi impossibile seguirne le vicissitudini
ventennali tra LP ufficiali e numerosissimi EP -, i Motorpsycho hanno sempre dimostrato una contingenza creativa rigogliosa, disposta a farsi contaminare ma alle volte
fin troppo autocelebrativa. Se nei Novanta il grunge contribuì non poco a mettere a fuoco le spinte centrifughe
della band norvegese fungendo da specchio e stimolo per una contemporaneità psych originale e lontana
dall'hard acidissimo e derivativo degli esordi, col nuovo
secolo e la perdita dei principali punti di riferimento si è
assistito all'affermazione di un utilitarismo formale piuttosto di maniera. Non brutto in assoluto, come testimoniano dischi come Phanerothyme e It's A Love
Cult , ma certamente poco significativo. Seguito da un
progressivo ritorno alle origini che ha sostanzialmente
confermato tutti i pregi e i difetti della formazione di
Trondheim: molte idee, ma qualche difficoltà nel saperle
valorizzare a dovere.
Il nuovo Heavy Metal Fruit riprende il concetto di suite
psichedelica - quello che era un po' mancato all'ultimo
Child Of The Future - cercando di dribblare i soliti problemi di logorrea inconcludente con sei episodi in bilico
tra hard anni Settanta (i Black Sabbath di W.B.A.T.) e
certe declinazioni jazzy rubate all'accoppiata Quicksilver Messenger Service /Grateful Dead (il drop out
progressivo e quasi “crimsoniano” di Starhammer). Una
scelta formale che ha il pregio di offrire una chiave interpretativa solida al materiale e che rispetto al penultimo Little Lucid Moments - anch'esso dilatato a dismisura
- serra le fila promuovendo un suono meno dispersivo,
highlight
Magnetic Fields - Realism (Nonesuch, Febbraio 2010)
G enere : folk pop
Due anni esatti dopo Distortion, ecco il di lui contraltare Realism. Entrambi all'insegna del "no-synth",
realizzati dallo stesso team di musicisti, sembrano le classiche due facce di
una stessa medaglia (che è poi l'arte melodica - apparentemente inesauribile - di Stephin Merritt). Se il predecessore muoveva dall'esplicita intenzione
di omaggiare il sound distorto dei Jesus And Mary Chain in un magma
talora ecessivo di chitarre deragliate, questo torna ad acquietarsi nel grembo
d'un folk di stampo popolare, ispirato alle produzioni britanniche a cavallo
tra Sessanta e Settanta, quindi puntigliosamente acustico anche se per nulla
parco negli arrangiamenti.
Violini, violoncelli, fisarmoniche, banjo, bouzuki e tabla sono gli abiti versicolori di canzoni straordinariamente ispirate e varie. Sogni di bambagia vagamente psych (Always Already
Gone), teatrini vaudeville-country (We Are Having a Hootenanny), incanti melmosi come un Julian Cope
sotto valium (Walk A Lonely Road), deliziose marcette fiabesche (The Dolls' Tea Party), uno Scott Walker
di carta da zucchero (I Don't Know What to Say) e una ballata da genuflessione come You Must Be Out of
Your Mind capace di tanta asprigna malinconia da mandare in solluchero (anche) i fan di R.E.M. e GoBetweens.
Il repertorio dei Magnetic Fields si arricchisce di un altro grande album. E - sapete cosa? - non ci stupisce. (7.6/10)
Stefano Solventi
fortemente contestualizzato ma forse poco coraggioso.
Il che, nella pratica, per i musicisti significa cavarsela con
stile confezionando un'opera che intercetta e personalizza il revival prog-hard di band come i Black Mountain
e per chi ascolta portare a casa il risultato senza uscirne
sfibrato.(7/10)
Fabrizio Zampighi
a una produzione pulitissima e a testi proporzionati alle
aspirazioni.
Buone potenzialità ma paracadute in spalla, per una formazione che ci piacerebbe vedere meno dipendente da
certe dinamiche legate all'immagine.(6.6/10)
Fabrizio Zampighi
Nadàr Solo - Un piano per fuggire
(Massive Arts, Gennaio 2010)
G enere : punk / noise
Ninca Leece - There Is No One
Else When I Lay Down And Dream
(Bureau-b, Gennaio 2010)
G enere : P op , dance
Scafati sono scafati, i Nadàr Solo. Lo capisci da come
agitano senza riguardo il loro punk-noise adatto ai classici
turbamenti adolescenziali come a contesti meno in linea
con i gusti massificati. Sicuri di potersela cavare in ogni
situazione, grazie a un suono non troppo compromesso
e capace di mostrare qualche ottima intuizione. Della
serie un colpo al cerchio e uno alla botte, un occhio ai
Ministri e uno alle innocue accelerazioni generaliste da
teenager con poche pretese. Contrasti e collusioni che
affiancano alle banalità telefonate di Un'ora sola la batteria isterica e fascinosa di Sette anni, ai Muse taroccati di
Stato Maggiore gli scambi al fulmicotone di Cento Cose, al
battere in levare da top ten di La Strada gli sviluppi noise
di Cinque secondi. Il tutto scevro da difetti di forma, grazie
Il lifestyle da club prima ad Amsterdam e dopo a Berlino
(dove ha abitato fino a l'altro ieri) deve aver inciso parecchio nella vita di questa ragazza francese cresciuta tra
il concervatorio e la passione per i suoni eterei (parole
sue) di New Order e My Bloody Valentine. Nel debutto There Is No One Else When I Lay Down And Dream la
troviamo perfettamente a suo agio tanto nella techno
quanto nell'house, entrambe virate secondo dettami della Capitale (e spesso funky). Non mancano i riferimenti
uber artici come Björk (l'opener fuorviante Touriste) ma
Ninca preferisce pose più sexy e terrene; di più, data la
sua di terra, i proverbiali Ottanta li troviamo sottoforma
di Lio in Funny Symphony.
Il mix di popness e electro (colta come, più praticamen57
highlight
Pantha Du Prince - Black Noise (Rough Trade, Febbraio 2010)
G enere : minimal techno
Ci avevamo visto giusto con Weber. Questo nuovo attesissimo disco infatti si incarica di traghettare la minimal techno mutante di Pantha Du Prince in un formato assai più gioioso e ammiccante, senza per questo
abbandonare il proprio status di griffe di prestigio nel settore della dance hall intelligente. Uno scarto che
si avverte all’istante, non foss’altro che per l’etichetta che distribuisce, una
Rough Trade in grado di presentare il dj tedesco al di fuori del suo normale
ambiente di riferimento. Ergo strizzatine d’occhio e pacche sulle spalle a profusione in un lavoro dal taglio denso e melodioso, che mette da parte tutto il
rigore teutonico che faceva il senso di un disco come This Bliss.
Qui Weber arricchisce la tavolozza partendo da una serie di field recordings
registrati mentre era in vancanza sulle alpi svizzere insieme ai fidati Joachim
Schütz (Arnold Dreyblatt Trio) e Stephan Abry (Workshop) e infatti la quasi
totalità dei brani parte proprio da questi suoni naturali remixati a rielaborati
digitalmente. Da qui anche tutto il discorso teorico che Weber butta giù, a mo’ di concept album, sul “rumore nero” della natura, quell’indefinibile e impercettibile rumore che viene avvertito dagli animali prima
di una tempesta.
A tutto questo aggiungiamoci i special guest stars, nelle persone di Tyler Pope (!!! e Lcd Soundsystem)
e Noah Lennox (ovvero Panda Bear) che danno una mano rispettivamente su The Splendour e Stick To
My Side e quello che otteniamo è Black Noise, un disco che sa unire vertiginosi giochi di chimes islandesi
(Lay In A Shimmer) e vigorose linee di basso campionato (Abglanz); inedite aperture vocali (Stick To My Side)
e nerissimi motorik techno modello Detroit (A Nomads Request, Behind The Stars) senza tralasciare ariose
aperture da soundscape romantico (Welt Am Draht, Im Bann).
La carne al fuoco forse è anche troppa e dischi come questo che giocano la propria ragion d’essere proprio sul contaminarsi di continuo, corrono sempre il rischio di risultare alla fine inconcludenti, come un
giochino fine a se stesso. In questo caso il pericolo è scongiurato perché il sound di Pantha Du Prince
ne esce fuori a testa sufficientemente alta, ma Weber deve lavorare ancora a lungo per definire meglio i
contorni di una formula così “user friendly”.(7.3/10)
Antonello Comunale
te, da club) è il punto di forza di un album che snocciola
minimal, clicks e cut e trance berlinese (leggi AGF fino
a Ellen Allien) con grande classe. Particolare non di
poco conto: perfettamente fuse le sensibilità nazionali.
Skippabile la cover dei Cure (Lovesong).(7/10)
elettronica che guarda all’ambient che già in Bat For
Lashes avevamo notato e apprezzato.
Ramona Gonzales è intrigante, l’operazione nondimeno didascalica e senza singoli da mandare a memoria.(5.5/10)
Edoardo Bridda
Marco Braggion
Nite Jewel - Good Evening (Human
Ear Music, Aprile 2009)
G enere : electropop , glo - fi
Mancava la voce femminile sotto l’ombrello glo-fi. Il trio
losangeliano Nite Jewel prende le eredità di George
Michael e Laurie Anderson filtrandole con gli '80 color pastello della dark wave e costruendo così un sogno
di beat in eco, Cure (Heart Won’t Start), polveri Enya
(Universal Mind) e sintetismi Japan (Artificial Intelligence);
58
Nitin Sawhney - London
Undersound - Instrumentals
and Remixes (Cooking Vinyl UK,
Novembre 2009)
G enere : chill - world - pop
Polistrumentista, produttore, autore di colonne sonore,
organizzatore di eventi culturali, uomo delle istituzioni
(è uno dei patron del "Programma per l'accesso alla musica" voluto nel '92 dal governo Major), Nitin Sawhney
- origini indiane, nazionalità inglese, vissuto londinese rivolge da sempre il proprio impegno a favore del multiculturalismo e dell'integrazione.
London Undersound ('08) - con ospiti prestigiosi
come il Macca e la figlia di Ravi, Anoushka Shankar - è
stato la naturale prosecuzione di questo percorso, tanto
nei contenuti (ponendosi esplicitamente come uno spaccato del "cuore positivo che pulsa a Londra" nell'epoca
degli attentati terroristici), quanto nella formula musicale, piccolo aggiornamento di quella brevettata già in
Beyond Skin ('99). Una avvolgente pulitissima miscela di
jazz, pop, orchestrazioni da soundtrack ed elettronica
soft, a creare un trip-hop/chill-out animato da forti richiami world music.
Questo disco adesso raccoglie gli strumentali (e un paio
di alt take) dell'album 2008 più alcuni remix (in parte già
pubblicati altrove): l'assenza della voce è tutto sommato
trascurabile; i rmx portano i pezzi originali nei club, ma
con risultati alterni. In ogni caso, grande cura per il dettaglio e alcuni singoli episodi ottimi, col rovescio di un
innegabile sentore di retorica e di lezioso che - inevitabilmente? - affiora a tratti.
Un sottofondo di bocca buona ma preparato con passione e classe.(6.5/10)
Gabriele Marino
Odd Clouds - Deceiving Illusion
(Tasty Soil, Gennaio 2010)
G enere : free - weird - jazz
Deceiving Illusion segna il ritorno della combriccola più
weird della Detroit mutante d’inizio millennio. Nata
dall’incontro tra Chris Pottinger e Jamie Easter, l’esperienza Odd Clouds si è sempre distaccata rispetto ai
compagni di merende detroitiani per la predilezione per
suoni di matrice più free e meno punk-oriented, tanto
che se dovessimo buttar lì coordinate generiche propenderemmo per una versione (molto) più acida dei
Rollerball o degli Animal Collective con sezione fiati
cresciuti a funghi e deserto.
In questo nuovo 12” il quintetto offre 6 tracce untitled
in cui pasteggia con free-jazz e rock mutante per poi
risputarlo fuori cialtronesco e infame, tanto quanto può
risultare lo stile da fumetto splatter impazzito col quale
Pottinger adorna le copertine dei dischi. Dilatazioni free
immaginate come colonna sonora di discariche post-industriali convivono con mascalzonate a base di marcette
da brass-band ubriaca; nello stesso modo fantasmi ayleriani si spalmano in allucinati passaggi folk-noise alieni,
ebbri e pure deformi. Con una naturalezza e una capacità di elaborazione tale che ci fa forse ripensare ai molti
dubbi che avevamo (e che abbiamo) sul reale portato
musicale di molti weird-heroes odierni. E che, se non si
fosse capito, ce li fuga in un momento.(7/10)
Stefano Pifferi
Oh No Ono - Eggs (Leaf, Febbraio
2010)
G enere : pop
Ha uno strano rapporto con l’orecchiabilità, Eggs. Funziona da subito, acchiappa l’orecchio con le soluzioni
iperdisegnate (come curatissime architetture); richiama
alla mente una costellazione di riferimenti, pop inglese,
Supertramp, ricchezza di dettagli pop-prog, ma anche
quella animosità art-oriented molto praticata a Portland.
Una miscela che carbura con strani giri di motore. Cresce repentinamente con
gli ascolti, poi si ferma, poi
inizia a scendere appena, e
quindi si stabilizza.
È comunque comprensibile
che, dopo essere uscito, nel
2009, su un’etichetta danese non meglio specificata (la
01-11700170), Eggs venga
licenziato - da Leaf - anche al di fuori del mercato scandinavo. Bastano i primi minuti del nuovo lavoro di Oh No
Ono, quintetto di Aalborg, per capirne le potenzialità
da indie-pop internazionale. Eppure il gioco dell’album
si risolve tutto in un paradosso apparente; non mancano
citazioni che escano dalla Danimarca, come dicevamo,
eppure si coglie l’intenzione di fare qualcosa di peculiare, che alla fine siamo portati ad associare a una scena
(quella del pop scandinavo).
In tutto e per tutto Eggs è un impasto di pop eccentrico che ha un sapore caratteristico, conseguenza della
ostinazione (senza giudizio di valore) nel voler far sprigionare la propria penna e le proprie atmosfere dalla
qualsiasi frammento e particolare dell’arrangiamento, e
specialmente nelle melodie aeree. Lo spettro di risposta
va dalla pillola indorata, nordica e intellettuale, di Swim,
alla stramberia Mercury Rev-iana di Eve. Non si può
nascondere una certa curiosità, e una completa incapacità di previsione, rispetto al modo in cui Eggs verrà
accolto dal mercato musicale anglosassone…(6.9/10)
Gaspare Caliri
Ok Go - Of The Blue Color Of The
Sky (Capitol, Gennaio 2010)
G enere : funk - power - pop
Saremmo portati a dire che WTF?, primo brano e primo
singolo da Of The Blue Color Of The Sky, sia una
sorta di manifesto del nuovo approccio degli Ok Go.
59
Niente più power-pop lineare, e al suo posto il singhiozzo animista - ma profondamente pop - di spezie funk
liofilizzate.Torna principesca la figura di Prince (Skyscrapers), e con lui quella di tutto il pop sensuale degli Ottanta - delle musiche che non andavano necessariamente
classificate sotto il prefisso synth- (che qui riecheggia in
White Knuckles, End Love), che vivevano di chitarre e produzione, che si agitavano nelle charts anglosassoni.
Non è un caso se diventa rilevante, per il terzo disco
dei chicagoani, la presenza del produttore Dave
Fridman, all’attivo con
altre realtà indie nobiliari
o meno - Flaming Lips,
Mercury Rev, Clap Your
Hands Say Yeah, Weezer. La stanza dei bottoni
è presente anche se non
ingombrante, e contribuisce non poco a dare una vena
raffinata alla pasta delle canzoni.
Gli Ok Go sembrano giocare la carta dell’eccentricità,
difficile forse per piazzare una giocata vincente, se il proprio nome è da sempre associato a meccanismi semplici,
idee efficaci e immediate. Eppure, i Nostri dimostrano
di avere una certa abilità, a volte (Needing/Getting), nel
decostruire il binario di marcia. Il passo successivo, non
parlando di una band per pochi intimi, è fare zoom-out
e cambiare scala. Da Here It Goes Again sono cambiate
un po’ di cose, diciamo contestuali, nel mainstream, che
dai Franz Ferdinand si è spostato qualche anno più
avanti, a proposito di padri putativi: le mosse di Ok Go
avvengono in una stanza già imbottita di suoni revivalistici, dove non è impensabile spendere pure un vocoder
ultra-citazionistico (Before The Earth Was Round).
La sorpresa è semmai (ancora Frid, il responsabile?) l’impianto costruttivo di In The Glass, ballata finale che conduce l’ascoltatore dalle campane al rumore. Una gemma
quasi glam, nelle armonie e nella prima metà del pezzo,
psichedelica poi. Come ogni brano finale, una chiusura e
una promessa…(6.5/10)
Gaspare Caliri
Olivier Girouard - La nuit nous
deconstruit par coeur (Ekumen,
Giugno 2009)
G enere : elettroacustica
Pedina irrinunciabile del collettivo Ekumen (Nicolas
Bernier, Jacques Poulin Denis) l'esordiente Olivier
Girouard è una delle più belle scoperte degli ultimi
mesi in ambito d’elettroacustica.
Cinque tracce per Le nuit nous deconstruit par co60
eur che s'ispirano alle poesie di Marie Uguay e scritte originariamente per lo spettacolo Beside Me di Kate
Hilliard, memoria ed omaggio alla recente scomparsa un caro amico.
Chitarra principalmente (Song for no one), suoni trovati,
texture in granuli (Ou il n’y a persone) e punteggiature in
beat (Ici seule), questi gli strumenti utilizzati con sensibilità estatica e riduzionista (D’autre que moi) a cui Olivier
Girouard dona voce giocando su rifrazioni, riverse (Ne
me lasse pas ici) loop, evanescenze e poetica intimista.
Ritorna il tema dell’intreccio e del collage, lezioni impartite già dai compagni nel più recente Sur le Fond Blanc
(Ekumen,2009) qui condotti con estrema padronanza di
tempo e sfumatura.
Erede angelicato del Chauveau più accomodante, il
suono di Girouard prima ancora che una nuova proposta si presenta come un’efficace lezione di genere.Ben
venga comunque.(6.7/10)
Sara Bracco
Oratio - Ora ti ho (Malintenti
Dischi, Dicembre 2009)
G enere : folk
Un Bugo primordiale (Una parte di me, Il tabacchino è
chiuso), Lucio Battisti (Il bianconiglio, Ce ne andremo via)
e qualche accento barrettiano. Flower power sdrucito
su canzone italiana anni Sessanta-Settanta, accompagnato da una chitarra acustica sfrontata e una naturalezza
per nulla retorica.
Nelle dodici tracce dell'esordio discografico di Oratio si
sperimenta la quotidianità dei dischi del Battisti nazionale, l'immediatezza e la cura del messaggio, l'orecchiabilità
e la melodia. Mirando a una formula in bilico tra folk/
blues americano, musica d'autore e surrealismo in forma
di testo. Ora ti ho parla del Mogol dei supermercati
e dei treni che partono, delle stagioni e delle case, oltre che di quel mediare tra rapporti personali e mondo
esterno che negli anni del boom economico rifletteva
su cambiamenti sociali epocali mentre qui si accontenta
delle ristrettezze di un semplice dare e avere.
Mi son svegliato presto / per conquistare l'universo / ma
già dopo il caffè / mi sentivo perso” canta Andrea Corno sotto mentite spoglie, con uno stile che potrebbe
ricordare quello di Dente. Del resto la discografia di
riferimento è analoga, anche se ai riflessi pop distratti e
stralunati del cantautore parmense il progetto Oratio
preferisce un impianto testuale serrato e una calligrafia
più aderente al folk. Nel CD contributi di Toti Poeta
(produttore) e di buona parte degli artisti del giro Malintenti Records.(7.3/10)
Fabrizio Zampighi
Paul Baran - Panoptic (Fang Bomb,
Novembre 2009)
G enere : E lettroacustica , canzone sbilenca
Soltanto omonimo del geniale ingegnere polacco che ha
fornito un contributo fondamentale, grazie alla messa
a punto del concetto di rete decentrata e ridondante,
alla nascita di internet, il nostro Paul Baran è, invece,
un sound-artist di Glasgow che sguazza a meraviglia nei
flussi musicali del dopo-internet.
A capo di una mini orchestra molto sui generis che annovera, tra i numerosi componenti, Keith Rowe (chitarra preparata), Werner Dafeldecker (contrabbasso,
processing analogico, voce) e Andrea Belfi (percussioni, processing), Baran si fa, da par suo, ingegnere di un
suono cervellotico e a tratti ostile, fermo a mezza strada
tra astratto pianismo di matrice feldmaniana (Love Under
Surveillance) e improv pura (Pin-snipers), da un lato, e
acerbi tentativi di incanalare rumore, improvvisazione ed
eccessi sonori in stralunati abbozzi di canzone rock (Pomerol) o jazz-ballad (Lewitt: comunque uno degli episodi
meglio riusciti dell'album), dall'altra. Solo per coraggiosi.(6.3/10)
Vincenzo Santarcangelo
Peter Gabriel - Scratch My Back
(EMI, Febbraio 2010)
G enere : cl as sical pop
“Un album molto personale di 12 canzoni eseguite per sola
orchestra e voce”, questa la definizione di Scratch My
Back da parte del musicista inglese. Dodici cover quindi,
eseguite con un’orchestra di 40 elementi, con arrangiamenti del veterano John Metcalfe (Durutti Column)
e produzione di Bob Ezrin. Un progetto ambizioso che
prevederà a breve uno scambio da parte dei personaggi coinvolti, David Bowie
escluso.
Scaletta azzeccata, scelta
di cover ad ampio range
(Randy Newman, Lou
Reed, Neil Young, Paul
Simon, Talking Heads,
Radiohead
ma anche
The Magnetic Fields,
Arcade Fire, Bon Iver, Elbow e Regina Spektor)
attraverso cui Peter Gabriel mostra come sempre un
ottimo gusto musicale. Artisti così diversi sono resi alla
sua maniera, senza snaturarli ma piuttosto rivisitando
ogni canzone, non stravolgendoli ma costruendo gli arrangiamenti attorno alla sua voce sempre efficace.
Ne viene fuori un incontro inusuale tra classica e pop,
con arrangiamenti spogli ma funzionali, dove l’enfasi è
messa solo all’occorrenza, come nel crescendo di My
Body Is A Cage degli Arcade Fire. Si sentono l’influsso
classico e quello minimalistico, ma anche il sincretismo
gabrieliano e anni di world music, una costruzione per
aggiunta di elementi, l’emotività e una resa sonora e vocale ben amalgamate: tutto questo fa sì che l’album sia
compatto e vi si senta il peso del “mestiere”, in positivo”,
di uno come il Nostro. Applausi.(7.5/10)
Teresa Greco
Peverelist - Jarvik Mindstate
(Punch Drunk Records, Novembre
2009)
G enere : dubstep ambience
Alle soglie dell'(auto)consacrazione Hyperdub, il disco
d’esordio di Tom Ford arrivava (era novembre) in un periodo di magra per il dubstep, seppellito dal fuorilegio di
produzioni wonky, ragga e step da salotto (King Midas
Sound). Logico che all'inizio a prevalere è il pregiudizio
di fronte a nove lunghe tracce dal sound inevitabilmente
citazionista.
Peverelist pesca certamente nella techno dub Basic
Channel (Jarvik Mindstate) nell'electro dub firmato Pole
(Valves) e negli ambientstep Scuba (Clunk Click Every
Trip) e Pinch (che compare in featuring in Revival) ma
lo fa talmente bene da far ripartire la giostra del genere. Il disco è dedicato a Robert Jarvik, l’inventore del
cuore artificiale e NME ha appena dichiarato che il 2010
sarà l'anno del dubstep mentre oramai più voci parlano
di nuovo la lingua della drum'n'bass... Staremo a sentire.(7.2/10)
Marco Braggion
Pillowdiver - Sleeping Pills (12k,
Aprile 2009)
G enere : P ost - rock
Dopo la Sleeping Pills Series di Dj Olive, un altro
disco il cui intento è quello di farci dormire sonni tranquilli. La pillola, stavolta, ce la somministra Pillowdiver,
nom de plume di René Margraff, impiegato presso una
nota compagnia che si occupa di software musicali e chitarrista nei ritagli di tempo.
Quello rilasciato dalla sempre attenta 12k è il debutto assoluto di questo musicista di stanza a Berlino, ma
meglio, forse, avrebbe trovato collocazione nel catalogo
della Slaapwel, un'etichetta interessata esclusivamente a
musica "which is interesting enough to listen to, but boring
enough to fall asleep to.
Ciò che si ascolta nelle nove tracce in scaletta - piuttosto simili l'una all'altra, come è bene che sia in questi casi -, sono stanchi (addormentati?) giri melodici di
61
chitarra che si adagiano in maniera ricorsiva su fragili
detriti di elettronica (pare ci sia un synth, da qualche
parte), riverberi, rumorini assortiti. Molto post-rock guitar driven fine '90, insomma, a metà strada tra Tarentel
e certi (i peggiori) Labradford. Passare oltre all'uscita
n. 12k1055 (questa portandosi addosso il numero seriale 12k1054) dell'etichetta di Taylor Deupree, prego.(5.5/10)
Vincenzo Santarcangelo
Plasma Expander - Kimidanzeigen
(Wallace Records, Gennaio 2010)
G enere : noise - rock
Torna ad espandersi il Plasma, a distanza di tre anni
dall’esordio omonimo. E se a quel tempo si era dubbiosi
sulla natura concreta o estemporanea del progetto, Kimidanzeigen fuga ogni incertezza. Sempre in trio senza
basso (esce Mauro Podda e entra Marcello Pisanu, sempre alla chitarra baritono) e in modalità strumentale, il
trio sardo reitera il proprio amore per un sound datato,
reinventato a suon di mazzate noise/math-rock e deragliamenti free in precedenza solo accennati.
Come se un gruppo postrock d’inizi ’90 fosse finito
alla Amphetamine Reptile e avesse sottoposto le
chitarre ad un trattamento termico miscelando
così cerebralità e fisicità.
Kimidanzeigen è fatto
di groove azzeccatissimi
dall'impatto letale, improvvisazione libera e ricercata
strutturazione, elaborate ragnatele d'aggressività ad alto
peso specifico. Stupisce, inoltre, la grana del suono: una
resa quasi da live per potenza ed impatto, unita a una
cura certosina nell’equilibratura.
Plasma Expander è una macchina rodata che viaggia a
100 all’ora senza rischiare derapate o testa coda.(7/10)
Stefano Pifferi
Portico Quartet - Isla (Real World,
Ottobre 2009)
G enere : jazz
Il jazz sognante e ‘ambience’ del quartetto londinese
prende le mosse da un amore incondizionato per le percussioni balinesi esplorate dal maestro Steve Reich (in
particolare lo hang, strumento simile allo mbira con dei
risuonatori che emettono un particolare riverbero di
armonici) e da guizzi melodici (dai sax di Jack Wyllie) in
linea con l’estetica ECM.
Alla seconda prova sulla lunga distanza (dopo l’acclamato
62
esordio Knee Deep In The North Sea) i quattro esplorano
sonorità visionarie che coniugano la tecnica con la melodia (Dawn Patrol), la progressività minimalista con l’anima
(Line) e in generale un sentire smoooth da club, cose
da frac e cravattino che scoppiano in sporadici assalti e
assoli uberboost (Life Mast, Isla). Il jazz dei Portico non
a caso è stato notato dai guru del selecting mondiale,
Gilles Peterson incluso.
Il disco, registrato nei mitici studi di Abbey Road, è un
tributo all’eterogenità di Miles Davis tagliato Molvaer,
che si distingue per la superba tecnica e per il piglio deciso di quattro giovani a pane e DIYness. Ottimo per chi
ama il jazz onirico o il minimalismo infarcito di citazioni world. Per i non addetti sarà una bellissima sorpresa.
Give ‘em a try!(7.3/10)
Marco Braggion
Quitzow - Juice Water (Young Love,
Febbraio 2010)
G enere : dance - pop
La diagonale M.I.A./Santogold continua a fare proseliti. Ninfette sensuali e riottose, meglio se di razza mista,
imbracciano synth, vocoder e chincaglieria più o meno
elettronica per dare vita ai propri personali anthem generazionali. Ne è ottimo esempio l’opener Let Out All The
Crazy, dal nuovo album di Quitzow, artista americana
che di nome fa Erica e di professione la musicista, produttrice, compositrice e quant’altro.
Un concentrato ipervitaminico di ritmi dancey e propulsioni electro, slanci CSS e sintetici appigli Daft Punk
virati Kraftwerk, misti a sensibilità pop melodica a grana grossa e aspirazioni da dancehall alternativo (ma non
troppo): roba che, man mano scorre l’album, include riferimenti e suggestioni altre rispetto ai canoni di genere (l’hard-pop-rock cafone e sintetico di Money Talks, le
ballads radioheadiane Race Car e Race Car 2). La ragazza
è eclettica - presta voce e violino anche al nuovo Setting Sun di Gary Levitt che ricambia suonando qua e
là - e dimostra di avere attitudine e buon orecchio nel
cogliere i trend del momento, piegandoli al proprio gusto personale. (6.5/10)
highlight
Richard Skelton - Landings (Type Records, Gennaio 2010)
G enere : modern cl as sical , ambient folk
Riprendo qui quello che Richard mi disse qualche anno fa: “E’ stata la scoperta che certi posti avevano una
risonanza acustica particolare - ponti, pozzi e altri posti chiusi - ad attirarmi fuori con la mia chitarra. Quando
questo accade, al principio mi sento un po’ vulnerabile, specie se sono da solo, ma diventa subito come una seconda vita. Ora come ora, spesso suono in posti che hanno una risonanza emozionale, più che acustica, sebbene sia
davvero grande quando le due cose coesistono. In pratica, Landings è un tentativo di creare una connessione più
intima con i paesaggi e di esplorare un senso di identità con i luoghi. Ogni lavoro è “site-specific” e spesso finisce
per essere un’offerta musicale, un oggetto che letteralmente si lega al posto in cui è stato fatto”.
Poco altro da aggiungere, perché la mission artistica è chiarissima, così come
la musica, che ha ormai da tempo lasciato qualsiasi dimensione temporale
per legarsi ad una indefinita eternità senza tempo e facendo del suo autore
una sorta di paradigma. Nè folk, né classico, né assolutamente niente altro,
forte di un linguaggio ormai così personale che è arrivato ad essere del tutto autonomo. A conti fatti non è neppure un musicista tout court, quanto
proprio un impressionista, alla maniera dei migliori paesaggisti britannici. E
l’uomo come misura e protagonista del paesaggio è il connettore delle emozioni che si muovono in Landings. Una questione a forte presa di fascinazione
come testimoniano le parole del libro in copia limitata che accompagna il disco e costituisce una sorta
di avvincente e poetico diario delle registrazioni, la cui lavorazione è durata per quattro anni, dal 2005 al
2008, muovendosi nella zona inglese del Lancashire, ed in particolare ad Anglezarke, nella zona rurale di
West Pennine Moors.
E’ dalla perdita di sua moglie Louise che parte questa sorta di randagismo ristoratore, che comincia a far
lentamente fluire energia nuova nelle vene, come si sorprende a testimoniare Richard stesso nel libro:
“More and more I was drawn to those low hills, wreathed in heather and pale grasses, and I discovered there
something analogous to my own experience of grief: a connection with the land itself through its hidden narratives of displacement and loss; a solace in the regenerative cycles of nature, as enacted in its wood and meadows
throughout the changing seasons”. La musica quindi si compenetra con l’elemento naturale, limitandosi non
soltanto all’uso degli sparsi field recordings che si avvertono qui e li nel disco, quanto proprio a mimarne
l’umore e la cadenza, il ritmo e il respiro.
Richard entra così in contatto con due fattorie diroccate chiamate Hempshaws e Old Rachels. Comincia a
suonarci dentro, attorno, di fronte. Comincia ad interessarsi alla storia e alle vicende di queste costruzioni.
Chi ci ha vissuto, come si sono trasformate nel tempo, che storia hanno avuto. Comincia quasi istintivamente ad immedesimarsi con questi spazi e il racconto stesso diventa la cronaca di una rinascita e di un
legame atavico inscindibile dalla propria terra.
“Approaching this outcrop of trees, the atmosphere hits me forcibly. The pitiable nakedness of the boughs and
branches.The sudden murmuring of the wind. Colluding. I want to make some kind of gesture. An offering. A mark
of passing. And to leave it here.Tied to the land”.(8/10)
Antonello Comunale
Stefano Pifferi
Radian - Chimeric (Thrill Jockey,
Dicembre 2009)
G enere : digital , chamber , post
Di quella creatura di carne e circuiti chiamata Radian
spendemmo giusti e sacrosanti elogi nell'anno di Juxtaposition, album che segna tuttora il capolavoro del
combo, nonché uno dei massimi sunti del dopo Slint.
Allora il trio aveva convinto portando, dieci anni dopo,
la lezione di Louisville negli anni zero del dopo glitch, e
prendendosi il meglio delle intuizioni in fatto di cutting
digitale e polveri industrial, succhiando dalla politicizzata
Mille Plateaux il meglio che potesse esportare. Poi c'era
the other side dei Radian meditativi e a un passo da certe
umbratilità cantautorali, vicini, per assunti di partenza, ai
cugini Autistic Daughters. Un altro cerchio comple-
tava un quadro quasi invisibile mediaticamente, eppure
decisivo, di culto massimo. Oggi, dopo quattro lunghi anni da tutto questo, i viennesi
ripartono cercando d'azzerare le lancette della memoria
senza cedere all'urgenza dell'atto, lasciando così che la
"giustapposizione" in missaggio amplifichi, raddoppi, massifichi la semplicità del suonato come un tempo.
63
highlight
Terre Thaemlitz/Dj Sprinkles - Midtown 120 Blues (Mule Musiq,
Gennaio 2009)
G enere : deep ambient house
House isn’t so much a sound as a situation... E lo capisci che questo non è un disco qualsiasi. Lo recensiamo
a più di un anno dall'uscita, consci dell’imperdonabile ritardo e in seguito all'insistenza con la quale lo abbiamo notato nelle chart di fine anno di mezzo mondo.
Non parlarne sarebbe un reato, peccare d'orgoglio diabolico: Midtown 120
Blues è un concentrato stile e 100% anima, l’house che ha in sè il blues,
l'omaggio di Terre Thaemlitz ai vecchi tempi dei club newyorkesi; il thrill
che attraversava la spina dorsale, la nostalgia del contesto da cui il suono
nasce (ovvero la disoccupazione, il movimento gay, il razzismo, l’HIV, la droga,
l’alcool) e da lì calarsi in una catarsi prima generazionale, poi etnica e infine
universale.
Un viaggio in una ambient house dai divini tagli deep che toglie il respiro, salti
temporali dal 1990-1991 giù fino al 1986-1987 in 120 bpm di oscurità che riprendono la lezione di Burial
e la elevano a purezza estrema, tocchi nel tunnel black che sentivi in Chatterton, pesi massimi dell’analisi
del ritmo vincolata da un patto di sangue con la depressione (quindi con la blackness).
Trascendono i generi di riferimenti, si diventa pura poesia urbana. Un disco che non si risolve mai, ogni
volta che lo si suona ne escono nuove lacrime e nuovi sorrisi. Geniale Terre. Un disco oltre il 2009. Un
disco da storia dell'house nation.(7.75/10)
Marco Braggion
Sparhawk riparte da dove si era fermato, ovvero una voglia di scarica radicale, risalire la miccia fino all'innesco
country rock - con escursioni power pop, palpiti psych e
qualche tentazione hard - accaduto nella cuspide tra Sessanta e Settanta. Come se tre lustri passati a masticare,
affinare, rimpolpare slowcore con la band madre fosse
stato una conseguenza di quell'imprinting, un ricercarvi i
codici e le declinazioni per il sentire contemporaneo.
Capita quindi di sentirci un senso di atto dovuto (non
a caso il debutto era omonimo e questo s'intitola semplicemente 2), di missione da compiere anzi compiuta.
Ci senti divertissement, inessenzialità ma anche un bel
piglio sbrigliato e brusco da roba suonata per arrivare
al bersaglio senza troppo garbo né giravolte. Divertitevi allora con l'apocrifo AC/DC di White Wolf, col Tom
Petty carburato Big Star di Workin' Hard, col denso
mesmerismo da Crazy Horse narcolettici di Electric
Guitar, oppure semplicemente con l'innodia gridata al
cielo di Hide It Away. Per poi acquietarvi nel drone weird
folk di Bless Us All, che ancora un altro po' e ti ricorda un
Peter Gabriel nientemeno.
Disco tutt'altro che indispensabile, ma ben fatto.(6.9/10)
Stefano Solventi
Un percorso noto che Chimeric gioca "in sottrazione"
proprio per tornare a una purezza caparbiamente messa
al centro della scena, un reset simile ai recenti Tortoise
(Chimera a ricordarcelo particolarmente) con analoghi
risultati per efficacia e riuscita.
Tra momenti potenti e filler interlocutori, i richiami alle
tenebre Einstürzende Neubauten sono tra le cose
migliori, ma complessivamente siamo lontani dallo sturm
und drang che aveva reso grande la prova della maturità.
Emblematica pertanto la marittima Subcolors che ricorda
i fine Novanta di Labradford (già in odor di Pan American) la cui inconsistenza senza impeto, né tensione, né
catarsi, rimane senza un perché. (6.8/10)
Edoardo Bridda
Rebel (The) - The Incredible Hulk
(Junior Aspirin, Gennaio 2010)
G enere : N on - sense C ountry
Ben Wallers è un tipo iper prolifico, si sa. Già da due
lustri, parallelamente ai più noti Country Teasers, rilascia materiale solista a nome The Rebel. Le differenze
tra i due progetti spesso stentano ad emergere, ma chi
ama la voce nasale e stizzita del londinese non avrà di
che risentirsi. Del 2008 è l’ottimo Northern Rocks Bear
Weird Vegetable (su Sacred Bones) e dell’anno scorso lo
64
scarsamente utile Mouthwatering Claustrophobic
Changes! (su Junior Aspirin), il primo un bel disco in
pieno stile Teasers, l’ultimo un tedioso collage di rumori
gastro-intestinali.
Il nuovo, ennesimo, capitolo della saga si posiziona a
metà strada. Piccole gemme di country al metadone
come solo lui sa (Aiming Low, Getting High) emergono
qua e la tra la coltre di demenza DIY. Demenza che è il
vero motore e collante, a partire dal titolo, passando per
la grafica da bambino disturbato realizzata (ovviamente)
dallo stesso Wallers. Fino ad arrivare allo zenith della
malattia: la cover di The Forest dei Cure, non suonata
come ci aspetterebbe, bensì presa pari pari e incollata
nell’album con l’aggiunta di scratch e locked groove.
I fan del ribelle sono preparati e solo a loro si rivolge
The Incredible Hulk.(6.9/10)
Andrea Napoli
Retribution Gospel Choir - 2 (Sub
Pop, Febbraio 2010)
G enere : psych rock
Sostituito Matt Livingston con Steve Garrington al basso,
e chiamato Eric Swanson (già al lavoro con Maroon 5
e ovviamente Low) al posto di Mark Kozelek alla produzione, il progetto Retribution Gospel Choir di Alan
RJD2 - The Colossus (RJ's
Electrical Connections, Gennaio
2010)
G enere : funk - hop + indiepop
Dopo un buon ep di inediti del periodo 2002-2007
(parte di un costoso cofanetto celebrativo uscito a fine
2009), ecco il quarto album di Ramble John Krohn aka
RJD2, disponibile in digital download per la sua label
personale.
Il taglio appare da subito piuttosto compilativo: c'è l'RJ
classico, produttore di un gustoso funk-hop di maniera,
legatissimo agli anni Novanta (trip-hop Mo' Wax e Ninja
Tune; l'RJ degli esordi - ricordiamolo - definito da molti
"the next DJ Shadow"), e c'è l'RJ - espostosi col terzo
criticatissimo album - autore di canzoncine indie tutte
"suonate" e cantate. Si tratta di pezzi funky-soul-pop che
strizzano l'occhio agli anni Ottanta (The Glow), artigianali
e naiffissimi, animati da una passione tanto sincera da
sembrare ingenua, quasi commoventi.
Una prova scomposta e imperfetta, ma convincente,
graziata da un tocco orgogliosamente inattuale e immediatamente riconoscibile. Disco assolutamente minore,
piccolo grande spasso.(7/10)
Gabriele Marino
Rollerball - Two Feathers
(Wallace Records, Febbraio 2010)
G enere : avant - rock
Ma sì, stavolta partiamo dalla fine. Senza farla troppo lunga col proverbiale “ogni fine è un nuovo inizio” ascoltiamo Spool, traccia finale del nuovo album del collettivo
di Portland e lì ci si chiarisce tutto, o quasi. I Rollerball
vengono da un altro pianeta e Spool è il portale attraverso il quale ritorneranno lassù, in qualche sperduto ed
evoluto pianeta, lontano anni luce da questa nostra Terra
così ottusa e miope. Sette minuti abbondanti di droning
alieno che sembra la rielaborazione di onde radio perse
nel vuoto del cosmo. Letteralmente.
Un gioco, ovviamente, il nostro, perché 15 anni e quasi altrettanti dischi dopo
l’inizio di una carriera sfavillante e giocata costantemente a livelli altissimi è
inutile mettersi lì a tentare
descrizioni o elaborare definizioni che non siano la
solita accozzaglia di aggettivi tronfi e ritriti. I Rollerball
sono loro stessi, da sempre e per sempre e Two Feathers
non sfugge alla regola. Punto e basta. Hanno dalla loro la
capacità (a questo punto legittimamente ultraterrena) di
costruire canzoni che sono minisuite iridescenti, piccoli
microcosmi sonori in cui trova degno alloggio ogni genere musicale (psych, jazz, rock, avantgarde) concepito
dall’uomo e messo in scena da un combo di grandissimi
artisti. Umili e normali, ma con una immensa capacità
nel creare sogni in musica. Cosa ben evidente nel dvd
allegato che mostra spezzoni di live, qualche video, un
mini-film dal titolo Two Brunos (con Ronin e Ovo in giro
per l’Europa) e una splendida improvvisazione collettiva
con Jacopo Andreini dal titolo Jacopo’s House. Il problema di fondo è che la maggioranza degli umani purtroppo non ha i mezzi per comprendere la Bellezza che i
Rollerball sistematicamente pongono di fronte a occhi e
orecchie.(7.4/10)
Stefano Pifferi
Rothkamm - ALT (Baskaru, Ottobre
2009)
G enere : E lettronica pura
Dunque Frank Holger Rothkamm è un genio per davvero. E' in grado di passare con rimarchevole disinvolutura
da tamarrate come il recente Frank Genius Is Star
Truck (Flux, 2009: cantata digitale che si risolve in un
terribile mesh-up di old-school disco, big beats, acid house...) e la celeberrima Opus Spongebobicum (quaran65
ta variazioni ispirate a - udite, udite - Spongebob) a questo ALT, ossia un vero e proprio arcano sonoro sotto
forma di sci-fi ambient music.
Quello del misterioso sound-artist e produttore tedesco
- ma da tempo stabilitosi negli Stati Uniti - è un affascinante viaggio tra paesaggi
sonori lunari (molto simili
a quelli ritratti in copertina) che, fuor di metafora,
sono suoni di una semplicità disarmante generati
con macchine analogiche e
disposti nello spazio sonoro con complessi algoritmi
(proprio come si faceva una volta) e un'eleganza che è
merce sempre più rara in contesti di musica di ricerca.
In un'ideale - quanto fantomatico - studio di fonologia
vintage, Frank Rothkamm appronta gli ultimi ritocchi a
una navicella spaziale che emette sibili, sinusoidi di suono, inquietanti borbottii, drone da ammassi galattici. E
che è ferma, ferma ancora per poco. Il consiglio è di imbarcarsi al più presto...(7.3/10)
Vincenzo Santarcangelo
Scarlatti Garage - Strane idee
(SuoniVisioni, Gennaio 2010)
G enere : rock
L'esordio dei napoletani Scarlatti Garage si sarebbe
potuto chiamare anche Heavy Soul. Un Heavy Soul
estremamente melodico, finanche pop, decisamente attuale, su un impianto strumentale che tocca funk, punk,
wave, canzone autoctona e mid-tempo à la Radiohead.
Il soul va rintracciato nel tratto distintivo del gruppo, la
voce di Dario Lapellazzuli, sorta di via di mezzo tra
Fausto Leali, Paul Weller e Mario Venuti. Identità timbrica
che va di pari passo con arrangiamenti senza sbavature,
lontani dai beat banali che spesso si ascoltano in produzioni del genere.
Personalità per il gruppo non significa sperimentazione
o originalità a tutti i costi, ma credibilità. Una credibilità
che gli permette di flirtate con il levare in stile Franz
Ferdinand di Non è colpa mia senza suonare datato, di
citare gli Hives in Mr. Blu su un sax decontestualizzante,
di incastrare i Perturbazione su certe chitarre Rolling
Stones (quelle di Mixed Emotions) e una melodia rubata ai Sessanta italiani ne L'uomo nero. Per poi ritrovarsi
nella sigla di chiusura della trasmissione Demo di Radio
Rai con il pop-rock elaborato de La radio.
Niente pose e molta sostanza, oltre alla capacità di rinnovarsi nei limiti del trad. rock.(7.2/10)
Fabrizio Zampighi
66
Scuba/AA.VV. - Sub:stance - Mixed
By Scuba (Ostgut Ton, Gennaio
2010)
G enere : dubstep , d ' n ’ b
Dopo la migrazione a Berlino, Scuba sforna una compilation di drum’n’bass (ormai confermato come moda
dell’anno), jungle (sì, proprio quella con le voci soul dei
4 Hero) e inevitabilmente ambientstep (il biglietto da
visita di sempre).
Il viaggio - ancorato a ricordi rave '90 - non si fossilizza
sul past, bensì sul present perfect del pianeta step con
Shackleton, Ramadanman e Joy Orbison, oltre agli
inediti dello stesso Paul Rose (e qualche picciotto che
si bacia le mani per essere stato inserito in questa selecta).
Grande gusto da notti berlinesi al Berghain ma ora è
giunto il momento di dare un seguito a A Mutual Antipathy...(7/10)
Marco Braggion
Seabear - We Built A Fire (Morr
Music, Febbraio 2010)
G enere : I ndie pop
Messo sotto il naso l'indie pop del nuovo lavoro di Sindri Màr Sigfùsson e co. e i profumi parlano una lingua
decisamente commestibile e digerita. C'è un sottobosco islandese che vuole un artigianato certosino per le
proprie canzoni, e una musica che sa della propria terra
e che subisce inevitabilmente il fascino delle americhe.
Dalla svolta adulta dei Mùm non si torna indietro, dalle
coralità canadesi neppure e così, mentre i tempi di elettroniche e astrattismi s'allontanano definitivamente, lo
scenario dei Seabear si tinge di un bel folclore a diverse
latitudini (fanfare, bandismi di paese, feedle di strada...),
oltre alle consuete strutture country e rock. La particolarità di questi arrangiamenti è la mancata urgenza d'esecuzione (oltre che la loro eccessiva rotondità). Se oggi sembra essere una regola ascritta, per Sindri
vale la strategia opposta: docilità e maniera ordinano
ogni cosa, persino strofe e ritornelli la cui scrittura mostra non poche perplessità e dubbia personalità. Emblematica a tal proposito l'impalpabilità e la piatta riuscita
della nuda ballata piano/voce (e crescendo) Cold Summer, come sgamatissimi gli airbag melodici sia quando
si rifanno a Sufjan Stevens (Wooden Teeth) sia quando
riecheggiano i Radar Bros (Leafmask).
Il difetto è quello dell'indiepop, del resto l'antidoto di
We Built A Fire l'abbiamo capito: certosino artigianato
che alle volte si basta e vuole bastarci.(6.3/10)
Edoardo Bridda
Secondamarea - Canzoni a
carburo. Memoria e miniera
(Stampa Alternativa, Novembre
2009)
G enere : canzone d ' autore
In Italia le miniere le hanno chiuse, ma solo per spostarle
dove manodopera ed estrazione costano meno e fanno
morti più silenziosi. I giacimenti dismessi sono diventati
musei o peggio discariche illegali (ma anche legali) di materiali altamente nocivi. Canzoni a carburo. Memoria
e miniera ravviva in un disco di quindici canzoni e un
libro non meno denso la memoria di un mestiere maledetto e dimenticato come quello del minatore, che fece
morti (Marcinelle, Monongah, Courrières), spacco famiglie e schiene, e con la silicosi i fiati di tanti uomini, fino
alla morte, adulti quanto bambini.
I Secondamarea, duo
toscano formato da Ilaria
Becchino e Andrea Biscaro,
hanno fatto prima di tutto
un lavoro di ricerca tra la
storia e la letteratura, radunando nel libro tante foto
importanti, e poi stralci di
articoli di giornale, atti di
convegni e brani di Bianciardi, Pasolini, Weil e dello
scrittore-minatore sardo
Manlio Massole. A completamento le canzoni, per lo più
autografe o vergate su testi dello stesso Massole, ma anche di Bassani ed Erri De Luca, in canovacci di folk scarnificato, per chitarra, contrabbasso, qualche volta fisarmonica e clarino (di Gabriele Mirabassi), con la voce della
Becchino vibrante e popolare lungo la strada di Giovanna Daffini e soprattutto Caterina Bueno e quella di
Biscaro più normalizzata, quasi dimessa.
Una raccolta di tracce dai toni elegiaci ed austeri, che
nel descrivere la vita di miniera evitano ogni eroismo
e nostalgica revanche, andando invece a sondarne tanti
aspetti, dalla condizione femminile allo spopolamento
di intere città (la desolata Ombre, dove le due voci s'incrociano), e mettendo bene in chiaro - vedi la vigorosa
reinterpretazione del tradizionale Maremma in chiusura
- come la storia di uomini e donne senza nome mandati
sottoterra prima del tempo, e spesso per rimanerci,
faccia parte della spina dorsale di questo Paese disgraziato e di questo pianeta tutto, ieri come oggi.(6.8/10)
Luca Barachetti
Setting Sun - Fantasurreal (Young
Love, Febbraio 2010)
G enere : pop
L’eleganza austera dei Tindersticks, l’accessibile ricercatezza di Beatles e figliocci, la malinconica e cristallina
classe dei Black Heart Procession. No, non esattamente in quest’ordine e nemmeno fino in fondo, in realtà, ma il nuovo album di Gary Levitt a.k.a. Setting Sun
può ricordare questi mostri sacri per la capacità di scrivere canzoni pop sofisticate e affascinanti senza risultare
mai banale.
Ora solari e spensierate (Into The Wire), ora inclinate
sul versante più psych-pop (Driving), aperte verso suggestioni mediorientali (I Love Mellotrons) o reminiscenti
del pop obliquo della Beta Band (Make You Feel), tradizionalmente americana (The Tree, Handsome Bridge) alla
maniera del Tom Petty meno banale o memori di certe
melodie umbratili e tristemente fanfaresche di Pall Jenkins (One Time Around): le canzoni di Fantasurreal sono
quadretti pop a tutto tondo, crocevia di suoni e sensazioni che si trasformano in piccole gioie grazie alla naturale e misteriosa alchimia che incolla l’ascoltatore allo
stereo. Una mezz’oretta di evasione da consigliare a tutti.
Indistintamente.(6.7/10)
Stefano Pifferi
Shearwater - The Golden
Archipelago (Matador, Febbraio
2010)
G enere : indie prog
A giudicare un disco dalla copertina si fa peccato, tuttavia qualche volta si s’azzecca. Dietro un’orrida foto
metà ultimi Pink Floyd e metà Alan Parson Project
si nasconde The Golden Arcipelago, terzo pannello di un
trittico iniziato nel 2006 da Palo Santo e, due anni più
tardi, dal convincente Rook. Lavori che in ambito indie
trafficavano col vituperato “concept album” senza raggiungere le vette di Decemberist o Richard Buckner, ma nemmeno scadendo in autocompiacimento e
prolissità. Che sono esattamente le tagliole in cui il deus
ex machina Jonathan Meiburg incappa qui, complice la
presenza al mixer di un John Congleton non contento
dei disastri combinati con i Black Mountain.
Va infatti benissimo discutere di problematiche ambientali e ricordi di famiglia, meglio ancora se documentandosi sul campo con viaggi nella Terra del Fuoco e alle
Galapagos, ma altra faccenda è affidare il tutto a una
pacchiana grandeur sonora. Prendete la buccia dei Talk
Talk di The Color Of Spring, allorché lasciavano il
new pop per spingersi oltre il rock; venatela di folk e
soprattutto progressive e soffiateci dentro il gigantismo
67
dei Simple Minds. Poiché di Arcade Fire non ne nascono a ogni decennio, accade che una scrittura di già
sottotono rimane soffocata da arrangiamenti enfatici,
ridondanze ritmiche e vocalità lamentosa. Uniche oasi
autenticamente affabulatorie, le soffuse An Insular Life e
Missing Islands non arginano prosopopea e irritazione.
Più una palude che un arcipelago, insomma.(5.5/10)
Giancarlo Turra
Silver Mt. Zion Orchestra & TraLa-La Band - Kollaps Tradixionales
(Constellation Records, Febbraio
2010)
G enere : post - rock
Esistono molte differenti maniere per affrontare un cambiamento. Sin dall’inizio un collettivo, la Banda del Monte
Sion ha dimostrato in otto anni una solidità d’intenti e
azioni rara, invidiabile; attestati di rilievo la discografia
a cadenza regolare e senza macchie e il sostegno,
di questi tempi ancor più
struggente, a Vic Chesnutt in una fase altissima
della sua carriera. Ragion
per cui c’era attesa attorno
a questo sesto disco, frutto di un non indifferente
rimescolamento d’organico avvenuto nell’estate di due
anni fa.
C’è un nuovo batterista - David Payant: solido e preparato - a compensare la dipartita di un “Tra-La-La Band”
nella ragione sociale e di tre membri. Succede dunque
che, di fronte alle scelte, si fa quadrato attaccandosi a ciò
che meglio si conosce, pur con un atteggiamento diverso. Ridotta a quintetto (ecco gli archi di Sophie Trudeau e Jessica Moss ancorati al basso di Thierry Amar),
la ribattezzata Thee Silver Mt. Zion Memorial Orchestra toglie gli ultimi veli rimasti all’umanità del suo
post-rock con risultato sublime, che dona concretezza e
calore a un genere che preferiva il distacco oggettivo e
l’accantonamento delle emozioni.
Conseguenza ne è che l’album sia, più del solito, un bagno di spiritualità che risale ai padri fondatori (Kollaps
Tradicional: gli Amon Düül II che rileggono Scarborough
Fair; I Built Myself A Metal Bird: echi di Can e dei Savage
Republic maturi). Ritrovi i tratti caratteristici di uno stile e non potrebbe essere altrimenti: presenti all'appello
l'impasto strumentale, le pause e i riverberi che spazzano
via, quel linguaggio composito eppure mai balbettante, la
voce di Efrim Menuck che scava dentro l’anima. L’insieme è tuttavia meno apocalittico, sovente addirittura
68
elegiaco con un piglio virile (‘Piphany Rambler, There Is A
Light), così da condensare ansia e rabbia come soltanto a
una certa età si può: ragionando calmi prima di uscire a
spaccare le vetrine.
E solo se necessario, senza scadere nel melodramma o
nella prosopopea, senza parlarsi né suonarsi addosso,
senza consegnare il genio ai vicoli ciechi. Raccogliendo
la propria poetica in un solido gheriglio la si è resa più
vibrante, nel frattempo mostrando che le cose sono
cambiate. E’ una nuova pelle, un’altra identità che della
precedente trattiene lo spirito. Per questo scintilla più
che mai.(7.3/10)
Giancarlo Turra
Sister Iodine - Flame Desastre
(Editions Mego, Novembre 2009)
G enere : A vant -N oise
Sister Iodine è in giro sin dall'inizio degli anni '90. All'epoca la band suonava una sorta di noise/no-wave e condivideva palchi con Faust, Sonic Youth, The Ex. Fermi
per oltre sette anni causa il trasferimento di uno dei
componenti negli States, tornano in scena nel 2007 con
Hale, quindi Flame Desastre, dapprima uscito in vinile per
Premier Sang e, in seguito, in cd per un'insolita (per il
genere trattato) produzione Editions Mego.
Di fatto, dopo il lungo iato, il trio francese il tiro l'ha spostato parecchio: un noise-rock di chitarre e sintetizzatori
dalla grana ruvida più simile a Wolf Eyes e Hair Police
che a DNA o Mars; rispetto ai toni disperati della band
di Ann Arbor però, il rumore qui è arreso, remissivo.
Densi fasci di frequenze si muovono lineari, come conati
di suono, pulsano ordinati lungo le scheletriche cadenze
ritmiche in un incedere circolare. Il rumore è confinato in
uno stretto controllo come se il loro intento fosse l'esistenzialismo francese, noise rock allo Spleen.(7.1/10)
Leonardo Amico
Skiantos - Phogna (Universal,
Dicembre 2009)
G enere : R ock demenziale
Si può annunciare un disco "serio" fatto di brani "più
intimisti" e definirlo il "The dark side of te Skiantos" sbagliando l'ordine dei titoli in copertina?
Si può e oltretutto, le note parlano della "prima volta"
degli Skiantos, gente che dei brani inediti di quest'eppì
ne fanno dal 1989 (da Troppo rischio… fino al recente live Skonnessi). Tentativo d'aggiornare l'immagine o
no soltanto Deserto di parole (ballata rock senza ironia
e giochi di parole, danneggiata da una produzione 80s)
corrisponde agli slogan e ci troviamo una riuscita cover
di Uno di questi giorni ti sposerò, un Tenco che era diffi-
highlight
Toro Y Moi - Causers Of This (Carpark Records, Febbraio 2010)
G enere : poptronica glo - fi
Cosa resterà degli anni 80? Sentendo il debutto di Chaz Bundick, la sensazione è che restano eccome.
L'onda lunga del revival Ottanta non ne vuole sapere di scivolare via dalle lenti (antiriflesso) degli occhialuti nerd d'oggi, e attenzione ai metri quadrati in cameretta. Per Causers Of
This, primo di una doppietta annunciata di long playing, troviamo un ragazzo
a stendere ponti ideale tra l'america di provincia glo e le istanze Ottanta
Novanta della chillout (Thanks Vision) e da lì risalire al presente bbreaking
di Bibio e compagnia vintage step (Lissoms, Freak Love) fino a certi Animal
Collective (Blessa).
I tocchi di clavietta Bontempi da festina delle medie (Low Shoulder), la lounge
blackness dal tocco funk diluito (Imprint After), oppure il soul soundtrack da
soft porno firmato Joe D’Amato (You Hid), la dicono lunga anche sulla varietà
del proposto. Se Washed Out, lavava via letteralmente gli Ottanta sgocciolandoci qualche lacrimuccia da
coccodrillo, lui, con spocchia intellettualoide che chiama Londra (e quel fascino discreto borghese) incarna
l'androgino in ritirata suburbica tra droghine sintetiche e un doppio alla Playstation. L'alloggio è di stanza
Brooklin e non più nell'america veramente tale.
Tra tutti i glo-fier sarà anche il più paraculo, nondimeno è uno dei più scafati e ammalianti nel dominare
le influneze emerse fin'ora nel sottobosco dei paesi che masticano l'English. Toro non guarda indietro
rincorrendo qualche trip amniotico, gioca con l'House di Knuckles e taglia di laptop. Lo metti in pista e fa
ballare senza troppe seghe (Lissoms), Blessa infine, già singolo pubblicato nel 2009, ne è il perfetto biglietto
da visita. Come se i Collective venissero stravolti da Washed Out. Da avere.(7.2/10)
Edoardo Bridda
cile immaginarsi rock-blues e invece ne esce benissimo,
torrido il giusto e credibile nella distanza dall'originale.(6.8/10)
Giulio Pasquali
Sole/Skyrider Band - Plastique
(Fake Four Inc., Ottobre 2009)
G enere : electro - rock - hop
Per tutto il 2008-2009 la crew Anticon - dentro e fuori
dalla label - ha alternato prove in cui è parsa riprendersi
dal torpore in cui era caduta dopo i primissimi Duemila ad altre in cui si è mostrata la stanca portavoce di
un'estetica fuori tempo massimo che probabilmente è.
A quest'ultima categoria appartiene anche la seconda
uscita di Tim Holland aka Sole (uno dei fondatori di Anticon, rapper capace di affilati stream-of-consciousness
ma finora sempre poco decisivo sotto il profilo musicale) assieme alla Skyrider Band (il produttore Bud
Berning, il giovanissimo musicologo e polistrumentista
William Ryan Fritch, il batterista John Wagner).
Meno apocalittico del precedente, sempre calato però in
un'atmosfera ansiogena, frutto del ritiro di Sole lontano
dalla città e immerso nelle sue letture (dal filosofo della
postmodernità Jean Baudrillard al vate americano Walt
Whitman), è - ancora una volta - una serrata invettiva
contro il mondo di plastica in cui viviamo. Fin qui. I pezzi
però - anche quelli migliori, come la Battlefields col feat
di Archer dei Notwist - deludono tanto per le basi (che
peggiorano la maniera Anticon in un rock-elettroindustrial appesantito da tante enfatiche emo-tastiere, basi
alla fine un po' tutte uguali tra loro), quanto per il rappato (che, pur serrato e aggressivo, non intriga mai davvero), quanto ancora per le lyrics (sempre abbastanza
"qualunquismo contro").
Un riciclo non particolarmente ispirato.(4.9/10)
Gabriele Marino
Souljazz Orchestra (The) - Rising
Sun (Strut Records, Febbraio 2010)
G enere : afro jazz
I precedenti lavori per Do Right!, Freedom No Go Die
(2006) e Manifesto (2008), hanno imposto la Souljazz orchestra come fervida realtà dell’odierno panorama neofunk-afro-jazz. Il passaggio nella casa del rinato Mulatu
Astatke, ne consolida la posizione. Presentato come il
loro album afro-jazz acustico, The Rising Sun combina la
69
highlight
Vampire Weekend - Contra (XL Recordings, Gennaio 2010)
G enere : pop
Hype incredibile, per Contra, forse di una consistenza mai vista nell’indie internazionale. Non si tratta
solo dei soliti fake buttati nei p2p, o delle anticipazioni e delle pillole che non fanno che aumentare l’astinenza: attorno al seguito del self-titled dei Vampire Weekend si è creata un’attesa di una qualità diversa,
trasversale, perchè instillata non solo nei fan ma anche nella critica. Con una settimana di anticipo rispetto
all’uscita ufficiale, è ufficialmente lanciato il fotofinish del recensore, grazie
alla pubblicazione sul My Space di tutto l’album, che macina migliaia di click
al giorno.
E non c'è un ma: la band dimostra di saper fare il mestiere che è chiamata
a fare, ovvero, al di là di tutto, scrivere canzoni convincenti. La formula non
cambia, a primissimo ascolto. Il rondò in levare di Holiday rasenta la manualistica (nel rapporto refrain / strofa, pieno / vuoto) quanto la perfezione,
specie nell’incastro di comprensibilità ed efficacia complete di chitarra e
batteria. Due minuti o poco più. I VW sanno quando essere più scoppiettanti (sentite il tiro di Cousins, ma forse l’avete già fatto, guardando il video da un po’ presente sul tubo) e
quando esserlo meno (Taxi Club). Sanno come guardarsi allo specchio ma anche come prendersi qualche
libertà, nella forma di parziali aperture negli arrangiamenti. Questi ultimi sono la vera novità che c’è e
non c’è. O meglio, c’è, ma con l'oculatezza di mettere il marchio inequivocabilmente VW sulle molteplici
peregrinazioni presenti a volte dentro lo stesso brano. Estraendo dal cilindro, sul finale di Run (episodio
armonicamente meno convincente), persino i New Order. Oppure occhieggiando divertiti e tra le righe
alla dance hall, in Diplomat’s Son, prima che gli archi e la drum machine ci portino su altri paesaggi. E, volgendo al termine, allentando la presa in I Think Ur A Contra.
Contra è l’ideale compendio di Vampire Weekend. Solfeggio di cantautorato balearico, Police-iano,
indorato e comunque secco, diretto, attualissimo. Esercizio di stile pop. Auto-manuale. Una sostanziale
conferma di uno stile unico al mondo, fatta dal di dentro, perché in realtà i vampiri stanno giocando con
se stessi, lo abbiamo capito. Per un sophomore è già molto, no?(7.2/10)
Gaspare Caliri
febbrile verve di Fela Kuti con certo jazz trascendente,
in primis Pharaoh Sanders ma anche Marcus Belgrave.
Dopo l’inizio di velluto (Awakening), le danze partono con
l’afro-beat di Agbara a cui seguono gli arabeschi Ethiojazz di Negus Negast. Più spirituale di Nomo e Budos
Band (ma meno in your face degli Antibalas), il combo
canadese sa farsi easy listening senza cadere nel kitsch
(Lotus Flower e Serenity sembrano farina del miglior Belgrave) vestendo panni post-bop come si usava alla Blue
Note (Consecration). A chiudere, nonché a confermare,
la ripresa di un classico minore dello stesso Pharoah
Sanders, Rejoice (dall’omonimo lavoro del 1981), diviso
in due parti e fastoso come in origine.
Il fan Gilles Peterson dalle frequenze della BBC di sicuro
apprezzerà. Nondimeno noi.(7/10)
Gianni Avella
70
Spiral Stairs - The Real Feel
(Matador, Ottobre 2009)
G enere : mid - life indie rock
Ha anche un pregio lo scioglimento di una band. E cioè
che, da quel che avviene dopo, sovente ne capisci meglio
le dinamiche interne, il fatidico chi faceva cosa. Valga per
tutti l’esempio dei Pixies, nelle cui fila Kim Deal sembrava una comprimaria finché non ebbe modo di respirare a pieni polmoni con le Breeders. In termini contrari,
confermano l’assioma di cui sopra anche la produzione
di Stephen Malkmus - svanito dietro la propria controfigura - e anche quella di Scott Kanneberg a/k/a
Spiral Stairs. Le sortite a nome Preston School Of Industry si arenavano infatti dentro a un limbo incolore,
nell'incapacità di rifarsi una vita artistica credibile come
- tanto per restare tra “slacker” cresciuti - ad esempio
un Lou Barlow.
Questione di indole(nza) e di giocare di retroguardia an-
che nel momento in cui si esce da dietro il paravento
di una band e ci si aspetta una dichiarazione più significativa del solito, non sorridente gregariato che manco
s’avvicina a una canzone minore del gruppo madre. Vaga
tra corridoi bui e stanze vuote tenendosi stretti ricordi di gioventù fatti di risciacquature Modern Lovers ,
mediocrità sixties o country-rock, ogni tanto uno stanco
inseguire gli Smog. Siccome due indizi fanno una prova,
si capiscono i retroscena della recente reunion dei Pavement.(5/10)
l'intera l'operazione sembra francamente poco interessante.
Nota a margine: Wilson cura le ristampe audiofile per
i Crimson; Harrison, batterista dei Porcupine, suona
come membro aggiunto nei Crimson dal 2007; Pat Mastelotto, batterista dei Crimson dal '94, è qui presente
con un suo remix. Che ha il pregio di avere un suono immediatamente riconoscibile: quello del bruttissimo The
ConstruKction of Light (2000). Gli altri a remixare sono i
Dälek e Sitek dei Tv On The Radio: delusione.(4/10)
Giancarlo Turra
Gabriele Marino
Stan Ridgway/Pietra Wexstun Silly Songs For Kids, Vol. 1 (A440,
Ottobre 2009)
G enere : E lectro western
Uscito prima in versione EP digitale e poi in full-lenght
fisico, il curioso progetto vede l'ex Wall Of Voodoo e
signora dedicarsi alla musica per l'infanzia (benché non ci
risultino piccoli Stans e pur se autore e fans dovrebbero
essere ormai grandicelli per la cosa).
Lontano dalle favole in stile folk britannico con tocco
psichedelico Lewis Carroll nell'analogo progetto di Donovan del 1971 (il classico H.M.S.), i due si ispirano,
con l'eccezione delle puntate celtiche di Leprechaun Cave
Of Candy e Tale Of The Sea Witch, al country maturo ed
evoluto che caratterizza la recente produzione ridgwayana arricchito da tipiche incursioni di jazz notturno
(Spider's Web), spruzzate di elettronica (Feelin' So Lazy) e
r'n'r (Kooky's Cuckoo Clock).
La terra fantastica popolata di elfi e animali gode d'ispirazione, meno le vocine per bambini che fanno torto a
qualche pezzo (vedi Mountain Top). Ad ogni modo esperimento riuscito rivolto a grandi e piccini; entrambi, ne
siamo sicuri, ugualmente inquietati dallo stile infantile
e minaccioso del Mark Ryden che firma la copertina.(7.1/10)
Giulio Pasquali
Steven Wilson - NSRGNTS RMXS
(Kscope, Agosto 2009)
G enere : psych - ambient - prog
Questo mini raccoglie i sei "vincitori" del concorso online per i migliori remix da Insurgentes di Steven Wilson (il leader dei Porcupine Tree). Ora, posto che quel
disco non era proprio un discone (nebulosa psichedelia
ambientronica filtrata da una sensibilità prog; ogni parola
pesata nella sua accezione negativa), posto che i remix
remixano poco (tanto gli Engineers, quanto i Danse
Macabre aggiungono un pianoforte; Dirk Serries aka
Fear Falls Burning toglie invece praticamente tutto),
Stonephace - Stonephace (Tru
Thoughts, Maggio 2009)
G enere : jazzrock / fusion
Larry Stabbins ha cominciato a suonare professionalmente a sedici anni al fianco
di Keith Tippett (tastierista progjazz - marito di Julie Driscoll - che i rockofili ricordano su alcuni dischi
dei King Crimson come
Lizard e Islands) e per tutta
la vita è stato diviso tra il
radicalismo di gente come
Peter Brötzmann e un amore profondo per il funksoul muoviculo, declinato spesso e volentieri nelle forme
più pop di progetti come i Weekend, costola stattoniana degli Young Marble Giants, e i Working Week,
costola della costola. Questo Stonephace è una delle
sue prove migliori di sempre, se non la migliore.
Accanto a Stabbins (sax e flauto) troviamo Adrian
Utley e Jim Barr (rispettivamente, chitarrista e bassista-turnista dei Portishead; per inciso, Stabbins è di
Bristol), Helm DeVegas alle tastiere elettriche e Krzysztof Oktalski al laptop. Gli interventi elettronici si
fanno evidenti giusto negli interludi (piccoli siparietti che
oscillano tra il trip-hop e l'ambient rumorista) e in certe sfumature effettistiche come il dub-echo applicato al
rimshot (sottolineamo pure che le batterie sono tutte
campionate, ma la cosa quasi non si capisce), mimetizzandosi per il resto perfettamente nel suono acusticoelettrico degli altri strumenti.
Stonephace guarda piuttosto alla Mahavishnu e allo
Zappa anni Settanta (altezza Grand Wazoo), con inflessioni di prog-canterburiano, speziature funk e venature
latin-etno su una base solidamente jazzrock. E' un disco
festoso, a tratti amazzonico (nell'evocare l'intricatezza
della giungla), ispiratissimo sotto il profilo melodico, avvincente nel solismo, soprattutto in quello del leader e
di DeVegas, fusion con tutto il corredo di tempi dispari
71
e giochi di accenti proprio del genere, ma senza eccessi
e senza noia.
Un disco vecchio stile (basti sentire il riverbero che accompagna il sax), un disco generosissimo.(7.5/10)
Gabriele Marino
Teepee - Morals (Senzei, Dicembre
2010)
G enere : synth - weird - pop
Spuntano come funghi (allucinogeni) i progetti collaterali
nella scena weird-no-fi-garage. E spesso sono anche di
pregevole fattura. Ne è testimonianza l’esordio lungo di
Teepee, nom de plume in solitaria di Eric Lopez, già uso
a seviziar chitarre dei misteriosi Electric Bunnies e qui
alle prese col proprio universo di fantasmi in chiaroscuro
e prospettive a tutto tondo. Una manciata di 7”, qualche
nastro come al solito e ora
Morals a sgrezzare l’ormai
nota materia prima.
Slabbrati quadretti shitgaze
con abbondanza di synth in
saturazione (Subconscious),
strambe ipotesi di taranta-wave paranoica (Tecum
Uman), cold-wave ora malinconica (Your Majesty), ora in the vein of Suicide (Sewing
Machine), triste synth-pop figlioccio dei J&MC (I Told You
So), pantani melmosi di drone lugubri (Yes You Khan Bismillah, No Mans Land), addirittura folk apocalittico limitrofo ai Death In June (Satisfied).
Tanta roba, eppure, a favore dell’album, gioca paradossalmente la coesione e non l'accozzaglia di già sentito.
Morals riesce infatti nella fusione delle istanze elettriche
ed elettroniche dell’odierno suono weird americano.
Dargli del bignami sarebbe riduttivo oltre che ingiusto.(6.9/10)
Stefano Pifferi
Tindersticks - Falling Down A
Mountain (Beggars Banquet,
Gennaio 2010)
G enere : chamber pop
Li avevamo lasciati con il comeback The Hungry Saw
nell’aprile 2008, ultimo album del gruppo dopo 5 anni, a
cui è seguito un tour di successo che è culminato in Hyde
Park nel luglio 2009. Stuart A. Staples e compagni si
sono dovuti allora per forza di cose confrontare con il
loro passato e un presente da continuare a scrivere.
Così è nato Falling Down A Mountain, loro ottavo
disco in studio. Nel frattempo due nuove aggiunte, il batterista Earl Harvin e il chitarrista e vecchia conoscen72
za David Kitt e la guest Mary Margaret O’Hara in
duetto in Peanuts. Il nuovo album riparte dal precedente,
intimo e soffuso, con il consueto carico di dolenze, per
superarlo man mano, in un mix dello Staples solista e
dei rinati Tindersticks. Percussività, talking Lou Reed
in più di un’occasione, ma sostanzialmente c’è tutto lo
stile del gruppo, arricchito dalle nuove presenze, per un
lavoro che prosegue la storia del gruppo senza citarsi
troppo addosso. Bene.(7/10)
Teresa Greco
Tomasz Bednarczyk - Let’s Make
better Mistakes Tomorrow (12k,
Giugno 2009)
G enere : elettronica / ambient
Terza trattazione in meno di due anni per Tomasz
Bednarczyk: due uscite con la Romm40, e ora il debutto con Let’s Make better Mistakes Tomorrow per
la 12k a svelare ancora una volta un’inclinazione naturale
all’ambient più sommesso.
L'album si muove in punta di piedi tra docili drones e
fragili texture (Kyoto), ombre (While), contemplazione
(Drawing), loop elettroacustici (Shimokita), field recording o crackle (The Sketch). Dieci processi di malinconia - qui in forma breve - che a cercarne i contorni ci
ricordano Mathieu e Hecker, pur con i modi disperatamente romantici del William Basinski. Un altro
nome da aggiungere alla lista degli autorevoli scultori
del suono.(7.2/10)
Sara Bracco
Transitional - Stomach Of The Sun
(Conspiracy Records, Settembre
2009)
G enere : D rone - I ndustrial
Il bassista dei Transitional non è un nome nuovo nel
giro sludge-industrial. Sodale compagno di Justin Broadrick, Dave Cochrane era con lui negli Head Of David
(ora freschi di reunion) e più recentemente ha collaborato con Jesu in alcuni live tour. A completare il quadro,
inoltre, la materia trattata dal trio non si discosta molto
dalle ambientazioni di quello che di Broadrick è stato il
progetto più significativo, i Godflesh. È da quelle stesse
sorgenti che Stomach Of The Sun sembra trarre linfa vitale, nonostante gli arrangiamenti siano debitamente aggiornati agli standard Isis e alle loro dinamiche rallentate
(fino a rendere inevitabile l'etichetta drone).
Fatta eccezione per le dilatate scariche di elettronica
granulosa dell'introduzione (suono che svolge un ruolo
duale al silenzio, nell'economia dell'album), i Transitional
suonano ritmi cadenzati in ampi riverberi sotto netti
colpi di chitarre, siano essi cupi fendenti o controllate
dissonanze. La voce - mai predominante - si presenta
violenta in Pyramid, per poi passare agli stranianti effetti vocoder di Hideaway (anche i Transitional riescono come i Boris in Altar - nella fragile arte di non suonare
come una giustapposizione Kraftwerk-Metal, nell'utilizzare questo effetto).
Al brano omonimo, con il lungo claustrofobico riff, va
il riconoscimento di pezzo migliore dell'album. Si chiude con Worst Eyes Shut, che all'ambient della prima
traccia aggiunge un drumming frenetico ed impazzito,
degna conclusione di un album che non è male davvero.(7/10)
Leonardo Amico
UnePassante - More Than One In
Number (Anna The Granny, Gennaio
2010)
G enere : folk / funk / pop
Attitudine freak à la Ani Di Franco e a una trasversalità che spazia dal pop, al jazz, al funk, a un classicismo
orchestrale che non ti aspetteresti. La base rimane un
interplay virtuoso tra chitarra acustica, contrabbasso,
batteria, percussioni, in linea con le aspirazioni autoriali
del progetto di Giulia Sarno - autrice di tutti i brani
-, Guido Masi, Sergio Schifano, Michele Staino e
Simone Sfameli. Dodici episodi adatti un po' a tutti i
contesti, tra suoni da camera virati pop (Wreckage) e un
Leonard Cohen da jazz club (A Une Passante), i Novanta indie della Di Franco citata in apertura (Bats, Rats &
Cats) e ambienti folk rarefatti (You Are Music).
Punto di forza di More Than One In Number, il sostanzioso
lavoro in fase di arrangiamento e produzione ad opera
dei musicisti, di Gianluca Cangemi e di Gianmaria
Ciabattari. Più che una semplice cornice d'autorevolezza, uno sviluppo supplementare capace di capitalizzare i
pregi di una scrittura “totalizzante” che ricorda una St.
Vincent in chiave chamber ma senza le torsioni metropolitane tipiche della musicista newyorkese.(7.1/10)
Fabrizio Zampighi
Uxo - Uxo1 (Queenspectra,
Dicembre 2009)
G enere : uonchi bbreaking
La via italiana alla contaminazione tra hip-hop electro
e sampling parte da gente come Marco Acquaviva. Il
tag per il produttore milanese è uonchi, italianizziamo
cioè la nozione UK e ci ritroviamo in un percorso che
ha le mani in pasta con una sensibilità beat addicted de
noantri. Il localismo implica un’amore tutto italo verso la
melodia già sentita sulle prove fidget di Congorock e
qui arricchita da vocine in elio, accenni glo (Exploitation),
synth 80 (The Cheapest Space Travel), sirene grimey (Beginning) e trucchetti che faranno impazzire i nerd dietro
la consolle.
Marco passa senza problemi dalle visioni di Badalamenti
ai beat di Dabrye e Madlib. L'eterogeneità segue un
percorso personale che parte dalla fascinazione per
l’abstract-hop (grazie probabilmente ai suoi trascorsi
street) e arriva alle proposte ritmiche d’oltremanica in
una lunga sequenza di tracce stringate che al massimo
superano i tre minuti. Brevi pezzi manipolati artigianalmente con l’old school analogica nell’anima e il manuale
di Ableton Live nella testa.
Un piccolo manifesto a tratti interlocutorio ma che probabilmente getterà la base per un proseguio più omogeneo. Aspettiamo con fiducia il botto. E magari la nascita
di una scena. Chiediamo troppo?(6.9/10)
Marco Braggion
Xiu Xiu - Dear God, I Hate Myself
(Kill Rock Stars, Febbraio 2010)
G enere : art pop
Gli Xiu Xiu sono stati uno degli avvenimenti sonori degli anni zero, che hanno segnato grazie ad una calligrafia
inconfondibile, caratterizzata da un sovraccarico drammatico con pochi precedenti e ancor meno eguali. Il canto di Jamie Stewart si poneva come una mutazione di
genere e generazionale del lirismo ineffabile d'un Mark
Hollis, strattonato da fantasmi wave e dark, sospeso tra
implosione ed esplosione
emotiva, tra stordente disillusione e pathos cupo. E'
comodo dirlo adesso, ma
appare inevitabile che quel
punto di forza finisse per
rivelarsi una prigione.
Questo Dear God, I Hate
Myself - album numero
sette in otto anni - azzarda un frastagliato repertorio
di espedienti electro a bassa fedeltà (pare che sia stato
utilizzato anche un Nintendo DS) come guarnizioni per
variare la portata. Ma è tutto inutile. Benché non manchino buone intuizioni - la delicata Hyunhye's Theme, quella
Chocolate Makes You Happy che assieme alla title track
rappresenta l'apice catchy di tutta una carriera - resta
più che in filigrana la sensazione di un panegirico funereo
già sentito troppe volte. E che non hai troppa voglia di
stare ancora a sentire.
Stewart ha talento da vendere e un'integrità indiscutibile. Credo sappia benissimo quanto sia necessario ripensarsi artisticamente, ma non è certo grazie ad un
73
maquillage a base di balzani stratagemmi sonici che ci
riuscirà.(5.8/10)
Stefano Solventi
Yeasayer - Odd Blood (Secretly
Canadian, Febbraio 2010)
G enere : synth pop
E menomale che doveva essere il disco della maturità!
Questo secondo lavoro della band di Brooklyn puzza
di flop lontano un miglio
e ci sono davvero poche
speranze che non vada a
finire tutto in rovina. Non
certo da un punto di vista
strettamente commerciale,
visto che tra hype (indirizzato) - marketing (evoluto) e video + teaser mp3
disponibili, più o meno volutamente, già da mesi, c’è da
coprirci almeno le spese di registrazione, tanto poi vai di
tour e almeno il piatto in tavola è assicurato.
Quello che lascia basiti è la drammatica involuzione stilistica di una band che al primo disco aveva tutte le cose
al posto giusto. Non dico che potessero mettersi sullo
stesso piano dei Vampire Weekend, ma le premesse
tra gusto eighties, tribalismo modaiolo e coretti glam ci
stavano tutte. Odd Blood accoltella subito allo stomaco la nostra buona volontà con il pachidermico synth
dell’iniziale The Children; ci spezza le gambe con l’animalismo collettivo di riporto del primo singolo Ambling Up
(con video però ipnagogico a base di effetti cheap anni
’80 e malattia jodorowskiana!); ci sventra gli intestini con
i coretti leziosissimi delle zuccherose Madder Red e I
Remember.
Con One siamo dalle parti del peggiore synth pop anni ’80,
qualcosa di informe che si muove tra la prima Madonna, i Pet Shop Boys e gli Spandau Ballet, e il rantolo
in gola comincia a spezzarsi definitivamente. Nemmeno
la forza di gridare ci viene concessa quando appaiono
Love Me Girl e Rome, parodie non si sa quanto volontarie
di mezza classifica Billboard di un anno qualsiasi tra il
1983 e il 1989. Tutto suona posticcio e artificioso, senza
un minimo di quella nostalgia malinconica che teneva le
sorti del primo disco ancorandolo al ricordo degli anni
migliori. Qua la band di Chris Keating si è messa a rovistare nel bidone della spazzatura.
Poi, per un qualche incredibile scherzo del destino, tutto
questo potrebbe anche suonare bene a qualcuno che nel
2010, in crisi dopo la morte di Michael Jackson è disposto a scendere a patti con il peggio del pop e fare due
più due, mettendo in relazione Mondegreen e Thriller, ma
noi a fine disco ci arriviamo praticamente in una pozza
di sangue, senza più un briciolo di vita, che a guardarci
anche il coroner ha un sussulto di pietà.(4.5/10)
Antonello Comunale
— libri
Rock, amore, morte, follia e un
paio d'altre sciocchezze che i
nipotini dovrebbero sapere
M ark O liver E verett (E lliot , 2009)
Poco appropriato parlare di “conferma” nel caso dei
transalpini Zëro. Perché se è vero che la prova del secondo album viene affrontata con disinvoltura e sapienza,
allo stesso modo si tratta di gente in circolazione - come
Bästard - da un decennio e passa. Che, ciononostante,
appare ben lungi dal placare la propria furia, avendola
semmai incanalata dentro strutture vieppiù meditate, in
martellamenti che non danno tregua, in creatività senza
limiti espressivi. I quali possono essere tuttavia unificati
tramite un prefisso per ben due volte assai magico nella
musica leggera e cioè post: da anteporre ovviamente a
“rock” e “punk” tenendo conto del padre comune krauto.
Si chiuderebbe in questo modo il discorso, nel contempo cavandosela alla svelta e centrando il nocciolo della questione, visto che per ogni Load Out e The Cage
per le quali Girls Vs. Boys e Trans Am menerebbero
rispettivo vanto ascolti una Dreamland Circus Sideshow
che erige ponti tra Chicago, Manchester e Colonia. Del
predecessore Joke Box ritroviamo urgenza, piglio esecutivo vibrante e partecipato, arrangiamenti curati senza
capitomboli nella leziosità (tranne il finale della faustiana
Viandox: poca roba, in ogni caso).
Si pesta di jazz ed elettronica vintage e ruvida con raffinatezza (Cheeeese) mentre osservi il grammo di verve
compositiva in meno. Non però nella cavalcata krauta
Pigeon Jelly e nei paesaggi tra Cluster e Sonic Youth
di Enough... Never Enough, nel singultare alla primissimi
XTC di Sick To The Bone e nella febbrile The Opening.
Dimostrazioni brillanti che, per mutare le visioni in realtà, servono consapevolezza storica e ingegno libero da
vincoli.(7/10)
Gli Eels sono la band che ha cambiato le prospettive del
pop rock alternativo negli anni novanta. Gli Eels sono
Mark Oliver Everett, e questo è il punto. Dalla sua
penna sono uscite canzoni formidabili: testi che t'inchiodano per la mistura di cinismo, disarmo, crudo dolore e
un amore per la vita che cova sotto la cenere; melodie
guizzanti, cristalline, brusche, setose. Un cantautore slacker folgorato sulla via dei Portishead, ai cui ectoplasmi
filmici si è ispirato per ricollocare un sound altrimenti
risaputo, azzeccando quella che per almeno tre album è
sembrata la formula perfetta.
Ma tutto ciò non sarebbe bastato a farne ciò che è stato.
L'uomo è l'ingrediente decisivo, Mark e la sua vicenda, quel
modo di affrontare i cataclismi che il destino gentilmente
gli ha vergato tra capo e collo senza riguardo né risparmio.
Una cognizione del dolore che è vero e proprio brodo di
coltura in cui fermenta tutto il repertorio, dal più mesto al
più furibondo allo speranzoso. Con questa autobiografia,
lo stesso Mark ci mette a parte di tutto ciò: è lo spietato
ribollire di quel brodo, senza lesinare sugli ingredienti (il
ritrovamento del cadavere del padre, l'agonia della madre
e l'amara cerimonia funebre, le tristi vicissitudini della sorella Liz...). Il tutto condito da un fatalismo lucido e agro
- al limite dello sprezzante - che inibisce ogni deriva melodrammatica, restituendoci il ritratto di un uomo selvatico
e brillante, che in mancanza di pace col mondo sembra
aver trovato quella con se stesso.
E che dire degli aneddoti folgoranti, illuminati da una luce
quasi surreale, come la pennellata che dipinge un Elliott
Smith ineffabile o il rovinoso quasi-incontro con uno
scoppiato Elton John? Infine, esci da questo libro come
dalle canzoni targate Eels, tramortito dalla zuffa tra intrattenimento e realtà, tra manufatto espressivo e vita
vissuta. Verrebbe da augurargli un futuro da scrittore, al
caro Mark, se non fosse un tipo tanto disilluso. Ma come
fargliene un torto? Giancarlo Turra
Stefano Solventi
Zëro - Diesel Dead Machine (Ici
d'ailleurs, Febbraio 2010)
G enere : post wave rock
Guida illustrata al frastuono più
atroce
AA.VV. (L amette C omic s , 2009)
casione) del più roccherrolle dei critici musicali poteva fungere da titolo per questa compilation di tributi.
Trentuno disegnatori della nuova onda italiana che più
indipendente non si può si cimentano in quello che in
apparenza è un sentito omaggio ai propri eroi musicali,
ma in realtà una fagocitazione reciproca. Parola di Simone Lucciola, curatore del volume nonché responsabile di
Lamette e disegnatore presente con uno struggente e
veritiero ricordo di Nico.
In questa ottica cannibalistica risiede il senso dell’albo:
mettere in scena il legame che ogni artista ha con gruppi o musicisti che hanno segnato la propria giovinezza,
quel cortocircuito tra musiche rock tra le più sguaiate,
oltranziste, storte e sboccate e l’arte fumettistica in b/n
ai suoi più alti livelli. Ovvero, immaginate Guida illustrata...
come una sorta di playlist immaginaria di tutti i tempi di
alcuni tra i migliori fumettisti italiani.
Ratigher, Tuono Pettinato, Maicol e Mirco, Alex Tirana,
Marco Corona in tandem con Antonio Solinas solo per
citarne alcuni si armano di carta, penna, matita e fantasia e apparecchiano una compilation letteralmente
da sballo con un paio di pagine cadauno (o poco più):
Wire e Captain Beefheart, Germs e Devo, Minor
Threat e Cramps, Cows e Nerorgasmo, Faust’O e
Wretched. Degni di nota la biografia stilizzata e liofilizzata di capitano cuordibue ad opera di Squaz, l’ossessiva
resa fumettistica di un classico del punk mai così attuale come California Uber Alles (Dead Kennedys) resa da
Riccardo Pieruccini, la putrescente vita del punk dei punk
GG Allin che Corona e Solinas rendono perfettamente
a colpi di caotico b/n.
Non da meno le avventure di Gino l’accendino – personaggio creato dalla mente malata di Alex Tirana – alle
prese col mito giovanile rappresentato dai RHCP e la
fantastica presa per il culo del gruppo metal più potente
e coatto del mondo (i Manowar), così come gli omaggi agli outsider Brutos (per mano di Hurricane Ivan) e
Truzzi Broders (di Marco Bailone).
Guida illustrata… è in definitiva una delle migliori performances all’incrocio tra arti affini, fumetto e musica, mai
così vicine come in questo caso.
Pubblica Lamette, la webzine più rozza d’Italia, col suo
marchio Comics, e non si può che consigliare da subito
l’acquisto a scatola chiusa.
Stefano Pifferi
Nulla meglio di una citazione (seppur riadattata per l’oc74
75
— live report
Patti Smith
P iazza S anta C roce , F irenze (9
2009)
settembre
In realtà a Firenze Patti Smith c'era e c'è stata spesso,
anche pochi mesi fa ad inaugurare la mostra dedicata
all'amico Mapplethorpe; ma questa settimana di eventi
e celebrazioni fa riferimento ad un momento preciso,
ossia a quando nel 1979, con una data qui e una a Bologna, la poetessa punk pose fine all'embargo nei confronti
dell'Italia da parte dei grandi nomi del rock (spaventati perché all'epoca il caro biglietti veniva contestato, e
capitava che i disordini conseguenti più che rovinare il
concerto lo sostituissero).
La data fiorentina in particolare passò alla storia, non
solo per i numeri (le cifre ballano, ma l'ipotesi più probabile è 70.000 spettatori), per la statura del personaggio
e il suo rappresentare allora i tempi o perché fu un concerto lunghissimo e strano, ma anche perché fu la fine
del Patti Smith Group: non ci furono disordini quella
sera ma tensioni sì, che unite alla decisione di dedicarsi
alla famiglia contribuirono a spingere la Smith verso il
suo lungo ritiro dalle scene.
A 30 anni di distanza si ricorda quello che fu un evento
vero con una settimana di celebrazioni culminanti in un
reading a Palazzo Vecchio e nel concerto "normale" in
Piazza S. Croce la sera successiva.
Quello che si celebra, in realtà, è l'amore della Smith per
l'Italia, che il '79 cementò: e benché in questa settimana
Patti abbia passeggiato per il centro fermandosi a suonare dove capitava e guardando in faccia gli italiani odierni,
la versione del nostro paese che ama è quella di Michelangelo e Dante, certo non quella triste di oggi.
Si dichiara commossa, infatti, di esibirsi in un luogo bello
come la sala dei Cinquecento ("nemmeno al mio paese
mi hanno fatto tanti onori", dice ringraziando Firenze per
l'ospitalità) in quello che più che un reading è un vero e proprio concerto acustico: pochi testi recitati (tra i quali People
Have The Power e la Footnote To Howl di Ginsberg che su
Peace and Noise era diventata Spell) per il resto canzoni,
sulle quali suona anche un po' la chitarra prima che Lenny
Kaye e poi Tony Shanahan vengano a soccorrerla.
La dimensione acustica mette a nudo i pregi delle canzoni in scaletta esaltando l'essenzialità solida e miliare
già degli originali (sarà un'idea vecchia di rock la sua ma
76
bisogna saperle scrivere certe canzoni "semplici", o tirare fuori un inno del tutto personalizzato semplicemente aggiungendo una propria poesia a un pezzo di Van
Morrison, con tanti saluti alla presunta modernità di
quell'hip-hop modaiolo che vorrebbe "riscrivere" campionando), anche grazie alla voce, cui il tempo ha sottratto due grammi di slancio in cambio però di profondità e
padronanza espressiva.
Il tempo limitato di una serata, poi, permette di lasciare
fuori dal quadro la parte non proprio imperdibile della
sua storia (unica eccezione una Helpless anonima come
sullo sfocato Twelve) presentando la parte migliore del
suo canzoniere: classico nelle particolarmente adatte
Ghost Dance e Pissing In A River e in Because The Night e
Dancing Barefoot che non perdono forza neanche unplugged, ma anche del post-rientro: tra le altre, aperta con
un'improvvisazione poetica su Firenze più cartolinesca
la prima sera efficacemente accorciata la seconda, My
Blakean Year (2004) conferma nel gioco di parole del titolo e in questo contesto che per lei il '79 non dev'esser
stato facile davvero. Dopo una passeggiata tra il pubblico
su Dancing Barefoot, per il finale viene chiamato sul palco anche Jay Dee Daugherty, non tanto per suonare (la
batteria non c'è) quanto per invitare tutti al concerto
elettrico dell'indomani.
Il caro biglietti non si contesta più, e anche trent'anni fa
il prezzo era stato tenuto basso per evitare problemi;
ma nel dubbio, il reading a Palazzo Vecchio era gratuito e
con 12 proletari euro si entra nel set altrettanto splendido di piazza Santa Croce, dove la spesso trascurata dal
vivo Frederick apre le danze in continuità col '79, confermando la buona ispirazione della serata precedente (ma
anche che il pezzo è ben più che un semplice tentativo
di bissare Because The Night).
Oltre ai tre della sera prima, in organico c'è l'amico
di sempre Tom Verlaine, il quale si scalda sui brividi
dell'incantesimo di Birdland e su una Beneath The Southern
Cross meno intima rispetto a Palazzo Vecchio ma gratificata dalla maggiore varietà strumentale.
Il gruppo si rivela duttile, scambiandosi gli strumenti a
seconda delle necessità del momento (il basso in particolare tocca per lo più a Shanahan in alternanza col
piano, ma anche a Verlaine e Kaye e, nella citata Birdland,
a Daugherty); ma soprattutto in forma superlativa nel
sostenere quella classe con cui la Smith, nei momenti
migliori della sua storia, ha tenuto in equilibrio i dualismi
tra poesia e punk, delicatezza della voce e furia del gruppo, raffinatezza dei testi e semplicità compositiva.
Evidentemente le piace recitare People…: anche stasera,
prima di suonarla normalmente nel crescendo finale, la
declama in coda a Peaceable Kingdom, così come ama le
dediche (Wing per la Pivano, ad esempio).
Ma è il bis finale che trasforma quello che era stato solo
uno splendido concerto in magia pura: apre My Generation grezza e sgangherata come nel (e come se non
la suonassero più dal) '75, tanto per sbattere in faccia
all'Italia di oggi che la gioventù può essere vitalità e rivolta (alla quale Patti esorta) e non carne fresca da vendere in tv; ed è così che l'inno del rock come musica da
giovani risulta credibile cantato da una 63enne la quale,
per ribadire il concetto, nella stessa sera in cui in tv inizia
X-Factor invita sul palco tale 12enne Nicola da Modena,
pescato chissà come-dove-perché, a suonare la chitarra
nel classico degli Who (con un'impostazione delle mani
migliore di Kaye, a dirla tutta).
E, trainata da un Daugherty che a 57 anni suona con velocità, potenza e precisione da non credere, chiude una
versione carrarmato di Rock'n'Roll Nigger, la cui ferocia
viene trasfigurata dalla coesione totale del gruppo (al
punto che Nicola è ancora lì, perfettamente inserito), il
quale raggiunge momenti di trance nei quali una rozza
cavalcata punk diventa un altro sublime.
E a quel punto celebrazioni e trentennali passano in secondo piano davanti ad un grande concerto (molto superiore a quello del '79, tra l'altro, a detta di chi c'era
entrambe le volte), una dimostrazione di vitalità ribadita,
che fa quasi credere, a momenti, che le canzoni possano
davvero cambiare il mondo: in caso, sono queste.
Giulio Pasquali
Tortoise
E stragon , B ologna (20
novembre ,
2009))
Niente da fare, i Tortoise, come tutte le grandi band
in pericolo (pericolo?) di storicizzazione (ed estinzione),
smuovono ragione e sentimento. Sono un gruppo che
ha segnato un’epoca - su questo nessuna obiezione partorito dischi memorabili, un'entità musicale che però
negli ultimi anni ha lentamente smarrito il proprio culto
per una strada ambigua, scivolosa, vuoi per quella sorta di mainstream intellettuale su disco (pur con colpi
d’ala, vedi il recente Beacons...), vuoi per quella spiccata
attitudine live che pian piano è diventata, non soltanto
mezzo, ma fine.
In ogni caso, la band, antagonista e protagonista di certi
Novanta assieme agli Slint, rappresenta oggi quella real-
tà media (per cachet e capienza Club) che soltanto una
mitologia passata riesce a deformare. Dietro infatti ci
respiri una stagione pre-filesharing che pare già un mondo lontanissimo appartenuto a una generazione peraltro
cortissima, post Grunge, frammentaria, e dall’accezione
universitaria e intellettuale. Una generazione che sicuramente s’è scritta l’epitaffio quando proprio gli Slint
miracolosamente (per l’epoca) riuniti radunarono praticamente tutti, dai fan di Scaruffi a quelli della neo realtà giornalistica Blow Up e tutti quelli che, mai letta una
nota di critica, sapevano intimamente che a Bologna quel
lontano giorno, o si partecipava o si perdeva qualcosa di
importante, di generazionale.
Era la fine del post rock. E, oggi, con quel termine ci s’infila tutto: Slint, Tortoise, Mogwai, Explosions In The
Sky; tutti dentro un’etichetta che fa comodo a chi ti
promuove il concerto e ti vende un pezzo di storia che
fa evento. Nel recente passato, sul fatto che i Tortoise
facessero post-rock c’erano serrati dibattiti. E di fatto
era chiaro che non potevamo di certo parlare di Slint e
Tortoise come realtà facilmente riconducibile l’una all’altra. Problemi che ai 30 something dell’Estragon, assiepati
davanti al palco, assieme ad avantmetallari che si sono
cibati di Sunn O))) fino a ieri, non passano neppure per
l’anticamera del cervello.
E se il metal, anche quello più nordico, s’identifica facilmente con mestiere, in comune i Tortoise hanno sicuramente quell’aspetto, in quanto a tecnica e professionalità, li fa facilmente etichettare come dei Pink Floyd
formato doppio zero, sia per sontuosità sia per fierezza
del marchio. Pertanto, zero indecisioni e tempi morti,
cambi di strumento/postazione che non si contano, sia
per l’animale da palco McEntire (sia ai tamburi sia alle
tastiere) sia per non meno importanti i quattro compari,
con il solo McCombs a non concedersi spostamenti ma
intento a forgiare le fondamenta del sound con i mitologici giri di basso.
Retorica a parte, è la resa di Beacons Of Ancestorship
quel che interessa veramente del report, ed è presto
detto: dal vivo le tracce del disco perdono ruvidità acquistando così una tipica patina tortoisiana. E’ la specialità
della casa: sezione ritmica muscolare e protagonista, alle
chitarre e tastiere il maquillage; è comunque e sempre
un bell’ascoltare per un'ora e mezza abbondante e innumerevoli bis fino all’esecuzione del grande classico Along
The Banks Of Rivers (l’album ovviamente è Millions Now
Living Will Never Die). Ci troviamo una band compiaciuta e soddisfatta di tante cose ma principalmente del
proprio cliché.
Nicolas Campagnari
77
Gimme Some
Inches #2
Altro giro a forza di vinili. Stavolta touredition ed esordi per Real Estate, Sic
Alps, Magik Markers, Microwave With
Marge e altri ancora. Il tutto come al
solito a 7, 10 e 12 pollici.
Il passaggio del testimone tra cd-r e
vinile si è fatto notare anche in sede
live. Se fino a poco tempo fa ad arricchire i banchetti post-concerto
erano strambe e colorate edizioni
digitali (casalinghe ovviamente, ma
c’è da ripeterlo?), da un po’ le stesse
modalità si avvalgono del vinile cosiddetto tour-edition. Della serie: o
qui e ora o mai più.
Proprio in questi giorni dalle nostre parti - più precisamente il 10
di febbraio al Diagonal di Forlì, unica data italiana) passeranno i Real
Estate di Matt Mondanile & co. e
molto probabilmente si porteranno
dietro qualche edizione fatta apposta per l’occasione o forse (magari) qualche ultima copia del 12”
Reality appena uscito per Mexican
Summer. Un ep che, senza aggiungere nulla all’ottimo debutto, reitera
quella estetica della dissolvenza che
li ha resi (ehm) famosi: maracas e fi78
schiettio senza pensieri (Basement),
deliqui riverberati e reminiscenze
surf in modalità malinconica (Dumb
Luck) per un’abbondante ventina di
minuti di psichedelia della risacca.
Mentale e non.
Con le stesse modalità prende il via lo split tra due ottime realtà dell’underground americano.
Background diverso ma integrità e
rispetto reciproco per Sic Alps e
Magik Markers che in occasione
di un west coast tour splittato del
dicembre scorso hanno rilasciato
via Yik Yak un grazioso 12”. Un lato
e 3 pezzi per uno: il duo allargato a
quartetto per l’occasione con Lars
Finberg degli Intelligence e Ty Segall (terzo membro
ombra del duo from
Frisco) a dar man forte, procede as usual
con l’afflato psych-garage-rock caratteristico, ma si spinge verso
sperimentazioni (Guxxe Bathe Ballade) e
destrutturazioni (Long
Cheveux) da rumore
in libertà. Sull’altro, la
voce di Elisa Ambrogio non si spalma
come al solito sui classici sperimentalismi perfora-timpani di matrice
no-wave, ma si libra verso una psych
metà kosmische, metà californiana
(The Diamond Guitar Of Tico Feo), lancinante alla Guru Guru (White Map
Laid With…) e in modalità free-noise
(Tighten One And Loosen The Other),
il cui unico rimpianto è la breve
durata. Ci sorprenderanno ancora?
Sempre Sic Alps – amanti del disseminare pezzi a destra e manca (l’ottimo 7” L.Mansion su Slumberland,
ad esempio) per poi raccoglierli in
edizioni compilative (A Long Way
Around To A Shortcut docet) –
mettono la loro firma sulla compila
in 10” Skulls Without Borders edita da una sempre più lungimirante
Siltbreeze. Nomi minori per una
manciata di minuti di scatafascio sonoro fatto di voci riverberate e nofi (im)produttivo, wave degenerata e
weirdità assortite offerte dai misconosciuti Chickins, Puffy Aureolas,
Tommy Jay Band e dai campioncini Kurt Vile (stavolta coi Violators)
e Dan Melchior. Roba che fa venire in mente quanto gruppi come
i Fall siano stati fondamentali per le
nuove generazioni.
Saltando a piè pari da un lato
all’altro degli states ci ritroviamo a
parlare dei Mi Ami, di cui ci si occupò a suo tempo. Quando cioè a colpire, più e prima dell’ottimo esordio
lungo Watersports, erano stati i 12”
(African Rhythms su tutti) a farceli
apprezzare, come se nelle misure intermedie il terzetto a stelle&strisce
fosse in grado di dire molto (ma
non tutto) del proprio caleidoscopico universo sonoro. Ora è il turno di Cut Men con cui debuttano
su Thrill Jockey: doppia traccia per
un minutaggio da mini-album che
offre l’ambivalente portato del trio
in tutto il suo splendore. Post-punk
nevrotico e engagé sul lato A (Cut
Men) e dilatazioni dub malatissime
e dance-oriented sull’altro (Out At
Night). Se necessario, la conferma di
un grande gruppo.
Tornando ai Real Estate e più
precisamente agli adepti del culto
Underwater Peoples, è da segnalare
l'uscita per la label del primo singolo
dei Frat Dad, duo di teenager che
già aveva partecipato alla compilation Summertime Showcase con
un brano piacevolmente gonfio di
riverberi. Per questo 7” i due puntano invece su un indie pop lo-fi piuttosto canonico che non fa risaltare
le componenti acquatiche tipiche
della casa madre e che lascia tutto
sommato indifferenti. Un’occasione
mancata. Chi invece non manca di
farsi notare, ancora una volta, sono
i californiani Nothing People che,
dopo il secondo lp su S.S., tornano
con un singolo dal packaging ultra
deluxe. Vinile bianco, copertina con
scritta “You’re Invited” incisa a sbalzo come fosse un biglietto per un
gala. Enemy With An Invitation infatti si chiama il 7 pollici e presenta
due pezzi musicalmente più affini al
primo album Anonymous che non
ai toni soporiferi di Late Night.
Quindi pre-punk, dopo-punk, glam
rock e psichedelia da garage at its
best. Bentornati.
Per concludere questo nostro
giro del mondo a 45 giri, rientriamo
alla casa-base. Il solito assemblamento di etichette (stavolta Lemmings,
Valvolare, Musica Per Organi Caldi)
mette la firma sul 10” di Microwave With Marge, Cow Licks Cow. Il
trio tarantino sforna 8 brevi tracce
in cui carica post-punk nuda e cruda
e gusto per la frammentazione nowave (più di marca Skin Graft che
newyorchese, in verità) si sposano a
ritmi schizoidi al limite del danzereccio, ma immediato e straight in your
face. Non che c’entri molto, ma a
venire in mente è una vecchia esperienza pugliese, i Bz Bz Eu, per la capacità di triturare in un guazzabuglio
sonoro influenze tra le più disparate.
Infine la neonata Shit Music For Shit
People dopo l’esordio di Cappottini I’ Lignu ci regala un secondo 7”,
stavolta a nome Satàn. Gruppo con
un piede a Torino e l’altro oltralpe,
i nostri sfornano quattro pezzi in
cui mischiano garage, surf e pop alle
urla isteriche della cantante Paula
H. Stampa di trecento copie con
quello che è ormai marchio di fabbrica della label: copertina in carta
da pacchi serigrafata in tre differenti
colori. Come a dire, l’occhio vuole
sempre di più la sua parte nell’era
del feticcio.
Stefano Pifferi
Andrea Napoli
79
Re-Boot
#1
L'avreste mai detto? Canzone d'autore in ogni dove. L'indie rock autoctono è sensibile come non mai
ad uno degli elementi più nobili del
nostro know how musicale di italiani medi. Alle realtà già affermate
come Dente, Le luci della centrale elettrica e 33 Ore, risponde
una pila di artisti emergenti che non
rinuncia a offrire una propria visione della chanson impegnata. Come
Fabrizio Frabetti in Uh! (6.6/10),
rapito da un' America fittizia e immaginaria un po' à la Massimo Bubola e traviato da un Ivano Fossati nemmeno troppo lezioso. Tra
chitarre elettriche sudiste (Le stelle
della Cisa) e hammond (Hu!) ci si ritrova tra le mani un disco che mescola mestiere, buone idee e un dna
melodico ineccepibile, fermo restando che la formula rimane piuttosto
conservatrice. Appena più pop sono
gli orvietini Petramante, il cui E'
per mangiarti meglio (7.2/10) etichetta Martelabel - deriva dalla
penultima generazione della scuola
romana (Fabi, Gazzé) una rotondità
di scrittura che li rende lievi e cutanei. Se incontrassimo una di queste
80
Un mese di ascolti
emergenti italiani
dieci canzoni in una riviera sempre
più cadaverica oppure in un etere
non meno irrancidito, sarebbe un
mondo un po' più giusto. La produzione non sempre è centrata (le chitarre…), ed è un peccato perché i
ragazzi hanno i numeri per ritagliarsi
uno spicchio d'identità nella landa
arida eppure ingombra del cantautorato al femminile (l'ottima autrice
di tutti i brani è la cantante Francesca Dragoni). Si ascolti Atterro: Turci,
Consoli e Donà sono avvisate.
Meno consueta è la proposta di
Gianandrea Esposito in arte Verner,
uno che si appiccica a certe musiche trasversali sospese tra “acusticherie” sudamericane e jazz, reggae
mascherato da pop (Indifferente,
Almeno credo) e melodie sghembe,
chiaroscuri malinconici e leggerezza
non superficiale. Nel suo Il mio vestito (6.9/10) affiorano altre tracce
di scuola romana nonché una maturità sorprendente, chiaro segno di
un percorso artistico consapevole
e del consueto ottimo lavoro del
producer Giacomo Fiorenza. Ancor
più peculiare è la calligrafia della nostra vecchia conoscenza Humpty
Dumpty, che esce in contemporanea con due lavori (entrambi in free
download). Uno, Pianobar dalla
fossa (7.1/10), è stato realizzato a
quattro mani con Stefano Zuccalà
e conduce il consueto stile di Humpty - una cruda/languida disanima
del vivere moderno - sul versante
più aspro e beffardo, sorta di cyber
Faust'O col morbo Syd Barrett
mai del tutto debellato. L'altro, che
vede la collaborazione di Renato
Q, è A Mile From Any Neighbor
(7.0/10) e contiene cinque tracce
di pop-wave talora strinite e algide,
talaltra votate ad espansioni psych
che non esiteremmo a definire Julian Cope.
A proposito di songwriting in english, i Pocket Chestnut col loro A
Route To Peruvian Bistrot (7.1/10)
suggeriscono come Mark Linkous
lasci figli ineducati dove meno te lo
aspetti, anche tra New York, Monza
Milano e Kiribati (!). Così è la geografia dei Pocket Chestnut, che camminano con passo caracollante ma
non troppo su didascalie blues-folkrock e spirito poppeggiante. Degli
Sparklehorse a profilo rialzato in
pratica, ma anche l'insegnamento
di Mr. Everett Eels quando la voce
si appoggia sul pianoforte e spunta
fuori tutto. L'ep è in download gratuito sul loro MySpace e conviene
provarli, perché (a tratti) non sembrano neanche italiani. Lo sembrano
così poco i genovesi Cartavetro
che persino Mike Watt non si è
fatto scrupoli a collaborare al loro
We Need Time EP (7.4/10). Pubblicato da un pool di label (Brigadisco,
Anomolo, Tesla e Taxi Driver), è disco che vuole colpire duro senza
smettere di credere al potere incantatorio di una chitarra, un basso,
una batteria. Ruvidi sì ma per nulla
grossolani, i tre grattano la scorza a
melodie intense, ipnotiche, sofferte.
Il sogno art-psych è ancora caldo
nel taschino e infatti To Care apre le
danze come dei dEUS strattonati
Mudhoney, scomodando memorie
Fugazi appena mollano le briglie.
Zio Watt regala un cavernoso reading in testa alla title track, e loro
ovviamente spendono devozione
Minutemen (quella spigolosità
senza vaselina) barattando però la
stringatezza con un lirismo visiona-
rio e dilatato. Insomma, un debutto
coi fiocchi.
Chi invece non è affatto un debuttante - già un paio di album alle
spalle - è Jet Set Roger, protagonista
di uno dei quattro ep del progetto
Eureka promosso da Kandinsky Records per valorizzare realtà emergenti del bresciano. Le band chiamate in causa sono tutte belle cariche e
ruspanti, ma tra i consueti kunzismi,
agnellismi e teatri orrorifici, è proprio il buon Jet Set Roger (6.8/10)
a farsi preferire col suo estro glam e
italian beat che mischia disarmo ed
assalto, minimi termini ed entusiasmo. Cambiamo decisamente prospettiva con i Bancali In Pietra
che ci rispediscono nella Germania
di metà anni Settanta. Ad accoglierci
nel loro Autumn Ep (7.3/10), pubblicato da Tafuzzi Records, i Tangerine Dream di Zeit, tra krauti interstellari e droni, profondità liquide e
inquietanti luminescenze. Curioso il
percorso del gruppo, partito nei primi dischi da un concettualismo anarchico e inclassificabile che generava
brani sotto i due minuti di durata e
arrivato a una solida rivisitazione del
lavoro dei corrieri cosmici tedeschi.
Noi li preferiamo ora, anche perché il nuovo episodio a nome BIP
è quanto di meglio ci sia capitato di
ascoltare negli ultimi tempi in tema.
Per finire, potevamo farci mancare del sano indie-pop? Dei mestrini
Margareth, ad esempio, che nel loro
White Lines (7.0/10) uscito per Macaco Records ingentiliscono in zona
Beatles strutture pop acustiche e
anglofone iniettandovi tante malinconie quanti indolenzimenti leggeri.
L'effetto non è ovviamente inedito,
ma la voce d'alone livido e i buoni
intrecci tra chitarra, pianoforti a cascata (Night Talker) e batteria sottolineano una scrittura sempre di buon
livello, in bella calligrafia insomma.
Una proposta retrodatata ma emozionale, anche quando vagheggia sulle pianure Barrett prima di inondare
l'aria con una tromba da Calexico
della media pianura padana (The
gate). Ok, per questo mese abbiamo finito. Ci rimettiamo in ascolto.
Luca Barachetti
Stefano Solventi
Fabrizio Zampighi
81
Rearview Mirror
—ristampe
highlight
AA. VV. - Next Stop….Soweto Vol.1: Underground Township Jive
1969-1976 (Strut Records, Febbraio 2010)
G enere : township jive
AA. VV./Peanut Butter Wolf - The
Minimal Wave Tapes Vol. 1 (Stones
Throw, Gennaio 2010)
G enere : no wave
La collaborazione tra Veronica Vasicka della newyorchese Minimal Wave e DJ Peanut Butter Wolf della losangeliana Stones Throw segue le ricerche archeologiche
dei suoni (nascosti tra le
pieghe dell’elettronica pop
80) già palesate dai Chromeo nel loro DJ Kicks. Il risultato rende disponibili su
supporto digitale le tracce
che dal 2005 la giovane DJ
sta rimasterizzando filologicamente su singoli e 12''.
La lungimiranza del boss
americano e l'amore per il bbreaking ci regalano una
complation al limite del dilettantismo (e per questo minimal), che possiede però quella spinta propulsiva No
Wave che influenzò Miss Kittin, Mylo, The Hacker e
tutti i '90 acid disco rock. I nomi sono pressoché sconosciuti, se non per gli industrial-dada spagnoli Esplendor
Geométrico, il dark francese di Martin DuPont o la
progressività krauta dei Das Kabinette (i fan dei Depeche Mode di Speak and Spell in lacrime)
Per nostalgici e neofiti, un documento che testimonia la
storia underground di un’estetica basilare per la costruzione del suono dancefloor contemporaneo. Stupenda
innocenza '80.(7.1/10)
Marco Braggion
AA. VV. - The Blank Generation –
Blank Tapes NYC 1975-1985 (Strut
Records, Febbraio 2010)
G enere : disco - mutant
Bob Blank è un produttore newyorkese, di quelli che
si sentono citare meno, ma attivissimo, con lo studio di
82
produzione Blank Tapes, tra metà Settanta e metà Ottanta. Un luogo baricentrico e pulsante, con una storia
costellata di aneddoti: Arthur Russell che ci produce
le proprie creature come Dinosaur L, tantissima disco music, il nichilismo pre-Ze Records, insomma quel
melange proverbiale e propulsivo che insegnano a tutti,
quando si parla di NYC.
Di questo vive la compila in questione. Non della mera
produzione di Blank ma dello spazio che ha allestito per
una decade buona. The Blank Generation - Blank
Tapes NYC 1975-1985 è un tributo alla città e al momento in cui underground e overground a momenti si
confondevano, almeno col senno di poi, e qui sta la questione. I Blank Tapes ospitavano uno spettro di musiche
tanto diverse tra loro quanto tutte vicine, una volta entrate in quel circuito e nelle stanze di Bob. Vale a dire
che la disco e la sofficità funk vi addensavano a sé anche
i contributi di Sun Ra o di Lydia Lunch, e quindi di
quegli insospettabili (o meno sospettabili) che senz’altro
fanno da specchietto per allodole a chi legga la tracklist
di Blank Generation.
Non di sola no-wave si viveva, opinione scontata. Ma è
pur vero che si viveva di tanta, tantissima disco, di tanta
mutant (I Got A Big Bee di Bumblebee Unlimited, pure
con un pizzico di dub in Wax The Van di Lola), di tanto
post punk ammorbidito (State Of Art dei The Necessaries, che sembra una cover di Cars di Gary Numan).
Coltura perfetta per i segugi della Strut.(7/10)
Gaspare Caliri
Frank Zappa - Philly '76
(Vaulternative Records, Dicembre
2009)
G enere : funk - rock - prog
Concerto del 29 ottobre '76 a Philadelphia che documenta il veloce passaggio nelle fila zappiane della vocalist
e tastierista Bianca Odin Thornton.
La qualità audio - impeccabile - e una performance ruvi-
Servì uno spirito illuminato come Paul Simon per spostare, a metà degli eighties, i riflettori sulla musica
proveniente dal Sudafrica e, più in generale, convincere i discografici che l’etnico poteva vendere. Cosa che
portò un allargamento di orizzonti benefico per critica e pubblico, l’inizio del crossover sonoro esploso negli
’90 e, occorre dirlo, anche un bel po’ di schifezze tagliate su misura per li Nord del mondo. Roba da salotto
che nulla ha a che vedere con la cultura originaria e il suo rispetto, col portare a galla qualcosa di meritevole
spiegandone le motivazioni e il contesto.
Che è invece quanto fa la Strut, etichetta serissima e da elogiare per l’ampiezza di orizzonti e l’elevato livello
delle pubblicazioni, confermato da questa nuova impresa. Dopo le “esplorazioni” in Nigeria ed Etiopia, una serie articolata su tre tomi indaga ora le sonorità sudafricane popolari tra Sessanta
e Settanta, quel township jive (o mbaganga) che fungerà da base del capolavoro
Graceland e mostra venature e influenze jazz e soul, gospel e rumba, finanche
rocksteady. E che capisci essere in perenne transito dalla sua fonte ai cento e più
fiumi che ne dipartono in un processo di mescolanza reciproca.
Partito dalla contaminazione tra jazz e sonorità rurali Zulu, il mbaganga inserì sul
suo robusto tronco armonie vocali e strumentazione occidentale, elettrificandosi come il blues (c’è anche lui, qui, spesso e volentieri) conservando vitalità e spirito anche quando ne sarà positivamente accentuata la danzabilità. Raccogliendo
materiale destinato al mercato locale dei 45 giri, i curatori Duncan Brooker e Francis Gooding colgono
il nocciolo della questione e allestiscono un quadro policromo e stordente, tracimante la voglia di vivere che
rispondeva in qualche modo all’apartheid.Vibrante, commovente, imperdibile.(8/10)
Giancarlo Turra
da e grintosa vivificano un repertorio tra alti e bassi, con
pezzi del periodo (Zoot Allures usciva in quei giorni),
ripescaggi (dalla vaudeville band con Flo & Eddie, uno
addirittura dalle primissime Mothers) e brani già noti
ma che sarebbero finiti su disco solo anni dopo. Taglio
funk/r'n'b espresso al meglio da una eccezionale City
of Tiny Lites (con un ultra solo di chitarra&scat di Ray
White), da una Wind Up Workin' In A Gas Station praticamente hard-disco, dai cantati felini - intrisi di soulness
- della Thornton.
Inutile sprecare ancora fiato sulla dissenatezza dello
Zappa Family Trust nelle persone di Gail e Dweezil, anche perché stavolta è andata più che bene. Il tutto però
non vale certo i trenta dollari richiesti.(6.8/10)
Gabriele Marino
Fucked Up - Couple Tracks: Singles
2002-2009 (Matador, Gennaio 2010)
G enere : hc - punk
Ogni tanto lo fanno. Come se si sentissero in dovere di
rendere disponibili ai fan le decine e decine di singoli in
edizioni hard-to-find che sfornano in continuazione. Dopotutto lo fecero un quinquennio fa con Epics In Minutes,
compila allora targata Deranged; ora tornano sul luogo
del delitto per rendere conto del periodo 2002-2009
mescolando b-sides a versioni mai suonate prima, pezzi
da 7” casalinghi a estratti da sessions sparse per il mondo.
Una modalità da piena etica punk, quella del sestetto canadese che predilige misure piccole per far deragliare
il proprio punk-hc no compromise alla faccia dei fichetti
che, loro malgrado, li hanno innalzati al livello di culto
(dopotutto, performance in gallerie d’arte e copertine
di magazine hype stanno lì a confermarlo). In Couple
Tracks, doppio cd (o doppio vinile) suddiviso in The
Hard Stuff e The Fun Stuff, sfilano 25 pezzi che sembrano
un giro del mondo hc a vedere dove e quando erano
stati pubblicati.
Premesso che la frammentarietà tipica di una operazione del genere non si nota affatto, sono sempre due i
(soliti) punti forti del suono dei Fucked Up: la voce di
Pink Eyes, imponente frontman dall’ugola d’oro, che gi83
highlight
AA. VV./4 Hero/Dj Marky - The King Of Drum + Bass (BBE, Febbraio
2010)
G enere : D rum ' n 'B as s
Il nuovo volume della serie The Kings Of continua la carrellata di producers superstar con un doppio ciddì
curato da 4 Hero in tandem con il brasiliano Dj Marky. Sarebbe l'ennesimo tomo del tanto agoniato ritorno
della drum'n'bass e la compila arriva quasi in risposta a quella della metalheadz
15 Years Of Metalheadz dello scorso dicembre. I capitani della label concorrente (la Reinforced) stilano il meglio del loro taste in fatto di d'n'b Novanta e
lo fanno con taglio soulfull smaltato balearica, singing Chicago house e fuorilegio
di techs sembre ben calibrati. Si parte dalla loro Universal Love, si batte spalla a
Goldie (ovvero Rufige Kru con il rullante straclassico di Terminator II) e si finisce
con A Guy Called Gerald e la splendida Sunshine. Più che la lacrimuccia ti
scappa il pensiero: il genere ha da sempre un dna più resistente dell'affabulatorio
e monocorde dub step da sala e la riprova è la sensibile membrana con l'esterno,
attentissima nel rielaborare passato e presente.
Non ce n'è neanche quando ascolti il mix di Marky concentrato sui Duemila: ci trovi il leggendario (e un po'
bolso) Roni Size, e roba buona di Krust, Marcus Intalex, Random Movement con l'ultimo quarto della portata
a proporre i nuovi tagli del brasilero coprodotti dal londinese S.P.Y. Una festa per i sensi.(7.5/10)
Edoardo Bridda
ganteggia riottosa e selvaggia e il monolitico muro delle
chitarre (due, tre, a volte anche quattro, a seconda delle
occasioni) che si stratificano in una marea montante. Si
ha come l’impressione a volte - Black Hats, ma gli esempi
potrebbero essere moltissimi - che il suono si increspi
o si sfaldi tanta è la violenza, i riverberi, lo spessore del
wall of sound dei canadesi che, paradosso dei paradossi,
riesce sempre a mantenere una sua vena melodica interna. Detto questo, non resta che mettersi alla ricerca dei
prossimi vinili che questi brutti ceffi metteranno fuori
per le etichette più scalcinate del mondo.(7/10)
Stefano Pifferi
Jackie Leven - Only The Ocean Can
Forgive/Greek Notebook (Cooking
Vinyl UK, Dicembre 2009)
G enere : folk
Tribolata assai la vita di Leven, al punto che viene naturale essere buoni con lui. Che il nostro rispetto se lo
merita fino all’ultimo vocabolo per come è uscito da una
spirale di dipendenze che poteva strapparcelo per sempre. Una vita all’insegna del nomadismo la sua - di natali
scozzesi e un passato dopo-punk con i Doll by Doll,
ha girato per tutta l’Europa continentale - che funge da
colonna portante di un virile romanticismo che, in una
84
produzione ampia per numero ed esiti, avvicina il folk
delle isole britanniche alle pagine coheniane d’inizio ’70.
Come spiega in modo splendido l’intensa Autumn Song,
terza traccia e ultima tra
quelle qui contenute a provenire dalle mura di uno
studio d’incisione.
Le rimanenti sei essendo
estratte da concerti tenuti sul suolo tedesco in un
disco che appartiene al
progetto Haunted Year,
serie di uscite stagionali in doppio cd precedentemente
disponibili solo attraverso il fan club del Nostro. Che è
qui colto a Colonia e Francoforte nel 2003 in compagnia
delle sue corde vocali sapientemente modulate, di storie
dal potenziale affabulatorio non comune, di una chitarra
acustica cui talvolta si aggiungono misurati interventi di
tromba e tastiere. Fascinoso in ogni frangente, che scavi
nel dramma autobiografico con My Philosophy o si porga
rabbioso in Paris Blues, che ritrovi i vecchi amici Kevin
Hewick e Joe Shaw (il chitarrista dei Doll By Doll) nella
fluviale Barefoot Days o che si immagini parente stretto
di Johnny Cash in Classic Northern Diversion.
Nulla aggiunge né sottrae alla bontà dell’esito un secon-
do cd di schizzi acustici ed embrioni di canzoni recuperati da un fedele walkman, sorta di diario dalle isole
greche in cui Jackie passò diversi mesi nel corso degli
anni Novanta. Artista per il quale il “culto” è condizione
immeritata, al di là di ogni retorica.(7/10)
Giancarlo Turra
Leonard Cohen - Live At The Isle
Of Wight 1970 (Columbia Records,
Ottobre 2009)
G enere : F olk rock
Un altro live pescato dall'archivio: si tratta del concerto
integrale del 1970 nel tempio fricchettone dell'Isola di
Wight, frammenti del quale erano già apparsi in Live
Songs, primo album dal vivo del canadese, e nella colonna sonora del documentario dedicato al festival.
Dalla stessa ricca messe di bobine filmate dal regista
Murray Lerner (Miles Davis, Jimi Hendrix...) proviene il documentario contenuto nel dvd che sacrifica
qualcosa del concerto rispetto al cd a vantaggio di spezzoni di testimonianze (Kris Kristofferson, Judy Collins e altri) che ricostruiscono l'atmosfera particolare
dell'evento tra contestazioni sul caro biglietti, le migliaia
di persone e il contorno dei festival dell'epoca (con occhio non benevolissimo, sembrerebbe).
Disco e film ci restituiscono soprattutto un Cohen che,
distante dal contesto per natura ed età, trova un dialogo
con il movimento pur nelle difficoltà di salire sul palco
dopo un Hendrix in vena di Storia. Due tre erroretti sindacali trovano comunque un pubblico desideroso
di catarsi dopo la tempesta psych blues. Merito anche
di una band che si presenta e suona come una comune freak (Tonight Will Be Fine e Diamonds In The Mine in
anteprima da Songs Of Love And Hate) ma che sa pure
sparire nei dettagli richiesti (una quasi finita Famous Blue
Raincoat, anch'essa in anteprima). Chiude Seems So Long
Ago, Nancy suonata su richiesta ma finale quanto mai
adeguato.
Come il Field Commander Cohen di qualche anno
fa, un ottimo ripescaggio.(7.4/10)
Giulio Pasquali
Luigi Tenco - Luigi Tenco, inediti
(Ala Bianca, Novembre 2009)
G enere : canzone d ' autore
Primo passo verso la pubblicazione dell'opera completa prevista, pare, per l'anno appena iniziato, questo cofanetto curato dal direttore del Club Tenco Enrico De
Angelis approfondisce il canzoniere di Luigi Tenco in
due direzioni temporali. Al passato nel primo dei due cd,
che recupera inediti, rarità e versioni alternative conte-
stualizzandole nel libretto con debite note a margine;
e al futuro nel secondo disco che raccoglie diciassette
reinterpretazioni ad opera di colleghi, tutte riprese dalle
varie edizioni del Premio sanremese e in particolare in
quella del 2007, interamente dedicata al cantautore piemontese.

Facile di fronte a operazioni del genere storcere
il naso, sia per il carattere un po' feticista della pubblicazione, sia perché l'effetto raschio del barile è sempre
in agguato. In verità questo Luigi Tenco, inediti brilla
soprattutto per l'accuratezza con cui De Angelis compila
le proprie annotazioni a completare tracce non sempre
perfette sotto il profilo della registrazione e dell'esecuzione, che però rilasciano qualche buona tensione in episodi sparsi tra i due dischi. 

Nel primo cd i tre inediti non sono capolavori ma confermano la qualità di una scrittura sempre all'altezza
(vedasi una Se tieni una stella cantata appositamente da
Massimo Ranieri), capace di spunti positivi sullo spartito (lo strumentale No, no, no riversato in sensuale ipnosi pianistica da Stefano Bollani) ed interessante quando si misura con classici da tradurre (una Vola colomba
che Tenco riscrive come Darling Remerber e Morgan
esegue facendo sperare in
un'insperabile versione di
Marc Almond); il resto
delle tracce invece gioca
su variazioni spesso non
così fondamentali se non
per testimoniare l'importante lavoro di riscrittura
e ripensamento che Tenco
conduceva sulle sue creazioni o per riportare in luce
qualche meritoria riscrittura estera (Un giorno dopo l'altro in francese e in inglese, quest'ultima cantata da Perry
Como).Tuttavia in corso di tracklist ci scappano almeno
due perle come Padroni della terra (prima versione in italiano di Le déserteur di Boris Vian, Fossati venne molto
dopo) e una Vedrai, vedrai in pianovoce che taglia le gambe per intensità; mentre in fondo due tracce del Settetto Moderno Genovese (anno 1957, Tenco al sax)
accennano alle origini jazzistiche del cantautore e un'intervista di Sandro Ciotti - dove Tenco risponde risoluto
a qualsiasi tipo di domanda, compresa una sull'eventuale
imbarazzo nel portare un cognome che rima con quello
di... Nico Fidenco - regala inattesi momenti di comicità
involontaria.
Del tutto differente, come già anticipato, il secondo disco. Tanti gli artisti coinvolti (Roberto Vecchioni, Simone Cristicchi, Ardecore, Skiantos e via dicendo),
e tutti alla fine la sfangano, magari con qualche debito di
85
suoni invecchiati male (vedi Alice in Se sapessi come fai),
ma in pochi riescono a portare a casa versioni di brani
tenchiani realmente memorabili. A parere di chi scrive
un applauso convinto va a Vinicio Capossela, che nel
1999 aprendo il Premio convertì Lontano, lontano alla
meccanica patafisica della sua manovella senza strozzarne lo spirito, e ad Eugenio Finardi che in altra apertura, anno 1994, se la giocò tutta d'anima e vinse.

Ispezionata dunque l'opera laterale, non resta
ora che da attendere la pubblicazione dell'opera completa, la quale non riserverà meno sorprese e meno (appassionata) precisione di questo cofanetto ottimo per
fedeli con istinti da collezionisti ma anche per ascoltatori
attenti e desiderosi di approfondire.(7/10)
Luca Barachetti
Matt Elliott - Songs (Ici d'ailleurs,
Dicembre 2009)
G enere : post cantautorato
E’ un sontuoso mettere il punto per andare a capo e magari dire altro, questo cofanetto che - in 4 cd (o 7 vinili)
- racchiude la trilogia di “canzoni maledette” concepita
da Matt Elliott dopo il trasferimento in Francia. Essendo
il Nostro un comprovato gentleman, ha aggiunto al già
noto - sul quale non torniamo nel dettaglio pur rimarcandone la grandezza - un quarto dischetto intitolato
Failed Songs, contenente sette inediti di qualità al solito elevata da rappresentare l’ideale completamento alla
metamorfosi. Sorprendente e ammirevole (tra)passo che
ha indagato i lati oscuri dell’umanità in maniera profonda
e rara per quest’epoca, la fase parrebbe oramai chiusa
dal ripescaggio del nome Third Eye Foundation.
Sarà nondimeno compito del nuovo lavoro in uscita chiarire le carte in tavola, laddove per adesso basta e avanza
sedersi in una fumosa bettola con Vinicio Capossela e
Tom Waits, mentre sul palco si esibisce Piero Ciampi. Ritrovarsi tutti insieme a tirare mattina in strada tra
una sigaretta e un bicchiere di rosso, a raccontarsi storie
che paiono le solite e invece sono per l’ennesima volta
diverse, come ogni consumato bohemien sa. Tra batterie
spazzolate e corde tese, archi levitanti e voci ombrose,
scorrono valzer falsamente timidi e fotografie seppiate
di un Mediterraneo della mente.
Si ragiona inseguendo fantasmi jazz e un’idea “ambientale” di cantautorato che farebbe la gioia di Scott Walker, rinnovando una tradizione inesauribile e scagliando
il coraggio al di là dell’ostacolo. Nell’ipotesi che ancora
non possediate gli originali, l’occasione è da non farsi
sfuggire; la musica di quelle che mandi a memoria e custodisci sugli scaffali del cuore.(7.7/10)
Giancarlo Turra
86
Morphine - At Your Service
(Rykodisc, Gennaio 2010)
G enere : post blues
"We are Morphine at your service", usava esclamare Mark
Sandman prima di avviare la giga veemente e sinuosa di
quei concerti che avrebbero pasturato la popolarità della
band fino alla tragica conclusione sul palco di Palestrina,
il 3 luglio del 1999. Cinque album, compreso il postumo
The Night, che ipotizzarono un rock indipendente capace di spazzolare le bettole e grattare la pancia al cielo,
giù sul ruvido dei marciapiedi e su tra le languide spire
dell'estasi.
Mark amava chiamarlo "low rock", ed escogitare un
nome non era un vezzo ma la naturale conseguenza di
chi s'inventava di tutto, strumenti e quadratura musicale.
La bussola puntata sull'essenzialità: basso a una o due
corde, slide a tre corde, la band rigorosamente impostata a tre (di norma batteria, sax, basso e voce) eppure
capace di un suono pieno, guizzante, impetuoso (ed è il
caso di spendere un plauso e rendere merito al formidabile Dana Colley). In più, una straordinaria fecondità
compositiva che in questa doppia raccolta vede parziale
celebrazione, presentandoci inediti, versioni alternative e live di un canzoniere
cui non è mai venuta meno
l'urgenza, la forza di volerci
essere come un incontenibile evento naturale.
Nulla di nuovo né di clamoroso rispetto a quanto
già noto, i blues ghignano tra esotismi sinuosi e sferzate
rock, il folk smania errebì e stempera jazz. Dal mucchio
di 35 tracce spiccano la splendida versione alternativa di
Patience, l'irruente Come Along e una Shoot 'Em Down emblematica di come si deve cavalcare dal vivo il demonio
imbizzarrito. Ma è come un pescare a caso dalla manna,
da questa cornucopia di scorie incombuste che, se lo
vorrete, possono ancora bruciare.(7.8/10)
Stefano Solventi
Rodolfo Alchourrón - Sanata Y
Clarificación Vol. 1 y 2 (Vampisoul,
Novembre 2009)
G enere : easy listening
Qualcosa più di due anni fa mi lanciavo, da queste colonne, in una lode dell’etichetta spagnola Vampisoul, annotando come possedesse uno stile prezioso nella cura
con cui promuoveva musiche inusuali degne di riscoperta. Avrò portato scalogna, chissà, ma da allora in poi soltanto ordinaria amministrazione e qualche occasionale
highlight
Gun Club - Miami/Death Party/The Las Vegas Story (Cooking Vinyl UK,
Dicembre 2009)
G enere : roots - punk
In modo paradossale, una band di “culto” come Gun Club s’è vista dedicare negli ultimi anni una nutrita serie di uscite tra ristampe, inediti e tributi. Stupisce sulle prime ma non ripensandoci, essendo la creatura di
Jeffrey Lee Pierce costantemente in bilico tra gloria e disastro, tra affermazione e crollo e non si nutre di
estremi il paradosso? Vincerà l’oscurità, infine, ma se Pierce lo davi per segnato a un’uscita di scena drammatica, altrettanto certo è che la musica - ciò che davvero conta e rimane - nella Storia ci sia entrata, che vi abbia
definito panorami che solo i più distratti potrebbero bollare come marginali.
Passa dalle sue mani (e anche da quelle di Kid “Congo” Powers, qui) il testimone di una tradizione antica però maltrattata a nuova vita: c’è il blues nella sua
vena più oscura e malata, odorante di whisky e voodoo, compagna di demoni
che giocano a dadi e di gente che si vende l’anima, ammesso che ne abbia mai
avuta una. In modo non dissimile dai Doors, altri bianchi che del “nero pece” conoscevano ogni risvolto e ne maneggiavano abilmente i meccanismi, i Gun Club
filtrarono le dodici battute usando lo spirito dei loro tempi: l’inquietudine dei
primi Ottanta americani, ereditata dal decennio precedente e palpabile ovunque
e vieppiù in una California dove era passato il ciclone punk.
Che è il paletto piantato nel cuore delle radici e che serve da fertilizzante per la mala pianta dei Gun Club,
tanto robusta che oggi vi si guarda con ammirazione e in cerca di esempi. Nello specifico, poiché altrove
raccontiamo vicende e dischi, sappiate che a ognuna di queste riedizioni è allegato un secondo cd con un live
(suono da bootleg di buon livello) che nulla aggiunge né toglie alla saga. Le illuminazioni essendo custodite
nelle scalette originali, a partire da Miami, sulfureo secondo LP che da sempre si contende la palma di Capolavoro col predecessore Fire Of Love, rispetto al quale versa più country nel cocktail e sfoggia una voce più
calda. Laddove Death Party fu mini album registrato a New York e focalizzazione di uno stile che inizia a essere
classico. Sarà infine compito del maturo - ombre di jazz, bassifondi e decadenza nella città di illusioni di cui
porta il nome - The Las Vegas Story ratificare a chiare lettere la Grandezza.
Da qui in poi “solo” dischi (alcuni buoni, altri passabili) e non più pezzi di vita per Pierce, ingoiato da un vortice
di litigi e droga, alcool e cuori spezzati. Di lati sempre più oscuri che sostituiscono la realtà alla rappresentazione e così era sin dall’inizio. Perché è ed era blues. Dovendo dunque dare più un senso che un giudizio a questi
dischi, non può essere meno di quanto leggete qui sotto. Riposa in pace, Ramblin’ Jeffrey.(8.5/10)
Giancarlo Turra
zampata dai madrileni, che scivolavano a centro classifica
tra grigi pareggi e deludenti sconfitte.
Categoria dove rientra questo recupero di due LP
pubblicati tra ’72 e ’74 dal compositore, arrangiatore
e chitarrista argentino Rodolfo Alchourrón: che, nato
nel 1934 a Buenos Aires, dopo un’educazione classica
trafficò col jazz al fianco di Gato Barbieri e si diede
al tango con Astor Piazzola senza tralasciare rock e
tradizione folk locale. Affrontando problemi commerciali, nei tardi Settanta proseguì l’attività a New York, dove
si spense undici anni or sono.
Spirito curioso e attivo con un’infinità di formazioni, è
qui latore di un lounge filmico che mescola quanto sopra
senza particolari guizzi né ironia; che invece di attrarre
l’attenzione trascolora in sottofondo. Non c’è peggior
destino per questa musica, che i nostri Umiliani e Piccioni concepivano con inventiva e verve superiori. Ragazzi, provate a cambiare schemi o allenatore, perché in
ballo adesso c’è la retrocessione.(5.5/10)
Giancarlo Turra
87
Rearview Mirror
—speciale
Gun Club
Camminando con la Bestia
Da quasi quindici anni Jeffrey Lee Pierce non è più
tra noi, eppure pare vivo più che mai, mentre la classicità dei Gun Club cresce da solide radici.
88
Testo: Giancarlo Turra
“Scrivo moltissime canzoni disperate, del tipo ‘O Dio perché
mi hai abbandonato’. Parlo d’emozioni tenute dentro e della
perdita di fiducia: è parte della condizione umana essere così
disillusi che l’anima muore. Non ha niente a che vedere col
fatto di vivere a Los Angeles." (Jeffrey Lee Pierce, 1981)
C
on quei lineamenti da paffuto Marlon Brando dei
bassifondi, uno come Pierce lo davi per spacciato
appena ci puntavi gli occhi sopra. Attorno a sé aveva
quell’aria tipica di chi non arriva alla vecchiaia; che si nega
- come certi bluesmen del Delta - un sereno tramonto
in cui si guarda la gioventù con un sorriso. Non era “nella
parte” e infatti il destino aveva in serbo ben altro: Jeffrey
era un doomed che non si limitava all’immagine esteriore. Andava a fondo e scavava nel profondo dei demoni di
chiunque perché qualcuno deve farlo. Poteva accontentarsi di un aspetto da B-movie e di oltraggi da teatrino,
della felicità di sembrare - come cantava lui stesso - un
“Elvis venuto dall’inferno.” Macchè: non sarebbe stato altrettanto potente e scorticante il suo rimestare in acque
punk le radici e i misteri del suono (e del sogno) americano. L’accostare santi e diavoli, gotico e beat, sesso e
romanticismo in un calderone incendiario e stordente; il
parlare esplicitamente della violenza insita nella società
statunitense sin dalla scelta di chiamare il gruppo “club
del fucile”, raccontare vicende che evocano personaggi
buoni per Cormac McCarthy, certi pazzi che di morte
vivono e la guardano negli occhi ridendo. Ma quelli sono
leggende e inchiostro, non carne e nervi.
Jeffrey Lee Pierce doveva per forza camminare sul
filo del rasoio, tagliarsi e sanguinare in un sadico gioco
di estremi. Un ragazzo biondo e stralunato che dentro
era negro e dal baratro non uscirà vincitore, schiacciato
dalle “solite” debolezze e, soprattutto, dal troppo dare
del tu ai demoni in un rapporto di amore/odio. Dall’eccesso di rovelli dell’animo, anche, scandagliati fino a non
poterne più e scivolare dentro una spirale di caos. Infine,
vittima di se medesimo e delle sue scelte.Tuttavia, la musica - ciò che conta veramente - resta un esempio mirabile di tradizione schiaffeggiata, di un futuro ricostruito
coi cocci del passato e condotto a viva forza fuori de
accademie e musei di nuovo in strada, dove dovrebbe
sempre stare a fregarsene delle convenzioni, a sconvolgerci ed esaltarci come se non vi fosse un domani.
Che oggi leggi modello morabile per giganti della levatura di Mark Lanegan (diverranno amici dopo che l'ex
Screaming Trees rileggerà da maestro Carry Home) e
David Eugene Edwards, di tutti coloro che seguono
quelle orme sonore e spirituali impresse con una rivisitazione animalesca di blues, country e memorie sixties
non così scontata nel 1980. Dopo il punk, di fronte a
un bivio di estremizzazione hardcore o a un immaginifico post, bastian contrari come i Gun Club indicarono
una “terza via” che poteva essere affrontata in svariate
maniere: da valenti traghettatori fedeli alla linea come
i Blasters, da sardonici fumetti divenuti realtà come i
Cramps, da torvi e pertanto umanissimi rimestatori del
torbido come loro.
Nulla mancava: non la conoscenza appresa dalla fonte (Jeffrey era un collezionista ed esperto di blues; ma
pure appassionato di soul ed errebì, di reggae e jazz);
non la capacità di dare del passato una visone contemporanea, soffiando le inquietudini e l’asfissia dell’America
reaganiana in qualcosa di antico e contemporaneamente
indenne alla clessidra. Era il Mississippi che sfociava in
California, tra le tante cose: la più terrigna delle musiche
che trascolorava nella città delle illusioni per eccellenza.
Uno stile che, da iconoclasta qual’era, pian piano sarà accettato tra le maglie del mainstream con i White Stripes (Jack White il fan terminale), assurgendo a classico
- seppur di nicchia - senza rimetterci un’oncia di furore.
Soltanto bestemmiando il Verbo ne trattieni lo spirito e
cosa meglio di un’anima che si vende al crocicchio di Robert Johnson, fradicia di depravazione e strabordante
oscura poesia. Quel buio che giace dentro ognuno e non
tutti vogliono scrutare: solo i più forti, e al contempo i
più deboli, ne sono capaci e talvolta qualcuno torna a
raccontare cosa ha visto. Dopo di che, per lui e noi non
c’è più pace.
Fired B y L ove
Una vicenda tormentata, questa, e spesso spiacevole. Per
questo - e perché di decessi del rock siamo stufi, pur
nella consapevolezza della nostra impotenza - su alcuni
aneddoti soprassederemo. Perché sapere quanta droga
scorreva a un certo punto nelle vene di Jeffrey o quando whisky gli stesse fottendo testa e fisico conta zero.
Importa il ruolo fondamentale di una formazione uscita
dal sottobosco punk losangelino per gettarsi con rabbia
famelica sulle radici, in ciò mostrando la via a legiosni
di successori. Il punto stava e sta tuttora nell’attitudine,
nell’omaggio che si realizza attraverso l’oltraggio; nella
mancanza di rispetto verso la rigidità dei puristi, per i
quali il rock and roll - che è soprattuo fusione! - non
sarebbe manco esistito, epperò vai a spiegarglielo. Nel
voler strapazzare l’oggertto del proprio amore per infondergli uno spirito nuovo.
Se presti fede al diabolus ex machina Pierce, l’idea di
partenza era distruggere e poi (ri)creare, dunque vicina
più ai Birthday Party che a band coeve e alle prese con
la medesima materia. Per restare in città e scovare qualcosa di simile devi in effetti bussare alla porta di Chris
89
D. e dei Flesh Eaters, cosicché un cerchio iniziale si
chiude. Prima del quale urge un flashback al 1979, quanto
il ventenne Pierce scrive per la fanzine punk Slash, occupandosi con competenza di rockabilly anni ’50 e blues
prebellico, sorprendendo per l’apertura mentale che lo
conduce ad appassionarsi alla musica giamaicana e, tra le
altre cose, a fondare il fan club dei Blondie stringendo
amicizia con Deborah Harry e Chris Stein. In occasione di un concerto dei Pere Ubu conosce Brian
Tristan, in arte Kid “Congo” Powers, ammiratore dei
Ramones e chitarrista autodidatta. Poiché il biondo glamorous è appena tornato da un istruttivo giro a New
York, scioccato dalla No Wave e dal suo approccio viscerale che tralascia la tecnica in favore dell’espressività,
ritiene una buona idea mettere su una band con questo
tizio. Il quale dovrebbe essere il chitarrista solista, ma
uno strumento manco lo possiede; Pierce prende per sé
il microfono e risolve la questione prestandogli la sua, un
amplificatore e - a mo’ di riferimenti - il vinile di debutto
delle Slits e vecchi 33 giri di Bo Diddley.
Appare già chiaro che il Nostro abbia un’immagine
chiara in testa, pur senza perdersi in fumosi intellettualismi. Dopo un breve periodo come Cyclones si ribattezzano con un più suggestivo Creeping Ritual, mentre
alla sezione ritmica passano un po’ di facce. Trascorrono
due anni facendosi le ossa, suonando spesso di supporto
al meglio della scena punk locale, finché l’amico Keith
Morris (che canta per Black Flag e presto sarà nei
Circle Jerks) se n’esce col nome che sappiamo. Con
mossa molto Settantasettina, rileggono Marvin Gaye
e cercano idee nella libertà regolata di Ornette Coleman, risoluti a sferzare il blues e mostrare che il vero
insulto è la versione fiacca datane da bianchi senza palle.
Così si spiega in buona parte il linguaggio esecutivo di
Powers volto a lavorare di tessiture e rumorismo, come
si evince - nonostante la scarsa qualità - da registrazioni d’epoca incluse in The Birth The Death The Ghost
(ABC, 1983; 6,5/10) e raccolte su palchi di L.A. nel 1980.
Persa la ritmica originaria causa screzi (non sarà mai individuo facile JL: dispotico, bugiardo patologico, debole e
perciò manipolatore), c’è un primo spartiacque.Arrivano
il bassista Terry Graham e il batterista Rob Ritter,
ambedue di solida e fantasiosa militanza nei Bags. Succede però che Lux Interior e relativa ghenga siano in
città e abbiamo problemi a gestire il chitarrista Bryan
Gregory: poiché le affinità elettive non le puoi domare,
iniziano a girare con i Gun Club e, già che ci sono, gli
scippano Kid Congo che in tal modo esce di scena per
un triennio. Sarà un caso, tuttavia anche il rimpiazzo aveva sostenuto un provino per i Cramps.
Si chiama Ward Dotson, californiano di Anaheim
90
e tecnicamente preparato, adroatore delle “roots” ed
elemento perfetto per fungere da pietra angolare. Finalmente pronto, l’LP d’esordio Fire Of Love (Ruby, 1981;
9,0/10) è sensazionale affare di famiglia “allargata”, l’etichetta proprietà di Chris D. che inoltre produce cinque
tracce e invita Tito Larriva dei Plugz al violino, piazzandolo poi dietro al mixer per il resto della scaletta. Inciso in un paio di giorni con pochi overdub e insistendo
su Pierce per un approccio punk molto ruvido e "tirato",
incalza e maledice, turbando come una lama passata sulla
giugulare. Una mescolanza non più distinguibile tra '77,
rockabilly, country e blues col piglio irrefrenabile della
gioventù, irosa e strafottente eppure capace di cogliere dettagli e robustezza del collettivo, nonostante un
contesto minimale. Lo chiariscono la sferragliante Sex
Beat e Cool Drink Of Water, classico di Tommy Johnson
dilatato a sei minuti caracollanti tra narcosi e desolazione; la controversa (con un testo presunto razzista:
è interpretazione, sappiatelo) For The Love Of Ivy scorre tra buio e riverberi mentre Promise Me incede stranita
su un violino scorticante e ronzare di corde velvetiane.
Rock furibondo eppure poetico, dal quale i primi Dream Syndicate e Violent Femmes trarranno subito
linfa vitale (She Is Like Heroin To Me, Jack On Fire) e che ti
sbatte in faccia con oggettività un infervorato delirio, un
terrore che magnetizza (Ghost On The Highway, Goodbye
Johnny: i Suicide con le chitarre?). Epocale, insomma, e
la prima indicazione di un ego geniale però accentratore
che subito litiga con la Ruby.
Ecco spiegato l’ingresso alla corte di Chris Stein per
il seguito Miami (Animal, 1981; 8,5/10), messo su nastro
in un’angusta stanza newyorchese che aggiunge ulteriore, claustrofobico fascino al cocktail. Titolo che evoca un
luogo dove l’apparenza è una cortina tirata sul sordido,
su qualcosa di sudicio e immorale (come del resto Los
Angeles e New Orleans; poi toccherà a Las Vegas…) e
un album che intelligentemente non ricalca il predecessore, approfondendo il lavoro sull’interpretazione vocale
(sorta di Jim Morrison “black”, moderno e privo di retorica: A Devil In The Woods), sui fraseggi country in composizioni fascinose e indimenticabili come Carry Home,
Like Calling Up Thunder e Mother Of Earth. Stein crea sottintesi e lascia a JL spazio per muoversi in un’atmosfera
oppiacea, lontana dall’impatto sul palco dei Gun Club ed
è giusto così. La band, intanto, salda il conto col passato
rileggendo Run Through The Jungle e il rockabilly The Fire
Of Love, poi s’inventa un sensazionale Chris Isaak perverso e corrotto in Watermelon Man. Senza tralasciare la
vena misticheggiante di testi che altrove sono brucianti
istantanee di realismo, l’irruenza ragionata e vieppiù irresistibile (Bad Indian, i cori - omaggio della Harry sotto
pseudonimo - di Brother And Sister; la traslucida gemma
Texas Serenade).
Roba da pronosticare onori e un po’ di soldi in più
nella tasca e figurarsi: col disco nei negozi, Ritter ha detto basta preferendo i 45 Grave e in copertina le facce
sono tre, Dotson offuscato dal faccione torvo del Jeffrey.
Un presagio, visto che anch’egli è fuori entro fine anno
(fonderà i discreti Pontiac Brothers) e idem Ward per
i troppi litigi tra galletti. Prima di sbattere la porta Rob ha
istruito sul repertorio la conturbante goth-lady Patricia
Morrison, che fa così il suo ingresso in una line-up completata dalla tagliente chitarra di Jim Duckworth e dal
batterista Dee Pop. Resistono sei mesi, nei quali il leader cerca di incassare due lire - vizio che presto genererà
una pletora di uscite trascurabili - con il live Sexbeat 81
(Lolita, 1982; 5,0/10) e si innamora follemente di Linda
“Texalcala” Jones, cantante di Tex & The Horseheads. Di costei la voce sul mini registrato approfittando di
una session per gli Horseheads andata buca: Death Party (Animal, 1983; 7,3/10) mostra sonorità più squadrate
e compatte da ascrivere ai nuovi innesti. Da ricordare
la title-track, il midollo diddleyiano Come Back Jim e una
raffinata The House On Highland Avenue.
Altro giro di giostra attorno al dispotico Pierce, frattanto, che richiama Terry Graham per un imminente tour
in Australia: Duckworth abbandona per disaccordi con il
management e Terry lo segue. Sull’aereo salgono Jeffery
Lee e Patricia, dapprima scortati da una band locale e poi
dalla vecchia conoscenza Kid Congo Powers. Mossa vincente, giacché il Kid sarà a lungo braccio destro del Nostro, restandogli accanto fino alla fine. C’è un lungo ed
eccitante tour europeo a benedire l’amalgama e a consegnare la maturità con Las Vegas Story (Animal, 1984;
7,8/10) senza smarrire verve e potenza, in virtù anche
del rientrato Graham. Il palco roda le composizioni che
affrescano un ritratto ancor più meditato del Grande
Paese e delle sue contraddizioni. Palesi la produzione di
una ricercatezza che è crescita progressiva in termini di
arrangiamento e scrittura, ma anche volontà di incanalare il “clima” della città che battezza il lavoro; soprattutto
91
l’impianto di base, sorta di romanzo noir che strada facendo si adatta da solo in pellicola.
Recuperata la tambureggiante e innodica Walking With
The Beast dal retro del 45 The Fire Of Love, si racchiude
la mezz’ora di The Creator Has A Master Plan - Pharaoh
Sanders: eccola, l’apertura mentale - in novanta secondi;
si ospita Dave Alvin nelle anthemiche Eternally Is Here
e Give Up The Sun; ci si getta nel buio per The Stranger In
Our Town e una My Dreams da Joy Division d’oltreoceano. Dominano varietà e rifiuto delle convenzioni ed è qui
il significato della cover di My Man's Gone Now, Pierce
che schiaccia il pedale di teatralità e confusione sessuale
da tossico Mark Almond. Tradizione rivisitata sempre
e comunque, altrove ratificata nella romantica Secret Fires (in origine non sul vinile, ripescata da cassetta e cd) e
nella livida Bad America, nelle camere del Moonlight Motel
e in tutte le date della touree europea. Riuscita al punto
che ne sortisce il live Danse Kalinda Boom (Megadisc,
1985; 6,8/10) e il quartetto compare nel programma della BBC The Tube in un’esibizione sconvolgente. Non tutto rose e fiori, comunque, dato che Terry getta la spugna
definitivamente a Parigi; il resto della brigata si stabilisce
a Londra cercando di capitalizzare quel poco di clamore
e confidando nel supporto della stampa locale.
Durante una data con i Scientists, il loro cantante
Kim Salmon presenta a Pierce la fotografa giapponese
Romi Mori: amore a prima vista e conseguente abbandono di tutto il resto, gruppo incluso. Congo e la Morrison fondano i trascurabili Fur Bible col batterista Nick
Sanderson. Il capo dal canto suo risponde in solitudine
con l’apprezzabile prova del dylaniano Wildweed (Statik,
1985; 7,0/10). Nei concerti che ne seguono la pubblicazione, lo scortano giustappunto Sanderson e la Mori al
92
basso. Ancora non può saperlo, ma è solo l’inizio di una
discesa in inferi non più redenti dall’arte.
R amblin' to the end
“Poiché non vivrò a lungo, dovrai rispondere tu alle mie lettere, spiegare a tutti i giornali che ho comprato il biglietto per
l’inferno. Per laggiù, sotto a questo mondo.” (Up Above The
World; 1993)
Prima della graduale picchiata al suolo da altezze forse troppo grandi, Mr. Pierce prende tempo riposandosi
con la Mori e qualche distratta apparizione in cui recita
poesie. Ricaricate a suo modo le batterie con alcol e
droga e la partecipazione all’emozionante “cult record”
I Knew Buffalo Bill di Jeremy Gluck (della partita Nikki Sudden, suo fratello Epic Soundtracks e Rowland S. Howard: viene da commuoversi e incazzarsi),
riapre il Club nel 1987 con la fidanzata e il fido Powers,
nel frattempo divenuto parte integrante dei Bad Seeds.
A tamburi e piatti siede Sanderson e i concerti dell’epoca non sono granché benauguranti: una band limitata
tecnicamente sorregge come può un frontman rifugiato nello stereotipo; certo non quello che vorresti dopo
un biennio di sosta. Per questo motivo desta sorpresa
a dicembre Mother Juno (Red Rhino, 1987; 7,0/10) e
ancor più la presenza, nel ruolo di produttore, di Robin
Guthrie dei Cocteau Twins. Stupore che lascia spazio
a un sorriso d’approvazione grazie alla teatralità di Breaking Hands e al rockabilly Bill Bailey, alla splendida Yellow
Eyes con ospite Blixa Bargeld e alla serrata Thunderhead. Se aggiungete Hearts e la lenta Lupita Screams, avrete
l’ultimo 33 del Nostro da mettere in casa senza alcun
patema. Ciò nonostante è palpabile la confusione ed è
evidente che le troppe interruzioni abbiano fatto perde-
re il treno e la centralità - seppur a livello “underground”
- della formazione.
Prova ne sia un progetto solista dell’uomo che si trascina per un biennio e ha per oggetto alcune cover di brani
preferiti da Jeffrey, sostanzialmente vecchi country, blues
e murder ballads. Ne discuterà a un festival con l’amico
Nick Cave, che ripulito e focalizzato sulla propria attività farà dell'intuizione miglior uso. Il disco a firma Ramblin'
Jeffrey Lee, vedrà la luce nell’indifferenza generale e con
vendite risicate. Il decennio si chiude in tono minore con
una nuova fatica dei Gun Club, quel Pastoral Hide And
Seek (PIAS, 1990; 6,7/10) in cui la chitarra di Romi guadagna spazio e le sonorità si ammorbidiscono: il leader pare
sereno, viaggia e si interessa alla cultura orientale; per un
poco allontana da sé i vizi e la matrigna Los Angeles; può
così scrivere brani di buon livello come Straits Of Love
And Hate e Another Country's Young, come Humanesque e I
Hear Your Heart Singing. Sostanza stilistica che non cambia,
benché l’opera risenta in positivo del successivo Divinity
(New Rose, 1991; 5,0/10), inconcludente pasticcio in studio e dal vivo che, tra ripescaggi e ispirazione in soffitta,
poteva raccontare un artista placato ma dimesso oppure
perso definitivamente dentro a follia e dipendenze. La
soluzione, in ambedue i casi, è in arrivo.
C’è il forfait di Nick Sanderson, cui subentra tale Simon Fish ovvero il 'Willie Love” che compare nel secondo album solista di cui sopra, Ramblin' Jeffrey Lee
& Cypress Grove With Willie Love (New Rose, 1992;
6,6/10).Vi sfilano un paio di originali discreti benché l’anima sia in riprese di brani altrui: Charlie Patton (Pony
Blues), Howlin’ Wolf (Moanin' In The Moonlight) e Skip
James (Hardtime Killin' Floor Blues) le più note e azzeccate. Chiamatelo atto d’amore o rivelazione, magari un
messaggio nella bottiglia nemmeno troppo velato in un
estremo momento di lucidità. Fatto è che il tunnel è imboccato e la luce, là in fondo, appartiene a un treno lanciato a folle velocità. Nel corso dei ventiquattro mesi che
seguono, Pierce alterna uscite acustiche a esibizioni un
po’ così con i Gun Club, come testimonia Ahmed's Wild
Dream (Solid, 1992; 6,4/10 - in America uscirà come Live
In The U.S.), ricavato da un’esibizione olandese che mostra del buon lavoro di sei corde ma suscita inevitabili e
stridenti confronti.Vale più come ultima registrazione ufficiale in cui appare Kid Congo: infine solo, Jeffery richiama Sanderson e combina casini a ruota libera. Non ne
risente troppo il commiato Lucky Jim (What’s So Funny
About, 1993; 6,7/10), più robusto compositivamente e
impreziosito da liriche belle come mai mentre il cantante
si fa carico della quasi totalità delle chitarre. Senza nulla
togliere, l’assenza del Ragazzo Congo è tangibile ma non
nel semiacustico brano omonimo, nell’autobiografica Ka-
mata Hollywood City, in Idiot Waltz e Cry To Me. Passabile,
ma Jeff non ci sta proprio più con la testa e da qui in poi
non è un bello spettacolo. Tradita la Mori con un’altra
giapponese - la fotografa Kayo Hosaka - se la gioca a favore di Sanderson: in siffatto “valzer idiota” spariscono
sezione ritmica, l’amore della vita e voglia di vivere.
Sulla via dell’autodistruzione a niente servono un
giro concertistico sul continente coi Cypress Grove e le
comparsate con Bad Seeds e Kim Salmon. Scade il visto
ed è obbligato a lasciare il Regno Unito, rifugiandosi in
Olanda e facendo la spola con l’oriente, tentando di ricostruirsi una carriera in Giappone. Ennesimo fallimento,
con la conseguenza di un fatale rimpatrio nel grembo californiano. Nuovamente a L.A., Jeffrey Lee butta giù un’avvelenata biografia che uscirà postuma, tuttavia la catarsi
è insufficiente. Ha ormai deciso, sicché è solo questione
di tempo. Che viene trascorso frequentando la cricca di
Snoop Doggy Dogg (!) e appassionandosi al rap, che
il Nostro - in un’ultima follia - vorrebbe fondere con
l’idioma del Sol Levante in un (parole sue...) rappanese
che siamo in fondo felici ci sia stato risparmiato. Eccolo
parlottare spento sul Tom Waits di Pasties & A G-string
per il tributo Step Right Up, suonicchiare con poca verve
e ancor meno convinzione qui e là, più di tutto stare seduro al bancone del Viper Room.
La lancetta scatta il 31 marzo 1997: a nemmeno trentotto
primavere, Jeffrey Lee Pierce è sieropositivo, ha l’epatite e
un fegato devastato ma non un dollaro per cercare di curarsi. In visita al padre nello Utah, lo sorprende un infarto
e addio. Sono trascorsi da allora tredici anni e gli omaggi
nel frattempo sono andati moltiplicandosi, sotto forma di
nuove edizioni, riscoperte (la più significativa Early Warning, un Sympathy For The Record Industry del 1997 con
versioni alternative in studio, demo acustici e live dell’82;
7,0/10), omaggi. Dapprima il progetto italiano di Nicola
Cereda e del Circo Fantasma che in I Knew Jeffrey
Lee (Lain, 2006; 7,0/10), ripropone col cuore in mano anche sei brani di Pierce con gusto e la presenza di Emidio
Clementi, Cesare Basile, Steve Wynn. Più recente
e “pesante” We Are Only Riders (Glitterhouse, 2009;
7,5/10), lungo il quale Pierce aleggia come uno spettro,
la voce recuperata - un paio di brani soltanto, però - da
un nastro scoperto da Cypress Grove e reinterpretato
da spiriti affini. Compaiono Cave, Lanegan, Edwards, Kid
Congo e Deborah Harry al fianco di leve più giovani (Raveonettes, Sadies) e figure che era logico aspettarsi
(Lydia Lunch, Mick Harvey, Barry Adamson). Legato da vigorose affinità elettive e da un’eredità benissimo
compresa e portata avanti. Che, in qualche modo, lenisce
la ferita di un’anima fin troppo (auto)devastata. Grazie
comunque, voodoo child.
93
(GI)Ant Steps #35
classic album rev
Sonny Clark
Violent Femmes
Dial "S" For Sonny (Blue Note, Luglio 1957)
Violent Femmes (Slash, Aprile 1983)
A cinquantadue anni compiuti il primo episodio solista
di Sonny Clark ha ancora lo stesso fascino discreto che
metteva in mostra in pieno Bebop. Defilato, certamente
meno pirotecnico di altre produzioni dell'epoca, ma capace di reggersi a meraviglia grazie a un jazz organico e a
una scrittura lineare come poche. Merito del suo autore,
pianista di sostanza cresciuto ricalcando lo stile di Horace Silver, Bud Powell, Thelonious Monk e merito
probabilmente anche di una biografia sfortunata che vide
il Nostro esordire a suo nome nel 1957 e lasciare questo mondo già nel 1963. Il tutto a soli trentadue anni, per
colpa dell'eroina e senza il tempo di dimostrare più di
quanto si ascolta in quel pugno di dischi che costituisce
la sua ridotta discografia.
Fino a quel momento il percorso di Clark era stato di
quelli istituzionali, tra collaborazioni di rilievo con Dexter Gordon, Stan Getz e Bud Shank quando la base operativa era ancora Los Angeles e sessions con Charles
Mingus e Sonny Rollins dopo il trasferimento in quel
di New York. Segno di uno stile giovane ma già formato,
sicuro ma al tempo stesso malleabile, ideale per il ruolo
di sideman e house pianist che la Blue Note gli affiderà
verso la fine degli anni Cinquanta.
Rilassatezza, interplay, organicità, blues: parole che in Dial
“S” For Sonny inventano sei brani che stemperano l'enfasi del Bebop trasformandola in armonia e soprattutto
94
visione d'insieme. A creare un ponte con la contemporaneità jazz pensa la tromba di Art Farmer, decisa a
sfruttare a dovere gli ampi spazi concessi dalla sobria
scrittura di Clark con uno stile energico ma non debordante. Come si ascolta nella title track ma soprattutto
in Bootin' It, tra saliscendi spericolati di ottoni – sono
della partita anche Curtis Fuller al trombone e Hank
Mobley al sax tenore – e svisate del padrone di casa sul
pianoforte. Il tutto entro gli steccati di una musica impostata su un backgrond virtuoso, sull'accento nascosto
e lontana da grossi scossoni o nette cesure, improvvisi
ribaltamenti o impeti rivoluzionari. Anche in quella Sonny's Mood posta a metà programma che rappresenta con
il suo mid tempo impeccabile un po' tutto il mood disco.
Con un Clark swingante più che mai chiamato a cesellare alla sua maniera, tra grassetti in solitaria rispettosi
della melodia e un impianto armonico lucidissimo.
Bistrattata da buona parte della critica dei grandi nomi e
scosciuta ai più dopo la morte dell'autore, la produzione
di Sonny Clark subirà una rivalutazione repentina soltanto verso la metà degli anni Ottanta, quando John Zorn
metterà in piedi il Sonny Clark Memorial Quartet. Una
degna conclusione di una storia finita troppo in fretta.
Fabrizio Zampighi
I primi anni ottanta. Musicalmente, il periodo assomiglia
alla spuma di un’onda sul punto di precipitare, tra ultimi
fuochi punk, spuri compiacimenti elettronici, amplificazioni selvagge e contaminazioni sbalorditive. E tradizione
che preme per indossare maschere nuove. A Los Angeles spuntano come demoni meravigliosi i Gun Club.
Ma quella, signori, è la California. A Milwakee, stato del
Wisconsin, città dei grandi laghi e della birra, accade
qualcosa di simile, in qualche modo. Ma diverso. Il destino suggerisce a Gordon Gano (voce e chitarra), Victor
De Lorenzo (batteria) e Brian Ritchie (basso e un sacco
di altre cose) una missione chiamata Violent Femmes.
Obiettivi principali: ruvidezza, genuinità, mancanza di rispetto. Tutti raggiunti, e al primo colpo.
La loro prima leggendaria esibizione, avvenuta nella
scuola frequentata da Gano, non fu priva di conseguenze:
le liriche troppo allusive (che in realtà poco lasciavano
all’immaginazione) guadagnarono al vocalist l’allontanamento dall’istituto e al padre di lui - predicatore battista
convinto di aver cresciuto il pargolo a pane e riverenze
sacre – qualche motivo di imbarazzo e riflessione. In realtà i tre sciagurati un sacro fuoco da adorare ce l’avevano
eccome, e alimentato da combustibili doc: come i Modern Lovers del geniale loser Jonathan Ritchman, o
il Tom Verlaine artefice di irrequieti sogni lunari, eppoi
il country-folk, il vaudeville, il blues, Lou Reed, la verve
del jazz, la Bibbia, il teatro d’avanguardia…
Ingredienti che, ben centrifugati e sottoposti a febbrile
disciplina unplugged (ante litteram), costituirono motore e sostanza dell’omonimo album d’esordio, ancora
oggi bruciante come un nervo appena scoperto, come
se avesse preso letteralmente a ceffoni le ingiurie degli
anni. In che modo questo sia possibile, è un mistero ma
neanche troppo: in realtà il chitarrone di Gano, il diteggiare fibroso di Ritchie e le batterie improvvisate di De
Lorenzo furono e sono la manifestazione tangibile di un
dissidio antico e ancora attualissimo, quello tra carne e
spirito, tra convenzione e istinto, tra regole e fregole. Di
questo sono fatte le loro canzoni, dello stesso impasto
che da sempre rende necessario, impellente, naturale il
fenomeno “rock”.
Insomma, Violent Femmes è un disco esplosivo fin dal
mefistofelico arpeggio che apre Blister In The Sun, due minuti e mezzo di lusinghe ormonali e potenza de-elettrificata, spiritello campestre prestato alle smanie del punk,
vero e proprio sortilegio acustico i cui gran cerimonieri
sono una batteria perversa (che esibisce in punta d'orgoglio la propria nudità) e la voce di Gano trotterellante
sul ritornello assatanato. Qui, contese tra la provincia
e il mondo, le radici del folk ritrovano urgenza, senso e
applicazione.
Per poi carburare bellamente rhythm and blues, come è
il caso della convulsa Add It Up o quella fanfaluca di Prove
My Love (dove De Lorenzo si esalta tra sincopi e ratataplan). E che dire dell'estro stradaiolo di Gone Daddy
Gone - con quello xilofono da mortesecca burlona - e
del jazz-blues di Confessions? Per approdare infine a Good
Feeling, con quel sorprendente assolo di violino e tutto
un languore sordidello che fa coagulare lo spirito Velvet
Underground annidato tra i solchi.
I lavori successivi (soprattutto Halloweed Ground e 3)
si difesero bene senza però eguagliare freschezza, urgenza e ispirazione dell’esordio. Che resta disco godurioso,
dalla portata enorme per tanto "indie" successivo e oserei dire contemporaneo.
Stefano Solventi
95
la sera della prima
—speciale
3-D
parte terza
Il salto finale nella storia del
3-D è complesso da decifrare perché lo stiamo vivendo
e perché sono in gioco fattori
che riguardano il progresso
tecnologico nell’ottica e nella
componente digitale.
Testo: Costanza Salvi
96
Eccoci arrivati all’ultima puntata della nostra storia del
cinema in 3-D; riassumendo le cose potremo notare, in
fondo, una relativa continuità. Continuità che riguarda,
prima di tutto, soggetti e generi privilegiati dal cinema
in 3-D: fantasy, horror, animazione per un pubblico molto giovane. Anche gli effetti sono rimasti più o meno gli
stessi o, al massimo, hanno subito qualche processo di
restyling. Basta notare la profusione di lanci degli oggetti
verso il pubblico o la loro disposizione sull’asse della
profondità all’interno dell’inquadratura, presenti già nei
primi film. Infine la commistione fra l’elemento commerciale curato dagli Studios e quello sperimentale/visionario di alcuni sconosciuti entusiasti della tecnica è
rimasta invariata dagli anni 50 in poi. Parlare del passato
e trovare elementi costanti è facile da questo punto di
vista, perché le varie ondate della rinascita del 3-D coincidono esattamente ai vari momenti di crisi economica
e di minaccia alla peculiarità della visione del film in sala:
TV nei 50,VCR e home-video negli 80, Internet nel 2000.
Il salto finale nella storia del 3-D è, però, più complesso da decifrare sia perché lo stiamo ancora vivendo sia
perché sono in gioco più fattori che riguardano proprio
il progresso tecnologico nell’ottica e nella componente digitale. Il digitale è, infatti, antagonista (chi fa più lo
sforzo di recarsi nelle sale se può scaricare dalla rete?)
ma anche nuovo alleato del cinema per grande schermo,
soprattutto rispetto al 3-D: risolve problemi tecnici, affranca da molti vincoli e permette alla creatività di volare
in territori sconfinati producendo risultati che si adattano perfettamente solo alle grandi dimensioni di uno
schermo.
Si tratta, poi, di decidere se considerare il 3-D come l’ultima tappa dell’evoluzione che portò dal muto al sonoro,
dal b/n al colore e concordare sulla possibilità che vada
a sostituire tutto il cinema che abbiamo conosciuto fin
d’ora. Le maggiori case di produzione, soprattutto per
l’animazione, hanno già dichiarato che i prossimi film
saranno tutti in 3-D e che, d’ora in avanti, verrà utilizzata solo questa tecnica. Ci sono registi che da qualche
anno si dedicano completamente a questa nuova strada: Robert Zemeckis e James Cameron in primis.
Nella loro scelta siamo quasi costretti ad intravedere
un sottotesto: il cinema del futuro sta qui. Non penso
siano molto sicuri di quello che dicono ma fanno finta di esserlo, seguendo quella famosa strategia in cui si
danno in pasto rumors e si raccolgono ‘verità’. In realtà
nessuno può essere sicuro di nulla; si tratta di scommesse e previsioni soggette a ritrattazioni e cambi repentini
d’opinione. Forse questa grande incognita che incombe
sul cinema d’intrattenimento rispetto al suo successo e
alle sue possibili nuove strade ha a che fare con l’estre-
ma fugacità del film, con la difficoltà che ha un film di
essere ricordato, di entrare nella memoria e nella stratificazione dell’immaginario comune. Per questo si devono ‘inventare’ e costruire momenti di svolta; soprattutto,
come accade per Avatar, si deve trasformare un film in
media-event attraverso la collaborazione con altri media,
lo si deve identificare con un look estroso che, come
un cappotto o una bibita, possa fare tendenza ed essere
all’avanguardia. In questa nostra metafora il 3-D appare
proprio come le scarpe all’ultimo grido, lo stile stravagante di una giacca che tutti finiscono per amare (e, in
realtà, è stato ripescato dal fondo del baule).
Il cinema, si diceva un tempo, sembra essere fragile come
la pellicola su cui viaggia, soggetto a caducità e invecchiamento precoce; ora che tutto è in digitale e che un film
viene scaricato, distribuito e scambiato nella rete, quel
senso di fragilità è stato forse leggermente corretto. Ciò
che fa venire in mente è, più che altro, l’idea di un contagio, di un virus che si clona in miliardi di varianti (serie,
sequel, prequel, reboot ecc). Paradossalmente, poi, nonostante il veloce ricambio degli apparati e dei software, un
film sembra anche essere più restio a dimostrare gli anni
che ha e ad invecchiare velocemente, come succede ad un
qualsiasi altro film girato su pellicola: lo direste che sono
già passati dieci anni da The Matrix? Questo del tempo
e della memoria è un tema da sempre connesso con il
cinema e ha una particolare relazione con il 3-D. Mi è
capitato di incorrere in un’interessante obiezione in proposito sollevata da Kristin Thompson (Duellanti, gennaio
2010). Lei sosteneva di non ricordare la tridimensionalità
delle immagini in 3-D; il suo ricordo, l’immagine mentale
che ha tratto da molti film 3-D, è, inesorabilmente, destinata alle due dimensioni. Forse questo ha a che fare con
i limiti dello schermo, ovvero il suo perimetro, dal quale
non si può prescindere, confine questo davvero inesorabile che comporta la scelta elettiva di una porzione di
realtà, di una ‘veduta’. Le cose potrebbero cambiare se
cominciassimo a pensare il 3-D non come un effetto che
riempie lo spazio tra lo schermo e il pubblico, venendo
fuori, ma come una profondità acquisita tra lo schermo
e un visionario al di là. Cioè se abbandonassimo l’idea di
un quadro che ispira volumetria e ogni tanto si spinge in
fuori e accettassimo quella di una scatola ‘animata’. Comunque sia rimane il fatto che il 3-D sembra funzionare
solo per alcuni film (o generi) e non per altri, che non
avrebbero il minimo giovamento da questo meccanismo
(un film, per citare uno attuale, come A Serious Man
cosa se ne farebbe del 3-D?). Rimane, poi, il problema
dell’effetto di realtà. Se colore e sonoro aggiungevano
elementi al fine di riprodurre il reale, il 3-D fa la stessa
cosa? Soprattutto è l’effetto di realtà quello che vuole
97
ottenere? Se è così perché ricordiamo colori e voci, ma
non la tridimensionalità di un’immagine? O forse siamo
più propensi a ricordare la storia che un film ci racconta
più che la sua dimensione visiva? Il 3-D aggiunge un elemento che è costitutivo della realtà o rimane relegato
alla stregua di un ‘effetto’ e, come tale, è qualcosa di cui
si fruisce sul momento e che non è funzionale al motore
narrativo o al meccanismo della produzione del senso
o, ancora, alla identificazione proiettiva (che, comunque,
rimangono intatti che ci sia o non ci sia 3-D)?
Ritorniamo ora un po’ indietro: eravamo rimasti agli anni
80. Il decennio precedente è stato molto particolare per
il cinema in 3-D, tenuto in vita quasi esclusivamente dalle
produzioni indipendenti e pornografiche. Il successo di
massa di Gola profonda aveva scatenato le iniziative.
Nel 1972 uscì The Stewardesses che fece un discreto
incasso anche perché in piena crisi il film venne acquisito
dal circuito generale degli esercenti e non dai soli cinema
a luce rossa. Fu distribuito dalla Stereo Vision International che si lanciò successivamente in una
join venture con la
Sierra Pacific Airlines
e produsse altri due
film della serie delle
scatenate assistenti
di volo. Altre compagnie indipendenti, fra cui la Sherpix
che produsse Gola
profonda, in quel
periodo operarono
tangenzialmente al
circuito principale. In
alcune di queste produzioni di skinflick o
softcore si imbarcò,
per esempio, la ben più famosa American International
Picture (di Arkoff/Nicholson) che aveva già distribuito i
film di Roger Corman, i beach-party movies e i film
dei bikers degli anni 60. Ma probabilmente a causa della
scarsa qualità di questi prodotti la AIP rifiutò di firmare i
company credits. I film erano Prison Girls e A Man with
a Maid che era di origine svedese e venne rieditato nel
1977 con un nuovo titolo, The Groove Room. È molto
facile perdersi nei meandri produttivi di questi film dal
momento che le riedizioni erano molte e i titoli spesso
cambiavano; rischierei, quindi, di dare solo un elenco di
film poco costruttivo. Chiunque voglia può andarseli a
scovare nella rete: gli anni 70, in fondo, sono una miniera
infinita di film di questo genere. Però qualcuno andrebbe
98
nominato: per esempio uno dei cult di questo periodo
fu Flesh for Frankenstein, conosciuto anche come Andy
Warhol’s Frankenstein, del 1974, girato in Italia con una
coproduzione italiana (Carlo Ponti), francese, tedesca e
americana da Paul Morrissey (e Antonio Margheriti?), con Joe Dallesandro e, in una piccola parte, Dalila
Di Lazzaro. Il pretesto era sempre il solito: carne e sangue.
Negli stessi anni anche le pubblicazioni periodiche si dedicarono al 3-D, spesso portando la mania pruriginosa
fuori dalla nicchia del film porno. Il fumetto underground
Deep 3D Comix del gruppo Krupp Comix Works, per
esempio, includeva degli occhiali con lenti colorate rotonde e circondate da una miriade di bolle (to bubble
in inglese significa anche essere pieni d’emozione, specialmente eccitati). Le pubblicità di questi prodotti alludevano a certe pratiche: It’s a malicious lie that 3D glasses cause kids to go blind. Reaserchers at Parson’s College
(Parson è un sinonimo di sacerdote) found that less than
10% of children so observed went totally blind, and nearly
half suffered absolutely no eye damage at all! Nel luglio del
1975 la rivista satirica National Lampoon che aveva
una tiratura decisamente più ampia del fumetto underground, uscì fuori con un numero dal titolo ‘X-Rated 3D
Entertainment’ con una delle copertine più trash della
storia del 3D: Stevie Wonder che indossa un paio di
occhiali blu e rossi! Decisamente poco elegante… Era
accluso un paio di occhialini anche per l’acquirente che
si poteva godere immagini e fumetti come Dirty Duck
e Nuts, tutti rigorosamente stereo. Altre riviste come
American Cinematographer, Australian Playboy e Club
pubblicarono numeri simili. A cavallo fra 70 e 80 uno store a buon mercato come 7 Eleven distribuì una serie di
vedute e comodi viewers pieghevoli che potevano essere riutilizzati in altre occasioni. Infine McDonald s’inventò un 3-D Happy Meal i cui occhiali per bimbi avevano
la forma della classica M gialla del logo. Ma nessuna iniziativa per una produzione destinata alla massa fu presa
durante questo decennio, almeno per quanto riguarda il
cinema. La grande distribuzione venne coinvolta solo per
alcune riedizioni di classici horror degli anni 50: House
of Wax, Creature from the Black Lagoon, It Came
from Outer Space.
La cosa interessante di questo periodo fu soprattutto la
strategia di sfruttamento della produzione commerciale
mainstream da parte di questi film indipendenti al fine di
ottenere notorietà. In molti casi si trattava di vere e proprie parodie: nel caso della locandina di The Flesh and
Blood Show venne disegnato un volto di donna modellato su quello di Farrah Fawcett che era allora all’apice
della popolarità. Alcuni film classificati come X-rated ve-
nivano pubblicizzati come ‘stereovision 4D’: di fatto non
si trattava tanto di tecnologie - se non dal punto di vista
dei formati della pellicola che variavano – quanto di un
riferimento alla componente erotica. La quarta dimensione era quella del ‘sensual involvement’. Attualmente
il 4-D movie è un film tridimensionale che comprende
anche l’uso di physical effects come pioggia, vento, luci
stroboscopiche, vibrazioni ecc. che vengono usate, però,
solo per i parchi a tema. Non sono da confondere con
i motion simulator che, invece, sono specificatamente utilizzati per la simulazione di effetti e sensazioni prodotte
dal movimento di un veicolo o di un aereo. Questi ultimi,
applicati all’intrattenimento, hanno prodotto i simulator
rides ispirati ai film più popolari come Back to the Future: the Ride o The Simpsons Ride.
Nel caso del film APE, invece, la locandina diceva: ‘Not to
be confused with King Kong’ che doveva servire come una
specie di teaser. La presenza di uno squalo nelle grinfie
del bestione, poi, irritò la Universal perché appariva a
molti come una sorta di tie-in promozionale senza che,
in realtà, questo film avesse nulla a che fare con il film Lo
squalo (Jaws). La produzione di APE era quasi interamente sudcoreana e, in effetti, furono molte le occasioni
in cui piccole compagnie indipendenti italiane, tedesche,
cinesi e giapponesi (il caso di Domo Arigato, terzo film
3-D di Arch Oboler) stabilirono cooperazioni e accordi
internazionali. Le tecniche 3-D si prestavano nella resa
spettacolare dei film sulle arti marziali e quindi il cinema
di Hong Kong visse un momento di crescita. Solo tre di
questi film, però, raggiunsero un discreto successo fuori
da Hong Kong: 13 Nuns (conosciuto anche come Revenge of the Shogun Women o Revenge of the 13), Dinasty
e, infine, Magnificent Guardsman (o Magnificent Bodyguard) con la superstar cinese Jackie Chan.
Negli Stati Uniti uno dei contesti di applicazione maggiori del prodotto in 3-D erano i parchi a tema. Uno dei
film più impressionanti fu proprio pensato per il parco
acquatico di Marineland in Florida, ora soppiantato dal vicino Disney World a Orlando. Il film di 23 minuti si intitolava Sea Dream. Ma il 3-D rimaneva ancora una tecnica
presa molto poco sul serio, alla stregua di un passatempo
da ragazzini, sottoprodotto di generi di consumo, buono
per serate al drive-in. Per capire come veniva percepito
dalla gente potete vedere il trailer di Real Life, un film
della Paramount, girato, però, in versione piatta. Il film
era una parodia di un programma tv di successo della
PBS che documentava la vita quotidiana di una famiglia
della middle-class americana. Albert Brooks, comico di
origine ebraica, girò questo film nel 1979. Il trailer, che
prende in giro i film in 3D, lo potete vedere qui: http://
www.youtube.com/watch?v=HvZTqRKX0GA.
99
Parlando di collaborazioni e partnership tra produzioni
indipendenti forse non tutti sanno che la seconda grande
fase del 3-D, quella degli anni 80, poggia proprio su di
uno spaghetti western di Ferdinando Baldi che in Italia
non venne distribuito: Comin’ at ya! L’artefice di questo
film del 1981 fu Tony Anthony (Roger Pettito) che per
l’occasione mise insieme un cast di origini spagnole (Victoria Abril), italiane e tedesche; la location era Almeria
(la stessa di Un pugno di dollari di Sergio Leone) e
la postproduzione e il soundtrack vennero fatti a Roma;
una parte del risultato la potete vedere qui http://www.
youtube.com/watch?v=PNnbR6mbBOE. Nonostante i
problemi causati dalla scarsità degli occhiali forniti agli
esercenti il film fece incassi sbalorditivi in confronto al
denaro speso e il gruppo produttivo Lupo-AnthonyQuintano riuscì a realizzare anche una scopiazzatura in
3D di Indiana Jones, Treasure of the Four Crowns, con alla
regia sempre Ferdinando Baldi.
La penultima ondata di rilancio del 3-D iniziò da questa
base semi-italiana proprio nei due anni successivi con
film come Friday the 13th – Part III, Jaws 3-D e Amityville 3-D. Guarda caso sono tutti terzi episodi di film
che hanno ottenuto grandissimo successo; stessa cosa
accade oggi con i terzi episodi in 3-D di Toy Story o di
Ice Age. La serialità (o prototipicità) cominciò ad essere
davvero incalzante a Hollywood proprio negli anni 80
e fu scoperta la sua potenzialità di money-making. Non
era, quindi, strano che il valore aggiunto del 3-D potesse
funzionare da ulteriore appeal per migliorare il meccanismo di fidelizzazione rappresentato dal sequel: il secondo film lo si vede per il primo, il terzo per il 3-D.
Friday the 13th – Part III in Italia uscì con il titolo di
Weekend di terrore; riscosse molto successo soprattutto in patria dove uscì contemporaneamente in 800
sale il 13 agosto 1982. La Paramount prese accordi con
la Sirius II Corporation per creare molte unità di proiezione che furono affittate dagli esercenti; inoltre questa
compagnia produsse anche le lenti che permisero di creare i titoli di testa. Rispetto allo sviluppo della tecnica e
agli standard usuali di quell’epoca, i titoli di testa passarono alla storia. Per avere un’idea della loro capacità di
‘proiettarsi’ nello spazio degli spettatori potete vedere
qui http://www.youtube.com/watch?v=XVb4TxO500k.
Il successo arrivò nonostante la censura avesse proibito
ad una gran fetta del suo potenziale pubblico di entrare
in sala. Il film, infatti, era ‘X-rated’ perché in una sequenza
Jason taglia la testa di una vittima e scaglia l’occhio verso
il pubblico.
Jaws 3-D uscì nelle sale l’anno dopo, a luglio del 1983,
distribuito dalla Universal. Nello stesso anno la 20th C.
Fox era uscita con il terzo episodio di Star Wars (Il ritor100
no dello Jedi) che a maggio aveva fatto numerosi incassi
ma non era in 3-D. Jaws 3-D passò attraverso numerosi
problemi di realizzazione che si fecero sentire nella scarsa qualità delle scene tridimensionali, in particolare in
quella dell’attacco dello squalo nel tunnel sottomarino.
Durante la postproduzione la corrispondenza tra riprese realizzate da due diverse unità non fu possibile per cui
si rigirarono alcune scene con materiale in miniatura e
attrezzatura video. Il risultato fu, poi, trasferito su pellicola ma disallineamenti e confusione fra sfondo e primo
piano non contribuirono alla qualità; inoltre alcune scene
riprese ‘dal vivo’ e scartate dal primo Jaws vennero convertite per il 3-D. Il film, comunque, stava andando benissimo ma stranamente rimase nelle sale solo due delle
quattro settimane concordate. Il film successivo, sempre in 3-D, che sostituì Jaws fu Metalstorm: la tempesta d’acciaio, un film mediocre che scimmiottava Star
Wars, sempre distribuito da Universal ma realizzato da
una produzione indipendente. C’erano molte aspettative
su questo film dal momento che lo stesso autore aveva,
precedentemente, scritto Parasite (in Italia Mutanti)
con Demi Moore che in USA aveva avuto successo.
Ma Metalstorm, nonostante tutto il rumore, i trailer, la
pubblicità che se ne fece, andò molto male e la Universal
perse denaro; il 3-D cominciò a perdere colpi di nuovo.
Il terzo ed ultimo film di grandi incassi di questo periodo
fu Amityville 3-D, uscito a novembre 1983. Questa serie
era tratta dall’omonimo romanzo del 1977 di Jay Hanson,
presentato come un fatto paranormale veramente accaduto. Il primo film del 1979 - di cui nel 2005 è stato fatto
un remake - è di Stuart Rosenberg, regista della New
Hollywood abbastanza interessante; questo terzo sequel
in 3-D, invece, è diretto da Richard Fleischer (Viaggio allucinante, Tora! Tora! Tora!, 2022: i sopravvissuti) e prodotto da
Dino de Laurentiis. Il film non era stato presentato come
sequel dei due precedenti e il suo personaggio principale
era modellato su un certo Stephen Kaplan, investigatore del paranormale, realmente esistito, che cercò di dimostrare che la storia della famiglia Lutz da cui Hanson
trasse il romanzo non era altro che un inganno! C’erano
numerose inquadrature in-your-eyes nel tipico linguaggio
3-D ma niente di troppo esaltante.
In seguito, a parte le riedizioni dei classici dei 50 e i pochi casi - come Starchaser: The Legend of Orin che è
onestamente noiosissimo - nessun altro film veramente
interessante venne girato negli anni 80. Ma c’è una piccola eccezione, guarda caso per un parco a tema. Si tratta
di Captain EO, uno dei più costosi film realizzati in 3-D,
almeno in quel periodo. Michael Jackson è protagonista di questa favola scritta da George Lucas insieme a
Francis Ford Coppola e Lemorande. Il film è del 1985
ed era stato realizzato esclusivamente per EPCOT, uno
dei 4 parchi a tema del Walt Disney World Resort a Orlando, ispirato all’utopica città del futuro pianificata dallo
stesso Disney. Pare inoltre che la morte di Jackson abbia
spinto a rimettere in circolazione questo film a partire
dal febbraio 2010 proprio a Tomorrowland, EPCOT, appunto. Strano che non sia ancora diventato un caposaldo del trash: http://www.youtube.com/watch?v=H9KZWKKpxk.
C’è una curiosa convergenza di fattori che, per ogni decennio in cui il 3-D si affaccia sulla scena commerciale
del cinema, spinge verso una fisiologica caduta dell’interesse. La curva del successo e della moda è inesorabile e, se ci facciamo caso, ha sempre a che fare con un
capostipite particolarmente remunerativo e di grande
successo di pubblico. Negli anni 50, gli anni migliori sono
stati il 1952 e il 1953, stessa cosa si può dire per gli anni
80 (1982, 1983), quasi come se le linee dirigenziali degli
Studios decidessero, all’affacciarsi di una nuova decade,
di richiamare fuori dal cilindro qualche novità, avidi come
sono di questo bene che si rivela sempre preziosissimo
nell’intrattenimento. A ben guardare – altra cosa che si
ripresenta e che ho già accennato – almeno un film che,
per destino e per capacità collettive, è riuscito (doveva
riuscire) a fare da spartiacque e ‘prototipo’ per una nuova ondata c’è sempre stato: Bwana Devil di Oboler nel
1952, Comin’ at ya! o Friday the 13th nel 1982/83 (in
Italia Lo squalo). Segue, poi, una fase della durata di due
anni, più o meno, che poi fisiologicamente decade quasi a
suggerire che l’apice del successo può essere raggiunto
una sola volta e che tutto quello che accade dopo è il
solo effetto a strascico di un momento.
Poi - sarà per il carattere episodico della moda e del
comportamento del pubblico, sarà per la natura del cinema così soggetto al fenomeno del tempo e della caducità - tutto si spegne nel giro di pochi anni; almeno così
è stato fino al 900 perché, forse, una certa inversione
di tendenza si è verificata proprio in questi primi dieci
anni del 2000. Da questa nostra storia abbiamo potuto
notare che, il 3-D - almeno per il 900 - è stato sinonimo
di cinema sperimentale, di serie B, a volte sconfinando
nel trash, a volte nel più completo e autonomo orgoglio
d’avanguardia. Se ha incontrato le masse lo ha fatto solo
per pochi film che hanno coinvolto personalità più forti
o nei casi in cui la possibilità economica era talmente
ampia da assicurare un successo.
Questo meccanismo è cominciato a cambiare durante
gli anni 90; solo che non ce ne siamo accorti perché
tutto veniva preparato all’interno dell’ambito ristretto
delle produzioni destinate ai parchi a tema. Ed è infatti
da qui che proviene l’ultima fase del 3D: stiamo parlando dell’IMAX. L’IMAX è un formato della pellicola più
grande di quello usuale (70 mm) e richiede standard particolari di proiezione e uno schermo adeguato che, in
genere, si aggira sui 22 x 16 metri. Questo tipo di standard è stato presentato per la prima volta nel 1970 per
un Expo sulla tecnologia a Osaka, in Giappone. I costi di
manutenzione e della logistica nelle attrezzature e nello
sviluppo erano altissimi, quindi, inizialmente, i film presentati in questi circuiti erano diversi da quelli di puro
intrattenimento. In genere si trattava di film documentaristici, molto più corti, adatti all’ambito nel quale l’IMAX
si stava installando: istituti o centri scientifici. Più tardi,
negli anni 90, cominciò anche il coinvolgimento dell’industria dell’entertainment ma i film girati continuavano
ad essere destinati ai parchi a tema o ai musei, unici posti
dove era possibile trovare dei teatri IMAX.
Durante tutti gli anni 90 non ci sono stati film in 3D per
il circuito tradizionale mentre molti sono stati girati per
questo circuito (uno dei primi film di fiction IMAX in
3D fu Wings of Courage di Jean-Jacques Annaud del
1995, lungo 40 minuti e costato 20 milioni di $). Nelle
sale tradizionali, invece, i 90 sono stati, più che altro, gli
anni della CGI, utilizzata soprattutto per gli effetti spe101
ciali. Discorsi sulla virtualità e sul rapporto tra digitale/
analogico, irrealtà/realtà, nuove tecnologie, si sono moltiplicati fra studiosi e intellettuali mentre la tecnologia procedeva inesorabilmente sull’onda del gusto per l’effetto
speciale più mirabolante. Visto in quest’ottica, l’approdo
al 3-D nel 2000 non è altro che la logica conclusione
di progressi tecnologici raggiunti dal digitale nel decennio precedente e dall’incontro tra prodotti e tecniche
un tempo destinati a circuiti separati. Nel 2003 James
Cameron crea per il circuito IMAX un documentario,
Ghosts of the Abyss sui resti del Titanic, con una digital
camera da lui realizzata, la Fusion Camera System, per
realizzare film in 3-D. Con lo stesso sistema nel 2005
realizza anche Aliens of the Deep. Lo potete vedere qui:
http://www.youtube.com/watch?v=PsS5IzcNnL8. Cameron, con questi due documentari, si comporta come se
si preparasse a sondare le tecnologie da lui stesso ideate
e implementate con l’obiettivo di registrarne il grado di
preparazione, in vista dei nuovi progetti (Avatar, che
era nel cassetto da un po’ e il futuro Battle Angel, tratto
dal primo volume della serie manga, Battle Angel Alita,
creata da Yukito Kishiro).
Intanto comincia a delinearsi la possibilità di portare il
3-D fuori dal contesto IMAX. Infatti con la stessa digital
camera (Fusion Camera System) Robert Rodriguez
gira nel 2003 il terzo episodio di Spy Kids, Missione 3DGame Over, la serie infarcita di star ma per un pubblico
molto giovane, questa volta con Sylvester Stallone e
cameo di George Clooney. Il 3-D comincia ad uscire
dal limbo della produzione IMAX ed invadere il territorio tradizionale (pare anche che alcuni effetti 3D siano stati mantenuti nella versione DVD e che siano stati
venduti con la dotazione di un set di quattro occhialini).
In patria non riscuote successo come i primi due, in Italia passa piuttosto inosservato così nel 2005 Robert
Rodriguez ci riprova e dopo aver diretto l’apprezzato
Sin City realizza sempre con la famigerata camera digitale Le avventure di Sharkboy e Lavagirl in 3D: http://
www.youtube.com/watch?v=8nU62Y6C4zo. I critici, Rodriguez, proprio non riescono a inquadrarlo a causa di
risultati incostanti che spiazzano; ma Sharkboy e Lavagirl
in effetti non si può vedere: è noioso e sembra che tutta
la profusione di tecnologia sia scomparsa in un risultato
mediocre e definito anacronistico a causa del formato
anaglifico presente anche nella versione home video dotata dei famigerati occhialini blu e rossi.
In realtà non penso che sia totalmente esatto questo
nostro modo di pensare al 3-D come una peculiarità
del cinema su grande schermo. Ci sono molti fattori che
fanno pensare che, se le cose andranno per il verso giusto in termini economici, un giorno avremo anche canali
102
televisivi interamente dedicati a spettacoli in 3D (http://
www.imax.com/corporate/pressReleases/) o dispositivi
3-D per l’home video.
Esiste anche una storia della televisione in 3D ma sarebbe troppo lungo anche solo accennarla. Chi vuole può
partire dai tentativi fatti dalla 3D Video Corporation. Alcune iniziative furono prese dalla ABC per una puntata
di Mork and Mindy in 3-D (‘Gotta Run’ è il titolo) di
cui poi non si fece nulla, venne però girato uno spot della
Coca Cola per la NBC durante il Super Bowl e il Rose
Bowl Parade venne trasmesso in 3D sulla Fox.
A dire il vero se il 3-D si fermasse a questi due prodotti
non faremmo fatica a pensare di poterne fare volentieri
a meno; ma, fortunatamente, negli anni successivi sono
usciti risultati più apprezzabili: La leggenda di Beowulf
del 2007 ha forse segnato un altro capitolo dal punto
di vista delle produzioni in 3-D. Robert Zemeckis,
poi, molto astutamente, si appoggia alla tradizione culturale accademica scegliendo con Beowulf un antico
poema epico – a dir la verità considerato soporifero e
complesso - che nei paesi anglosassoni viene studiato
nelle facoltà umanistiche; il risultato finale è una girandola pop piena di citazioni e umorismo sboccato. Al
di là del contenuto, che qui non stiamo considerando,
il film è spesso ricordato per l’utilizzo di una tecnica
di manipolazione digitale dell’immagine che Zemeckis
aveva già utilizzato per Polar Express. Si tratta della performance capture che permette di registrare
le espressioni del volto e i movimenti dell’attore, per
formare un pattern digitale utile a creare un personaggio o più personaggi animati, sia in 2-D che in 3-D. Se
volete una versione della motion capture direttamente
da Homer Simpson potete vedere qui: http://wtso.net/
movie/351-1209_HOMR.html
Pare che Zemeckis sia completamente fiducioso delle
possibilità di questo sistema: permette, infatti, al regista
di affrancare la sua creatività dalla gabbia dell’unicità
dell’attore in carne ed ossa, da un lato rispetto alle sue
caratteristiche specifiche e la sua fisionomia, dall’altro
dai limiti dovuti alla variabilità delle singole performance. È particolare il caso di Beowulf, per esempio, dove
l’attore Ray Winstone interpreta sia Beowulf che il drago. Il drago ha, quindi, le fattezze di un drago ma la sua
fisicità è quella di un attore, una sorta di ‘clonazione
mutante’ come è stata definita. Non tutti gradiscono,
però, il risultato visivo.
Questo tipo di texture della parte visiva, secondo qualcuno, rende gli attori inespressivi e, in modo inquietante, simili a statue di cera sul punto di sciogliersi. In alcuni casi, invece, la riconoscibilità dell’attore al di sotto
delle sue ‘spoglie digitali’ può fungere da attrattiva; un
gioco che funziona ampiamente perché in pieno accordo con l’estetica e il look dell’immagine a cui attualmente siamo abituati. La performance capture - peraltro
proibitiva per produzioni a basso costo perché implica software e hardware complessi con programmatori molto competenti e qualificati - è stata utilizzata di
nuovo da Zemeckis per l’ultimo suo film tratto da un
racconto di Dickens, A Christmas Carol, ma anche da
Tim Burton per Alice in Wonderland, che dovrebbe uscire a breve. Se questo discorso esula, in parte,
da quello centrale sul 3-D, sarebbe stato sbagliato non
menzionarlo dal momento che si tratta di una tecnica
che viene, evidentemente, esaltata e ravvivata dall’uso
dell’immagine tridimensionale.
Ultimamente sono davvero aumentate le possibilità di
scelta sul 3-D: c’è stato l’horror di San Valentino di
sangue, il cinema d’avventura con quel film-giostra che è
Viaggio al centro della terra; ci sono stati, soprattutto,
apprezzabili prodotti per i più piccoli come Up (Pixar),
Mostri contro Alieni (DreamWorks), il delizioso Piovono polpette (Sony Pictures Animation) e il clamoroso
successo del terzo episodio di Ice Age, L’alba dei dinosauri (Blue Sky Studios); tutti hanno segnato un anno, il
2009, tra i più prolifici per l’animazione tanto da spingere
anche un gruppo spagnolo con sede a Madrid, Ilion Animation Studios, nel business dell’animazione in 3D con
Planet 51, ispirato alla fantascienza anni 50. Nell’ambito
del 3-D ci sono nuovi arrivi anche da Germania, Francia,
Australia, Gran Bretagna, perfino Sud Africa e India, oltre
che dall’Italia, con un noir diretto da Avallone, tratto da
Henry James.
Ciascuno giudicherà rispetto alle proprie preferenze e
gusti personali ma se dovessi eleggere il migliore direi
senz’altro Coraline di Henry Selick. La cosa incredibile di questo film è la sua realizzazione: è il primo film
d’animazione stop-motion in 3-D. Il film è tratto dall’omonima fiaba noir di Neil Gaiman in cui si racconta della
scoperta fatta da una bambina di un mondo parallelo
dove tutti hanno bottoni al posto degli occhi. In realtà
il film non contiene molti dei classici effettoni 3-D ma
sicuramente ne contiene il potere fantasmagorico d’immersione. Quello che si addice di più a questa tecnica:
permettere allo spettatore di entrare in un mondo, viverlo in prima persona, rompere la separazione tra l’oggetto e il punto di vista. Se il 3-D non si limiterà a fare
questo ma riuscirà anche a raccontare storie e dotarle
di senso forse qualcosa di veramente nuovo verrà.
103
nel lager mentre gli altri prigionieri corrono verso il forno crematorio, così nel film tv di Daniel Mann Playing
For Time (1981), tratto da una storia vera, un gruppo di
donne sopravvivono alla camera a gas suonando in una
piccola orchestra. Infine, Il Pianista (Roman Polanski,
2002), film Palma d’Oro a Cannes: le svastiche si chiudono a tenaglia sulla Polonia del giovane pianista Wladyslaw
(Adrien Brody) precipitandolo nella spirale di deportazioni, ghetti, morti e ordinari traditori.
Anche il cinema, come Adam, ha dovuto fare i conti con
il suo passato, insomma.
—recensioni
Adam Resurrected
P aul S chrader (USA, G ermania , I sraele ,
2010)
Quella tratta dal romanzo di Yoram Kaniuk (1968), non
è semplicemente una storia sull’Olocausto, bensì «la storia di un uomo che prima era un cane che incontra un cane
che prima era un ragazzo» come più volte ha suggerito
Paul Schrader. Un percorso di redenzione personale,
un racconto sul lascito delle generazioni passate e i sensi di colpa di un sopravvissuto nei confronti dei martiri
della follia umana e delle generazioni a venire.
L’inferno è prima di tutto personale e ripropone su larga
scala il paradigma di A Porte Chiuse (1944) che proiettano su Adam Stein (Jeff Goldblum) lo spettro del Garcin
sartriano, disertore per codardia. «L’inferno sono gli altri»,
che siano demoni in divisa da SS o non morti emaciati
che riaffiorano in sogno per ricordare costantemente il
peso di questa concessione, che siano altri prigionieri del
Negev o una seconda gioventù rabbiosa.
La psiche per Schrader è costruita su strati di sedimentazioni confusi e non sempre intelligibili, e passa necessariamente per il prisma dell’ego sessuale. Da questa instabilità latente il rapporto tra eros e thanatos trova vigore
fino a trasformarsi in un indissolubile connubio bestiale
in cui anche i gesti quotidiani vengono denaturalizzati
e rivestiti di una ferinità violenta. Una trasformazione
totale che ha fatto di Adam Stein, da clown ed artista di
varietà apprezzato, un cane in tutto e per tutto, da domatore a bestia domata. Così l’appagamento fisico per
Adam passa necessariamente per la forma canina a cui si
presta la l’infermiera Gina Grey (Ayelet Zurer), risarcimento postumo per lo stato annichilente cui fu piegato
in maniera coatta da un comandante nazista (Willem
Dafoe). Il momento del massimo godimento perde ogni
valenza positiva divenendo meccanico e performativo,
riaffiorando nel subconscio con le prestazioni di intrattenimento a cui era stato condannato nel lager.
La redenzione, insomma, passa per la sopraffazione di
sé e degli altri, riproponendo la logica che spinse alcuni
ebrei ad arruolarsi tra le file degli aguzzini divenendo
kapò. Non a caso è proprio la rinuncia al desiderio di
potenza a permettere ad Adam di riconciliarsi con il suo
passato attraverso la riabilitazione del fanciullo cresciuto
pensando di essere un cane e la riconquista di una dignità umana e del diritto alla vita per un’intera generazione. Non necessariamente per Adam, che come capofila
104
di questo esercito di diseredati, ha dell’Abramo biblico.
A lui viene indicata la terra promessa dopo l’esilio nel
Negev, ma come tutti i patriarchi biblici potrà soltanto
percorrere la strada verso la salvezza senza goderne in
prima persona.
Le concessioni di una sopravvivenza agognata sono un
avamposto psichiatrico nel bel mezzo del deserto ed infermieri ben disposti ad usare la forza, dall’altro una resistenza esistenziale nella Germania del muro che sembra
essere un residuo impolverato di quella di Weimar, una
monade tumorale. Non a caso l’ultimo stadio di prigionia
da cui Adam non riesce ad evadere è quello che lo incatena ai suoi ricordi, flashback di demoralizzazione fisica
e psicologica che affiorano dall’inconscio e si materializzano come piccoli tumori maligni o come nazisti dai rovi
nel deserto, quelli che nell’Antico Testamento erano la
voce di Dio.
Un clown, voce super partes per eccellenza, viene catapultato negli orrori della politica. E’ la trasformazione
del primo Charlie Chaplin, quello che ancora poteva
giocare innocentemente con il mappamondo ne Il Grande Dittatore (1940) nel clown di Böll (1963). Con le sue
paure, le sue opinioni, le sue riflessioni sull’importanza
dell’identità in un mondo borghese.
Seppur in ritardo sulla produzione culturale, il cinema si
è interessato al tema dell’Olocausto offrendo una lucida
analisi sotto differenti punti di vista. Anzi potremmo dire
che vista la successiva capacità produttiva di pellicole a
tema, lo scotto sia stato completamente pagato, trovando in questo riflettere anche un modo di esorcizzare lo
spettro del collaborazionismo che una certa intelligentia
prestò al regime. I rapporti tra gli orrori del nazismo e
il mondo dello spettacolo, in tutte le forme, da quelle
del mero servilismo, a quello della ribellione armata o
intellettuale, sono sicuramente l’aspetto che più dimostra di avere ancora da dire all’interno della produzione
cinematografica. Il risultato è una videoteca carica di impegno politico, satira e riflessioni al vetriolo imperniata
sulle relazioni tra artisti, imbonitori e regime.
Forse l’immagine più celebre è quella consegnata agli
spettatori dal Chaplin de Il Grande Dittatore (1940), la
danza con il mappamondo del malcapitato barbiere che
per un’infelice somiglianza si ritrova nei panni di Hitler. Il
film più dichiaratamente politico di Chaplin che tuttavia
dichiarò successivamente che se fosse stato a conoscenza degli orrori dei campi di sterminio non avrebbe mai
Luca Colnaghi
Il riccio
M ona A chache (F rancia , I talia , 2010)
trattato con leggerezza certi argomenti. Nel 1942 è il
turno di Ernst Lubitsch con Vogliamo vivere, opera
magistrale in cui il messaggio politico è affidato alla feroce satira di una compagnia teatrale polacca impegnata nell’Amleto, ovviamente riletto con chiari riferimenti
antinazisti. Esattamente trent’anni dopo Cabaret (1972)
di Bob Fosse con Liza Minnelli, musical premiato con
otto premi Oscar tra cui miglior regia, miglior attrice
protagonista, fotografia, montaggio e musica. Gli anni
della nascita del nazismo sono visti attraverso la vicenda di una spregiudicata cabarettista: un bagno musicale
alla Kurt Weill con svastiche, Lilì Marlene e fantasmi
di brechtiana memoria. Il dramma dell’Olocausto e del
suo rapporto con il mondo dello spettacolo fu analizzato anche da Francois Truffaut con il suo L’ultimo
metrò (1980), una delle pellicole più mature del maestro
francese. I temi trattati sono numerosi: l’occupazione
tedesca, i rapporti tra vita e palcoscenico in un’epoca
in cui ogni accezione pirandelliana per la relazione era
stata sostituita dall’imperativo alla sopravvivenza. La storia dell’impresaria Marion Steiner (Catherine Deneuve)
contesa tra l’attività teatrale, la compiacenza degli usurpatori e l’amore per il marito nascosto nello scantinato
ripropone i meccanismi di difesa contro l’oppressione e
l’oscurantismo portati in scena anche con Fahrenheit
451 (1966).
Come l’Adam di Paul Schrader costretto a suonare
Rue de Grenelle 7, in realtà quartiere latino, nel mondo
al vetriolo della Barbery è una ricca via borghese, sponsorizzata Chabrol come da brand nella libreria segreta di Renée. Qui, tra cariatidi con l’Alzheimer, clochard
ballerini, borghesi repubblichini, portinaie misantrope ed
erudite (Josiane Balasko) può persino arrivare un pensionato giapponese (Togo Igawa) che si costruisce una
pagoda dalle porte scorrevoli e dai sanitari che suonano
Mozart per coprire gli effetti nefandi della dieta al Wasabi. E come No. E si viene a scoprire che guarda caso il
nipponico anziano viene a vivere proprio nel condominio dove c’è una bambina di dodici anni (Garance Le
Guillermic) che tra le sue tante velleità parla giapponese manco fosse un agente della CIA sotto copertura,
e - Carramba che trasloco! - per pura combinazione anche
una portinaia che tra le sue tante passioni segrete coltiva
un amore per la cultura giapponese. Che fortunello. Ed
è chiaro che ci scappi l’insolito triangolo, la relazione in
cui molti hanno visto un richiamo di Harold e Maude
di Al Ashby (1971).
Insomma in definitiva, film e libro sono un po’ ruffiani,
e si possono concedere vezzi, luoghi comuni, filosofia
spicciola da Luciano De Crescenzo, psicanalisi di quel
caciarone naif che piace tanto alla setta Crepet e scivolate di dubbio gusto come quella del water che suona Mozart. Perché se lo fa Jerry Calà (ndr. Vado a Vivere
da solo di Marco Risi ,1982) si parla di trash, qui – nel
calderone di citazioni e rimandi - si parla di antropologia
alla Lèvi Strauss magari. Paradossalmente libro e film
nella loro rigidissima formalità sono persino postmoderni, se consideriamo la cosa sul campo letterario, sempre
che con postmoderno si intenda solamente un affastellarsi di citazioni che a volte diventano delle appendici(ti,
e come tali da levare anche a discapito del funzionamento complessivo). Puri ornamenti su cui costruire attorno
un’arzigogolata verbosità che rimane nel film conferendo
105
un andamento lento, su tempi (morti) letterari e aperture a stazioni obbligatorie, come se fosse una Via Crucis
costruita su due binari, le vite delle due protagoniste. Gli
altri sono solo satelliti che popolano l’universo indistinto del condominio, la regia non si preoccupa nemmeno
di introdurli o darci spiegazioni. Del resto i punti di vista
sono sempre e solo quelli delle due Cenerentole, portati
all’estremo con la soggettiva finale della portinaia e con i
primi piani della macchina da presa di Paloma.
Personalmente ho sempre odiato il 90% degli attori bambini: Shirley Temple, la piccola bambina rumena di Orphan (Jaume Collet-Serra, 2008), Michael Oliver in
La Piccola Peste (Problem Child, Dennis Dugan, 1990),
e mettiamoci dentro anche il napoletanissimo Adriano
Pantaleo (Gli intoccabili – Ci hai rotto papà, Castellano e Pipolo 1993). Caso a parte per Macaulay Culkin in Mamma ho perso l’aereo (Home Alone, Chris
Columbus, 1990). Della lista nera, tolto l’odio per il
peldicarota di Dugan che aveva una faccia da spaccare
a sprangate sugli incisivi, e Pantaleo che sembrava uno
scugnizzo con precoci problemi di tossicodipendenza, gli
altri soffrono di una forma affine a quella che è stata definita come sindrome di Dawson Leery. Adulti che giocano
a fare i bambini. L’esatto opposto dello stereotipo reso
immortale dalla spocchiosa «Sono il re della casa» (ndr.
Home Alone). Solo che se il Marzullo del Massachusetts
interpretato da James Van Der Beek e compagni se non
altro si ostinavano a recitare la parte di eterni teen, qui
abbiamo dei vecchi che si travestono da bambini per recitare la parte dei vecchi. Nel libro Paloma (Garance Le
Guillermic) è la figlia di una coppia borghese. Saputella e grafomane, se non altro si sforza di vivisezionare il
mondo alla ricerca della bellezza e del buono. Nel film
la bambina non scrive, se non sui muri, ma si dedica ad
un videoreportage che sa del peggior Erik Gandini alla
ricerca dello scabroso nel mondo borghese. Mettiamoci
che si veste come un mimo francese senza cerone, che
assomiglia a Wim Wenders e si esprime come il Marzullo dei tempi peggiori, e il cerchio si chiude. Forse lei il
buono non lo riesce proprio a vedere, del resto proprio
quando con la sua videocamera veste i panni dell’indagatrice morale, deve togliersi gli occhiali. Sarà che nelle
favole con piccoli principini l’essenziale è invisibile aglio
occhi e quindi tanto vale, però l’immagine anche con la
videocamera è sempre sgranata.
Ci dovrebbero essere una regola capitale nell’avvicinarsi
al cinema: mai andare a vedere la riduzione di un libro
che vi è piaciuto. Mai. Tanto più se si tratta di un film
francese. Dopo 600.000 copie vendute, la trasposizione
al cinema del romanzo era ovvia. La lettura de L’eleganza del Riccio, il comunque sopravvalutato bestseller di
106
Muriel Barbery,
aveva suscitato in
me le stesse sensazioni che mi dà
un libro di Fabio
Volo. All’inizio lo
evito come un monatto. Poi qualcosa
mi stuzzica, o forse semplicemente
sono
un’ottima
vittima da centro commerciale.
Cedo. Mi piace incredibilmente. Mi
rendo conto che è
nazionalpopolare e dal sentimento facile. Me ne vergogno, però mi piace. Col tempo lo trovo banale, però, mi
piace. Ma il film no, anche se ripensando all’ammiccante
trailer confezionato dai distributori italiani, forse sono
finito a vedere un film diverso.
Luca Colnaghi
La principessa e il ranocchio
R on C lements /J ohn M usker (USA, 2009)
In epoca di pieno New Deal Obamiano, la principessa è
una ragazza indigente di colore che ricorda la protagonista di Imitation Of Life (Lo specchio della vita, Douglas
Sirk, 1959). È il ritorno del vintage, l’impero sensoriale
del classico. Yes we can. Su note jazzate che flirtano con
il fusion partiture swing, le migliori coreografie che ricordano una pubblicità tipo di Carosello, il ritmo degli
affetti e della vita in cui ballano a tempo gli esponenti
della lowerclass e quelli viziati della upperclass. Giudici di
gare perfidi agenti immobiliari, post crisi, che sanno dove
speculare costruendo bolle ed incantesimi finanziari.Tiana e il ranocchio Naveen – principe diseredato e dissipatore che ricorda il modello nobiliare dell’odierna classe aristocratica e abbiente – raccolgono l’eredità della
tradizione iconografica classica disneyana, e già questa è
una notevole concessione per vivere di rendita. È come
quando non devi pensare al mutuo sulla casa.
Primo cartoon recente della casa madre ad aver ripristinato i fasti del disegno manuale concedendosi una
parentesi meravigliosamente bidimensionale dopo i già
mitologici UP (2009) e Wall-e (2008). Paradossalmente
caldeggiato dal genio fondatore della Pixar, John Lassenter, che evidentemente fa il suo tributo al maestro
Walt Disney, riconoscendone i meriti. La regia è affidata a Ron Clements e John Musker, padri di Aladin (1992) e La Sirenetta (1989), che ricompaiono così
come Bianca & Bernie (1977) come reminiscenze in
alcuni numeri musicali – si pensi a quello palustre che ricorda per modalità e tema la celebre direzione d’orchestra del granchio Sebastian - degni del miglior Vincent
Minnelli: coordinamento di forme, colori, sincronia tra
singolo e gruppo.Tutto il corredo di irresistibili e visionarie fantasie, coreografie pittoriche e proiezioni plastiche
di umanità tipo e sentimenti morali.
Più che una mossa riparatrice nostalgica, la potenzialità
de film sta nel climax attuale, proiettato sul presente, in
cui ogni inserto fiabesco più che ad un revival visionario
degli anni ’80 è costruito con la certezza che qualcosa –
se non nel mostro pensiero politico, almeno nel nostro
immaginario – con Barack Obama è davvero cambiato. Quindi nonostante non siano presenti continui riferimenti alla cultura cinematografica d’animazione e non,
resta difficile stabilire con certezza quale se il nuovo capitolo Disney risulti più adatto ad un pubblico di bambini,
estranei alle allusioni politiche, alle implicazioni culturali,
a anche alla complessità musicale di alcune partiture che
fuori sala vengono fischiate più da un pubblico adulto. Ad
esempio, il numero musicale de I miei amici nell’aldilà è
una vera chicca. Ma non per bambini. Nonostante l’alligatore Louis, evidente tributo al genio della tromba Louis Armstrong, sembri la versione squamata del mitico
urside Baloo de Il libro della Jungla (1967). Certo, poi
il caleidoscopico omaggio alla tradizione viene fatto con
gusto, intelligenza ed humor, qualità che non sono mai
mancate alle produzioni Disney.
Una New Orleans di fine ‘800 che scandisce la propria
esistenza su partiture jazz come risarcimento all’incubo
post Katrina e post Bush, il terrore dei Buffalo Soldiers
reloaded e le ombre voodoo nero petrolio della guerra
preventiva che si muovono minacciose sull’America. Ma
soprattutto l’agognata parità sociale e dei sessi, in cui la
protagonista ha un sogno in 3D: economico, di genere e
razziale, proiettato sempre in una dimensione del riscatto delle quote rosa che ad esempio le permettono di
sopportare la viziatissima e biondissima amica Charlotte,
probabilmente discendente di chi le catene ai suoi avi le
aveva messe davvero.Tiana ha da sempre il sogno di aprire un ristorante in cui servire la mitica zuppa del papà
morto in guerra. La banca dei bianchi brutti e cattivi le
chiede più soldi. Lei bacia un ranocchio, ma per lei la favola gira al contrario e più che nell’immaginario regno di
Maldonia si trova a regnare una palude dove tra bracconieri, spettri voodoo dell’uomo ombra (la versione cartoon di Samuel L. Jackson come hanno già notato in
molti) e adorabili vecchine cubane dalla pelle raggrinzita,
è sempre l’universo cosmopolita del mondo animale ad
esser protagonista. Residui faustiani ed elementi edipici
mescolati nel gran calderone in cui la metafora culinaria mo’ di Barilla alla fine fa la parte del leone. Alla fine
quindi c’è casa. L’utopia gastronomica è l’ovvia strada di
realizzazione per l’happy end, ricetta della felicità che la
casa madre Disney non può non servire a tavola, anche
quando – come ormai fa in ogni sua produzione – riflette sulle pagine obbligate e tristi della nostra vita, come la
morte. Ma lo fa sempre con un’infinita classe e una disarmante profondità che raramente nel cinema si riscontra.
La parentesi della lucciola innamorata di una stella riesce
a strappare una lacrimuccia anche ai più coriacei.
La principesse e il ranocchio ha la fascinazione dei giocattoli old style di Fao Schwarz e dei vecchi bottegai,
l’arma vincente contro l’ipertecnologia fumettistica di
Astro Boy (David Bowers, 2009) della Eagle, che manca completamente il bersaglio non riuscendo ad interessare né alle generazioni cresciute con il fumetto né alle
nuove leve per cui il personaggio è un perfetto estraneo.
E la sfida è anche vinta con il divertente e citazionistico
Piovono Polpette (Phil Lord, 2009) distribuito dalla
Sony. Il segreto? Un modo dove fantasia e vita vera, frustrazione e desiderio, superstizione e caparbietà coesistono. L’attuale vestito di vintage, senza ridicoli fardelli
gadgettistici e fantascientici. Per chi non vuole smettere
di sognare.
Luca Colnaghi
107
www.sentireascoltare.com