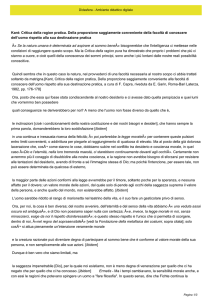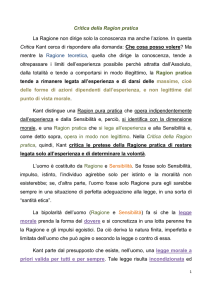Immanuel Kant
(1724-1804)
Critica della
ragion pratica
Storia della filosofia II
Il titolo
La ragione serve a dirigere non solo la conoscenza, ma
anche l'azione.
Accanto alla ragione teoretica abbiamo quindi una
ragione pratica.
Mentre nella Critica della Ragion pura Kant ha criticato le
pretese della ragione teoretica di trascendere
l'esperienza,
nella Critica della Ragion pratica, egli ha criticato invece le
pretese opposte della ragion pratica di restar legata
sempre e solo all'esperienza.
Kant distingue:
• ragion pura pratica
(che opera indipendentemente dall'esperienza e dalla sensibilità)
• ragione empirica pratica
(che opera sulla base dell'esperienza e della sensibilità).
La ragione pratica non ha bisogno di essere criticata nella
sua parte pura, perché in questa essa si comporta in
modo perfettamente legittimo, obbedendo ad una
legge universale.
Invece nella sua parte non pura, cioè legata all'esperienza,
la ragione pratica può darsi delle massime, cioè delle
forme di azione, dipendenti appunto dall'esperienza, e
perciò non legittime dal punto di vista morale. Perciò
deve essere sottoposta a critica.
Il fatto che la ragion pura pratica non debba venir
criticata, ma semplicemente illustrata nelle sue
strutture e funzioni, non significa tuttavia che essa
sia priva di limiti; infatti, come vedremo, la morale,
secondo Kant, risulta profondamente segnata dalla
finitudine dell'uomo e necessita di essere
salvaguardata dal fanatismo, ossia dalla presunzione
di identificarsi con l'attività di un essere infinito.
Il motivo che sta alla base della Critica della ragion pratica è
la persuasione che esista, scolpita nell'uomo, una legge
morale a priori valida per tutti e per sempre.
Infatti:
o la morale è una chimera, in quanto l'uomo agisce in virtù
delle sole inclinazioni naturali,
oppure, se esiste, risulta per forza incondizionata,
presupponendo una ragion pratica "pura", cioè capace di
svincolarsi dalle inclinazioni sensibili e di guidare la
condotta in modo stabile.
moralità =
incondizionatezza = libertà = universalità e necessità
La tesi dell'assolutezza o incondizionatezza della morale
implica due concetti di fondo strettamente legati tra loro:
la libertà dell'agire e la validità universale e necessaria della
legge.
Essendo incondizionata la morale implica la capacità umana
di autodeterminarsi al di là delle sollecitazioni istintuali,
facendo sì che la libertà si configuri come il primo
presupposto (postulato) della vita etica. Essendo
indipendente dagli impulsi del momento e da ogni
condizione particolare, la legge risulterà anche, per
definizione, universale e necessaria, ossia immutabilmente
uguale a se stessa in ogni tempo e luogo.
Per Kant la morale è ab-soluta, cioè sciolta dai condizionamenti
istintuali, non nel senso che possa prescinderne, ma perché è in
grado di de-condizionarsi rispetto a essi.
La morale si gioca infatti all'interno di una tensione bipolare tra
ragione e sensibilità.
Se l'uomo fosse esclusivamente sensibilità, ossia animalità e impulso,
è ovvio che essa non esisterebbe, perché l'individuo agirebbe
sempre per istinto.
Viceversa, se l'uomo fosse pura ragione, la morale perderebbe
ugualmente di senso, in quanto l'individuo sarebbe sempre in
quella che Kant chiama «santità» etica, ovvero in una situazione
di perfetta adeguazione alla legge.
Invece la bidimensionalità dell'essere umano fa sì che per Kant
l'agire morale prenda la forma severa del «dovere» e si concretizzi
in una lotta permanente tra la ragione e gli impulsi egoistici.
La categoricità dell’imperativo morale
Kant distingue i «principi pratici» che regolano la nostra volontà
in «massime» e «imperativi».
La massima è una prescrizione di valore puramente
soggettivo, cioè valida esclusivamente per l'individuo che la
fa propria.
L'imperativo è una prescrizione di valore oggettivo, ossia che
vale per chiunque.
Gli imperativi ipotetici prescrivono dei mezzi in vista di
determinati fini e hanno la forma del "se... devi" .
L'imperativo categorico, invece, ordina il dovere in modo
incondizionato, ossia a prescindere da qualsiasi scopo, e
ha la forma del "devi" puro e semplice.
Solo l'imperativo categorico, in quanto incondizionato,
ha i connotati della legge, ovvero di un comando che
vale in modo perentorio per tutte le persone e per
tutte le circostanze.
Solo l'imperativo categorico, che ordina un "devi"
assoluto, e quindi universale e necessario, ha in se
stesso i contrassegni della moralità.
Formalismo dell’imperativo categorico
L’imperativo categorico, in quanto incondizionato consiste
nell'elevare a legge l'esigenza stessa di una legge. E poiché
dire legge è dire universalità, esso si concretizza nella
prescrizione di agire secondo una massima che può valere
per tutti.
Da ciò la formula-base dell'imperativo categorico:
Agisci in modo che la massima della tua volontà possa sempre
valere nello stesso tempo come principio di una legislazione
universale.
(Critica della ragion pratica, A 54)
L'imperativo categorico è quel comando che prescrive di tener
sempre presenti gli altri e che ci ricorda che un comportamento
risulta morale solo se la sua massima appare universalizzabile.
La seconda formulazione
Nella Fondazione della metafisica dei costumi troviamo anche
una seconda e una terza formula.
La seconda afferma:
agisci in modo da trattare l'umanità, sia nella tua persona sia in
quella di ogni altro, sempre anche come fine e mai
semplicemente come mezzo.(Fondazione della metafisica dei costumi, BA 67)
In altri termini, rispetta la dignità umana che è in te e negli
altri, evitando di ridurre il prossimo o te medesimo a
semplice mezzo.
In questo contesto la parola "fine” fa sì che alla persona venga
riconosciuta la prerogativa di essere soggetto e non oggetto.
Tant'è vero che Kant sostiene che la morale istituisce un
«regno dei fini», ossia una comunità ideale di libere
persone, che vivono secondo le leggi della morale e si
riconoscono dignità a vicenda.
La terza formulazione
La terza formula prescrive di agire in modo tale che «la volontà, in
base alla massima, possa considerare contemporaneamente se
stessa come universalmente legislatrice» (Fondazione della metafisica dei costumi, BA 76)
Questa formulazione sottolinea l'autonomia della volontà,
chiarendo come il comando morale non sia un imperativo esterno
e schiavizzante, ma il frutto spontaneo della volontà razionale, la
quale, essendo legge a se medesima, fa sì che noi,
sottomettendoci a essa, non facciamo che obbedire a noi stessi.
Tant'è vero che nel "regno dei fini", precisa Kant, ognuno è
suddito e legislatore al tempo stesso.
In altre parole:
la volontà non è semplicemente sottoposta alla legge, ma lo è in
modo da dover essere considerata autolegislatrice, e solo a
questo patto sottostà alla legge.
La "formalità" della legge e il dovere
Caratteristica strutturale dell'etica kantiana è la formalità, in
quanto la legge non ci dice che cosa dobbiamo fare, ma
come dobbiamo fare ciò che facciamo.
Se non fosse formale, bensì "materiale", e prescrivesse quindi
dei contenuti concreti, sarebbe "vincolata" a essi, perdendo
inevitabilmente in termini di libertà da un lato e di
universalità dall'altro.
Questo significa che l'imperativo etico non può risiedere in una
casistica concreta di precetti, ma soltanto nella legge
formale-universale: quando agisci tieni presenti gli altri e
rispetta la dignità umana che è in te e nel prossimo.
Sta poi a ognuno di noi "tradurre" in concreto, nell'ambito
delle varie situazioni esistenziali la parola della legge.
Il carattere formale e incondizionato della legge morale fa tutt'uno
con il carattere antiutilitaristico dell'imperativo etico.
Infatti, se la legge ordinasse di agire in vista di un fine o di un utile,
si ridurrebbe a un insieme di imperativi ipotetici e
comprometterebbe la propria libertà, in quanto non sarebbe
più la volontà a dare la legge a se medesima, ma gli oggetti a
dare la legge alla volontà.
Noi non dobbiamo agire per la felicità, ma solo per il dovere:
Dovere! Nome sublime e grande, che non porti con te nulla di
piacevole che importi lusinga; ma esigi la sottomissione; che
tuttavia non minacci nulla [...] ma presenti semplicemente una
legge che penetra da sé sola nell'animo e si procura
venerazione.
Da ciò il cosiddetto "rigorismo" kantiano, che esclude dall'etica
emozioni e sentimenti, che sviano la morale, oppure, quando
collaborano con essa, ne inquinano la severa purezza.
Il dovere-per-il-dovere nel rispetto della legge: ecco l’unica
condizione affinché vi siano moralità e virtù e non si passi
dalla moralità alla semplice "legalità".
Non basta che un'azione sia fatta esteriormente secondo la
legge, ovvero in modo conforme a essa.
La morale implica una partecipazione interiore, altrimenti
rischia di scadere in atti di legalità ipocrita oppure in
forme più o meno mascherate di autocompiacimento.
Kant sostiene dunque che non è morale ciò che si fa, ma
l'intenzione con cui lo si fa (morale dell'intenzione),
essendo la «volontà buona», ovvero la convinta adesione
della volontà alla legge, l'unica cosa incondizionatamente
buona al mondo.
Il dovere e la volontà buona, secondo Kant, innalzano
l'uomo al di sopra del mondo sensibile (fenomenico), in
cui vige il meccanismo delle leggi naturali, e lo fanno
partecipare al mondo intelligibile (noumenico), in cui
vige la libertà.
La vita morale è la costituzione di una natura
sovrasensibile, nella quale la legislazione morale
prende il sopravvento sulla legislazione naturale.
Questa noumenicità del soggetto morale non significa
tuttavia l'eliminazione di ogni legame con il mondo
sensibile.
Difatti, proprio perché l'uomo partecipa
strutturalmente dei due mondi, egli non può
affermare quello intelligibile se non nel e in virtù di
quello sensibile.
Anzi, la noumenicità dell'uomo esiste solo in relazione
alla sua fenomenicità, in quanto il mondo
soprasensibile, per lui, esiste solo come forma del
mondo sensibile.
La rivoluzione copernicana morale
Il senso profondo dell'etica kantiana, e della sua sorta di
"rivoluzione copernicana morale", consiste infatti nell'aver
posto nell'uomo e nella sua ragione il fondamento dell'etica.
Se la libertà, presa in senso negativo, risiede nell'indipendenza
della volontà dalle inclinazioni, in senso positivo si identifica
con la sua capacità di autodeterminarsi, ossia nella
prerogativa autolegislatrice della volontà, la quale fa sì che
l'umanità sia norma a se stessa.
Di conseguenza, Kant polemizza aspramente contro tutte le morali
eteronome, cioè contro tutti quei sistemi che pongono il
fondamento del dovere in forze esterne all'uomo o alla sua
ragione, facendo scaturire la morale, anziché dalla pura "forma"
dell'imperativo categorico, da principi "materiali".
I postulati pratici e la fede morale
Nella Dialettica Kant prende in considerazione l'assoluto
morale o sommo bene cui tende irresistibilmente la
nostra natura.
La felicità non può mai erigersi a motivo del dovere, perché
in tal caso metterebbe in forse l'incondizionatezza della
legge etica.
La virtù, pur essendo il "bene supremo", non è ancora,
secondo Kant, il "sommo bene”, il quale consiste, invece,
nell'addizione di virtù e felicità.
C'è in noi il bisogno di pensare che l'uomo, pur agendo per
dovere, possa anche essere degno di felicità.
Ma in questo mondo virtù e felicità non sono mai
congiunte, poiché lo sforzo di essere virtuosi e la ricerca
della felicità sono due azioni distinte e per lo più opposte,
in quanto l'imperativo etico implica la sottomissione
delle tendenze e l'umiliazione dell'egoismo. Di
conseguenza, virtù e felicità costituiscono l'antinomia
etica per eccellenza.
Afferma Kant l'unico modo per uscire da tale antinomia
(che rischia di rendere impossibile il sommo bene e di
ridurre la morale che lo prescrive a un'impresa senza
senso) è di "postulare" un mondo dell'aldilà in cui possa
realizzarsi ciò che nell'aldiquà risulta impossibile:
l'equazione "virtù = felicità".
I postulati di Kant sono quelle proposizioni teoretiche non
dimostrabili che ineriscono alla legge morale come
condizione della sua stessa esistenza e pensabilità,
ovvero quelle esigenze interne della morale che
vengono ammesse per rendere possibile la realtà della
morale stessa, ma che di per se stesse non possono venir
dimostrate.
I postulati tipici di Kant sono l'immortalità dell'anima e
l'esistenza di Dio.
La realizzazione del sommo bene (santità) implica il postulato
dell'immortalità :
a) poiché solo la santità, cioè la conformità completa della
volontà alla legge, rende degni del sommo bene e
b) poiché la santità non è mai realizzabile nel nostro mondo,
c) si deve per forza ammettere che l'uomo, oltre il tempo
finito dell'esistenza, possa disporre, in un'altra zona del
reale, di un tempo infinito grazie a cui progredire all'infinito
verso la santità.
La felicità proporzionata alla virtù, comporta il postulato
dell'esistenza di Dio, ossia la credenza in una «volontà santa
ed onnipotente», che faccia corrispondere la felicità al merito.
Accanto ai due postulati "religiosi" dell'immortalità
dell'anima e dell'esistenza di Dio, Kant pone un altro
postulato che ci è ben noto: la libertà. Quest'ultima è
infatti la condizione stessa dell'etica, che nel momento
in cui prescrive il dovere, presuppone anche che si
possa agire o meno in conformità di esso e che quindi si
sia sostanzialmente liberi. «Devi, dunque puoi», afferma
Kant: se c'è la morale deve, per forza, esserci la libertà.
Mentre la libertà è la condizione stessa dell'etica
l'immortalità e Dio rappresentano soltanto delle
condizioni ipotetiche affinché la morale trovi, in un altro
mondo, quella realizzazione che in questo le è negata.
Kant sostiene che non sono le verità religiose a fondare
la morale, ma è la morale, sia pure sotto forma di
"postulati", a fondare le verità religiose.
Dio, per Kant, non sta all'inizio e alla base della vita
morale, ma eventualmente alla fine, come suo
possibile completamento.
L'uomo di Kant è colui che agisce seguendo solo il
dovere-per-il-dovere, con, in più, la «ragionevole
speranza» nell'immortalità dell'anima e nell'esistenza
di Dio.
Il male radicale nell'uomo
Nella natura dell'uomo, accanto a una propensione al bene
(testimoniata dalla presenza della legge morale), vi è
un'ineliminabile inclinazione al male: è quello che Kant
chiama il male radicale. Dire che nell'uomo vi è
un'inclinazione naturale al male non significa per Kant
presuppone una forza estranea alla volontà (che, in
quanto tale, non sarebbe imputabile all'uomo) né
identificare il male con l'istinto naturale (che non è
valutabile in termini morali).
Il male radicale è quella tendenza, dovuta alla finitezza e
alla fragilità dell'essere umano, ad adottare una massima
di comportamento contraria alla legge morale, pur
essendo consapevole di questa.
Come il male morale sia comparso per la prima volta è,
secondo Kant, incomprensibile per noi.
Altrettanto incomprensibile è allora come possa essere «che
un uomo naturalmente cattivo si renda da se stesso
buono». E tuttavia noi sappiamo che dobbiamo divenire
migliori, e quindi anche che possiamo farlo: e farlo da noi
stessi, sottolinea Kant, perché l'idea di un aiuto
sovrannaturale, come grazia, è «difficilmente compatibile
con la nostra ragione», oltre che pericolosa, in quanto può
ingenerare indolenza morale.
La vita dell'uomo si svolge allora in una lotta tra il principio
ideale della perfezione morale e l'inclinazione innata al
male
È necessario che venga istituita una «comunità etica»,
un'associazione di uomini sotto «le sole leggi della virtù»,
perché è proprio nella dimensione della socialità che il male si
esprime con maggior forza.
Questa comunità etica è una chiesa invisibile, retta da Dio, che
trova nei comandamenti divini l'espressione assoluta dei
propri doveri morali. La religione di questa chiesa è la
religione naturale, che consiste in una fede religiosa pura, una
«semplice fede della ragione».
La religione naturale è una sola, in quanto «concetto pratico
della ragione», anche se si esprime poi, per il bisogno
dell'uomo di cercare sempre appoggio e conferma nella
realtà, nelle diverse confessioni religiose che «il caso ha fatto
capitare sotto mano». È dunque un elemento storico,
puramente accidentale, che differenzia e contrappone le
diverse religioni.
Quando la vita religiosa "empirica" si allontana dalla fede
razionale pura si determinano degenerazioni: il feticismo e la
superstizione di chi crede che la buona condotta consista nelle
pratiche di culto; il fanatismo di chi si illude di poter entrare in
rapporto diretto con Dio.