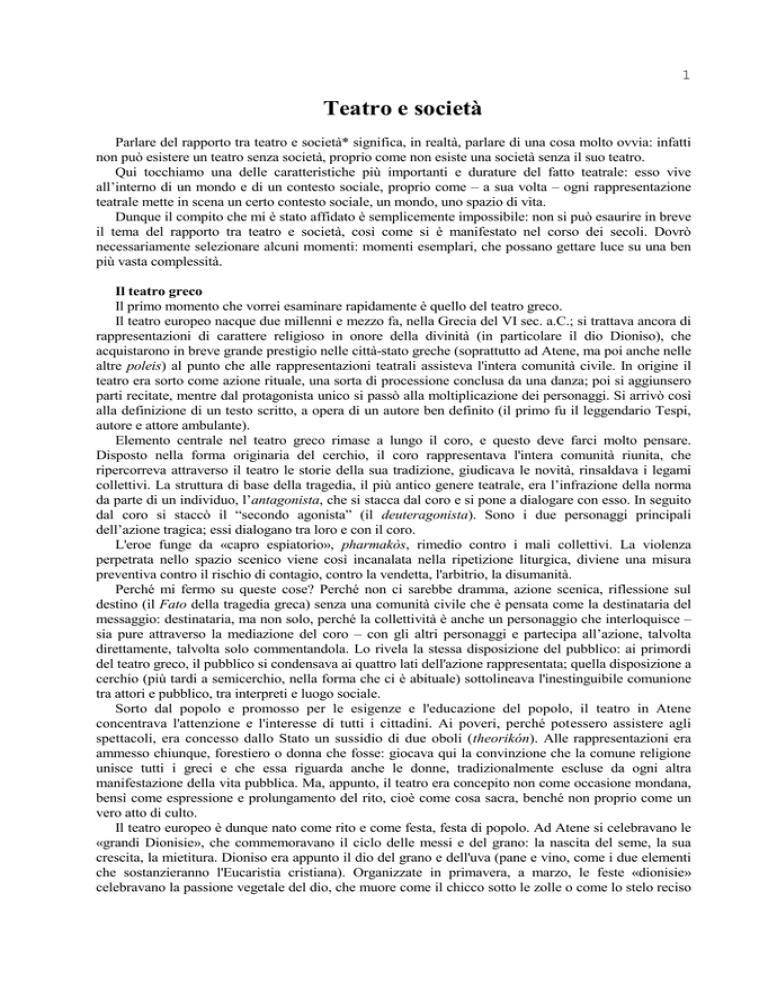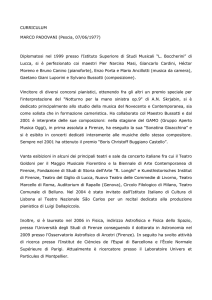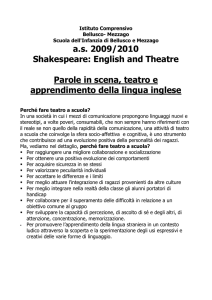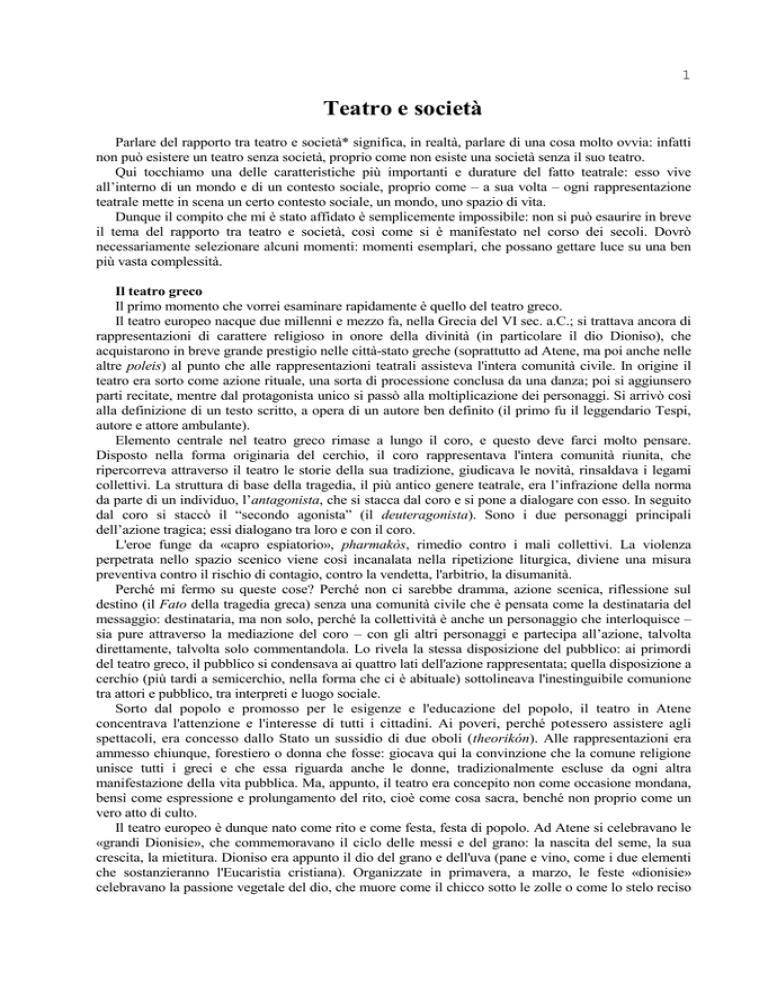
1
Teatro e società
Parlare del rapporto tra teatro e società* significa, in realtà, parlare di una cosa molto ovvia: infatti
non può esistere un teatro senza società, proprio come non esiste una società senza il suo teatro.
Qui tocchiamo una delle caratteristiche più importanti e durature del fatto teatrale: esso vive
all’interno di un mondo e di un contesto sociale, proprio come – a sua volta – ogni rappresentazione
teatrale mette in scena un certo contesto sociale, un mondo, uno spazio di vita.
Dunque il compito che mi è stato affidato è semplicemente impossibile: non si può esaurire in breve
il tema del rapporto tra teatro e società, così come si è manifestato nel corso dei secoli. Dovrò
necessariamente selezionare alcuni momenti: momenti esemplari, che possano gettare luce su una ben
più vasta complessità.
Il teatro greco
Il primo momento che vorrei esaminare rapidamente è quello del teatro greco.
Il teatro europeo nacque due millenni e mezzo fa, nella Grecia del VI sec. a.C.; si trattava ancora di
rappresentazioni di carattere religioso in onore della divinità (in particolare il dio Dioniso), che
acquistarono in breve grande prestigio nelle città-stato greche (soprattutto ad Atene, ma poi anche nelle
altre poleis) al punto che alle rappresentazioni teatrali assisteva l'intera comunità civile. In origine il
teatro era sorto come azione rituale, una sorta di processione conclusa da una danza; poi si aggiunsero
parti recitate, mentre dal protagonista unico si passò alla moltiplicazione dei personaggi. Si arrivò così
alla definizione di un testo scritto, a opera di un autore ben definito (il primo fu il leggendario Tespi,
autore e attore ambulante).
Elemento centrale nel teatro greco rimase a lungo il coro, e questo deve farci molto pensare.
Disposto nella forma originaria del cerchio, il coro rappresentava l'intera comunità riunita, che
ripercorreva attraverso il teatro le storie della sua tradizione, giudicava le novità, rinsaldava i legami
collettivi. La struttura di base della tragedia, il più antico genere teatrale, era l’infrazione della norma
da parte di un individuo, l’antagonista, che si stacca dal coro e si pone a dialogare con esso. In seguito
dal coro si staccò il “secondo agonista” (il deuteragonista). Sono i due personaggi principali
dell’azione tragica; essi dialogano tra loro e con il coro.
L'eroe funge da «capro espiatorio», pharmakòs, rimedio contro i mali collettivi. La violenza
perpetrata nello spazio scenico viene così incanalata nella ripetizione liturgica, diviene una misura
preventiva contro il rischio di contagio, contro la vendetta, l'arbitrio, la disumanità.
Perché mi fermo su queste cose? Perché non ci sarebbe dramma, azione scenica, riflessione sul
destino (il Fato della tragedia greca) senza una comunità civile che è pensata come la destinataria del
messaggio: destinataria, ma non solo, perché la collettività è anche un personaggio che interloquisce –
sia pure attraverso la mediazione del coro – con gli altri personaggi e partecipa all’azione, talvolta
direttamente, talvolta solo commentandola. Lo rivela la stessa disposizione del pubblico: ai primordi
del teatro greco, il pubblico si condensava ai quattro lati dell'azione rappresentata; quella disposizione a
cerchio (più tardi a semicerchio, nella forma che ci è abituale) sottolineava l'inestinguibile comunione
tra attori e pubblico, tra interpreti e luogo sociale.
Sorto dal popolo e promosso per le esigenze e l'educazione del popolo, il teatro in Atene
concentrava l'attenzione e l'interesse di tutti i cittadini. Ai poveri, perché potessero assistere agli
spettacoli, era concesso dallo Stato un sussidio di due oboli (theorikón). Alle rappresentazioni era
ammesso chiunque, forestiero o donna che fosse: giocava qui la convinzione che la comune religione
unisce tutti i greci e che essa riguarda anche le donne, tradizionalmente escluse da ogni altra
manifestazione della vita pubblica. Ma, appunto, il teatro era concepito non come occasione mondana,
bensì come espressione e prolungamento del rito, cioè come cosa sacra, benché non proprio come un
vero atto di culto.
Il teatro europeo è dunque nato come rito e come festa, festa di popolo. Ad Atene si celebravano le
«grandi Dionisie», che commemoravano il ciclo delle messi e del grano: la nascita del seme, la sua
crescita, la mietitura. Dioniso era appunto il dio del grano e dell'uva (pane e vino, come i due elementi
che sostanzieranno l'Eucaristia cristiana). Organizzate in primavera, a marzo, le feste «dionisie»
celebravano la passione vegetale del dio, che muore come il chicco sotto le zolle o come lo stelo reciso
2
dalla falce: ma muore per mutarsi in farina e pane fragrante. Ebbene, queste celebrazioni rituali
venivano solennizzate proprio attraverso il teatro. Gli spettacoli avevano luogo nel grande teatro
cittadino appoggiato sul bordo del colle dell'Acropoli; iniziavano nel pomeriggio e si protraevano a
lungo, in un'atmosfera di straordinaria suggestione emotiva. Il sole annegava nel mare, mentre le ombre
del tramonto fasciavano la grande folla cosmopolita convenuta da tutta l'Attica e l'Eubea: il coro
compiva le sue solenni evoluzioni cantando ritmicamente i versi della tragedia, mentre a poco a poco si
isolavano i protagonisti dell'azione, agghindati con costumi multicolori, con la grande maschera tragica
sul volto sormontata da turbanti e pennacchi.
Certo l'effetto d'insieme, mentre il sole lentamente scompariva nella sera tra i bianchi marmi dei
templi, doveva essere indimenticabile. Il pubblico, composto in gran maggioranza da illetterati
contadini e mercanti, era capace di rimanere estasiato per ore e ore a contemplare lo spettacolo di quei
giganti variopinti, rialzati dai sandali e dalle maschere fino a due metri e mezzo d'altezza, che
danzavano con agilità sulle nenie della musica e del coro, declamando le mirabili imprese degli dèi e
degli eroi del mito collettivo.
Non dovremmo mai dimenticarci di quest’anima collettiva, festiva e liturgica insieme del teatro.
Altrimenti rischiamo di ridurre le nostre rappresentazioni a eventi intellettualistici, slegati dalla vita di
una comunità – che è il pubblico, ma che è anche il nostro gruppo di attori. Il teatro viene a incarnare i
conflitti e le speranze, la legge e la colpa, a sublimare in simbolo e gesto ciò che una comunità vive nel
suo profondo. Dev’essere così, altrimenti non è più teatro, diviene letteratura, esibizione o altro ancora.
Mentre, in quest’ottica, il coinvolgimento del pubblico non è più solo un espediente per prendere più
applausi, ma deve divenire un ingrediente necessario del nostro fare teatro. Senza di esso, il teatro non
è pienamente tale.
Il teatro elisabettiano
Un secondo momento davvero interessante per sondare il rapporto tra teatro e società è quello del
teatro di Shakespeare, il teatro elisabettiano.
«Età elisabettiana» è il lungo periodo di regno della regina Elisabetta I Tudor (1558-1603): un regno
che inaugurò un periodo di relativa tranquillità interna, dopo il truculento passaggio della Guerra delle
due rose, con le sue rovine economiche e sociali. Fu appunto in questo periodo che il teatro inglese
conobbe la sua massima fioritura, associata al nome glorioso di William Shakespeare (1564-1616).
«Preparate le vs. orecchie e le vs. lacrime, perché niente di così tragico vi ho presentato finora!».
Così gridava al suo pubblico il drammaturgo Mashe. Avventure, storie spaventose, oscuri complotti e
crudeli punizioni, dolori ed emozioni a non finire: quello elisabettiano era un teatro a tinte forti, un
teatro popolare, diremmo oggi. Infatti il pubblico andava agli spettacoli come a una gran cagnara, si
azzuffava, fumava e beveva a volontà, sbraitava all'indirizzo di attori ed autori; ma era poi capace di
seguire con grande attenzione le evoluzioni psicologiche dei personaggi, le immagini dei versi, la
poesia dei sentimenti e degli affetti.
Era per questo pubblico che scrivevano gli autori. All'inizio i testi erano confezionati con rapidità e
senza pretese artistiche, simili, in ciò, ai semplici testi della sacra rappresentazione medioevale. I
copioni, anzi, non venivano neppure stampati, per evitare che fossero utilizzati dalle compagnie rivali;
gli autori li vendevano all'impresario senza firmarli, per sei sterline o poco più; costui poi lo
rimaneggiava a suo piacimento. Perciò i moderni editori faticano tanto a ricostruire l'esatto testo dei
lavori shakespeariani; l'Amleto e il Romeo and Julieth, per esempio, ci sono noti in ben tre differenti
versioni.
Poi però le cose cambiarono. Il teatro divenne una cosa molto seria; un pubblico sempre crescente
chiedeva novità e creatività, e gli autori presero coscienza del loro ruolo accresciuto. Così, all'inizio del
'600, una smisurata produzione teatrale fiorì a Londra e dintorni (tra il 1580 e il 1640 c'è rimasta traccia
di circa duemila testi nuovi). Se fino ad allora il teatro inglese era stato una rozza imitazione degli
autori classici e degli italiani, da quel momento i drammaturghi presero a scrivere con grande libertà e
fantasia. Si sottrassero alle regole di Aristotele e recuperarono la struttura del teatro religioso
medioevale, che si svolgeva per quadri successivi.
Tutti i generi del teatro elisabettiano, dalle tragedie ai drammi allegorici, dalle commedie
buffonesche ai drammi storici, mostrano questi tratti comuni: rifiuto delle regole aristoteliche; fusione
di generi diversi; alternanza continua tra tragico e comico; teatralità immediata e indipendente da
3
qualunque schema, capace di creare con le sole parole sfondi, atmosfere, scenari, costumi, surrogando
così la povertà degli allestimenti.
Credo che ci siano diverse cose che si possono sottolineare in una situazione del genere e
attualizzare per noi. In primo luogo, il fatto che il teatro non è prima di tutto letteratura e che il copione
è solo uno degli ingredienti e certo non il più importante. Poiché il teatro elisabettiano era soprattutto
un grande divertimento popolare, gli autori poco badavano alle convenzioni e regole della letteratura
teatrale “alta”, quella che era stata codificata dai trattatisti del Rinascimento con le regole delle tre
unità. Abbandonando l’imitazione dei classici e degli italiani, i drammaturghi elisabettiani
recuperano semmai al loro teatro la struttura della successione per quadri, che era stata tipica della
sacra rappresentazione medioevale; essa venne riproposta perché consentiva agli autori grande
libertà fantastica.
I loro testi creavano da sé sfondi, atmosfere, scenari, costumi, ecc., surrogando in tal modo la
povertà degli allestimenti. Sul fondo del palcoscenico elisabettiano mancava un qualunque fondale
dipinto, a suggerire il luogo della vicenda; le rappresentazioni, tranne quelle a corte, si svolgevano di
giorno e perciò torce e candele rischiavano di essere quasi inutili: stava insomma all’autore evocare,
con il linguaggio, l’ambientazione, gli sfondi, l’illusione desiderata. In questo senso i critici hanno
parlato di «scenografia verbale». Di essa Shakespeare è l’interprete sommo, come avviene per esempio
in questo passaggio dell’Amleto: «Ma guardate: il Mattino avvolto in un manto rossastro/ avanza sulla
rugiada di quell’alto colle a oriente» (I, 1). All’inizio di una scena, di regola, i personaggi dicevano
dove si trovavano e alla fine dove stavano andando (così in Riccardo III: «Benvenuto, dolce principe, a
Londra vostra dimora» - a.III, 1)
Anche questo, credo, può insegnarci qualcosa. La scenografia a teatro è utile, forse necessaria,
ma non è indispensabile. Si può fare teatro anche con mezzi scenici poverissimi, o quasi inesistenti –
basta dare ali alla fantasia del pubblico, che però va sollecitata in modo coerente, rigoroso e
possibilmente poetico, come faceva Shakespeare.
Infine è sbagliato dire che quando il teatro è davvero popolare, allora il livello dei testi si abbassi.
Nell’età elisabettiana è accaduto semmai il contrario: la popolarità del teatro ha sollecitato la
creatività di alcuni grandi poeti del teatro, Shakespeare ma anche Christopher Marlowe o Ben
Johnson. Lo stesso vale per la Grecia antica, che nell’arco di pochi decenni del V secolo a.C. ci ha
lasciato una straordinaria concentrazione di capolavori. Le epoche in cui il teatro è stato un fatto
intimamente vissuto dalla società e in grado di parlare a ogni strato sociale, sono anche le epoche in
cui sono nati i maggiori autori. Il che potrebbe forse aiutarci a capire la latitanza dei grandi autori
oggi.
La riforma di Goldoni
Il terzo momento su cui vorrei soffermarmi è il Settecento, con la riforma di Goldoni (1707-1793).
Per coglierne la reale portata dobbiamo ragionare su quanto era accaduto nei due secoli prima di lui.
Il teatro, soprattutto in Italia, aveva conosciuto una sostanziale divaricazione: vi era un tipo di teatro
letterario, colto, allestito per un pubblico di intellettuali e cortigiani nelle accademie, nelle università o
nelle corti; era il teatro che continuava a coltivare i generi classici della tragedia e della commedia, per
un gusto di differenziazione sociale: la cultura come uno strumento di separatezza. C’era poi un altro
tipo di teatro, profondamente diverso, il teatro popolare della commedia dell’arte, destinato quasi
soltanto ai pubblici delle piazze e delle cascine. In mezzo, tra queste due forme così differenti, vi era un
genere, il melodramma, per il quale anche Goldoni si spese come scrittore di libretti: l’unico genere che
all’epoca era in grado di attirare un pubblico misto, di aristocratici e di borghesi (non però di popolani).
Nei teatri dove l’opera veniva allestita, vigeva comunque una nettissima separazione tra il pubblico dei
palchi e quello, assai meno aristocratico, della platea.
Torniamo alla commedia dell’arte. La sua stessa esistenza, in un contesto sociale ed economico di
povertà e di strettezza, culturale ed economica, vale a dimostrare che il teatro è un bisogno
insopprimibile della vita umana e che si può ben spendere qualche soldo, anche quando i soldi
mancano, per godere un momento di relax, se non di godimento dell’anima. Dunque in un tempo di
teatro letterario, che tendeva a isolarsi e a autoperpetuarsi nell’imitazione dei classici, il popolo
chiedeva un divertimento più semplice e immediato. Per il popolo era nato così, tra Cinque e Seicento,
la commedia delle maschere o commedia dell'arte. Era recitata da attori professionisti, che cioè
4
vivevano della loro «arte» (nel senso di “lavoro, artigianato”) e che se la tramandavano di padre in
figlio. Le compagnie dei comici si spostavano di piazza in piazza, di fiera in fiera, ed ebbero grande
fortuna in Italia e poi in tutta Europa.
I comici dell'arte recitavano senza un testo scritto: seguivano la rudimentale traccia dei canovacci o
scenari, allestiti da qualche autore improvvisato su un intreccio convenzionale. Servi astuti che rubano
e che bastonano i loro padroni; vecchi famelici che inseguono a vista la bella servetta e finiscono a
testa in giù nel barile colmo d'acqua; giovani che si sposano per amore, mandando a monte gli
interessati raggiri di avidi genitori; contadini inermi che sventano le smargiassate dei capitani di
ventura: era quanto chiedeva il pubblico delle cascine e delle piazze, che sognava, immedesimandosi
nelle figure di Arlecchino o Brighella, un'immaginaria rivincita sulle prepotenze dei violenti e sui
soprusi dei ricchi. Il divertimento popolare allude sempre, o quasi sempre, al rovesciamento, che è
l’anima di quella festa così intimamente connessa al teatro che è il carnevale, con le sue maschere.
Gli attori dell’arte improvvisavano, sfruttando le proprie capacità di mimi, acrobati, cantori;
ciascuno di loro era specializzato su una maschera particolare, molte delle quali erano nate su base
regionale, nell’Italia politicamente divisa di quei tempi. C'erano i servi o zanni: Arlecchino bergamasco
«vegnù de campo» o Pulcinella napoletano, e il più astuto Brighella; c'erano mercanti (il veneziano
Pantalone), dottori (il bolognese Balanzone), capitani sbruffoni (Spavento, Smargiassa, il napoletano
Coviello, lo spagnolo Matamoros), serve svelte (Colombina milanese, Ricciolina), innamorati di buona
famiglia e dai nomi presi dalla commedia letteraria (Leandro, Rosaura, Lelio, Flaminio, Isabella, ecc.).
Questa era la situazione quando Goldoni si mise d’impegno nel «riformare» la commedia, che fu la
missione cui votò l’intera propria carriera, con i suoi alti e i suoi bassi.
Goldoni vive nel tempo dell'illuminismo: i «lumi» della ragione consigliavano anche al teatro una
maggiore aderenza alla realtà nei soggetti, nel linguaggio, nei personaggi. Nasce da qui il bisogno di
una «riforma», che correggesse le buffonerie e le convenzionalità nelle quali era ormai scaduta la
commedia dell'arte. Le gags si ripetevano meccanicamente, la libertà (concessa dall’assenza del
copione scritto battuta per battuta) era del tutto teorica; i personaggi erano diventati maschere fisse e
prevedibili.
Fu appunto Goldoni a interpretare le nuove esigenze della società borghese settecentesca, il suo
desiderio di un divertimento «medio», ispirato cioè alla verità della vita quotidiana. Probabilmente fu
decisivo il suo essere cittadino di Venezia, cioè la città più teatrale del mondo di allora. Dalla piazza
veneziana partivano e si fermavano a lungo le compagnie di comici e cantanti per le altre città
d'Italia e le corti di tutta Europa; gli itinerari delle tournées partivano da Venezia e andavano da
Vienna a Praga a Dresda, e di qui a Varsavia, Mosca e Pietroburgo. Per questo Venezia contava su
un numero di teatri superiore a ogni altra città europea: sette teatri pubblici, sette sale a gestione
privata e in concorrenza tra loro. In esse si svolgeva la stagione teatrale veneziana, da ottobre a
carnevale. Il «mercato» teatrale dava luogo a una forte rivalità tra compagnie, attori e «poeti»,
com'erano chiamati i drammaturghi, ciascuno strettamente vincolato da un contratto a una specifica
compagnia. In questo clima, il consenso del pubblico pagante, sempre numerosissimo, era
essenziale; la valutazione delle opere e degli allestimenti era ormai svincolata dal giudizio dei
letterati. Questa dimensione pubblica del teatro, caratteristica di Venezia, solo sul finire del
Settecento s'imporrà in tutta Europa.
Ebbene Goldoni, che era un uomo di teatro e anche di mondo, aveva ben presente l’esigenza di non
alienarsi questo pubblico. Egli lottò anzitutto per restituire alle diverse «maschere» della commedia
dell'arte (Pantalone, Arlecchino, Brighella, ecc.) una precisa identità da personaggio: un servo ragiona
e si muove da servo, il padrone da padrone, il soldato da soldato, e così via. Questa fu la sua prima e
fondamentale novità. In secondo luogo circoscrisse la vicenda in un tempo e luogo ben precisi:
Venezia, il tempo di carnevale, l'ambiente mercantile e cittadino divennero la cornice inconfondibile
delle sue commedie. Nel teatro di Goldoni si afferma cioè una cornice di realismo, in dose superiore a
quella di qualsiasi altro drammaturgo del presente e del passato. Il realismo dei personaggi e il realismo
delle persone, del resto, erano ingredienti necessari perché il pubblico dei veneziani potesse
riconoscersi nel teatro e quindi apprezzarlo intimamente: finito il tempo del mito greco, finita la
scenografia fantasiosa del teatro shakespeariano, nel nuovo mondo dominato dalla logica degli affari è
soltanto in una solida cornice realistica che può attecchire davvero l’idea di un teatro come specchio
(ma specchio critico) dei costumi contemporanei. Infine, le commedie riformate di Goldoni celebrano
5
gli ideali della migliore società del suo tempo, quella borghese: in primo luogo la virtù del «buon
senso», che è la capacità di sapersi imporre al capriccio del caso attraverso doti di «garbo», di misura
negli affetti, di equilibrio personale. Sono le virtù laiche promosse dall’illuminismo, che non guardano
più a un orizzonte trascendente, ma soltanto a un piano umano e terreno.
Il risultato della riforma goldoniana fu che essa, nata nel teatro e non nelle accademie, restituì alla
«commedia» una dignità letteraria prossima a quella del teatro colto, il teatro che era sopravvissuto
solo nelle corti e nelle accademie. Goldoni rifiutò infatti i rozzi scenari o canovacci dei comici dell'arte
e prese a scrivere per intero i suoi lavori, battuta per battuta.
Un altro risultato della riforma fu che nelle maggiori commedie di Goldoni (La bottega del caffè, La
locandiera, I rusteghi, La trilogia della villeggiatura, Le baruffe chiozzotte) si assiste a quella fusione
di comico e di drammatico che interessava parallelamente, nel Settecento, gran parte del teatro
europeo. È un punto importante. Da molti secoli, ormai, il teatro europeo non era più espressione di ciò
che è festivo, rituale, comunitario; esso rappresentava piuttosto un'idea privata, individualistica borghese, appunto - dell'esistere. Attenzione però: il fatto che l’attenzione si concentri sull’individuo,
non impedisce al teatro di conservare una funzione sociale. Cade la dimensione della collettività, nel
senso che il teatro coglie la diversità degli individui, delle persone, una differente dall’altra, tutte
potenzialmente fonte di conflitto interiore e di dramma: ebbene, la funzione sociale del teatro moderno
diviene precisamente questa, rappresentare le interiori contraddizioni dell’io, farle emergere, mostrare
la distruttività degli eccessi, ma anche le potenzialità delle risorse.
Si diffuse così in tutta Europa – il suo teorico fu uno dei filosofi dell’illuminismo, Diderot – il
nuovo genere che sarà chiamato dramma borghese, che mirava a una maggiore aderenza alla vita e che
cercava forme di recitazione e di scenografia più vicine al vero. Esso assorbì le opposte tendenze di
commedia e tragedia, offrendo al vasto pubblico «medio» delle città personaggi e vicende comuni in
cui riconoscersi, per divertirsi riflettendo su di sé e sugli altri.
Il teatro del romanticismo
All’inizio dell’Ottocento la riscoperta della vita quotidiana si combinò con la sottolineatura di ciò
che è sentimento, interiorità, individualità: e nacque allora il teatro romantico. Un preannuncio venne
dall'avanguardia tedesca dello Sturm un Drang («Tempesta e assalto», nel senso di «Bufera di
sentimenti»). Fu un movimento di violenta ribellione contro la tradizione letteraria e il primato
culturale francese. In nome del sentimento e del «genio» individuale, alcuni drammaturghi come Kleist,
Schiller, Goethe rivoluzionarono le scene. Il capolavoro di questo teatro è il dramma-poema di Goethe
Faust, che esprime la tensione verso il «lontano» e l'«oltre», e la nostalgia di chi sa che non potrà mai
raggiungere un simile traguardo.
Quello romantico può sembrare teatro d’élite, per la sua forte componente letteraria, ma non è
affatto così. Non dobbiamo dimenticare che l’inizio dell’Ottocento è il momento dell’Europa della
restaurazione: dopo l’incendio della rivoluzione francese e la ventata di Napoleone, ora i regni si
prendono la rivincita sugli impulsi di libertà e «restaurano» il precedente ordinamento, l’«antico
regime», fondato sul privilegio sociale dell’aristocrazia e sul potere assoluto dei re. Ebbene, in questa
situazione l’arte, la letteratura e il teatro diventano degli strumenti in un certo senso rivoluzionari per
diffondere le nuove idee. I drammaturghi si fanno interpreti dei nuovi bisogni di libertà politica e di
libertà dalle regole e costrizioni del teatro classico tradizionale. Cade il vecchio genere della tragedia e
si afferma il nuovo genere del dramma storico romantico. Opere come il Gugliemo Tell di Schiller
(1804), come il Boris Gudunov (1825) di Puskin o il Cromwell (1827) di Hugo incendiano i
palcoscenici e calamitano l’attenzione del grande publico. In un’epoca in cui mancano i mezzi di
comunicazione di massa, a cui siamo abituati noi, proprio il teatro (e anche il teatro musicale: basti
pensare all’azione poderosa in favore del Risorgimento esercitata qui in Italia dai melodrammi di
Verdi) costituisce un efficacissimo mass medium in grado di raggiungere le masse, quantomeno il
pubblico borghese delle città, ormai pronto a intervenire direttamente nella storia, come dimostra la
«rivoluzione europea» del 1848.
In questo contesto, non dobbiamo dimenticare la figura e l’opera di Goethe: non solo perché il suo
Faust divenne veramente un grande poema drammatico capace d’interpretare l’anima della nazione
tedesca (una nazione ancora politicamente divisa, come lo erano gli italiani); ma anche perché, nella
sua qualità di direttore del teatro di Weimar (incarico che Goethe tenne per molti anni) egli contribuì
6
realmente a fare del teatro una presenza socialmente rilevante. Goethe curava personalmente la scelta
di autori e attori, la scenografia, la recitazione. Fondandosi sulle idee illuministiche di Lessing, riteneva
che il teatro fosse continua sperimentazione e stimolo di educazione e riflessione per la società.
L'Ottocento è anche il tempo in cui si afferma il fenomeno del divismo dell’attore: il pubblico delle
città comincia a recarsi al teatro per ammirare il proprio attore preferito, che condensa su di sé gran
parte del senso complessivo dell'allestimento. Nacque a metà dell’Ottocento la figura del «grande
interprete», colui che aderisce perfettamente al proprio personaggio (un personaggio di statura eroica,
secondo la misura dei romantici): ama e soffre con lui, sovrapponendosi a lui per forza di intima
sensibilità. Alcuni celebri «mattatori» sono rimasti famosi: il francese Talma, l'inglese Kean, gli italiani
Alamanno Morelli, Gustavo Modena, Tommaso Salvini.
L’età del naturalismo
Pian piano si affermò nel corso del secolo un'esigenza di realismo, che diverrà dominante nel
secondo Ottocento. In stretto rapporto con i romanzieri del naturalismo (come Zola e Verga) nacque a
Parigi il Théâtre Libre (Teatro libero) di André Antoine (inaugurato nel 1887).
Esso si proponeva di svecchiare il repertorio e le forme della recitazione, superando il
protagonismo artificioso dei grandi mattatori e portando sulla scena la vita reale: la recitazione
avrebbe dovuto imitare i comportamenti quotidiani, le suppellettili di scena dovevano essere quelle
reali. Una volta, dovendo rappresentare l'interno di una macelleria, Antoine portò in scena un
autentico bue squartato. Occorreva inscenare insomma una tranche de vie, un "pezzo di vita". Agli
attori era richiesto non tanto di «entrare nella pelle di un ruolo, ma di adattare piuttosto il ruolo a se
stessi», recitando «come a casa, ignorando le emozioni suscitate nel pubblico» (Jean Jullien); l'arco di
proscenio, si diceva, dovrebbe essere una specie di «quarta parete, trasparente per il pubblico, e opaca
per l'attore».
Il secondo Ottocento è l’epoca in cui trionfa il dramma borghese, appunto ispirato alla
rappresentazione della realtà contemporanea. I suoi massimi autori furono gli scandinavi Henrik
Ibsen (1828-1906) e August Strindberg (1849-1912) e il russo Anton Cechov (1860-1904). In realtà
il dramma borghese, specie nell’interpretazione di Ibsen e Strindberg, non è affatto un contenitore
neutrale o pacifico. Esso fa spazio a violenti contrasti psicologici, concentrati di preferenza sui temi
della crisi della famiglia. Anche in Italia il tema dell'adulterio viene trattato da alcuni drammaturghi
come Giuseppe Giacosa (Tristi amori, 1887), Marco Praga (La moglie ideale, 1890), Roberto
Bracco (Infedele, 1894).
A questo punto è necessaria un’importante sottolineatura. Parlando del teatro naturalistico di fine
Ottocento stiamo implicitamente descrivendo quel tipo di teatro «borghese» che costituisce l’ultima
forma di teatro realmente sociale. Dico sociale e non popolare perché si tratta in ogni caso di un
teatro rivolto ancora a un’élite, pur se si tratta dell’elite borghese e non più di un’élite aristocratica;
ma resta appunto un’élite, che non supera il 10-15% della popolazione. Il restante 85-90% è
composto da popolani allo stato puro: contadini, braccianti agricoli, proletariato e sottoproletariato
urbano, operai, tutte classi impossibilitate a recarsi nei teatri cittadini e ad assistere ai loro
spettacoli. Invece, per quell’élite sociale di cui parlavamo, il teatro è effettivamente una cosa
importante: corrisponde a un mezzo potente di diffusione e di discussione delle idee, come per
esempio la nuova idea «femminista», divulgata nel 1879 da quel rivoluzionario dramma che fu Casa
di bambola di Ibsen.
Aggiungo che il teatro è per l’ultima volta una cosa importante, mezzo di diffusione e di
discussione delle idee. Sul finire dell’Ottocento stanno infatti per affermarsi in misura definitiva i
nuovi mezzi di comunicazione di massa: dai giornali da un penny, com’erano chiamati, alla portata
cioè di tutte le tasche, al cinema (la prima proiezione dei fratelli Lumière risale al 1895), cui
seguiranno l’editoria popolare con il «romanzo d’appendice», poi la radio, infine la televisione. Ma
non si tratta semplicemente di sviluppo tecnologico. Sta cambiando il modo di elaborare e
trasmettere le idee. Se, un tempo, a guidare l’opinione pubblica erano stati i filosofi, i poeti, gli
scrittori (e per loro il teatro costituiva un prolungamento naturale della penna), adesso a guidare
l’opinione pubblica sono altri protagonisti, altre «agenzie», come diciamo oggi: sindacati, partiti di
massa, leaders politici che per la prima volta possono indirizzare i loro discorsi anche a masse non
presenti fisicamente davanti a loro.
7
La rivoluzione del Novecento
In una situazione simile è logico che la portata, l’incidenza sociale del teatro fatalmente
diminuisca. Soprattutto perché il «teatro» continua a essere identificato nel corso del Novecento con
la forma «borghese» che il naturalismo di fine Ottocento aveva portato ai massimi fastigi. Una forma
fatta di:
- realismo scenico;
- prestigio del testo drammatico;
- bravura degli interpreti;
- netta separazione tra platea e palcoscenico.
Questa è rimasta ed è tuttora, per noi, la forma «normale» del teatro. Ma precisamente contro
questi aspetti si batteranno, nell’arco di tutto il Novecento, le cosiddette «avanguardie» o teatro «di
ricerca». Esso mette in discussione uno dopo l’altro tutti questi requisiti:
- allo spettacolo borghese inteso come evasione, vuole sostituire un tipo di teatro come shock e
provocazione;
- al realismo scenico, l’uso alternativo di una scenografia essenziale, talvolta inesistente;
- al peso prevalente del singolo attore, cerca di sostituire il primato collettivo del gruppo degli
interpreti;
- al prestigio del testo drammatico, l’ipotesi di un teatro privo di testo scritto o il cui testo si
scrive insieme da parte di regista e attori;
- alla netta distinzione tra platea e palcoscenico, infine, il teatro d’avanguardia novecentesco
cerca di sostituire forme diverse di architettura teatrale, che recuperino l’antica disposizione a
cerchio del pubblico, nello sforzo di renderlo partecipe del dramma com’era anticamente il pubblico
greco.
Sono gli elementi che nel corso del Novecento hanno modificato profondamente i modi e gli scopi
del fare teatro. Dico «hanno modificato» pensando all’élite, non al pubblico medio, che invece ha
continuato a identificare il teatro con quegli elementi (realismo scenico, prestigio del testo ecc.) che ho
prima enunciato. Ma appunto, a livello di élite culturale, si è imposto un teatro diverso dal prodottomerce: se quest'ultimo deve piacere al pubblico e quindi deve divertire a ogni costo, il «teatro di
ricerca» novecentesco ha proposto un nuovo tipo di spettacolo, in cui ciò che conta è «liberarsi» di ogni
regola o aspettativa. Si cerca intenzionalmente di scandalizzare il pubblico: esso deve assistere non a
una finzione, ma a un evento reale, irripetibile, attraverso il quale deve prendere maggiore coscienza di
sé (Brecht). Il luogo stesso del teatro si sposta dalla sala appositamente allestita, con la sua gerarchia di
posti e funzioni, a un «ovunque» indifferenziato: nel '900 si fa teatro per le strade, nelle palestre, negli
scantinati, dove capita.
In questo passaggio, il ruolo dell'attore si è enormemente accresciuto: le nuove teorie, da
Stanislavskij ad Artaud a Grotowski, fanno proprio dell'attore il centro di ogni attenzione, nel senso che
egli deve 'vivere' il proprio personaggio aldilà di ogni finzione. Alle parole si associa dunque la
mimica; i valori letterari del dialogo sono surrogati da quelli corporei della mimica, della gestualità,
che traduce – come in un rito di nuovo tipo – l'assoluta serietà del teatro. L’importanza sempre minore
attribuita al testo scritto è documentata dal teatro dell'assurdo di Beckett e Ionesco, fatto di dialoghi
senza senso, di segni sconclusionati, di suoni inutili.
In realtà il teatro di ricerca novecentesco non è stato mai un teatro popolare o almeno un teatro
sociale, in grado di avere un forte impatto sulla società. Ma in fondo la diminuzione di «socialità»
caratterizza anche il tanto, tantissimo teatro che si è continuato a produrre e a rappresentare nelle
grandi sale per il grande pubblico – teatro di stampo tradizionale, o se vogliamo commerciale, e che dal
1960-70 in avanti ha inesorabilmente dovuto registrare una forte diminuzione in termini quantitativi,
dal punto di vista del «peso» economico e del numero degli spettatori.
La fruizione sociale del teatro, oggi, assomiglia sempre di più alla fruizione di una piccola,
piccolissima minoranza. Difficile poter calcolare l’incidenza di essa rispetto al cammino della cultura o
della società. In se stesso il teatro è, oggi, cosa per pochi, ma attenzione: non dobbiamo dimenticare
che il teatro rimane straordinariamente presente nella vita sociale sotto altre forme, ben diverse dal
palcoscenico «borghese» di fine ‘800 di cui abbiamo parlato. Difficile negare che la televisione, il
cinema, le forme di spettacolo di massa come i grandi concerti non posseggano un’anima teatrale e non
8
ricorrano a codici teatrali di messa in scena. Il teatro insomma si perpetua anche sotto forme diverse da
quelle in cui lo conosciamo noi. E sopravvive soprattutto come bisogno di una comunicazione tra le
persone che sia diretta, vera, cioè non mediata dal medium televisivo o multimediale: una
comunicazione che non ricorra a simulacri, a fantasmi, ma a individui in carne e ossa. È la funzione che
il teatro svolge ancora nelle parrocchie e in altri ambienti amatoriali: dove in fondo si possono
recuperare quei valori antichi e modernissimi che il teatro possiede da sempre, e che la comunicazione
multimediale può forse mettere in un angolo, ma non soffocare.
Come ha dichiarato di recente il grande regista russo Lev Dodin: «il teatro vive, [...] non può
sparire. Perché fa provare al pubblico le emozioni vere, le più pure, che possono colpirlo. Le emozioni
che gli mancano nella vita quotidiana. [...] Nella nostra esistenza siamo già abituati a nascondere le
emozioni, a tenerle dentro. E il teatro invece le fa uscire permettendoci di vivere il dolore, la gioia, la
compassione: tutto ciò che ci fa uomini. Il teatro ci fa sentire – anche se solo per qualche attimo –
migliori, ci fa crescere umanamente. Questa è la qualità del teatro. Una qualità inesauribile e per questo
il teatro stesso non finirà mai.» (Io e Strehler, fratelli di teatro in giro per il mondo, in «Corriere della
sera/Eventi», 8-9-2003, p. 1).
Paolo Di Sacco
*relazione tenuta al Convegno del G.A.T.a.L. «Tavernola 2003 – Teatro e società» il giorno 12
settembre 2003