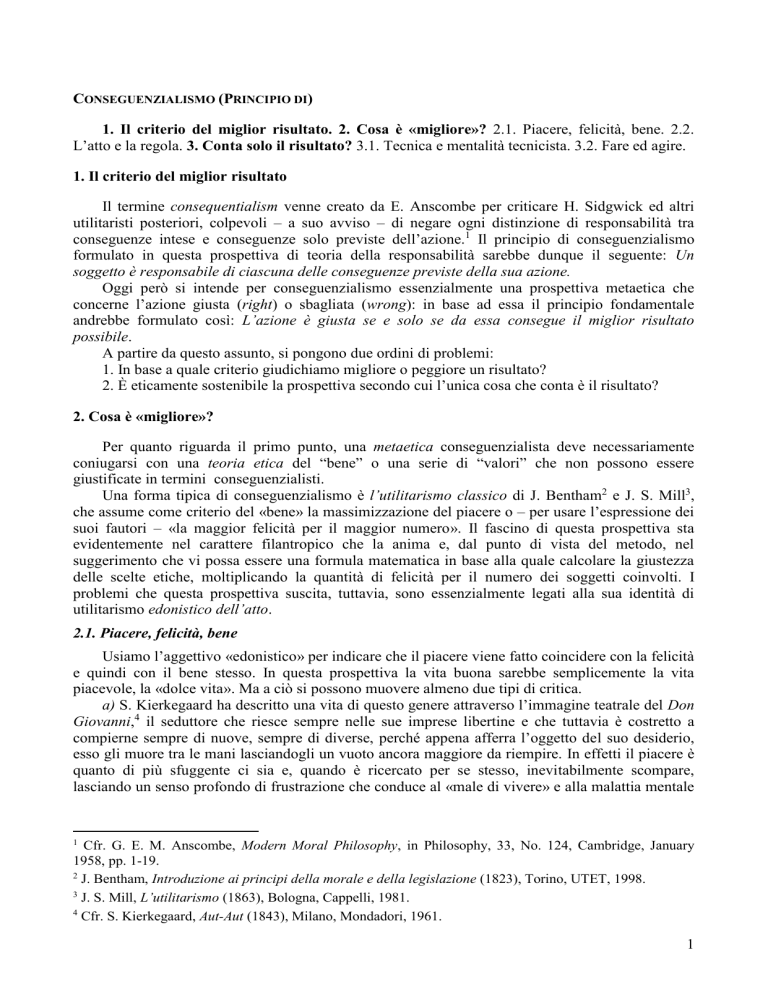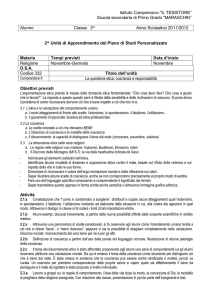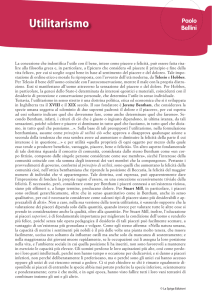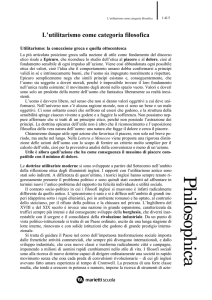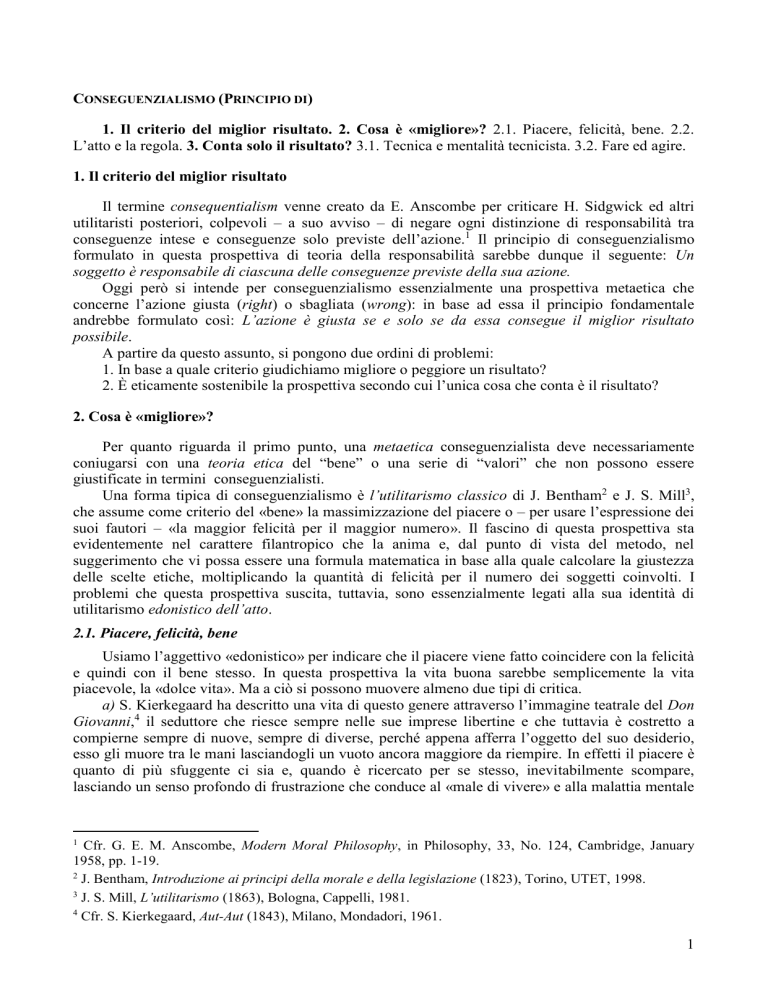
CONSEGUENZIALISMO (PRINCIPIO DI)
1. Il criterio del miglior risultato. 2. Cosa è «migliore»? 2.1. Piacere, felicità, bene. 2.2.
L’atto e la regola. 3. Conta solo il risultato? 3.1. Tecnica e mentalità tecnicista. 3.2. Fare ed agire.
1. Il criterio del miglior risultato
Il termine consequentialism venne creato da E. Anscombe per criticare H. Sidgwick ed altri
utilitaristi posteriori, colpevoli – a suo avviso – di negare ogni distinzione di responsabilità tra
conseguenze intese e conseguenze solo previste dell’azione.1 Il principio di conseguenzialismo
formulato in questa prospettiva di teoria della responsabilità sarebbe dunque il seguente: Un
soggetto è responsabile di ciascuna delle conseguenze previste della sua azione.
Oggi però si intende per conseguenzialismo essenzialmente una prospettiva metaetica che
concerne l’azione giusta (right) o sbagliata (wrong): in base ad essa il principio fondamentale
andrebbe formulato così: L’azione è giusta se e solo se da essa consegue il miglior risultato
possibile.
A partire da questo assunto, si pongono due ordini di problemi:
1. In base a quale criterio giudichiamo migliore o peggiore un risultato?
2. È eticamente sostenibile la prospettiva secondo cui l’unica cosa che conta è il risultato?
2. Cosa è «migliore»?
Per quanto riguarda il primo punto, una metaetica conseguenzialista deve necessariamente
coniugarsi con una teoria etica del “bene” o una serie di “valori” che non possono essere
giustificate in termini conseguenzialisti.
Una forma tipica di conseguenzialismo è l’utilitarismo classico di J. Bentham2 e J. S. Mill3,
che assume come criterio del «bene» la massimizzazione del piacere o – per usare l’espressione dei
suoi fautori – «la maggior felicità per il maggior numero». Il fascino di questa prospettiva sta
evidentemente nel carattere filantropico che la anima e, dal punto di vista del metodo, nel
suggerimento che vi possa essere una formula matematica in base alla quale calcolare la giustezza
delle scelte etiche, moltiplicando la quantità di felicità per il numero dei soggetti coinvolti. I
problemi che questa prospettiva suscita, tuttavia, sono essenzialmente legati alla sua identità di
utilitarismo edonistico dell’atto.
2.1. Piacere, felicità, bene
Usiamo l’aggettivo «edonistico» per indicare che il piacere viene fatto coincidere con la felicità
e quindi con il bene stesso. In questa prospettiva la vita buona sarebbe semplicemente la vita
piacevole, la «dolce vita». Ma a ciò si possono muovere almeno due tipi di critica.
a) S. Kierkegaard ha descritto una vita di questo genere attraverso l’immagine teatrale del Don
Giovanni,4 il seduttore che riesce sempre nelle sue imprese libertine e che tuttavia è costretto a
compierne sempre di nuove, sempre di diverse, perché appena afferra l’oggetto del suo desiderio,
esso gli muore tra le mani lasciandogli un vuoto ancora maggiore da riempire. In effetti il piacere è
quanto di più sfuggente ci sia e, quando è ricercato per se stesso, inevitabilmente scompare,
lasciando un senso profondo di frustrazione che conduce al «male di vivere» e alla malattia mentale
1
Cfr. G. E. M. Anscombe, Modern Moral Philosophy, in Philosophy, 33, No. 124, Cambridge, January
1958, pp. 1-19.
2
J. Bentham, Introduzione ai principi della morale e della legislazione (1823), Torino, UTET, 1998.
3
J. S. Mill, L’utilitarismo (1863), Bologna, Cappelli, 1981.
4
Cfr. S. Kierkegaard, Aut-Aut (1843), Milano, Mondadori, 1961.
1
– come dimostra anche la psicologia clinica.5 D’altra parte, come è noto, la tecnologia ha oggi reso
possibili le «esperienze virtuali» in cui il soggetto è collegato ad una certa macchina che è capace di
stimolarlo in modo da trasmettergli tutte le sensazioni che egli desidera, in assenza della realtà che
normalmente gliele procura. Immaginiamo che qualcuno ci proponga di trascorrere tutta la nostra
esistenza in una «realtà virtuale» sommamente piacevole:6 molto difficilmente troveremo qualcuno
disposto ad accettare questo tipo di «felicità».
b) Inoltre, l’affermazione che il bene consista nel piacere appare quanto meno discutibile. Vi
sono piaceri che ragionevolmente vengono recepiti come eticamente ripugnanti, come ad esempio
quello dello stupratore o del sadico. E inoltre vi sono dei beni che vengono valutati moralmente
come tali e non sono affatto connessi con il piacere, come tutti quelli relativi agli ambiti
dell’abnegazione e del dono di sé.
Una correzione al modello edonista dell’utilitarismo classico consiste nel sostituire al criterio
del piacere il criterio della «preferenza». In questa prospettiva, nella scelta etica bisognerebbe
optare per quel comportamento che massimizza la realizzazione delle aspirazioni del maggior
numero di soggetti. Ma anche questo utilitarismo delle preferenze non sfugge ad una delle critiche
qui sopra esposte: vi sono preferenze – come quelle espresse nel 1933 in Germania dalla
maggioranza elettorale che mandò al potere A. Hitler – che giustamente vengono recepite come
eticamente sbagliate.
Altre correzioni sostituiscono al piacere il «benessere»: si parla a questo proposito di
utilitarismo welfarista.7 In questa prospettiva, però, il problema della definizione del bene è
semplicemente spostato: ora si tratta di definire il benessere, e siamo di nuovo al punto di partenza.
Altri ancora ricorrono a criteri di ordine diverso, come la promozione di valori ideali quali
l’amicizia, la virtù ecc. (utilitarismo ideale)8 o la perfezione del soggetto agente (conseguenzialismo
perfezionista o eudemonistico)9. Il problema, in prima battuta, è evidentemente quello di fondare i
valori ideali e definire in cosa consista la perfezione.
2.2. L’atto e la regola
Dicevamo che uno degli elementi che conferiscono maggior fascino all’utilitarismo è l’idea che
vi possa essere una formula matematica grazie alla quale determinare quale sia l’azione giusta.
Purtroppo però un calcolo di questo genere è impossibile e la pretesa di utilizzarlo conduce –
paradossalmente – a conseguenze indesiderabili. Infatti, per sottoporre a calcolo la «felicità» delle
persone, devo attribuirle necessariamente un valore «finito», per cui il bene di due varrebbe più del
bene di uno, anche quando questo bene fosse la vita umana, la salute, la libertà: di qui la tendenza
ad agire nell’interesse della maggioranza anche quando ciò significasse coartazione delle
minoranze.
Se proviamo ad esemplificare le «conseguenze del conseguenzialismo» in campo bioetico,
notiamo come l’utilitarismo classico sembra una strada in grado di giustificare molte posizioni
incompatibili con valori condivisi: la sperimentazione sugli esseri umani potrebbe essere consentita,
in nome dell’interesse generale anche se non recasse vantaggio al singolo paziente; il contenimento
della spesa sanitaria a danno di segmenti minoritari della popolazione potrebbe essere accettato in
nome di benefici maggiori in altri settori; persino gli orrori perpetrati dai medici nazisti nei lager,
oppure l’esclusione di qualche minoranza etnica dall’assistenza sanitaria potrebbero risultare
5
Si vedano, a questo proposito, le fondamentali ricerche di V. Frankl, Teoria e terapia delle nevrosi (1975),
Brescia, Morcelliana, 1978.
6
L’esperimento mentale della «macchina delle esperienze» venne proposto da R. Nozick in Anarchia, stato
e utopia (1974), Milano, Feltrinelli, 2000, pp. 63-65.
7
Cfr. A. Sen, Utilitarismo e welfarismo (1979), in Saggi di filosofia della scienza economica, a cura di S.
Zamagni, Firenze, Nuova Italia Scientifica, 1982, pp. 179-205.
8
Cfr. G. E. Moore, Principia Ethica (1903), Milano, Bompiani, 1972.
9
Cfr. T. Hurka, Perfectionism, New York, Oxford University Press, 1993.
2
matematicamente giustificabili in nome di vantaggi per la maggioranza della popolazione10.
Per far fronte a queste incongruenze, recentemente è stato proposto l’utilitarismo della norma.
L’utilitarismo classico, infatti, si configura come utilitarismo dell’atto, ossia pretende di giustificare
direttamente le azioni e i giudizi in base al principio suddetto. L’utilitarismo della norma, invece,
giustifica i giudizi e le azioni in base alle norme, e le norme in base al principio di utilità. Pertanto,
in una prospettiva utilitaristica della norma, una sperimentazione su soggetto umano che non
recasse alcun vantaggio al paziente, anche quando fosse di vantaggio per la collettività, non sarebbe
giustificabile, in quanto l’esistenza di una norma che la giustificasse sarebbe essa stessa gravemente
svantaggiosa per la collettività stessa. Dunque la maggiore utilità potrebbe conseguire dal rispetto di
un insieme di regole prefissate, fermo restando che dovrebbe essere possibile fare eccezione a
ciascuna di queste regole quando l’utilità lo richiedesse.
Questa opzione rende senz’altro meglio applicabile il principio conseguenzialista, tuttavia non
risolve un problema centrale: determinate convinzioni morali, per esempio che la schiavitù sia
inaccettabile, non derivano dalla persuasione che una norma che proibisce la schiavitù sia più utile,
ma dal fatto che si vede nella schiavitù una ingiustizia11.
Nella prospettiva dell’utilitarismo, in forza del quale il bene sarebbe ciò che torna a vantaggio
del maggior numero di persone creando il minimo svantaggio, la schiavitù sarebbe invece ingiusta
solo in quanto socialmente «dannosa»; ora, non è impossibile immaginare alcune circostanze in cui
tenere in stato di schiavitù una minoranza (magari composta da persone che hanno dimostrato
scarsa capacità di deliberazione razionale, come voleva Aristotele12) potrebbe portare consistenti
vantaggi sociali. Ma nondimeno noi riteniamo che ciò sia ingiusto.
Gli utilitaristi contemporanei rispondono che la loro è un’etica per il mondo come attualmente
è, e che rispetta in modo uguale tutti gli individui: nelle circostanze attuali il ragionamento etico
non giustificherebbe la schiavitù13. Ma l’obiezione resta in piedi: ammesso (e non concesso) che il
calcolo utilitarista impedisca di giustificare la schiavitù nelle circostanze attuali, nulla esclude che
esso la giustifichi per circostanze diverse, e giacché le circostanze sociali cambiano continuamente,
domani potremmo ritrovarci a legittimare quel che oggi condanniamo. Eppure ciò ci ripugna.
3. Conta solo il risultato?
Una risposta più sofisticata rimanda alla motivazione etica più profonda del conseguenzialismo
stesso. La tesi teoretica implicita in ogni conseguenzialismo, infatti, è che, quali che siano i valori a
cui un individuo o un’istituzione si richiamino, la risposta adeguata a questi valori consiste non nel
10
Cfr. R. M. Veatch, A Theory of Medical Ethics, Basic Books, New York 1981, p. 175.
Il giudizio comune contemporaneo sulla schiavitù è che si tratta di una pratica intrinsecamente malvagia.
Poche affermazioni di carattere morale registrano consensi così vasti come quelle della Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo (Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 10.12.1948), in cui all’art. 1 si
afferma: «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti», e all’art. 4. si stabilisce:
«Nessun individuo potrà esser tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi
saranno proibite sotto qualsiasi forma». Siamo di fronte a uno dei pochi assoluti morali ammessi dalla cultura
contemporanea, che potrebbe essere in grado di costituire – anche da solo – una valida confutazione del
relativismo etico e del nichilismo. Le affermazioni sopra menzionate, infatti, intendono essere riconosciute
come verità assolutamente certe. Non si dice: «Noi siamo dell’opinione che gli esseri umani nascano liberi
ed eguali in dignità e diritti, pertanto consigliamo di non tenere nessuno in schiavitù». Si parte da un asserto
veritativo forte (a. 1) e se ne trae una conseguenza etico-giuridica vincolante (a. 4). Ora, se possediamo
almeno una verità di ordine antropologico e se c’è almeno un assoluto morale, ciò vuol dire che non tutto è
relativo. Cfr. A. Vendemiati, Présupposés anthropologiques de l’esclavage et de son abolition, in Mémoire
Spiritane, 9, Paris, 1er sem. 1999, pp. 16-26.
12
Cfr. Aristotele, Politica, I, 3, 1253 b 20 ss.
13
Cfr. R. M. Hare, What is Wrong with Slavery, in Philosophy and Public Affairs, 8, Princeton, N.J.,1979,
pp. 103-121.
11
3
«rispettarli», ma nel «promuoverli», e che ha senso rispettarli solo se ciò è parte del processo che
conduce a promuoverli o è necessario a tal fine.14
Pertanto la relazione tra i valori e il soggetto agente sarebbe di tipo strumentale: l’unico
compito del soggetto sarebbe quello di produrre conseguenze atte a promuovere un dato valore.
L’azione giusta sarebbe quella che ha come conseguenza la promozione del valore, anche nel caso
in cui l’azione stessa, nella sua struttura oggettiva, contrastasse con il valore in questione. Poniamo,
ad esempio, che il valore sia quello della vita umana: in prospettiva conseguenzialista non si
dovrebbe esitare ad uccidere un innocente qualora ciò fosse prevedibilmente utile per salvare la vita
di più persone. Si comprende dunque che il conseguenzialismo si oppone al deontologismo, ossia
alla convinzione che vi siano delle azioni che vanno evitate sempre e in ogni circostanza.
3.1. Tecnica e mentalità tecnicista
Il successo delle teorie conseguenzialiste dipende in gran parte dalla mentalità tecnicista. La
tecnica, infatti, valuta la correttezza delle azioni sulla base della loro capacità di produrre
determinate conseguenze. Ora, giacché nella letteratura bioetica un gran numero di questioni è stato
sollevato ed impostato da parte di tecnici, non suscita meraviglia il clima conseguenzialistico che
avvolge tanti contributi, al punto che molti autori assumono il termine «buono» sempre e soltanto in
riferimento alle conseguenze dell’azione, creando così una grande confusione, giacché nella
filosofia classica il «bene» è il «fine».
Ma appare evidente già dal linguaggio che il concetto di «conseguenza» non coincide con
quello di «fine». Si può parlare di fine o scopo quando c’è un’intenzionalità più o meno cosciente,
ma sempre, almeno in certa misura, razionale. La conseguenza si colloca, invece, nel mero ordine
dei fatti. Le scienze empiriche moderne non vedono – non possono vedere – fini o scopi: vedono
solo conseguenze (e questo è il frutto del livello molto alto di astrazione con cui esse si avvicinano
alla realtà)15. Così la normatività tecnica che su essa si basa non può che riguardare le conseguenze.
E questo finisce col produrre un’impostazione decisamente impersonale delle problematiche
bioetiche, inducendo una procedura «di protocolli» che tende a scavalcare il lavoro della coscienza
morale delle persone.
Certamente la correttezza dell’agire tecnico è necessaria per la bontà dell’azione, giacché se ci
si propone un fine, il mezzo che si sceglie deve provocare conseguenze congruenti con il
conseguimento del fine. Questo approccio, però, è di per sé incapace di elevarsi alla considerazione
della bontà etica, che implica un discernimento non solo dei mezzi e delle loro conseguenze, ma
anche e soprattutto dei fini.
In questa prospettiva la norma giuridica stessa tende a configurarsi in modo meramente
pragmatico: così, se pure si afferma che essa deve difendere la dignità umana, tale difesa non è però
intesa come fine in sé, bensì come strumento (relativizzabile, pertanto) che possa tornare
utilitaristicamente vantaggioso per la collettività. Ma cosa significa «vantaggioso»? Il criterio
dell’utilità, in mancanza di una riflessione più profonda, tende a riferirsi unicamente a ciò che
corrisponde alla volontà, ai desideri della maggioranza.
3.2. Fare ed agire
Il fatto è che la tecnica considera il fare in quanto produzione (póiesis) di qualcosa, che termina
all’oggetto prodotto; l’etica, invece considera l’azione (prâxis) in quanto oggetto di scelta,
corrispondente alla volontà del soggetto, che persegue fini tali che il risultato del loro
conseguimento resta nel soggetto stesso.16 La prospettiva della tecnica considera l’agire come
Cfr. P. Pettit, Consequentialism, in P. Singer, A Companion to Ethics, Oxford – Malden (Mass.), Blackwell, 1993, pp. 230-240.
15
Su questi temi, cfr. H. Jonas, Sull’orlo dell’abisso. Conversazioni sul rapporto tra uomo e natura (1993),
Torino, Einaudi, 2000, pp. 138-140; Tecnica, medicina ed etica. Prassi del principio responsabilità (1987),
Torino, Einaudi, 1997, pp. 66-67.
16
Cfr. Aristotele, Metafisica, L. VIII, 8 (1050 a 35 – b 2); Etica nicomachea, L. I, 1 (1094 a 1 – 2).
14
4
«operazione transitiva», la prospettiva etica lo considera come «operazione immanente»:17
«L’“agire morale” non è il “comportarsi verso gli oggetti”, “realizzare qualcosa fuori di noi”,
“produrre”, ma “realizzazione di ciò che possiamo essere, realizzazione del proprio essere umano”.
L’agire bene fa dell’agente un uomo buono (...). Con l’agire morale trasformiamo innanzitutto e
soprattutto quella parte del mondo che siamo noi stessi».18 Il «fare» tecnico è pur sempre un
«agire», che passa sì su oggetti esterni all’agente, ma rimbalza sull’agente stesso e richiede che egli
sia ben disposto rispetto ai suoi fini, ossia richiede la rettitudine della sua volontà.
È qui che si svela l’essenza della normatività etica: nella ricerca della vita buona e felice. La
questione etica fondamentale è: «Va bene la mia vita?», ovvero: «Che tipo di persona voglio essere?
Che tipo di persona posso essere? Che tipo di persona debbo essere?». Si tratta dunque della
questione del senso della vita umana, della mia vita, che è sempre in relazione con quella di altri
miei simili; per cui la questione si articola anche al plurale: «Va bene la nostra società?», ovvero:
«Che tipo di società vogliamo, possiamo, dobbiamo essere?». A partire da qui si pongono questioni
più specifiche, del tipo: «Che tipo di persona divento se mi comporto in questo modo?»; «Che tipo
di società diventiamo se incoraggiamo, ammettiamo o proibiamo questo comportamento?»; queste
domande portano all’elaborazione di norme specificamente etiche, del tipo: «Questo tipo di
comportamento è buono (o cattivo)», dietro le quali c’è una riflessione che intende: «Questo tipo di
comportamento ci fa diventare migliori (o peggiori); fa andare bene (o male) la nostra vita». Ora,
tali norme presuppongono anche considerazioni di carattere conseguenzialistico, ma esse sono
comprensibili soltanto sulla base di una intenzionalità agente nella prospettiva della prima persona.
In sintesi, va riconosciuto che la normatività conseguenzialista, tipica della tecnica, è di
carattere ipotetico, giacché concerne unicamente i mezzi per realizzare scopi particolari; la
normatività etica, invece, è sostanzialmente di carattere categorico, perché concerne il fine
dell’agire umano in quanto tale (il bene umano), quel fine che i soggetti agenti non possono fare a
meno di porsi, per realizzare la propria esistenza. Certamente, una volta chiarito il fine a cui si deve
tendere (categoricamente), l’azione si configura come mezzo intenzionale per il suo conseguimento.
E va notato che vi sono atti per natura loro ordinati al bene della persona e della comunità (es.:
aiutare i poveri, curare i malati, confortare i sofferenti, ecc.), mentre vi sono atti che contrastano con
questi beni (es.: uccidere gli innocenti, violentare, ridurre in schiavitù, ecc.). L’atto viene così a
collocarsi, sin dalla sua intenzionalità di base, in una specie morale, che può essere buona o
cattiva19. Ora, giacché «scegliere un mezzo in vista di un fine» è un unico atto di volontà, che
costituisce un’unica azione intenzionale, si capisce perché non ogni mezzo tecnicamente capace di
produrre un effetto desiderato è in realtà compatibile con il bene morale dell’azione. Un fine buono
come, ad esempio, quello di lenire le sofferenze di un paziente non può eticamente essere raggiunto
mediante l’uccisione del paziente stesso, anche se tecnicamente l’effetto è garantito! Le violazioni
dei diritti umani fondamentali – primo fra tutti il diritto alla vita – costituiscono azioni
intrinsecamente cattive, che nessun movente e nessuna circostanza varrà mai a giustificare sul piano
oggettivo (v. alla voce DIRITTO NATURALE).
Aldo Vendemiati
Bibliografia essenziale: M. BAYLES, Contemporary Utilitarianism, Doubleday & Co., Garden City (NY),
Cfr. san Tommaso d’Aquino, In Ethicorum, L. I, lect. I, (ed. Spiazzi, n. 13).
M. Rhonheimer, La prospettiva della morale. Fondamenti dell’etica filosofica, Roma, Armando ed., 1994,
p. 23.
19
«Omnia enim moralia ex fine speciem consequuntur. Ex ordine autem ad finem debitum specificatur bona
actio et bonus habitus, ratione cujus bonum differentia speicifica ponitur habitus et actionis moralis; mala
vera actio specificatur ex ordine ad finem indebitum, cuius admiscetur privatio finis debiti, ex quo ratio mali
incidit», San Tommaso d’Aquino, In II Sententiarum, d. 34, q. 1, a. 3, ad 3m. Si noti che «Actus moralis non
habet speciem a fine remoto, sed a fine proximo qui est obiectum», Id., De malo, q. 2, a. 6, ad 9m.; cfr. q. 8,
a. 1, ad 14m. «Cum enim actus moralis ex suo obiecto speciem hebeat, vel in genere collocetur, ex hoc potest
cognosci aliquem actum moralem esse malum ex suo genere, si actus ipse non referatur convenienter ad
suam materiam vel obiectum», Ibid., q. 10, a. 1, c; cfr. q. 12, a. 3, c.
17
18
5
1968; P. PETTIT, Consequentialism, in P. SINGER, A Companion to Ethics, Oxford – Malden (Mass.), Blackwell, 1993, pp. 230-240; S. SCHEFFLER, The Rejection of Consequentialism. A Philosophical Investigation of
the Considerations Underlying Rival Moral Conceptions, Clarendon Press, Oxford 1994; J.J.C. SMART – B.
WILLIAMS, Utilitarismo: un confronto (1973), Napoli, Bibiliopolis, 1985.
6