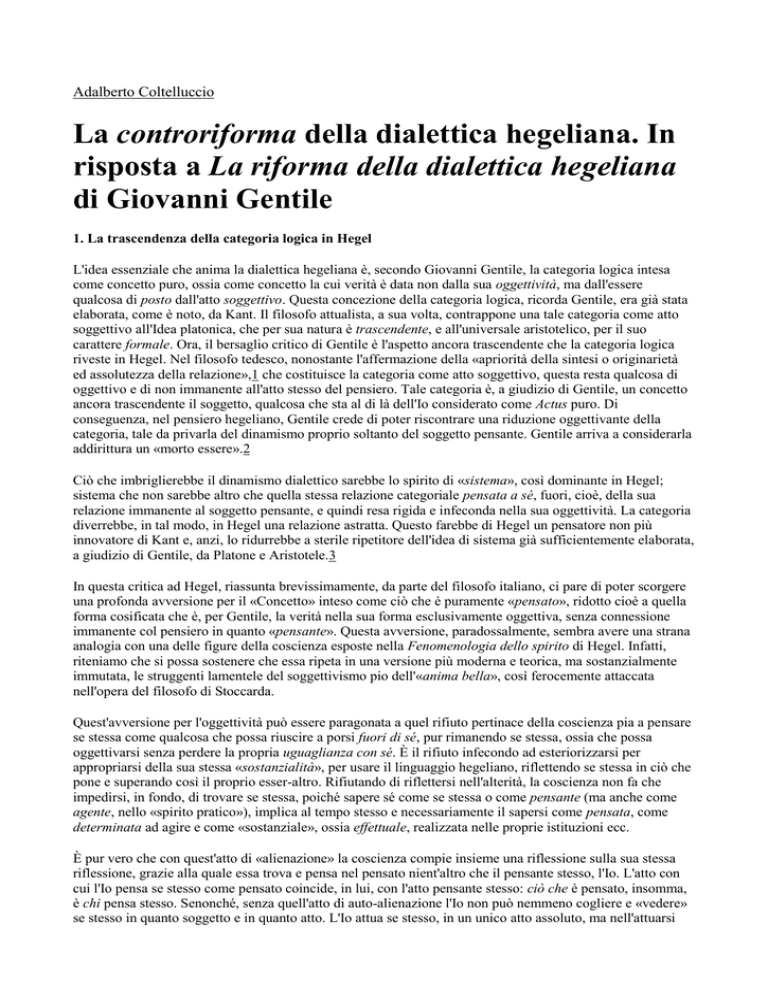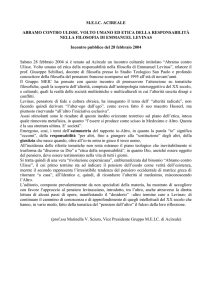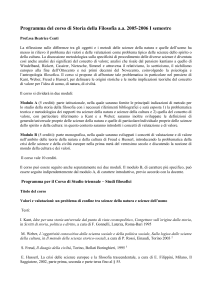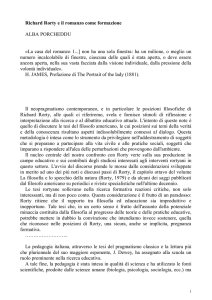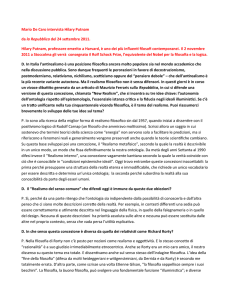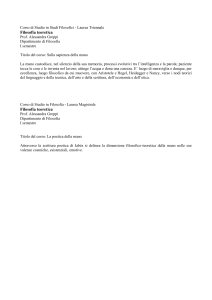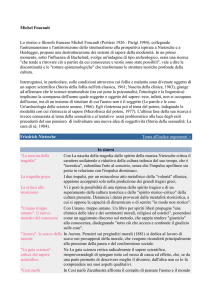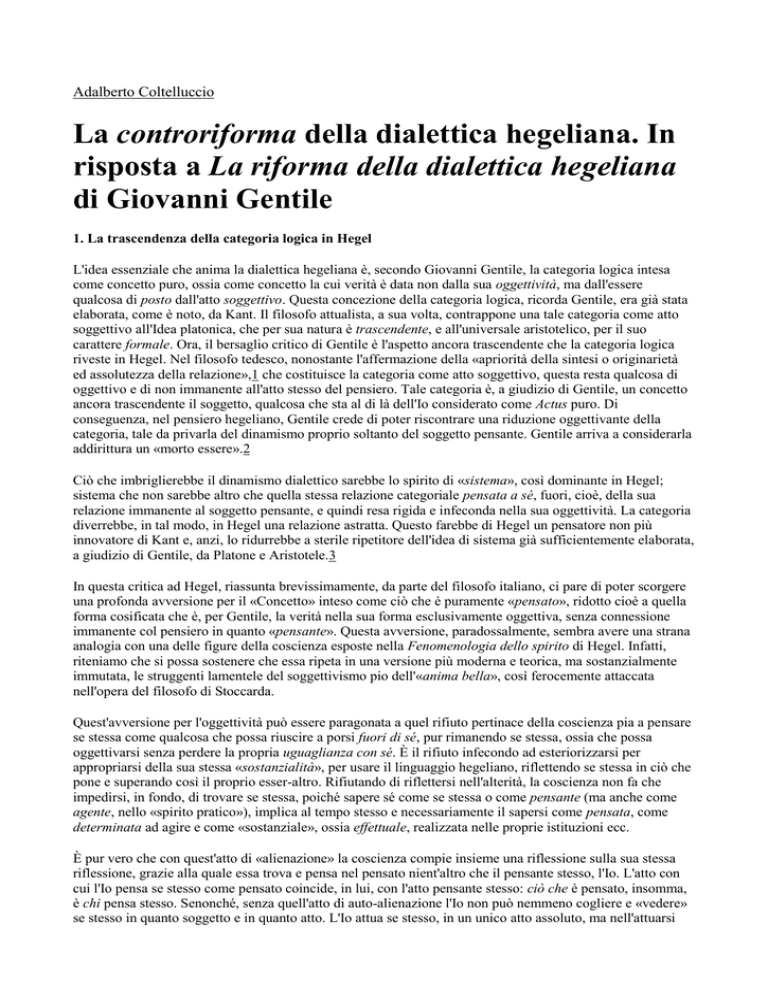
Adalberto Coltelluccio
La controriforma della dialettica hegeliana. In
risposta a La riforma della dialettica hegeliana
di Giovanni Gentile
1. La trascendenza della categoria logica in Hegel
L'idea essenziale che anima la dialettica hegeliana è, secondo Giovanni Gentile, la categoria logica intesa
come concetto puro, ossia come concetto la cui verità è data non dalla sua oggettività, ma dall'essere
qualcosa di posto dall'atto soggettivo. Questa concezione della categoria logica, ricorda Gentile, era già stata
elaborata, come è noto, da Kant. Il filosofo attualista, a sua volta, contrappone una tale categoria come atto
soggettivo all'Idea platonica, che per sua natura è trascendente, e all'universale aristotelico, per il suo
carattere formale. Ora, il bersaglio critico di Gentile è l'aspetto ancora trascendente che la categoria logica
riveste in Hegel. Nel filosofo tedesco, nonostante l'affermazione della «apriorità della sintesi o originarietà
ed assolutezza della relazione»,1 che costituisce la categoria come atto soggettivo, questa resta qualcosa di
oggettivo e di non immanente all'atto stesso del pensiero. Tale categoria è, a giudizio di Gentile, un concetto
ancora trascendente il soggetto, qualcosa che sta al di là dell'Io considerato come Actus puro. Di
conseguenza, nel pensiero hegeliano, Gentile crede di poter riscontrare una riduzione oggettivante della
categoria, tale da privarla del dinamismo proprio soltanto del soggetto pensante. Gentile arriva a considerarla
addirittura un «morto essere».2
Ciò che imbriglierebbe il dinamismo dialettico sarebbe lo spirito di «sistema», così dominante in Hegel;
sistema che non sarebbe altro che quella stessa relazione categoriale pensata a sé, fuori, cioè, della sua
relazione immanente al soggetto pensante, e quindi resa rigida e infeconda nella sua oggettività. La categoria
diverrebbe, in tal modo, in Hegel una relazione astratta. Questo farebbe di Hegel un pensatore non più
innovatore di Kant e, anzi, lo ridurrebbe a sterile ripetitore dell'idea di sistema già sufficientemente elaborata,
a giudizio di Gentile, da Platone e Aristotele.3
In questa critica ad Hegel, riassunta brevissimamente, da parte del filosofo italiano, ci pare di poter scorgere
una profonda avversione per il «Concetto» inteso come ciò che è puramente «pensato», ridotto cioè a quella
forma cosificata che è, per Gentile, la verità nella sua forma esclusivamente oggettiva, senza connessione
immanente col pensiero in quanto «pensante». Questa avversione, paradossalmente, sembra avere una strana
analogia con una delle figure della coscienza esposte nella Fenomenologia dello spirito di Hegel. Infatti,
riteniamo che si possa sostenere che essa ripeta in una versione più moderna e teorica, ma sostanzialmente
immutata, le struggenti lamentele del soggettivismo pio dell'«anima bella», così ferocemente attaccata
nell'opera del filosofo di Stoccarda.
Quest'avversione per l'oggettività può essere paragonata a quel rifiuto pertinace della coscienza pia a pensare
se stessa come qualcosa che possa riuscire a porsi fuori di sé, pur rimanendo se stessa, ossia che possa
oggettivarsi senza perdere la propria uguaglianza con sé. È il rifiuto infecondo ad esteriorizzarsi per
appropriarsi della sua stessa «sostanzialità», per usare il linguaggio hegeliano, riflettendo se stessa in ciò che
pone e superando così il proprio esser-altro. Rifiutando di riflettersi nell'alterità, la coscienza non fa che
impedirsi, in fondo, di trovare se stessa, poiché sapere sé come se stessa o come pensante (ma anche come
agente, nello «spirito pratico»), implica al tempo stesso e necessariamente il sapersi come pensata, come
determinata ad agire e come «sostanziale», ossia effettuale, realizzata nelle proprie istituzioni ecc.
È pur vero che con quest'atto di «alienazione» la coscienza compie insieme una riflessione sulla sua stessa
riflessione, grazie alla quale essa trova e pensa nel pensato nient'altro che il pensante stesso, l'Io. L'atto con
cui l'Io pensa se stesso come pensato coincide, in lui, con l'atto pensante stesso: ciò che è pensato, insomma,
è chi pensa stesso. Senonché, senza quell'atto di auto-alienazione l'Io non può nemmeno cogliere e «vedere»
se stesso in quanto soggetto e in quanto atto. L'Io attua se stesso, in un unico atto assoluto, ma nell'attuarsi
non può che farsi al tempo stesso «attuante» e «attuato»: non potrebbe, infatti, essere attuante nei confronti
di stesso se non fosse insieme attuato da se stesso.
2. Inoggettivabilità dell'Atto puro del pensiero in Gentile
Riappropriandosi di se stesso nell'oggetto (il cosiddetto «ritorno in sé dall'esser-altro», da parte
dell'autocoscienza), l'Io non perde la sua determinazione d'essere, la sua effettualità, quasi che il pensato
venisse «ingoiato», per dir così, dalla coscienza e che l'oggetto posto come se stessa svanisse. Anzi, proprio
il trovare sé nell'oggettività, fa sì che l'Io acquisti concretezza e si realizzi, al tempo stesso razionalizzando il
reale. Tale risultato, come si sa, è conseguito dalla coscienza solo perché il reale stesso, inizialmente saputo
come estraneo, viene poi riconosciuto come costituito in sé dal concetto stesso. Del resto, come l'essere è
uno con il pensare, così il pensare è uno con l'essere: l'Io sa se stesso e si sa come Io proprio grazie al suo
porre in sé questa determinazione necessaria dell'essere e della differenza. Non la rifiuta, quindi, sebbene
attui questo porsi in essere in modo Incondizionato, soltanto da sé, ossia liberamente. Sapersi è, perciò,
secondo Hegel realmente farsi-altro, alienarsi e sapere se stesso in ciò che è, dopo che ogni opposizione
fenomenologica è stata superata. Sapersi è sapersi come essente, e superare l'opposizione tra certezza
soggettiva e verità oggettiva.
Il sapere inteso da Gentile soltanto come Actus puro che non arriva mai ad oggettivarsi, è un inafferrabile
introiettarsi del soggetto ponente che sprofonda in un auto-annullamento dello stesso atto che pone, perché è
un atto senza esito (privo, cioè, di quello che gli Scolastici medievali denominavano «atto elicito»), senza la
forza di porre effettivamente il posto, e di riprenderlo in sé dopo averlo posto. Laddove, invece, la verace
relazione del sapere è solo quella in cui, per stare alle parole di Hegel, «l'alienazione dell'autocoscienza,
proprio lei pone la cosalità, onde l'alienazione ha significato non solo negativo, ma anche positivo», in
quanto l'autocoscienza «sa la nullità dell'oggetto», proprio perché lei stessa vi si è posta e così «resta presso
di sé nel suo esser altro».4
Sulla base di questa ricognizione del testo hegeliano, in cui mettiamo in rilievo aspetti che insistono, da un
lato, sulla necessità per lo spirito di auto-alienarsi per divenire realmente essente, e, dall'altro, sul fatto che
comunque l'autocoscienza «pone sé come oggetto» o, che è lo stesso, «l'oggetto come se stessa»,5 in modo
anche da togliere e riprendere in sé tale alienazione nell'oggettività, ci sembra di poter affermare che la
pretesa contrapposizione della «dialettica del pensato» alla «dialettica del pensante», di cui parla Gentile,
possa valere soltanto per quell'«intelletto astratto» (Verstand) di cui lo stesso Hegel denunciava la fissità e la
mancanza di speculatività. La dialettica del pensato, se autenticamente dialettica, e dunque in cui si
concepisce il pensato essenzialmente come momento che toglie se stesso (essendo negativo in sé), supera la
fissità intellettualistica e media se stessa nella dialettica del pensante.6 Il pensato è, così, essenzialmente
momento già nello stesso sistema hegeliano, quel momento in cui lo stesso pensante, in quanto posto, viene
rinviato a se stesso, in quanto ponente, dalla propria riflessione nell'esser-altro. Quella drastica dicotomia tra
l'atto puro dello spirito e il porsi nell'oggetto, come in un'alterità radicalmente trascendente, che Gentile lesse
nella dialettica hegeliana, alla luce delle precedenti considerazioni apparirebbe meno sostenibile.
3. Molteplicità delle categorie e Wirklichkeit dello Spirito
Altro aspetto preso di mira dalla critica gentiliana è quello riguardante il concetto di unità del molteplice
nella logica hegeliana, che, a suo avviso, lascerebbe sussistere come irriducibili le categorie (di derivazione
kantiana), nella loro pluralità irrelata. Gentile riconosce a Hegel il merito di avere coerentemente seguito lo
schema kantiano della deduzione trascendentale delle categorie, e di aver sostenuto che «la realtà è lo stesso
pensiero, e che il vero, il solo reale concetto è lo stesso concepire»,7 ossia l'atto pensante in sé. Pensiero qui
ha la valenza dell'atto intrinseco alla categoria come unità del molteplice empiricamente dato nell'intuizione.
L'Idea assoluta di Hegel non sarebbe nient'altro che appunto la «categoria produttiva del giudizio sintetico a
priori, in cui Kant aveva mostrato che si risolve ogni atto reale di pensiero».8 E, del resto, «la scienza
dell'idea» come «scienza della relazione», intesa però «non come pensato, bensì come pensare»,9 è questo
stesso sistema delle categorie kantianamente concepito.
Azzerata, a nostro avviso, la differenza essenziale tra logica trascendentale di Kant e logica dialetticoontologica di Hegel, Gentile pensa che in quest'ultima, che sarebbe quindi sostanzialmente la medesima nei
due filosofi tedeschi, verrebbe moltiplicato il numero delle categorie da trattare. Vero è che «Hegel bensì,
nella sua deduzione, se enumera di fatto le categorie, tende col suo metodo dialettico ad annullarne il
numero, mercè quella legge del superamento (aufheben)»,10 e che «tutta la molteplicità delle categorie
hegeliane si risolve, infine, nella concreta categoria (sola concreta categoria) dell'idea assoluta, e quindi
nell'unità assoluta».11 Ma nel fatto, nell'effettuale procedimento dialettico, Hegel non può non produrre una
molteplicizzazione di momenti e di categorie che non risponde al «punto di vista trascendentale, ma solo al
punto di vista empirico e storico».12 Dunque, Hegel in realtà «tende ad annullare il numero delle
categorie»,13 ma non annullerebbe di fatto il concetto della molteplicità delle stesse, che inficierebbe l'autoattualità immanente e immoltiplicabile del Conceptus.
Ma, intanto, per esplicita ammissione di Gentile, dobbiamo constatare che il pensante lascia sussistere
necessariamente fuori di sé un molteplice empirico che non è immanente alla spiritualità del puro pensare,
bensì è un alter non mediato e irriducibile all'unità (perché nell'unità assoluta del pensante è impossibile
introdurre qualsiasi molteplicità); alter che è quello del «punto di vista empirico e storico». Vi sarebbe,
quindi, nella stessa filosofia dello Spirito gentiliana, qualcosa di eterogeneo alla omogeneità assoluta del
pensante, un pensato che sfuggirebbe alla immoltiplicabilità e inoggettivabilità dell'Atto puro del pensiero:
un actum, insomma, che non riesce ad essere actus. Se questa molteplicità empirica è tacitamente ammessa
dall'Attualismo (come lo è, del resto, da parte di tutti gli idealismi della storia della filosofia),
quest'ammissione è inevitabile, perché è l'esito necessario cui va incontro ogni Idealismo puro che rifiuti
l'auto-realizzazione del pensiero nella realtà già attuata, seppure questa realtà restituisca sempre qualcosa di
non razionalizzabile.
L'effettualità del pensato è, invece, necessaria; e lo è talvolta, malgrado e contro la ragione. Certo, Hegel
cerca di riportare alla razionalità tutti gli eventi storici che possono essere giustificati in base ad una «ragion
d'essere» o fondamento (Grund). Tuttavia, è noto argomento della critica antihegeliana (ci riferiamo
soprattutto alla critica ottocentesca, per es., di Trendelenburg, ma anche a quella di Schopenhauer, o di
Kierkegaard, di Marx, di Nietzsche) che la razionalità non riesca a giustificare proprio tutto, e che sia
costretta a lasciare in preda alla più arbitraria casualità molte delle cosiddette «effettualità» o «realtà in atto»
(Wirklichkeit) del processo dialettico del Concetto. Ma ciò non è un argomento sufficiente a scongiurare la
necessità che lo spirito si cerchi e tenti di trovarsi anche nelle infime regioni dell'essere sia naturale che
storico-sociale; anzi sembrerebbe una ragione in più per sostenerne l'esigenza. Ad ogni modo, comunque,
l'effettualità dell'autocoscienza è in sé un momento razionale ed essenziale alla vita dell'Idea.
Ciò non significa che il processo dialettico muti irreversibilmente il «pensante» in «pensato», o che lo ponga
come qualcosa di sostanzialmente trascendente rispetto al soggetto come atto puro, oppure come qualcosa di
refrattario al «lavoro» del negativo. Significa, però, che la Totalità, nella quale soltanto può cogliersi per
Hegel la verità, si costituisce sempre come un processo di auto-attuazione del Concetto, ove sono compresi
al tempo stesso sia il pensante sia il pensato, come momenti assolutamente inscindibili che non possono
sussistere nel loro isolamento l'uno rispetto all'altro, pena il ritorno ad una visione intellettualistica e astratta.
A rigore, non sarebbe da accettare come valida nemmeno l'accusa gentiliana che nella dialettica hegeliana sia
presente una dicotomia tra pensante e pensato, in quanto la dialettica del Concetto ha già risolto e superate
tutte le opposizioni proprie del sapere fenomenologico.
Quando si considera il pensiero nella sua assolutezza, e in questo senso mostra sempre di parlarne Gentile, il
processo dialettico non divide mai in un modo astratto, quale potrebbe essere quello che vede nell'articolarsi
dell'unità e nell'auto-distinguersi del Concetto, soltanto un «fissarsi» nella contrapposizione delle categorie
del Begriff, o delle figure del Geist. Tale fissarsi intellettualistico considera sempre i distinti come
assolutamente uno fuori dell'altro e incapaci di auto-invertirsi in loro stessi. Ma effettivamente nella
dialettica hegeliana è in opera tale auto-inversione: il pensante è sempre in sé-pensato, e il pensato è sempre
in sé-pensante. Il pensiero assoluto si auto-distingue eternamente da se stesso proprio per auto-attuarsi, e
dunque resta già sempre in una relazione di auto-eguaglianza con se stesso, ogni volta che si pone nei
distinti. Il che equivale a dire che il pensiero, anche come Actus, mentre è pensante se stesso è sempre anche
pensato da se stesso, in modo da non restare irrimediabilmente separato da se stesso, proprio perché ciò che
esso pensa coincide inscindibilmente con chi lo pensa. Nonostante gli inevitabili giri di parole, il senso
complessivo crediamo che rimanga chiaro. Ci piace ricordare, a questo proposito, l'eloquente citazione che
Hegel fa, alla fine della sua Enciclopedia, relativa alla nozione aristotelica del «pensiero di pensiero»14
(nòesis noèseos): «Epperò l'Intelletto pensa se stesso, se è vero che esso è il bene supremo, e il suo pensiero è
pensiero-di-pensiero».
L'inscindibile atto auto-riflessivo dell'Idea assoluta corrisponde proprio al pensiero-di-pensiero, in cui è
superata ogni possibile separazione ed esclusione dell'oggettività che, nella sua verità, non è altro che il
Concetto pensante stesso in quanto si è attuato (Wirklichkeit). Il nocciolo speculativo proprio della dialettica
hegeliana ci sembra, a questo punto, più vicino alla dialettica dell'Atto puro di quanto, forse, non pensasse lo
stesso Gentile.
Note
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
G. Gentile, La riforma della dialettica hegeliana, Sansoni, Firenze, 1913, p. 3.
Ibid.
«Perché già nella dialettica quale la concepisce Platone le idee sono concepite come costituenti essenzialmente un sistema
[...]. E tutta la logica formale, svoltasi dall'Analitica aristotelica, [...] non poteva muoversi e in realtà non si è mossa mai
fuori di questo concetto» (ivi, pp. 3-4), che è quello «dell'assoluta oggettività della verità» (ibid.).
G. W. F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, traduz. it. E. De Negri, La Nuova Italia editrice, Firenze, 1979, vol. II, p.
287.
Ivi, p. 288.
Non ci sembra avere altra funzione che questa di mediare la contrapposizione tra pensato e pensante, la celebre
articolazione nei tre momenti del processo logico-ontologico, descritti da Hegel come: «a) l'astratto o intellettuale; b) il
dialettico, o negativo-razionale; c) lo speculativo o positivo-razionale» (Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche,
traduz. it. B. Croce, Roma-Bari, 1980, vol.I, p. 95). Proprio l'ultimo momento ci pare decisivo per l'atto dello spirito che
riprende in sé ogni opposizione, togliendo ogni alterità e ogni estraneità rispetto al Concetto assoluto, attraverso il secondo
momento dialettico-negativo.
Gentile, op. cit., p. 8.
Ibid.
Ibid.
Ivi, p. 9.
Ibid.
Ivi, p. 10.
Ivi, p. 9.
Aristotele, Metafisica, 1074 b 35-37.
Alessandro Medri
Il fiore azzurro. Considerazioni sul
rapporto tra filosofia e poesia in
Heidegger, Valéry e Novalis
Nell'azzurro cristallo
Sta pallido un uomo, la guancia appoggiata alle sue stelle;
O china il capo nel sonno purpureo.
Ma il volo nero degli uccelli sfiora sempre
Chi guarda, la santità di fiori azzurri,
la quiete vicina pensa cose dimenticate, angeli spenti.1
1. Premessa
Per lo meno tre atteggiamenti fondamentali sono possibili, al fine di approssimarsi alla essenza
della poesia -- in particolare -- e dell'arte -- in generale:
a. si può intendere l'opera d'arte come strutturalmente informata dallo spirito del tempo
[Zeitgeist] in cui è sorta, come in qualche modo da esso determinata, sua manifestazione
sensibile. In tale prospettiva, l'accento è chiaramente posto sul genio collettivo come
elemento ermeneutico centrale;
b. potremmo altresì interpretare l'opera d'arte a partire dall'intentio dell'artista che la ha
prodotta, al fine di evincere ciò che in essa e tramite essa egli ha voluto esprimere. L'opera è
in tal caso considerata come un mezzo per comunicare un certo messaggio; di guisa che ad
agire è qui il genio individuale;
c. il terzo approccio, ritenuto peraltro eterodosso dalla maggior parte dei critici, giacché
trascende le due dimensioni testé illustrate, attribuisce all'opera d'arte un valore non già
indipendente sibbene ulteriore rispetto a quello riconducibile al contesto d'origine e alla
volontà dell'autore.
I tre livelli (che potremmo chiamare storico, psicologico e metafisico) non sono autonomi e
separati, anzi vicendevolmente si reclamano; tuttavia essi non sono punto equivalenti: tra loro,
infatti, è presente una precisa gerarchia, la quale contempla il terzo approccio ermeneutico come
quello filosoficamente più fecondo.
Ad esempio, è evidente che il poema dantesco fornisce elementi preziosi per ricostruire lo spirito
della cultura medievale; è parimenti ovvio e attestato che ogni dettaglio è stato abilmente
concretato dal poeta, detiene nella di lui mente un preciso significato ed è collocato in una
posizione che non potrebbe essere diversa nella formidabile e perfetta architettura complessiva:
per tutti gli elementi in gioco sarebbe possibile risalire all'esatto valore storico e simbolico che
Dante desiderava conferire loro (su questo, Charles Singleton e Erich Auerbach hanno scritto
pagine memorabili e da cui certo non si può prescindere). Ciò nondimeno, commetteremmo una
leggerezza qualora ci arrestassimo a quest'ordine di considerazioni. Il centro vitale della
Commedia, a mio avviso, è da ricercarsi -- contrariamente a quanto la critica ha sempre sostenuto - nei numerosi luoghi, soprattutto della terza Cantica, in cui il poeta confessa la propria
inadeguatezza rispetto alla comunicazione dell'intuizione che gli è stata elargita. La grandezza del
poema, insomma, risiede non solo e non tanto nella sua pur mirabile monumentalità, ma nella sua
natura di esperienza mistica poeticamente narrata.2
Ancora: quantunque sia indubbio che con i tre solenni rintocchi che aprono il suo IX Sonetto (né -più -- mai, sorta di Schicksalmotiv, come all'inizio della Quinta Sinfonia di Beethoven, della Quarta
di Èaikovskij e anche della Seconda di Mahler) Foscolo volesse introdurre ad una tragische
Weltanschauung ohne Erlösung, sviluppata compiutamente in ogni riga dei suoi scritti, il senso
ultimo della poesia (di questa come di ogni poesia autentica) pare essere rinvenibile solo altrove.
Quando Dilthey si impegna nella ricostruzione della poetica dei massimi autori tedeschi della
seconda metà del XVIII secolo (Lessing, Goethe, Novalis, Hölderlin), fonda le sue ricognizioni sui
primi due dei tre aspetti che ho rintracciato, specialmente sul secondo: la poesia [Dichtung] è
manifestazione dell'esperienza vissuta [Erlebnis] dell'autore.3
Ciò che intendo sostenere è semplice: esiste un significato dell'arte irriducibile alle condizioni
storiche durante le quali essa è stata prodotta e alle intenzioni dell'artista che la ha concepita,
nonché all'oggetto che è stato causa occasionale della sua origine.4 Se un'opera si presenta come
una descrizione di qualsivoglia oggetto, non per questo dobbiamo necessariamente concludere che
essa si risolva in una mera rappresentazione; ciò neppure quando l'artista programmaticamente
intende la propria opera come esaurientesi in una Darstellung di natura realistica. Il
suprematismo di Maleviè e l'astrattismo in genere mostrano come l'arte sia quintessenzialmente
decisa da ogni ingenua «obiettivita».5
Aderisce completamente a una simile prospettiva Giuseppe Ungaretti, quando, in Ragioni d'una
poesia, dice: «Oggi il poeta sa e risolutamente afferma che la poesia è testimonianza d'Iddio, anche
quando è una bestemmia».6
Che l'artista lo voglia o meno, terminus a quo e terminus ad quem del suo lavoro convergono e
convengono in un unico punto: il Sacro [das Heilige]: «C'est une erreur contraire à la nature de la
poésie, et qui lui serait même mortelle, que de prétendre qu'à tout poème correspond un sens
véritable, unique, et conforme ou identique à quelque pensée de l'auteur».7
Thomas Mann ha compreso molto bene come in arte ci siano dimensioni che sfuggono al controllo
dell'autore. Nella celebre lezione di Princeton sullo Zauberberg, egli afferma infatti:
Accetto volentieri gli aiuti della critica altrui, perché è errore credere che l'autore sia colui che
meglio conosce e può commentare la propria opera. Lo è forse fintanto che vi indugia e vi sta
lavorando. Ma un'opera compiuta e lasciata alle spalle gli diventa sempre più estranea, distaccata, e
col tempo gli altri ne sono informati e vi si raccapezzano meglio di lui, sicché possono
rammentargli molte cose che egli ha dimenticato o forse non ha neanche saputo mai con
chiarezza. In genere, si ha bisogno di essere ricordati a se stessi.8
I primi due momenti ermeneutici (storico e psicologico) giustificano e implicano un lavoro di
parafrasi onde acquistare una interpretazione univoca; il terzo (metafisico) rifiuta o supera la
parafrasi,9 poiché riconosce il carattere originariamente evocativo e sorgivo del linguaggio poetico,
e, inoltre, si fonda sul canone ermeneutico principale: quello della necessaria coralità delle
interpretazioni -- in conseguenza della inesauribilità semantica della poesia -- e della
convergenza dei veri in un unico punto inattingibile e inattuale che è la loro origine: «ogni strada
nuova attraversa paesi nuovi e ognuna, alla fine, riporta a queste dimore, a questa patria sacra».10
Come dice Valéry -- e lo vedremo più approfonditamente in seguito:
Quanto più un poema è conforme alla Poesia, tanto meno può essere pensato in prosa senza che
venga distrutto. Riassumere o volgere in prosa un poema, significa ignorare semplicemente
l'essenza d'un'arte. La necessità poetica è inseparabile dalla forma sensibile.11
Porsi in ascolto del linguaggio poetico nella sua originarietà allusiva alla fonte: è ciò che
Heidegger chiama Erörterung.
2. Heidegger e l'irriducibile inattualità del linguaggio poetico
Ci sarà sempre qualcosa che la parola
non può rendere compiutamente,
e che non è il superfluo, ma l'essenziale.12
La mia opera consta di due parti:
di ciò che qui è scritto, e di tutto ciò che io non ho scritto.
E proprio questa seconda parte è quella importante.13
Una cosa è certa: Heidegger non avrebbe mai definito metafisico il proprio approccio ermeneutico
alla poesia (e all'arte). Ma qui non si tratta di sottoscrivere in toto le sue tesi, men che meno quelle
relative alla metafisica occidentale. Si vuole solamente recuperare il pondus, lo spirito, per così
dire, che sostanzia le sue analisi al fine di ritenerne gli spunti più significativi.
Erörtern significa rapportarsi al luogo [Ort] in cui dimora l'essenza del linguaggio. Per raggiungere
tale regione, ci si deve abbandonare al linguaggio medesimo, senza volerlo costringere entro le
nostre anguste categorie. Esso si sottrae a una mera trattazione logico-filologicoscientifica.L'essenza del linguaggio perdura in ciò che è stato detto, perché nel detto il linguaggio si
è già realizzato. Per questa ragione, nel primo dei saggi che compongono Unterwegs zur Sprache
(1959), Heidegger si dispone al commento di una poesia di Georg Trakl (Una sera d'inverno). Fra
le altre, troviamo questa frase fondamentale: «Che il poeta sia lui, non ha importanza: qui, come in
ogni altro caso di poesia riuscita. La grandezza sta appunto in questo: che può prescindere da
persona e nome del poeta».14
Una analisi particolareggiata della poesia non farebbe, a giudizio di Heidegger, che perpetuare una
fuorviante precomprensione imperante da due millenni, ossia che
il linguaggio è l'espressione, attuata dall'uomo, di moti interiori dell'animo e della visione del
mondo che li regge [...] Il linguaggio [invece], nella sua essenza, non è né espressione né attività
dell'uomo. Il linguaggio parla. Noi ricerchiamo ora il parlare del linguaggio nella poesia. Ciò che si
cerca è, pertanto, racchiuso nella poeticità della parola.15
Il linguaggio nomina, non nel senso che attribuisca ad ogni cosa un nome, ma nel senso che
chiama, e-voca. Chiamare è chiamare nella vicinanza; pertanto, ciò che è chiamato, qua talis,
sussiste come l'ancora assente. Tale absens, che la poeticità del linguaggio evoca, è das Geviert, la
quadratura hölderliniana di cielo e terra, uomini e dei. Il Geviert è adunanza di una doppia
polarità, la quale, per sua natura, indica la fonte originaria da cui essa medesima scaturisce. La
poeticità del linguaggio consiste in questo: che esso, evocando il Geviert, allude al principio
inattuale e inattingibile, sorgente da cui il linguaggio proviene e che nel linguaggio si annuncia
come evento [Ereignis]. Il linguaggio chiama nella prossimità un assente irriducibilmente remoto
in quanto istituisce una dif-ferenza [Unter-schied] . Il linguaggio poetico, fondamentalmente,
nomina la differenza. Non è linguaggio che determina e con-cepisce, ma parola che apre e rinvia
alla propria condizione di possibilità.
Heidegger chiama il Geviert anche die Welt. Il mondo è ciò che consente la cosa, ciò in cui la cosa è
cosa, così come il principio è ciò che consente il mondo. Il rapporto fra essi è segnato dalla
differenza.16 Il linguaggio, evocando la differenza, nomina il rapporto di cosa, mondo e principio.
L'intimità di tale rapporto, che nel linguaggio si annuncia e viene alla presenza, li acquieta nella
semplicità della loro essenza.
La totalità dei componimenti di un poeta non esaurisce il senso del suo poetare. Ogni poetare
autentico proviene da un unico poema originario che la totalità delle poesie addita senza risolverlo
in essa. Il pensiero deve entrare in dialogo con la poesia per riattingere l'essenza pura del
linguaggio; la quale consiste in ciò, che il linguaggio è l'Aperto in cui l'essere si eventua. L'essere,
giacché possibilizza ogni definizione, non può venire compiutamente semantizzato; possiamo
unicamente disporci al semplice annuncio del suo e-venire e del suo a venire: «La Erörterung che il
pensiero viene compiendo può tutt'al più fare dell'ascolto un problema e renderlo, nel caso
migliore, più pensoso».17
Ciò che i quattro del Geviert indicano e che nella Lichtung aperta dal linguaggio poetico si
annuncia lo chiamiamo das Heilige; l'ultimo Dio ci salverà in quanto risveglierà la nostalgia
[Heimweh] ormai obliata, in questo tempo di inedia [in diese dürftiger Zeit], per il Sacro:
Il linguaggio della poesia di Trakl attinge la sua parola dal trapasso. Il sentiero di questo conduce
dal tramonto, che è rovina, al tramonto che è passaggio nell'azzurro crepuscolare del Sacro. Il
linguaggio attinge la sua parola dal viaggio che porta oltre e attraverso il lago notturno della notte
spirituale. Tale linguaggio canta il canto del distacco che è ritorno dalla tarda ora del disfacimento e
rientro nel mattino di quell'inizio più quieto che ancora non è stato. In questo linguaggio parla das
Unterwegs, attraverso cui si fa percepibile la musica e la luce degli anni spirituali dello straniero
dipartito.18
Ventitré anni prima della pubblicazione di Unterwegs zur Sprache, Heidegger tenne un famoso
ciclo di tre conferenze che andò poi a costituire il primo degli Holzwege col titolo Der Ursprung
des Kunstwerkes (1936). Ur-sprung è il salto originario, ciò da cui e per cui una cosa è ciò che è;
allora il problema dell'origine coincide con il problema dell'essenza (dacché l'essenza [das Wesen] è
ciò che qualcosa è essendo ciò che è -- il positivo che risulta, secondo Hegel, dalla negazione
determinata come secondo fondamentale momento del processo dialettico).
Ora, è l'opera d'arte che a noi si presenta e che esibisce l'arte nella sua essenza. Per coglier l'essenza
dell'arte dobbiamo volgerci all'opera nel suo immediato apparire. Il dato più evidente è che l'opera
è qualcosa, ossia non è un puro ni-ente (N-ichts). Che significa essere qualcosa? Che è la «cosalità»
di una cosa? E, soprattutto, in che differisce l'esser-cosa di una cosa dall'esser-cosa di un'opera?
La cosa è stata intesa dalla filosofia via via come hypokèimenon (ricettacolo di accidenti), come
àistheton (oggetto percepito dai sensi) e come synolon di hyle e morphè. Un oggetto naturale, ad
esempio un blocco di granito, è un sinolo la cui forma è determinata dalla disposizione delle
particelle che ne costituiscono la materia. Anche una brocca, una scure, una scarpa sono dotate di
materia e forma; solo che, in questi casi, è la forma che si impone sulla materia e ne configura
l'ordinamento. La materia è scelta sulla base di ciò cui l'oggetto dovrà servire: origine e fine di
questi oggetti risiedono nella usabilità.
Il mezzo ha un nome adeguato alla sua natura: esso è un che di intermedio tra cosa e opera d'arte.
Riposa in sé come la cosa ed è frutto di un'attività umana come l'opera d'arte, ma non possiede né
la caratteristica dell'esser-sorta da sé propria dell'una né l'autosufficienza del suo esser-presente
propria dell'altra. Le scarpe di un contadino sono un mezzo. L'esser-mezzo del mezzo consiste nella
sua usabilità. Le scarpe sono mezzo nella misura in cui vengono calzate e utilizzate nel campo: sono
tanto più mezzo quanto meno si pon mente al loro esser-mezzo, quanto più la coscienza del loro
esser-mezzo si dilegua in chi le usa. Nell'usare il mezzo, la sua usabilità è dimenticata come
costituente la sua essenza. Noi possiamo accedere all'esser-mezzo del mezzo solo quando il mezzo è
sottratto alla sua destinazione, quando l'usabilità che lo fa essere mezzo viene meno. Nell'uso,
l'esser-mezzo del mezzo si risolve nella usabilità; tolto l'uso concreto, l'usabilità attuale, emerge il
mezzo nel suo puro esser-mezzo.
Un siffatto emergere avviene nell'opera d'arte. Quando Van Gogh disegna le scarpe da contadina, le
sottrae al loro concreto impiego e le porta a stare nella stabilità del loro apparire. Nell'opera d'arte,
l'ente si presenta nel suo non-nascondimento [Un-verborgenheit]:
Nell'opera è in opera l'evento della verità. Nell'opera d'arte la verità dell'ente si è posta in opera [...]
Nell'opera è in opera l'apertura dell'ente nel suo essere, il farsi evento della verità [...] L'opera d'arte
apre, a suo modo, l'essere dell'ente. Nell'opera ha luogo questa apertura, cioè lo svelamento, cioè la
verità dell'ente. Nell'arte è posta in opera la verità dell'ente. L'arte è il porsi in opera della verità.19
Quest'idea apocalittica, rivelativa dell'arte corrisponde al senso dello spirituale nell'arte, una
conquista teorica tutta otto-novecentesca. A partire da Cézanne, la luce non illumina più gli oggetti
manifestandoli nella loro semplice presenza (come accade nel Rinascimento e fino a Caravaggio),
ma ne rivela la più intima essenza. La ricerca proustiana e joyciana delle claritates, che svelino la
quidditas degli oggetti, è tutta su questa linea: gli oggetti sono -- o possono essere a certe
condizioni -- epifanie dell'origine.
Ciò che distingue il mezzo dall'opera è il fatto che mentre il primo subordina a sé la materia in vista
dello scopo cui deve servire, nella seconda la materia viene alla luce nella maniera più alta. Solo nel
tempio la pietra dispiega le sue potenzialità essenziali; il pittore non usa la materia colorata, ma fa
sì che essa si esprima, la illumina; il poeta non usa la parola come coloro i quali chiacchierano per
abitudine, ma la conduce a divenire e a rimanere veramente parola.
L'essenza della verità, così come essa si dà nell'opera d'arte, è caratterizzata da un continuo
sottrarsi, da un pertinace diniego. Il sottrarsi non è nulla di negativo, ma, anzi, il principio grazie a
cui la Lichtung può aprirsi in mezzo all'ente. La verità non è mai un nascondimento
definitivamente scovato dal suo riparo, compiutamente dis-velato. La verità si dà solo come
dialettica di Verborgenheit e Unverborgenheit; l'opera d'arte s-vela e ri-vela la verità che in essa è
posta in opera: «Le considerazioni che precedono concernono l'enigma dell'arte, quell'enigma che
l'arte stessa è. Esse sono ben lontane dalla pretesa di sciogliere questo enigma. Ciò che conta è
vederlo».20 Ogni tentativo estetico non può che essere misterioso, poiché l'arte è voce di un
mistero, custodito in quanto tale dalla Terra, che impedisce al mondo aperto ed esposto dall'arte di
perdere la sua «costante inoggettività» e di essere fra-inteso come la totalità della verità disvelata:
«Esponendo un mondo e facendo esser-qui la terra, l'opera è l'attuazione di quella lotta in cui è
conquistato il non-essere-nascosto dell'ente nel suo insieme: la verità».21
Nell'arte, la verità si annuncia in maniera sublime; del sublime fa parte la duplicità, la lotta, la
dialettica: «Il limite estremo del sublime [...] si trova la dove due mondi diversi e congiunti si
separano a un tratto, e un'illuminazione fulminea ci consente di intravederli nello stesso momento,
con un unico sguardo».22
Ogni nostro percorso verso la verità rimane pur sempre un Holzweg che indica il Centro del Bosco,
frammento di una verità non raggiungibile che per intuizione ed allusione, sillaba dell'Unico Lògos
che conferisce senso a tutti i discorsi. La verità, come dialettica fra nascondimento e illuminazione,
e-viene in quanto poetata, si storicizza ponendosi in opera: «la poesia [Poesie] è soltanto un modo
della progettazione illuminante della verità, cioè del poetare [Dichten] nel senso più ampio».23
Tuttavia, la poesia non è solo un'arte fra le altre: il linguaggio istituisce l'Aperto in cui l'ente in
quanto ente è portato all'apparizione. Il linguaggio nominando l'ente, lo fa accedere alla parola e
all'apparizione per la prima volta.24 Il linguaggio è essenzialmente Poesia, in quanto luogo
dell'evento dell'essere dell'ente nel suo aprimento. Esso custodisce l'essenza originaria della Poesia;
pertanto in esso la poesia si realizza: «l'essenza dell'arte è la Poesia. Ma l'essenza della Poesia è
l'instaurazione della verità».25
L'origine dell'opera d'arte è l'arte, nella misura in cui l'arte è essenzialmente origine: l'arte fa
scaturire la verità, la pone in opera con un salto [Sprung] che muove dalla sua provenienza
essenziale: questo risuona nella parola Ur-sprung.
L'essenza dell'arte è detta dall'endiadi goethiana Dichtung und Warheit: l'arte è Poesia, la Poesia è
luogo eminente dell'avvento della verità.
3. Valéry: ispirazione e costruzione
Quel che non si sente, non s'afferra. Ed egualmente
quel che non sgorga con impeto dall'anima,
o che non trascina gli spiriti degli uditori con simpatia profonda di natura.
Ma sicuro: statevene pure a sedere!
Impastate, rimpolpettate insieme gli avanzi dei desinari altrui;
suscitate pure qualche miserabile fiammella dal vostro mucchiettino di cenere!
Sarete la meraviglia delle scimmie e dei ragazzi, dato che ci troviate gusto.
Ma un cuore al vostro cuore non avvicinerete mai,
se quel che dite non viene dal cuore!26
Siamo ora in procinto di compiere un ulteriore passo in direzione della comprensione dell'essenza
della poesia e del suo rapporto con la filosofia. Per ciò fare, ci affideremo a uno dei grandi poeti del
Novecento, Paul Valéry, seguendo l'incedere leggiadro quanto inesorabile del suo saggio su Poesia
e pensiero astratto.27 La positio di questa fondamentale quaestio avviene spesso nella forma della
op-positio: Poesia e Pensiero, come dire Caldo e Freddo, Secco e Umido, Bene e Male.
Ogni parola, perfettamente perspicua allorché si presenti in un discorso ordinario, diviene
«magicamente e stranamente resistente e ingombrante» qualora venga abs-tracta dalla
circolazione, dalla sua dimora in-mezzo al linguaggio. Così, indifesa, la parola può essere soggetta
ai più diversi usi e abusi, finendo per allontanarsi irrimediabilmente dalla sua origine. Si deve
perciò fare attenzione quando ci si presentano innanzi questi due massi erratici (poesia e pensiero
astratto).
Che cosa succede nell'anima di un lirico quando viene sorpreso dall'ispirazione? L'ispirazione, lo
stato poetico, erompe quando la vita momentaneamente esce dal suo ciclo consueto e ne inaugura
un altro, separato e insolito: la vita, per qualche tempo, si affaccia a sé con meraviglia e stupore, per
poi ritornare al regime abituale dell'esistenza, del pensiero e del loro rapporto. Questa ec-stasis
temporanea, questa fuoriuscita dalla normalità, si lascia dietro qualcosa, provoca una «capacità
poetica». Questo salto è indispensabile affinché si dia poesia: non c'è un poeta solo poeta, né un
logico solo logico, ma logici e poeti a un tempo, perché in grado di vivere molte vite entro una
medesima vita.
La Poesia è un dire, appartiene al linguaggio; taluni accostamenti verbali hanno la facoltà di
suscitare un'emozione poetica. Ciascuno degli oggetti circostanti resta lo stesso eppure è diverso, o
stabilisce un diverso rapporto con i modi della nostra sensibilità. Le cose, che punteggiano il
mondo abituale in (non) rapporto monadico l'una con l'altra prendono, a un tratto a corrispondersi
e a richiamarsi in un movimento armonico e musicale: «l'universo poetico così definito presenta
notevoli analogie con l'universo del sogno» (!). Ma siamo solo all'inizio: lo stato poetico, di per sé,
non è sufficiente a fare un poeta, così come sognare un oggetto non basta a garantirne il possesso.
Il poeta non mira a generare entro sé lo stato poetico: sa bene che l'ispirazione è un evento
eccezionale, inatteso, indisponibile; non è il poeta che la (pre) dispone, piuttosto egli è da essa
disposto. Come dice Heidegger: «Non è stato il poeta a escogitarsi la peculiarità della sua poesia.
Gli è stata assegnata. Egli si conforma alla destinazione e segue la vocazione».28 Quello che il poeta
fa è tentare di suscitare lo stato poetico negli altri; ciò che corrisponde esattamente all'idea
kandinskiana dell'arte:
In generale, il colore è un mezzo per influenzare direttamente l'anima. Il colore è il tasto. L'occhio è
il martelletto. L'anima è un pianoforte con molte corde. L'artista è la mano che, toccando questo o
quel tasto, fa vibrare l'anima. È chiaro che l'armonia dei colori è fondata solo su un principio:
l'efficace contatto con l'anima. Questo fondamento si può definire: principio della necessità
interiore. 29
Il poeta si distingue per questo: egli fa del suo lettore un «ispirato». L'ispirazione poetica procura
un ritmo inatteso che afferra e si impone imperiosamente come alcunché di estraneo. Ritmi diversi
si sovrappongono e intrattengono l'un l'altro rapporti cromatici e musicali. Si possono raccontare e
manipolare le idee; non così per la policroma e polifonica varietà dei ritmi inattesi.
Questa esperienza è il fondamento della poesia, ma non è ancora poesia; è, per dir così, condizione
necessaria, non sufficiente. Arte è tèchne, consiste nel trovare strumenti opportuni per comunicare
quella esperienza e farla rivivere ad altri, secondo l'idea per cui l'arte è anche «mezzo in funzione di
un effetto determinato».30 L'arte si compone di due momenti: quello dell'ispirazione e quello
dell'esercizio della tecnica artistica che la restituisce. Il secondo, da solo, non genera che vuote
forme; il primo, da solo non è che il magma di un episodio eminentemente ed insuperabilmente
privato. L'artista senza ispirazione è cieco e sordo, senza tecnica è muto. Ciò che consente a un
artista di stagliarsi in maniera originale sul grande sfondo dell'arte è lo stile, e lo stile è
precisamente l'insieme delle tecniche costruttive di cui l'artista si giova per esporre la propria
ispirazione.
Il linguaggio -- e qui siamo davvero al punto centrale -- può ingenerare due tipi di effetto. Il primo
è quello che mira a realizzare tutte le condizioni che annullano ed esauriscono il linguaggio
medesimo. Se do una istruzione e questa viene correttamente eseguita, le parole che la hanno
causata scompaiono, del tutto trasformate e riversate nel loro effetto pratico concreto. L'esecuzione
di un algoritmo è la sua distruzione. Se quando parlo vengo capito, le mie parole subiscono nella
mente di chi ascolta una metamorfosi in immagini, che possono in seguito essere nuovamente
narrate con un linguaggio totalmente altro da quello che le ha suscitate. Un discorso che ambisca
ad essere compreso è perfetto nel momento in cui ogni parola che lo forma è divenuta altro. Nella
veste pratica del linguaggio, le sue forme non sopravvivono alla comprensione, ma vi si dissolvono.
Il secondo effetto del linguaggio si ha quando la forma, nonché esaurirsi, «acquista un'importanza
tale da imporsi all'attenzione e da farsi, in qualche modo, rispettare». In musica, sussiste una
differenza sostanziale tra rumore e suono: il rumore presenta alla nostra mente un avvenimento
isolato -- un cane, una porta, un'auto; il suono, invece, segna l'inizio di un mondo: evoca l'universo
musicale nella sua totalità. Il poeta è in svantaggio rispetto al musicista, poiché il suo unico
strumento è il linguaggio. La parola non è che un provvisorio connubio di suono e senso. Un
discorso straordinariamente sensato e logico può essere affatto privo di ritmo. Reciprocamente,
una ridda assolutamente assurda di parole può essere dotata di un ritmo superbo.31
Il poeta è come un bambino il quale, dopo avere imparato a camminare, scopre che le proprie
membra possono organizzarsi anche per dar vita a quella forma di movimento che è la danza. La
marcia è alcunché di monotono e invariabile; la Danza, invece, serba in sé infinite possibilità di
creazioni, variazioni e figure. Il poeta scopre a poco a poco che il linguaggio non si dà nella sua
mera declinazione pratica.
Il linguaggio pratico (o della prosa) è intenzionato verso un preciso scopo; alla stregua di una
marcia, esso vi si dirige in modo rettilineo e senza deflessioni di sorta. Il linguaggio poetico, invece,
è un insieme di atti che hanno il loro fine in sé. La poesia non è nulla come una marcia che proceda
inarrestabile verso una determinata destinazione, ma è come una danza che non va in luogo
veruno. La danza si serve pur delle membra, come la marcia, ma con un fine e un esito diversi. La
poesia si serve delle parole, ma conferisce loro una funzione e un valore altri da quelli che vengono
loro comunemente assegnati dalla prosa. Poesia e prosa si differenziano non già e non tanto in
forza del materiale e degli strumenti di partenza di cui dispongono, che sono in fondo i medesimi,
quanto in virtù delle associazioni che creano e istituiscono tra essi.
Quando l'uomo marcia, annulla l'atto nella sua totalità con il raggiungere lo scopo che perseguiva:
l'effetto fagocita la causa, il fine assorbe il mezzo; dell'atto non resta che il risultato. Il linguaggio
pratico non ha altro scopo che di annullarsi, trasformandosi in comprensione ed esecuzione. Dal
proprio perire ottiene testimonianza della sua efficacia. Il discorso è totalmente sostituito dal
significato, il fine di questo linguaggio è la fine: esso sorge come già destinato alla morte. Sua
perfezione è l'autodistruzione: consummatun est.
La poesia, come l'araba fenice, perennemente rinasce dalle proprie ceneri, e viene ogni volta
reintegrata nella sua forma danzante. Il suo andamento è circolare, come La danza di Matisse
(1909-'10), di contro alla rectitudo della prosa. Giammai si esaurisce; sempre torna a danzare:
resurrexit. Con tutto ciò, non si può ipotizzare una decisione radicale tra poesia e filosofia:
Ogni vero poeta sa condurre con rigore un ragionamento ed elaborare pensieri astratti [...] La
filosofia più autentica non risiede negli oggetti della nostra speculazione, quanto invece nell'atto
medesimo del pensiero e nella forma della sua attività.
Nondimeno, la poesia si colloca a un livello più alto, in quanto dice l'ispirazione originaria che la ha
causata con un linguaggio parimenti originario.
4. Novalis: sogno, poesia, essenza dell'arte
Nella terra buia riposa il santo straniero.
Un dio gli colse il lamento dalla bocca soave
Quando cadde nel fiorire degli anni.
Fiore azzurro
Vive ancora il suo canto nella casa notturna dei dolori.32
Novalis nasce come filo-sofo: ama il sapere in maniera quasi morbosa: «Non vi è gioia più grande
che quella di comprendere tutto, di trovarsi dovunque come a casa propria, d'intendersi d'ogni
cosa, di cavarsi d'impiccio dovunque sia» (13) .33 Egli cerca il libro ideale («Il mio primo libro deve
diventare una Bibbia scientifica, un modello e germe reale e ideale di tutti i libri», 10), ossia quel
libro che Borges,34 Calvino35 e altri36 ritengono naturaliter introvabile.37 Non è affatto un puro
caso che il dire di Novalis sia sempre frammentario; non è legato al mero accidente della sua morte
prematura il fatto che quasi tutte le sue opere siano incompiute. Solo le due brevi raccolte poetiche
più celebri (Hymnen an die Nacht e Geistlische Lieder) sono, in qualche modo, finite. Ma la poesia
è quintessenzialmente non-finita, la parola poetica è in sé frammentaria, anche quando assume
una forma de-finita e determinata.38
La verità è che l'opera novalisiana è strutturalmente incompibile. Novalis va alla ricerca di un
metodo enciclopedico (5 sgg, 352 [!], 356) che consenta di radunare e sussumere tutto il sapere, ma
il suo impegno viene sistematicamente frustrato. È davvero così?
Anche Hegel cerca l'enciclopedia; e non deve certo alla lunghezza della sua vita rispetto a quella di
Novalis (nasce due anni prima e gli sopravvive di trenta) il fatto di averla, oltre che cercata, anche
trovata. Per Hegel, il sapere filosofico o è enciclopedico o non è. Egli ostracizza il tema della
finitezza, che aveva informato tutta la critica kantiana (limitatezza sul piano teoretico, amoralità su
quello pratico) 39: il fatto stesso che la ragione veda il limite testimonia la sua capacità di
tematizzarlo e, riconoscendolo, superarlo. La filosofia è la prospettiva divina: o è vera del tutto o
non lo è affatto. Non c'è una verità parziale; questo binomio è logicamente contraddittorio: il vero
è l'intiero. La comprensione che la filosofia ha come proprio tèlos è totale e totalizzante: la filosofia
si qualifica come sapere assoluto. Come si potrebbe ravvisare il limite senza essersi già posti in una
dimensione ulteriore rispetto al limite medesimo? L'assolutezza è il presupposto da cui la filosofia
sorge e che richiede di essere esplicitato. Il lungo, faticoso e doloroso cammino della
Fenomenologia dello Spirito non è altro che l'esperienza del raggiungimento dell'autocoscienza,
ossia della coscienza della assolutezza del proprio sapere, e -- il che è lo stesso -- del sapere tout
court; è il duro cimento del soggetto che via via sottrae autonomia all'oggetto, erodendo la sua
realtà in quanto estranea: al termine del suo percorso, il sistema filosofico è completo, privo di
residui non tematizzati, assoluto. La filosofia è un colosso onnivoro e onnicomprensivo, è il Tutto.
Enciclopedia, per Hegel, non significa altro che questo: il sapere è circolare, chiuso su se stesso,
autoreferenziale. Ogni punto è un inizio, non c'è un fondamento. La filosofia sorge da sé e su di sé
finisce; il suo centro generatore è interno, immanente. La filosofia è rigorosamente coerente perché
rispecchia un mondo coerente e governato dalla Ragione. Quando, infine, la Ragione è compresa
nella sua astuzia, allora essa è compresa tout court. Al limite, il Lògos Assoluto si risolve nelle
determinazioni del lògos umano (scil.: filosofico).
È vero che, nelle intenzioni, il sistema hegeliano dovrebbe rendere conto di una realtà diveniente
ed essere, ipso facto, altrettanto mobile e dinamico. Ma il divenire, come suprema legge
dell'essere,40 finisce per tradursi in una stabilità radicale. Se il divenire, così come si configura
nella Wissenschaftlehre, non è il passare dell'essere nel nulla e viceversa, ma il reciproco esser-già
passati l'uno nell'altro, ne viene che il movimento, a causa della sua estrema rapidità, si tramuta in
quiete assoluta, la stàsis si pietrifica in stasi; la lotta, esacerbata nel suo travaglio, diviene pace, una
pace che blocca ogni possibile sviluppo ulteriore; la fluidità dei concetti, di cui parla Bloch, 41 si
congela. Il sistema dinamico dei propositi iniziali diventa un sistema statico, rigido e chiuso, già
deciso ab origine, quantunque non ancora compiutamente saputo dal soggetto.
Nulla di tutto questo in Novalis. La sua enciclopedia è per vocazione e per struttura un sistema
aperto; il suo stile frammentario non è uno spiacevole inconveniente, ma l'essenza intima del suo
dire poetico:
I frammenti sono schegge di un Tutto (mancato) [...] [essi] non sono in grado di rappresentare
questo tutto. E rappresentano indirettamente questa assenza -- come l'Irrappresentabile -attraverso la reciproca -- ironica -- negazione, correggendo in questo modo esteticamente la cattiva
particolarità che li rende assoluti mancati [...] Novalis si muove sul sottile spartiacque fra il parlare
intenzionale e la visione dell'impossibilità di cogliere, attraverso di esso, ciò che propriamente
ritiene degno di essere detto. Il Monolog risolve questo paradosso -- esprimere, nonostante tutto,
l'inesprimibile -- nel momento in cui si volge alla ricchezza semanticamente indominabile della
poesia. Solo un messaggio che non corra il rischio di essere esaurito da alcuna interpretazione
pensabile potrebbe offrirsi come allegoria dell'Assoluto.42
Non si deve prendere troppo alla lettera Novalis, allorché dice di voler costruire una sintesi
completa di tutto il sapere. I suoi frammenti sono come quelli postumi di Nietzsche: si negano l'un
l'altro, e il loro senso più alto sta proprio in questa contradditorietà: «Creazione di frammenti
mutilati a dimostrazione che il fondo di tutte le opinioni efficaci e di tutti i pensieri efficaci del
mondo quotidiano è costituito da frammenti» (269).
Neppure a Novalis riuscì di rinvenire quel centro la cui indefessa e disperata ricerca afflisse Musil
per tutta la vita43: «Sono troppo alla superficie; non ho una vita quieta, interiore -- un nocciolo -che agisca dal di dentro, da un centro, ma alla superficie, a zig-zag, orizzontalmente, con
irrequietezza e senza carattere, gioco, caso, non effetto di leggi, né traccia d'indipendenza,
manifestazione di un unico essere» (17). Peraltro, la frammentarietà è la cifra stilistica di tutto il
Novecento letterario44: come dice Saul Bellow -- attraverso Moses Herzog -- il pensiero non può
svegliare dal sonno dell'esistenza se non smaschera «l'illusione delle spiegazioni totali».45
I frammenti di Novalis non sono aforismi: considerarli tali significherebbe fraintendere e perdere
l'autenticità del suo poetare. L'aforisma è una precisa struttura stilistica dotata di due caratteri
fondamentali: autosufficienza e autoconclusività. Gli aforismi sono monadi compiute in se stesse.
Il frammento, invece, è per definizione insufficiente a se stesso e non concluso. Löwith ha definito
la filosofia di Nietzsche un sistema di aforismi;46 ma essa né è un sistema né è costituita -- nella
sua dimensione più rilevante -- da aforismi; anzi, forse neppure può essere definita «filosofia».
Fondamentalmente, non può essere affatto de-finita. Il meditare nietzscheano è in-definito per sua
natura, poiché il suo pondus (ammesso che sia dato trovarlo) risiede nei frammenti postumi, cioè
nel non pubblicato e, al limite (ha ragione Heidegger), nel non detto.47
Il significato del frammento sta proprio nella sua complessione cagionevole e deficitaria: solo in
quanto è lacero, interrotto, carente, senza capo né coda; solo qua talis può essere essenzialmente
simbolico; solo in quanto incoerente può rinviare alla fonte di ogni coerenza, solo in quanto povero
può invocare la sorgente di ogni pienezza e ricchezza. I frammenti stanno tra loro in una sin-fonia
provvisoria, labile, aleatoria, che, proprio nella e per la sua prossimità al nulla, indica l'armonia
universale garantita dal Silenzio originario che possibilizza ogni dire e ogni cantare.48
Novalis ha tenuto mano sempre ad un'unica opera, e non ha mai prodotto (né avrebbe mai potuto
produrre) altro che frammenti. Se comprendiamo questo, acquistiamo a un tempo dimestichezza
col fondamento poetico di tutto il suo dire. Solo la perenne e perennemente irrisolta dialettica di
finito e infinito può conferire alla dimensione simbolica la pienezza di significato che le compete. È
esattamente nel conservarsi dinamico di questa dialettica che il simbolo mantiene il suo senso. Se
si desse definitiva Aufhebung della dialettica, crollerebbe eo ipso l'intero edificio poetico. La
filosofia hegeliana, dal punto di vista di Novalis, segna la morte senza resurrezione della poesia.
Certo, anche per Novalis, come per Hegel, fare filosofia è dire l'Assoluto; ma per il secondo,
filosofia è sapere assoluto nel senso che è sapere l'Assoluto: l'Assoluto è compiutamente risolto
nelle e dalle categorie della ragione; o, se si preferisce, la ragione assurge alla coincidenza con
l'Assoluto. In Novalis, di contro, l'Assoluto è detto e saputo sempre e soltanto come l'inoggettivabile
e non presentabile assente; la abissale prossimità dall'Assoluto è detta nella forma della
lontananza. Non c'è tentativo di comprehensio; Novalis non vuole penetrare il mistero per
spiegarlo e illuminarlo, ma è consapevole del fatto che esso può essere saputo unicamente qua
mysterio. Compito insuperabile della poesia è esibire la natura irriducibilmente misteriosa del
Mistero.
«La poesia è il reale, il reale veramente assoluto. Questo è il nocciolo della mia filosofia. Quanto più
poetico, tanto più vero» (1186). E ancora: «Il filosofo diventa poeta. Il poeta è solo il grado
supremo di colui che pensa» (70). Pensare, per Novalis, è rapportarsi alla fonte del pensiero
medesimo; pensiero è rapporto con l'origine; la dimora di Iside, signora di Sais e custode della
verità, si trova risalendo il corso del fiume: questa è l'indicazione che i fiori danno a Giacinto.49
Filosofia è riflessione sulla condizione di possibilità del pensiero: «La filosofia non deve spiegare la
natura, deve spiegare se stessa» (36). La poesia sorge dall'intuizione dell'originaria appartenenza
alla fonte. Novalis evoca la sorgente di quella che Valéry chiama ispirazione poetica:
Ci sono in noi poemi che sembra abbiano un carattere del tutto diverso dagli altri, poiché sono
accompagnati dal sentimento della necessità, eppure non hanno alcun motivo esteriore. L'uomo ha
l'impressione di trovarsi in una conversazione e che qualche ente spirituale e ignorato lo induca in
maniera arcana a sviluppare i pensieri più evidenti. Questo ente dev'essere un ente superiore
perché entra con lui in una specie di rapporto che non è possibile per nessun ente legato a
fenomeni. Dev'essere un ente omogeneo perché tratta l'uomo come un ente spirituale e lo esorta
soltanto alla più rara attività personale [...] Descrivere non si può questo fatto. Ciascuno lo deve
vivere da se stesso (27. Il corsivo è mio).
L'esperienza dell'ispirazione è ineffabile e personale. Il senso poetico si sveglia nell'uomo allorché
questi percepisce la presenza di un mondo ulteriore da cui tutto viene e a cui tutto deve il suo
senso. La poesia è l'essenza del mondo come per Schopenhauer (e poi per Proust) lo è la musica.50
D'altra parte, «per Novalis la musica rappresenta il limite a cui tende la poesia per raggiungere la
sua totale liberazione, cioè il puro arabesco, in cui si disvela simbolicamente la struttura dell'essere
al di fuori di ogni determinazione linguistica e concettuale».51
La parola mira a purificare se stessa onde giungere a dire nel modo meno inadeguato il ritmo che si
dispiega nel mondo e lo costituisce:
il poeta è colui che intona la sua parola al ritmo di questo spirito poetico universale [il quale
rappresenta il nesso che collega le infinite apparenze del molteplice in una totalità, retta da
un'unica legge], immedesimandosi con esso e seguendolo nel suo fluire, che lo conduce nel segreto
di tutte le forme e di ogni divenire [...] Una poesia intesa in tal modo è sempre protesa verso
l'infinito oltre le distinzioni e i limiti delle forme finite.52
Il poeta si fa voce dell'essere nel suo eventuarsi come Poesia; la sua parola viola le leggi del lògos
apofantico e si costituisce come lògos apofatico. La poesia abolisce la sintassi tradizionale e ne
istituisce una nuova che consenta di giovarsi della intera ricchezza semantica potenziale del
linguaggio. Il pregiudizio razionalistico della necessaria univocità del linguaggio, sulla base del
quale Spinoza ha assimilato la profezia al delirio di un folle,53 è da Novalis rigorosamente
proscritto.
Ogni rivelazione avviene tramite segni. Si rammenti il celebre frammento 22 B 93 DK di Eraclito:
«Il signore, il cui oracolo è a Delfi, non dice e non nasconde, dà segni (oute lègei oute kryptei, allà
semàinei)». L'Apocalisse, nel suo particolarissimo andamento sintattico -- che rendo qui con una
versione letterale -- si apre con parole decisive, sotto questo profilo: «Apocalissi di Gesù Cristo, che
Dio gli diede perché fosse mostrata ai suoi servi, le cose che devono accadere in fretta, e [che Gesù
Cristo] esèmanen»: la traduzione «manifestò» è errata. La comunicazione della rivelazione (apòkàlypsis) avviene attraverso segni (sèmata), da cui la necessità del linguaggio simbolico per
esprimerla. Il simbolo è richiesto dalla natura stessa della rivelazione, che non è mai palese ma solo
ac-cennata.
La Poesia è il ritmo essenziale della Natura (l'idea romantica di Natura è, nel suo significato, molto
più prossima alla Physis greca che non alla Natura cartesiana o galileiana);54 ma il suo
presentimento da parte del poeta si qualifica come ritmo inatteso. Il poeta, cioè, non è, per così
dire, in costante stato di grazia. L'ispirazione è un evento, alcunché di eccezionale.
Comunemente si ritiene che Heidegger si collochi in una posizione di alterità rispetto a Platone, il
quale, nella Repubblica, condanna l'arte mimetica, in quanto distante di due gradi dall'idea (X,
595A -- 598D). Ma qui Platone se la prende, appunto, con la deriva «realistica» dell'arte, intesa
come riproduzione fedele, mìmesis, di un oggetto, non con l'arte nella sua espressione più alta.
Questa, nel Fedro (244A -- 245B), si chiarisce come mania, ovvero come enthousiasmòs:
In terzo luogo viene l'invasamento e la mania che proviene dalla Musa, la quale, impossessatasi di
un'anima tenera e pura, la desta e la trae fuori di sé nella ispirazione bacchica in canti e in altre
poesie [...] La poesia di chi rimane in senno viene oscurata da quelli che sono posseduti da mania.
Dunque l'ispirazione è un'esperienza ineffabile, incomunicabile, personale, elargita dal dio
(eventualmente attraverso il dàimon). Il poeta intuisce l'essenza intima (scil.: poetica) della realtà.
L'ars poetica consiste nel restituire con linguaggio opportuno (o col meno inopportuno) tale
intuizione: «poetare è generare» (1188). Il poeta diviene veramente «il novello Re Mida» che tutto
trasfigura di cui parla Ladislao Mittner:
Non il poeta fa la poesia, ma la poesia che è diffusa in tutto l'universo ed è l'anima dell'universo fa il
poeta, il quale, simile al rabdomante, scopre dappertutto le particelle di poesia nascoste nella
natura.55
Lo stato poetico cambia la vita: esso trasforma in profeti che recano il verbo inattuale dell'essere
che si annuncia. L'ispirazione è un dono che proviene dalle remote regioni del Sacro e che è
suscitato dagli eventi significativi della vita dell'uomo. Per Novalis, l'evento fondamentale che ha
destato l'ispirazione è costituito dalla morte. Fu la morte dell'amata Sophie von Kühn a far
scaturire nell'anima del poeta la nostalgia per quel mondo verso il quale ogni pensiero
rammemorante («Il ricordo ci apparirà come un presentimento necessario», 546) si sente
irresistibilmente attratto. Sophie fu rapita agli alti spazi della Notte, dove regna una luce spirituale
rispetto a cui quella del nostro giorno non è che un pallido bagliore, timida bragia fumigante.
Paragonato alla pienezza della notte, il giorno in cui Novalis resta suo malgrado (anche se a poco a
poco recupererà il desiderio di vivere, ciò che peraltro farà vieppiù aumentare il suo senso di colpa
nei confronti di Sophie) non è che un misero nulla, la sua fecondità e la sua vita non sono che
sterilità e morte, la sua serenità e la sua pace non sono che inquietudine e travaglio. Solo nel
mistico incontro con la Notte il dolore può trovare requie, solo la nuova vita può placare la
malinconia del cuore. La morte trasfigura e dona nuova vita, la notte illumina e apre un nuovo
mondo, la terrestre lacerazione trascolora in beatitudine celeste.
Nell'Atto secondo del Tristan und Isolde, Wagner rende in poesia e in musica la dialettica di giorno
e notte. La Scena prima esordisce col Tagesmotiv, un tremolo d'archi intenzionalmente rozzo e
adusto (il direttore deve premurarsi di farlo eseguire così all'orchestra). Brangäne tenta di
persuadere Isolde a non incontrare Tristan, perché Melot non attende altro che un'occasione per
coglierli in flagrante e poterli così denunciare a Marke. Ma Isolde è completamente in balia di Frau
Minne -- l'amore cantato dai Minnesänger medievali -- e vede la realtà con occhi diversi rispetto
alla sua fedele serva (la fanfara di caccia le sembra il dolce mormorio della fontana). Il suo unico
pensiero è smorzare la fiaccola (il segnale per Tristan), spegnere il scheuchende Schein (v. 903), lo
«splendore allontanante». La luce confina in solitudine e lontananza Frau Minne; è il principio
della separazione.
Nella luce tutti i limiti sono chiaramente tracciati, in essa trionfano i valori ordinari della società
feudale. Nella notte, tutto è straordinariamente confuso, passibile di profonda e completa unità.
Isolde è disposta a tutto pur di spegnere la torcia e, nel nome di Frau Minne, lancia impavida al
giorno la sua sfida (vv. 1039-1040). Tristan, a sua volta, scaglia contro il tückischen Tage (il
«fraudolento giorno») una furiosa invettiva: «Al più crudele dei nemici / odio e accusa! / Come tu
la luce, / oh potess'io la fiaccola, / per vendicare i dolori dell'amore, / al prepotente giorno
spegnere» (vv. 1043-1048).56 Egli vorrebbe eliminare per sempre il giorno e calarsi in una
perpetua notte. Isolde addita il giorno come origine di ogni frode (e rammenta l'inganno perpetrato
ai suoi danni da Tristan in Irlanda). Tristan ribadisce il carattere distanziante del giorno: «nella
chiara luce del giorno, / come poteva Isolde esser mia?» (vv. 1031-1032).
Dal v. 1106, la cesura musicale è evidente: fin qui si è parlato del giorno, e lo stile ha mantenuto un
andamento procelloso e ansiogeno. Di repente, all'apparire della parola Nacht, tutto muta, e
l'atmosfera si fa placida e soave. Da questo momento, le parole Tag e Nacht, col loro esser
pronunciate, segneranno l'avvicendarsi dei due stili opposti. A un certo punto, il tema della notte e
quello della morte si legano esplicitamente (vv. 1186-1201). Segue l'attacco finale di Tristan al
giorno (vv. 1219-1245), che si conclude con uno splendido duetto (il cui senso è riassumibile con la
parole del fliegende Holländer: «Ew'ge Vernichtung, nimm mich auf!», v. 84), al termine del quale
i due amanti non possono che perdersi nella plenitudine dell'estasi (così recita la didascalia: «T
und I versinken wie in gänzliche Entrücktheit»).
Forse che il sopravvenire della morte non rimuoverebbe per sempre anche l'amore? Non certo! Per
Tristan, la morte non fa che eliminare tutti i meschini impedimenti che ostacolano l'eternità
dell'amore: «Che cosa soccomberebbe alla morte, / se non quel che ci disturba, / se non quello che
impedisce a Tristan / di amare sempre Isolde, / e di vivere eternamente per lei?» (vv. 1347-1351)
.57
La Stimmung che pervade l'opera wagneriana è assai prossima a quella diffusa negli Hymnen an
die Nacht di Novalis.58 L'esperienza di cui il primo inno ci dà contezza è quella di una pasqua, di
un passaggio dalla tristezza della morte alla rivelazione della Notte. Dapprima, non si ha che la
coscienza della fine, l'accorgimento della desolazione che la morte reca:
Lontano giace il mondo -- / perso in un abisso profondo -- / la sua dimora è squallida e deserta. /
Malinconia profonda / fa vibrare le corde del mio petto. / Voglio precipitare / in gocce di rugiada /
e mescolarmi con la cenere.59
Quando il giorno finisce, pare destinato a non più ritornare. I toni dominanti sono cupi, le tinte
fosche. Ma ecco che la notte rivela il suo viso «devoto e soave» e si dimostra ben più preziosa del
giorno:
Che cosa a un tratto zampilla / grondante di presagi / sotto il cuore / e inghiottisce la molle brezza
/ della malinconia? / Da noi derivi a tua volta piacere, / o buia notte? / Quale cosa tu porti sotto il
manto / che con forza invisibile / mi penetra nell'anima? / Delizioso balsamo / stilla dalla tua
mano, / dal mazzo di papaveri. / Le gravi ali dell'anima tu innalzi. / noi ci sentiamo oscuramente e
ineffabilmente turbati -- / con gioioso spavento / vedo un volto severo / che su di me si china /
dolce e devoto, / e svela tra i riccioli / senza fine intrecciati / la cara giovinezza della madre.
Dopo che la Notte ha palesato il suo volto, gli splendori del giorno («die Wunderlichkeit des
irrdischen Reichs») smarriscono il loro incanto. Prima sembrava che nulla di più alto ci fosse della
luce del giorno e della vita terrena; ora, la vera realtà è evidentemente quella della notte, rispetto
alla quale luce e vita non sono che mere parvenze, ingannevoli simulacri:
Come infantile e povera / mi sembra ora la luce -- / come grato e benedetto / l'addio del giorno -- /
Solo perché la notte distoglie / e allontana da te i tuoi fedeli, / tu seminasti per gli spazi immensi /
le sfere luminose, ad annunziare / l'onnipotenza tua -- / il tuo ritorno -- / nel tempo della tua
lontananza. / Più divini / delle stelle scintillanti / ci sembrano gli occhi infiniti / che in noi la notte
dischiude.
La notte desta in noi sensi che erano ottusi, occhi e orecchie che possono percepire una luce e una
musica qualitativamente più alte. Sophie diventa l'angelo della Notte; sottratta al poeta nel corpo,
gli è restituita in Spirito, come messaggera della Verità:
Lode alla regina del mondo, / alta annunciatrice / di mondi santi, / custode del beato amore, / che
a me ti manda -- / tenera amata -- / amabile sole notturno, -- ed ora veglio -- / sono Tuo e Mio -- /
la notte mi annunziasti come vita -- mi hai fatto uomo -- / consuma con l'ardore / dell'anima il mio
corpo, / perché lieve nell'aria / con te più strettamente io mi congiunga / e duri eterna / la notte
nuziale.
La scoperta di una dimensione trascendente non implica il contemptus di questa realtà: è possibile,
per Novalis, vivere in modo sovrasensibile una vita sensibile. E, di fatto, dopo la morte di Sophie,
egli si trovò a condurre una sia pur breve doppia vita: quella in Cielo accanto a Sophie, e quella in
terra, con Julia von Charpentier.
L'antitesi notte/giorno si esprime anche in quella analoga sonno/veglia. Nel secondo inno, il sonno,
nella misura in cui libera dalla frenesia della veglia e dalle cure del giorno, rigenera una vita più
profonda in noi e garantisce l'apertura di mondi misteriosi e superiori:
Deve il mattino sempre ritornare? / La potenza terrestre avrà mai fine? / Consuma un vano
affaccendarsi il volo / celeste della notte. E mai l'offerta / segreta dell'amore / arderà in eterno? /
Fu misurato alla luce il suo tempo; / ma il regno della notte è senza tempo / e senza spazio. -Eterno dura il sonno. / Sonno santo -- / non fare troppo raramente lieti / i consacrati alla notte / in
questa terrestre / quotidiana fatica [...] uscita da antiche leggende / tu avanzi e schiudi i cieli, /
portando la chiave / dei soggiorni beati, / silenzioso araldo / di misteri infiniti.
L'eternità si rivela non nella veglia ma nel sonno; chi veglia anela al sonno come sua liberazione in
senso forte. Il sonno è l'unico vero fine. Ma la triste e faticosa vicenda terrena riprende a ogni levar
di Sole; sicché il desiderio del sonno trascende se stesso in direzione della sua versione eterna: è il
quarto inno:
Ora so quando sarà l'ultimo mattino -- quando la luce non mette più in fuga la notte e l'amore -quando eterno sarà il sonno e un solo sogno inesauribile.
Il terzo, meraviglioso inno è, ancora, il luogo del passaggio; in esso la natura mistica della
rivelazione, che rende partecipi della beata superiorità della notte di contro all'amarezza dolorosa
della vita diurna, è poetata nella guisa più sublime. L'epifania coglie il poeta in un momento di
dolore, angoscia e solitudine estremi; egli è gettato bocconi innanzi alla miseria della propria
esistenza, paralizzato dallo sgomento:
allora venne dalle azzurre lontananze -- dalle altezze della mia antica beatitudine un brivido
crepuscolare -- si spezzo d'un tratto il vincolo della nascita -- la catena della luce. Svanì la
magnificenza terrestre e il mio lutto con lei -- confluì in un mondo nuovo e impenetrabile la
malinconia -- e tu, estasi della notte, sopore del cielo scendesti su di me -- la contrada lentamente si
sollevò; e sulla contrada aleggiò il mio spirito nuovo, liberato.
La fascinazione esercitata dal mondo della luce su Novalis è molto intensa. Ma egli «ne è il cantore
di tanto più efficace in quanto egli è soprattutto il cantore della notte».60
La luce è regina di tutte la meraviglie che il quarto inno magnifica, ma è altresì l'agente che fa
emergere ansia, infelicità, inquietudine; essa fonda un mondo che è essenzialmente mutevolezza,
instabilità, transitorietà, lotta, divisione, morte. Pertanto non è la luce la vera patria dell'uomo; solo
il volto della Notte è heimlich. Solo la notte è eterna e senza tempo. La luce è feconda, ma la notte lo
è di più; questa è veramente feconda, poiché è l'origine della luce medesima:
Tu l'hai adornata / di colori e lievi contorni -- / o fu lei che diede / significato più alto e più caro /
alla tua grazia? / Quale voluttà, / quale godimento offre la tua vita, / che in fascino equivalgono / ai
rapimenti della morte? / Non porta i colori della notte / tutto quanto ci esalta? / Lei ti porta /
maternamente, / e tu le devi tutta la tua gloria. / Svaniresti in te stessa -- / nell'infinito spazio / ti
sperderesti, / se lei non ti tenesse, / né ti serrasse, / così che calda, accesa, / con la tua fiamma
generassi il mondo.
La luce proviene dall'inesauribile abisso della notte, a cui l'uomo è, nella sua essenza, coeterno. La
luce è nata e, come tutto ciò che nasce, perirà. Allora l'uomo, che era stato deputato dalla notte a
consacrare il mondo della luce mediante la propria opera, tornerà a congiungersi con la sua Grande
Madre. Ciò avverrà quando l'uomo avrà spiritualizzato e umanizzato il mondo nella sua totalità:
l'uomo è il tramite per la redenzione del mondo.61
Il poeta, che ha avvertito la ricchezza della notte, vive il resto della sua esistenza terrena nello stato
d'animo che dà il titolo al sesto inno: Sehnsucht nach dem Tode. Ogni mattino pone termine
all'estasi del sonno; ma giungerà l'ultimo mattino, in cui il Sole persisterà nel suo riposo e il giorno
non nascerà: la pace della notte continuerà, eterna. L'attesa di questo tempo sarà all'insegna della
serenità, giacché confortata dalla rivelazione notturna: «Egli viveva nel mondo dell'al di là, che era
realmente la patria del suo cuore».62 Il poeta canta la notte oscura da cui tutto viene, la fonte cui
tutto è destinato e vocato a riedere: il dire poetico più autentico è prossimo al silenzio, a quel
Silenzio originario da cui ogni parola scaturisce.
Nella storia dell'uomo, la rivelazione notturna ha acquisito un nome: sogno. Dopo Freud, siamo
soliti considerare il sogno nulla più che l'espressione delle nostre pulsioni represse che, da qualche
parte dovendo pur emergere, approfittano della momentanea latenza del controllo razionale per
esibirsi. Ma il sogno ha una valenza simbolica potentissima, che ai giorni nostri ha rilevato, fra gli
altri, Pavel Florenskij. Nella Germania di fine Sette e inizio Ottocento, a introdurre e studiare la
natura profetica del sogno è stato Jean Paul. Ciò che più gli preme è chiarire la contiguità di sogno
e poesia.63 Anche per lui, come per Novalis, poesia e sogno sorgono da una rivelazione, e,
precisamente, dalla rivelazione del mondo soprannaturale. Egli ricevette questa divina intuizione
in un tempo e in un luogo determinati (e determinanti): il 15 novembre 1790, a Schwarzenbach.
L'immaginazione e il sogno, secondo lui, non sono affatto uno sbiadito riverbero dei sensi, come
sostengono le scuole materialistiche, sulla scorta di Helvétius. Essi sono invece conseguenza del
senso d'infinito e della brama di Assoluto che albergano in noi e che sono momentaneamente
ricompensati con pegni che attendono di essere integrati nella vita futura. Tali pegni sono, per
l'appunto, i sogni. Sogno e poesia sono frutto della magia dell'immaginazione:
Nel sogno come nella poesia, la verità non ci giunge affatto dal mondo dei sensi: essa sembra
parlare dal nostro stesso cuore, ma è la voce di Dio. Il poeta è passivo, e così il sognatore; entrambi
ascoltano il linguaggio ispirato della propria anima. Lo spirito del poeta è contemplativo, aperto
alle rivelazioni della profondità, al linguaggio dell'inconscio. La nostra coscienza è illusoria, tutto il
mondo della veglia non è più vero di quello dei sogni; è la celebre 'ironia'dei romantici, per i quali
la vita è un gioco, un sogno del creatore; la verità è altrove, e il poeta è colui che gioca con gli
oggetti del mondo esterno, conferendo loro un valore simbolico, ricreandoli per un'altra verità. 64
Le rivelazioni e le esperienze mistiche vengono sempre in momenti di sonno o di dormiveglia, ossia
di totale o parziale sospensione della vigilanza razionale.65 Anche la vicenda di Heinrich von
Ofterdingen è inaugurata da un'esperienza onirica. Il centro del capolavoro novalisiano è costituito
dal tema del viaggio iniziatico. Non si dimentichi che Novalis era un profondo conoscitore ed
estimatore della tradizione alchemica, la quale svolge un ruolo fondamentale in tutta la sua
opera.66
Secondo uno stilema che sarà assunto e volto in chiave tragica dall'espressionismo, nulla di quanto
descritto o narrato nel romanzo ha un carattere realistico in senso stretto. La realtà di cui si tratta è
sempre e solo quella dell'interiorità del protagonista: l'iniziazione è ricerca di sé. Tutti gli elementi
del racconto non sono che aspetti oggettivati dell'anima di Heinrich contemplata nel suo crescere.
Ogni evento è da lui in qualche modo presagito: tutto è una potente metafora del suo io. Con ciò,
non siamo in presenza di un soggettivismo o di uno psicologismo radicali: in Novalis, l'io non pone
se stesso assolutamente, ma si trova e si realizza nella misura in cui riconosce che la propria verità
è altrove. L'esprimersi dei personaggi (al di là della preponderanza del protagonista, il romanzo è
un capolavoro di polifonia, in senso bachtiniano) è oscuro e faticoso nel momento in cui essi sono
ignari della dimensione trascendente che li fonda, diviene chiaro e agile allorché si accompagna
all'avvertimento di quella Unerkannte, di «quell'unica [...] che nessuna pensò mente mortale / e
nessuna virtù ha conquistato»,67 di quella fonte da cui tutto viene.
Il percorso di Heinrich, come dicevamo, è aperto da un sogno: il fiore azzurro (die Blaue Blume) ne
è l'oggetto. Il tema dell'azzurro è abbastanza frequente nella lirica ottocentesca. Lo ritroviamo, ad
esempio, in Mallarmé, il quale dichiarava di esserne addirittura ossessionato. In una lettera a
Cazalis del 1864, a proposito della poesia L'Azur, dice:
L'azzurro tortura l'impotente in genere [...] Voglio fuggire ancora, ma intuisco il mio torto e
confesso di essere ossessionato. Era necessaria tutta questa straziante rivelazione per motivare il
grido sincero e incongruo della fine, l'azzurro.
Nei suoi componimenti giovanili, l'Azzurro è una dimensione iperurania in cui egli vorrebbe
rifugiarsi per emanciparsi dalla realtà che lo nausea (Les fenêtres). Anche il simbolo del fiore
(«l'azur des corolles» di Apparition) è centrale: i fiori sono messaggeri dell'Assoluto, sue
manifestazioni in terra, veicoli di contatto con esso in quanto partecipi della sua essenza
sovrumana. Essi recano notizia del supremo nulla che l'assoluto contiene («le gouffre» di
Baudelaire: «Et mon esprit, toujours du vertige hanté, / Jalouse de néant l'insensibilité») e del
dono della morte, estrema consolatrice (Les fleurs): «Vertiginosamente vuoto del Dio cristiano, il
cielo persiste a figurare quello stato di sovrumana serenità, di purezza immacolata, di profondità e
limpidezza intellettiva che è proprio della divinità, o meglio di una trascendenza tanto chiusa in sé
da divenire crudele. Crudeltà che in essa non può esprimersi in altra forma se non in quella, calma
e fredda, dell'ironia, che tanto più tortura ed esaspera l'uomo umiliato, il poeta impotente, quanto
più egli si ribella, nel vano tentativo di scuotere il suo giogo».68
In Novalis, il simbolo del fiore azzurro ha un'importanza decisiva e una connotazione non tragica,
come in Mallarmé, bensì magico-mistica. Il fiore azzurro non è solo il simbolo della poesia, della
lontananza e della nostalgia, nonché dell'amore e della morte, come dice Claudio Magris.69 Queste
indicazioni sono troppo vaghe; c'è un preciso significato alchemico e metafisico. Come ha intravisto
Jung,70 il fiore azzurro rinvia all'età primigenia in cui conoscenza e natura non erano ancora
separate, in cui tutto era voce dell'origine.71 Il fiore consente di rammemorare l'origine; il suo
significato alchemico è quello della concordia72 oppositorum, intuita come fonte degli opposti
stessi.
Il fiore azzurro è simbolo di un mistero che non potrà mai essere svelato, ma soltanto saputo nella
sua inesauribilità, in una dimensione comunicativa metarazionale: «Si addormentò fra profumi
celestiali, perché solo al sogno era permesso condurlo nella parte più sacra e riposta del tempio». 73
Esiste una modalità della comprensione diversa da quella puramente intellettuale (sinonimo per
Novalis di tecnica e scientifica), ed è questo uno dei motivi per cui Goethe deve essere superato
(1283-1290, 1354: «Goethe è interamente poeta pratico [...] Egli ha, come gli inglesi, un gusto
naturalmente economico e un gusto nobile acquistato con l'intelletto». Fondate o meno che siano le
critiche, i riferimenti polemici servono a chiarire la prospettiva di chi le elabora) . 74
Il padre di Heinrich è simbolo di quella cultura intellettiva che ha perso la memoria dell'originario.
È lui che sveglia Heinrich, facendolo ripiombare bruscamente nella realtà. Egli è un artigiano; pian
piano la sua interiorità si è completamente risolta in una serie di competenze tecniche che lo hanno
incatenato alla triviale quotidianità. Il padre incarna la negazione delle aspirazioni al mondo
superiore che distinguono il figlio. Nondimeno, anch'egli ha un sogno da raccontare, un sogno di
alcuni anni prima (ora non è più in grado di farne) la cui struttura e il cui oggetto (un fiore!) sono
analoghi a quelli del sogno di Heinrich. Tuttavia, il padre, ormai da tempo dedito esclusivamente
all'intelletto, ha perso dimestichezza coi sogni ed elasticità nella loro interpretazione (è la moglie
che gli fa tornare alla mente il sogno): fatica infatti considerevolmente a ricomporre le immagini e,
infine, il tentativo fallisce.
Il viaggio vero e proprio inizia al secondo capitolo. Anche i Lehrlinge zu Saïs si strutturano come
un'iniziazione: nella fiaba di Hyacinth und Rosenblüthchen, Giacinto, sotto il velo della dea, scopre
il volto della sua amata. Ma, già nei frammenti preparatori all'opera, o destinati alla sua
integrazione, le varianti sono notevoli:
A uno riuscì -- egli sollevò il velo della dea di Sais -- Ma cosa vide? vide -- miracolo dei miracoli -Se Stesso.75
Questo è lo scopo dell'Ofterdingen: cercare e trovare se stessi. Si parte da sé non conoscendosi e si
torna a sé con più matura autocoscienza. Ma questo processo è lungo e faticoso e comporta la totale
epoché dei riferimenti ordinari: per tornare in patria più ricchi bisogna allontanarsene, per
rinascere si deve morire.
In tutto l'Ofterdingen, il compito di comunicare verità che trascendono la ragione è consegnato alla
fiaba.76 Siamo condotti al mondo superiore mercé l'uso di strutture narrative e linguistiche che
trascendono il rigido schematismo deduttivo: è il principio secondo il quale agisce la formula
magica. Il mondo superiore può essere evocato, non descritto, è oggetto di comunione, non di
comprensione.77 Immagine squisita di tale comunione è l'amplesso dei due amanti della fiaba
raccontata dai mercanti nel terzo capitolo.
Amore e comunione sono dimensioni interiori; per questo l'iniziale entusiasmo per la Crociata si
affievolisce: il Sepolcro vero è la nostra anima, noi siamo l'autentico tabernacolo di Cristo. Come
sostiene Nietzsche in due dei suoi ultimi frammenti postumi: «Gesù mira direttamente a creare la
condizione del 'regno dei cieli'nel cuore [...] è puramente interiore. Il regno dei cieli è uno stato del
cuore».78
L'Heinrich von Ofterdingen è tutto volto alla dimensione intima -- la miniera del quinto
capitolo.79 Il minatore è figura di colui il quale scava dentro di sé per trovarsi; l'eremita è il suo
complementare.
In uno dei libri dell'eremita, accanto a persone già conosciute (o ancora da incontrare), Heinrich
vede se stesso. Soggetto e oggetto non sono poli opposti, ma si informano e influenzano
vicendevolmente: ogni incontro con l'oggetto, implica un incremento di esperienza e, quindi, di
coscienza -- non essendo la coscienza altro che esperienza elaborata e sedimentata.
La lezione che Heinrich ha fin qui appreso è quella della concordia oppositorum. Si tratta ora di
trasformare questa conoscenza in vita vissuta: egli deve scoprire il proprio «opposto» e
congiungervisi. Nel sesto capitolo, Heinrich incontra il poeta Klingsohr e si innamora di sua figlia
Matilde: l'amore realizza la conoscenza. Attraverso l'amore, Heinrich può divenire parte attiva nella
vita dell'universo.
Giunto a questo livello, neppure la morte di Matilde può vanificare i risultati conseguiti; lungi
dall'essere una fine, la morte è un inizio e un potenziamento: Novalis lo aveva imparato da Sophie.
L'iniziazione di Heinrich si conclude, se così si può dire, con la raggiunta coscienza del significato
dell'amore. Ma il progresso dell'anima non ha termine.
L'Ofterdingen si compone di due parti: Erwartung e Erfüllung, attesa e compimento. In un grande
come Thomas Hardy, il compimento (Fulfilment, titolo della settima fase di Tess of the
d'Urbervilles) è davvero tale, e, precisamente, si qualifica come compimento tragico con toni da
Liebestod wagneriano: all'apogeo della sua parabola, l'amore pienamente raggiunto -- incarnato
nella sua versione più pura da Tess -- non può non tradursi in morte -- un destino tragico
annunciato fin dall'inizio dell'opera (Prima fase, III), quando con tagliente ironia viene citato il
«Nature's holy plan» di Wordsworth.80
La seconda parte dell'opus maius novalisiano, invece, è interrotta, e non poteva non interrompersi:
essa è un segnavia, indica al lettore una direzione. Il lettore è ora chiamato a procedere da sé sulla
propria strada, a eleggere il proprio destino. Egli ha capito il libro se vi ha riconosciuto il proprio
volto, come Heinrich nel volume dell'eremita. Solo così l'opera di Novalis può essere la Bibbia cui
egli aspirava: solo, cioè, se chi legge capisce che questo libro -- come ogni libro -- non parla d'altri
che del lettore medesimo. Ognuno ha una sua via per trovare l'unità e la pienezza annunciate da
Astralis, figlio di Heinrich e Matilde. Rimanendo incompiuta, l'opera di Novalis realizza se stessa.
La nostra Erörterung dell'opera novalisiana ha assunto un andamento ondivago e ha finito per
coinvolgere molteplici piani. Tuttavia, la ricchezza del dire di Novalis protegge il segreto della sua
poesia, come il velo nero del pastore di Hawthorne;81 o come la casa dell'Impero delle luci di
Magritte82: chi mai potrà svelare il mistero della luce che si nasconde dietro le sue finestre? La
poesia di Novalis, come ogni autentica poesia, attende ancora -- e attenderà sempre -- di essere
adeguatamente compresa.
C'era una bella battuta di Robert Browning [...]: gli chiedono il significato di una poesia e lui la
legge, la rilegge e finalmente dice: 'quando fu scritta questa poesia, solo Dio e Robert Browning ne
conoscevano il significato. Adesso lo conosce solo Dio'.83
Note
1.
G. Trakl, Pace e silenzio (Ruh und Schweigen), in id., Poesie, Einaudi, Torino 1979, p. 97.
2.
Mi rincresce di dover su questo punto contestare -- absit iniuria verbis -- il giudizio di Croce, il quale concorda
con Cosmo «che di recente con maggiore accorgimento e ponderazione di altri ha discorso dell'ultimo canto
della Commedia, -- e con ragione, tra l'altro, ha negato che Dante vi diventi mistico e seguace di san
Bonaventura, -- ha ben riconosciuto che la poesia di questo canto non è nella rappresentazione della visione
beatifica e in ciò che Dante ve ne riporta e ridice», B. Croce, Filosofia Poesia Storia, Ricciardi, Milano-Napoli
1951.
3.
Cfr. W. Dilthey, Das Erlebnis und die Dichtung (1905), Teubner, Leipzig 1922; tr. it. Esperienza vissuta e
poesia, Il melangolo, Genova 1999: «La poesia si offre al nostro esame dapprima determinata dallo spirito
collettivo di comunità politico-militari piuttosto piccole. Essa espresse nella lirica lo spirito di tali società», p. 5;
«Ciò che mi porta a Novalis è l'ambiziosa speranza di far vedere in lui alcuni fra i più importanti motivi della
visione del mondo che si manifesta nella generazione successiva a Goethe, Kant e Fichte [...] Ora la questione è
soprattutto questa: se l'esame di una singola personalità possa permettere di penetrare nei motivi generali della
cultura della sua generazione», p. 272.
4.
«In arte ciò che conta è il prodotto, l'artista ne è lo strumento; ciò che egli aveva in mente non può essere
ricostruito con rigorosa certezza, e in ultima analisi è irrilevante. Seguendo una propria legge immanente l'opera
impone i lineamenti all'autore, il suo esecutore, senza che egli vi debba appositamente riflettere. Sarà tanto più
riuscita quanto più compiutamente l'artista si aliena nella cosa. La sua subordinazione alle esigenze che l'opera
presenta fin dalla prima battuta ha un peso incomparabilmente maggiore dell'intenzione dell'artista», T. W.
Adorno, Alban Berg. Der Meister des kleinsten Übergangs, Verlag Elisabeth Lafite, Wien 1968; tr. it. Alban
Berg. Il maestro del minimo passaggio, Feltrinelli, Milano 1983, p. 54.
5.
Cfr. K. Maleviè, Suprematismo, Abscondita, Milano 2000, passim. I luoghi sono così numerosi che non mette
conto citarli.
6.
G. Ungaretti, Vita d'un uomo, Mondadori, Milano 1969, p. LXXX.
7.
P. Valéry, Commentaires de Charmes, in Variété III, Gallimard, Paris 1936, p. 80.
8.
T. Mann, Adel des Geistes: Sechzehn Versuche zum Problem der Humanität (1945), S. Fischer, Frankfurt am
Main 1955; tr. It. Nobiltà dello Spirito, Mondadori, Milano 1997, p. 1518 (Il corsivo è mio).
9.
«Dove è possibile la parafrasi, le lenzuola non sono gualcite, la poesia non ha pernottato», O. Mandel'stam,
Discorso su Dante, in id., Sulla poesia, Bompiani, Milano 2003, p.121.
10. Novalis, Die Lehrlinge zu Saïs; tr.it. I discepoli di Sais, Rusconi, Milano 1998, p. 115.
11. P. Valéry, A proposito del «Cimitero marino», in id., Varietà, SE, Milano 1990, p. 239. Con ciò viene negata la
teoria lucreziana propugnata anche dal Tasso secondo cui le poesia non è che un sotterfugio per far assimilare
una verità altrimenti dura da intendere o da accettare: «'l vero, condito in molli versi, / i più schivi allettando ha
persuaso. / Così a l'egro fanciul porgiamo aspersi / di soavi licor gli orli del vaso: / succhi amari ingannato
intanto ei beve, / e da l'inganno sua vita riceve», Gerusalemme liberata, I, 3, 3-8. cfr. Lucrezio, De rerum
natura, I, 936-950.
12. W. Kandinsky, Über das Geistige in der Kunst, Insbesondere in der Malerei (19122); tr. It. Lo spirituale
nell'arte, SE, Milano 1989, p. 72.
13. L. Wittgenstein, Briefe an Ludwig von Ficker, Salzburg, 1969, Brief 23, p. 76.
14. M. Heidegger, Unterwegs zur Sprache (1959), Klostermann, Frankfurt am Main 1985; tr. it. In cammino verso
il linguaggio, Mursia, Milano 1973, p. 32.
15. Ibid., pp. 32-33.
16. Perspicua è qui la reminiscenza hegeliana: è dal rapporto che qualcosa intrattiene con ciò che essa non è, che
qualcosa è ciò che è. Una cosa è quella che è, perché non è ciò che non è. Nominando ciò che qualcosa è, evoco
per ciò stesso quello che essa non è, poiché è esattamente in virtù di ciò che qualcosa non è, che quel qualcosa è
ciò che è. Tale è il significato ultimo della dialettica quale si evince dalla Wissenschaft der Logik.
17. Ibid., p. 46.
18. Ibid., p. 74.
19. M. Heidegger, Holzwege (1950), Klostermann, Frankfurt am Main 1950; tr. it. Sentieri interrotti, La Nuova
Italia, Firenze 1968, p. 23. Quando Magritte scrive «Ceci n'est pas une pipe» nel suo celebre quadro del 1928-29
(e «Ceci n'est pas une pomme» in quello del 1964) coglie in pieno questa dinamica. La pipa è sottratta al
contesto in cui può essere pipa, e perciò non è più tale: non può essere né riempita, né fumata, né usata in modo
alcuno.
20. Op. cit., p. 62.
21. Op. cit., p. 40.
22. R. Wagner, Mein Leben (1870; I ed. pubblica 1911); tr. it. Autobiografia, Dall'Oglio Editore, Milano 1983, p.
290.
23. M. Heidegger, op. cit., p. 57.
24. «Kein ding sei wo das Wort gebricht» è l'ultimo verso della poesia di Stefan George che Heidegger commenta
nel quarto saggio contenuto in Unterwegs zur Sprache.
25. M. Heidegger , op. cit., p. 58.
26. J. W. Goethe, Faust, Mondadori, Milano 1932, versione di G. Manacorda, vv. 534-545.
27. P. Valéry, Varietà, cit., pp. 277-302.
28. M. Heidegger, Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung (1981), Klostermann, Frankfurt am Main 1981; tr. it. La
poesia di Hölderlin, Adelphi, Milano 1988, p. 221.
29. W. Kandinsky, op. cit., p. 46.
30. A. Gide, Paul Valéry, in P. Valéry, Charmes, Crocetti Editore, Milano 1992, p. 130. Lo dice anche Novalis, ne I
discepoli di Sais (cit., p. 213): «Ogni arte consiste nella conoscenza dei mezzi con cui raggiungere uno scopo
prefissato e con i quali ottenere un particolare effetto o un particolare fenomeno, e nell'abilità nello scegliere e
nell'utilizzare questi mezzi».
31. Da cui l'impossibilità oltre che della parafrasi anche della traduzione.
32. G. Trakl, A Novalis (An Novalis), in id., op. cit., p. 177.
33. Indico con il numero fra parentesi i Frammenti nell'edizione a cura di Ervino Pocar (BUR, Milano 1997).
34. «In un certo scaffale, di un certo esagono deve esistere un libro che sia la chiave e il compendio perfetto di tutti
gli altri: un bibliotecario l'ha letto, ed è simile a un dio [...] Molti peregrinarono in cerca di Lui, si spinsero
invano nelle più lontane gallerie», La biblioteca di Babele, in J. L. Borges, Tutte le opere, Mondadori, Milano
1984, p. 686.
35. «Lettore, è tempo che la tua sballottata navigazione trovi un approdo. Quale porto può accoglierti più sicuro
d'una grande biblioteca? [...] Ti resta ancora una speranza, che i dieci romanzi che si sono volatilizzati tra le tue
mani appena ne hai intrapresa la lettura, si trovino in questa biblioteca [...] Il libro non si trova [...] Continui a
riempire schede; per una ragione o per l'altra, nessuno dei libri che chiedi è disponibile», Se una notte d'inverno
un viaggiatore, Mondadori, Milano 1994, Capitolo XI, p. 297.
36. «Ma io cerco un libro, da qualche mese. E in tutte le librerie che mi capita di vedere, quando ho la fortuna di
andare in qualche città, non mi è riuscito di trovare quel libro [...] Allora forse non è in nessuna parte del
mondo», Un libro introvabile, in A. Delfini, Il ricordo della Basca, Garzanti, Milano 1992, pp. 173-174.
37. Molti nomi potrebbero qui figurare a proposito. Non posso esimermi dal citarne almeno altri due. Die Blendung
termina con Peter Kien (sinologo, ossia aspirante decifratore di codici enigmatici, proprio come lo Stephen
Albert del Giardino dei sentieri che si biforcano di Borges) che arde se stesso insieme alla sua biblioteca
universale (Autodafé è stato tradotto prima in Inghilterra e poi in Italia l'unico romanzo di Elias Canetti). Nel
microromanzo che chiude Centuria di Giorgio Manganelli la morte dell'unico scrittore necessario sancisce eo
ipso la morte di tutte le immagini di scrittore, compresa quella dello scrittore autore di tutti gli scrittori. Non
solo: nella premessa al volume, Manganelli immagina un grattacielo di tanti piani quante sono le righe di
Centuria; ad ogni piano sta un lettore. Il Supremo Lettore precipita e al suoi passare ogni lettore leggerà la riga
rispettiva. La fine della lettura coinciderà con la fine della vita (lo schianto al suolo). In entrambi i casi, l'esito
del rapporto tradizionale tra lettore, scrittore e Scrittura è letale, mortifero. Si veda in proposito G. Guglielmi,
La prosa italiana del Novecento, Einaudi, Torino 1986.
38. Le due raccolte possono considerarsi compiute solo perché nella mente dell'autore non c'era un preciso progetto
di ciclo poetico che debba ritenersi incompiuto. Del resto, Novalis non vide pubblicate queste composizioni,
come avvenne per quasi tutte le sue opere.
39. «Il conoscere divino è quel modo di rappresentazione che crea, intuendolo, l'ente intuibile come tale. E poiché lo
intuisce in modo immediato e totale, con subitanea e assoluta trasparenza, non ha bisogno del pensiero. Il
pensiero come tale è quindi già il sigillo della finitezza [...] Il fatto che un essere finito conoscente debba 'anche'
pensare è solo una conseguenza essenziale della finitezza del suo intuire», M. Heidegger, Kant und das Problem
der Metaphysik (1929), Klostermann, Frankfurt am Main 1991; tr. it. Kant e il problema della metafisica,
Laterza, Bari 1989, pp. 32-33.
40. «Man's yesterday may ne'er be like his morrow; / Nought may endure but Mutability», P. B. Shelley, Mutability,
in id., Opere, Einaudi-Gallimard, Torino 1995, p. 10.
41. V. E. Bloch, Subject-Object. Erlauterungen zu Hegel, Frankfurt am Main, Suhrkamp 1962, tr. it. SoggettoOggetto. Commento a Hegel, il Mulino, Bologna 1975, pp. 21-22.
42. M. Frank, Stil in der Philosophie (1992); tr. it. Lo stile in filosofia, Il Saggiatore, Milano 1994, pp. 92-93.
43. «Come tante opere del XIX secolo, la Recherche nasce dal 'desiderio e dalla ricerca del Tutto'. I testi che le
assomigliano sono il Faust II, la Comédie humaine, Guerra e pace, i Fratelli Karamazov, La Tetralogia -- fino
all'Uomo senza qualità, dove questo desiderio tende all'estremo e manda in frantumi il libro, perché
l'architettura non riesce a esprimere la forza che la sostiene: un'analogia fatalmente incompiuta», P. Citati, La
Colomba Pugnalata. Proust e la Recherche, Mondadori, Milano 1995, p. 243.
44. «Il romanzo europeo del Novecento si è distaccato dal modello dominante ottocentesco [...] Il Novecento ritrova
la libertà di genere che appartiene al romanzo [...] L'ideale del 'tutto configurato' delle poetiche naturalistiche
non è più suo [...] La nuova narrativa, nella varietà dei suoi orientamenti, di tipo esistenziale, surreale e miticofavoloso, presenta una riduzione dei nessi causali e temporali, e una struttura a segmenti liberamente articolati
[...] Anche le opere di grandi dimensioni sono 'nucleate': organizzate a nuclei. In esse si parte dal dettaglio. Ed è
il dettaglio che riceve uno sviluppo, al limite abnorme, in estensione», G. Guglielmi, La prosa italiana del
Novecento II. Tra romanzo e racconto, Einaudi, Torino 1998, pp. VII-VIII. Evocare i nomi di Kafka, Pessoa e
Bernanos significherebbe scomodare solo una minima parte -- quantunque la più rilevante -- degli esempi a
disposizione. Almeno i primi due debbono però essere menzionati, poiché la loro vicenda artistica presenta
sconcertanti analogie con quella novalisiana.
45. S. Bellow, Herzog (1961), Mondadori, Milano 1985, p. 252.
46. K. Löwith, Nietzsches Philosophie der ewigen Wiederkehr des Gleichen (1935), Felix Meiner Verlag, Hamburg
1978; tr. it. Nietzsche e l'eterno ritorno, Laterza, Bari 1998, p. 9.
47. «Le sue immagini non sono che apparizioni e fantasmi d'un cervello allucinato e rarefatto nella tremenda fatica
di carpire pensieri irraggiungibili», V. Cardarelli, Lo stile di Nietzsche, in id., Opere, Mondadori, Milano 198119985, p. 328.
48. Su questo punto decisivo si veda soprattutto il quinto capitolo di I. Berlin, The roots of Romanticism, tr. it. Le
radici del Romanticismo, Adelphi, Milano 2001.
49. Novalis, I discepoli di Sais, cit., pp. 161-163. Lo stesso dice Heidegger: «La poesia è il corso delle acque che a
volte scorre all'indietro, verso la sorgente», Was heiât Denken? (1954), Max Niemeyer Verlag, Tubingen, 1971;
tr. it. Che cosa significa pensare?, Sugarco, Milano, 1978, p. 45.
50. cfr. Die Welt als Wille und Vorstellung, § 52.
51. E. Fubini, L'estetica musicale dal Settecento a oggi, Einaudi, Torino, 1987, p. 147.
52. C. Magris, Itaca e oltre, Garzanti, Milano 1999, p. 45.
53. B. Spinoza, Etica -- Trattato teologico-politico, UTET, Torino 1972, p. 393. Si vedano inoltre i primi due capitoli
del Tractatus nella loro interezza.
54. Ancora una volta si prendono le distanze da Hegel per il quale la natura è il regno della pura accidentalità da cui
ci si deve emancipare tramite il lavoro, ossia la trasformazione della materia bruta in coscienza deificata e
dunque in auto coscienza acquisita. Il percorso della Fenomenologia consiste in una progressiva denaturalizzazione del mondo.
55. L. Mittner, Storia della letteratura tedesca, Einaudi, Torino 1971, vol. II, tomo III, p. 769.
56. Mi servo, d'ora in avanti, della splendida traduzione di G. Manacorda (R. Wagner, Tristan und Isolde, Le
Lettere, Firenze, 1994). Ove, a fini divulgativi, le traduzioni non possano essere evitate, conviene giovarsi di
quelle che meno tradiscano il senso originario e meglio restituiscano la sublimità del canto.
57. Si riguardi il rapporto che Wagner intrattiene con Schopenhauer: «L'elemento tragico della vita [come gli spiega
Herwegh] è precisamente racchiuso nella coscienza che Schopenhauer ci dà della nullità del mondo fenomenico.
Ogni grande poeta, e in generale ogni grande uomo ha avuto l'intuizione di questo nulla. Pensai allora al mio
poema nibelungico e constatai con sorpresa che inconsciamente, nelle mie concezioni poetiche, avevo
riconosciuto ciò che mi rendeva così perplesso in teoria. Solo in quel momento compresi realmente il mio
Wotan», R. Wagner, Autobiografia, cit., p. 510.
58. Ricordo le commoventi pagine finali della prima parte di Tod des Virgil, dove Hermann Broch coniuga
mirabilmente il tema goethiano delle Madri con una notturna corrente di coscienza di ispirazione chiaramente
novalisiana (tr. it. La morte di Virgilio, Feltrinelli, Milano 1962, pp. 96-107). Quello di Broch non è nulla di
simile a un romanzo storico, neppure lato sensu. È invece l'applicazione personalissima di tecniche narrative di
ascendenza joyciana e l'esplorazione di una regione che solo il romanzo può perscrutare, quella delle infinite
possibilità esistenziali nella loro polifonica compresenza.
59. La traduzione è quella di Giovanna Bemporad (Novalis, Inni alla notte -- Canti spirituali, Garzanti, Milano,
1999).
60. L. Pareyson, Il poeta e la morte in Novalis, in «Rivista di estetica», maggio-agosto 1972, p. 148.
61. È la trasfigurazione del punto di vista hegeliano sul lavoro umano che trasforma il mondo, portandolo con ciò
alla verità.
62. W. Dilthey, op. cit., p. 318.
63. Come non rammentare, a tal riguardo, le parole di Hans Sachs nella Scena Seconda del Terzo Atto dei
Meistersinger von Nurnberg? «Amico mio! Questa appunto è l'opera del poeta, / di interpretare e segnare i
propri sogni. / Credetemi: la visione [Wahn] più vera dell'uomo / è quella che gli viene svelata in sogno: / ogni
arte poetica [Dichtkunst] e ogni poesia [Poeterei] / non è che interpretazione di verità sognate
[Wahrtraumdeuterei]». Nessuna caduta in vacui irrazionalismi con tutto ciò: le parole di Sachs che concludono
l'opera (Atto Terzo, Scena Quinta), ribadite dal coro finale, enunciano leggi costruttive e strutturali confrontabili
con quelle propugnate da Valéry!
64. A. Béguin, Jean Paul e il sogno, in Jean Paul, Sogni e visioni, Mondadori, Milano 1998, pp. XXVII-XXVIII.
Questi temi sono stupendamente ed abbondantemente approfonditi in A. Béguin, L'âme romantique et le rêve,
Librairie José Corti, Paris 1939, tr, it. L'anima romantica e il sogno, Il Saggiatore, Milano 2003.
65. Si pensi alla Commedia dantesca («tant'era pien di sonno a quel punto», Inferno I, 11 e anche Purgatorio IX, 11:
«vinto dal sonno, in su l'erba inchinai»), o a Petrarca («vinto dal sonno, vidi una gran luce», Triumphus
cupidinis I, 11), o a La coscienza di Zeno («Nel dormiveglia ricordo...», Preambolo), o, ancora, alla vocazione di
Samuele («la lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele era coricato nel tempio del Signore, dove si
trovava l'arca di Dio. Allora il Signore chiamò: 'Samuele!'», I Sam III, 4).
66. «La narrazione onirica; diciamo piuttosto: l'immaginazione, che, affrancata dal controllo della ragione e
dall'assillo della verosimiglianza, penetra in paesaggi inaccessibili alla riflessione razionale. Il sogno è il modello
di questa specie di immaginazione [...] Come può il romanzo, che dev'essere, per definizione, un esame lucido
dell'esistenza, accogliere l'immaginazione incontrollata? Come è possibile unire elementi così eterogenei? Ci
vuole una vera alchimia! Credo che il primo ad aver pensato a questa alchimia sia stato Novalis. Nel primo tomo
del suo romanzo Heinrich von Ofterdingen, Novalis ha inserito tre grandi sogni. Non si tratta di un'imitazione
'realistica' dei sogni come se ne trovano in Tolstoj o in Thomas Mann. Si tratta di una grande poesia che si ispira
alla 'tecnica immaginativa' propria del sogno», M. Kundera, L'arte del romanzo, Adelphi, Milano 1988, pp. 118119.
67. F. Hölderlin, Le liriche, Adelphi, Milano 1977, p. 167 (traduzione di E. Mandruzzato).
68. L. Frezza, in S. Mallarmé, Poesie, Feltrinelli, Milano 19983, pp. 187-188.
69. Loc. cit.
70. C. G. Jung, Psychologie und Alchemie, Olten; Freiburg i. B.: Walter 1976; tr. it. Psicologia e alchimia, Einaudi,
Torino 1981, p. 85.
71. Novalis, I discepoli di Sais, cit., p. 105: «Gli uomini percorrono strade molteplici. Chi le segue e le confronta
vedrà originarsi figure bizzarre; figure che sembrano far parte di quella grande scrittura cifrata che si scorge
dappertutto».
72. Il termine concordia è tanto cusaniano quanto coincidentia, ma lo preferisco perché dà meno adito a
fraintendimenti hegelistici.
73. Novalis, I discepoli di Sais, cit, p. 163.
74. «Là dove Goethe intravede la crisi o il dissolversi delle forme organiche nel caos della storia moderna, i
romantici scorgono l'occasione di un'infinita libertà dello spirito che, non più condizionato dall'ordine organico
di una natura in sé, può costruire a suo piacere, nell'euforia di una vera e propria cabbala estatica, infinite catene
di analogie, metafore e similitudini, fino ad arrivare a Novalis che si immagina 'racconti senza alcuna coerenza,
ma pieni di associazioni, come i sogni' oppure 'poesie solo melodiose e piene di belle parole, ma anche senza
senso e del tutto incoerenti' [...] Tutto può rinunciare al nesso organico e consequenziale, farsi gioco onirico di
pure associazioni», G. Baioni, L'alchimia, la chimica e il fiore androgino, in J. W. Goethe, Le affinità elettive,
Marsilio, Venezia 1999, p. 24.
75. Novalis, Opera filosofica, Einaudi, Torino, 1993, vol. I, 250, p. 525. Le due versioni, peraltro, non sono in
contraddizione: il ritrovamento di sé, il progresso nell'autocoscienza -- qui Hegel ha ragione -- avviene solo
attraverso il confronto con la realtà e, eminentemente, con un'altra coscienza.
76. «Credo di poter esprimere nel modo migliore il mio stato d'animo nella fiaba. Tutto è fiaba» (18).
77. «Dio è l'amore. L'amore è il sommamente reale -- il fondamento originario», Novalis, Allgemeines Brouillon, in
id., Opera filosofica, cit., vol. II, 79, p. 279.
78. F. Nietzsche, La volontà di potenza, Bompiani, Milano 1992, frr. 160-161, pp. 96-97.
79. «Noi sogniamo di viaggi attraverso il cosmo -- Ma non è il cosmo in noi? Noi non conosciamo le profondità del
nostro spirito -- Il cammino misterioso va verso l'interiorità», Novalis, Osservazioni sparse, in id., Opera
filosofica, cit., vol. I, 17, p. 362. L'interesse per la mineralogia risale in Novalis al suo fraterno rapporto col
maestro A. G. Werner.
80. Se tale prospettiva non è ancora definitivamente acquisita nel primo romanzo importante di Hardy, Far from
the Madding Crowd (1874), essa indiscutibilmente prende a chiarirsi almeno a partire da The Return of the
Native (1878) e poi con The Mayor of Casterbridge (1886), per realizzarsi in Tess (1891) e in Jude the Obscure
(1896). È ampiamente eccepibile il giudizio di Carlo Cassola che, per sostenere la sua tesi secondo la quale
«Thomas Hardy è uno scrittore esistenziale» (il termine è inteso in accezione sartriana), contesta l'asserzione di
Virginia Woolf: «Hardy è il più grande scrittore tragico di tutti i romanzieri inglesi» (cfr. C. Cassola,
Introduzione a T. Hardy, Tess dei d'Urberville, Mondadori, Milano 1979). A mio avviso, è proprio quest'ultima
la sentenza da sottoscrivere.
81. Il riferimento a Hawthorne non è solo una suggestione; è, invece, del tutto pertinente: il poeta di The Great
Carbuncle è una sorta di caricatura dell'Heinrich novalisiano; inoltre, la prossimità dello scrittore americano a
temi alchemici è nota, documentata e studiata, fra gli altri, da Zolla, nella prefazione alla sua traduzione del
Septimius Felton; infine, gran parte della sua opera evoca il topos del viaggio iniziatico alla ricerca di una
identità inizialmente indefinita: il «chiamiamolo Wakefield» all'inizio di uno dei suoi racconti più celebri
riecheggia il «Call me Ismael» di Moby Dick (il viaggio del Pequod narrato dal grande amico di Hawthorne
inizia così e si conclude con l'acquisita coscienza da parte del protagonista della sua condition humaine, uno
stato di sconfortante orfananza. Considerare il capolavoro melvilliano, questo straordinario compendio di tutti i
generi letterari, come il Baedeker della baleneria sarebbe altrettanto fuori luogo quanto considerare -- come
pure è stato e continua ad essere fatto -- Death in the afternoon di Hemingway il Baedeker della tauromachia,
perdendo tutta la dimensione tragica che lo sostanzia).
82. Soprattutto nella versione non finita del 1967 (L'empire des lumières, olio su tela, 45 x 50,3 cm, Collezione
privata).
83. L'episodio è narrato da Orson Welles a Peter Bogdanovich nel celeberrimo libro-intervista This is Orson Welles
(tr. it. Io, Orson Welles, Baldini & Castoldi, Milano, 1996, p. 288).
Andrea Muni
Il nichilismo in Richard Rorty
1. Introduzione: Rorty tra nichilismo e antinichilismo
Richard McKay Rorty (New York, 4 ottobre 1931 -- Palo Alto, 8 giugno 2007) attualmente è uno dei
filosofi di maggior successo a livello mondiale. Tra le varie onorificenze ricevute, Rorty nel 1999 ha
ricevuto una laurea honoris causa dall'Università di Parigi viii (Vincennes-St. Denis), nel 2000
un'altra dalla Johannes Pannonius University di Pecs, in Ungheria, nel 2001 una dall'Università
Babes-Bolyai di Clui, in Romania, e una dall'Università «Vrije» di Bruxelles, in Belgio.
Fino ad oggi, quando si è parlato di nichilismo, non sempre si è fatto riferimento a Rorty, il quale
piuttosto è stato associato soprattutto al pragmatismo (in particolare, vedendo il lui un fondatore
del neopragmatismo) e ricollegato alla ricezione e alla rielaborazione, negli Stati Uniti, di autori
europei «continentali», tra cui Heidegger, Gadamer e Derrida, in contrapposizione agli «analitici»
di area anglosassone. Alcuni, quando hanno parlato di nichilismo, Rorty nemmeno lo hanno
nominato (cfr. p. es. Vercellone 19921, 2009u. ma; Volpi 19961, 2004u. ma). Anche se ci sono
sempre stati, negli scritti di Rorty, molti elementi propri del nichilismo, questi non sono stati
evidenziati dalla maggioranza dei suoi commentatori. Solo una stretta minoranza, a partire almeno
dagli anni Ottanta, ha parlato apertamente di Rorty come nichilista (cfr. ad. es. Larsen 1987, p. 14).
Rorty è stato anche interpretato, esattamente al contrario, come «antinichilista», e questo
soprattutto da parte di alcuni critici di area pedagogica (p. es. Cambi 2005, p. viii). Questa
contrapposizione radicale, per certi aspetti inconciliabile, tra alcune interpretazioni di Rorty come
nichilista e altre di Rorty come antinichilista, per altri aspetti conferma un approccio condiviso e
unitario nel vedere nel nichilismo un concetto chiave almeno per alcune delle interpretazioni che
fino ad ora sono state date del pensiero Rorty.
Si tratta a mio avviso di un nichilismo contraddittorio, che finisce col contraddire se stesso e
risultare, di fatto, antinichilismo. Se ci si attiene a quanto Rorty si limita a dire, è nichilista -lo
vuole essere, ritiene di esserlo, dichiara esplicitamente e ripetutamente tesi nichiliste-. Se, invece,
si vogliono trarre alcune conclusioni dall'esterno degli scritti di Rorty, spingendo alcune sue
affermazioni a conclusioni che lui stesso non ha tratto e che possiamo prendere noi per lui,
osservandone alcune incongruenze di fondo, allora Rorty può risultare, di fatto, antinichilista.
È presente, in Rorty, il conflitto con i principi della tradizione già presente nei Padri e figli di
Turgenev (1862) o nella negazione di qualsiasi valore ancorato a basi metafisiche e religiose (cfr. p.
es. Dostoevski). Più in generale, Rorty rientra a pieno nella definizione di Lalande, secondo la quale
«non esiste nulla (di assoluto)», «non v'è verità morale» e in quella di Eisler, secondo la quale si
nega «ogni possibilità di conoscenza, ogni verità generale certa».
Si tratta di un nichilismo implicito sia gnoseologico che etico, metafisico e politico. Per quanto
riguarda l'atto conoscitivo (aspetto gnoseologico), non si può conoscere niente con sicurezza. Per
quanto riguarda l'aspetto etico, non c'è una verità etica. Per quanto riguarda l'aspetto metafisico,
viene negata la categoria dell'essere, la stessa ragion d'essere della metafisica, in quanto inutile. Per
quanto riguarda l'aspetto politico, la libertà individuale è, per Rorty, una libertà che dovrebbe stare
quanto più possibile al di sopra di ogni autorità, legge e condizionamento sociale. Come in
Nietzsche, anche in Rorty si proclama un'assoluta mancanza di certezze e una negazione di tutti i
valori tradizionali, ultramondani e soprasensibili.
2. Cenni biografici: per una genesi del pensiero nichilista rortyano
Rorty è figlio unico di James Rorty e Winifred Rauschenbusch Rorty, due scrittori
socialdemocratici entusiasti di Trotsky, filocomunisti e antimilaristi.
Il padre, James (1890-1973), scriveva poesie articoli di carattere etico-politico per giornali. Il
nonno paterno era un immigrato irlandese, aspirante poeta; la nonna paterna, una maestra di
scuola elementare di convinzioni femministe (cfr. p. es. Gross 2008, in part. pp. 16-25).
La madre, Winifred, morta a Princeton (New York) nel 1980 a 85 anni, a casa del figlio, aveva
studiato all'Università di Chicago e negli anni giovanili era stata assistente del sociologo
statunitense Robert Ezra Park (Harveyville, 1864 -- Nashville, 1944), uno dei principali fondatori
ed esponenti della «scuola dell'ecologia sociale urbana» o «scuola sociologica di Chicago» (the
Chicago School of Sociology), dopo esser stato allievo, tra gli altri, di William James e di John
Dewey. Tale scuola si interessava prevalentemente di problematiche sociali quali la criminalità, il
divorzio, il suicidio, ritenendo che i rapporti sociali e culturali sono strettamente condizionati
dall'ambiente sociale di appartenenza. Park in particolare è noto per aver messo a tema le
«personalità marginali», intese come soggetti non inseriti in un ambiente sociale, insicuri e
disorientati; l'«uomo marginale», inteso come chi sta al confine tra due culture che non si
integrano; e l'«uomo asociale», inteso come chi viene escluso dal processo di produzione,
comprendendo gli alcolisti e i malati di mente. La madre di Rorty, tra l'altro, ha scritto un libro su
questo suo professore (Rauschenbush 1979). La nonna materna, Pauline Rauschenbush, era
un'immigrata della Prussia.
Il nonno materno, Walter Rauschenbusch (Rochester, New York, 4 ottobre 1861 -- Rochester, New
York, 25 luglio 1918), figlio a sua volta di un predicatore protestante tedesco, è particolarmente
interessante per una interpretazione della genesi del pensiero di Rorty. È stato professore al
«Rochester Theological Seminary» dal 1902 al 1917. Gli eventi della prima guerra mondiale, che si
era consumata tra il 28 luglio 1914 e l'11 novembre 1918, lo avevano turbato e deluso
profondamente. Prima di questo periodo, era stato per 11 anni, dal primo giugno 1886 al 1897, un
ministro battista a New York in zone industriali di operai poveri, quartieri di Brooklyn chiamati
Hell's Kitchen, «Cucina dell'Inferno». Luoghi caratterizzati da slums, insicurezze e deprivazioni
economiche, disoccupazione, malnutrizione, epidemie, criminalità, diffuso disagio psicologico e
sociale, estrema povertà accentuata dalle diseguaglianze concretizzate nelle marcate separazioni
sociali tra ricchi e poveri. Era stato molto noto e attivo in un movimento del «Social Gospel», da lui
stesso fondato, influendo, con la sua vita e i suoi scritti di teologo (cfr. Christianity and the Social
Crisis, Macmillan, New York 1907; Christianizing the Social Order, Macmillan, New York 1912;
Theology for the Social Gospel, Abingdon Press, New York 1917; Social Principles of Jesus, The
Association Press, New York 1918), oltre che su suo nipote Richard Rorty, anche su altri, tra cui
Martin Luther King e Mahatma Gandhi. L'etica sociale di Rauschenbusch era basata sul pietismo,
sul settarismo anabattista, sul liberalismo e sul trasformismo politico, e si può condensare in poche
parole: vivere «sulla terra come se si fosse in Cielo» (on earth as it is in heaven), «trasformando la
vita sulla terra nell'armonia del Cielo» (transforming the life on earth into the harmony of heaven)
(cfr. ad es. Gotobed, Charles 1994, tr. it. mia).
Rorty descrive la sua infanzia come libresca e solitaria (bookish and solitary) (Rorty 1992, ora in
1999, pp. 3-20, tr. it. mia). In effetti la sua infanzia e la sua famiglia sono state insolite (unusual)
(Guignon, Hiley 2003, p. 3; in rimando a Weaver 2000, p. 38); i suoi genitori di sinistra e
simpatizzanti del partito comunista (Guignon, Weaver 2000, p. 3). A 12 anni comincia a filosofare.
Scrive: «A 12 anni, ho capito che il senso dell'essere umano era di usare la propria vita per
combattere le ingiustizie sociali» (At 12, I knew that the point of being human was to spend one's
life fighting social injustice) (Rorty 1992, tr. it. mia). A 15 anni i suoi genitori lo iscrivono in un
college per ragazzi precoci all'Università di Chicago (Hutchins College), chiamato da Liebling «la
più grande collezione di nevrosi giovanili» (the biggest collection of juvenile nevrotics) (in
Guignon, Hiley 2003, p. 4, tr. it. mia). È sempre a 15 anni che legge Platone e si identifica con
Socrate: «Ho letto Platone durante l'estate dei miei 15 anni, e mi sono convinto che Socrate era nel
vero -- la virtù era conoscenza» (I read through Plato during my fifteenth summer, and convinced
myself that Socrates was right -- virtue was knowledge) (Rorty 1992, tr. it. mia). Nel 1949, a 18
anni, discute la sua tesi su Whitehead, nel 1952, a 21 anni, inizia a Yale un dottorato in filosofia. Nel
1954, a 23 anni, si sposa. Nel 1956, a 25 anni, porta a termine gli studi con una dissertazione
dottorale sul concetto di potenzialità (The Concept of Potentiality).
Il matrimonio di Rorty del 1954 è con una professoressa di filosofia dell'Università di Harvard,
Amelie Oksenberg Rorty, da cui ha una figlia, Jay Rorty. Questa moglie di Rorty, che attualmente
insegna in un Dipartimento di Filosofia a Boston e in un Dipartimento di Medicina Sociale ad
Harvard, nel 1951 aveva conseguito un baccellierato in filosofia a Chicago, nel 1954 alla Yale
University un M. A. con una tesi dal titolo A Theory of the Comic, nel 1957 comincia a insegnare
filosofia, nel 1961 sempre alla Yale University, aveva conseguito un Ph. D. con una dissertazione
intitolata Self Reference and the Theory of Error, a partire dagli anni sessanta aveva scritto dei
saggi all'interno di alcuni libri, tra i quali Pragmatic Philosophy (Doubleday, 1966), The Identities
of Persons (University of California Press, 1976) e, tra i suoi numerosissimi articoli che pubblica dal
1962, nel 1995 ne scrive uno, Ruins and Runes (Journal of the Philosophy of Education, ristampato
in Tamir Y., cura, Democratic Education in a Multicultural State, Blackwell, 1995, pp. 59-64), tutti
scritti i cui temi si avvicinano molto a quelli degli scritti di Rorty, per certi aspetti coincidono.
Da questa prima moglie Rorty si divorzia. Diciotto anni dopo quel primo matrimonio, nel 1972, a 41
anni, si sposa con un'altra donna, Mary Varney Rorty, anche lei professoressa di filosofia in
università statunitensi, dalla quale ha due figli, Kevin e Patricia. Da quanto ricavo dall'url
dell'Università di Stanford (http://www.stanford.edu/~mvr2j/), questa seconda moglie, di area
femminista e con interessi scientifici in area bioetica, attualmente insegna all'Università dello Stato
di San Francisco; aveva conseguito un baccellierato in filosofia nel 1961, nel 1965 aveva cominciato
a insegnare filosofia e a far parte della American Philosophical Association, nel 1970 aveva
conseguito il suo Ph. D., negli anni 1972-1974 (in coincidenza con il suo matrimonio con Rorty)
aveva interrotto la sua attività di insegnamento e, nel 2003, avrebbe scritto una lunga recensione a
Habermas J., The Future of Human Nature (in Notre Dame Philosophical Review, 12. 02. 2003).
Attraverso questi rapidi cenni biografici, è facile osservare, da una parte, una genesi del pensiero di
Rorty ascrivibile in buona parte alla sua storia familiare, a condizionamenti parentali; dall'altra,
una sostanziale sovrapposizione dei suoi interessi culturali con quelli di alcuni componenti della
sua famiglia, in particolare della prima moglie e della seconda.
3. Un contesto al nichilismo rortyano: il pragmatismo
Rorty in tutti i suoi scritti aderisce sostanzialmente al pragmatismo, per sua stessa esplicita e
ripetuta ammissione. È pragmatista, ad esempio, nel ritenere che qualcosa (un'affermazione, una
ricerca) è utile (ha senso, è ammissibile) se ci aiuta a capire o a risolvere un problema dato. Ma il
pragmatismo, che Rorty condivide, non è solo questo; ha a che fare anche con 'filosofia dell'azione'
(cfr. Sciacca 1952, p. 1884).
Una forma, a volte esasperata, di fare della verità una specie di candidato 'democratico' in una lista
di tante presunte verità, in attesa di ottenere la maggioranza dei suffragi per proclamarsi vere o
non vere; e l'esito dipende dall'efficacia della messa in scena e della pubblicità. Il pragmatismo
nega, in fondo, ogni verità e si risolve in una forma di storicismo empirico e, da ultimo, di
autentico materialismo; e, quando si chiama religioso e spiritualista, in un fideismo non meno
rovinoso, in una specie di mistica dell'azione e della volontà, che, non sorretta da un saldo
principio razionale né da un concetto ben fondato della trascendenza, si orienta verso
l'immanentismo più radicale e perciò verso una mistica dell'efficacia trasformatrice ed operativa
dell'uomo, in vista della instaurazione di una società futura sempre più idonea ad appagare i suoi
bisogni e a godersi i beni del mondo; cioè s'incontra con il marxismo (Sciacca 1952, p. 1889-90,
corsivi miei).
Il neopragmatismo è sempre anche antifondazionismo: non parte da principi o fondamenti, ma da
«convinzioni formate nella concreta esperienza di vita» (Restaino 2006, p. 7833). In particolare, al
libro di Rorty Philosophy and The Mirror of Nature (Oxford 1979) si attribuisce la nascita di
questo neopragmatismo (cfr. p. es. Restaino 2006, p. 7833).
4. Il pensiero di Rorty: aspetti nichilisti (1979-2005)
A 48 anni Rorty, nel libro «La filosofia e lo specchio della natura» (Philosophy and the Mirror of
Nature), del 1979, scrive che il desiderio di una teoria della conoscenza è un desiderio di trovare
«fondamenti ai quali potersi aggrappare», «rappresentazioni che non si possano mettere in
discussione». Pur rendendosi conto che l'accantonamento dell'epistemologia fondazionale «lascia
un vuoto che richiede di essere riempito», non intende proporre niente come un soggetto
sostitutivo dell'epistemologia e della metafisica, nemmeno l'ermeneutica (Rorty 1979, tr. it. 2004,
p. 631). Rorty stabilisce una contrapposizione tra «il sovrintendente culturale che conosce il
terreno comune a tutti -- il re-filosofo di Platone che sa quel che tutti gli altri fanno [...], perché lui
conosce il contesto ultimo [...] all'interno del quale essi agiscono», sotto il nome di
«epistemologia», e quello «del dilettante informato, del mediatore poliedrico e socratico tra i vari
discorsi», sotto il nome di «ermeneutica» (Rorty 1979, tr. it. 2004, pp. 635-37). Da questo
contrasto Rorty fa emergere «la nozione di cultura come conversazione piuttosto che come
struttura unificata su fondamenti», e «quest'idea di interpretazione suggerisce che giungere alla
comprensione somigli più al far conoscenza con una persona che al seguire una dimostrazione»
(Rorty 1979, tr. it. 2004, p. 639).
Lo stesso anno, in un altro libro, Rorty esalta il pragmatismo, definendolo «la maggior gloria della
tradizione intellettuale del nostro paese» e affermando che «nessuno scrittore americano, quanto
James e Dewey, ha avanzato una proposta tanto radicale al fine di rendere il nostro futuro diverso
dal nostro passato» (Rorty 1979b, ora in Rorty 1982, tr. it. 1986, p. 167). Anche se i profondi limiti
teorici del pragmatismo erano stati messi a nudo da varie parti fin dall'inizio (p. es. Spirito 1921),
Rorty continuerà a identificarsi esplicitamente in James e Dewey per tutta la vita, fino agli ultimi
scritti (cfr. ad es. Rorty 1992; Rorty 1999, p. xvi).
Nel 1984, Rorty, a 53 anni, in uno scritto intitolato «La priorità della democrazia sulla filosofia»
(The priority of democracy to philosophy), si rifà a Jefferson quando scrive che le questioni ultime
(matters of ultimate importance) «non sono essenziali per una società democratica», «non sono
essenziali per una coesione sociale», per cui «devono essere scartate», «forse per essere
rimpiazzate [...] con una sorta di esplicita fede politica secolare che formerà la coscienza morale del
cittadino». Per Rorty «dobbiamo abbandonare o modificare le opinioni sulle questioni ultime»
(Rorty 1984, ora 1991, pp. 175ss., tr. it. mia; con rif. a Jefferson 1905). Per Rorty, che si richiama
esplicitamente a Jefferson, sono da abbandonare tutte queste «opinioni sulle questioni ultime sul
nostro posto nell'universo e la nostra missione sulla terra» (Rorty 1984, ora 1991, p. 195, tr. it.
mia). Nello stesso saggio, Rorty finisce col dire che tutti quelli che non la pensano come lui sono dei
pazzi: «Noi eredi dell'Illuminismo pensiamo di persone simili che sono pazze. Questo avviene
perché non c'è modo di considerarle come concittadini della nostra democrazia» (Rorty 1984, ed.
it., vol. i, p. 248).
In questo modo, Rorty mostra almeno due contraddizioni, entrambe estremamente profonde.
Prima contraddizione: da una parte, Rorty rifiuta ogni fondamento, ogni questione ultima (o
principio primo); dall'altro, fa della democrazia un fondamento e una questione ultima (o principio
primo). Seconda contraddizione: Rorty da un lato assolutizza la democrazia come un principio
vero, di per sé evidente, indiscutibile, fondamentale; dall'altro lato non è per niente democratico,
né rispettoso, quando nega il diritto di dissentire, di discostarsi dalla sua filosofia democratica, che
finisce coll'essere, più che una filosofia, una fede, ed estremamente dogmatica, fondamentalista e
intollerante, potenzialmente terroristica. Ancora: l'idea di «democrazia», che Rorty dichiara di
riprendere in primo luogo da Jefferson e da Dewey, non è da Rorty sufficientemente esplicitata,
rimane un concetto vago, non solo non teorizzato, ma neppure storicizzato. Vale a dire che in Rorty
manca sia una esposizione teorica che una esposizione storica del concetto di «democrazia»; analisi
teoretiche e storiche recenti del concetto di «democrazia» ne hanno evidenziato tutti i limiti, a
partire dal carattere violento e dalla dannosità, a volte, al bene comune (cfr., uno per tutti, Canfora
2002; 2004; 2007). La stessa cosa si può osservare a proposito di un altro concetto fondamentale
per Rorty, anch'esso di fatto assolutizzato, quello di «conversazione».
In uno scritto del 1987 dal titolo Science as solidarity, Rorty scrive che oggi «lo scienziato
rimpiazza il sacerdote» (Rorty 1987, ora 1991, p. 35, tr. it. mia). Forse non si accorge che in questo
modo finisce non con lo svuotare i sacerdoti della propria sacerdotalità, e la religione della propria
religiosità (il che sarebbe un controsenso), quanto piuttosto col conferire agli scienziati un'identità
sacerdotale, sacra, e alla scienza uno statuto religioso, di sacralità, assolutezza, fondamento primo e
fine ultimo. In uno scritto del 1986, La filosofia come scienza, come metafora e come politica,
Rorty aveva allargato l'attacco al sacerdozio e alla religione alla filosofia: «Senza ricadere in
desideri di santità», «non ricorreremo più ai filosofi per cercare aiuto, esattamente come i nostri
antenati si rivolgevano ai sacerdoti. Ci rivolgeremo, invece, ai poeti e agli ingegneri, le persone che
producono nuovi, sorprendenti progetti per il raggiungimento della maggior felicità possibile per il
maggior numero di persone possibile» (Rorty 1986, ora 1993, tr. it. 1994, p. 34). Ma in questo
modo non si accorge che finisce, di fatto, col proporre non solo i poeti e gli ingegneri come nuovi
filosofi, e sacerdoti, ma anche la poesia e l'ingegneria come nuova filosofia, e religione. Una nuova
fede umanista e umanitaria, un culto dell'uomo che non è nuovo: è sempre il solito, classico,
notissimo, aversio ab incommutabili bono, conversio ad commutabile bonum più volte ripetuto da
S. Tommaso d'Aquino (cfr. p. es. S. Th. I-II, 72, 6; Iª-IIae qq. 85-89, IIª-IIae qq. 17-22; De malo, q.
4, a. 5, o. 3; Scriptum super Sententiis, l. 2, dd. 30-33).
Nel 1988, in Identità morale e autonomia privata: il caso di Foucault, Rorty dice di Foucault che
«è stato, tra le altre cose, un cittadino utile ad un paese democratico, un cittadino che ha fatto del
suo meglio per rendere migliori e più degne le istituzioni del suo paese» (Rorty 1988, ora 1993, tr.
it. 1994, p. 268). Leggendo tra le righe, si potrebbe interpretare che, per Rorty, la categoria
dell'utilità sia una categoria etica di primaria importanza, e sia da riferire sempre alla democrazia,
come a dire che non ci sia altra «utilità» al di fuori di quella funzionale alla democrazia. Spingendo
oltre l'interpretazione, si potrebbe ipotizzare che un cittadino «inutile» (non funzionale alla
democrazia, alla società democratica) non ha proprio nessun senso, nessuna ragion d'essere, nel
pensiero di Rorty, e vedere in questa mancanza di senso una possibile via giustificatoria di pratiche
omicide come quelle dell'aborto, dell'eutanasia, della pena di morte.
Nel 1989, nello scritto Wittgenstein, Heidegger e la reificazione del linguaggio, Rorty scrive: «il
linguaggio di Heidegger è semplicemente un dono che Heidegger ha fatto a noi e non un dono
dell'Essere a Heidegger» (Rorty 1989, ora in 1993, tr. it. 1994, p. 88); in Heidegger, Kundera e
Dickens paragona Heidegger a «un prete ascetico» (Rorty 1989b, ora 1993, tr. it. 1994, pp. 100101), paragone che detto da altri potrebbe essere addirittura un complimento, ma detto da Rorty
suona evidentemente come una derisione o una commiserazione. In questo modo Rorty sembra
scrivere a spintoni. Si rende esempio, in questo modo, di come una persona, per quanto
intelligente ed erudita, e per quanto democratica a parole, di fatto possa essere del tutto
irrispettosa del pensiero e dell'identità degli altri, nascondendo nel proprio sorriso (sono note le
fotografie nelle quali Rorty è uscito sorridente) una risata, un atteggiamento aggressivo e beffardo.
In Contingency, irony, and solidarity Rorty concorda con chi nega la natura umana e riconduce
tutto a circostanza storica: «A partire da Hegel i pensatori storicisti hanno [...] negato l'esistenza di
una 'natura umana'o dello 'strato più profondo dell'io'. Hanno affermato che tutto è socializzazione,
e quindi circostanza storica -- che non esiste un'essenza dell'uomo 'al di sotto'della socializzazione e
prima della storia» (Rorty 1989c, p. xiii, tr. it., p. 1, tr. it. mia).
«Questa svolta storicista ci ha permesso di liberarci, gradualmente ma fermamente, della teologia e
della metafisica. [...] Ci ha permesso di sostituire alla Verità, come traguardo del pensiero e del
progresso sociale, la Libertà. [...] Autori come Marx, Mill, Dewey, Habermas e Rawls sono, più che
dei modelli, dei concittadini. Il loro impegno è sociale, è il tentativo di rendere le nostre istituzioni
e pratiche più giuste e meno crudeli» (Rorty 1989c, pp. xiii-xiv, tr. it., p. 2, tr. it. mia). Ma dire
istituzioni e pratiche «più giuste» è anche dire senza misericordia, perché una giustizia chiusa in se
stessa esclude da sé qualunque misericordia; una società solo umanamente giusta è una società
senza amore.
«Il massimo che possiamo fare [...] consiste nel vedere il fine di una società [...] nel fatto che i suoi
cittadini siano privatistici, 'irrazionalisti'ed estetizzanti quanto vogliono fin tanto che lo fanno per
conto loro, senza danneggiare gli altri e senza sfruttare le risorse necessarie ai meno privilegiati»
(Rorty 1989c, tr. it., pp. 2-3). «Una cultura storicista e nominalista come quella che immagino io
deciderebbe invece a favore di narrazioni che collegano il presente da un lato al passato, dall'altro a
un futuro utopico. Soprattutto, considererebbe l'attuazione e la creazione delle utopie un processo
infinito: una realizzazione e proliferazione infinita della Libertà, e non un convergere verso una
Verità già data» (Rorty 1989c, tr. it., pp. 5-6); una forma di «politica utopistica» che «sogna di
creare una forma di società mai vista prima» (Rorty 1989c, tr. it., p. 9). E qui Rorty rivela tutto il
suo nichilismo politico, se stiamo alla definizione nietzschiana per cui «il nichilista è un uomo il
quale afferma del mondo, così com'è, che non dovrebbe esistere, e del mondo, così come dovrebbe
essere, che non esiste» (Nietzsche 9 [60] 1887 = La volontà di potenza, 585; tr. it. in Magris 2003,
p. 211). Oltre a ricadere sempre nella stessa contraddizione: di dire di rinunciare ad ogni assoluto,
ma di continuare a sentire un bisogno, un desiderio insopprimibile di assoluto e di finire col
sostituire a un assoluto (la Verità) un altro assoluto (la Libertà).
Rorty vuole essere un radicale ironico, laddove per ironico intende colui al quale «non gli interessa
trovare un metodo, un programma o un criterio di base per sé e per i suoi colleghi. La sua unica
occupazione è quella di tutti gli ironici: la ricerca dell'autonomia» (Rorty 1989c, tr. it., p. 118).
Autonomia anche in pedagogia: «Quando la gente di sinistra parla di educazione, parla prima di
tutto di libertà» (Rorty 1989d, p. 114, tr. it. mia). E provoca: «L'acculturazione alle norme della
nostra Società produrrà libertà o alienazione?» (Rorty 1989d, p. 115, tr. it. mia).
Nel 1992 Rorty scrive: «non c'è niente di sacro» per «i pragmatisti deweyani come me», per «i
tipici professori di sinistra come me» (Rorty 1992, tr. it. mia). Si tratta di un ateismo «di
indifferenza» (cfr. p. es. Colomer 1997, p. 108).
Nel 1993 Rorty, pur avendo commentato a lungo Heidegger e Derrida, e pur dovendo proprio a
questo suo recepire e rielaborare negli Stati Uniti Heidegger e a Derrida gran parte del suo
successo, non si sente per niente heideggeriano o derridiano. Ammette infatti testualmente: «io ho
scritto a lungo (fino alla noia) contro Heidegger e Derrida» (Rorty 1993, ora 1998, tr. it. 2003, p.
43, richiamandosi a Rorty 1984 e Rorty 1985 ora in Rorty 1991, corsivo mio).
Nel 1994 scrive: «man mano che la società nordamericana si è laicizzata si è sempre più sviluppata
la convinzione che le credenze religiose -- e forse anche la mancanza di credenze -- di una persona
sono irrilevanti per la sua partecipazione a quasi tutte le nostre pratiche sociali» (Rorty 1994, ora
1998, tr. it. 2003, p. 61). «La nostra maturazione è consistita nel comprendere a poco a poco che se
possiamo contare gli uni sugli altri non abbiamo bisogno di contare su nient'altro. In termini
religiosi questa è la tesi feuerbachiana che Dio è solo la proiezione dell'aspetto migliore
dell'umanità, e qualche volta del peggiore; [...] in termini politici è la tesi che purché riusciamo a
tenere in vita la democrazia e la tolleranza politica, tutto il resto si può risolvere avanzando a
piccoli passi verso un qualche compromesso ragionevole» (Rorty 1994, ora 1998, tr. it. 2003, pp.
76-77). Rorty non contrasta la religione (e tutto ciò che è assoluto, infinito), ma ne è indifferente. Il
suo nichilismo è un nichilismo di indifferenza verso tutto ciò di cui non vede l'utilità; la
trascendenza, il fondamento, l'assoluto, la verità sono tutte idee inutili per lui. Questa convinzione
personale diventa una filosofia della storia di tipo progressivo, evolutivo: man mano che la storia
procede, il ricorso alle trascendenze, ai fondamenti, agli assoluti, alle verità si farebbe sempre meno
necessario, sempre più superfluo e inutile.
Nel 1995 è Rorty stesso a vedere nel proprio pensiero «lo stesso messaggio dell'illuminismo e
dell'umanesimo secolarizzato, e cioè l'idea che non esiste niente al di fuori della comunità umana.
In un mondo in cui ci siamo solo noi, in cui non ci sono più Dio, la legge morale, la natura della
realtà, ci rimane soltanto la speranza in una società più libera» (Rorty 1995, corsivo mio). Rorty
riconosce di restare sostanzialmente fermo agli ideali dell'illuminismo e dell'umanesimo; nel
condividerli non si dà conto che l'illuminismo e l'umanesimo non sono andati avanti, ma sono
tornati indietro, non hanno creato, ma hanno imitato (cfr. p. es. Pernoud 1977), contraddicendo
così la sua visione della filosofia della storia.
Da una parte, Rorty insiste a scrivere: «mi sembra che l'immagine greca della filosofia come
riflessione sui problemi eterni che si ripresentano costantemente alla mente umana sia sbagliata.
Non ci sono problemi filosofici fondamentali» (Rorty 1995). Dall'altra parte continua a ripetere: «la
democrazia, a mio parere, è un fine in se stessa [un problema filosofico fondamentale?], non un
mezzo per ottenere qualcos'altro. E lo stesso vale per la libertà [...] . Non credo che si possano
offrire argomenti filosofici a favore della democrazia» (Rorty 1995). È quindi per fede che la
democrazia è indicata da Rorty come il «miglior tipo di società finora inventata» (Rorty in
Massarenti 1993, cfr. Rorty 1992) e come unico punto fermo, vero e fondamentale. In Rorty,
l'ossessiva intenzione di essere senza punti fermi, verità e fondamenti rimane uno stato di
desiderio, un'illusione, un sogno irrealizzato e irrealizzabile.
Nel 1997, concordando con James, Rorty ammette: «la democrazia è una specie di religione, e noi
siamo tenuti a non ammettere il suo fallimento» (Rorty 1997, ed. it. 1999, p. 21). Per Rorty il
rispetto e l'orgoglio sono atteggiamenti rischiosi: così come il rispetto di sé può condurre
all'arroganza, allo stesso modo l'orgoglio nazionale può sfociare nell'imperialismo e nella
bellicosità. Da questi rischi, secondo Rorty, ci potrebbe salvare qualcosa come l'ironia e la
vergogna, di sé e della propria appartenenza sociale (cfr. Rorty 1997, ed. it. 1999 p. 15). Ora, a parte
il fatto che in Rorty l'ironia e la vergogna sono cose diverse dall'umiltà, si tratta di un'ironia e di
una vergogna piene di orgoglio democratico e arroganza nichilista: quella dell'ironia e della
vergogna è solo una maschera d'argento con cui Rorty copre il suo vero volto, tutt'altro che ironico.
Nel 1999 Rorty ancora una volta si dichiara apertamente deweyano: «il filosofo che ammiro di più,
e che di cui di più vorrei pensarmi come discepolo, è John Dewey» (Rorty 1999, p. xvi, tr. it. mia).
Proprio «Dewey, il democratico radicale e il più politico dei pragmatisti» (Habermas 2007b, tr. it.
mia).
Nel 2000 Rorty, quando scrive contro i fondamentalisti religiosi (Rorty 2000, pp. 21-2), in realtà
scrive contro i religiosi tout court. In questo modo non si accorge dell'atteggiamento
contraddittorio in cui finisce col cadere, ritrovandosi di fatto lui stesso un fondamentalista, antireligioso, per il quale tutto può aver senso, tutto può aver significato, tutto può essere ammissibile,
legittimo, tollerabile, fuorché la religione e tutto quello che ci può assomigliare, avvicinare, avere in
qualche modo a che fare. La parola «religione» per Rorty ha a che fare con parole come «verità»,
«certezza», «fondamento», «senso o significato primo o ultimo». Alla religione intesa in questo
modo, di fatto, Rorty finisce col sostituire una «religione», una «fede», in idee come la
«democrazia», la «contingenza», lo «scetticismo», «il progresso sociale», la «solidarietà-senzaDio».
Nel 2005, a 74 anni, Rorty scrive: «noi esseri umani non abbiamo obblighi morali se non quello di
aiutarci vicendevolmente a soddisfare i nostri desideri» (Rorty 2005, p. 14). «Per quanto riguarda
la democrazia sociale -nel senso che si dà a questa nozione negli Stati Uniti -- credo che i suoi
difensori, come Dewey, direbbero che essa non è di per sé un assoluto, ma semplicemente il mezzo
migliore che siamo stati in grado di immaginare fino a questo momento per giungere alla massima
felicità possibile per gli esseri umani» (Rorty 2005, p. 33).
5. Aspetti pedagogici del nichilismo rortyano
L'ambito pedagogico è un ambito nel quale si rendono particolarmente visibili le implicazioni
pratiche delle filosofie sottostanti; la filosofia di Rorty non fa eccezione. Il pensiero di Rorty è stato
oggetto di attenzione in ambito pedagogico almeno dagli anni Ottanta (cfr. p. es. Santoianni 2005,
p. 1, con esplicito riferimento a Suppe 1982, Arcilla 1990, 1995, Neiman 1991, Hostetler 1992, Hare
1995, Martin 1993, Cambi 1995, 2002, Santoianni 1996). Qui Rorty è stato da alcuni accolto come
un innovatore e un liberatore: la pedagogia troverebbe modo, «collocata tra pragmatismo e
ermeneutica», di oltrepassare «quello statuto di 'scienza regia', votata alla e vocata dalla Verità
(unica, stabile, imperativa)», «per assumere invece un «volto umano, postmetafisico», «senza
fondamenti», «sottratta all'ipoteca della metafisica», «sottratto a ogni ottica di Dominio e di
Potenza, di Unicità/Univocità e di Fondazionismo» (Cambi 2005, pp. vii-viii). Come pedagogia
«anti-nichilista» (!) (Cambi 2005, p. viii), porrebbe «al centro la democrazia come struttura-basica
delle società attuali» (Cambi 2005, p. ix).
Il valore pedagogico della filosofia di Rorty è stato visto nella critica di Rorty alla metafisica,
all'epistemologica, alla tradizione filosofica e nella ricerca di un «nuovo modo di pensare»
(Santoianni 2005, p. 5). Il nucleo pedagogico ruoterebbe intorno ad alcune categorie interpretative,
come il concetto di contingenza, il concetto relativizzato di verità intesa come credenze «situate,
condivise, confutabili e negoziabili» (Santoianni 2005, p. 8). Categorie chiave nell'interpretazione
pedagogica sono stati il concetto di democrazia e di speranza sociale, ma anche di conversazione e
narrazione, strettamente interrelati tra loro (cfr. Santoianni 2005, p. 9). Gli aspetti pedagogici di
Rorty sono stati accostati alla psicopedagogia culturale Bruner degli anni Ottanta e Novanta; in
particolare al Bruner del 1997 (cfr. Santoianni 2005, p. 9), come pure al Bruner del 1988 e del 1992
(cfr. ibid., pp. 41 ss.). In ogni caso, sono i concetti di contingenza, verità, democrazia e speranza
sociale a costituire il presupposto teorico, il fondamento della pedagogia di Rorty (cfr. Santoianni
2005, p. 10).
Da una parte, Rorty apre la strada a una pedagogia in cui «non esiste una verità superiore, con la V
maiuscola», e in cui «nessun sapere, d'altra parte, può essere considerato in grado di 'illuminare' la
verità delle cose meglio di ogni altro, così come nessun vocabolario (cioè nessun linguaggio) può
essere considerato migliore di un altro» (Santoianni 2005, p. 11); dall'altra parte questa stessa
finisce con l'essere, di fatto, una verità superiore, con la V maiuscola. Il fondamento teorico,
pragmatista, che starebbe alla base di questa posizione di pensiero sarebbe quello di James,
secondo cui la verità sarebbe «ciò che ci è utile credere», e quello di Peirce, secondo cui «ogni
differenza nella teoria deve fare una differenza nella pratica» (Santoianni 2005, p. 12). In questo
modo Rorty cade in contraddizione, perché nel dire che qualcosa è utile e qualcosa non lo è, o che
qualcosa è più utile di qualche altra cosa, è implicito un criterio di migliore e peggiore e un
riferimento a un'idea di verità fondativa di tale criterio.
Sempre in quest'ambito pedagogico, Rorty è stato inoltre accolto nella sua interpretazione della
pedagogia, e della vita, come romanzo: «nel romanzo si moltiplicano e si sommano i punti di vista,
le modalità e le angolazioni descrittive, senza che alcuna prenda il sopravvento o sia considerata
esaustiva, univoca, apodittica, risolutiva -- il romanzo è al di là dei concetti di verità, e di realtà;
senza che si supponga, anche per un momento, che esistano spiegazioni e schemi astorici
sovraordinati, o una 'natura umana'la cui comune essenza sia universale» (Santoianni 2005, p. 43).
Nel romanzo «non sono le tipologie, le schematizzazioni, le assunzioni dogmatiche e le
formulazioni assertive a caratterizzare un luogo, un ambiente, un fatto»; il romanzo è il migliore
«approccio alla realtà» (Santoianni 2005, p. 43).
In pedagogia, come in filosofia, «l'ironico dubita, di se stesso, delle proprie convinzioni, del proprio
senso esistenziale, non perché non possano essere validi, ma perché non tende ad assolutizzare, ed
è alla continua ricerca di creazioni (e non di scoperte), di divergenze (e non di convergenze), di
cambiamento. [...] La riflessività ironica, in senso culturalista, concerne la comprensione
soggettiva, e il continuo ripensamento, delle proprie opinioni, e credenze» (Santoianni 2005, p.
60). L'ironia «non dà garanzie, e si apre soltanto, continuamente, alla più assoluta libertà della
espressione umana» (Santoianni 2005, p. 67). Si tratta di una filosofia «liberal», che «non ha altro
scopo eccetto la libertà» (Santoianni 2005, p. 61).
6. La critica (1987-2008)
Subito dopo la morte di Rorty, avvenuta l'8 giugno 2007, sono stati scritti un po'in tutto il mondo
articoli di ricordo su di lui, solitamente da parte di giornalisti e filosofi a vario titolo filo-rortyani.
Questi articoli sono apparsi sia nelle principali testate nazionali che in riviste scientifiche
specializzate. Ad oggi sono già stati pubblicati usciti, in lingua inglese, dei volumi biografici. Ai
molti commenti entusiastici se ne sono fin dall'inizio affiancati altri più critici, prevalentemente
ricollegati ai temi nichilistici presenti in Rorty. Le interpretazioni di Rorty come nichilista iniziano
almeno a partire dagli anni Ottanta.
Nel 1987 Rorty viene definito da Larsen come nichilista sia per quanto riguarda la conoscenza delle
verità (gnoseologia), che per quanto riguarda l'ordine dei valori (etica) e molte alter cose (p. es.
metafisica, antropologia, politica) (Larsen 1987, p. 14, tr. it. mia). Il nichilismo in Rorty nega la
possibilità di realtà e di conoscenze di tipo metafisico.
Nel 1991 Bhaskar osserva in Rorty la profonda contraddizione di questo nichilismo metafisco, che
ricade in una «ontologia implicita» (implicit ontology), coperta da una parte in un positivismo e in
uno strumentalismo, dall'altra in uno scetticismo da far risalire prima di tutto a Hume e a Hempel
(Bhaskar 1991, p. viii). Da una parte Rorty, a parole, rifiuta qualsiasi ontologia; dall'altra, di fatto,
finisce per crearsi un'ontologia della democrazia.
Nel 1993 Bernstein scrive che è la democrazia, progressista, pluralista, ugualitaria, unitamente
all'idea di solidarietà e di cittadinanza, a costituire, per Rorty, l'«accordo fondamentale» (accord
fondamental), l'«accordo sul fondo» (accord sur le fond), il «filo rosso» (fil rouge) (Bernstein
1993, p. 14, tr. it. mia). Secondo Bernstein, l'idea da cui parte Rorty è «non argomentata» (non
argumentée), ed è da mettere in discussione che le idee a cui arriva possano contribuire a farci
«diventare migliori cittadini» (à devenir de meilleurs citoyens) (Bernstein 1993, p. 21, tr. it. mia).
Le posizioni di Rorty, per alcuni aspetti, sono state assimilate a quelle di Habermas. Bernstein
rovescia quest'ottica, interpretando Rorty in contrapposizione ad Habermas proprio per il
nichilismo che li separa. Rorty, nichilisticamente, si contrappone alla ricerca della verità,
dell'oggettività, della razionalità, dell'universalità e della validità, tutti temi invece centrali in
Habermas; per Habermas stesso, dal canto suo, tutto il pensiero di Rorty si riduce a contestualismo
e relativismo (Bernstein 1993, p. 13).
Nel 1993 Massarenti paragona le «fedi» di Rorty, quella democratica e quella ironica, a «gusti che
per definizione, proprio come i valori assoluti, non si discutono» (Massarenti 1993), a contraddire
le posizioni nichiliste rortyane.
Nel 1996 Reich scrive che il modello filosofico di Rorty, e il suo uomo ideale, non è solo il filosofo, e
l'uomo, democratico, ma è anche l'ironico, e che questa è una figura elitaria (cfr. p. es. Reich 1996),
a indicare ilo carattere elitario del nichilismo rortyano.
Tra tutti i critici ostili a Rorty, per durezza e chiarezza espositiva si distingue una donna italiana,
Irene Giurovich, particolarmente combattiva e severa nei confronti di Rorty in un testo del 2001:
Dietro il nichilismo liberale di Richard Rorty si nascondono progetti politico-culturali di natura
autoritaria. Il fine del filosofo postmetafisico è proprio quello di eliminare le opinioni che
divergono dalle proprie e di allontanare fisicamente quanti non accettano, in una presunta
democrazia, il suo pensiero relativista. In quanto filosofo relativista, le idee di cui si fa portavoce
ricalcano, seppur estremizzate, quelle del relativismo antico: inesistenza di una natura umana,
inconcepibilità di valori oggettivi, assenza della verità. [...] Una società tanto più apparentemente
laica e liberale quanto più concretamente dittatoriale. Infatti chi non si accoda al pensiero debole
dei postmetafisici non solo è bollato come pazzo, ma non ha neanche il diritto di chiamarsi
cittadino di una democrazia liberale. [...] La società rortiana non può che trasformarsi in una
eterna guerra di tutti contro tutti, [... uno] scontro libero e aperto» [...] . Una società «liberale»
solidale con il pensiero dominante [...] . Sorge il fondato sospetto che l'analisi rortiana poggi sulla
concezione di un uomo inesistente, astorico (Giurovich 2001).
Nel 2002 Geuras scrive, del pensiero di Rorty, che «è irrazionale e cade sul suo proprio peso [...] in
un'inconsistenza evidente», che le sue tesi «sono incapaci di stare in piedi da sole», così che tutto il
sistema rortyano «si autodistrugge», in una completa, radicale «auto-distruzione» (Geuras 2002,
tr. it. mia).
Nel 2003 Williams vede di cattivo occhio Rorty per il suo nichilismo: se «niente è assolutamente
certo», se «perfino le vie più profondamente consolidate possono essere rigettate o abbandonate»,
se non c'è altro che «un dubbio radicale e continuo», e se tutto questo alla fin fine si fa «eco
dell'antico scetticismo pirroniano», allora noi siamo paralizzati nella capacità di giudizio (Williams
2003, p. 76, tr. it. mia). Sempre Williams riporta indietro Rorty, nella sua ironia, allo scetticismo di
Pirrone e di Agrippa (cfr. Williams 2003, p. 77).
Sempre nel 2003, da Rouse, di Rorty viene messa in evidenza «l'idea che le scienze procurano un
modello per una libera comunità democratica», accostandola a quella di Conant 1947, Popper 1962,
Merton 1973 e Feyerabend 1978 (Rouse 2003, p. 93, tr. it. mia; per il riferimento a Conant, Popper,
Merton e Feyerabend, cfr. Rouse 2003, p. 103, nota 10); ma tutto il pensiero di Rorty, nel suo
insieme e nelle sue parti, viene visto come più simile al discorso della fantasia che a quello della
razionalità, come poetico e non argomentativo (more akin to poetry than calculation) (Rouse
2003, p. 96). Nel 2003 anche Rockwell denuncia le contraddizioni in cui cade il tentativo
nichilistico di Rorty di buttare a mare l'epistemologia (cfr. p. es. Rockwell 2003, p. 6).
Nel 2007 Palacio insiste sul carattere di indimostrabilità delle tesi rortyane, che finiscono col
risolversi in un credo etico-politico assolutamente dogmatico: «Per un liberale come Rorty, tutto il
progetto politico si inquadra nella difesa della libertà, e questa difesa è quella che rende possibile
occuparsi della giustizia» (Palacio 2007, p. 6, tr. it. mia). Rorty vorrebbe «difendere la libertà» e
«garantire il superamento delle ingiustizia» (Palacio 2007, p. 9, tr. it. mia), «però non c'è modo di
dubitare della democrazia né del liberalismo. Questo è un nostro presupposto di base, ed è questo il
limite del nostro linguaggio, dal quale non possiamo venirne fuori» (Palacio 2007, p. 13, tr. it. mia).
Nel 2007 Habermas, che per la prima volta aveva conosciuto Rorty nel 1974 ad un convegno su
Heidegger a San Diego (Habermas 2007b), aperta con una videoconferenza di Marcuse,
contrappone all'ateismo nichilistico di Rorty, dissacrante, un'idea etica politica religiosa, che fa dei
concetti di libertà e di democrazia qualcosa di sacro. Scrive: da una parte, «niente è sacro per Rorty
l'ironico, [...] l'ateo», dall'altra parte Rorty vorrebbe «riconciliare la paradisiaca bellezza delle
orchidee con il sogno trotsckyano di giustizia sulla terra» (Habermas 2007, tr. it. mia); vale a dire
che il sogno paradisiaco di Rorty sacralizza le idee di libertà e di democrazia, fondando la filosofia
sull'assoluto della democrazia, e la teoria sull'assoluto della tecnologia (cfr. Habermas 2007b, tr. it.
mia). Questo implica che niente è sacro fuorché la libertà, la democrazia e i progressi nelle
applicazioni tecniche. Così ci sono forme socio-politiche sacre, assolute, indiscutibili: quelle
democratiche e liberali; e valori etico-morali altrettanto sacri, assoluti, indiscutibili: quelli della
libertà individuale e dell'utile, dell'utilizzabile, del misurabile in termini di utilità. Ma libertà di chi?
Libertà da chi? Utilità a chi? A cosa? In contrapposizione a cosa? Alle inutilità degli altri?
Nel 2008 Vattimo osserva che per Rorty «il pragmatismo non significava soltanto 'è vero ciò che
funziona', ma anche 'noi siamo al mondo non per guardare come sono le cose ma per produrre, per
fare, per trasformare la realtà'» (Vattimo 2008, p. 11). Vattimo scrive: «Riassumerei i discorsi
rortyani [...] dicendo che nel Novecento la filosofia è passata dall'idea di verità all'idea di carità: il
valore supremo non è la verità come descrizione oggettiva, il valore supremo è l'accordo con gli
altri» (Vattimo 2008, p. 12).
7. Conclusioni: un nichilismo contraddittorio
Da un punto di osservazione psicologico, è possibile ipotizzare che il pensiero nichilistico di Rorty
abbia alla base alcuni atteggiamenti e bisogni nevrotici: un bisogno nevrotico di potere, inteso
come «fondamentale mancanza di rispetto verso gli altri», desiderio di «controllare gli altri per
mezzo dello sfruttamento intellettuale e della loro superiorità» (definizione di Horney 1942 in HallGinzey, ed. it. 1986, p. 184), oppure un bisogno nevrotico di riconoscimento sociale e prestigio,
oppure un bisogno nevrotico di ammirazione della propria personalità, oppure un bisogno
nevrotico di prodezze; ma soprattutto un bisogno nevrotico di perfezione e di inattaccabilità, tipico
della persona «timorosa di sbagliare e di essere oggetto di critiche, la persona che ha tale bisogno
cerca di rendersi irreprensibile e infallibile» (ibid., p. 185). Tutti questi bisogni nevrotici
potrebbero rientrare in un bisogno d'indipendenza e in un bisogno di potere (ibid., p. 185).
In particolare, l'ateismo nichilistico dichiarato da Rorty potrebbe accostarsi a quello che è stato
chiamato «ateismo nevrotico», conscio, inconscio o semiconscio (Raab 1993; cfr. Dacquino 1984,
in part. pp. 174, 176), nel senso che potrebbe nascere da un transfert negativo, da una rabbia di
transfert (conscia, semiconscia o inconscia) contro figure parentali o di autorità, avrebbe cioè alla
radice problemi di identificazione negativa con figure parentali o comunque autoritarie. Più facile è
ipotizzare che un ateismo nichilistico «nevrotico» di questo tipo sia stato acquisito non tanto da
Rorty in prima persona, quanto piuttosto dai suoi genitori, e poi trasmesso da questi al figlio, che
l'avrebbe semplicemente assimilato in modo acritico e passivo. Ma queste sono solo ipotesi sulle
motivazioni psicologiche che hanno spinto Rorty a fare filosofia e a farla in un certo modo.
Per quanto riguarda il suo pensiero, gli scritti di Rorty, che fino ad oggi sono stati letti quasi
esclusivamente attraverso le categorie del pragmatismo, in realtà possono essere letti anche, e forse
più profondamente, attraverso le categorie del nichilismo (gnoseologico, metafisico, etico e
politico); alcuni, anche se pochi, hanno aperto questa linea interpretativa, sia in senso nichilista
(cfr. p. es. Larsen 1987, p. 14), sia in senso antinichilista (cfr. p. es. Cambi 2005, p. viii);.
Interpretando gli scritti di Rorty nella prospettiva del nichilismo è possibile vederne l'unitarietà e la
linearità dai primi agli ultimi scritti. Questo tipo di interpretazione permette facilmente una critica
di fondo alle tesi di Rorty, evidenziando la contraddittorietà tra la dichiarata mancanza di assoluti
(di verità, di certezze, di fondamenti) e la fede, di fatto, in valori etico-politici assoluti (veri, certi,
fondamentali), a partire da quelli delle libertà individuali, della democrazia e della solidarietà atee.
Certamente anche per la fede cattolica la libertà è un presupposto essenziale della moralità delle
azioni umane e di quanto ne segue, nel bene e nel male (cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica,
(1992), 1730-1738). Tuttavia per tutta una tradizione autorevole della Chiesa, la persona è
considerata libera non per essenza, ma per partecipazione (cfr. p. es. S. Tommaso d'Aquino, S. Th.,
I-II, q. 10, a. 4; Forment 1997, p. 255).
Rorty, da una parte assolutizzandola e dall'altra rigettandone la trascendenza, finisce di fatto col
legittimare quell'eccesso della libertà che è l'anarchia, già ben rappresentata dalla figura di
Prometeo (cfr. p. es. Díaz 1997, p. 81; ma anche Díaz 1975a, 1975b, 1976 e 1980), e che corrisponde
alla superbia, alla presunzione, all'arroganza, alla vanità, all'edonismo (cfr. Catech. C. Catt., 173940). Nel tipo di libertà assoluta e indipendenza totale sostenuto da Rorty è possibile vedere un vizio
di accidia, inteso come «disgusto delle cose di Dio», «odio o indifferenza del sacro» (cfr. p. es.
Tommaso d'Aquino, S. Th., II-II, q. 35, aa. 1-2; De Malo, q. 11, aa. 1-2). L'ironia stessa,
atteggiamento fondamentale di Rorty, e tesi di fondo nei suoi scritti, è stata ritenuta peccato da San
Tommaso (cfr. S. Th., II-II, q. 113), e in qualche modo assimilata alla bugia (cfr. ibid., q. 110) , alla
simulazione e all'ipocrisia (cfr. ibid. q. 111), all'ostentazione (cfr. ibid., q. 112).
All'assoluto metafisico, in Rorty, si sostituisce, di fatto, un assolutismo tecnico (cfr. p. es. Benedetto
xvi, Caritas in Veritate, 2009, cap. vi, nn. 68-77), l'assoluto di una particolare tecnica di governo
politico, quello democratico, e un assolutismo etico, di una particolare condizione dell'uomo, quella
della libertà. In Rorty, l'assolutismo della metafisica viene, di fatto, sostituito con l'assolutismo
della tecnica, intesa come forma fondamentale dell'apparire, come nascondimento e
assolutizzazione del fenomeno (cfr. p. es. Heidegger), ma anche come quell'atteggiamento centrato
sull'uomo (sull'autonomia, l'autosufficienza e l'iniziativa dell'uomo) e come quella fede nel
progresso che sono propri dell'illuminismo greco (Protagora, Democrito, ecc.). Per Rorty la stessa
idea di solidarietà si riduce a convivenza pacifica senza riferimento a nessun assoluto, mettendo a
fondamento un convenzionalismo tale da mettere in discussione tutto, anche il principio del
miglior argomento (cfr. p. es. Habermas, Apel).
Alla base di tutto il pensiero rortyano, fin dai primi scritti, è chiarissima un'idea della democrazia
che, oltre a rimanere in Rorty un concetto vago e generico in sé né buono né cattivo (cfr. p. es.
López-López 1996 e 1997), in realtà è un sogno mai realizzato e mai realizzabile. Questa fede nella
democrazia è fondata su un presupposto antropologico estremamente ottimistico e inverosimile,
cioè che il mondo possa veramente trovare forme di convivenza solidali soddisfacenti senza
aperture alla trascendenza, senza la presenza e l'intervento della grazia, senza il coinvolgimento del
soprannaturale, senza verità.
Gli uomini non sono angeli (non possono esserlo), e questo mondo non è un paradiso (non può
esserlo), per cui non si riesce a capire come possa essere costruito un regno umano veramente
libero, solidale e buono (cioè di fatto angelico, paradisiaco) sulla terra laddove, tolto Dio, resta solo
il lupus est homo homini di Plauto (Asinaria, v. 495), il bellum omnium contra omnes, la war of
all against all, l'every man is enemy to every man di Hobbes (1642, De Cive, 1. 12; 1651,
Leviathan, 1. 13). Non si riesce a capire su cosa possano fondarsi le libertà e le solidarietà,
individuali e sociali, tanto meno come possano esserci pur rimanendo infondate, prive di
fondamenti. D'altra parte Rorty, nel suo desiderio di un mondo migliore, un regno umano delle
libertà e delle solidarietà, è coerente con il suo professato ateismo. La giustizia, e la solidarietà,
dell'uomo che non si apre alla relazione con Dio, sono infinitamente meno della misericordia, e
dell'amore, di Dio partecipato all'uomo.
Posto che la grazia non annulla la natura, ma la suppone e la perfeziona (cfr. p. es. S. Tommaso
d'Aquino, S. Th., I, q. 1, a. 8, 2um; q. 2, a. 2, 1um; II-II, q. 26, a. 9, ob. 2); la carità di Cristo è
tutt'altra cosa che la solidarietà dell'uomo (cfr. p. es. Maceiras 1997, p. 29), non è «al servizio di
servizio di strategie mondane» (Benedetto xvi, Deus Caritas Est, 2006, ii parte, n. 31b), per cui
oggi anche i cristiani, conformemente alla propria fede in Cristo, «non devono ispirarsi alle
ideologie del miglioramento del mondo» (ibid., 33). Dire che all'uomo può bastare una libertà, una
solidarietà senza assoluti, senza verità, senza fondamenti, senza principi, senza origini prime e
senza fini ultimi, senza la presenza, l'azione, l'amicizia di Dio, è come dire che l'uomo può vivere
tranquillamente «di solo pane» (Mt 4, 4; cfr. Dt 8, 3). È esattamente questa una delle tentazioni di
Satana a Gesù nel deserto, il Satana che si presenta come umanitario e umanista nell'offrire
all'uomo tutto il bene del mondo, nel mondo.
In questo modo «la speranza biblica del regno di Dio è stata rimpiazzata dalla speranza del regno
dell'uomo, dalla speranza di un mondo migliore che sarebbe il vero 'regno di dio'» (Benedetto xvi,
Spe Salvi, 2007, n. 59). «Un mondo che si deve creare da sé la sua giustizia è un mondo senza
speranza» (ibid., n. 42; cfr. n. 44), sia perché «solo Dio può creare giustizia» (ibid., n. 44), sia
perché all'uomo «può bastargli solo qualcosa di infinito» (ibid., n. 30). Il nichilismo, negando
l'assoluto, l'infinito, finisce col negare anche il finito, negando Dio, finisce col negare anche l'uomo,
a svuotarlo di ogni traccia di mistero, di soprannaturale, di divino, a ridurlo a una cosa della
natura, o tutt'al più a un animale politico. L'uomo non più come immagine di Dio, non più come
cosa molto, molto buona, ma come semplice «cosa» senza un perché particolare, incapace di una
condizione esistenziale (metafisica) e di atti (conoscitivi, etici, politici) propriamente umani.
Forse il pensiero di Rorty, nelle sue profonde contraddittorietà e insufficienze, è espressione del
limite della condizione umana e delle sue possibilità conoscitive. Limite che si apre sul mistero
della realtà umana e del mondo. Limite che si fa porta aperta alla grazia di Dio. Limite che al tempo
stesso, sotto un aspetto separa il finito dall'infinito, ci mantiene in atteggiamento di radicale
umiltà, povertà nel nostro status creaturale (cfr. p. es. San Bonaventura, Quaestio de humilitate, ad
1, ed. Quaracchi, Firenze, vol. v, p. 122, cfr. ib., viii, p. 658); sotto un altro aspetto, rende possibile
che il finito si unisca all'infinito, che l'uomo si faccia partecipe dell'amore di Dio e lo comunichi.
Tutto sommato, per quanto il pensiero di Rorty sia stato visto da molti come originale, non è
originale. Come è stato notato da alcuni (cfr. p. es. Williams 2003, p. 77), tutto il pensiero di Rorty
può esser fatto risalire allo scetticismo orientale attraverso le sue versioni greche tra il iv e il iii sec.
a. C. Pirrone, com'è noto, più giovane di Aristotele di una ventina d'anni, era vissuto tra il 365 e il
275 a. C., dal 334 al 324 aveva preso parte alla spedizione di Alessandro in Oriente, fino all'India, e
aveva probabilmente importato il suo pensiero dall'India e dalla Persia (cfr. p. es. Brunschwig
1996b, p. 535; Donini 2005, p. 256). Lo scetticismo indiano e persiano ripreso in Grecia, in forme
di radicalizzazione di atteggiamenti socratici e democritei, metteva in dubbio la possibilità stessa
della conoscenza delle cose nella loro vera natura, nel loro lato nascosto (le conoscenze come
dogmata). Lo scopo di Pirrone, nell'astensione da ogni asserzione (aphasia) e nella sospensione di
ogni giudizio (epoche), era «un progetto di felicità», «una ricetta infallibile per la felicità», una
«tranquillità sovrumana» (Brunschwig 1996, ed. it. p. 202), «l'ataraxia, cioè l'assenza totale del
turbamento e dell'inquietudine che causano l'infelicità dell'uomo» (Brunschwig 1996, ed. it. p.
204), ma anche l'insensibilità (apatheia) (cfr. ad es. Brunschwig 1996b, ed. it. p. 533). In effetti,
anche a Rorty quello che interessa, attraverso la sua filosofia, è il progetto di una felicità,
individuale e sociale, non sostanzialmente differente da quella di Pirrone e, in generale, degli
scettici antichi: una felicità che, alla fin fine, «cercava di annullare il desiderio» (Canto-Sperber
1996, p. 133). In questo modo, non è difficile concludere che l'intero pensiero nichilista di Rorty,
come quello di tutti i nichilisti, potrebbe finire col coincidere, alla fin fine, con uno scetticismo
tutt'altro che nuovo (cfr. p. es. Weischedel 1971).
Giovanni Gaetani
Oltre il nichilismo: il «sole invincibile»
di Albert Camus
Consultando un qualsiasi manuale di storia della filosofia contemporanea, molto probabilmente
non troveremo mai un capitolo dedicato esclusivamente ad Albert Camus -- al massimo il suo nome
verrà citato in appendice ad un altro filosofo, Jean-Paul Sartre, che nei sopraddetti manuali invece
ha una dimora pressoché stabile. Il perché di questa omissione risiede in un approccio a nostro
avviso pregiudiziale alla sua opera, la quale viene spesso ricondotta dagli «addetti ai lavori» sotto le
categorie della letteratura piuttosto che sotto quella della filosofia: la poeticità intrinseca del suo
scrivere, il suo far coincidere ad ogni concetto un immagine,1 nonché il fatto che solo due delle sue
opere sono veri e propri «livres d'idées» -- mentre per la parte restante troviamo soltanto romanzi
e opere teatrali -- sono elementi decisamente estranei al rigoroso linguaggio filosofico dei
contemporanei di Camus -- linguaggio dominato in gran parte da un approccio analitico e da quel
razionalismo di derivazione fenomenologica.
Oltre a ciò, riteniamo vi sia almeno un altro pregiudizio che impedisce una piena lettura del
pensiero camusiano: quello secondo cui tale pensiero sia essenzialmente un pensiero nichilista,
decadente, pessimista, nient'altro che l'ennesima espressione di quella «filosofia dell'assurdo» o di
quel «esistenzialismo crepuscolare» che prima e dopo la seconda guerra mondiale imperversò in
Europa -- ad esempio con Heidegger, Sartre, ma anche Beckett, Cioran, etc.
Questo saggio si ripropone di dissolvere questi due pregiudizi appena detti, e quindi: 1) da una
parte mostrare come l'opera di Camus possa essere letta, senza alcun difficoltà o forzatura, come
una coerente e unitaria filosofia -- consapevoli del fatto che molto probabilmente lo stesso Camus
non avrebbe accettato tale lettura;2 2) dall'altra, mettere in risalto la luminosità e la propositività di
un pensiero tutt'altro che nichilista -- «al centro della mia opera, c'è un sole invincibile».3 Il nostro
sarà un percorso volutamente «a tappe», proprio perché è lo stesso Camus che ha inteso in questo
senso4 la sua opera. Di essa infatti dirà, in una nota dei suoi Carnets:
La mia opera avrà tante forme quante sono le tappe sulla strada di una perfezione senza
ricompensa. Lo Straniero è il punto zero. Idem il Mito. La peste è un progresso, non dallo zero
verso l'infinito, ma verso un complessità più profonda che deve ancora essere definita. Il punto
d'arrivo (L'uomo in rivolta, n. d. A.) sarà il santo, ma avrà un valore aritmetico, misurabile come
l'uomo.5
1. La mediterraneità come condizione originaria
La prima di queste tappe è la «mediterraneità». Essa è l'armonia originaria, l'equilibrio naturale tra
uomo e mondo: è quella condizione solare e luminosa nella quale non cade ancora nessuna «ombra
di pensiero». Una condizione pre-riflessiva, pre-concettuale, e dunque silenziosa, di quel silenzio
accogliente che solo gli elementi naturali sanno offrire:
Mare, campagna, silenzio, profumi di questa terra, mi riempivo d'una vita odorosa e mordevo il
frutto già dorato del mondo, turbato di sentire il suo succo dolce e forte colare lungo le mie braccia.
No, non ero io che contavo, né il mondo, ma soltanto l'accordo e il silenzio che fra il mondo e me
faceva nascere l'amore. Amore che non avevo la debolezza di rivendicare per me solo, cosciente e
orgoglioso di esserne partecipe con tutta una razza nata dal sole e dal mare, viva e saporosa, che
attinge la propria grandezza dalla semplicità e in piedi sulle spiagge rivolge il proprio sorriso
complice al sorriso splendente dei cieli.6
Traspare chiaramente da queste parole quel senso di unione sensibile tra uomo e mondo nel quale
appunto ad essere prevalente non è né l'io, né il mondo in sé, ma piuttosto quel silente e tacito
consenso che i due elementi si scambiano senza parole. Il titolo del libro del 1939, Nozze, in cui
furono raccolti per la prima volta quelli che Camus definì «saggi solari», può sicuramente aiutarci
nella comprensione di tale condizione mediterranea: le «nozze», infatti, sono metafora di quella
unione sinergica tra l'uomo che si abbandona al mondo e il mondo che si dà in tutta la sua naturale
lucentezza e solarità; sono metafora di quella condizione in cui i due elementi si riuniscono per
riconciliarsi in un unico legame che non ha nulla di artificioso né di ricercato, poiché naturale e
originario. A tal proposito si legga la seguente nota dei Taccuini del maggio 1936:
Non staccarsi dal mondo. Non si fallisce nella vita quando la si pone in piena luce. Tutti i miei
sforzi, in tutte le situazioni, le sventure, le delusioni, tendono a ristabilire i contatti. E anche nella
tristezza, quale desiderio di amare e quale ebbrezza alla semplice vista di una collina nell'aria della
sera. Contatti con il vero, anzitutto con la natura, e poi con l'arte di coloro che hanno capito, e con
la mia se ne sono in grado. Se no, ho pur sempre davanti la luce, l'acqua, e l'ebbrezza, e le labbra
umide del desiderio. Una disperazione sorridente. Senza via d'uscita, ma tale da tenere
costantemente in esercizio un dominio di sé peraltro vano. L'essenziale: non perdersi e non
perdere ciò che di se stessi dorme nel mondo.7
Quel «non staccarsi dal mondo» all'inizio della nota è un vero e proprio «imperativo morale»:
bisogna aderire al mondo, al suo lato più vivo e spontaneo, non occasionalmente come se si
trattasse di una temporanea tregua nell'esistenza, ma costantemente proprio per condurre un
esistenza vera e autentica. La natura viene intesa quindi come elemento catartico, come possibilità
di un esperienza originaria dissolvente la coscienza linguistica, che con i suoi continui rimandi e
problemi non lascia spazio ad alcun tipo di silenzio:
Spesso mi è stato detto: non esiste nulla di cui essere fiero. Si, qualcosa c'è: questo sole, questo
mare, il mio cuore che balza di giovinezza, il mio corpo che sa di sale e l'immenso scenario dove si
incontrano l'amore e la gloria nel giallo e nell'azzurro. È per conquistare questo che devo adoperare
la mia forza e le mie risorse.
Ma, attenzione, questa capacità catartica degli elementi naturali non è né mistica -- «qui tutto mi
lascia integro, non abbandono nulla di me stesso» -- né divina -- «qui gli dei servono da letto»: è in
realtà una dimensione di immediata lucidità che non conosce ancora Dio, neanche come mito,
semplicemente perché di esso non ve ne ha ancora la necessità. Dire quindi che tale felicità
naturale è un ateismo è sicuramente un errore, poiché tale ateismo lo troveremo soltanto
successivamente nella storia degli uomini, quando l'idea di Dio sarà già sorta, sarà già stata creata e
soltanto allora negata. In questo fragile istante iniziale di gioia naturale che stiamo sforzandoci di
descrivere, Dio non ha posto perché non ha posto il suo elemento genetico, che è il male: come
mostreremo più avanti, solo successivamente all'esperienza del male -- e proprio in risposta ad essa
-- sorgerà l'idea di Dio. Per ora, essa non esiste. E non esistono neanche problemi filosofici, morali
o esistenziali. Se esistono, vengono semplicemente dimenticati: «c'è un tempo per vivere e un
tempo per portare testimonianza del vivere. C'è anche un tempo per creare, che è meno naturale.
Mi basta vivere con tutto il mio corpo e portare testimonianza con tutto il cuore. Vivere Tipasa, 8
portare testimonianza e l'opera d'arte verrà in seguito. C'è in questo una libertà».9
Ci sono essenzialmente due elementi -- uno biografico, l'altro filosofico -- che hanno determinato
tale visione della natura in Camus: da una parte, l'infanzia algerina, dall'altra, la sua rivendicata
«grecità». Della prima Camus ha parlato molto, implicitamente nelle sue opere, esplicitamente nei
suoi Taccuini e in alcune interviste:
La povertà10 intanto non è mai stata una disgrazia per me: la luce vi spandeva le sue ricchezze.
Persino le mie rivolte ne sono state illuminate. Quasi sempre, credo di poterlo dire senza barare,
furono rivolte per tutti e perché la vita di tutti fosse elevata nella luce. Non è certo che il mio cuore
fosse disposto per natura a questa sorta di amore. Ma le circostanze mi hanno aiutato. Per
correggere una indifferenza naturale, venni messo a metà strada fra la miseria e il sole. La miseria
mi impedì di credere che tutto sia bene sotto il sole e nella storia; il sole mi insegnò che la storia
non è tutto. Cambiare vita, sì, ma non il mondo, di cui facevo la mia divinità.11
Dal che si deduce che l'infanzia di Camus è sostanzialmente segnata da due fattori complementari:
la povertà -- oltre alle gravi condizioni familiari, occorre ricordare che Camus intorno ai 17 anni si
ammalò di tubercolosi, malattia che lo perseguitò per tutta la vita -- e la natura, che quella povertà
compensava. Grazie a questa singolare esperienza biografica si comprende il perché Camus non si
sia mai abbandonato ad un ingenuo edonismo o ad un esasperato nichilismo -- «la mia più costante
tentazione, quella contro cui io non ho mai cessato di condurre un estenuante combattimento, è il
cinismo»12 -- e si comprende anche la continua ossessione di affiancare temi tanto eterogenei
quanto apparentemente inconciliabili come «bellezza e povertà», «bellezza e malattia», «bellezza e
lotta contra l'ingiustizia». Il saggio Ritorno a Tipasa da questo punto di vista è illuminante, perché
ci parla allo stesso tempo dell'infanzia di Camus e dell'appena citato binomio «bellezzaingiustizia»:
Cresciuto nello spettacolo della bellezza che era la mia sola ricchezza, avevo cominciato nella
pienezza. Poi era venuto il filo spinato, voglio dire le tirannie, la guerra, le polizie, il tempo della
rivolta. Era stato necessario mettersi in regola con la notte: la bellezza del giorno non era più che
un ricordo. [...] Tuttavia, in tutti quegli anni (trascorsi lontano da casa a Parigi, n. d. A.), mi
mancava oscuramente qualcosa. Quando uno ha avuto una volta la fortuna di amare intensamente
passa la vita a cercare di nuovo quell'ardore e quella luce. La rinuncia alla bellezza e alla felicità
sensuale che ad essa è legata, il servire esclusivamente l'infelicità, richiede una grandezza che mi
manca. Ma, in fin dei conti, niente di ciò che costringe a escludere è vero. La bellezza isolata finisce
col far le grinze, la giustizia solitaria finisce con l'opprimere. Chi vuol servire una escludendo l'altra
non serve nessuno, né se stesso e, alla fine, serve doppiamente l'ingiustizia.13
Quindi, da una parte, un infanzia passata ad amare intensamente la bellezza del giorno e della
natura, dall'altra, l'esilio da quella terra materna e da quella condizione sensuale dettato dall'inizio
della notte, metafora del male, sia fisico -- si pensi ancora una volta alla sua precaria salute -- sia
morale ed esistenziale -- l'esperienza della prima guerra, anche se toccò marginalmente l'Algeria, lo
rese orfano del padre. Ma tale scoperta del «male nel mondo» non fu distruttiva: Camus infatti non
sprofondò nella depressione o nel pessimismo, proprio perché, come abbiamo detto in precedenza,
non dimenticò mai le suo origini geografiche e spirituali. Prima di definirsi europeo, egli era e si
sentiva sempre algerino, perché, se in lui vivevano due anime, la più profonda delle due era sempre
quella mediterranea. Certo, in Europa conobbe il male degli uomini, lo sfruttamento, il
totalitarismo, la necessità della lotta, ma non per questo rinnegò l'insegnamento della sua terra
d'origine:
Non ho potuto rinnegare la luce in cui sono nato e tuttavia non ho voluto rifiutare le servitù di
questo tempo. Sarebbe troppo facile contrapporre al dolce nome di Tipasa altri nomi più sonori e
più crudeli: per gli uomini d'oggi c'è una strada interiore che io conosco bene per averla percorsa
nei due sensi, e va dalle colline dello spirito alle capitali del delitto. [...] Visto che poche epoche
richiedono come la nostra che si faccia eguali al meglio come al peggio, mi piacerebbe appunto non
eludere nulla e conservare intatta una doppia memoria. Si, c'è la bellezza e ci sono gli umiliati. Per
quanto difficile che sia l'impresa, vorrei non essere mai infedele né all'una né agli altri.14
Bellezza e umiliazione, sole e miseria, mare e povertà: c'è sostanzialmente un binomio di questo
tipo dietro la mediterraneità camusiana e, in ultima analisi, dietro l'intera opera. Ma basta solo
questo rimando all'infanzia per spiegare tale concezione? Evidentemente no. Come prima
preannunciato, ci concentreremo ora sull'altro elemento che influì su tale visione della natura: la
grecità. La Grecia, infatti, è per Camus più di un luogo geografico: essa è un ideale filosofico, un
modo di vivere, di pensare, di orientarsi nel mondo. Rappresenta quell'ideale originario e originale
da cui nacque l'Europa, la quale ben presto da esso si allontanò, voltandogli le spalle, come una
giovane figlia che misconosce la sua stessa madre perché forte della propria presunta autonomia.
Eppure, proprio perché da essa ci siamo allontanati con tanto disprezzo e con tanta conseguente
violenza, non possiamo che rivolgerci di nuovo ad essa, «la Grecia alla quale bisogna sempre
ritornare».15
In sostanza sono tre i punti di divergenza tra spirito europeo -- incarnato massimamente dalle
filosofie tedesche -- e spirito greco. Il primo risiede nel differente valore attribuito alla bellezza:
Noi abbiamo esiliato la bellezza, i Greci per essa han preso le armi. È la prima differenza, ma risale
molto addietro. Il pensiero greco si è sempre trincerato nell'idea di limite. Non ha spinto nulla
all'estremo, né il sacro, né la ragione. Ha tenuto conto di tutto, equilibrando l'ombra con la luce.
Invece la nostra Europa, lanciata alla conquista della totalità, è figlia della dismisura. Essa nega la
bellezza come nega tutto quello che non esalta. E, per quanto in modo diverso, esalta una sola cosa:
l'impero futuro della ragione.16
La bellezza universale viene rinnegata, «esiliata» da quella Europa che rincorre superba l'ideale
della ragion pura e nient'altro che quello. Ma l'errore, per Camus, non è nella ragione in sé, come se
essa fosse un male a priori. Tutt'altro. L'errore consiste piuttosto in quel esasperato razionalismo
che si crede capace di tutto, che si crede senza limite, illimitato, ignaro dell'insegnamento della
«vecchia Nemesi, dea della misura, non della vendetta. Chi supera il limite, ne è castigato senza
pietà».17
Di qui si arriva al secondo punto di divergenza: la questione del limite, della misura. Se i Greci,
come si legge nella precedente citazione, vissero nel limite senza spingere mai nulla all'estremo,
tenendo conto di tutto, luce e ombra, giorno e notte, l'Europa, bramosa di totalità, volendo fare del
mondo un unico eterno giorno, è finita per sprofondare in un unica eterna notte. La misura sta
proprio in questo: nel considerare tutto e sempre, e di conseguenza nel non escludere mai un
aspetto dell'esistenza (ad esempio, la natura) a discapito di un altro (ad esempio, la ragione),
perché, riprendendo le parole di una precedente citazione, «niente di ciò che costringe ad escludere
è vero». Ma l'Europa è, da questo punto di vista, il simbolo dell'oblio, e per questo «oggi è
indecente proclamare che siamo figli della Grecia».18
Infine, il terzo e ultimo punto di divergenza tra il «nostro» pensiero e quello greco consiste nella
così definibile «divinizzazione della storia». Se, come abbiamo detto, l'Europa ha dimenticato la
bellezza per ipertrofizzarsi di ragione, è perché in ultima analisi ha deificato «la Storia» obliando
ciò che veniva prima di essa: la natura, l'elemento originale. Dirà Camus a riguardo, in una sua
pagina di taccuino:
Tutto lo sforzo del pensiero tedesco è consistito nel sostituire al concetto di natura umana quello di
situazione umana, e di conseguenza la storia a Dio e la tragedia moderna all'antico equilibrio.
L'esistenzialismo moderno spinge questo sforzo ancora più in la e introduce nell'idea di situazione
la stessa incertezza che in quella di natura. Non resta più altro che movimento. Ma io, come i greci,
credo nella natura.19
Quando Camus parla di «pensiero tedesco» si riferisce, oltre che all'appena citato esistenzialismo
(Heidegger), anche e soprattutto al materialismo marxista e all'idealismo hegeliano: se il primo è
colpevole di aver abiurato lo spirito e il secondo di essersene ubriacato, entrambi si ritrovano
accomunati in quello smisurato ottimismo nel procedere razionale della storia. Camus non crede
nella storia, o almeno non vi crede nella misura in cui essa viene divinizzata, disumanizzata, resa
un entità a sé capace di agire secondo fini all'uomo sconosciuti, secondo una imprevedibile «astuzia
della ragione». Egli crede piuttosto che dietro e alla base dei singoli eventi storici, più che la
ragione e gli ideali, ci siano e non possano non esserci che gli uomini -- con i loro bisogni materiali
e spirituali. Ma se in prima battuta la dimenticanza di tale evidenza sembra essere una semplice
ingenuità filosofica, in realtà essa è qualcosa di più di una semplice distrazione del pensiero, perché
presto tale meditazione, dapprima solo astratta, ricadrà violentemente sulla terra con la sua furia
totalizzante e omicida: «la virtù», infatti, «non può separarsi dal reale senza diventare principio di
male».20
Per tutti questi motivi Camus rivendicherà sempre la solarità e l'onestà del pensiero greco contro la
cupezza e l'estremismo dello spirito europeo -- che «non filosofeggia più a colpi di martello, ma di
cannone». L'insegnamento ellenico sarà allora essenzialmente duplice: da una parte il ritorno alla
natura, che «è sempre lì» e che «alla follia degli uomini contrappone i cieli calmi e le proprie
ragioni»; dall'altra la riconsiderazione del limite e della misura -- «ammettere l'ignoranza, rifiutare
il fanatismo, por limiti al mondo e all'uomo, il viso amato, la bellezza insomma, è questo il terreno
su cui ci ricongiungeremo ai Greci».21
2. Perdere il mondo: l'estraneità
Tale condizione mediterranea, per come l'abbiamo descritta, è però una situazione fragile,
destinata presto a infrangersi e a mutare in altro. Se, come abbiamo già detto, in questa fase di
armonia naturale l'uomo quasi non si distingue dal mondo in cui abita, se egli appunto in questa
spontanea concordanza non si distacca da esso, ci sono però delle «situazioni limite» -- per dirla
alla Jaspers -- che mutano il rapporto tra gli elementi e minano la persistenza dell'uomo in tale
stato. La natura, infatti, per come l'abbiamo descritta finora, ha sempre mostrato un volto solare,
accogliente e pacifico, ma in realtà -- non c'è certo bisogno di dimostrarlo -- essa non è solo questo,
anzi, si può facilmente sostenere che essa si riveli così ospitale soltanto in minima parte e soltanto
in determinati luoghi, ad esempio nell'Algeria di Camus.
Le situazioni limite di cui parlavamo sono quelle in cui l'individuo sperimenta sulla sua pelle il
male derivante dalla rottura dell'equilibrio che intercorreva tra sé e il mondo: lì dove regnava
l'imperturbabilità di quell'animo abituato a vivere in un ambiente familiare, lì dove ci si sentiva
ancora «una docile fibra dell'universo22», sopraggiunge d'improvviso e senza nessuna ragione un
evento sconvolgente, capovolgente -- sia che si tratti di un fatto naturale, sia che si tratti di un
gesto umano. Alla prima categoria di eventi «estranianti» appartiene, ad esempio, quel vento
descritto nel saggio Il vento a Djemila:
Ci sono luoghi dove muore lo spirito perché nasca una verità che ne è l'esatta negazione. Quando
sono andato a Djemila, c'era vento e sole, ma questa è un'altra storia. Prima bisogna dire che vi
regnava un gran silenzio pesante e senza incrinatura -- qualcosa come l'equilibrio della bilancia. I
gridi degli uccelli, il suono felpato del flauto a tre buchi, uno scalpiccio di capre, suoni venuti dal
cielo, tanti rumori di cui erano fatti il silenzio e la desolazione di quei luoghi. [...] E ci si trova là,
raccolti, messi di fronte alle pietre e al silenzio, man mano che il giorno avanza e le montagne
s'ingrandiscono diventando viola. Ma il vento soffia sul pianoro di Djemila. Nella gran confusione
del vento e del sole che mescola alle rovine la luce, si forgia qualcosa che dà all'uomo la misura
della sua identità con la solitudine e col silenzio della città morta.23
Abbiamo messo in corsivo la parola «silenzio» proprio per sottolineare la sua ossessiva e ripetitiva
presenza in questo passo: in meno di una pagina ben quattro volte. Evidentemente non è solo una
casualità. Silenziosa, infatti, era la stessa condizione mediterranea che prima abbiamo descritto.
Silenziosa perché antecedente l'origine del pensiero e, se non proprio della coscienza, almeno del
suo monologo interiore. In tale condizione regnava un mutismo particolare, dettato da una
sostanziale imperturbabilità dell'esistenza individuale -- esistenza non ancora sconvolta da alcun
tipo di accadimento. «Ma il vento soffia su Djemila», ed ecco l'imperturbabilità infrangersi:
Mi sentivo sbattere dal vento come gli alberi d'una nave. Svuotato dall'interno, con gli occhi
brucianti, le labbra screpolate, la pelle mi si disseccava fino a non essere più mia. Prima, con la
pelle, decifravo la scrittura del mondo. Il mondo vi tracciava i segni della sua tenerezza o della sua
collera, riscaldandola con il soffio estivo o mordendola con denti di brina. Ma per tanto tempo
strofinato dal vento, scosso per più di un'ora, stordito dalla resistenza, perdevo coscienza del
disegno che il mio corpo tracciava. Come i ciottoli dalle maree, io ero levigato dal vento, consumato
fino all'anima.24
La terra, fino allora grande ed accogliente madre, perde ora tutta la sua familiarità: il disegno del
mondo, fino ad allora dispiegato chiaramente di fronte agli occhi, perde il suo ordine, svanisce,
come se quel vento l'avesse soffiato via. Si afferma allora nell'individuo il sentimento della più
profonda passività, quello sperimentato nei momenti in cui il mondo con i suoi fatti supera la
nostra cifra: l'estraneità. Quella «sottile pellicola di sole» che rivestiva «ogni cosa di un eterno
sorriso»25 si è spezzata, rivelando la sua intrinseca fragilità. Quel silenzio dominante, che
assicurava la quieta e felice permanenza tra gli oggetti del mondo, ora si è infranto, lasciando il
posto ad un assordante incoerenza e inconciliabilità tra l'animo umano e il mondo: ci si distacca dal
mondo -- e con quale sensazione di disorientamento!
In questo caso il sentimento dell'estraneità è stato provocato da un accadimento naturale quale il
vento, ma in un altro caso, come abbiamo accennato prima, potrebbe essere invece un gesto
umano, dell'individuo o altrui. È il caso de Lo straniero. Il protagonista di questo romanzo,
Meursault, vive in un sostanziale silenzio per tutta la prima metà del libro: è un impiegato che
conduce un esistenza tanto solare quanto anonima, tanto sensuale quanto muta -- così muta che
neanche la morte della madre interromperà tale silenzio, lì dove ci si aspetterebbe il fragore di un
pianto. Egli è capace di passare in tale silenzio un intera domenica affacciato al balcone,26 senza
porsi alcun problema su come impiegare il suo tempo. Soltanto quando, con il sole ormai calato, il
freddo si farà sentire egli rientrerà in casa, con in testa il disarmante pensiero che «era sempre
un'altra domenica passata, che adesso la mamma era seppellita, che avre (bbe) ripreso il lavoro; e
(che) tutto sommato non era cambiato nulla».27
Nulla è cambiato, come dire che ogni cosa gli è indifferente. Ogni istante non si distingue da quello
precedente: la veglia alla camera mortuaria, il funerale, l'incontro con Maria, il ritorno al lavoro,
etc. Tutto scorre quietamente nello stesso silenzio, ma non per questo si può dire che egli sia triste,
o felice. Per descrivere l'agire quotidiano di un personaggio simile si possono usare soltanto
espressioni neutre del tipo: «egli vive», «egli mangia», «egli fuma» e così via. La felicità, la
tristezza, come il matrimonio, il dolore, l'amore, sono concetti non suoi: essi appartengono
piuttosto a quella morale comune che lo circonda e che egli ignorerà fino a quando gli sarà
possibile. Si leggano queste parole -- apparentemente insignificanti, cariche di una certa «ingenua
lucidità» -- per comprendere fino a che punto si spinga l'indifferenza di Meursault:
La sera Maria è venuta a prendermi e mi ha domandato se volevo sposarla. Le ho detto che la cosa
mi era indifferente («cela m'était égal»), e che avremmo potuto farlo se lei voleva. Allora ha voluto
sapere se l'amavo. Le ho risposto, come già avevo fatto un'altra volta, che ciò non voleva dir nulla,
ma che ero certo di non amarla. «Perché sposarmi allora?» mi ha detto. Le ho spiegato che questo
non aveva alcuna importanza e che se lei ci teneva potevamo sposarci. Del resto era lei che lo aveva
chiesto e io non avevo fatto che dirle di sì. Allora lei ha osservato che il matrimonio è una cosa
seria. Io ho risposto: «No». È rimasta zitta un momento e mi ha guardato in silenzio. Poi ha
parlato: voleva soltanto sapere se avrei accettato la stessa proposta se mi fosse venuta da un'altra
donna cui fossi legato allo stesso modo. Io ho detto: «Naturalmente». Allora si è domandata se lei
mi amava, e io, su questo punto, non potevo saperne nulla. Dopo un altro istante di silenzio, ha
mormorato che ero molto strambo, che certo lei mi amava a causa di questo, ma che forse un
giorno le avrei fatto schifo per la stessa ragione. Siccome io tacevo, non avendo niente da dirle, mi
ha preso il braccio sorridendo e ha detto che voleva sposarmi. Io ho risposto che l'avremmo fatto
appena lei avesse voluto.28
In questo passaggio ritroviamo due fondamentali tratti caratteriali di Meursault -- elementi che in
ultima analisi caratterizzano in generale qualsiasi esistenza «straniera»: il primo è l'ignoranza e il
rifiuto di qualsiasi forma di valore o di ideale; il secondo, la sua scoraggiante passività. Il primo è
un tratto che permea tutto libro29: in ciò Meursault è un personaggio nietzschiano -- in quanto
appunto non crede in alcun valore «metafisico» né di «retro-mondo» -- ma di un nietzschianesimo
immediato e irriflesso. Se egli non crede, non è né per volontà ragionata né per convinzione
filosofica, ma per sua disposizione naturale: egli conosce soltanto ciò che «sente», e soltanto a
questo si attiene nel suo vivere. «Il ne joue pas le jeu»30: Meursault non sta al gioco. Non sta al
gioco perché si rifiuta di mentire -- «il refuse de mentir».
Di qui arriviamo al secondo aspetto prima annunciato: la scoraggiante e inalterabile passività di
Meursault. Egli è, per sua natura, un personaggio privo di iniziativa: se con il termine «agire» si
intende essere attivi, propositivi, allora si può e si deve dire che Meursault non agisce, in alcun
modo. Egli è infatti capace soltanto di rispondere a stimoli e richieste esterne, ma mai di iniziare
un'azione a partire da una sua volontà precisa. Egli «si limita a rispondere alle domande»31 come
un meccanismo ad ingranaggi risponderebbe agli stimoli ad esso esterni. Lasciato a sé, egli rimane
in quiete: viene smosso soltanto talvolta da bisogni istintuali come il mangiare e il bere, o il fumare.
Meursault è dunque il simbolo della passività e dell'indifferenza32: è, sin da subito, lo straniero per
eccellenza. Ma per tutta la prima parte del libro non ne è consapevole. A condurlo sulla soglia della
sua personale presa di coscienza è uno di quegli eventi estranianti di cui parlavamo prima. Invitato
da Raimondo a passare una domenica al mare, Meursault si ritrova nel mezzo di un regolamento di
conti tra il suo compagno e degli arabi. Lo scontro finirà con il ferimento di Raimondo.
Successivamente, dopo un altro scontro -- stavolta però sventato -- Meursault si ritroverà a
passeggiare da solo sulla spiaggia, sotto il sole caldo che non gli dà tregua: decide allora di andarsi
a rinfrescare alla fonte dietro le rocce, lì dove avevano incontrato prima gli arabi, lì dove incontra la
sua futura vittima. Il tono della narrazione è tesissimo: gli occhi di Meursault bruciano per il sale, il
sudore e il sole. I due parlano un linguaggio animale, fatto solo di sguardi e di gesti, e in effetti
l'intera scena è la narrazione di uno scontro fra animali. Quando l'arabo improvvisamente
sfodererà il suo coltello, perché il suo rivale si era avvicinato a lui di un passo, e quando il riflesso di
tale coltello abbaglierà gli occhi di Meursault, la risposta di quest'ultimo non sarà né riflessiva né
ragionata, ma istintiva, immediata, incosciente: un primo colpo di pistola seguito da altri quattro,
sparati con quella rivoltella che prima Raimondo aveva dato a Meursault, ma della quale
quest'ultimo già si era dimenticato. Le parole che narrano il fatto non possono essere più
significative per noi:
Quella spada ardente (il riflesso del coltello sugli occhi, n. d. A.) mi corrodeva le ciglia e frugava nei
miei occhi doloranti. È allora che tutto ha vacillato. Dal mare è rimontato un soffio denso e
bruciante. Mi è parso che il cielo si aprisse in tutta la sua larghezza per lasciare piovere fuoco. Tutta
la mia persona si è tesa e ho contratto la mano sulla rivoltella. Il grilletto ha ceduto, ho toccato il
ventre liscio dell'impugnatura ed è là, in quel rumore secco e insieme assordante, che tutto è
cominciato. Mi sono scrollato via il sudore ed il sole. Ho capito che avevo distrutto l'equilibrio del
giorno, lo straordinario silenzio di una spiaggia devo ero stato felice. Allora ho sparato quattro
volte su un corpo inerte dove i proiettili si insaccavano senza lasciare traccia. E furono come
quattro colpi secchi che battevo sulla porta della sventura.33
Ecco la rottura dell'equilibrio mediterraneo -- dell'«equilibrio del giorno». Ecco il suono secco e
violento che distrugge lo «straordinario silenzio» in cui aveva vissuto fino ad allora Meursault. Nel
nostro percorso, questo è il punto che sancisce il drammatico passaggio dalla mediterraneità
all'estraneità,34 e con esso, dall'incoscienza alla coscienza. Infatti, se è vero che questi spari di
Meursault sono atti irriflessi ed involontari, come irriflessi ed involontari sono stati tutti i suoi gesti
finora, è vero anche che soltanto dopo di essi ci sarà spazio per il primo -- e unico -- gesto
consapevolmente proprio. Si tratta dello sfogo veemente e incontrollato a quel prete che
insistentemente voleva «salvarlo», ora che era stato condannato a morte e mancava poco alla sua
esecuzione. Dopo una serie di silenzi e di brevi risposte, Meursault esplode:
Allora, non so per quale ragione, c'è qualcosa che si è spezzato in me. Mi sono messo a urlare con
tutta la mia forza e l'ho insultato e gli ho detto di non pregare e che è meglio ardere che scomparire.
L'avevo preso per la sottana. Riversavo su di lui tutto del mio cuore con dei sussulti misti di collera
e di gioia. Aveva l'aria così sicura, vero? Eppure nessuna delle sue certezze valeva un capello di
donna. Non era nemmeno sicuro di essere in vita dato che viveva come un morto. Io, pareva che
avessi le mani vuote. Ma ero sicuro di me, sicuro di tutto, più sicuro di lui, sicuro della mia vita e di
questa morte che stava per venire. Si, non avevo che questo. Ma perlomeno avevo in mano questa
verità come essa aveva in mano me. Avevo avuto ragione, avevo ancora ragione, avevo sempre
ragione. Avevo vissuto in questo modo e avrei potuto vivere in quest'altro. Avevo fatto questo e non
avevo fatto quello. Non avevo fatto una tal cosa mentre ne avevo fatta una tal altra. E poi? Era come
se avessi atteso sempre quel minuto... e quell'alba in cui sarei stato giustiziato. Nulla, nulla aveva
importanza e sapevo bene il perché. [...] Mi aprivo per la prima volta alla dolce indifferenza del
mondo.35
Con queste parole36 il personaggio di Camus afferma esplicitamente il nichilismo del reale e,
contemporaneamente, la sua ineludibile estraneità ad esso. Ne prende finalmente coscienza: fino
ad allora si era limitato a vivere in tale sentimento tacitamente e inconsciamente. Ma, attenzione,
questa che abbiamo chiamato «affermazione nichilista» è in realtà tutt'altro che una affermazione:
essa è una vera e propria negazione, una «verità negativa»,37 che distrugge senza alcuna volontà di
creare, e Camus stesso ne è consapevole.38 Per questo, allo stesso modo in cui, filosoficamente
parlando, bisogna andare oltre Nietzsche -- «la coscienza più acuta del nichilismo», il filosofo con il
quale «per la prima volta il nichilismo diviene cosciente»39 -- occorre, nel proprio vivere, superare
Meursault e la sua estraneità.
Per esso, il silenzio del mondo è divenuto vuoto e assordante, lì dove prima gli garantiva quella
familiarità vitale e quella felicità sensuale. Ma non si torna indietro in alcun modo: una volta
perduto il mondo, non c'è possibilità di ritorno a nessun tipo di «età d'oro» o di «stato di natura».
L'uomo estraniatosi al mondo non può che tentare di riappropriarsi del mondo stesso secondo
un'altra direzione, perché un'esistenza fino a questo punto «straniera» è una condizione
impossibile in cui mantenersi.
3. Un'impossibile riappropriazione: l'assurdo
Qual è, dunque, quell'imponderabile sensazione che priva lo spirito del sonno necessario alla vita?
Un mondo che possa essere spiegato, sia pure con cattive ragioni, è un mondo familiare; ma
viceversa, in un universo subitamente spogliato di illusioni e di luci, l'uomo si sente un estraneo, e
tale esilio è senza rimedio, perché privato dei ricordi di una patria perduta o della speranza di una
terra promessa. Questo divorzio tra l'uomo e la sua vita, fra l'attore e la scena, è propriamente il
senso dell'assurdo.40
Abbiamo iniziato questo terzo capitolo direttamente con una citazione da Il mito di Sisifo -- il libro
che maggiormente affronteremo parlando dell'assurdo -- proprio per sottolineare subito quella
svolta linguistica e metodologica che compie Camus in questa opera: non ci troviamo più, infatti,
all'interno di quella narrazione romanzesca in prima persona caratteristica de Lo straniero, e
nemmeno all'interno di quel tono autobiografico tipico dei Saggi solari, ma piuttosto siamo di
fronte ad un linguaggio in terza persona che riflette un'esigenza non più solamente descrittiva e
narrativa, ma autenticamente filosofica e chiarificatrice. E d'altronde, l'intento è fin dalle prime
pagine più che chiaro.41 Preferiamo comunque non approfondire troppo tale discorso metatestuale, quanto più concentrarci sul testo in sé e sul concetto di assurdo che in esso viene discusso.
Finora abbiamo affrontato due tappe del percorso filosofico camusiano, la mediterraneità e
l'estraneità, esemplificando il passaggio dalla prima alla seconda condizione come un distaccarsi
dell'uomo dal mondo. In questo distacco, l'uomo, che prima possedeva con familiarità il suo
ambiente vitale, perde il mondo. Seguendo la metafora, l'assurdo -- terza tappa del percorso -- è
appunto l'umano e impossibile tentativo di riappropriazione del mondo: il reale deve essere di
nuovo compreso, spiegato, chiarificato, reso familiare; il male, che come abbiamo visto è l'elemento
fondamentale che conduce all'estraneità, va giustificato in qualche modo, perché è impossibile
mantenersi saldi di fronte alla sua incomprensibilità.
Camus, in sostanza, individua due ben definite -- e tra loro collegate -- vie d'uscita dall'estraneità:
da una parte, quello che potremmo definire il «ritorno al mondo» -- dove con tale espressione si
intende quell'atto che tenta di rendere nuovamente familiare il mondo stesso attraverso una
comprensione razionale di esso; dall'altra, il suicidio, inteso come affermazione dell'impossibilità
del sopraddetto «ritorno al mondo». Analizziamo le due alternative, iniziando dall'ultima.
Il suicidio è il riconoscimento esplicito e radicale della «vittoria del mondo» sul nostro tentativo di
condurre un'esistenza sensata e coerente in esso. «Uccidersi», scriverà Camus nelle prime pagine
del Mito, «è confessare: confessare che si è superati dalla vita o che non la si è compresa».42 In
sostanza, è l'affermazione di una impossibilità, quella di non poter vivere in un modo tale che «ne
valga la pena».
Prima il problema del senso o non-senso della vita non si poneva, perché l'individuo, trovandosi in
una condizione animale, era tutt'uno con il suo mondo: «se fossi albero tra gli alberi o gatto fra gli
animali, questa vita avrebbe un senso o piuttosto questo problema non sussisterebbe, perché farei
parte del mondo. Io sarei quel mondo».43 Ma ormai ci siamo distaccati da esso, e il mondo è per
noi ora un estraneo:
Scendiamo ancora di un gradino (rispetto all'assurdo, n. d. A.) ed ecco l'estraneità: accorgersi che il
mondo è "denso", intravedere fino a che punto una pietra sia estranea e per noi irriducibile, con
quale intensità la natura, un paesaggio possano sottrarsi a noi. Nel fondo di ogni bellezza sta
qualcosa di inumano, ed ecco che le colline, la dolcezza del cielo, il profilo degli alberi perdono,
nello stesso momento, il senso illusorio di cui noi li rivestivamo, più distanti ormai che un paradiso
perduto. L'ostilità primitiva del mondo risale verso di noi, attraverso i millenni. Per un secondo
non lo comprendiamo più, [sia] perché per secoli non avevamo capito in esso [nient'altro] che le
figure e i disegni che gli avevamo antecedentemente attribuiti, sia perché ormai ci mancano le forze
per servirci di tale artificio. Il mondo ci sfugge poiché ritorna sé stesso. Le scene travisate
dall'abitudine, ridiventano ciò che sono e si allontanano da noi.44
A questo punto dell'esistenza, dunque, dobbiamo ricostruire il senso di essa secondo un'altra
dinamica fondamentale -- che non sia più quel contatto armonico con la natura che vigeva nella
mediterraneità. Oppure dobbiamo abdicare a questo compito e, in ultima analisi, alla nostra stessa
vita. Questo rifiuto di «rifare il senso» è appunto il suicidio. Dirà Camus in apertura del capitolo Il
suicidio filosofico: «Il vivere sotto un tal cielo soffocante, richiede che se ne esca o che vi si
rimanga. Si tratta di sapere come se ne esca nel primo caso e perché si resti nel secondo. Io così
definisco il problema del suicidio [...]».45 Se tale «cielo soffocante» è appunto il mondo a cui siamo
estranei, allora l'uscirne è il suicidio, il rimanervi -- almeno per ora -- il comprenderlo.
Ci concentreremo ora proprio su questo secondo aspetto. Iniziamo innanzitutto col mostrare cosa
ci sia alla base di questa necessità improcrastinabile di comprendere il mondo e, allo stesso tempo,
il perché dell'impossibilità di mantenersi nell'estraneità. Alla base di questa necessità c'è un
sentimento, tanto semplice quanto profondo e ineliminabile, che Camus chiamerà ora «esigenza di
familiarità», ora «brama di chiarezza», ora «nostalgia di unità», etc. Si legga a riguardo il seguente
passo del Mito:
Il profondo desiderio dello spirito, anche nei suoi più evoluti processi, si ricongiunge al sentimento
incosciente dell'uomo di fronte al proprio universo: è esigenza di familiarità, brama di chiarezza.
Comprendere il mondo, per un uomo, significa ridurre quello all'umano, imprimergli il proprio
suggello. L'universo del gatto non è l'universo del formichiere. La lapalissiana verità che «tutti i
pensieri sono antropomorfici» non ha altro significato. Parimente, lo spirito che cerca di capire la
realtà, non può ritenersi soddisfatto se non quando la riduca in termini di pensiero. Se l'uomo
riconoscesse che anche l'universo può amare e soffrire, si riconcilierebbe con questo. Se il pensiero
scoprisse, nei mutevoli specchi dei fenomeni, eterne relazioni che potessero sintetizzarli e
sintetizzarsi esse stesse in un unico principio, si potrebbe parlare di una felicità dello spirito, di cui
il mito dei beati sarebbe soltanto una ridicola contraffazione. Questa nostalgia di unità, questa
brama di assoluto spiega lo svolgimento del dramma umano nella sua essenza.46
La molteplicità nella quale siamo «gettati» e alla quale siamo estranei va ricondotta dal pensiero al
di sotto di una nuova unità che ci renda ogni aspetto del reale profondamente familiare: v'è in noi
un istinto primordiale che ce lo impone -- un istinto ineludibile. Ma tale istinto è tanto
ineliminabile quanto inappagabile, perché v'è una inconciliabilità di fondo tra la «stoffa» del nostro
pensiero e quella del mondo: se l'uomo è condannato alla parola, il mondo invece permane in un
inespressivo silenzio; se il primo si muove tra gli schemi della ragione, il secondo invece è
semplicemente al di là di qualsiasi razionalità o irrazionalità; se il primo è per eccellenza il simbolo
della mutevolezza emotiva e dell'incostanza, il secondo simboleggia altrettanto bene l'immutabilità
e l'indifferenza.
In questa eterogeneità, in questa distanza tra i due elementi, sta l'irrevocabile e umana
impossibilità di comprendere il mondo: l'uomo che ha perso il mondo, non può riappropriarsene.
L'assurdo sta in questa impossibilità: è questa impossibilità. Esso nasce appunto «dal confronto fra
il richiamo umano e il silenzio irragionevole del mondo».47 L'uomo vorrebbe com-prendere ciò che
per essenza è in-comprensibile: egli domanda e parla a un qualcosa che non è in grado di
rispondergli -- poiché per sua natura muto. Tra l'uomo e il mondo si instaura una perpetua
tensione: il primo parla e domanda, il secondo non ascolta né risponde, semplicemente perché non
può. Questa condizione di incomunicabilità, di separazione tra i due termini è appunto la
condizione assurda. Camus dirà appunto che tale condizione «è essenzialmente un divorzio, che
non consiste nell'uno o nell'altro dei elementi comparati, ma nasce dal loro confronto», sicché
«distruggere uno dei termini, è distruggerla interamente». Da ciò consegue che «non può esistere
assurdo al di fuori dello spirito umano» come «non può neppure esistere assurdo al di fuori di
questo mondo».48
La storia del pensiero raramente ha riconosciuto e affermato tale condizione assurda, poiché ha
sempre presupposto tacitamente una sorta di «principio di trasparenza del mondo», nonché di
comunanza di quest'ultimo con il pensiero umano. Non ha mai creduto che tutte quelle forme e
idee che egli rintracciava nel mondo in realtà fossero delle sue creazioni e proiezioni. Camus,
allievo -- seppur critico -- di Nietzsche, afferma insieme a quest'ultimo il millenario «male
platonico» da cui l'umanità è affetta, e sostiene con amarezza l'impossibilità di un senso
preesistente all'uomo, lì dove il suo «maestro» invece faceva lo stesso ma con esaltazione e fervore.
Si mettano a confronto i seguenti due passi, rispettivamente di Camus e di Nietzsche, nei quali si
afferma, con toni opposti, la sostanziale indifferenza del mondo e l'insolvibile e caotico nichilismo
del reale:
Posso tutto confutare, in questo mondo che mi circonda, mi urta o mi trasporta, salvo questo caos,
questo caso imperante e questa divina equivalenza, che nasce dall'anarchia. Non so se il mondo
abbia un senso che lo trascenda; ma so che io non conosco questo senso e che, per il momento, mi è
impossibile conoscerlo. Che valore ha per me un significato al di fuori della mia condizione? Io
posso comprendere soltanto in termini umani. Ciò che tocco e che mi resiste, ecco quanto
comprendo. E queste due certezze, la mia brama di assoluto e di unità e l'irriducibilità del mondo a
un principio razionale e ragionevole, so anche che non posso conciliarle. Quale altra verità posso
conoscere senza mentire, senza far intervenire una speranza che non ho e che non significa nulla
entro i limiti della mia condizione?
109. Stiamo all'erta! Guardiamoci dal pensare che il mondo sia un essere vivente. In che senso
dovrebbe svilupparsi? Di che si nutrirebbe? Come potrebbe crescere e aumentare? Sappiamo già a
stento che cos'è l'organico: e dovremmo reinterpretare quel che è indicibilmente derivato, tardivo,
raro, casuale, percepito da noi soltanto sulla crosta terreste, come un essere sostanziale, universale,
eterno come fanno coloro che chiamano l'universo un organismo? Di fronte a ciò sento disgusto.
Guardiamoci bene dal credere che l'universo sia una macchina: non è certo costruito per un fine: gli
rendiamo un onore troppo alto con la parola «macchina». [...] Il carattere complessivo del mondo è
invece caos per tutta l'eternità, non nel senso di un difetto di necessità, ma di un difetto di ordine,
articolazione, forma, bellezza, sapienza e di tutto quanto sia espressione delle nostre estetiche
nature umane. [...] L'universo non è perfetto, né bello, né nobile e non vuol diventare nulla di tutto
questo, non mira assolutamente ad imitare l'uomo!
Come si denota chiaramente dal confronto dei due testi, ciò che era per Nietzsche una scoperta
esaltante da gridare all'umanità intera, è invece diventato per Camus un dato di fatto con cui fare i
conti. Se il primo avvertì solo la necessità di distruggere tutte le illusioni «umane, troppo umane»,
filosofando con il martello e riducendo la verità in cenere, il secondo ebbe invece l'onere di
ricostruire a fatica su tali ceneri: in sostanza, Nietzsche per primo riconosce e pone il nichilismo
con grande lucidità; Camus, con altrettanta lucidità, tenta di superarlo -- e lo supererà, come
mostreremo più avanti.
Ma stiamo parlando appunto di un superamento dell'assurdo nichilista, non di una sua negazione:
la tensione tra l'esigenza di familiarità umana e il silenzio irragionevole del mondo rimane sempre
e comunque, non viene mai dimenticata -- lì dove molti uomini pur di uscirne la negarono,
compiendo il famoso «salto mortale». Ad esempio Chestov, filosofo russo poco conosciuto ma
citato da Camus, dirà che da tale condizione assurda «la sola vera via di uscita è proprio là dove,
secondo il giudizio umano, non v'è alcuna. Altrimenti, perché avremmo bisogno di Dio? Non ci si
rivolge a Dio che per ottenere l'impossibile. Quanto al possibile, gli uomini soli vi bastano».49
Camus di fronte all'impossibile e allo sconosciuto si ferma, in nome di una lucidità umana
superiore. Chestov -- come Kierkegaard, d'altronde -- invece vi si tuffa: la sua nozione di assurdo
non è nient'altro che «un trampolino per l'eternità» e il suo salto non è che «un modo di sottrarsi»
ad esso. In ultima analisi, dunque, la differenza sostanziale tra una tale «filosofia del salto mortale»
e un pensiero lucidamente assurdo sta nel diverso atteggiamento nei confronti della trascendenza:
«per Chestov la ragione è vana; ma, al di là di questa, vi è qualche cosa. Per uno spirito assurdo, la
ragione è vana; ma non vi è nulla al di là di essa».
Non per questo Camus condannerà in toto la ragione: come abbiamo già detto, il vero problema
infatti non è la ragione in sé, ma quella forma di razionalismo che la divinizza. D'altronde
il nostro desiderio di comprendere, la nostra nostalgia di assoluto non sono spiegabili proprio che
nella misura in cui noi possiamo comprendere e spiegare molte cose. È vano negare assolutamente
la ragione. Essa ha un ordine proprio, nel quale risulta efficace, e che è appunto quello
dell'esperienza umana. Partendo di là noi volevamo rendere tutto chiaro. Se non lo possiamo, se
l'assurdo sorge in simile circostanza, è proprio al punto d'incontro di questa ragione, efficace ma
limitata, e dell'irrazionale sempre rinascente.50
Camus, al contrario di Lutero,51 di Kierkegaard e di Ignazio di Loyola, il fondatore della compagnia
dei Gesuiti, non vuole nessun «sacrificio dell'intelletto».52 Per lui la ragione, lungi dall'essere
nulla, ha invece un preciso dominio di operatività, oltre il quale non può e non deve andare: si
ritorna alla questione del limite e della misura di cui abbiamo parlato in precedenza. Le parole che
Camus usa in questo caso sono perfette, tanto che le citeremo per esteso:
Questo -- si dice -- passa la misura umana, bisogna dunque che sia sovrumano. Ma questo
"dunque" è eccessivo. Qui non vi è affatto certezza logica e neppure probabilità sperimentale. Tutto
quanto posso dire è che, in realtà, ciò passa i miei limiti. Se anche non ne traggo una negazione,
almeno non voglio fondare nulla sull'incomprensibile. Voglio soltanto sapere se posso vivere con
ciò che so e con ciò soltanto. Mi si dice ancora che l'intelligenza deve sacrificare il proprio orgoglio
e che la ragione deve inchinarsi. Ma se pure riconosco i limiti della ragione, non la nego fino a tal
punto, poiché ammetto i suoi poteri relativi. Voglio solamente restare in quella via di mezzo, in cui
l'intelligenza può mantenersi chiara. Se è quello il suo orgoglio, non vedo una sufficiente ragione
per rinunciarvi.53
Qui sta tutta la lucidità e l'onestà di Camus, tutto il suo realismo e il suo rispetto della finitudine
umana. Egli è consapevole come pochi dell'inconciliabilità fondamentale tra ciò che l'uomo
desidera e ciò che la verità è -- «cercare ciò che è vero, non significa cercare ciò che è
desiderabile»54 -- ma non per questo abdicherà alla vita, né sprofonderà nelle tenebre del
nichilismo. Egli, al contrario di quanto si possa pensare, è animato nel suo pensare da un amore
assoluto per la verità: come Meursault, infatti, si rifiuta di mentire, ma, al suo contrario, egli vive
ricercando quel senso capace di «capovolgere» il nichilismo del reale.
Ora, arrivati alla conclusione del capitolo, tenteremo di ricapitolare quanto detto riguardo
all'assurdo. Siamo partiti dal sentimento d'estraneità, e abbiamo detto che da esso l'uomo vuole e
deve uscirne, o attraverso la rinuncia assoluta (il suicidio), o attraverso una ricomprensione del
reale (il «ritorno al mondo»). Constatata l'estremità del primo gesto e l'impossibilità del secondo,
ciò che rimane è una ineliminabile tensione tra l'umana esigenza di familiarità e il silenzio
irragionevole del mondo, ovvero l'assurdo. Lungi dall'uscirne attraverso un salto mortale che lo
neghi, ciò che va descritta al meglio è la condizione umana in esso, al fine di assumere quella
consapevolezza necessaria per slanciarsi verso la rivolta, perché -- lo ricordiamo ancora una volta -Il mito di Sisifo è «un punto di partenza»,55 non di arrivo. Lo è nella misura in cui in esso non vi
sono punti di riferimento, né valori da perseguire, poiché tutto si allinea secondo una «divina
equivalenza»: «l'assurdo, considerato come regola di vita, è dunque contraddittorio», «ci lascia in
un vicolo cieco».56 Sisifo, il simbolo dell'esistenza assurda, è costretto al suo gesto senza fine
proprio a causa di questa in-differenza del mondo: egli, come l'uomo nietzschiano, essendo «giunto
alla libertà della ragione, non può sentirsi sulla terra nient'altro che un viandante -- non un
viaggiatore diretto a una meta finale: perché questa non esiste».57
Ma Sisifo è ancora un uomo irrimediabilmente solo, isolato su quel monte che è al tempo stesso la
sua prigione e la sua felicità: egli vive il nichilismo senza rimedio né volontà di trasvalutazione.
Verrà il tempo che anch'egli conoscerà gli altri uomini e il loro male, e allora lascerà il suo masso e
il suo insensato gesto, per correre a rubare il fuoco agli dei e portarlo agli uomini. Sisifo si farà
Prometeo: la rivolta si instaurerà nell'assurdo.
4. Opporsi al male della creazione: la rivolta
È lo stesso Camus a suggerire tale continuità tra la condizione assurda e la rivolta che in essa sorge:
dirà nella per noi fondamentale introduzione a L'uomo in rivolta che «i due ragionamenti sono
legati», e che «questo saggio si propone di proseguire, di fronte all'omicidio e alla rivolta, una
riflessione iniziata intorno al suicidio e alla nozione d'assurdo».58 Niente di più chiaro: ma -domandiamoci -- perché e come i due ragionamenti si legano? Anche qui Camus è esplicito.
Eravamo arrivati nel precedente capitolo ad una conclusione in parte negativa: se è vero che Il mito
di Sisifo si concludeva con le parole «bisogna immaginare Sisifo felice», altrettanto vera in Camus è
la consapevolezza che quella felicità non è né definitiva né tanto meno pienamente possibile in un
epoca come la nostra. A renderla di difficile attuabilità, o quanto meno cinica e anacronistica, è
infatti proprio lo sviluppo incontrollato e imprevisto delle condizioni sociali e degli eventi storici:
perché non siamo più «ai tempi ingenui in cui il tiranno radeva al suolo qualche città a propria
maggior gloria, in cui lo schiavo aggiogato al carro del vincitore sfilava per le città festanti, e il
nemico veniva gettato alle belve davanti al popolo adunato», bensì ai tempi dei «campi di schiavi
sotto il vessillo della libertà», dei «massacri giustificati dall'amore per l'uomo o dal sogno di una
super-umanità». Se di fronte ai primi «la coscienza poteva essere salda, e chiaro il giudizio», di
fronte all'atrocità e all'insensatezza dei secondi il giudizio stesso si trova disarmato.
Sisifo, figlio dell'assurdo, non può più ignorare il male del mondo, e per questo grida la sua rivolta:
«grido che a nulla credo e che tutto è assurdo, ma non posso dubitare del mio grido e devo almeno
credere alla mia protesta. La prima e sola evidenza che mi sia data così, all'interno dell'esperienza
assurda, è la rivolta».59 Camus, lontanissimo da Descartes, si scopre inaspettatamente cartesiano,
almeno nel metodo: al centro dell'assurdo -- l'equivalente camusiano del dubbio metodico -- egli
scopre un evidenza fondamentale, quella della rivolta, che con «il suo cieco slancio rivendica
l'ordine in mezzo al caos e l'unità al cuore stesso di ciò che fugge e scompare». La rivolta si instaura
nell'assurdo opponendo alla sua irragionevolezza una richiesta esplicita di giustizia.
Se il suicidio era al centro della riflessione sull'assurdo, lo era nella misura in cui l'uomo assurdo
era ancora rinchiuso nel suo solipsismo: ora che gli eventi lo hanno forzatamente aperto al male
altrui, il suo pensiero si concentra sulla eventuale legittimità dell'omicidio. La questione infatti è la
seguente: «si tratta di sapere se l'innocenza, dal momento che agisce, non può impedirsi di
uccidere. [...] Non sapremo niente finché non sapremo se abbiamo il diritto di uccidere quest'altro
che ci sta davanti o di acconsentire a che venga ucciso».60 Ora, la riflessione sull'assurdo aveva
sancito l'illegittimità del suicidio, poiché ammetteva «la vita come il solo bene necessario». Ma
allora, se ciò è riconosciuto come vero, «come serbare per sé il beneficio esclusivo di un simile
ragionamento? Dall'istante in cui questo bene è riconosciuto come tale, è un bene di tutti gli
uomini. Non si può dare coerenza all'omicidio ove la si rifiuti al suicidio. Uno spirito compenetrato
dall'idea dell'assurdo ammette indubbiamente l'omicidio per fatalità: non potrebbe accettare
l'omicidio di ragionamento».
Insomma, l'assurdo «ha fatto tabula rasa», senza lasciare apparentemente nessuna via d'uscita da
sé, e invece è proprio dalla condanna del suicidio raggiunta nel Mito che Camus parte per uscire
dall'assurdo stesso. Il suo intento è dunque il seguente: constatare se e cosa all'interno della
condizione assurda può essere considerato come punto di leva per una uscita da tale condizione
nichilista, e da ciò ricavare le conseguenze per una coerente e universale condotta di vita, lì dove il
Novecento è stato per eccellenza il secolo dell'irrazionalismo e della più incoerente atrocità, del
dostoevskiano «tutto è possibile». La riflessione, proprio per questo, ha inizio con il
riconoscimento, per adesso ancora indefinito, dell'esistenza di una frontiera:
Che cos'è un uomo in rivolta? Un uomo che dice no. Ma se rifiuta non rinuncia tuttavia: è anche un
uomo che dice di sì, fin dal suo primo muoversi. Uno schiavo che in tutta la sua vita ha ricevuto
ordini, giudica ad un tratto inaccettabile un nuovo comando. Qual'è il contenuto di questo "no"?
Significa, per esempio, "le cose hanno durato troppo", "fin qui si, al di là no", "vai troppo in là" e
anche "c'è un limite oltre il quale non andrai". Insomma, questo no afferma l'esistenza di una
frontiera. [...] Egli afferma, insieme alla frontiera, tutto ciò che avverte e vuol preservare al di qua
della frontiera. Dimostra, con caparbietà, che c'è in lui qualche cosa per cui "vale la pena di... ",
qualche cosa che richiede attenzione. In un certo modo, oppone all'ordine che l'opprime una specie
di diritto a non essere oppresso al di là di quanto egli possa ammettere.61
Come per il Cartesio della seconda meditazione metafisica, anche qui troviamo una iniziale
negazione che, ritornando su se stessa, si trasforma in una esplicita affermazione, seppur in origine
indefinita: Cartesio trae dal dubbio totale la consapevolezza che tale dubitare implica
necessariamente l'esistenza del soggetto dubitante; Camus, invece, trae dalla negazione
pronunciata dal soggetto oppresso rispetto all'ordine che l'opprime, l'affermazione dell'esistenza di
una «frontiera valoriale» secondo la quale è appunto possibile la negazione stessa. «La rivolta, in
senso etimologico, è un voltafaccia. In essa, l'uomo che camminava sotto la sferza del padrone, ora
fa fronte. Oppone ciò che è preferibile a ciò che non lo è. Non tutti i valori trascinano con sé la
rivolta, ma ogni moto di rivolta fa tacitamente appello a un valore».62
Affermata l'esistenza di tale valore, il passo successivo è la sua determinazione contenutistica. Esso
è innanzitutto un passaggio dal solipsismo in cui versava l'individuo nella condizione assurda al
senso di comunanza con gli altri simili nella rivolta:
Vediamo dunque che l'affermazione implicita in ogni atto di rivolta si estende a qualche cosa che
eccede l'individuo in quanto lo trae dalla sua supposta solitudine e gli fornisce una ragione d'agire.
[...] L'analisi della rivolta conduce almeno al sospetto che esista una natura umana, come
pensavano i Greci, e contrariamente ai postulati del pensiero contemporaneo. Perché rivoltarsi se
non si ha, in se stessi, nulla di permanente da preservare? È per tutte le esistenze a un tempo che
insorge lo schiavo quando giudica che, da un determinato ordine, viene negato in lui qualche cosa
che non gli appartiene esclusivamente, ma che è luogo comune in cui tutti gli uomini, anche quello
che l'insulta e l'opprime, hanno pronta una comunità. [...] L'individuo non è dunque, in se stesso,
quel valore che egli vuole difendere. Occorrono almeno tutti gli uomini per costituirlo. Nella rivolta,
l'uomo si trascende nell'altro e, da questo punto di vista, la solidarietà umana è metafisica.63
Ma tale solidarietà metafisica non rivendica nulla di trascendente né di divino: essa richiede
interventi concretamente umani, in nome di un valore immanente all'uomo stesso. È una
solidarietà che sorge sulle ceneri della morte di Dio, e quindi non può far appello a nessun ideale
oltre-mondano né a nessuna ricompensa nell'aldilà: essa fa riferimento semplicemente a quel
sentimento incarnato nell'individuo che è un evidenza originale ed innegabile. E se l'individuo
reclama giustizia per qualcun altro di fronte al male, non lo fa certo per una «comunione di
interessi» -- infatti «possiamo trovare rivoltante l'ingiustizia imposta ad uomini che consideriamo
nostri avversari»64 -- né per guadagnarsi la salvezza ultraterrena: il suo è un gesto umano e
volontario, non una risposta ad un ordine divino. In effetti, a questo stadio di rivolta, l'uomo,
credente o meno che sia, non fa più appello a Dio:
Se nel mondo religioso non si trova il problema della rivolta, si è che in verità non vi si trova alcuna
problematica reale, tutte le risposte essendo date in una volta. [...] L'uomo in rivolta è l'uomo che
sta prima o dopo l'universo sacro, e si adopera a rivendicare un ordine umano in cui tutte le
risposte siano umane, cioè razionalmente formulate. Da quell'istante, ogni interrogazione, ogni
parola è rivolta, mentre nel mondo religioso, ogni parola è rendimento di grazie.65
Quindi occorre evitare, ora come prima, di definire il pensiero camusiano come un pensiero
ateo,66 almeno nella misura in cui con il termine «ateismo» si intende la negazione esplicita e
sprezzante di Dio: tale pensiero si ritrova piuttosto in quell'ateismo definito da Levinas come quella
«posizione anteriore sia alla negazione che all'affermazione del divino» -- ateismo per il quale «si
vive al di fuori di Dio, a casa propria».67
Ma, tornando alla rivolta, occorre sottolineare come essa, proprio in quanto slegata da qualsiasi
forma di eternità divina, non sia uno stato permanente ed immodificabile nel quale l'uomo è
situato da sempre, a prescindere dal suo sforzo e dal suo volere: al contrario, essa si definisce nei
limiti di una certa contingenza spazio-temporale, secondo la quale essa sorge soltanto in alcuni
luoghi e in determinate epoche -- in base al configurarsi delle condizioni esistenziali e sociali -- e
soltanto nell'animo di determinati «uomini avvertiti che abbiano coscienza dei propri diritti». La
rivolta, dunque, sorge soltanto dove vi sono uomini coscienti che la reclamano: essa non esiste da
sempre ma è solo in quanto è voluta. Ma non per questo essa è relativa: nel momento in cui un
uomo si rivolta, lo fa in nome di un sentimento universale, comune ad ogni uomo ovunque -- il
rifiuto istintivo di ogni forma di male, il bisogno imprescindibile di senso. Nel momento in cui tale
rivendicazione dovesse cadere o mutare in interesse particolare, la rivolta stessa si annullerebbe:
La solidarietà degli uomini si fonda sul movimento di rivolta, e questo, reciprocamente, solo in tale
complicità trova giustificazione. Saremmo dunque in diritto di dire che ogni rivolta che s'autorizzi a
distruggere questa solidarietà perde con questo il nome di rivolta e coincide in realtà con un
assenso omicida. Allo stesso modo questa solidarietà, fuori dall'universo religioso, prende vita
soltanto sul piano della rivolta. Il vero dramma della rivolta del pensiero è allora annunziato. Per
essere, l'uomo deve rivoltarsi, ma la sua rivolta deve rispettare il limite che scopre in se stessa:
limite nel quale gli uomini, venendo a raggiungersi, cominciano ad essere. Il pensiero informato
alla rivolta non può dunque prescindere dalla memoria: esso è tensione perpetua. Seguendolo nelle
opere e negli atti, dovremo dire, ogni volta, se rimanga fedele alla sua primitiva nobiltà oppure, per
stanchezza e pazzia, se ne scordi, in un'ebbrezza di tirannia o di servitù.
Dunque, in definitiva, la rivolta, per quanto possa essere affermata da un uomo solitario, si erge
sempre per tutta l'umanità -- altrimenti non è rivolta. Essa a questo di peculiare: dà un senso al
sentimento individuale proprio nella misura in cui, mostrandone la comunanza col quello altrui, lo
rende universale. Se l'io sapesse che è solo a soffrire in questo modo, persevererebbe
nell'estraneità. Ma anche gli altri soffrono come lui, e allora egli trova momentaneamente placata la
sua ansia di familiarità:
Ecco il primo progresso che lo spirito di rivolta fa compiere ad una riflessione da principio
compenetrata dell'assurdità e dell'apparente sterilità del mondo. Nell'esperienza assurda la
sofferenza è individuale. A principiare dal moto di rivolta, essa ha coscienza di essere collettiva, è
avventura di tutti. Il primo progresso di uno spirito intimamente straniato sta dunque nel
riconoscere che questo suo sentirsi straniero lo condivide con tutti gli uomini, e che la realtà
umana, nella sua totalità, soffre di questa distanza rispetto a se stessa e al mondo. Il male che un
solo uomo provava diviene peste collettiva. In quella che è la nostra prova quotidiana, la rivolta
svolge la stessa funzione del "cogito" nell'ordine del pensiero: è la prima evidenza. Ma questa
evidenza trae l'individuo dalla sua solitudine. È un luogo comune che fonda su tutti gli uomini il
primo valore. Mi rivolto, dunque siamo.68
Giunto a questo stadio di consapevolezza, l'uomo non è più solo, come lo era Sisifo sul suo monte:
egli ha trovato la possibilità del senso proprio perché, al contrario di Sisifo, si è aperto all'altro,
all'umanità. Da questo momento in poi ogni sua parola sarà una parola di rivolta pronunciata in
nome di essa.
Nella parte centrale de L'uomo in rivolta Camus mostrerà come è possibile rintracciare nella
letteratura, nella storia della filosofia e nella storia tout-court gli inizi -- e i tradimenti -- della
rivolta. In questi capitoli (La rivolta metafisica, La rivolta storica, Rivolta e arte) si analizzano atti
e pensieri che anticiparono l'idea della rivolta -- seppur finendo sempre in qualche modo con il
tradirla. Noi in questa sede non possiamo trattare, per ragioni di spazio, tale argomento, e quindi
passeremo ora ad analizzare l'ultima parte del libro, Il pensiero meridiano, nel quale Camus
approda ad un punto di svolta definitivo rispetto alla negatività assurda finora trattata.
Il pensiero meridiano è, in sostanza, la «proposta di senso» camusiana: esso sorge sulle
fondamenta dell'assurdo, ne conserva sempre vivo il ricordo senza dimenticarlo mai. Tale pensiero
tiene conto -- senza affatto smentirla o negarla -- di tutta la riflessione che, a partire dalla
mediterraneità, ci ha condotto fin qui: ed infatti, in maniera più o meno manifesta, sarà possibile
rintracciare nella nostra descrizione tutte le già affrontate tappe dell'opera di Camus.
Iniziamo innanzitutto con il descrivere il pensiero meridiano per via negativa, affermando cosa
esso non sia. Esso non è uno storicismo, né una «filosofia dell'eternità»: se il primo è colpevole di
divinizzare la storia e di asservirsi ciecamente ad essa nel cambiamento violento della realtà, la
seconda invece accetta supinamente l'apparente ingiustizia di tale realtà, affermando l'esistenza di
una giustizia divina di ordine superiore; se lo storicismo accetta la violenza e l'abnegazione della
libertà al fine di ristabilire la giustizia «dall'alto», una filosofia dell'eternità sposa integralmente la
non-violenza perché convinta che la giustizia sia già in atto, e che la libertà umana sia nelle mani di
Dio.
Il pensiero meridiano si pone come terza via tra lo storicismo e il teismo: esso è consapevole
dell'ingiustizia, ma non vuole che il suo contrastarla ne generi di altra; combatte il male e la
violenza, ma con mezzi capaci di non spargere altro ingiustificabile sangue; non accetta l'omicidio
come mezzo per un fine più elevato perché è proprio contro l'omicidio che esso si scaglia.
Insomma, il pensiero meridiano si pone come una perpetua tensione tra poli opposti lì dove gli altri
due pensieri descritti si pietrificavano arbitrariamente su uno solo: esso non sceglie la giustizia
assoluta perché distruggerebbe la libertà, ma altrettanto ragionevolmente non sceglie la libertà
assoluta perché ingiusta, omicida e nichilista.
Per esso il male è l'unica realtà certa ed ingiustificabile, lì dove lo storicismo e il credo in Dio
concludono sempre con la sua giustificazione. Si può dire, infatti, che un'intera tradizione di
pensiero -- -- quella marxista-storicista in particolare -- abbia giustificato sempre i suoi mezzi
violenti e oppressivi in base ad un presunto fine utopico superiore. Con il pensiero meridiano la
situazione si capovolge:
Quando il fine è assoluto, cioè, storicamente parlando, quando si ritiene certa la sua realizzazione,
si può arrivare a sacrificare gli altri. Quando non lo è, si può sacrificare soltanto se stessi, come
posta di una lotta per la dignità comune. Il fine giustifica i mezzi? È possibile. Ma chi giustificherà il
fine? A questo interrogativo, che il pensiero storico lascia in sospeso, la rivolta risponde: i mezzi.
Il pensiero meridiano, come si evince da tutte queste parole, è un pensiero della misura, e non a
caso il penultimo capitolo de L'uomo in rivolta si intitola proprio Misura e dismisura: «la misura
non è il contrario della rivolta. La rivolta è essa stessa misura: essa, la ordina, la difende e la ricrea
attraverso la storia e i suoi disordini».69
Questa legge della misura si estende anche a tutte le antinomie del pensiero in rivolta. Né il reale è
interamente razionale, né il razionale del tutto reale. [...] Non si può dire che nulla ha senso poiché
con ciò si afferma un valore consacrato da un giudizio; né che tutto abbia senso poiché la parola
tutto non ha significato per noi. L'irrazionale limita il razionale che a sua volta gli conferisce la
propria misura. Qualche cosa, infine, ha un senso che dobbiamo conquistare sul non-senso. Allo
stesso modo, non si può dire che l'essere sia soltanto sul piano dell'essenza. Dove cogliere l'essenza
se non sul piano dell'esistenza e del divenire? Ma non si può dire che l'essere sia soltanto esistenza.
Ciò che sempre diviene non ha la possibilità di essere, occorre un inizio. L'essere non può
esperimentarsi se non nel divenire, il divenire è nulla senza l'essere. Il mondo non consiste in una
fissità pura; ma non è soltanto movimento. È movimento e fissità. La dialettica storica, per
esempio, non fugge indefinitamente verso un valore ignoto. Gira intorno al limite, primo valore.
Eraclito, inventore del divenire, dava tuttavia un confine a questo perpetuo scorrere. Questo limite
era simboleggiato da Nemesi, dea della misura, fatale ai dismisurati. Una riflessione che volesse
tenere conto delle contraddizioni contemporanee dovrebbe chiedere ispirazione a questa dea.
Siamo ritornati alla dea Nemesi, che avevamo già incontrato all'inizio della nostra riflessione -- e
questo non fa che avvalorare la tesi seconda la quale l'opera di Camus sia in sostanza un'unica e
ininterrotta meditazione, che tiene conto di ogni sua tappa senza negarne nessuna. L'ultima di
queste tappe -- almeno di quelle che Camus è riuscito a raggiungere prima della sua prematura
morte -- non è ancora un punto di arrivo, ma piuttosto un ennesimo slancio: il suo nome è, infatti,
Oltre il nichilismo. Alla domanda «posso vivere con ciò che so e con ciò soltanto?» posta dall'uomo
assurdo nel Mito, l'incipit di questo capitolo risponde affermativamente:
Esistono dunque, per l'uomo, un'azione e un pensiero possibili a quel livello medio che gli è
proprio. Ogni tentativo più ambizioso si rivela contraddittorio. [...] Oggi, nessuna saggezza può
pretendere di dare di più. La rivolta cozza instancabilmente contro il male, dal quale non le rimane
che prendere un nuovo slancio. L'uomo può signoreggiare in sé tutto ciò che deve essere
signoreggiato. Deve riparare nella creazione tutto ciò che può essere riparato. Dopo di che, i
bambini moriranno sempre ingiustamente, anche in una società perfetta. Nel suo sforzo maggiore,
l'uomo può soltanto proporsi di diminuire aritmeticamente il dolore nel mondo. Ma ingiustizia e e
sofferenza perdureranno, e, per limitate che siano, non cesseranno di essere scandalo. Il "perché"
di Dimitri Karamazov continuerà a risuonare, l'arte e la rivolta non moriranno se non con l'ultimo
uomo.70
«Diminuire aritmeticamente il dolore nel mondo»: questo è l'unico compito possibile per l'uomo -un compito tanto nobile quanto necessario. In esso, però, non vedremo mai all'opera tutti gli
uomini, perché alcuni di essi preferiranno aspettare la loro sempre ipotetica vita oltremondana,
mentre altri rimarranno fiduciosi in quell'astuzia della ragione che si suppone operi nella storia.
Ma di sicuro a tale compito non potranno sottrarsi «coloro che non trovano quiete né in Dio né
entro la storia», coloro i quali «si dannano a vivere per quelli che, come loro, non possono vivere,
per gli umiliati».71
In questa categoria di uomini Camus avrebbe voluto vedere un giorno quegli europei reduci delle
due guerre mondiali, di Auschwitz e di Hiroshima: egli auspicava infatti un passaggio da quella
ragione totale «che non ama più la vita» a quella ragione della misura sempre consapevole dei
limiti che la vita stessa impone. Per questo dirà nel 1951, con un profetismo rivelatosi ai nostri
occhi purtroppo errato, che «al di là del nichilismo, noi, tutti, tra le rovine, prepariamo una
rinascita. Ma pochi lo sanno».72
Tutto il possibile insegnamento era il seguente: occorre rispettare la realtà con i suoi i limiti e la sua
misura, senza escludere nulla, perché l'uomo «si serve nella sua totalità o non lo si serve per
nulla»;73 occorre ritornare alla luce, dove gli uomini e il mondo restano «il nostro primo e ultimo
amore»; bisogna, infine, «imparare a vivere, a morire e, per essere uomo, rifiutare di essere dio».
Ognuno dice all'altro che non è Dio; qui termina il romanticismo. In quest'ora in cui ognuno di noi
deve tendere l'arco per rifare la prova, per conquistare, entro e contro la storia, quanto già
possiede, la magra messe dei suoi campi, il breve amore di questa terra; nell'ora in cui nasce infine
un uomo, bisogna lasciare l'epoca e i suoi furori adolescenti. L'arco si torce, il legno stride. Al
sommo della più alta tensione scaturirà lo slancio di una dritta freccia, dal tratto più duro e più
libero.74
Così si conclude L'uomo in rivolta, ma non la sua lezione: infatti, tutte queste regole di condotta
morale che abbiamo ritrovato qui, alla fine del nostro cammino nell'opera di Camus, saranno
personificate magistralmente dal dottor Rieux e da tutti gli altri personaggi de La peste, il romanzo
che, a parer nostro, è la miglior e più essenziale espressione di tutta la filosofia camusiana.
«Un romanzo come manifesto di una filosofia?» domanderà qualcuno. Si, risponderebbe Camus,
perché in fondo «un romanzo non è mai altro che una filosofia tradotta in immagini».
5. La peste: «filosofia tradotta in immagini»
Scritto in contemporanea con L'uomo in rivolta, ma pubblicato ben quattro anni prima di esso (nel
1947), il romanzo La peste riprende temi e riflessioni del saggio sulla rivolta al fine di trasporli e
condensarli in immagini letterarie: in effetti, è possibile sostenere che un'opera completi l'altra,
poiché tra le due si crea un legame di chiarificazione reciproca; ma, ovviamente, i piani delle
diverse esposizioni non vanno confusi. In questo capitolo, ciò che vogliamo tentare di fare è di
rintracciare concisamente ne La peste i temi della rivolta -- concentrandoci sulla descrizione del
dottor Rieux -- e quindi avviarci a trarre delle brevi conclusioni che pongano le basi per una
rivalutazione di quella che ormai non esitiamo più a chiamare «filosofia camusiana».
Come d'obbligo quando si affronta un romanzo, inizieremo con un piccolo riassunto della trama. Ci
troviamo ad Orano, in Algeria, in un periodo indefinito tra il 1940 e il 1949. In questa piccola città
sul mare, la vita scorre quietamente senza imprevisti, fino al giorno in cui a sconvolgere le vite degli
Oranesi verrà la peste, portata non si sa da chi, ma segnalata dall'iniziale e inspiegabile morte di
centinaia di topi per le strade di tutta la città: l'intero romanzo tratterà, in sostanza, dei diversi
atteggiamenti dei personaggi rispetto alla peste, che li ha costretti in quarantena dentro la città
dalla quale è vietato uscire; c'è chi cercherà di sfuggirle, chi la accetterà come una punizione divina,
chi in essa si pascerà perseguendo un cinico egoismo, chi invece -- è il caso del dottor Rieux -lotterà senza eroismi75 contro di essa.
Proprio di quest'ultimo personaggio e del suo rispettivo atteggiamento nei confronti della peste noi
ci occuperemo più approfonditamente, poiché esso rappresenta l'alter ego di Camus, come da una
sua nota di taccuino si evince chiaramente.76 Il dottor Rieux è per Camus il principale di quelli che
la coppia filosofica Deleuze-Guattari definirebbe «personaggi concettuali»77: in esso si incarnano
alla perfezione tutti i concetti della rivolta, come in Meursault si incarnavano quelli dell'estraneità.
Il primo aspetto che caratterizza Rieux è il suo «credere ai flagelli», ovvero il suo considerare il
male in tutta la sua evidenza e concretezza, lì dove i suoi concittadini «erano degli umanisti: [e
quindi] non credevano ai flagelli»78: a Richard, che gli domanda se abbia la certezza assoluta che si
tratti di un'epidemia di peste, egli risponde: «lei pone male il problema: non è una questione di
vocabolario, è uno questione di tempo». Dal che si evince un secondo aspetto del personaggio: egli
pone al di sopra di ogni «ragione teoretica» capace di spiegare il male, la necessità di quella
«ragion pratica» che richiede prima di tutto che tale male venga contrastato. Nel caso del romanzo,
tale ragion pratica coincide con l'esigenza improrogabile di contrastare la peste senza domandarsi il
perché essa esista: in uno dei tanti e indimenticabili dialoghi del libro, Rieux esclamerà: «non
posso nello stesso tempo guarire e sapere! E allora guariamo il più presto possibile: è la cosa che
più importa».79 Guarire, alleviare il dolore, ma certo non eliminare il male metafisico che è
insanabilmente al cuore della realtà: perché la sua gramigna sostanzialità supera i nostri limitati
poteri di azione, sicché l'uomo può soltanto prevenirlo prima o tentare di curarlo poi, senza mai
aver la possibilità di sottrarvisi totalmente.
Per comprendere questi primi due punti -- l'evidenza del male e la «priorità della cura» rispetto
alla «comprensione del dolore» -- consigliamo la lettura di uno dei dialoghi fondamentali del
romanzo,80 quello tra il solito Rieux e Tarrou, altro personaggio fondamentale che aspira con tutte
le sue forze a divenire un «santo senza dio».81 In esso, Rieux arriva a pronunciare le seguenti
parole: «se l'ordine del mondo è regolato dalla morte, forse val meglio per Dio che non si creda in
lui e che si lotti con tutte le nostre forze contro la morte, senza levare gli occhi verso il cielo dove lui
tace». Parole a cui Tarrou risponderà ricordando la provvisorietà di tali vittorie contro il male. Ma
Rieux, consapevole di ciò, risponderà a sua volta che questa provvisorietà «non è una ragione per
smettere la lotta».
Possiamo trarre da quest'ultima affermazione un terzo aspetto della «filosofia della rivolta» di
Rieux, quello della rinuncia -- ancora una volta senza eroismi -- ad una felicità appagata o, per dirlo
in altro modo, ad un condotta soddisfatta della propria vita etica.82 Quando Rambert83 decide di
rimanere e di arruolarsi nelle file dei volontari di Rieux -- perché ha capito che, se non «c'è
vergogna nel preferire la felicità», ce ne può essere invece «nell'essere felici da soli» -- , Tarrou gli
fa notare che «se volesse condividere le sventure degli uomini non avrebbe mai avuto più tempo
per la felicità» e che avrebbe dovuto scegliere. Ma quando successivamente Rambert chiede a
Tarrou e Rieux se anche loro, come appena detto, avessero «rinunciato alla felicità», quest'ultimo
gli risponde a fatica prima con un confuso «mi scusi, Rambert, ma io non lo so. Resti con noi, se lo
desidera», per poi dire «nulla al mondo vale che ci distolga da quello che si ama. E tuttavia me ne
distolgo anch'io, senza poterne sapere la causa».84
Arrivati a questo punto, vogliamo concludere questo breve capitolo mettendo in risalto un quarto e
fondamentale -- ma di sicuro non ultimo -- aspetto della personalità di Rieux: il suo rifiuto di Dio,
che non è di certo un ateismo, quanto più un agnosticismo che non nega né attesta l'esistenza
divina ma che rifiuta la divinità in nome di una «fedeltà alla terra» e al male tutto terreno degli
uomini. Quando padre Paneloux gli dirà che forse «dobbiamo amare ciò che non possiamo capire»,
abdicando alla ragione per gettarsi in una fede consapevolmente paradossale, egli, scuotendo la
testa, risponde: «No padre, io mi faccio un'altra idea dell'amore; e mi rifiuterò sino alla morte di
amare questa creazione dove i bambini sono torturati». E gli ricorda che, contro la peste, «noi
lavoriamo insieme per qualcosa che riunisce oltre le bestemmie e le preghiere», cosi che neanche
Dio può separarli in quel momento di cooperazione contro il male -- cooperazione oltre ogni credo.
Ed è proprio a partire da questa ultima affermazione che vogliamo avviarci verso una conclusione,
consapevoli che ci sarebbe molto altro da dire se solo lo spazio lo permettesse.
6. Conclusioni
Sperando di essere riusciti in quanto ci eravamo riproposti all'inizio del saggio -- ovvero mostrare
la «filosofia camusiana» in tutta la sua solarità -- vogliamo ora tentare in breve e schematicamente
di riassumere quello che riteniamo possa essere il lascito di Camus.
6.1. L'ingiustificabilità e la sostanzialità del male: «il male è, e non può non essere»
Padre Paneloux nelle sue due prediche -- in particolare nella prima -- opera una tuonante
giustificazione del male portato dalla peste, sostenendo che esso sia una punizione divina per
l'arroganza e la fede lassista degli Oranesi. La sua prima predica si apre addirittura con le parole:
«Fratelli miei, voi siete nella sventura, fratelli miei, voi lo avete meritato». Ora, la posizione di
Paneloux è evidentemente metafora di quell'altra posizione -- teista, religiosa, credente -- che nella
storia del pensiero si è sforzata, sin dai suoi albori, di giustificare agli occhi degli uomini il male: a
partire dalle forme più primitive -- il male come vendetta degli dei adirati, oppure la sua reductio in
mysterium -- fino a quelle più complesse e filosofiche -- il male come privatio boni, come nonessere, come evento all'interno di un disegno divino, come momento di unione mistica con un Dio
sofferente, come prodotto del libero arbitrio umano, etc. -- il pensiero «credente» non ha potuto
fare a meno di costruire in qualche modo un «alibi divino» per l'ingiustificata e irrimediabile
presenza del male nel mondo.
Camus è agli antipodi di questa posizione «giustificazionista»: egli afferma, da una parte,
l'evidenza e la sostanzialità del male, dall'altra, la sua incomprensibilità e ingiustificabilità.85 Le
sue opere ci insegnano che quando si esperisce il male non si può dubitare di tale esperienza,
poiché essa è vissuta sempre in prima persona con un evidenza immanente e indubitabile. Con echi
parmenidei, potremmo affermare seguendo questo ragionamento che «il male è, e non può non
essere». Dunque non resta che combatterlo o perirne:
molti nuovi moralisti andavano allora dicendo nella nostra città che nulla, nulla sarebbe servito e
che bisognava mettersi in ginocchio. E Tarrou, e Rieux, e i loro amici potevano rispondere questo o
quello, ma la conclusione era sempre quella a loro nota: bisognava lottare in questo o in quel modo
e non mettersi in ginocchio. Tutta la questione era di impedire al maggior numero possibile
d'uomini di morire e di conoscere la separazione definitiva. Per questo non c'era che un solo mezzo:
combattere la peste. Questa verità non era ammirevole, ma soltanto logica.86
6.2. La responsabilità del bene, la necessità della cura: il «sole invincibile» di Camus
Il male, dunque, persiste autonomamente nella sua essenza insensata e tumorale, sordo ai lamenti
umani, cieco al sangue versato irreparabilmente. Ma è questa l'«ultima parola»? No. Camus
insegna -- e noi non riteniamo di fraintenderlo -- che nel cuore del reale, oltre e contro il male, ci
sia l'uomo e la sua capacità di amare. Egli è l'unico responsabile del bene, l'unico essere che con la
sua rivolta è capace di porre rimedio quanto più possibile ad una condizione intrinsecamente
ingiusta e dolorosa. Sicché, anche nel buio più totale delle guerre e degli olocausti, deve sempre
riemerge dal fondo degli animi abbattuti quel «sole invincibile» capace di scacciare le tenebre del
male -- siano esse connaturate al reale, siano esse prodotte dagli uomini stessi.
In definitiva, dunque, se c'è un sentimento che permea tutta l'opera di Camus, lungi dall'essere il
risentimento, o peggio il pessimismo, questo è senza dubbio l'amore: amore contemporaneamente
profondo e incolmabile quanto lucido e realista; amore di chi si rifiuta di mentire e, allo stesso
tempo, di darsi per vinto.
Note
1.
«Si può pensare solo per immagini. Se vuoi fare il filosofo, scrivi romanzi». Albert Camus, Taccuini, II ed.
Bompiani, Milano 2004, libro I, p. 14.
2.
«La mia opera non è filosofia». Ma, a nostro avviso, questo fu per Camus soltanto un modo per distinguere la
sua «filosofia» da quell'altro modo di intendere la filosofia allora dominante -- l'esistenzialismo. Citato in Jan
Sperna Weiland, Albert Camus tra filosofia e letteratura, disponibile all'indirizzo URL:
http://www.emsf.rai.it/scripts/interviste.asp?d=313.
3.
Albert Camus, L'estate e altri saggi solari, I ed. Bompiani, Milano 2003, p. 163-4.
4.
In occasione dell'assegnazione del Premio Nobel, Camus disse: «Avevo un piano preciso quando ho cominciato
la mia opera: volevo prima di tutto esprimere la negazione. Sotto tre forme. Romanzesca: e fu Lo straniero.
Drammatica: Caligola, Il malinteso. Ideologica: Il mito di Sisifo. Prevedevo il positivo sempre sotto tre forme.
Romanzesca: La peste. Drammatica: Lo stato d'assedio e I giusti. Ideologica: L'uomo in rivolta. Intravedevo già
un terzo stato di questo piano relativamente al tema dell'amore». Tratto dalla introduzione di Roger Grenier ad
Albert Camus, Opere, I ed. Bompiani, Milano 1988, pp. VIII-IX.
5.
Albert Camus, Taccuini, libro II, p. 26 (corsivo mio).
6.
Albert Camus, Nozze a Tipasa, in L'estate e altri saggi solari, p. 9, (corsivo mio).
7.
Albert Camus, Taccuini, libro I, p. 25-6 (corsivo mio).
8.
Tipasa, città algerina sul mar mediterraneo, luogo di svolgimento del saggio in questione (Nozze a Tipasa).
9.
Albert Camus, Nozze a Tipasa, in L'estate e altri saggi solari, pp. 5-8 per l'interno capoverso (corsivo mio).
10. «La famiglia Camus si reputava di origine alsaziana. Lucien Auguste, cantiniere salariato, figlio di immigrati
francesi in Algeria, aveva sposato Catherine Hélène Sintès, di tre anni più anziana di lui, di origine spagnola
delle Baleari, sorda e balbuziente per un incidente subito nella prima infanzia e analfabeta. Da questa unione
nacquero Lucien Jean Etienne, nel 1910, e tre anni dopo Albert, a Mondovi, nei pressi della città di Bona, dove
era vissuto sant'Agostino. Lucien Auguste morì nella battaglia della Marna nel 1914, lasciando la famiglia priva
di adeguato sostentamento. Catherine Hélène andò a vivere in un piccolo appartamento a Belcourt, quartiere
popolare di Algeri, con i figli presso la mamma e un fratello handicappato. Vivono con un piccolo vitalizio
erogato dallo Stato e con i proventi del lavoro a ore come domestica svolto da Catherine Hélène». Tratto da
Aniello Montano, Camus. Un mistico senza Dio. Edizioni Messaggero Padova, 2003, p. 33-4.
11. Albert Camus, Il rovescio e il diritto, in Opere, a cura e con introduzione di Roger Grenier, Milano 1988, p. 6.
12. Marcello Del Vecchio, La fenomenologia dell'assurdo in Albert Camus, Firenze 1979, p.277.
13. Albert Camus, Ritorno a Tipasa, in L'estate e altri saggi solari, p. 95-6 (corsivo mio).
14. Ivi, p. 99.
15. Albert Camus, Incontro con Albert Camus, in L'estate e altri saggi solari, p. 168.
16. Albert Camus, L'esilio di Elena, in L'estate e altri saggi solari, p. 79.
17. Ivi, p. 80 (corsivo mio).
18. Ivi, p. 81.
19. Albert Camus, Taccuini, libro II, p. 149-150.
20. Albert Camus, L'uomo in rivolta, IV ed. Bompiani, Milano 2005, p. 323.
21. Albert Camus, L'esilio di Elena, in L'estate e altri saggi solari, p. 81-82 per l'intero capoverso .
22. Giuseppe Ungaretti, I fiumi, in Tutte le poesie, Mondadori, I ed. 2005, p. 43.
23. Albert Camus, Il vento a Djemila, in L'estate e altri saggi solari, p. 11 (corsivo mio).
24. Ivi, p. 12.
25. Albert Camus, Taccuini, libro I, p. 12. Ma anche in Il rovescio e il diritto, p. 50.
26. Albert Camus, Lo straniero, XXIII ed. Bompiani, Milano 2008, pp. 27-31.
27. Ivi, p. 31.
28. Ivi, pp. 55-6.
29. Al suo principale che gli offre la possibilità di cambiare vita andando a lavorare per lui a Parigi, egli risponde che
«non si cambia mai vita, che del resto tutte le vite si equivalgono» e che la sua, così com'era, non gli dispiaceva
affatto; oppure al suo vicino di casa Raimondo, conosciuto da poco, il quale gli dice di essere per lui «un vero
amico», egli risponde semplicemente con un inespressivo «sì». Ma gli esempi da fare sarebbero sicuramente di
più.
30. Questo è quanto dirà Camus riguardo al suo personaggio nella prefazione ad un'edizione americana del libro.
31. Albert Camus, Taccuini, libro II, p. 28.
32. «Ça m'était égal» - «per me era uguale»: è questa una delle frasi più ricorrenti di Meursault.
33. Ivi, p. 75-6 (corsivo mio).
34. E non a caso, nella struttura del libro, questo è il punto che sancisce la fine della prima parte e l'inizio della
seconda.
35. Ivi, pp. 148-150 (corsivo mio).
36. Camus, in una nota dei suoi Taccuini, descriverà questo passaggio come «un luogo privilegiato dove si riuniva
finalmente quell'individuo descritto così disperso».
37. «Meursault per me non è dunque un relitto, ma un uomo povero e nudo, amante del sole che non lascia ombre.
Lungi dall'essere privo di sensibilità, una passione profonda, perché tenace, lo anima, la passione dell'assoluto e
della verità. Si tratta di una verità ancora negativa, la verità di essere e di sentire, ma senza la quale nessuna
conquista su se stessi e sul mondo sarà mai possibile». Parole di Albert Camus per una prefazione ad
un'edizione americana de Lo straniero, tratte dalle Note ai testi di Jean Grenier contenute nel volume Albert
Camus. Opere, I ed. Bompiani, Milano 1988.
38. Si veda la sopracitata prefazione all'edizione americana de Lo straniero.
39. Albert Camus, L'uomo in rivolta, p. 77.
40. Albert Camus, Il mito di Sisifo, VII ed. Bompiani, Milano 2008, p. 10 (corsivo mio).
41. Si veda la premessa al Mito.
42. Ivi, p. 9.
43. Ivi, pg 48.
44. Ivi, p. 17. Ho preferito usare degli accorgimenti nella traduzione, al fine di rendere il testo più comprensibile,
evidenziando le aggiunte con delle parentesi.
45. Ivi, 29.
46. Ivi, p. 19-20.
47. Ivi, p. 28.
48. Ivi, 31.
49. Ivi, p. 34. Corretta dall'autore una piccola omissione nell'edizione del Mito citata (manca il termine «che»: il
senso della frase ne risulta sconvolto, «non ci si rivolge a Dio per ottenere l'impossibile»). In Opere, il passo è
scritto correttamente.
50. Ivi, p. 35, anche per le precedenti.
51. «La ragione è direttamente opposta alla fede; perciò si deve abbandonarla; nei credenti essa dev'essere uccisa e
sepolta». Citato in Jacques Maritain, Tre riformatori. (Lutero, Cartesio, Rousseau), Morcelliana, 1928, p. 49.
52. Ivi, p. 37.
53. Ivi, p. 39.
54. Idem.
55. Si legga la premessa al Mito.
56. L'uomo in rivolta, p. 11-2.
57. Friedrich Nietzsche, Umano, troppo umano, XI ed. Adelphi, Milano 2006, aforisma 638, p. 304-5.
58. L'uomo in rivolta, pp. 6-7, per l'intero capoverso.
59. Ivi, p. 12.
60. Ivi, pp. 6-8, per l'intero capoverso.
61. Ivi, p. 17.
62. Ivi, p. 18.
63. Ivi, p. 20.
64. Ivi, p. 21.
65. Ivi, p. 25.
66. In un intervista resa poco prima di morire, Camus afferma: «Io non credo in Dio, è vero. Ma non per questo
sono ateo. Sarei anche d'accordo con Benjamin Constant nel trovare l'irreligione qualcosa di volgare e [...] di
logoro». «Le monde», 31 agosto 1956.
67. Emmanuel Lévinas, Totalità e infinito, VI ristampa Jaca Book, Milano 2006, p. 57.
68. L'uomo in rivolta, p. 26-7.
69. Ivi, p. 329.
70. Ivi, p. 331.
71. Ivi, p. 332.
72. Ivi, p. 333.
73. Taccuini, libro II, p. 155.
74. L'uomo in rivolta, p. 335.
75. Rieux: «Non ho inclinazione, credo, per l'eroismo e per la santità. Essere un uomo, questo m'interessa». Albert
Camus, La peste, XXIV ed. Bompiani, Milano 2004, p. 197.
76. «L'uomo non è innocente e non è colpevole. Come uscirne? Ciò che Rieux, io, voglio dire, è che bisogna guarire
quel che si può guarire -- nell'attesa di sapere o di vedere. È una posizione d'attesa, e Rieux dice: "non so"».
Citato in Note ai testi di Roger Grenier, in Albert Camus, Opere, p. 1317.
77. «I personaggi concettuali [...] operano i movimenti che descrivono il piano di immanenza dell'autore e
intervengono nella creazione stessa dei concetti. Così, anche quando sono "antipatici", appartengono
pienamente al piano che il filosofo traccia e ai concetti che crea: essi segnalano allora i pericoli insisti in questo
piano, le cattive percezioni, i cattivi sentimenti o anche i movimenti negativi che ne derivano, introducendo dei
concetti originali il cui carattere di ripulsa resta una proprietà costituente di questa filosofia. [...] Il destino del
filosofo è quello di diventare il proprio o i propri personaggi concettuali, così come loro divengono altro da ciò
che sono storicamente, mitologicamente o correntemente (il Socrate di Platone, il Dioniso di Nietzsche, l'Idiota
di Cusano). Il personaggio concettuale è il divenire o il soggetto di una filosofia, è ciò che sta per il filosofo, al
punto che Cusano o anche Descartes dovrebbero firmarsi "l'Idiota", così come Nietzsche si firma "l'Anticristo" o
"Dioniso crocifisso"». Gilles Deleuze, Félix Guattari, Che cos'è la filosofia?, III ed. Einaudi, Torino 2002, p. 534, ma a riguardo leggere l'intero III capitolo del libro.
78. La peste, p. 30.
79. Ivi, p. 162.
80. Ivi, pp. 95-100.
81. Ivi, p. 197.
82. Riteniamo di poter affiancare, almeno su questo tema, Camus a Levinas. Come non intravedere quanto meno
delle concordanza tra i due, quando ad esempio il filosofo franco-lituano afferma che «la fame d'altri risveglia gli
uomini dalla loro sonnolenza di satolli e fa loro passare la sbornia del sussiego. La nuova trascendenza è il
rifiuto di credere a una pace in altri a causa di un'armonia qualsiasi nella totalità; la certezza che nulla può
ingannare la fame dell'altro uomo»? Tratto da Secolarizzazione e fame, disponibile all'URL
http://www.kainos.it/numero7/emergenze/Levinas.html
83. Giovane giornalista trovatosi impossibilitato a ritornare dalla propria amata a causa della peste, ma disposto ad
evadere a qualunque costo pur di rivederla.
84. La peste, p. 161-2.
85. «[...] ma non la sofferenza in se stessa era il suo problema (dell'uomo, n.d.A.), bensì il fatto che il grido della
domanda "a che scopo soffrire?" restasse senza risposta. L'uomo, l'animale più coraggioso e più abituato al
dolore, in sé non nega la sofferenza; la vuole, la ricerca persino, posto che gli si indichi un senso di essa, un
"perché" del soffrire. L'assurdità della sofferenza, non la sofferenza, è stata la maledizione che fino a oggi è
dilagata su tutta l'umanità - e l'ideale ascetico offrì a essa un senso!» Contrariamente a quanto ci si aspetti, la
citazione non è di Camus, ma di Nietzsche. Friedrich Nietzsche, Genealogia della morale, XV ed. Adelphi,
Milano 2008, p. 156.
86. Ivi, p. 102.
Irene Bianchi
Valore dell'etica, valore della
fenomenologia
1. Il filo conduttore
Condivido con Jacqueline Russ1 il fatto che stiamo entrando in un periodo in cui la 'scienza della
libertà', che Kant aveva battezzato come 'etica'2 tende a configurarsi come 'controllo di controllo' e
come 'potere sul potere'; per contro il pensiero etico contemporaneo dovrebbe tendere verso
un'esigenza di saggezza ovvero ad una riconquista di una ragione pratica di tipo inedito, garantita
dal più ampio consenso basato sulla capacità di dialogo e di ascolto, in direzione di un'etica che gia
Habermas e Rawls, peraltro, avevano teorizzato, e di 'un principio di responsabilità universale', e di
autoresponsabilità, che non escluda la reciprocità, così come Jonas per un verso, e Husserl per un
altro, proponevano a gran voce già molti anni fa.3
La ricerca di un'etica valida per l'umanità nel suo insieme, compreso il genere umano futuro datoci
in affidamento, dovrebbe quindi almeno illuminare l'ordine etico contemporaneo; la filosofia
pratica, già Kant sottolineava, non si fonda su ciò che è ma su ciò che 'deve essere', non tanto una
constatazione storica dell'avvenuto ma uno sguardo su ciò che 'deve succedere'; un divenire di una
società in continua trasformazione dove l'etica è da intendersi come uno dei compiti ultimi nel
mentre si realizzi un tentativo di ricomposizione dell'orizzonte ideologico (mai così aperto, direi
frammentato) fatto di molteplici differenze ed insieme anche di molteplici fraintendimenti, di
chiusure e barbarie; orizzonte che radica la nostra stessa responsabilità nel cuore delle
trasformazioni odierne.
Ciò che ci condurrà quindi attraverso le nostre riflessioni, verso l'etica fenomenologia, è una
domanda che è doveroso porsi nuovamente nella situazione storica attuale, ovvero: che cosa ha da
dirci la filosofia oggi, e ancor più la fenomenologia? Quale ne è lo scopo? La sua 'utilità'?
Tentiamo di rispondere iniziando da ciò che Husserl scrisse a proposito dell'VIII Congresso
Internazionale di Filosofia, che si svolse nel 1934 a Praga, in una lettera a Radl:
La filosofia è l'organon di una nuova forma di esistenza (Daseins) storica dell'umanità, un'esistenza
che si esprime nel suo spirito di autonomia [...] . L'autoresponsabilità filosofica si realizza
necessariamente nella comunità di coloro che filosofano. Considerando tutto ciò come principio, la
comunità filosofica e la filosofia sono il fenomeno originario e allo stesso tempo la forza viva
operante [...] la quale, partendo dalla mera intenzionalità attraverso la sua forza (Macht) ha creato
e coltiva un'intenzionalità del tutto nuova, ovvero un'unione mediante lo spirito di autonomia.4
Ciò che Husserl proponeva, con riferimento alla funzione della filosofia nel 1934, coincide con la
sua tesi, peraltro già conosciuta, in riferimento al processo di 'positivizzazione' della scienza in
relazione con la crisi della cultura; positivizzazione che ha condotto ad un occultamento del 'mondo
della vita' ed all'oblio della soggettività.5
Deplorando la perdita di valore vitale, causata dall'aspirazione incessante a ridurre tutto ciò che si
dà ad una natura calcolabile, Husserl ravvisa il pericolo di una visione 'generale' del mondo che
domini la cultura e porti alla dispersione della stessa filosofia «Questa è una questione pratica» -sottolinea il Nostro -- «Dunque la nostra influenza storica, e insieme la stessa nostra responsabilità
etica, si estende perfino alla più remota lontananza dall'ideale etico».6 Ed è nel trattare il rapporto
tra ontologia e fenomenologia che Husserl sviluppò un'etica fenomenologica seguendo proprio il
suo stesso modello ontologico.
Brevemente ricordiamo che nella prima parte della sua riflessione etica, egli si occupò della
refutazione dello scetticismo che si manifesta soprattutto nello psicologismo, al quale egli oppose
l'unica alternativa possibile ovvero la filosofia fenomenologica. La risposta allo scetticismo consiste
infatti nel riconoscere prima di tutto la validità, anche nell'etica, della rivendicazione del significato
dei sentimenti morali, per dimostrare dopo, sistematicamente, la possibilità di un ruolo 'obiettivo'
dell'etica stessa; si tratta di una teoria formale dei valori che sarà ripersa nelle sue lezioni del
1920.7
Egli sviluppò quindi inizialmente un modello etico partendo dal presupposto che tra la ragione
logico-teoretica e la ragione assiologico-pratica, ovvero tra l'idea della Verità e quella del Bene,
esista un'analogia;8 e sarà solo in un secondo momento che ad essa si collegheranno le ricerche
sulla cultura e sulla storia, frutto anche del periodo di transizione inerente alla Prima Guerra
Mondiale; transizione che consiste nel comparare criticamente quell'attualità 'priva di senso' con la
pretesa razionalità di una cultura filosofica del periodo, in contrapposizione ad una motivazione
che possa elevare al principio di responsabilità come condizione di possibilità di un 'rinnovamento'
(Erneuerung) della vita individuale, e di una cultura in generale, a partire da un impianto
teleologico dell'intenzionalità e della storia.9
Ne risulterà che il soggetto trascendentale non deve solamente 'preservare' il mondo da uno stato
di caoticità, ma anche dare 'forma' all'esistenza secondo le supreme idee della ragione, difendendo
così la vita dal caos che si presenta non appena la ragione si ritrae.
Husserl svilupperà nei suoi ultimi scritti una concezione pratica della fenomenologia, nel senso in
cui essa si rivela una riflessione che si conforma in un ethos', tramite il quale si costituisce una
comunità, quella dei 'funzionari dell'umanità', ovvero dei filosofi, che vive dello spirito di
autonomia ed indipendenza tipico della filosofia, il cui compito non si esaurisce nell'essere un
gruppo di persone appartenenti ad una determinata cultura, ma diviene un compito infinito di
tensione verso la 'Verità'.
Questo impegno etico, segnala Husserl, che è insieme una nuova concezione della temporalità, in
quanto l'autoresponsabilità del soggetto etico, costituisce la fenomenologia in una filosofia del
presente, partendo da una tradizione fondatrice, in un orizzonte di un lavoro infinito da realizzarsi
in ogni momento storico.
La fenomenologia ci aiuta ad approfondire il significato della proposta di come il sentimento
morale, quale punto di partenza del discorso etico, non solo non è una caduta nel relativismo,
proprio dello scetticismo, ma al contrario permette di superarlo fino a riconoscere la sua stessa
verità. Ricordiamo che nell'argomentazione di Husserl contro lo psicologismo, inteso come la
forma più pericolosa dello scetticismo, ovvero contro quel verdetto di condanna sulla conoscenza e
sulla logica che nega la possibilità stessa che esita una verità tanto nella logica come nella morale,
occupa un luogo importante la critica a Kant e al razionalismo. Il formalismo kantiano non
riconosce il significato 'situativo' del sentire e dell'atto del vivere, elementi di un'affettività invece
richiesta dalla fenomenologia. Per Kant solo la retta intenzione ha un significato morale mentre
sentimenti quali la gioia intimamente vissuta, è estranea al merito; tutt'al più può essere conforme
alla morale e può ricondurvisi per ciò che in essa si rispecchia dell'immanente razionalità. Quindi la
contraddizione dello scetticismo logico trova così un analogon' nel controsenso pratico in cui si
dibatte ogni proposizione imperativa che ci inviti a considerare illegittima, dal punto di vista
razionale, la pretesa racchiusa in un qualsiasi gesto di comando.
Per Husserl appare chiaro che solo la filosofia può vincere lo scetticismo in tutte le sue forme, quali
lo psicologismo, il naturalismo e insieme il positivismo scientifico in quanto inibitori, nella loro
visione unilaterale, di un diverso sforzo di comprensione insito nella filosofia stessa, così come egli
fortemente sottolinea proprio nella sua conferenza di Praga. Si tratta del 'tragico della scienza
positiva', che si esplica nella dispersione, data dalla massiva specializzazione delle scienze naturali.
2. Deprecato positivismo
L'iperspecializzazione delle scienze, la loro tecnicizzazione sempre più massiva, si scontra con un
sentire più profondo ed inglobante, tipico dell'uomo, che si esprime nell'universo filosofico,
portandolo verso la decadenza. Così facendo si deforma il concetto stesso di scienza; la
tecnicizzazione e iperspecializzazione portano ad un risultato che, al di là delle sue positive
scoperte, che non sono certo deprecate da Husserl, il fenomenologo è teso per lo più contro una
superficiale arroganza data dal 'finto' potere della 'macchina' sull'uomo e non viceversa; lo
scetticismo quindi nella sua forma fondamentale, che coltiva una sorta di diffidenza in riferimento
alla stessa filosofia, termina per essere l'oggetto della critica, la quale a sua volta motiva il
significato radicale del compromesso etico della fenomenologia.
Come sottolinea Ullrich Melle nella sua Introduzione' alle Vorlesungen ueber Ethik,10 Husserl
segue inizialmente, nelle sue prime lezioni sull'etica, lo stesso cammino del suo maestro Franz
Brentano e delle sue lezioni sulla filosofia pratica. Anche per Brentano si tratta di chiarire come è
possibile una considerazione dei sentimenti nel processo di fondazione etica, senza per questo
cadere nel relativismo o nello scetticismo etico. Certamente l'etica tratta del sentimento morale,
però non si chiarisce sul sentimento così come fa con il giudizio. Kant, per esempio, sottolinea
Brentano, per arrivare alle sue conclusioni sulla morale determina il significato ultimo e la validità
della morale stessa nella formalità dei principi, rifiutando tutta la partecipazione del sentimento e
dell'esperienza nel processo della conoscenza e della motivazione dell'azione morale. All'altro
estremo, l'empirismo riconosce tutta la forza morale propria dei sentimenti; il principio nel quale
però essi concludono non supera il livello di generalità di verità che in verità può darsi con
l'induzione e con l'abitudine.
Husserl argomenterà contro ambedue le posizioni; entrambe per un verso unilaterali,
sottolineando però che l'empirismo ha ragione ad iniziare le sue analisi dai sentimenti e nel
decidersi per l'esperienza viva nella quale si dà a noi il fenomeno morale; ma è necessario accedere
ad un'analisi intenzionale di questa esperienza viva del sentimento per poterlo includere
nell'intuizione del valore e non semplicemente interpretarlo come se si trattasse di un dato naturale
dell'esperienza interna.11 Come per la logica anche per l'etica vale affermare che gli empiristi
scoprendo l'intenzionalità nella loro analisi dell'esperienza interna, furono però ciechi ravvisando
in essa solo il luogo della forma e della genesi in modo naturalistico, non ne intesero perciò il senso
del trascendere del concetto di intenzionalità, del concetto stesso e del giudizio; ed è in questo
senso che anche Kant interpreta il sentire, come lo stesso empirismo, caratterizzando le sue analisi
al modo di una specie di fisiologia naturalista del conoscere umano.12
Alla fine però né Kant (nella deduzione trascendentale della prima edizione) né gli empiristi,
furono capaci, per Husserl, di esplicare e spiegare le scoperte dell'intenzionalità della coscienza per
ritrovare in quella forma la struttura del sentimento, pienamente 'vittime' appunto del pregiudizio
psicologista che guarda al sentimento solo come 'dato' naturale dell'esperienza interna.
Nell'analisi intenzionale del vivente, si evidenziano nella loro originarietà i fenomeni morali come
coscienza della situazione discernibile dal punto di vista morale, il che permette ad Husserl di
distinguere, classificare e sistematizzare, tutti quegli atti che confermano una 'fenomenologia della
morale'. In questo aspetto più analitico che trascendentale dell'etica fenomenologica si può
certamente accettare che Husserl sia superato da Max Scheler.13 Come già si è tentato di dire, il
punto cruciale dell'etica fenomenologica, si situa però non tanto nell'analisi etico-logica, quanto nel
passaggio dall'analisi intenzionale dei valori all'intenzionalità, intesa come responsabilità, e da qui
all'etica come coscienza storica e culturale tanto dell'individuo come della società.
In effetti, Husserl stesso ammette che la dimensione formale dell'etica non coincide con l'etica
stessa e il filosofo non avrebbe ancora assolto al suo compito quando avesse delineato in modo
esaustivo il sistema delle leggi formali della ragione pratica; alla dimensione formale deve
affiancarsi dunque una dimensione materiale dell'etica.14 Infatti le sue lezioni sull'etica del 1914 si
concludevano con una quarta parte dedicata alla 'Pratica formale' di cui l'ultimo paragrafo si
intitola Obiettività delle possibilità pratiche e la loro relatività al soggetto'.15 In questo paragrafo
si tematizza l'assunto della morale in relazione al soggetto dell'azione venendo così ad infrangere
una certa forma analogica tra l'analisi intenzionale della morale con l'ambito logico, così come
Husserl stesso scrive: «D'altro canto a una soggettività non può essere a priori richiesto nulla che
non sia poi in suo potere raggiungere»",16 e più avanti aggiunge:
Le nostre considerazioni [...] ci mostrano che [...] non è possibile cadere nell'errore di voler predelineare con il solito aiuto di un imperativo categorico, privo di contenuto, che cosa sia
praticamente richiesto e che cosa sia dunque assolutamente dovuto nella situazione determinata di
volta in volta presente. La logica formale con tutte le sue leggi non può metterci nella condizione di
dedurre la più piccola verità fattuale. Essa abbraccia [...] solo le verità formali. [...] Lo stesso si può
dire dell'assiologia e della pratica formali. [...] Sarebbero ora da definire le classi fondamentali dei
valori e dei beni pratici per poi rendere oggetto di indagine le leggi della preferenza. [...] Che cosa
dire dunque della valutazione di una persona in quanto essere razionale? [...] Di qui dunque
muovono le linee che ci conducono verso l'etica in senso proprio, verso l'etica individuale e
sociale.17
Che cosa significa per l'etica questo ampliamento di analisi da parte di Husserl grazie al quale si
scopre una nuova funzione della soggettività? Che cosa motiva il cambio di prospettiva nella sua
riflessione etica, ovvero il passare da un'analisi fenomenologica costitutiva del valore ad una
riflessione sul soggetto che valorizza e che agisce sino a convertirsi in una 'filosofia del presente',
così come il fenomenologo stesso la reclama alla fine della sua vita? Tentiamo di rispondere a
queste domande analizzando il pensiero di Husserl degli anni venti.18
3. La forza dell'autoresponsabilità
La particolare e tragica congiuntura storica presente in Germania nel periodo della prima guerra
mondiale entra direttamente a far parte dell'evoluzione del 'sentire' etico da parte di Husserl tanto
da promuovere una serie di tre lezioni per i soldati che ritornavano dal campo di battaglia. La
seconda è intitolata: L'ordine etico del mondo come principio creatore del mondo'19
Punto di partenza della lezione è la ormai nota diagnosi di Husserl in riferimento all'oblio della
tradizione filosofica a causa del positivismo. Questa rimozione della filosofia in favore della scienza
esatta farà esclamare ad Husserl che l'autogiustificazione farisaica della scienza è quanto mai
inopportuna senza contare l'ingiustificata deprecazione da parte della filosofia per parte di coloro
che sono educati alle scienze esatte e rigorose del tempo in cui viviamo. Per questo anche la stessa
guerra può essere intesa come un tempo di rinnovamento sin dalla fonte di tutti gli ideali di forza,
che fluisce verso il popolo stesso conservandone tutta la forza salvatrice. La caratteristica di questa
forza della filosofia sta nel suo determinare il sentire della vita:
«che può esser definita in funzione di un fine superiore della vita personale».20 Ed è solo questa
teleologia propria della filosofia, ed intrinseca nella stessa soggettività, che si presenta come il fine
etico superiore. Si tratta pertanto di una filosofia (e del sentire di una nuova metafisica) che
trasforma eticamente l'umanità, dove la persona diviene libera di agire, libera nel 'sapere' libero,
facente parte di una società a sua volta libera. Husserl non si inclina quindi verso una critica delle
guerra ma critica ampiamente la 'retorica bellica' puntando ad una posizione morale
universalistica, così come scriveva a Ingarden nel 1917: «l'etica come tale è una forma
transpersonale [...] come la stessa logica, tanto che il materiale della nostra posizione etico-politica
evidentemente non ne è poi tanto distante».21
Ma già alla fine della guerra il motivo etico si radicalizza più verso il versante della critica alla
cultura e alle sue diverse manifestazioni dove possiamo comprendere l'attitudine radicale della
fenomenologia:
come una decisione che mira ad elevare la vita da un mero fatto di scambio e di produzione,
attitudine che diviene una nemica mortale del capitalismo e di tutto un modo del tutto egoistico di
accumulare dei beni che non hanno a che fare con l'elevazione morale della persona.22
Alla fine comunque la valutazione della guerra, da parte di Husserl, non potrebbe essere più
negativa. Il fenomenologo sottolinea fortemente come questa metta allo scoperto un'indescrivibile
miseria morale, religiosa ed insieme filosofica dell'umanità. Tutto questo trasforma tutti i valori:
la scienza, l'arte e tutto ciò che sin ora si poteva considerare un bene spirituale assoluto, in oggetto
di apologetica e nazionalista, di mercificazione, [...] uno strumento di potere.23 L'effetto ideologico
di questa trasmutazione di valori è palese: [...] . La fraseologia e le argomentazioni politiche,
nazionaliste e socialiste hanno potere sulla massa più delle argomentazioni della 'sapienza
umanitaria'.24
A questa critica corrisponde per altro, purtroppo, l'entusiasmo percepito da Husserl da parte dei
giovani di ritorno della guerra verso questa stessa retorica ed una manipolazione propagandistica
degli ideali filosofici e religiosi e nazionalisti che minano l'autonomia del lavoro accademico, che
dovrebbe fondarsi in un ideale di un sapere fondamentale ed autentico. Con queste osservazioni,
quali segno del tempo storico vissuto, Husserl pensava inoltre di iniziare il primo di una serie di
articoli per la rivista giapponese The Kaizo', alla fine però preferisce tacere cercando di staccarsi
dalla polemica, sottolineando in altro modo il sentire tragico della situazione.
Husserl inizia i suoi articoli appellandosi al rinnovamento come unica possibilità di fuoruscita dal
tragico e tormentato momento storico. La guerra che dal 1914 ha devastato l'Europa e che dal 1918
non ha fatto che sostituire i mezzi di coercizione militare con quelli più raffinati della tortura
psicologica e dell'indigenza economica, non meno depravata dal punto di vista morale, ha rivelato
l'intima non verità ed insensatezza di tale cultura. Proprio questa rivelazione però finisce per
impedire che essa dispieghi appieno la sua autentica forza.25 Non è pertanto solo l'eco storica
dell'accadere che motiva la riflessione filosofica su di una determinata azione ma la sua
interpretazione culturale; infatti una nazione, sottolinea Husserl, un'umanità, vive e opera nella
pienezza delle forze soltanto se sorretta nel suo slancio da una fede in se stessa e nella bellezza e
bontà della vita della propria cultura.
Verrebbe da chiedersi come sia possibile in verità pensare al rinnovamento di fronte ad una falsità
del sentire, ad una stanchezza culturale così profonda; e la filosofia che tipo di competenze avrebbe
dovuto avere in un momento storico così cupo?
Diagnosticare la crisi per Husserl infatti non è sufficiente bisogna cercare anche una soluzione. Nei
manoscritti sulle lezioni etiche degli anni venti, Husserl si pone questo problema ed insieme
analizza anche la differenza tra mondo dello spirito e mondo della natura.26 La distinzione tra le
due differenti 'regioni', riguardanti ambedue in effetti il 'mondo della vita', permette di
caratterizzare in maniera rigorosa (in opposizione al mero principio di causalità), il sentire
profondo della motivazione quale perno per il regno universale dei fini che non è altro che lo stesso
'mondo della vita' nel quale riconosciamo la soggettività nel suo essere attiva da un punto di vista
della comunità.27 Da qui i valori positivi si vanno determinando a partire dall'autocoscienza, nella
quale si manifesta la possibilità infinita dell'essere umano non solo come individuo ma come
membro di un'unità culturale, dato che in essa si obiettiva l'unità della vita attiva, della quale
l'umanità di un'epoca e di una nazione ne diviene una sorta di soggetto. Per Husserl la motivazione
morale ultima, la quale accorda al sentimento un'autoresponsabilità radicale, forma parte della
fenomenologia stessa che si inscrive in un particolare sentire culturale, davanti al quale il filosofo
non può restare indifferente sin tanto che vuole autocomprendersi come 'funzionario
dell'umanità'.28
4. Filosofia ed etica individuale
Ma che cosa intende Husserl con l'uso della parola cultura o meglio di 'unità culturale'?
Per cultura -- scrive nel 1923 -- non intendo nient'altro che l'insieme delle azioni e operazioni
messe in atto da uomini accomunati nelle loro continue attività, operazioni che esistono e
perdurano spiritualmente nell'unità della coscienza della comunità e della sua tradizione
mantenuta sempre viva.29
La cultura quindi, che si esprime anche nell'espressione fattiva della creatività del singolo, e che
può sempre di nuovo essere fonte di ispirazione fruitivo-creativa, dando così senso ad una
continuità storica del farsi della cultura stessa, trascende la singolarità nella comunità pur creando
della comunità un'unità di membri legati tra loro, intrecciati da atti sociali complessi, che uniscono
spiritualmente una persona all'altra. In quest'ambito appare chiaro che l'etica individuale trova il
suo senso in un'etica sociale; così come l'invocato 'rinnovamento' dell'uomo si realizza nel
considerare l'individuo come parte integrante dell'umanità che diviene così il tema centrale
dell'etica stessa.
Questa concezione dell'etica significa che la filosofia morale può esserne solo una parte; mentre la
morale regola il comportamento pratico, buono, razionale, dell'uomo in relazione all'altro, l'etica
deve essere concepita necessariamente come la scienza della vita attiva, totale, della soggettività
razionale, dal punto di vista della ragione, dirigendo unitariamente vita e totalità; pertanto il titolo
di ragione deve, per Husserl, comprendere un sentire generale, di conseguenza: «la vita attiva di
una comunità di un'intera comunità -- quand'anche non fosse comparsa nessuna realtà storica -può assumere la forma unitaria della ragione pratica, la forma di una vita etica»30
Per specificare maggiormente e qualificare questo suo sentire etico Husserl, nel terzo dei suoi
articoli per il The Kaizo, si pone il problema, forse più importante dell'intera riflessione, ovvero:
che cosa intendiamo quando parliamo di soggetto inteso come 'persona libera'? Il punto di
partenza per una così complessa ma essenziale analisi è la facoltà dell'essere umano, che
appartiene alla sua stessa essenza, di avere un'autocoscienza, ovvero un sentire preciso
dell'introspezione (inspectio sui) e della facoltà di prendere posizione e di agire; atti personali che
si riferiscono riflessivamente alla propria vita e a se stessi; pertanto sembra chiaro che l'essenza
stessa dell'uomo si incentri sulle capacità di rappresentazione, pensiero e di avvaloramento, in
quanto atti singolari e valutazione dei propri atti, motivazioni e scopi, possibili o reali che siano.
L'essere umano può quindi passare da una dimensione particolare ad un'universale, dalla forma
dell'assoluto a quella del generale; egli può far precedere ad ogni attività una valutazione e una
libertà di scelta che nessun altro essere può esercitare. Di più, l'uomo ha la facoltà di inibire gli
effetti delle proprie pulsioni e delle affezioni 'passive', di metterle in questione, di esaminarle; esso
diviene così, in senso pregnante, soggetto di volontà che non segue il corso degli eventi ma prende
da sé (e su di sé) le proprie decisioni.
Una libera volontà che per Husserl si eleva nel momento che il soggetto può far valere questa
possibilità nel confronto tra altri atti liberi, dove porre una posizione critica ed esaminare l'intera
questione riconfermando un'eventuale presa di posizione, oppure rifiutandola, e questo in un
possibile continuo Immer wieder che mi permette di liberarmi da catene causali negative e di 'ricominciare' ogni volta alla luce della ragione. Non posso revocare l'evento gia accaduto ma posso
nel corso ulteriore della vita, a seconda dei casi, revocare, rivedere, rivalutare, i miei atti di
volontà.31
All'essenza della vita umana appartiene inoltre lo svolgersi costantemente nella forma
dell'aspirazione: «e alla fine questa assume la forma dell'aspirazione positiva e che perciò è
abbinata al conseguimento dei valori positivi».32 Questa 'tendenza' (Streben), che Husserl sembra
riprendere dal pensiero fichtiano, è la tipica teleologia dell'intenzionalità, che alla fine non è altro
se non la ragione stessa, nella quale l'autoregolazione del soggetto trova la sua genesi pre-riflessiva
e il suo pieno significato come responsabilità personale e sociale. Questa caratteristica dell'uomo,
conquistata con la descrizione fenomenologica, a partire dal concetto di inspectio sui, può essere
ampliata sia in riferimento all'auto-riflessione, il che significa 'auto-referenzialità' come struttura
formale del soggetto, che all'attività libera come principio personale oltreché alla tendenza come
sua dinamica materiale e infine alla razionalità come Telos' universale; tutte queste caratteristiche
coniugandosi costituiscono, secondo Husserl, le competenze etiche del soggetto.
Davanti ad un'etica del piacere, della tendenza materiale, si oppone un'etica della ragione,
indipendente da tutte le tendenze materiali; l'uomo può così liberarsi da determinazioni eteronome
per poter 'auto-determinarsi' al fine di evolversi positivamente. Questa capacità etica la si
comprende poi come 'auto- motivazione', la quale a sua volta si relaziona con la ragione pratica.
Una relazione che costituisce la possibilità di assumere l'imperativo categorico di 'essere un uomo
autentico', nel senso di compiere il 'meglio possibile', di vivere una vita della quale si possa essere
sempre auto-responsabili; una vita alla luce della ragione pratica il che significa 'volere il mio
dovere'.33
In questa forma possiamo arguire che il primo successo della fenomenologia, nello spostare la
riflessione sul modo di darsi dei valori e degli atti della volontà al soggetto della valorizzazione e
dell'azione, consiste nel riscatto della persona morale, della sua attitudine etica, nel suo essere
'buona moralmente'. Rimane però da risolvere la questione dell'etica individuale che deve essere in
fondo un'etica sociale e culturale, quale lavoro comune che si costituisce in una forza culturale, che
incide alla fine nel particolare stesso. A tal fine è necessario, prima di tutto, riconoscere il
significato dell'appartenenza di ciascun uomo a una società, dato che ogni circostanza della sua
vita, intergrata in una vita comunitaria, ha una sua conseguenza, conseguenza che determina così
principalmente il suo comportamento etico, che lo caratterizza formalmente. In effetti il fatto di
appartenere ad una società, non solo mi permette di valutare gli altri come facenti parte del mio
'mondo della vita', portatori di un valore particolare riconosciuto socialmente, un valore in sé che
nulla ha a che fare con l'utile, un puro interesse etico, ma insieme come valore in riferimento alla
società stessa, per questo la mia volontà etica deve essere diretta nel fare il possibile perché si
realizzino i beni veri, autentici, in ogni circostanza e nell'intera vita in un effettivo impegno di
volontà etica. Conseguentemente dovrebbe essere proprio della mia esistenza non solo lo sforzarmi
per essere più buono ma arrivare a desiderare che anche l'altro lo sia per far sì che in modo
concorde si possa conformare una società buona.
Questo implica però che nella vita sociale si presentino, come del resto succede, dei conflitti;
conflitti che Husserl crede di poter sciogliere tramite un mutuo intendimento etico che permetta
soluzioni 'migliori possibili'; e ciò nel costituirsi, alla luce di un tale intendimento, di
un'organizzazione etica della vita attiva, nella quale le persone siano una di fronte all'altra, in
continuo rapporto, sino a poter parlare di una 'comunità della volontà' che abbia un mutuo comune
intendimento volontario. Per giungere alla conformazione di questa comunità dobbiamo sì pensare
all'importanza del punto di vista personale, ma evitare una ristrettezza che non permetterebbe di
procurare che i valori della società siano un obiettivo comune di coloro che la formano.
In effetti l'appartenere ad una società non solo mi permette di apprezzare l'altro come parte
integrante della mia stessa Lebenswelt' (fornito quindi di un particolare valore), ma anche come,
insieme a me, facente parte dello stesso valore sociale libero da ogni utilitarismo, valido quindi
come 'valore in sé'; per questo è importante per me che anche l'altro realizzi la sua vita il più
correttamente possibile con un forte impegno di volontà etica.34
A questo punto l'intero livello di valore dato dal singolo dipende da quello della comunità e
correlativamente la stessa comunità ha un valore che, pure essendo mutevole, ed eventualmente
accrescibile in virtù della mutevolezza e dell'accrescimento del valore del singolo, via via
accrescendosi dei singoli dotati di valore, abbia
un valore come unità di una comunità di cultura e come ambito di valori fondati che non si
risolvono nei singoli valori, ma sono fondati dal lavoro dei singoli, in tutti i valori legati alla loro
singolarità e a questi conferiscano un valore più elevato, anzi incomparabilmente più elevato.35
La relazione di fondazione è così completa. Il fondato si costituisce a partire dall'atto del quale è
fondamento, e la nuova realtà fondata non è semplicemente un risultato addizionale, sommatorio,
di una serie di attitudini valori o azioni. La società acquisisce un sentire nuovo ed esplicitamente
distinto dal mero integrarsi e conformarsi alla regola. L'importante significato che qui si vuole
sottolineare è che la società non è semplicemente un insieme di singoli individui (così come la vita
e l'agire comuni non sono un mero collettivo di vite e di azioni individuali), ma ogni singolo essere,
ogni singola vita, sono 'attraversati' da un'unità di vita. Sebbene questa stessa unità rimanga
fondata sulla singola vita, trascendendo il mondo circostante di ognuno di noi, e costituendosi in
relazione costante con questo stesso mondo, la società emerge quindi come relazione. Resta
pertanto chiaro lo specifico di una società fondata nel modo d'essere di differenti persone, nei loro
progetti e nelle loro attitudini; ed anche il modo di essere della comunità, come costituita e fondata
a partire dalle persone stesse, influisce a sua volta sul singolo, e ciò caratterizza il senso
dell'appartenenza sociale. Si apre così una relazione biunivoca tra il singolo, eticamente orientato e
la comunità stessa, che orientandosi eticamente su se stessa, in quanto comunità etica, si orienta
sul singolo che ne è parte integrante. Inoltre è essenziale che tutte queste riflessioni si 'socializzino',
che producano dei 'movimenti sociali' e che motivi e azioni sociali, corrispondenti al compromesso
etico degli associati, siano orientati alla conformazione e rinnovamento della società
autenticamente etica costituita perché «una direzione della volontà che è tale in quanto propria
della comunità stessa, e non è mera somma delle volontà dei singoli che la fondano».36
In questo complesso intreccio relazionale si inserisce così quel rinnovamento etico individuale,
insieme a quello culturale, fondantesi sulla persona. In questo modo via via progredisce sia lo
sviluppo culturale della società come di chi la compone. Il significato etico della comunità influisce
in modo sostanziale nel comportamento dell'individuo, perciò l'eticità di un popolo deve essere
preoccupazione della persona se questa nel suo proprio comportamento tiene ad una certa
autenticità. Si tratta infatti, come abbiamo visto, di descrivere come una società passi dall'essere
una 'mera comunità di vita' per convertirsi in una 'comunità di persone', è per tanto necessario che
la persona non solo abbia attitudine etica ma che si dia in essa un'idea della necessità di una
cultura eticamente costituita.
A partire da questa intenzionalità fondazionale della società etica si ha il compito formale di
rinnovamento della comunità verso l'idea di un autentica umanità giusta ed equa razionalmente
nei diversi ambiti della vita. La scienza sociale come forma culturale deve essere quindi
intimamente relazionata con la filosofia quale organo di riflessione proposto al destino etico di una
società.
L'atteggiamento da assumere al fine di ottenere questa società e cultura etica passa attraverso la
mediazione dell'educazione. La consolidazione di una cultura etica in un popolo porta a
confrontare una comunità che si identifichi con l'idea di ragione e con valorizzazioni ad essa
corrispondenti. Deve quindi esserci coscienza di scopi comuni, del patrimonio comune da
incrementare di una volontà totale della quale tutti si sanno 'liberi' funzionari. In una nota al
secondo articolo per il The Kaizo' Husserl scrive: «Vi è un legame universale di volontà che
producono l'unità della volontà, senza che vi sia un'organizzazione imperialista» ed in nota alla
pagina aggiunge: «Qui potremmo parlare anche di una unità comunista della volontà in
opposizione ad una imperialista».37 Più avanti egli chiarirà l'uso di questi termini, che sono in
verità estranei alla terminologia husserliana, riferendosi all'autorità del filosofo all'interno della
cultura antica. Se la comunità filosofica era per così dire comunista ciò non significa che l'idea di
comunista fosse maneggiata per una particolare volontà sociale inglobante, ma bensì allora si
intendeva la comunità corrispondente dei sacerdoti o dei filosofi dominati da una volontà
unitaria.38
5. Ricapitolando
Alla fine la proposta di Husserl sembra essere per tanto una società fondata e guidata, per l'idea di
filosofia e per il senso delle teleologia e dell'etica, dalla responsabilità. In questo tipo di società non
solo si protegge la libertà della persona, ma la si arricchisce grazie al carattere etico della società
stessa nella quale si promuovono i valori di una cultura ogni volta più umana. Questo è il
significato pieno della cultura filosofica di una comunità in continuo progresso dove si sviluppa
uno spirito etico comune che dà vigore all'idea etica di comunità e al carattere di un'idea teleologica
di comunitaria. Questa forma di argomentazione si orienta dunque a mostrare come il patto etico
del soggetto, fondato sulla autoriflessione, è proprietà intrinseca dell'intenzionalità quale
responsabilità, capacità di autonomia e di autodeterminazione per 'un imperativo categorico' del
ragionante. Per Husserl non sembra possibile separare autoresponsabilità e responsabilità storica e
culturale, per ciò la possibilità del singolo di essere responsabile dei fini dell'umanità schiude
l'orizzonte del singolo direttamente verso un compito storico in relazione con la cultura del 'suo
proprio popolo' che è in personale relazione con l'altro. Questo aspetto della riflessione si accentua
molto chiaramente in un testo del 1924, dove il fenomenologo lo ripete e lo chiarisce, così scrive:
Io posso assumere e ricercare un destino sociale e lo posso compiere in diversi modi, per questo
destino io sono responsabile. Come la comunità, da un lato, non è una mera 'serie' di individui che
si raggruppano insieme, ma al contrario una unificazione di questi individui per opera
dell'intenzionalità interpersonale, un'unità fondata grazie alla vita, all'azione sociale, di uno nei
confronti dell'altro, così come anche di uno contro l'altro, allo stesso modo l'autoresponsabilità, la
volontà di autoresponsabilità, la riflessione razionale del senso e delle vie possibili di questa
autoresponsabilità, per una comunità, non è una mera somma di varie autoresponsabilità [...], ma
al contrario di nuovo una unificazione che tiene uniti intenzionalmente, una con l'altra,
l'autoresponsabilità individuale e fonda tra queste un'unità interna.39
La citazione appartiene al testo che tanto impressionerà Habermas nel momento di proporre la
trasformazione del suo iniziale modello filosofico; ovvero dalla filosofia della coscienza alla teoria
dell'azione comunicativa, a partire dall'analisi del 'mondo della vita' e dell'intersoggettività in
Husserl.
Husserl -- scrive Habermas -- conclude la sua riflessione guardando alla vita intenzionale come in
continua universale relazione con la verità, [...] verso l'esigenza pregevole di una autoresponsabilità
assoluta dell'umanità socializzata; Husserl non dubita nel designare questa problematica come
etica e propone uno sviluppo razionale di questa tematica.40
Di fatto la stessa intenzionalità, intesa come tendenza verso la ragione e verso la verità, che si dà
nella sua 'struttura teleologica universale', è la stessa ragione pratica. Rimane però aperta la
domanda di come si dia nella soggettività il fenomeno stesso dell'intersoggettività, a partire dal
quale appunto si apre e si costituisce originariamente la 'regione' dell'etico, come Husserl scrive
sempre nel 1924:
La domanda è -- parlando idealmente- come può una pluralità di persone [...] in una possibile
relazione di comprensione, oppure attraverso relazioni personali, uniti tra loro in collettività,
realizzarsi in una vita di assoluta responsabilità e condurre tale vita comunitaria, fatta di una
comunità di volontà, dirigendosi verso questa responsabilità; [...] una tale premessa ci conduce
verso la necessità di ricercare l'origine di questa idea, ovvero di un'idea di scienza critica ed ideale
che si origini in ogni persona insieme al compito di conformarsi all'idea teleologica di comunità. 41
Note
1.
J. Russ, L'etica contemporanea, Il Mulino, Bologna 1997, p. 99.
2.
I. Kant, Prefazione alla Fondazione della metafisica dei costumi (1785), Laterza, Bari, 1993.
3.
J. Habermas, Etica del discorso, Laterza, Roma 2004, J. Rawls, La giustizia come equità. Saggi (1951-1969),
Liguori, Napoli 1995, H. Jonas, La filosofia alle soglie del Duemila. Una diagnosi e una prognosi, Il Nuovo
Melangolo, Bologna 1994.
4.
E. Husserl, An den Präsidenten der Internationalen Philosophen-Kongresses in Aufsätz und Vorträge (19221937), Kluwer Acad. Publ., Dordrecht 1989, Hua XXVII, p. 240.
5.
Il testo del 1934, in verità non è molto diverso dall'articolo apparso sulla rivista Logos del 1911, intitolato La
filosofia come scienza rigorosa', dove Husserl si riferiva, molto polemicamente, alla differenza tra la filosofia
intesa quale scienza rigorosa e la pretesa visone d'insieme della 'mera scienza'; tutto questo riguarda il destino
stesso della persona, quale diverso senso dell'umanità e della storia nel senso di un diverso compito della cultura
e con: "la possibilità di una realizzazione continuamente progressiva dell'idea di eternità dell'umanità ", in
Aufsätz und Vorträge (1911-1921), M. Nijhoff, Den Haag 1986, Hua XXV, p. 116.
6.
E. Husserl, Die Krisis der Europäischen Wissenschaftten und die traszendentale Phänomenologischen
Reduktion, M. Nijhoff, Den Haag 1959, Hua VI, p. 100.
7.
E. Husserl, Einleitung in die Ethik. Vorlesungen Sommersemester 1920 und 1924. Kluwer Acad. Publ.,
Dordrecht 2004, Hua XXXVII.
8.
E. Husserl, Vorlesungen über Ethik und Wertlehre. (1908-1914), Kluwer Acad. Publ., Den Haag 1988 Hua
XXVIII, p. 29.
9.
E. Husserl, Aufsätze und Vorträge (1922-1937), Kluwer Acad. Publ., Den Haag 1989.Hua XXVII.
10. U. Melle, Einleitug des Herausgeber, in Hua XXVIII, op.cit., p. XX.
11. E. Husserl, Hua XXVIII, op. cit., pp. 390-391.
12. E. Husserl, Phänomenologische Aufklärung del Doppelseitigkeit der Formalen Logik als Formalen Apophantik
und Formaler Ontologie in Formale und Transzendentale Logik, M. Nijhoff, Den Haag, 1974, Hua XVII, op.
cit., p. 100 e sgg.
13. M. Scheler, Il Formalismo nell'etica e l'etica materiale dei valori, Fratelli Bocca, Milano, 1944.
14. E. Husserl, Hua XXVIII,op. cit., p. 140.
15. Idem, p. 145 e sgg.
16. Idem, p. 149.
17. Idem, pp. 154-155.
18. Così Husserl scrive nel 1934: «Chiediamoci la filosofia del presente, è totalità che, come succede con la scienza
positiva, collega tutta la sua analisi in un'unità grazie alla sua stessa finalità alla cui investigazione, intesa come
un progresso infinito collaborano tutti i suoi ricercatori? C'è nella filosofia un metodo unitario, un sistema
crescente di dottrine, che si unifichi tutta la teoria? Sono tutti i ricercatori uniti sotto la stessa motivazione,
verso la ricerca in riferimento ad un unico fondamentale problema?» in Hua XXVII, op. cit., p. 184. Si veda
anche il mio I. A. Bianchi, Etica husserliana, FrancoAngeli, Milano 1999.
19. E. Husserl, in Hua XXV, op. cit., p. 267 e sgg.
20. Idem p. 271.
21. E. Husserl, Briefe an Roman Ingarden, a cura di R. Ingarden, M. Nijhoff, Den Haag, 1968, p. XXXI,.
22. Così scrive Husserl ad Arnod Metzger; in Briefe, op. cit., p. XXX.
23. E. Husserl, Beilage X, Hua XXVII, op. cit., p. 122.
24. Idem, p. 117.
25. E. Husserl, Fünf Aufsätze über Erinnerung, Hua XXVII, op. cit., p. 3.
26. Cfr. I. A. Bianchi, Etica husserliana, op. cit., pp 163-175.
27. E. Husserl, Natur und Geist, Kluwer Acad. Pub., Dordrecht 2001, Hua XXXII ed anche Natur und Geist.
Vorlesungen Sommersemester 1919, Kluwer Acad. Pub., Dorderecht 2002, Husserliana Materialien Bd IV.
28. Guillermo Hoyo Vásquez, Intentionalität als Verantvortung. Geschichtsteleologie und Teleologie der
Intentionalität bei Husserl., M. Nijhoff, Den Haag, 1975, Phä 67.
29. E. Husserl, Erneuerung als individualethisches Problem, in Hua XXVII, op, cit., p. 21.
30. Idem, p. 20.
31. In riferimento anche I. A. Bianchi, Autocoscienza e libertà: le tesi husserliane sulla persona quali fondamento
dell'agire etico, in Etica e persona, Atti convegno, Verona, aprile 2003, FrancoAngeli Milano 2004, (pp.111133).
32. E. Husserl, Erneuerung als individualethisches Problem, Hua XXVII, op. cit., p. 25.
33. Idem, p. 36.
34. Ibidem.
35. Idem, p. 48.
36. Idem, p. 49.
37. Idem, p. 53 in nota.
38. E. Husserl, Die Entwicklung der philosophischen Kulturgestät' in Hua XXVII, op. cit., p. 90.
39. E. Husserl, Meditation über die Idee eines Individuellen und Gemeinschaftslebens in Absoluter
Selbstverantwortung, in Erste Philosphie (1923/1924), M. Nijhoff, Den Haag 1949, Hua VIII, pp. 197-198.
40. J. Habermas, Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikatives Handelns. Suhrkamp, Frankfurt
a. M. 1984, p. 44.
41. E. Husserl, Hua VIII, op.cit., p. 199.
Loretta Pistilli
Il corpo tra scrittura e morte. Una
lettura fenomenologica del racconto di
Franz Kafka «Nella colonia penale»
1. Introduzione
Il presente articolo si propone di analizzare il modo in cui il corpo, da sempre al centro della
cultura occidentale, è rappresentato da Franz Kafka nel racconto «Nella colonia penale» del 1914.
Procedendo secondo la prospettiva fenomenologica e partendo dalle nozioni di Leib e Körper che
Edmund Husserl introduce nella quinta delle sue Meditazioni cartesiane, si cerca di mostrare
come, nel racconto kafkiano, i personaggi siano sottoposti ad un'inarrestabile quanto irreversibile
processo di regressione allo stato di Körper, con conseguente e definitiva chiusura di qualunque
spazio relazionale e caratterizzazione della colonia penale come la rappresentazione letteraria di
quella società disciplinare successivamente teorizzata da Michel Foucault in Sorvegliare e punire
(1975). In questo senso, l'incisione impressa sulla pelle del soldato dalla macchina delle esecuzioni
diventa il segno di un potere che trova nel corpo Körper il naturale spazio in cui imporre se stesso.
Il corpo marchiato, che nelle società arcaiche è spazio simbolico per eccellenza, assurge nella
colonia kafkiana a simbolo di un sistema coercitivo per il quale l'individuo è semplicemente il corpo
che ha piuttosto che il corpo che è. La colonia si configura dunque come un apparato costruito in
modo tale che i corpi reificati diventino finalmente docili e chiusi in un orizzonte dove niente ha
più senso, nemmeno la morte.
2. Corpo e scrittura attraverso il processo di regressione a Körper
Quale destino attende la parola scritta quando la sua vita si consuma nella serialità di un gesto
meccanico e ripetitivo, quando, nella coazione a ripetere, è declassata a mero segno che non
rimanda ad altro se non a se stessa? Dato atto che scrivere è
una questione di divenire, sempre incompiuto, sempre in fieri, che travalica qualsiasi materia
visibile o vissuta, [...] ossia un passaggio di vita che attraversa il visibile e il vissuto,1
quando il gesto scrittorio coincide con le
funzioni puramente pratiche di contabilità, di comunicazione, di registrazione, censurando il
simbolismo che anima il segno scritto»,2
quello che ne deriva è la morte del segno, ovvero la morte di tutte le sue possibilità di senso. «In tal
modo, scrittura entra in opposizione con [...] scrivimento»,3 ossia con «la semplice trascrizione dei
messaggi».4 In questo quadro, l'incisione dolorosa che la micidiale macchina per le esecuzioni
capitali descritta da Franz Kafka in Nella colonia penale (1914) 5 scava sulla pelle del condannato,
non rinvia a nient'altro se non a quello che indica, cioè al comandamento trasgredito dal reo: onora
il tuo superiore.
È una macchina curiosa, disse l'ufficiale all'esploratore, abbracciando con uno sguardo in certo
senso ammirato la macchina, che pur conosceva bene. Ma l'esploratore sembrava aver ceduto
soltanto per cortesia all'invito del comandante di assistere all'esecuzione capitale di un soldato
condannato per insubordinazione e oltraggio al superiore.6
La pena, che il reo apprende soltanto nel momento in cui la subisce, è sempre la stessa:
Quando l'uomo è steso sul letto e questo comincia a sussultare, l'erpice viene abbassato sul corpo e
si colloca da sé in maniera da toccarlo appena con le punte. Una volta fissata la posizione, questo
cavo d'acciaio s'irrigidisce in modo da diventare come una sbarra. Ed ora, incomincia il gioco. Chi
non è iniziato, non si accorge lì per lì di qualche differenza tra pena e pena. L'erpice par lavorare
sempre allo stesso modo. Vibrando, trafigge con le sue punte il corpo, che vibra per conto suo nel
letto. Per rendere possibile a tutti di controllare l'esecuzione della condanna, l'erpice è fatto di
vetro. C'è stata qualche difficoltà tecnica da superare per riuscire a fissarvi gli aghi, ma dopo molti
tentativi ci siamo riusciti. Ed ora, tutti possono vedere, attraverso il vetro, come l'iscrizione venga
segnata sul corpo.7
Durante le prime sei ore, il corpo viene ripetutamente trafitto dall'erpice e, solo più tardi, il
condannato inizia a decifrare, nel fitto groviglio di ferite disegnate sulla schiena e sull'addome, lo
scritto della legge violata. La macchina
non deve infatti uccidere subito, ma in media soltanto in un periodo di dodici ore. Dopo sei ore, si
calcola, giunge il punto culminante. Occorre dunque che lo scritto vero e proprio sia circondato da
molti ghirigori, perché da solo gira intorno al corpo.8
Il terribile supplizio, a cui il carnefice sottopone le sue vittime, poggia su tutta un'arte quantitativa
della sofferenza», giacché «la morte supplizio è l'arte di trattenere la vita nella sofferenza,
suddividendola in mille morti e ottenendo, prima che l'esistenza si concluda, le più sublimi
agonie.9Il sistema di potere della colonia penale, governata dall'ufficiale custode della macchina,
agisce in modo da svuotare la scrittura del suo essere
pratica di godimento legata alle profondità pulsionali del corpo e alle produzioni più sottili e più
felicemente riuscite dell'arte10
e il corpo della sua capacità di significazione, riducendolo, in quanto inerte superficie di scrittura, a
pura estensione. Perduta ogni possibilità di apertura all'interpretazione, la scrittura, portatrice di
morte e morta essa stessa, conserva come unica funzione quella di proiettare sulla carne i segni
indicativi di un potere annientante che, esibendo il corpo all'interno di spazi di controllo e di
manipolazione, lo trasforma in oggetto. In questo racconto, il corpo perde la sua peculiare qualità
di corpo-Leib, nel senso di corpo soggettivo e vivente, che è «subito fuori di sé, aperto al mondo,
proteso sulle cose»,11 per scadere al livello di Körper, quale realtà somatica esperibile come mera
aggregazione di organi e, in quanto tale, chiusa nell'unica modalità di esistere, ossia nella modalità
dell'avere. Ma l'esperienza corporea, della cui complessità abbiamo costantemente coscienza, non
può essere ridotta ad un fascio di funzioni vissute in terza persona e slegate fra loro e dal mondo,
dal momento che
noi siamo anzitutto viventi e abbiamo poi un'apparecchiatura chiamata corpo, ma viviamo vivendo
come corpo. [...] Vivere come corpo è qualcosa di essenzialmente diverso da un mero essere gravati
da un organismo,12
e coincide con «l'orizzonte d'essere»13 del nostro soggiorno, nel senso dell'abitare il mondo quale
luogo delle nostre azioni e scopi. Col che s'intende il corpo non semplicemente come mezzo per fare
qualcosa, bensì come possibilità per essere nel mondo, ovvero come possibilità per accedere, in
quanto soggetti incarnati, alla rete di significati che il mondo dischiude. Nella colonia penale, in cui
è negata qualsivoglia libertà d'azione, I personaggi sono circoscritti ai loro corpi e penosamente
irrigiditi nel proprio ambiente, senza mai essere posti nella libertà dell'apertura dell'essere, mentre
solo tale apertura è il mondo.14
Il movimento senza posa entro gli interminabili labirinti che disegnano l'immutabile mondo
kafkiano in cui Josef K. e l'agrimensore K. si smarriscono alla ricerca di una meta inesistente, viene
qui ricondotto all'immobilità del faccia a faccia tra l'ufficiale e l'esploratore, e al meccanico
dilaniare di un corpo che è, come quelli, solo Körper.
3. Il corpo marchiato: da spazio simbolico a simbolo del potere
Il corpo rappresentato da Kafka sul punto di essere scavato dagli innumerevoli aghi della
macchina, non è più il corpo inciso e inscritto nell'ordine del simbolico delle società arcaiche, le
quali, «marchiando il corpo, lo de-signavano come l'unico spazio degno a portare il segno del
gruppo»,15 ma è l'organismo inserito in un «orizzonte spersonalizzato»16 che, annullando
l'individuo come «polo d'identità intenzionale»,17 dissolve la potenzialità eversiva della corporeità
in quanto centro d'irradiazione del desiderio e delle pulsioni. La trasformazione del Leib in Körper,
imposta dal sistema disciplinare interno alla colonia penale, coincide con il venir meno di quel
patto originario che deve necessariamente stabilirsi tra
il mio corpo come esigenza di certi piani privilegiati e lo spettacolo percepito come invito ai
medesimi gesti e teatro delle medesime azioni», un patto che «Fa usufruire dello spazio e in pari
tempo dà alle cose un potere diretto sul mio corpo. [...] Il mio corpo è in presa sul mondo quando la
mia percezione mi offre uno spettacolo il più possibile vario e chiaramente articolato, quando le
mie intenzioni motorie, dispiegandosi, ricevono dal mondo le risposte che attendono.18
Se il corpo definito dalla logica del potere è un corpo-Körper oggettivato che si manifesta entro la
forma del dato anatomico, quello delle società primitive è un corpo Leib comunitario
a cui i singoli partecipano come frammenti o anelli dell'ordine unitario, dove circola quell'ordine
simbolico che compone le energie del corpo umano con quelle degli altri.19
In queste società strutturate in clan e tribù, imprimere tatuaggi e scarificazioni sulla pelle di
qualcuno significa non soltanto segnalarne l'età o il rango sociale, allontanare le malattie o
acquisire poteri magici, ma indica soprattutto la possibilità di condividere con gli altri lo stesso
linguaggio simbolico, che, precedendo la parola nella sua immediatezza espressiva, consente una
comunicazione più profonda, in virtù di quella capacità, propria del simbolo, di produrre forti
«legami di identificazione tra singolo e comunità».20
Il gruppo, nel suo farsi realtà concreta di riferimento, si costituisce a divinità incarnata capace di
gestire quell'energia dei singoli, che i singoli, nella loro finitudine, non possono sopportare. Il
gruppo vive e ha bisogno di questa energia che è qualcosa di più potente, nel bene e nel male, della
semplice somma delle parti, proprio come il singolo ha bisogno del gruppo.21
Anche il dolore sofferto durante le pratiche di modificazione del corpo contribuisce in modo
determinante alla formazione dell'identità individuale. Avvertendo con maggiore intensità le parti
sottoposte al trattamento, il singolo vede enormemente potenziata la sua capacità percettiva, dato
che è proprio nelle situazioni estreme che il corpo si rivela nella sua essenziale natura di corpo
vivente. Ma c'è di più: poiché ad essere perforate o incise sono spesso la lingua, i capezzoli e gli
organi genitali,22 zone tradizionalmente considerate erogene, l'esperienza dolorosa è
accompagnata dall'aumento dello stimolo sessuale in sé e nel proprio partner, il che favorisce
l'accesso all'insieme integrato delle sensazioni corporee, e quindi all'idea della persona come
totalità. L'immagine che questi popoli hanno dell'uomo, non è quella
d'un io distinto, con i suoi organi, pelle, affettività, pensieri separati dal resto della comunità, ma
quella di un corpo in comunicazione con tutta la natura e tutta la cultura, e tanto più singolo
quanto più si lascia permeare dal maggior numero di forze naturali e sociali. Il corpo comunitario
crea così un gioco sottile e precario fra il simbolico e l'immaginario, dove però queste categorie non
sono pertinenti come pretendono di essere nella società moderna. L'immaginario è talmente
presente, soggiacente e aggrovigliato al simbolico, che, molto spesso, anche nelle sue
manifestazioni estreme come la follia, fa irruzione nella socialità delle comunità arcaiche.23
L'equilibrio tra il singolo e la comunità e tra questa e l'ambiente si fonda sull'idea che l'uomo e
l'universo siano governati dalle medesime leggi e che, proprio in virtù di tale analogia, l'armonia
del macrocosmo si rifletta sul microcosmo umano attraverso la perfetta sintonia di corpo, mente e
spazio. In questo contesto simbolico di corrispondenze, Il corpo segnato da cicatrici e ornamenti
vari si apre al mondo per immergersi nel più vasto ordine cosmico, dove tutte le cose sono
indissolubilmente legate in un eterno fluire. Si tratta di un movimento circolare e del tutto estraneo
ai rigidi binari della ragione oggettivante fondatrice della dialettica degli opposti, che l'Occidente
ha di volta in volta nominato in diversi modi:
universale-particolare, inconscio-coscienza, se-io, eros-tanatos, eros-logos, emisfero destroemisfero sinistro, immagine-parola, simbolo-parola, omologazione-differenziazione, maternopaterno. [...] È vero che di volta in volta la vita si può dare, o meglio, noi la possiamo vedere ed
esperire, ora solo nell'uno, ora solo nell'altro modo, ma questo accade e si dà come momento di un
unico processo che racconta il dialogo amoroso tra i due. Solo questo continuo fluire è vita.24
In questa dimensione di apertura alla totalità dell'essere, il corpo, in quanto mediatore tra interno
ed esterno, rivela la sua capacità di conferire senso alla scena dello spazio-tempo di cui l'individuo è
protagonista e dove persino la morte rappresenta un evento collettivo non disgiunto dalla vita
quotidiana. Sebbene essa modifichi in maniera decisiva la fisionomia dell'intera comunità, il
gruppo cerca di fronteggiarne le conseguenze ricorrendo alla funzione mediatrice offerta dai
paradigmi mitici e rituali,
cosicché l'esperienza di morte, per quanto concerne l'individuo, viene costantemente mediata dai
modelli che il gruppo di cui fa parte gli offre. L'individuo reagisce alla morte difendendosi
magicamente e religiosamente dai possibili attacchi degli stregoni, ovvero realizza la sua esigenza
di superamento della morte in una proiezione d'immortalità e di resurrezione, ma, in ogni caso, il
suo atteggiamento è condizionato dalle soluzioni che il gruppo gli propone e che trova vere e
reali.25
Quando l'Occidente ha smesso di assumere l'integrità corporea come suo concetto fondamentale e
ha iniziato a pensare l'uomo unicamente nei termini della divisione tra la psiche e il soma, la morte
si è trasformata nel definitivo scioglimento dell'anima dal corpo prigione e nella sola vera
possibilità per l'uomo di attingere la perfezione. Limite estremo di una vita sulla quale impera un
sapere medico che tende a superare ogni limite, la morte come fenomeno accidentale e non più
come accadimento naturale della vita umana, ha conosciuto nelle società contemporanee la sua
definitiva rimozione in quanto sovvertitrice di una scena da cui è stata espunta ogni forma visibile
di dolore. Con ciò, si è consegnato
il morente all'estrema solitudine, senza nemmeno più il contatto e l'affetto, in quanto alla morte
pensa sempre di più il competente. [...] Oggi, la scena si è scomposta ed è stata destrutturata. Noi
non ci rappresentiamo più la morte.26
4. La colonia penale come luogo di scissione
L'abbandono del simbolico, relegato all'ambito artistico e religioso a tutto vantaggio della ragione
speculativa, ha di fatto prodotto la disintegrazione dell'unitarietà dell'essere e la sua declinazione
secondo quelle categorie antinomiche che l'orizzonte di concettualizzazione del pensiero dualistico
occidentale ha chiamato nei modi più diversi. In questa cornice, inaugurato da Platone e
radicalizzato da Cartesio, ha avuto inizio il processo di rimozione e demondanizzazione del corpo
umano, che, privato delle sue implicazioni simboliche, è stato ridotto a oggetto di scissione. Ma che
il corpo fosse molto di più di un comune oggetto, era cosa che si offriva e si offre all'evidenza di
ognuno, giacché
il mio corpo si distingue dalla tavola o dalla lampada perché costantemente percepito, mentre da
quelli posso distogliermi. Pertanto, è un oggetto che non mi abbandona. [...] In realtà, questo
essere sempre con me del corpo, è un'indicazione della sua soggettività.27
Il vissuto dell'individuo inserito nel circuito vitale io-altri-mondo delle società arcaiche s'infrange
contro la realtà della colonia penale, che, lungi dall'essere la comunità al cui centro è collocata
l'esperienza soggettiva del corpo, si configura quale luogo dell'impossibilità per il soggetto di esserci, in un'esistenza pienamente libera, laddove libertà coincide con «la condizione della possibilità di
sentirsi situati»28 nello spazio non come cosa tra le cose, nel senso di una relazione puramente
oggettiva, ma come corporeità che esprime il costante bisogno di tendere alle cose e al mondo delle
altre persone. L'orizzonte spaziale in cui agiscono i protagonisti del racconto di Kafka, non è mai il
mondo dell'esperienza possibile di persone e cose, e non può esserlo in forza dell'insanabile
frattura tra il soggetto e la realtà esterna, che, ridotta a soffocante prigione, comporta il venir meno
del processo di formazione reciproca. Perciò l'uomo, «impotente a rettificare il suo destino, è
costretto a non essere».29 In un mondo fondato su strutture categoriali di tipo antinomico quale
appare la kafkiana colonia penale, e in cui si assiste all'interruzione del corso ordinario del punto di
vista logico basato sul principio di non contraddizione e d'identità, anche la coppia colpa-innocenza
assume un nuovo significato, e precisamente quello che «la reciproca appartenenza dell'ordine
della legge e del caos»30 le conferisce. L'intrecciarsi dei piani, che sta alla base del ribaltamento del
normale rapporto tra i termini del binomio, fa sì che il personaggio kafkiano risulti sempre
colpevole, verso se stesso e gli altri,
non di una singola azione, ma di un manco ontologico. È colpevole perché è inadeguato alla legge.
Ma che cosa chiede la legge? Esiste un'individualità in grado di soddisfarne le esigenze? [...] In un
universo separativo, la legge si presenta sia mediante una serie di regole, sia incarnandosi in
individui che la esemplificano, e che rappresentano per il soggetto dei modelli (Ciò che Freud
chiama l'ideale dell'io). In un universo confusivo congiuntivo, la legge non può esprimersi
mediante regole perché l'ordine, includendo il caos, implica un'infinita possibilità di smentire le
regole e di sottrarsi ad esse. Le regole acquistano un'elasticità infinita, parodica, autoparodica, e la
legge viene infinitamente elasticizzata dalle interpretazioni di cui si riempie come una spugna, che
s'imbeve di qualunque liquido.31
Nella società degli ordini e delle coercizioni
il controllo [...] sugli individui non si effettua solo attraverso la coscienza o l'ideologia, ma anche
nel corpo e con il corpo. [...] è [...] importante, prima di tutto, il biologico, il somatico, il
corporale.32
Per questo, il marchio della colpa non può che avere nel corpo Körper il suo naturale spazio di
rappresentazione, ed è proprio per il medium della carne che il colpevole perviene «a decifrare
direttamente lo scritto, dalle cui lettere apprenderà il nome della sua colpa sconosciuta».33 Il
processo di oggettivazione messo a punto dal sistema giuridico della colonia penale, colloca
scrittura e corpo all'interno di spazi autosufficienti e improduttivi, che negano all'una la
progettualità insita in ogni forma di comunicazione, e all'altro la possibilità di assumere tutti i
significati conferitigli dal soggetto stesso e dai soggetti altri con cui viene in relazione. Il
«significare attivo»34 della parola, che apre allo «scambio comunicativo attraverso un linguaggio
che avviene tra diversi soggetti»,35 e la peculiare specificità del corpo umano, che è dato al
soggetto in modo del tutto differente dal modo in cui sono date le altre cose materiali, vengono
forzati entro un contesto refrattario ad ogni dialogo e relazione fra il corpo vivente del soggetto e il
corpo vivente degli altri. Allora, le parole impresse sul corpo del condannato, nella loro esclusiva
funzione di pratica di morte, diventano il sigillo che sancisce la definitiva collocazione del corpo e
del linguaggio in un altrove dove nessuna comunicazione è ormai davvero più possibile.
5. Estraneità contro intersoggettività
Il Leib, quale corpo vivo non può costituirsi senza la relazione con altri soggetti. L'uomo, il Mensch,
rimanda per essenza ad altri uomini a lui correlati e la sua apparizione porta un nuovo strato di
senso nell'oggetto Leib. La soggettività che nel Leib si esprime, non si esaurisce come soggettività
psicofisica, e per il costituirsi di questo ulteriore strato di senso è necessaria l'esperienza di un
soggetto altro, analogo al soggetto percipiente. Nel formarsi dello schema Leib, il corpo del
soggetto e quello dell'altro, risultano originariamente appaiati. Almeno per una costituzione
completa di tutti gli strati di senso che il Leib implica, i due corpi sono quindi legati, connessi,
costituiti in una coppia.36 La mancata costituzione del Leib e il conseguente regredire del corpo
allo status di Körper annullano di fatto qualunque possibilità di relazione interpersonale, sicché «il
corpo [...] si predispone come corpo macchina, tassello di una circolazione tesa a nullificare gli
affetti».37 Difatti il sentimento
non è per niente qualcosa che si svolge soltanto interiormente, ma è quel modo fondamentale di
esistere in forza del quale e in conformità del quale, noi siamo sempre trasportati al di là di noi
stessi nell'ente nel suo insieme che, in un modo o nell'altro, ci riguarda o non ci riguarda.
Disposizione emotiva non è mai un essere emotivamente disposto meramente interiore, chiuso in
sé, ma è anzitutto un certo lasciarsi predisporre e porre in una disposizione emotiva. La
disposizione emotiva è appunto il modo fondamentale in cui noi siamo al di fuori di noi stessi.38
Dall'impossibilità di realizzare questo movimento di uscita dai confini corporei, non funzionale ai
meccanismi di autoconservazione del sistema di potere della colonia penale, deriva l'atomizzazione
dell'esperienza esistenziale e l'inevitabile collocazione dei personaggi all'interno di un ordine
fondato su un pensiero oggettivante, nonché su un processo di totale distacco emotivo dall'altro da
sé, che viene reificato e destinato all'annientamento. Per l'ufficiale e per l'esploratore, che pure
sembra mostrare fin da subito qualche dubbio rispetto alle modalità dell'esecuzione, il condannato
è solo un corpo depersonalizzato, assurto per il carnefice ad archetipo della colpa, e per il visitatore
a rappresentazione di un barbaro spettacolo. I due personaggi, chiusi nel loro solipsismo, non
riescono a costituirsi come soggetti in grado di farsi carico l'uno dei vissuti dell'altro e entrambi dei
vissuti del condannato, e a realizzare quel dialogo fecondo e aperto al comprendere che trasforma il
semplice incontro nella «relazione intersoggettiva propriamente detta»,39 ovvero nella relazione
implicante la scoperta dell'altro come essere nel mondo, in un interscambio continuo e costitutivo
della propria identità.
Nessun vero dialogo è possibile senza assumere quel rapporto dagli interminati e dai molteplici
rimandi dell'alter nascosto nell'alienus e di se stessi nell'altro, -non nell'eterna lotta di sé con
l'altro, ma nell'ascolto infinito dell'altro in sé, nell'incessante moltiplicarsi di voci e ridefinirsi di
volti, identità plurali in se stesse, perché in se stesse diverse, mai definibili in sé benché
inesorabilmente singolari e uniche, da cui ciascuno di noi è continuamente attraversato. Né
relativismi dissolventi, né confini inviolabili. In questo implacabile attraversamento, che è insieme
sempre ininterrotta apertura, il senso è dato proprio dall'incontro della vita e della morte, del lutto
e dell'ospitalità dell'altro in me e fuori di me, che non finiscono mai e che non smettono mai di
finirci e di sfinirci, di de-finirci.40
L'oggettivazione dell'altro, che all'io totalizzante appare solo nella sua identità di Körper, segna il
progressivo scivolamento dell'ufficiale e dell'esploratore in un luogo altro, con ciò precludendo loro
l'accesso al mondo dell'intersoggettività, e cioè al «mondo che c'è per tutti e icui oggetti sono
disponibili a tutti»41 sebbene ognuno abbia «le sue esperienze, le sue manifestazioni ed unità di
manifestazione, il suo fenomeno mondano».42 La colonia penale, in cui l'atroce agonia inflitta con
l'erpice rappresenta l'unico modo d'intrecciare la propria vita con quella degli altri, si configura
come un mondo strutturato all'insegna dell'estraneità, ossia all'insegna dell'irrimediabile frattura
della dialettica io/tu, che al contrario implica sempre una visione relazionata dell'altro. Nella
dimensione dell'estraneità, il restringimento dello spazio relazionale alla sola sfera dell'io riduce a
soma il secondo termine della coppia e fa in modo che il tu, espulso dalla relazione, sia avvertito
come minaccia per la propria sopravvivenza. Non a caso, quando l'ufficiale si rende conto che il
viaggiatore spezzerà il suo unico legame con il mondo adoperandosi per l'abolizione della macchina
della morte, capisce che da quel momento in poi la sua vita non avrà più senso e, liberato il soldato,
si sottopone volontariamente all'azione dell'erpice. Egli compie così l'ultimo atto di quel processo
di reificazione di sé, originatosi dalla mai avvenuta identificazione, «nella forma dell'essere, tra il
corpo e il soggetto».43 Per chi come lui concepisce l'uomo unicamente nella forma dell'avere, e il
linguaggio in quella della parola che non dice, ma che prescrive e interdice soltanto, è assurdo
pensare di poter vivere senza ciò da cui parte e converge il suo sguardo sul mondo. Per tutta la vita,
non aveva fatto altro che «venire ad esistenza come soggetto, attraverso quelle strutture
comportamentali»,44 che proprio nella loro eterna ripetitività, lo avevano fatto essere in qualche
modo. La grottesca autodistruzione della macchina, incarnazione di un'auctoritas che ha perso
ormai ogni sua giustificazione, segna il definitivo venir meno «dell'interlocuzione simbolica», 45
ovvero di quell'ente sovraindividuale a cui l'ufficiale sapeva di dovere obbedienza. Il suo corpo
senza vita, su cui aveva voluto incidere il comandamento «Sii Giusto», non mostra alcuna traccia di
quella avvenuta redenzione che pure gli altri sembravano aver trovato nella macchina. Dai suoi
occhi, in apparenza ancora vivi sotto la fronte spaccata dal grande puntale dell'erpice, traspare lo
stesso impassibile distacco di sempre. nessuna salvifica rivelazione accompagna il momento finale
della dissoluzione, perché non è dato all'uomo conoscere nulla di più della sua terribile condizione
di estraneità verso il proprio corpo e il mondo. Il lettore di questo racconto non sperimenta alcun
senso di catarsi, giacché nell'opera di Kafka la morte non ha mai una funzione liberatoria, ma si
presenta piuttosto, come tutte le azioni umane, nella sua intrinseca paradossalità. Gli atti violenti
come il suicidio dell'ufficiale o la morte insensata di Josef K, assassinato come un cane, ritrovano
una qualche interpretabilità solo all'interno della forma narrativa, in virtù di quell'elemento della
riflessione ad essa immanente. In questo senso, la morte dell'ufficiale e di K. servono a ricordarci la
condanna senza appello che incombe su ognuno di noi.
Note
1.
Gilles Deleuze, Critica e clinica, Raffaello Cortina, Milano 1996, p. 13.
2.
Roland Barthes, Variazioni sulla scrittura seguite dal piacere del testo, Einaudi, Torino 1999, p. 13.
3.
Roland Barthes, Variazioni sulla scrittura, cit. in nt. 2, p. 42.
4.
Roland Barthes, Variazioni sulla scrittura, cit. in nt. 2, p. 42.
5.
Franz Kafka, Nella colonia penale, in Tutti i racconti, vol. II, Mondadori, Milano 1970.
6.
Franz Kafka, Nella colonia penale, cit. in nt. 5, p. 26.
7.
Franz Kafka, Nella colonia penale, cit. in nt. 5, p. 36.
8.
Franz Kafka, Nella colonia penale, cit. in nt. 5, p. 38.
9.
Michel Foucault, Sorvegliare e punire, Einaudi, Torino 1976, p. 37.
10. Roland Barthes, Variazioni sulla scrittura, cit. in nt. 2, p. 3.
11. Umberto Galimberti, Il corpo, Feltrinelli, Milano 1983, p. 67.
12. Martin Heidegger, Seminari di Zollikon, Protocolli seminariali, Colloqui-Lettere, Guida, Napoli 1991, p. 154.
13. Martin Heidegger, Seminari di Zollikon, cit. in nt. 12, p. 154.
14. Martin Heidegger, Lettera sull'Umanismo, Sei, Torino 1975, p. 90.
15. Umberto Galimberti, Il corpo, cit. in nt. 11, p. 185.
16. Gabriel Marcel, Manifesti metodologici di una filosofia concreta, Minerva italica, Bergamo 1972, p. 73.
17. Edmund Husserl, Logica formale e logica trascendentale, Laterza, Bari, 1966, p. 292.
18. Maurice Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, Milano, Il Saggiatore, 1980, pp. 334, 335.
19. Umberto Galimberti, Il corpo, cit. in nt. 11, pp. 18, 19.
20. Eric Voegelin, La politica. Dai simboli alle esperienze, Giuffré, Milano 1993, p. 13.
21. Ada Cortese, Microanalisi dei nostri rituali quotidiani, «Conferenze», n. 1, 1999, in http://www.geagea.com.
22. Un esempio è fornito dagli Aborigeni australiani che incidono la parte inferiore del pene e allungano le labbra
vaginali, edalle popolazioni del Borneo, Okkaido, Samoa, Amazzonia, che praticano la perforazione dei genitali
(cfr. «L'ornamento e la modificazione del corpo nel corso del tempo», in http://docenti.lett.unisi.it).
23. José Gil, Voce «Corpo», in Enciclopedia Einaudi, Torino, 1978, p. 1119.
24. Alberto Toniutti, La dimensione simbolica, in Individuazione, trimestrale di psicologia analitica e filosofia
sperimentale, n. VIII, anno 29, settembre 1999, p. 11.
25. Marco Pucciarini, Dallo scacco del pensiero filosofico alla risposta della religione, 1 gennaio 2000, in
http://www.centrostudilaruna.it.
26. Ada Cortese, Sorella morte, ancora..., in Individuazione, anno XV, maggio 2006, n. 56, p. 7.
27. Maurice Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, cit. in nt. 18, p. 544.
28. Ludvig Binswanger, Il delirio, antropoanalisi e fenomenologia, 1990, p. 12.
29. Marino Freschi, Introduzione a Kafka, Bari, Laterza, 1993, p. 109.
30. Giovanni Bottiroli, L'identità modale dei personaggi di Kafka, in Cultura tedesca, n. 35, luglio/dicembre 2008.
31. Giovanni Bottiroli, L'identità, cit. in nt. 30.
32. Michel Foucault, La nascita della medicina sociale, in Archivio Foucault, vol. II, Feltrinelli, Milano 1997, p.
222.
33. Walter Benjamin, Angelus Novus, Saggi e frammenti, Einaudi, Torino 1995, p. 298.
34. Arcangelo Licinio, Filippo Silvestri, Alessandro Toriello, Corpo, Linguaggio, Intersoggettività. Studi
husserliani, Albalibri, Milano 2007, p. 107.
35. Corpo, Linguaggio, Intersoggettività, cit. in nt. 34, p. 202.
36. Laura Scarpat, Un'espressione sbagliata e un penoso enigma, in Leitmotiv, 3/2003,
http://www.ledonline.it/leitmotiv.
37. Tiziana Villani, Una scrittura di carne e sangue, in Mille piani, 1997, n. 11, p. 69.
38. Martin Heidegger, La volontà di potenza come arte, in Nietzsche, Adelphi, Milano 1994, pp. 107, 108.
39. Corpo, Linguaggio, Intersoggettività, cit. in nt. 34, p. 202.
40. Bruno Callieri, Mauro Maldonato, Fenomenologia dell'incontro, in Ciò che non so dire a parole, Guida, Napoli,
1998, p. 33.
41. Edmund Husserl, Meditazioni cartesiane, Bompiani, Milano 1960, p. 101.
42. Edmund Husserl, Meditazioni cartesiane, cit. in nt. 41, p. 102.
43. Maurice Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, cit. in nt. 18, p. 540.
44. Ada Cortese, Microanalisi dei nostri riti quotidiani, cit. in nt. 21.
45. Ada Cortese, Microanalisi, cit. in nt. 21.
Marco Lo Giudice
L'éveil nelle letture talmudiche di
Levinas
1. Levinas pensatore coerente e unitario
Se si può intendere la meditazione di Levinas, complessivamente, nei termini di una risposta
concretamente e teoreticamente praticabile alla domanda di senso, un ruolo decisivo spetta
certamente alla figura del risveglio (éveil). La costellazione metaforica nella quale il risveglio si
trova -- veglia, insonnia, sonno -- è infatti presente in tutti gli snodi principali della riflessione
levinassiana, dalla ricerca giovanile di «una nuova via per uscire dall'essere»1 alla formulazione
matura dello scompiglio etico (dérangement) provocato nell'io dall'altro uomo. Fin dagli anni '30,
Levinas è alle prese con una forte dicotomia -- a tratti ossessiva -- tra un soggetto incagliato nelle
pieghe dell'essere e assopito nella sua essenza, e un soggetto liberato da questo incatenamento
proprio nell'obbligo di accoglienza e responsabilità nei confronti del prossimo: il risveglio non è
soltanto figurazione di questa «evasione», ma è anche la categoria descrittiva della dimensione
della soggettività individuata proprio nell'uno-per-l'altro e la definizione stessa della filosofia, come
etica del risveglio alla convocazione dell'altro uomo.
Questa particolare figura sembra inoltre potersi rintracciare, e in qualche modo «giustificare»,
nelle letture talmudiche che Levinas tiene, a partire dagli anni '60, ai Colloqui tra gli intellettuali
ebrei di lingua francese. In ragione di una crescente importanza di queste letture all'interno della
critica levinassiana -- importanza giustificata peraltro da una consapevolezza più matura
dell'imprescindibilità dell'ebraismo nella comprensione del pensiero di Levinas -- le pagine
seguenti cercheranno precisamente di approfondire il rapporto tra il risveglio levinassiano e i testi
del Talmud.
Prima di procedere nell'analisi, però, è opportuno esplicitare i termini in cui si presenta l'ebraismo
di Levinas, al centro ancora oggi -- anche se appunto in misura sempre minore -- di una forte
incertezza critica: da un lato, pare che il pensiero del filosofo di Kaunas sia ugualmente
comprensibile anche senza l'analisi dei suoi testi «confessionali»;2 dall'altro, si ha la sensazione
che, a causa di una certa estraneità alla tradizione filosofica «greca», il contesto culturale ebraico
non dia i punti di riferimento necessari per uno studio completo sull'opera levinassiana, e si
preferisca così attribuirgli un ruolo non decisivo.
a. In primo luogo, è importante ricordare che Levinas era ebreo fino in fondo, nella
quotidianità, in famiglia e nel suo lavoro: «per fedeltà e disciplina, per attaccamento al
rituale, anche per l'ambiente, nella vita quotidiana, Emmanuel Levinas fu senza dubbio un
ebreo praticante».3 Un dato biografico che porta a considerare Levinas prima di tutto come
un «credente». Salomon Malka, in quella che rimane la biografia più appassionata del
pensatore lituano, riporta una testimonianza del nipote David Hansel (figlio di Simone
Levinas) che insiste sulla distinzione tra praticante e religioso:
È forse il primo insegnamento che ci ha trasmesso mio nonno. Non c'erano per lui delle
dicotomie religioso/non religioso, credente/non credente. Queste categorie non sono quelle
in cui si vive il giudaismo. [...] Io non dico che l'idea di Dio sia qualcosa di estraneo. Ma la
credenza non è una nozione prima. [...] È la responsabilità per altri, il dovere, l'obbligo, il
comandamento. Sono temi che sono stati sviluppati molto da mio nonno e che ci hanno
segnato molto.4
Per quanto possa apparire banale, non va dimenticato che è anzitutto nella sua esistenza
che Levinas mette in pratica l'insegnamento della Torah. Gli sviluppi del suo pensiero
all'interno del rapporto tra giudaismo e filosofia avvengono soltanto conseguentemente alla
sua origine e pratica ebraiche.
b. Accanto a questo ebraismo «quotidiano», si trova in secondo luogo l'approfondimento del
Talmud stimolato dagli incontri con Mordechaï Chouchani. Il mistero che avvolge il
bizzarro maestro talmudista5 -- capace di ridare a Levinas la «fiducia nei libri»6 -- non
oscura affatto l'amplissimo raggio delle sue conoscenze e l'arguta raffinatezza della sua
interpretazione del Talmud, testimoniate quasi all'unisono da chi ha avuto l'onore di
ascoltarlo.7 Sebbene l'accostamento di Levinas ai testi talmudici, materia molto
complessa,8 avvenga dunque «tardi e in margine a studi puramente filosofici»,9 l'intenso
periodo che coincide con l'insegnamento di Chouchani (collocabile all'incirca tra il 1947 e il
1952) porterà in realtà frutti molto importanti: è dunque possibile rilevare anche come la
maturazione filosofica presente prima in Totalité et Infini e poi in Autrement qu'être, trovi
abbondante linfa nei colloqui con il maestro.10
L'approccio al Talmud che Levinas apprende da Chouchani è indicato da Shmuel Wygoda
come sviluppantesi in tre tappe.11 a) I testi vanno studiati nella loro integrità, inscrivendoli
nel loro contesto immediato: la Mishnah, il capitolo, il Trattato. Ciò significa saper trovare
unitarietà ai commenti della Gemara, che spesso, pur commentando la medesima Mishnah,
sembrano molto lontani gli uni dagli altri. b) È necessario uno studio scrupoloso dei
richiami biblici o di altri Trattati talmudici, che non abbia alcuna esitazione a rivestire di un
significato più esteso il contesto della parola o del versetto in questione. c) Bisogna saper
leggere il testo all'interno di un orizzonte ermeneutico molto allargato: il testo si presta a
interpretazioni supplementari, non ci si ferma mai alla prima lettura. È probabilmente a
questo livello che va collocato il concetto di sollecitazione:
La sollecitazione è, da una parte, una sorta di auscultazione semiotica che si appoggia alla
lettera del testo finché questa cede e rivela il suo significato (o i suoi significati). Dall'altra
parte, è il 'tentativo di animare il testo per mezzo di corrispondenze e di echi', di misurarlo
interminabilmente [...]. La sollecitazione è il compimento di un senso rimasto in sospeso.
Letteralmente e lateralmente. Questo doppio movimento è costitutivo del metodo
midrashico: si fa appello all'insieme per comprendere un versetto (lateralità); ma non si
esita neppure ad isolare una parola o una sequenza, per auscultarle in isolamento
(letteralità).12
Tale azione interpretativa, in una corrispondenza insospettabile con gran parte degli
approcci ermeneutici moderni,13 è molto meno astratta di quanto possa sembrare e, in
questo senso, trova la giusta concrezione in alcune metafore. Ad esempio, quella della
«brace ardente» che troviamo in una nota a piè di pagina che Levinas riprende da Rabbi
Hayyim di Volozhin14: in tal caso la sollecitazione è paragonata al soffio continuo sulla
brace ardente per ravvivare il fuoco (e cioè il significato) che cova al di sotto di essa. Ma
anche verbi quali «strofinare», «sfregare», «triturare», sono significativi del gesto costante
e produttivo, operatore di senso,15 della sollecitazione. È in questo senso che la
sollecitazione può definire il midrash16: «parola che significa "ricerca", ma anche
"esigenza", e "interrogazione", e quasi "interrogatorio", e comunque "sollecitazione"».17 Nel
midrash, però, il concetto operativo di «sollecitazione» vira immediatamente
non in concetto -- che sarebbe pura astrazione -- ma in esigenza di sollecitudine, in
preoccupazione per l'uomo. Dell'altro uomo: prossimo o lontano. [...] La sollecitazione
squarcia dunque la trama del testo e vira, attraverso lo strappo che ha aperto, in
sollecitudine. La sollecitazione sviluppa modi di leggere che la inducono a oltrepassare se
stessa, a mutarsi in sollecitudine. [...] Questo doppio movimento centripeto -- sollecitazione
-- e centrifugo -- sollecitudine -- è caratteristico della lettura midrashica. È in questa sorta
di mutazione che si genera il soggetto etico, la cui essenza consiste in un 'essere'verso e per
l'altro".18
Con le parole di David Banon -- che nelle stesse pagine giungerà a definire il midrash come
procedimento eseg-etico -- è ormai chiaro che la Bibbia non può essere considerata un
oggetto di conoscenza lasciato alla comprensione del soggetto lettore, bensì un'infinita
riserva di significati che devono trovare concretezza nella vita individuale e sociale. Il
commento, nella sua ripresa incessante, nel suo approccio paziente e nella sua lettura
infinita, «conserva al testo la sua dimensione di dismisura e mantiene l'opera nella sua
apertura».19
Il midrash diventa allora un punto di riferimento irrinunciabile per tutta la riflessione
successiva di Levinas, e lo si può collocare senza dubbio al fianco del metodo
fenomenologico, da lui mai realmente abbandonato -- almeno a parole -- nel corso degli
anni. È certamente anche nel superamento dell'aspetto puramente metodologico operato
dall'irruzione dell'ordine morale -- «come se commentare non fosse altro che
comandare»20 -, che Levinas trova la «nuova via» per la quale «uscire dall'essere».
Chouchani diviene allora davvero una tappa fondamentale della formazione di Levinas, al
pari di Husserl e Heidegger.21
c. Non c'è alcun dubbio che gli scritti «confessionali» siano di un ordine diverso da quelli
«filosofici», ed è lo stesso Levinas ad affermarlo: «io separo molto chiaramente questi due
tipi di opere. Ho anche due case editrici; una pubblica i miei testi confessionali, l'altra i miei
testi che sono considerati puramente filosofici. Tengo i due ordini separati».22 Ma bisogna
comunque tenere presente che i testi dedicati all'ebraismo «insegnano la stessa etica -- la
stessa moralità del faccia-a-faccia, lo stesso appello alla giustizia come una chiamata divina
-- che si trova nei suoi scritti non-confessionali o cosiddetti 'filosofici'. Non c'è alcuna
spaccatura in Levinas tra filosofia e religione",23 esse corrispondono infatti a due
movimenti "distinti, ma solidali, del processo spirituale unico che è l'approccio alla
trascendenza».24 Una trascendenza etica. La questione è decisiva: la separazione dei due
ambiti certamente non esclude -- anzi: stimola -- un continuo e fertile dialogo tra il versetto
e la parola filosofica, sotto il segno del medesimo invito alla responsabilità per l'altro. È ciò
che accade, ad esempio, con il comandamento «non uccidere»: in Levinas esso non equivale
alla semplice proibizione dell'assassinio; questo comandamento, scrive il filosofo lituano,
diventa una fondamentale definizione o descrizione dell'evento umano dell'essere, una
prudenza permanente nei confronti delle azioni violente e omicide verso l'altro che sono
probabilmente l'affermazione più completa di un essere, come se l'imposizione della
propria esistenza fosse già mettere a repentaglio la vita di qualcun altro.25
Alla stessa maniera, anche il versetto «io sono straniero sulla terra / non nascondermi i tuoi
comandi»,26 è «filosofico fin dall'inizio. Non soltanto l'ammissione di un popolo senza
terra, ma il significato di quella presenza sulla terra, di un esilio [...] che è la definizione
della pura soggettività trascendentale e la necessità primordiale di una legge morale in
quell'esilio».27
In quest'ottica, non vi è soltanto un illuminarsi vicendevole dei due ordini di sapere, ma
anche una vera e propria ricerca linguistica che permette a Levinas di rovesciare le
tradizionali categorie filosofiche. È il caso, ad esempio, della nozione di «elezione»:
L'elezione, scrive Levinas, si sostituisce in me alla nozione di individuazione. Io dico
[infatti] che nella responsabilità inalienabile vi è una individuazione dell'io ad opera
dell'elezione. [...] Molte nozioni suggerite dalla Bibbia consentono di liberare
un'intelligibilità 'più forte'di quella determinata dalle contraddizioni della logica formale.
28
In altre parole: è la Parola che consente a Levinas di andare al di là del linguaggio
filosofico,29 e di dare piena espressione al superamento della filosofia dell'essere
nell'appello alla responsabilità per altri.
Se da un lato, insomma, la filosofia sembra essere «frutto più naturale»30 della
meditazione ebraica di Levinas, dall'altro lato è precisamente il suo sforzo filosofico di
«evasione dall'essere» che lo porta ad interrogare le sue radici ebraiche e la saggezza
talmudica. È in questa direzione che egli allora può scrivere che «la filosofia deriva [...] dalla
religione. La filosofia è suscitata dalla religione alla deriva, e probabilmente la religione è
perpetuamente alla deriva».31
d. L'ebraismo di Levinas è infine segnato, indelebilmente, dal dramma della Shoah. Oltre a
colpire direttamente anche la sua famiglia,32 lo sterminio dei 6 milioni di ebrei da parte dei
nazisti, è lo sfondo ineliminabile della sua riflessione, che si può così intendere come una
proposta concreta per un'umanità dopo Auschwitz. Malka è convinto che proprio l'assenza
di Dio ad Auschwitz ordini al popolo ebraico di continuare ad essere là, «di assumere una
fedeltà etica contro Dio stesso».33 È qui che, secondo lui,
si tocca con mano ciò che costituisce la visione 'laica'dell'ebraismo in Levinas. Fedeltà senza
fede. Dio senza divinità. Messianismo senza messia. Religione senza oracolo. [...] Il culto
consacrato all'altro all'uomo -- che egli chiama 'religione'- non avviene nello slancio,
nell'ebbrezza o nella dolcezza. Esso è quando tutti i cammini si sono esauriti e non si cerca
più alcuna consolazione. È la fragile dimora della coscienza. È estrema coscienza.34
Per capire quanto effettivamente pesi la Shoahin questo ebraismo «», Malka riporta alcune
parole dalle «gelide pagine»del saggio Sans nom, che chiude la raccolta di saggi Noms
Propres:
Più di un quarto di secolo fa, la nostra vita s'interruppe e indubbiamente persino la storia.
[...] Quando si ha questo tumore nella memoria, venti anni non possono cambiarvi nulla.
[...] Ma anche se durante questa dilazione gratuita, le occupazioni o le distrazioni della vita
riempiono di nuovo la vita, anche se tutti i valori disprezzati -- o antidiluviani -- rientrano
in vigore, [...] nulla ha potuto colmare, neppure ricoprire l'abisso spalancato. Vi si ritorna
soltanto un po'meno di frequente dagli angoli riposti della nostra dispersione quotidiana e
la vertigine che afferra sull'orlo dell'abisso è sempre la stessa.35
Con queste necessarie premesse, si è voluto dar ragione di un contesto complesso e problematico:
rintracciare nei testi «confessionali» la figura del risveglio, aldilà della ricerca filologica, equivale a
voler dimostra come, rispetto agli anni precedenti all'incontro con Chouchani -- significativo della
maturazione dell'ebraismo di Levinas -, la costellazione metaforica del risveglio viri decisamente
verso una connotazione etica, che proprio nella disubriacatura dalla perseveranza nell'essere,
nell'appello alla responsabilità per l'altro, nell'irruzione dell'altro nel soggetto, individua il
risveglio. Il passaggio per questi testi a sfondo giudaico, allora, metterà in luce una sorta di doppio
movimento: da un lato la lettura di Levinas irrora i commenti talmudici delle figure filosofiche a lui
care, dall'altro sono gli stessi testi ebraici a chiarificare le categorie, il messaggio e il lessico nei
quali si esprime il pensiero levinassiano.
Si tratta, allora, di mettere in pratica l'insegnamento levinassiano (e prima di Chouchani) che invita
alla sollecitazione del testo e all'allargamento dei suoi orizzonti, e di applicarlo alle sue letture del
Talmud tenute (nella quasi totalità) ai Colloqui tra intellettuali ebrei che la sezione francese del
Congresso mondiale ebraico ha organizzato nel corso degli anni. Ciò che ne risulterà sarà dunque
un viaggio inedito nei testi talmudici commentati da Levinas: un collage solo apparentemente
frammentario,36 poiché in realtà tenuto insieme con grande forza filosofica dall'originale proposta
levinassiana di un'etica del risveglio all'altro come dimensione costitutiva del soggetto.
2. Torah come risveglio
Nella giustizia biblica, quando un assassinio è commesso sotto forma di omicidio involontario, non
potendo essere perseguito in tribunale, vengono istituite delle «città-rifugio», che fanno da
rifugio/esilio all'assassino involontario, braccato dalla comprensibile vendetta dei parenti stretti
della vittima. Questi luoghi sono, allo stesso tempo, protezione d'innocente e punizione
dell'oggettivamente colpevole: protezione perché sono rifugio dell'omicida involontario a rischio di
vendetta, punizione perché fanno da esilio a colui che comunque si porta addosso la colpa
dell'assassinio. Nel commentare una pagina del Trattato Makkoth, che tratta appunto delle cittàrifugio, Levinas compie un gesto tipico del metodo sopra descritto e riporta l'attenzione sulla nostra
condizione attuale:
Le città nelle quali soggiorniamo e la protezione che, legittimamente, in forza della nostra
innocenza soggettiva, troviamo nella nostra società liberale [...] contro tante minacce di vendetta
senza fede né legge, contro tante forze riscaldate, non è, in effetti, la protezione di una semiinnocenza o di una semi-colpevolezza, che è innocenza ma anche colpevolezza, -- tutto questo non
trasforma le nostre città, in città rifugio o città per esiliati? [...] Ci si può chiedere se la spiritualità
che si esprime nella nostra maniera di vivere, nelle nostre rette intenzioni, nelle nostre buone
volontà, nella nostra attenzione al reale, sia sempre sveglia.37
Alla base di questa riflessione, sembra stare il medesimo concetto di coscienza non ancora
abbastanza cosciente che si ritrova in alcune pagine di De l'existence à l'existant,38 «quel "sonno"
che nella metaforica di Levinas equivale all'ovvietà del giorno, alla normalità del nostro quotidiano
essere svegli».39 Che cosa allora ci risveglia veramente? Levinas mutua la risposta dalla comparsa,
nelle opinioni rabbiniche del Trattato, della Torah: essa non è solo protezione contro il
vendicatore, allo stesso modo delle città-rifugio, ma appunto si situa già aldilà del delitto, aldilà
della violenza. La Torah -- meglio: lo studio e la pratica della Torah, assolutamente inseparabili -corrisponde al «risveglio completo dell'anima»40: nella conoscenza e nella prassi della Torah si
trova il «livello più alto della vita [...], come se l'umano vi si elevasse consegnando una nuova
condizione, un nuovo modo della spiritualità dello spirito».41 Bisogna guadagnare quest'ottica per
comprendere Levinas quando riporta una celebre frase del protagonista di un racconto di Zvi
Kolitz, Yossel ben Yossel.42 Questa frase «è il punto culminante dell'intero monologo e [...] fa eco a
tutto il Talmud: "lo amo, ma amo ancora di più la sua Torah [...] e se anche fossi deluso da lui e
come disincantato, non smetterei comunque di osservare i precetti della Torah"».43 Amare la
Torah più di Dio significa allora che la concretezza di Dio non sta nell'incarnazione, ma
precisamente nella Legge, e nell'uomo capace di studiarla, interpretarla, reinterpretarla e obbedire
ai suoi mitsvot, alle sue prescrizioni. In questo senso, allora,
essa esige, contro la naturale perseveranza di ogni essere nel proprio essere -- legge ontologica
fondamentale -, la cura dello straniero, della vedova e dell'orfano, la preoccupazione per l'altro
uomo. Capovolgimento dell'ordine delle cose! Non ci si stupisce mai abbastanza di tale
capovolgimento dell'ontologia nell'etica.44
È il medesimo concetto espresso in un altro luogo della produzione levinassiana, appartenente agli
scritti cosiddetti «filosofici»:
La relazione con altri non è [...] ontologia. Questo legame con altri che non si riduce alla
rappresentazione d'altri, ma alla sua invocazione e, dove l'invocazione non è preceduta da una
comprensione, la chiamiamo religione. Ciò che distingue il pensiero che intenziona un oggetto da
un legame con una persona è il fatto che in quest'ultima si articola un vocativo: ciò che è nominato
è, nello stesso tempo, ciò che è interpellato.45
Il risveglio della Torah equivale allora ad una costrizione, ad un peso? Ciò che San Paolo, nella
lettera ai Galati (3, 13-15), definisce come «il giogo della Legge», è smentito a più riprese dalle
parole di Levinas. In questo senso, in un'altra lezione talmudica, Levinas potrà definire la mitsva -il comandamento, la prescrizione -- come un «contorno di rose». Ciò che si ama non sarà mai causa
di sopportazione: «Quel che ci trattiene non è per nulla il giogo insopportabile della Legge, che
faceva paura a San Paolo, è un contorno di rose. L'obbligo di osservare i comandamenti -- le
mitsvot -- non ci pesa affatto come una maledizione, ci porta i primi profumi del paradiso».46
3. Rivelazione come Risveglio
La Torah è la Parola rivelata. E la Rivelazione è l'amore di Dio che comanda all'uomo l'amore per
l'altro uomo. È soltanto attraverso la Rivelazione della Torah, nell'elezione dell'uomo alla
responsabilità per il prossimo, che si può uscire -- evadere -- dalla perseveranza dell'essere in se
stesso. La rivelazione di Dio è rivelazione del prossimo. Quest'articolazione originale di
trascendenza, separazione ed etica è difficilmente comprensibile per la tradizione occidentale,
perché
denuncia la figura del Medesimo e del conoscere nella loro pretesa d'essere il solo luogo della
significazione. Questa figura del Medesimo, questo conoscere, rappresentano solo un certo livello
dell'intelligenza, quello nel quale essa si assopisce [...] e nel quale la ragione, sempre ricondotta alla
ricerca del riposo, della quiete, della conciliazione, che implicano l'attribuzione al Medesimo del
carattere di realtà ultima e prima, si assenta già dalla ragione vivente.47
Ma allora la Rivelazione può davvero essere pensata come il risveglio del Medesimo?
In una lezione talmudica degli anni '60, sul tema della «tentazione», Levinas commenta una pagina
del Trattato Shabbath nella quale si tratta dell'accettazione della Torah da parte del popolo ebraico.
Centrale è, secondo i maestri del Talmud, la necessità della priorità dell'obbedienza sull'ascolto,
espressa da Es 24, 7: naasse ve-nishma, «noi faremo e ascolteremo». È solo attraverso questo
rovesciamento paradossale e all'apparenza illogico che, secondo Levinas, può avvenire la rottura
della totalità, la Rivelazione come risveglio. Non c'è nessuna regressione infantile, anzi: lo sforzo è
prettamente adulto. Per il Talmud, questo versetto svela il segreto dell'agire degli angeli: «disse
Rabbi Eliezer: quando gl'Israeliti s'impegnarono a "fare" prima d'"udire" -- esclamò una voce dal
cielo: chi ha rivelato ai miei figli il segreto di che si servono gli angeli, perché sta scritto (Sal 103,
20): "benedite l'Eterno, voi, suoi angeli, eroi possenti, che eseguite i suoi ordini, attenti al suono
della sua parola"» (Shabboth 88a-88b). E Levinas aggiunge:
Eseguono prima di aver udito! Segreto d'angeli, non coscienza infantile. Israele sarebbe stato un
secondo Prometeo [...]. 'Faremo e udremo', ciò che sembrava contrario all'ordine logico, è l'ordine
proprio dell'esistenza angelica.48
Nel cuore di Autrement qu'être, Levinas scrive:
Obbedienza precedente l'ascolto dell'ordine, l'anacronismo dell'ispirazione o del profetismo è,
secondo il tempo recuperabile della reminiscenza, più paradossale della predizione dell'avvenire
attraverso un oracolo. "Prima che mi chiamino, io risponderò" [Is 65, 24] -- formula da intendere
alla lettera. [...] Ma questa singolare obbedienza all'ordine di arrendersi, senza comprensione
dell'ordine, questa obbedienza anteriore alla rappresentazione, questa fedeltà prima di ogni
giuramento, questa responsabilità preliminare all'impegno, è precisamente l'altro-nel-medesimo,
ispirazione e profetismo, l'accadere dell'Infinito.49
Questa prossimità dei due luoghi levinassiani testimonia perfettamente del dialogo continuo, nella
sua produzione, tra testi «» e scritti «».
Naasse ve-nishma è insomma «una formula da intendere alla lettera» proprio perché invita a
rispondere all'appello del prossimo prima di ogni chiamata, elezione prima di ogni comprensione.
Infatti, «il fare che ricorre nella formula commentata non [è] semplicemente la prassi opposta alla
teoria, ma una maniera di attualizzare senza incominciare dal possibile, di conoscere senza
esaminare»,50 di situarsi al di fuori della razionalità del Medesimo, di cominciare prima. Questa
formula, dunque, sembra fare qualcosa di più che preservare dalla tentazione: l'integrità
(temimùth) che si fa strada attraverso di essa equivale ad una nuova e più profonda struttura della
soggettività. Una soggettività proiettata nell'etica, se davvero in questo «fare» prima di «udire»,
che corrisponde all'accoglimento della Rivelazione, c'è già relazione con l'altro.
La Torah è data nella luce d'un volto. L'epifania dell'altro è ipso facto la mia responsabilità nei
confronti dell'altro: la visione dell'altro è fin d'ora un'obbligazione nei suoi confronti. L'ottica
diretta -- senza la mediazione di un'idea -- si può attuare soltanto come etica. La conoscenza
integrale o Rivelazione (accoglimento della Torah) è comportamento etico.51
La soggettività pensata da Levinas è descritta in un appassionato paragrafo di un'altra lezione
talmudica dedicata al tema della femminilità. Ancora una volta, il punto di partenza è la
Rivelazione, la chiamata dell'amore di Dio:
Essere sotto lo sguardo insonne di Dio è precisamente essere, nella propria unità, portatore di un
altro soggetto -- portatore e sostegno -- essere responsabile di questo altro, come se il volto,
tuttavia invisibile, dell'altro, ampliasse il mio volto e mi tenesse sveglio con la sua stessa
invisibilità, con l'imprevedibile di cui mi minaccia. Unità del soggetto uno e insostituibile,
nell'assegnazione irrecusabile della responsabilità per questo altro, più vicino di ogni prossimità, e,
ciò nonostante, sconosciuto.52
Un Dio insonne che esige un'umanità tenuta sveglia dall'appello del volto dell'altro uomo. Nella
stessa ottica, Levinas può dunque interpretare l'«ispirazione» come modalità della Rivelazione:
l'uomo capace di sentirsi insostituibile nella responsabilità per il prossimo, in risposta all'amore di
Dio (di cui il volto dell'altro è la traccia),53 è uomo capace di ispirazione, capace cioè di intendere,
nell'ascolto, un senso altro al di là di ciò che è inteso; è un uomo dalla coscienza estrema, dalla
coscienza risvegliata.54 A confermare nuovamente l'unità del pensiero levinassiano, tornano alla
memoria alcune tra le pagine più intense di Autrement qu'être, in cui l'ispirazione è definita come
la
denucleazione del nucleo sostanziale dell'Io che si forma nel Medesimo, fissione del nucleo
'misterioso'dell''interiorità'del soggetto attraverso questa convocazione a rispondere, attraverso
questa convocazione che non lascia nessun luogo di rifugio, nessuna possibilità di scampo e, così,
malgrado l'io, o più esattamente, mio malgrado, tutto il contrario del non-senso, alterazione senza
alienazione o elezione. Il soggetto nella sua responsabilità si aliena nell'intimo della sua identità di
un'alienazione tale che non svuota il Medesimo della sua identità, ma ve lo assoggetta, con una
convocazione irrecusabile [...]. L'identità del soggetto qui si mette in risalto non attraverso una
quiete su di sé, ma attraverso un'inquietudine che mi insegue fuori dal nucleo della mia
sostanzialità.55
La Rivelazione che si fa concreta -- che si fa etica -- significa perciò una
nuova visione dell'uomo. L'anima umana non è qui origine di sé, soggetto in grado di render conto
di sé e dell'universo, né esistenza preoccupata di questa esistenza stessa. Essa è obbligata prima di
ogni impegno [...], responsabilità nell'oblio di sé. [...] Umiltà, discrezione, perdono delle offese, che
non debbono esser scambiate soltanto per virtù; tutte queste attribuzioni 'rovesciano'la nozione
ontologica della soggettività per collocarla nella rinuncia, nella cancellazione e in una passività
totale.56
4. Veglia come attenzione
Nel pensiero di Levinas -- che egli stia commentando una pagina del Talmud o che sia alle prese
con la critica delle categorie filosofiche della tradizione occidentale -- si trova dunque la stessa,
originale, soggettività, che si riconosce come tale soltanto nello scoprirsi già usurpatrice del posto
che occupa, già ostaggio responsabile dell'altro. Paiono ricordarlo bene, nell'ultima lezione
talmudica tenuta da Levinas,57 le parole di Abramo, che in Gn 18, 27 si vede e si dice «polvere e
cenere»58:
Verità di uno sguardo in qualche modo 'avventizio'lanciato su di sé da Abramo nel corso di un
pensiero volto all'altro totalmente altro, preoccupato dell'altro e nato da una cura per l'altro. [...]
Miseria che si rivela gloria! Rinnegandosi nelle sue ceneri e polveri, pensiero che resta, o è già,
quanto-a-sé, abnegazione, elevazione dell'umana creatura a un'altra condizione, a un diverso
ordine dell'umano,59
l'ordine della santità.
E proprio al passaggio «dal sacro al santo» -- locuzione che dà il titolo ad una raccolta di lezioni
talmudiche dei primi anni '70 -- corrisponde precisamente il movimento del «risveglio». In più di
qualche lezione talmudica, torna a giocare un ruolo determinante la nozione della «notte», che
assieme all'il y adescrive la situazione del soggetto primadella rottura -- fondamentale ma non
definitiva -- dell'ipostasi. Nella lettura di una pagina del trattato Menachoth, dedicata alla
fabbricazione del tavolo su cui sarà posato il «pane di proposta»,60 Levinas s'imbatte nella paura
ebraica di lasciare scoperto questo tavolo durante la notte:
Perché questa importanza attribuita alla notte? Che cosa si teme nella notte? Io penso che la notte
costituisca il momento critico per le grandi collettività fondate sull'organizzazione delle funzioni
piuttosto che sui contatti personali. La notte ognuno fa ritorno a casa sua. È la vita privata.
Disintegrazione e individualismo.61
Non c'è in effetti molta distanza dalla notte che tutto dissolve di De l'existence à l'existant,62 la
notte che definisce l'anonimato, l'impersonale dell'il y a. Per descrivere in maniera più completa
questa condizione di spersonalizzazione e indistinzione, Levinas si appoggia, nel saggio del 1947, al
concetto di «partecipazione» sviluppato da Lévy-Bruhl:
Nella partecipazione mistica [...] l'identità dei termini viene meno [...]. L'esistenza privata di
ciascun termine, dominata dal soggetto che è, perde il suo carattere privato, e ritorna a un fondo
indistinto [...]. L'impersonalità del sacro nelle religioni primitive [...] descrive [...] un mondo in cui
non c'è nulla che prepari l'apparizione di un Dio.63
La notte può essere quindi la corretta metafora dell'ambiguità del sacro, concetto al centro anche
di un'appassionata lezione su un testo di Sanhedrin.64 Seguendo i commenti dei dottori rabbinici,
Levinas descrive il «sacro» in termini di ambiguità, dissoluzione del vero nell'apparenza e
indistinzione: nel sacro -- e soprattutto nella sua peggiore degenerazione, la magia, che «fiorisce
nella sua penombra» (ancora l'idea dell'oscurità come anonimato) -- non c'è più niente di identico
a se stesso, ma tutto si assomiglia, e tutto si confonde. È necessaria allora una certa separazione,
«una assenza protetta dalla presenza di proibizioni, [...] speranza di santità contro il sacro
incorreggibile».65 Si delinea così «la strada "dal sacro al santo": è quella della vigilanza, del non
dimenticare, del non interrompere la luce dello sguardo che deve restare sveglio».66 Santo è colui
che sa vigilare, che sa riconoscere nella notte l'appello che proviene dal volto dell'altro, e che,
nell'oblio di sé, è consapevole della sua elezione irrecusabile alla responsabilità.
A scanso di qualsiasi equivoco, è forse opportuno aprire una parentesi e precisare qui il significato
preciso a cui si riferisce Levinas quando fa uso del termine «veglia». Come per l'italiano, anche la
parola francese veille ha due sfumature di significato sostanzialmente diverse. Da un lato, essa
indica lo stato di coscienza nel quale vi è piena attività dei centri nervosi, in contrapposizione alla
temporanea sospensione di alcune delle loro funzioni, che è tipica del sonno; dall'altro, invece, per
estensione, essa si riferisce all'impiego delle ore notturne, normalmente dedicate al sonno, in
attività lavorative o assistenziali o in pratiche di culto o devote, oppure in piacevoli intrattenimenti.
Il verbo da essa derivato, «vegliare» (veiller), descrive precisamente il secondo significato, ma può
anche sfumare nell'accezione di «vigilare», e perciò: stare desto, non dormire, prestare attenzione,
... È certamente in questo senso che vanno intesi il «vegliare» e la «veglia» presenti nei termini
levinassiani. Ed è anche nelle diverse pieghe di questo significato che si trova lo scarto tra il Levinas
degli anni '40 e l'autore di Totalité et Infini e Autrement qu'être, nonché lettore del Talmud: se
prima la «veglia» veniva associata allo stato di insonnia,67 ora appare evidente che la connotazione
etica è non soltanto presente, ma centrale.
In un'altra lezione talmudica, il cui tema è la guerra, si incontra un passo segnato da un
pessimismo radicale: l'interpretazione di una barayta68 porta a non considerare alcuna reale
differenza tra pace e guerra, poiché il male si cela dappertutto; assassini e omicidi si nascondono in
ogni angolo. «A meno che codesta tesi non sia precisamente l'appello a un'infinita responsabilità
dell'uomo, a una vigilanza infaticabile, a un'assoluta insonnia»69: la veglia arriva a coincidere con
la responsabilità. È un appello a non essere disattenti, anche nell'oscurità più indistinta, alla
chiamata del volto del prossimo.
È sulla base di queste considerazioni che si può intendere la concezione ebraica del tempo nei
termini della permanenza: la veglia -- infinita attenzione, eterno ascoltare -- è il segreto di un
popolo che, proprio nel rito quotidiano (fusione di studio e liturgia) e nella «verità riaffermata con
regolarità»,70 risveglia l'essere assopito nella vita naturale. La storia stessa corrisponde, per
l'ebraismo, all'attesa ed all'attenzione estrema che descrivono lo stato di veglia;71 vigilanza
paziente e costante in un risveglio che non può mai considerarsi definitivo, se i termini della
questione sono questi:
La Torah è una permanenza perché è un debito impagabile. Più pagate questo debito, più siete
indebitati, e, cioè, meglio vedete l'estensione di quel che resta da scoprire e da fare. Categoria che
occorre trasporre alla relazione con l'altro uomo insegnata dalla Torah: più vi accostate all'altro,
più cresce la vostra responsabilità nei suoi confronti. Ci si riferisce, dunque, all'infinito del dovere - che è forse la modalità stessa della relazione all'infinito.72
Infinito del dovere, cioè infinito della veglia ma anche infinito del risveglio, che è sempre meno un
passaggio da uno stato di coscienza ad un altro, e sempre più un'indicazione etica, per una vita
estremamente attenta alle esigenze del prossimo. E in un'ottica che lega a doppio filo risveglio e
veglia, nel segno entrambi di una pazienza infinita e costante, certamente non ci si stupirà se le
tante chiamate di Dio che si trovano nella Bibbia possano essere lette come un esplicito invito a
restare svegli, a «non dormire»,73 come nel caso di Giacobbe (Gn 46, 2: «Dio disse a Israele in una
visione notturna: "Giacobbe, Giacobbe"»): «risveglio di Israele in Giacobbe. Ma quanti risvegli non
sono altro che insonnie! 'Visioni notturne', verità notturne in cui Dio parla a Israele ma lo chiama,
come in passato, Giacobbe».74
5. Figure del risveglio: il nazireo e il Messia
Per dare concretezza all'appello alla vigilanza di Levinas, si possono individuare due -- tra le altre -significative fisionomiedel risveglio. La prima è al centro di una lettura talmudica del trattato
Nazir,75 nella quale Levinas, invitato a parlare della "giovinezza d'Israele", si confronta con
l'istituzione ebraica del nazireato. La seconda, dai tratti certamente più intensi, è contenuta invece
nella prima lezione di commento al Talmud di Levinas,76 a proposito di alcuni testi messianici del
trattato Sanhedrin.
Del nazireato si parla in Nm6, 1-21: è un «speciale», fatto al Signore, che consta di alcune
particolari proibizioni (non tagliarsi i capelli, non bere vino o qualsiasi altro prodotto della vigna,
non avere alcun tipo di contatto impuro, specialmente con i morti). A partire da due specifici voti di
nazireato, quello di Sansone e quello di Samuele (entrambi non per scelta, ma decisi da qualcun
altro), Levinas sembra comprendere il senso profondo di questo voto nella logica dell'ebraismo:
Il disinteresse. Non nel senso unicamente morale del termine, senso indubbiamente presente
anch'esso nel disinteresse, ma in un senso ancora più radicale. Si tratta di quel disinteresse che si
oppone all'essenza di un essere la quale è sempre precisamente persistenza nell'essenza,
ripiegamento dell'essenza su se stessa, coscienza di sé e compiacimento di sé.77
E allora, non tagliarsi i capelli corrisponde proprio al rifiuto non tanto della bellezza, ma della
contemplazione di essa, di «questo narcisismo che è la coscienza di sé, sulla quale è costruita la
nostra filosofia occidentale e la nostra morale».78 Pare così che soltanto un soggetto predisposto
ad un certo oblio di sé sia in grado di accogliere la chiamata traumatica del volto del prossimo. Se
poi questa condizione non rientra in una volontà personale, com'è il caso del nazireato di Sansone e
Samuele, tale impossibilità di scegliere il voto nei confronti del prossimo -- che in quanto
contestazione radicale della libertà umana è il tratto specifico del Bene -- dona al soggetto una
particolare «giovinezza»: la giovinezza propria di un età precedente a quella in grado di scegliere.
«Ma così il nazireo assoluto porta attraverso tutta la sua vita il segno di una giovinezza
inimmaginabile, di una giovinezza prima della giovinezza, di una giovinezza al di fuori di ogni
invecchiamento».79 Il nazireo significa allora il disinteresse e la giovinezza, connotati necessari del
soggetto capace di risveglio.
Per quanto riguarda il Messia,80 va precisato che la tradizione talmudica e rabbinica non parla
molto di esso. La ragione principale è certamente storica e legata alle varie vicende che nel corso
dei secoli hanno portato ad indicare in una persona piuttosto che in un'altra il Messia.81
L'ebraismo è perciò generalmente prudente e silenzioso sul tema messianico. Prima di entrare nel
merito dei testi levinassiani, è necessario cercare di capire in che termini è presente l'idea
messianica nell'ebraismo. In un saggio dedicato a questo specifico tema,82 Gershom Scholem è
certo che tale idea sia da sempre presente nella storia dell'ebraismo, ma che nel corso dei secoli
abbia assunto sfumature e caratteristiche diverse. Egli distingue tre generiche correnti all'interno
dell'ebraismo: una conservatrice, tesa a mantenere e difendere i valori dell'ebraismo -- questa
corrente si identifica con il mondo rabbinico, che è anche il mondo del giudaismo di Levinas -, una
restauratrice, che vuole ricreare un determinato passato, ed una utopica, che guarda ad una
situazione ancora da vivere nel futuro. È certamente nella prima corrente che l'idea messianica ha
trovato meno spazio. Nella seconda e nella terza, invece, è stata attiva e generatrice di tensioni e
cambiamenti. Con queste premesse, Scholem può distinguere tra messianismo apocalittico (che
considera la venuta del Messia come un evento imprevedibile, che irrompe violento nella storia e la
sconvolge) e messianismo «razionalista».83 Il filosofo tedesco pensa qui soprattutto alla
concezione del messianismo che ha Maimonide: nel suo pensiero, ciò che è più importante, ciò che
solo può guidare l'ebreo, è lo studio della Torah; c'è l'attesa messianica, ma nessuno spazio è
presente per immagini o fantasie apocalittiche.
La concezione del messianismo di Levinas è dunque in linea con il pensiero di Maimonide o più
generalmente dei dottori rabbinici presente nel Talmud, che mette appunto in relazione l'idea
messianica con lo studio e la pratica della Torah. In questa stessa direzione, il commento alle
pagine 98b e 99a del trattato Sanhedrin fa però un passo in più, e mette in luce la connotazione
universale ed etica della venuta del Messia.
Nella coesistenza di varie opinioni, anche radicalmente differenti, dei dottori rabbinici -- che bene
si inserisce nell'apertura esegetica infinita tipica dei testi talmudici -- balza all'attenzione quanto
dice Rabbi Hillel: «non c'è Messia per Israele. Israele ne ha già gustato all'epoca del re Ezechia». Il
Messia sarebbe in qualche modo superato, già realizzato nella storia al tempo del re Ezechia. È una
possibilità scandalosa, ma proprio perché mantenuta all'interno del Talmud va presa in
considerazione con molta serietà: c'è da aspettarsi forse un'altra salvezza -- di livello superiore -per Israele?84 Ciò che sembra sicuro è che al fondo di queste parole si trova una sostanziale
sfiducia nei confronti dell'idea messianica, soprattutto per quella dalle sfumature politiche. Ma si
può anche constatare che, stando così le cose, la salvezza -- che coincide con l'avvento del Messia -non ha più a che fare con la fine della storia. In altre parole, «essa rimane possibile in ogni
momento»85: il messianismo va allora inteso come una possibilità quotidiana di realizzare la
«vocazione personale degli uomini»,86 che consiste nella sofferenza, segno non di una qualche
espiazione, ma della fedeltà e della vigilanza della coscienza alla chiamata dell'altro uomo. Levinas
può così
concepire il messianismo, prima ancora che come un tratto "particolare"'del popolo ebraico e della
sua storia, come una struttura universale della "soggettività" o dell'umano in generale, che consiste
nell'assunzione di responsabilità nei confronti del prossimo. Ogni uomo deve essere Messia se
vuole essere pienamente uomo.87
Scrive Levinas:
Il Messia sono Io, ed Essere Io è essere Messia. Si vede dunque che il Messia è il giusto che soffre,
che egli ha preso su di sé le sofferenze degli altri. D'altra parte, chi è che prende su di sé le
sofferenze degli altri se non colui che dice "Io"? L'ipseità stessa è definita da questo non sottrarsi al
peso che impone la sofferenza degli altri. Tutte le persone sono Messia. L'Io in quanto Io,
prendendo su di sé tutta la sofferenza del Mondo, si designa da solo per questo ruolo. Designarsi da
sé, non sottrarsi fino al punto di rispondere prima ancora che l'appello risuoni: tutto questo è
essere Io. [...] Questo vuol dire che ognuno deve agire come se fosse il Messia. Il messianismo non
è la certezza della venuta di un uomo che arresta la storia: è il mio potere di sopportare la
sofferenza di ognuno. È l'istante in cui riconosco questo potere e la mia responsabilità
universale.88
Il Messia è allora l'Io che sa sopportare il peso della sua condizione irrecusabile di ostaggio, l'Io che
si scopre se stesso nell'esposizione all'altro, preliminare ad ogni decisione, l'Io che veglia sull'altro e
dall'altro viene risvegliato, ... in una parola: l'umano.
Ma se il Messia, da unica persona capace di liberare questo mondo, diventa una vocazione da
realizzare in ogni momento della propria vita, un compito che ogni uomo deve assolvere
responsabilmente in prima persona, si può allora ben comprendere ciò che sottintende Levinas con
queste parole:
Mi è stato chiesto se l'idea messianica ha ancora un senso per me, e se è necessario conservare
l'idea di una tappa ultima della storia in cui l'umanità non sarà più violenta, in cui squarcerà
definitivamente la crosta dell'essere e in cui tutto si chiarirà. Ho risposto che per essere degni
dell'era messianica bisogna ammettere che l'etica ha un senso, anche senza le promesse del
Messia. 89
6. Partire dall'ebraismo?
Nei commenti talmudici, quindi, Levinas pone in luce quell'etica della responsabilità che
caratterizza i suoi saggi più significativi e che è descritta dalla particolare figura del risveglio;
d'altro canto, però, si è visto come sia da considerarsi indiscutibile la rilevanza del Talmud nella
formulazione delle tesi principali della filosofia levinassiana.
Questo «doppio movimento» ha alla base, in realtà, un ulteriore spostamento di livello: il risveglio
acquista attraverso i testi talmudici una profondità inedita, per certi versi né catalogabile né
definibile, e che lascia alcune questioni aperte.
D'altro canto, e qui si fa necessaria una parentesi, gli ultimi sviluppi della ricerca filosofica sugli
scritti levinassiani, che hanno visto l'importante pubblicazione degli inediti Carnets de captivité e
Notes philosophiques diverses, sembrano confermare con forza l'irrinunciabilità del confronto con
la c? téebraica del pensatore lituano. Scritti all'incirca tra il periodo della prigionia e la
pubblicazione di Totalité et Infini,90 queste pagine testimoniano di un pensiero in ricerca, libero e
originale, dove il legame tra filosofia ed ebraismo è sorprendentemente molto più esplicito, rispetto
alle pubblicazioni edite conosciute fino ad oggi: la filosofia in divenire di Levinas si scopre fin da
subito ricerca di una via alternativa all'ontologia heideggeriana nelle pieghe dell'ebraismo. La
prigionia e lo hitlerismo, a detta del filosofo, hanno fatto si che l'ebreo si sentisse, di nuovo,
«ineluttabilmente connesso al proprio ebraismo»,91 e che ritrovasse così la propria identità
israelita: dalla lettura di queste pagine, è evidente che è proprio da qui che Levinas ha intenzione di
partire. In due appunti dei Carnets, segnati nella stessa pagina, si può leggere: «partir du Dasein
ou partir du J.» e ancora «J. comme catégorie».92 Nello stesso momento in cui Levinas elaborava
il suo primo confronto critico con l'ontologia in De l'existence à l'existant, insomma, vi è un
tentativo di fare dell'essere-ebreo il punto di partenza e separazione dall'ontologia, poiché unico
luogo possibile per una nuova interpretazione dell'uomo e della sua soggettività. Le Notes, poi,
sono ancora più ricche di riferimenti espliciti a questo tema. L'interesse di Levinas, in queste
notazioni, è principalmente per la metafora, considerata dal pensatore come l'essenza stessa del
linguaggio spinto all'estremo, capace di significare aldilà di ciò che dice. Se la filosofia levinassiana
è ricerca di trascendenza e superamento nella relazione con l'altro, nell'esigenza di rispondergli e,
rivolgendosi a lui, nell'essere in relazione stessa con il superiore, allora questo spirituale si dona per
eccellenza in ciò che viene definito «miracolo»93 della metafora: la relazione sensibile, esigente e
insistente con l'altro come altezza e volto, e il pensiero della metafora come cammino verso
l'altezza, sono indissolubili.
In questo contesto, non può che meritare estrema attenzione il fatto che siano presenti nelle
Notescitazioni di varia lunghezza in ebraico, riguardanti questioni squisitamente filosofiche. Non
sembra, infatti, trattarsi semplicemente di una questione linguistica o di traduzione, ma di un
contributo irrinunciabile all'elaborazione del pensiero levinassiano, che passa indelebilmente per
un idioma che porta con sé tutta l'esperienza millenaria di studio e commento del popolo ebraico:
le citazioni di passaggi biblici e talmudici, presenti davvero in gran numero e associate a temi
filosofici fondamentali nella meditazione di Levinas, sono ricche di associazioni di senso radicate
nella tradizione ebraica di lettura della Bibbia che -- va detto -- nella maggior parte dei casi il
mondo filosofico ignora.
Per una comprensione il più possibile completa e definitiva della ricerca filosofica di Levinas, il
«»ebraismo è quindi un passaggio obbligato, e -- per i motivi che abbiamo già esposto -- ancora
tutto da indagare. E le letture talmudiche diventano allora -- a maggior ragione dopo la
pubblicazione dei Carnets delle Notes- uno dei luoghi privilegiati di confronto e approfondimento
del delicato rapporto tra ebraismo e filosofia all'interno del pensiero levinassiano. Un rapporto che,
se letto nella prospettiva corretta, non è né quello di un filosofo ebraico (la ricerca di Levinas è
legata fin dall'inizio al metodo fenomenologico husserliano), né quello di un filosofo sulla scia dei
maestri Husserl e Heidegger. La definizione che forse più da ragione di questa ambivalenza è quella
data da David Banon, capace di sottolineare la separazione e il dialogo tra l'ambito filosofico ed
ebraico, scrivendo di Levinas come un ebreo che pensa.94
Note
1.
Emmanuel Levinas, «De l'évasion», Recherches Philosophiques, V (1935-36), pp. 373-392, riedito in volume da
Jacques Rolland, trad. it di Donatella Ceccon, Dell'evasione, Cronopio, Napoli 2008, p. 46.
2.
Con questo aggettivo, Levinas intende classificare i testi della sua produzione dedicati alla lettura del Talmud o a
temi comunque specificamente giudaici. Cfr. François Poirié, Emmanuel Levinas. Essai et entretiens, Actes Sud,
Arles 2006, pp. 61-169.
3.
Salomon Malka, Emmanuel Levinas. La vie et la trace, trad. it. di Claudia Polledri, Emmanuel Levinas. La vita
e la traccia, Jaca Book, Milano 2003, p. 230.
4.
Ibid.
5.
«Non si sa granché di questo personaggio. Non si conosce il suo nome - Chouchani non è il suo vero nome. Si
ignora la sua origine, la città di nascita, l'ambiente in cui è cresciuto, il luogo dove ha fatto i suoi studi. [...] Visse
tutta la sua vita come un clochard, senza un domicilio fisso, vagando da una città all'altra, passando da New
York a Strasburgo, da Strasburgo a Parigi, poi a Gerusalemme ed infine a Montevideo, in Uruguay, dove si
spense nell'anonimato. Con questo epitaffio sulla tomba: "la sua nascita e la sua vita sono annodate da un
segreto"» (Ivi, p. 156). Per una ricerca biografica su Chouchani, cfr. Salomon Malka, Monsieur Chouchani.
L'énigme d'un Maître du XXème siècle, J. C. Lattès, Paris 1994.
6.
François Poirié, Emmanuel Levinas, cit. alla nt. 3, p. 160. In un'altra intervista, Salomon Malka chiede a Levinas
se è merito di Chouchani la sua scoperta del Talmud. Levinas risponde: «Io non so neppure se ciò che so è già
una scoperta, ma è lui che mi ha mostrato come bisogna leggerlo. Accanto al suo genio, alle sue conoscenze, alla
sua potenza dialettica, tutto impallidisce. [...] Chouchani era molto duro, esigente verso di me come verso tutti.
Maestro inflessibile! Ma quando aveva un sorriso di incoraggiamento, significava molto. E talvolta egli aveva
questo sorriso per dei passaggi midrashici che io tentavo di commentare. Egli pensava che non bisogna costruire
né speculare nell'astratto, ma nell'immaginazione. Bisogna pensare a dei mondi che sono evocati da ogni
immagine del testo, allora il testo si mette a parlare» (Salomon Malka, Lire Levinas, ed. it. a cura di Emilio
Baccarini, Leggere Levinas, Queriniana, Brescia 1986, pp. 116-117).
7.
Tra questi, assieme a Levinas, va ricordato anche un altro nome illustre: Elie Wiesel.
8.
« I trattati talmudici costituiscono la trascrizione - avvenuta tra il II e il VI secolo della nostra era - delle lezioni
orali e delle discussioni svoltesi tra i dottori rabbinici. Queste lezioni e queste discussioni sono, per la tradizione
ebraica, insegnamenti risalenti al Sinai, che completano e chiariscono gli insegnamenti della Torah scritta (la
Bibbia e, più particolarmente il Pentateuco) e che, Torah orale, significano teologicamente la Parola e la Volontà
di Dio con la stessa autorità della Torah scritta. [Un testo talmudico è composto di] due parti distinte poste l'una
dopo l'altra: Mishnah e Gemara. Mishnah significa "insegnamento" o "lezione da ripetere". Gemara vuol dire
"tradizione"; essa appare come commento o discussione della Mishnah; è anche il termine con il quale si
designa l'insieme del Talmud (Mishnah + Gemara), termine che significa, all'incirca, "studio". Il Talmud (o la
Gemara) rappresenta la Torah orale attraverso la quale la Torah scritta è letta nel giudaismo tradizionale. La
Mishnah enuncia insegnamenti pratici o relativi alla condotta (Halakah) attribuiti ai dottori rabbinici della più
grande autorità - i Tannaiti - e messi per iscritto verso la fine del II secolo della nostra era [grazie all'opera di
Rabbi Yehudah Ha-Nasi, nell'anno 186 d.C. La parte più narrativa del Talmud, composta di aneddoti,
conversazione, aforismi di tutti i generi, generalmente di interesse filosofico o morale, viene chiamata invece
Aggada]. La Gemara, che si riferisce il più delle volte agli enunciati della Mishnah, è composta dalle discussioni
che ebbero luogo nelle accademie rabbiniche della Terra Santa e di Babilonia a partire dal terzo secolo tra i
dottori chiamati Amorei; queste discussioni furono messe per iscritto verso la fine del VII secolo» (Emmanuel
Levinas, L'au-delà du verset. Lectures et discours talmudiques, trad. it. e cura di Giuseppe Lissa, L'aldilà del
versetto. Letture e discorsi talmudici, Guida Editori, Napoli 1986, pp. 164-164, nn. 3 e 4). Per un'analisi
esaustiva delle articolazioni della tradizione interpretativa ebraica (Talmud, letteratura midrashica, traduzioni
della Torah, ...), cfr. David Banon, La Lecture infinie. Les voies de l'interprétation midrachique, trad. it. Di
Giuseppe Regalzi, La lettura infinita. Il midrash e le vie dell'interpretazione nella tradizione biblica, Jaca Book,
Milano 2009.
9.
Emmanuel Levinas, Quatre Lectures Talmudiques, trad. it. e cura di Alberto Moscato, Quattro letture
talmudiche, Il melangolo, Genova 1982, p. 34.
10. Va aggiunto che le recenti pubblicazioni dei Carnets de captivité e delle Notes philosophiques diverses - in
Emmanuel Levinas, Cahiers de captivité et autres inédits, a cura di Rodolphe Calin e Catherine Chalier, Imec
Grasset, Angoulê2009 - sembrano mostrare un rapporto tra ebraismo e filosofia esplicito e già forte negli anni
dell'elaborazione di De l'existence à l'existant. Cfr. paragrafo 6 di questo saggio.
11. Cfr. Shmuel Wygoda, «Le maître et son disciple: Chouchani et Levinas», Cahiers d'études levinassiennes, 1
(2003), pp. 149-183.
12. David Banon, La lettura infinita, cit. alla nt. 9, p. 145. All'interno del passo, si trova tra virgolette un estratto di
Emmanuel Levinas, Quattro letture talmudiche, cit. alla nt. 10, p. 104.
13. Si pensi alla vicinanza con la disseminazione di Jacques Derrida: «il Midrash si lascia guidare, quando vuole,
dalla forma fisica dei vocaboli. Modo di leggere che assomiglia ai procedimenti della "disseminazione" in uso
oggi in certi circoli d'avanguardia» (Emmanuel Levinas, L'aldilà del versetto, cit. alla nt. 9, p. 119).
14. Cfr. ivi, p. 189, n. 7. Ecco il passo di Rabbi Hayyim di Volozhin: «i nostri maestri insegnano che tutte le loro
parole somigliano a braci (Avot 2, 10). [Per quale ragione? Perché?] se soffi sulla brace - in apparenza spenta e
in cui rimane una sola scintilla - la rianimerai smuovendola e l'attizzerai soffiando su di essa. E più soffierai, più
la fiamma avvamperà e più si propagherà il fuoco, finché si trasformerà in un focolaio incandescente. Allora
potrai approfittarne, facendoti luce col suo fulgore o riscaldandoti vicino al suo braciere. Ma soltanto ad una
certa distanza, senza possibilità di toccarlo. [...] [E Rabbi Hayyim conclude:] anche se le loro parole ci sembrano
semplici e prive di stile, in realtà sotto l'azione del martello si disseminano. Perché più si triturano e si
esaminano meticolosamente queste parole, più i nostri occhi si rischiarano per lo sfavillio del loro lume vivace, e
più si troverà un contenuto insospettato, come dicono i nostri maestri: "volgiti là e ritorna là, perché tutto vi si
trova..." (Avot 5, 22)» (Rabbi Hayyim di Volozhin, Nefesh ha-hayyim, trad. fr. a cura di Benjamin Gross, L'âme
de la vie, Verdier, Lagrasse 1986, parte III, cap. I).
15. Cfr. David Banon, La lettura infinita, cit. alla nt. 9, p. 39.
16. Letteralmente spiegazione e/o ricerca; questo termine indica allo stesso tempo il procedimento interpretativo e
l'insieme dei commentari ebraici al testo biblico, la cui compilazione va dal V al XIII secolo d.C.
17. Emmanuel Levinas, Dalla scrittura all'oralità, prefazione a Cfr. David Banon, La lettura infinita, cit. alla nt. 9,
pag. 11.
18. David Banon, La lettura infinita, cit. alla nt. 9, pp. 241-242.
19. Ivi, p. 255.
20. Ivi, p. 232.
21. «Sono arrivato a utilizzare tutto questo [i testi talmudici] partendo dalla filosofia tradizionale. Ho pensato per
molto tempo che fosse una cultura 'a lato'. Ho avuto un rapporto approfondito con il pensiero talmudico
piuttosto tardi, a contatto con M. Chouchani. Egli non mi ha infuso nulla del suo immenso sapere, né certo della
sua incomparabile intelligenza, ma mi ha insegnato come si dovevano affrontare questi testi, questo fondo
irraggiungibile. A confronto con lui, tutto questo è nulla e noi non si è nulla. [...] Ne ho conservato un ricordo
indimenticabile e incomunicabile della vita dello spirito» (Emmanuel Levinas, Transcendance et intelligibilité,
trad. it. e cura di Francesco Camera, Trascendenza e intelligibilità, Marietti, Genova 1990. p. 58, corsivo mio).
22. François Poirié, Emmanuel Levinas, cit. alla nt. 3, p. 131.
23. Richard A. Cohen, «Levinas and Rosenzweig: Proximities and Distances», Cahiers d'Ètudes Levinassiennes, 8
(2009), p. 21.
24. Emmanuel Levinas, A l'heure des nations, trad. it. e cura di Silvano Falcioni, Nell'ora delle nazioni, Jaca Book,
Milano 2000, p. 204.
25. François Poirié, Emmanuel Levinas, cit. alla nt. 3, p. 132
26. Sal 119, 19.
27. François Poirié, Emmanuel Levinas, cit. alla nt. 3, p. 132.
28. Emmanuel Levinas, Trascendenza e intelligibilità, cit. alla nt. 21, p. 39, corsivo mio.
29. Un'operazione che si concluderà soltanto con Autrement qu'être, in risposta soprattutto alle considerazioni di
Derrida, che imputerà a Levinas di aver criticato l'ontologia presupponendo e utilizzando il linguaggio
ontologico. Cfr. Jacques Derrida, Violence et métaphysique. Essai sur la pensée d'Emmanuel Levinas, in
Jacques Derrida, L'écriture et la différence, trad. it. di G. Pozzi, La scrittura e la differenza, Einaudi, Torino
1990, pp. 99-198.
30. A zzolino Chiappini, Amare la Torah più di Dio. Emmanuel Levinas lettore del Talmud, Giuntina, Firenze 1999,
p. 268.
31. Emmanuel Levinas, Du Sacré au Saint. Cinq nouvelles lectures talmudiques, trad. it. e cura di Ornella Nobile
Ventura, con introd. di Sofia Cavalletti, Dal Sacro al Santo. Cinque nuove letture talmudiche, Città Nuova,
Roma 1985, p. 138.
32. Al ritorno dalla prigionia trascorsa nello Stalag XIB nella regione di Hannover, Levinas scoprirà di aver perso
tutta la sua famiglia in una fucilazione a Kaunas. Si salveranno soltanto la moglie Raïssa e la figlia Simone,
grazie all'accoglienza accordata dal monastero di Saint-Vincent de Paul, vicino ad Orléans (cfr. Salomon Malka,
Emmanuel Levinas, cit. alla nt. 4, pp. 75-91).
33. Id., Leggere Levinas, cit. alla nt. 7, p. 82.
34. Ivi, p. 83.
35. Emmanuel Levinas, Noms propres, trad. it. e cura di Francesco Paolo Ciglia, Nomi propri, Marietti, Casale
Monferrato 1984, p. 156, corsivo mio.
36. Le conferenze di Levinas, infatti, si svolgono con cadenza quasi annuale dal 1963 al 1989 e trattano dei temi più
eterogenei: «timidezza e audacia. Morale e politica. Il messianismo e la fine della storia. Il perdono. La
tentazione. Israele. Il mondo ha bisogno degli ebrei? Giudaismo e rivoluzione. La giovinezza d'Israele. Gli ebrei e
la società desacralizzata. Lo Shabbat. Solitudine di Israele. La guerra. Il modello occidentale. Comunità
musulmana. Religione e politica. La comunità. La Bibbia al presente. Israele, il giudaismo e l'Europa. L'idolatria.
Zakor, memoria e storia. Le settanta nazioni. Il denaro. La questione dello Stato. In quanto a me... Questi
furono i temi dei colloqui che si susseguirono dal 1957 al 1989» (Salomon Malka, Emmanuel Levinas, cit. alla
nt. 4, p. 134).
37. Emmanuel Levinas, L'aldilà del versetto, cit. alla nt. 9, p. 111.
38. Cfr. Emmanuel Levinas, De l'existence à l'existant, trad. it. di Federica Sossi, con premessa all'ed. it. di Pier Aldo
Rovatti, Dall'esistenza all'esistente, Marietti, Casale Monferrato 1986. pp. 61-65.
39. Pier Aldo Rovatti, «L'insonnia. Passività e metafora nella "fenomenologia" di Levinas», Aut - aut, 209-210
(1985), p. 71.
40. Emmanuel Levinas, L'aldilà del versetto, cit. alla nt. 9, p. 116.
41. Ivi , p. 119.
42. Cfr. Zvi Kolitz, Yossl Rakover si rivolge a Dio, Adelphi, Milano 1997. Il testo si presenta come un monologo di
un ebreo del Ghetto di Varsavia, sopravvissuto agli orrori della Shoah.
43. Emmanuel Levinas, Difficile Liberté. Essais sur le judaïsme, trad. it. integrale e cura di Silvano Falcioni,
Difficile Libertà, Jaca Book, Milano 2004, p. 182, corsivo mio.
44. Id., Nell'ora delle nazioni, cit. alla nt. 24, p. 70.
45. Emmanuel Levinas, Entre nous. Essais sur le penser-à-l'autre, trad. it. e cura di Emilio Baccarini, Tra noi.
Saggi sul pensare-all'altro, Jaca Book, Milano 1998, p. 36.
46. Id., Quattro letture talmudiche, cit. alla nt. 10, p. 145. Questa concordanza di «rivelazione» e «comandamento»
è centrale nel pensiero ebraico. Anche Rosenzweig, in un saggio in cui si trovano le concezioni generali che
saranno poi alla base della Stella, esprime più o meno la stessa idea: «la rivelazione dice: fai la mia volontà,
compi la mia opera! Presupposto dunque: che l'uomo divenga fiduciario del proprio Dio, della volontà di Dio,
dell'opera di Dio così da compierla» (Franz Rosenzweig, Die Schrift, ed. it. a cura di Gianfranco Bonola, La
scrittura. Saggi dal 1914 al 1929, Città Nuova, Roma 1991, p. 251).
47. Id., L'aldilà del versetto, cit. alla nt. 9, 234, corsivo mio.
48. Id., Quattro letture talmudiche, cit. alla nt. 10, p. 89.
49. Id., Autrement qu'être ou au-delà de l'essence, trad. it. e cura di Silvano Petrosino e Maria Teresa Aiello,
Altrimenti che essere o al di là dell'essenza, Jaca Book, Milano 1983, p. 189.
50. Id., Quattro letture talmudiche, cit. alla nt. 10, p. 87.
51. Ivi, pp. 92-93.
52. Id., Dal Sacro al Santo, cit. alla nt. 31, p. 120. Il corsivo per "insonne" e "sveglio" è mio.
53. «Il Dio che è passato non è il modello di cui il volto sarebbe l'immagine. Essere a immagine di Dio non significa
essere l'icona di Dio, ma trovarsi nella sua traccia. Il Dio rivelato nella nostra spiritualità giudaico-cristiana
conserva tutto l'infinito della sua assenza nell'ordine personale stesso. Si mostra unicamente attraverso la sua
traccia, come nel capitolo 33 dell'Esodo. Andare verso di Lui non significa seguire questa traccia che non è un
segno, ma andare verso gli Altri che si trovano nella traccia» (Id., En découvrant l'existence avec Husserl et
Heidegger, trad. it. integrale a cura di Federica Sossi, Scoprire l'esistenza con Husserl e Heidegger, Cortina,
Milano 1998, p. 233). È ancora possibile, dopo queste parole, poter sostenere l'esistenza separata di un «Levinas
filosofo» ed un «Levinas interprete del Talmud»?
54. Cfr. Id., L'aldilà del versetto, cit. alla nt. 9, p. 191.
55. Id., Altrimenti che essere, cit. alla nt. 49, pp. 177-178.
56. Id., L'aldilà del versetto, cit. alla nt. 9, p. 208.
57. La conferenza, dalla quale è stata poi trascritta la lezione, è dell'11 dicembre 1989.
58. Il contesto è la preghiera in favore della perversa Sodoma minacciata dal castigo di Dio.
59. Emmanuel Levinas, Nouvelles lectures talmudiques, trad. it. a cura di Beato Caimi, Nuove letture talmudiche,
SE, Milano 2004, pp. 84-85.
60. Cfr. Es 25, 23-30 e Lv 24, 5-9. Il passo del Levitico menziona in primo luogo la confezione del pane - in
traduzione italiana chiamato «pane di proposta» - da depositare tutti i Sabati e da esporre fino al Sabato
successivo; poi, la deposizione di questi pani su un tavolo, «davanti al Signore, sempre» e il loro consumo ogni
Sabato da parte dei pontefici o da parte dei sacerdoti. Il passo dell'Esodo tratta della fabbricazione del tavolo
destinato a portare questo pane.
61. Emmanuel Levinas, L'aldilà del versetto, cit. alla nt. 9, pp. 94-95.
62. Id., Dall'esistenza all'esistente, cit. alla nt. 38, p. 50.
63. Ivi , p. 53.
64. Cfr. Id., Dal Sacro al Santo, cit. alla nt. 31, pp. 81-111.
65. Ivi , p. 102.
66. Azzolino Chiappini, Amare la Torah più di Dio, cit. alla nt. 30, p. 291.
67. «L'insonnia non ha oggetto, né soggetto, avverte Levinas: però qualcosa che ha a che fare con la coscienza vi
lavora. L'insonnia è ancora l'il y a, è la notte: ma al tempo stesso è un vegliare, forse il limite della veglia. E se
fosse questo il "risveglio"?» (Pier Aldo Rovatti, «L'insonnia», cit. alla nt. 39, p. 61).
68. Cioè un insegnamento tannaita che non è entrato nella collezione di Rabbi Yehudah Ha-Nasi (barayta significa
«esterno» in aramaico). Tutte queste baraytot daranno luogo alla Tosefta, «il complemento», che presenta lo
stesso carattere della Mishnah, ma lasciando uno spazio più ampio all'aneddoto. Ecco la barayta in questione:
«se l'angelo della morte è in città, non si deve camminare sulla via, poiché l'angelo della morte circola in mezzo
alla strada; approfittando della libertà che gli è concessa, procede pubblicamente; se la città è in pace, non si
deve camminare ai lati della via, perché, non godendo di libertà, l'angelo della morte avanza nascondendosi»
(Trattato Baba Kama 60a-60b, cfr. Emmanuel Levinas, Dal Sacro al Santo, cit. alla nt. 31, p. 152).
69. Ibid.
70. Emmanuel Levinas, L'aldilà del versetto, cit. alla nt. 9, p. 95.
71. In una lezione talmudica del 1988, a sfondo prettamente politico, Levinas esplicita questo concetto per definire
propriamente il buon governo. Egli scrive, infatti, che un «ordine politico accettabile può instaurarsi tra gli
uomini solo se fondato sulla Torah, la sua giustizia, i suoi giudici, i suoi maestri sapienti. Politica messianica.
Attesa, attenzione estrema e storia come veglia» (Emmanuel Levinas, Nuove letture talmudiche, cit. alla nt. 59,
pp. 64-65).
72. Emmanuel Levinas, L'aldilà del versetto, cit. alla nt. 9, p. 100. Cfr. anche Emmanuel Levinas, Altrimenti che
essere, cit. alla nt. 49, p. 141: «più io ritorno a Me, più mi spoglio [...] della mia libertà di soggetto costituito,
volontario, imperialista, più mi scopro responsabile; più sono giusto, più sono colpevole» (corsivo mio).
73. «Il segreto della vita di Israele, il segreto della sua coscienza del "sempre": il "non dormire", come il Guardiano
stesso di Israele "che non dorme e non sonnecchia" [Sal 120, 4]» (Emmanuel Levinas, L'aldilà del versetto, cit.
alla nt. 9, pp. 95-96).
74. Emmanuel Levinas, Nell'ora delle nazioni, cit. alla nt. 24, p. 98.
75. Cfr. Emmanuel Levinas, Dal Sacro al Santo, cit. alla nt. 31, pp. 59-80.
76. Cfr. Emmanuel Levinas, Difficile libertà, cit. alla nt. 46, 83-124.
77. Emmanuel Levinas, Dal Sacro al Santo, cit. alla nt. 31, pp. 68-69.
78. Ivi , p. 69.
79. Ivi , p. 80.
80. Per il tema del messianismo di Levinas, cfr. Azzolino Chiappini, Amare la Torah più di Dio, cit. alla nt. 30, cap.
VI.
81. Su tutte sicuramente si può pensare alla vicenda di Gesù di Nazaret. Ma anche a quella di Sabbataï Tsevi,
fondatore del sabbatianismo, che mise a dura prova l'ebraismo del XVII secolo. Cfr. Gershom Scholem,
Sabbatai Zwi. Der mystische Messias, ed. it. a cura di Milka Ventura, Sabbetay Sevi. Il messia mistico (16261676), Einaudi, Torino 2001.
82. Cfr. G. Scholem, Zum Verständnis der messianischen Idee im Judentum, tr. it. di Michele Bertaggia, Per la
comprensione dell'idea messianica nell'ebraismo in Gershom Scholem, Concetti fondamentali dell'ebraismo,
Marietti, Genova 1986.
83. Questa definizione di «razionalista» non sembra piacere molto a Levinas, che in una nota alle lezioni talmudiche
sui testi messianici scrive: «tuttavia non tutto è stato detto - come talvolta sembra credere Scholem - quando si
afferma il carattere razionalista di questo messianismo. Come se la razionalizzazione significasse solo la
negazione del meraviglioso e come se, nel dominio dello spirito, fosse possibile lasciare valori contestabili senza
influire su altri valori» (Emmanuel Levinas, Difficile libertà, cit. alla nt. 46, pp. 83-84, n. 1).
84. «Il modo in cui leggo il testo talmudico (modo che non ho certo inventato e che mi è stato insegnato da un
maestro prestigioso [Chouchani]) consiste nel non donare mai al termine "Israele" un senso solo etnico. Quando
si dice che Israele è degno di qualcosa di più grande del messianismo non si tratta solo dell'Israele storico. Non è
dal fatto di essere Israele che si definisce il qualcosa di meglio, ma è partire dal qualcosa di meglio - la dignità di
essere liberato da Dio stesso - che si definisce Israele. La nozione d'Israele designa sicuramente un'élite, ma
un'élite aperta che si definisce a partire da proprietà che sono concretamente attribuite al popolo ebraico.
Questo amplia tutte le prospettive che si aprono sui testi talmudici e ci sbarazza, una volta per tutte, del
carattere strettamente nazionalista che si vorrebbe dare al particolarismo di Israele. Questo particolarismo
esiste [...] ma non possiede in nessun modo un senso nazionalista. Una certa nozione di universalità si esprime
nel particolarismo ebraico» (Ivi, pp. 109-110).
85. Ivi , p. 111. Non si può non rilevare la prossimità con il pensiero di Franz Rosenzweig, che individua
precisamente nella concezione del «tempo»" la principale differenza tra ebraismo e cristianesimo: mentre per i
cristiani, con l'avvento di Cristo l'eternità ha fatto il suo ingresso nel tempo, nel mondo ebraico il tempo è
precisamente questa eternità. «Per lui [il popolo ebraico] la sua temporalità, il fatto che gli anni si ripetano, vale
solo come un attendere, tutt'al più come un peregrinare, ma mai come una crescita. Crescita significherebbe che
per lui nel tempo il compimento rimarrebbe ancora da raggiungere e sarebbe quindi una negazione della sua
eternità. Poiché l'eternità è proprio questo, che tra l'istante presente ed il compimento non c'è tempo alcuno che
possa pretendere di avere posto perché nell'"oggi" è già afferrabile tutto il futuro» (Franz Rosenzweig, Der
Stern der Erlösung, ed. it. a cura di Gianfranco Bonola, La stella della redenzione, Vita e Pensiero, Milano
2005, p. 337).
86. Emmanuel Levinas, Difficile libertà, cit. alla nt. 46, p. 115.
87. Francesco Camera, introd. di Emmanuel Levinas, Il messianismo, Morcelliana, Brescia 2002, p. 40-41.
88. Emmanuel Levinas, Difficile libertà, cit. alla nt. 46, pp. 116-117.
89. Id., Ethique et Infini. Dialogues avec Philippe Nemo, trad. it. e cura di Franco Riva, Etica e Infinito. Dialoghi
con Philippe Nemo, Troina 2008, p. 108, corsivo mio.
90. Per i Carnets, la stesura va dal 1937 al 1950. Per le Notes, si può pensare con discreta certezza che siano state
composte nel decennio tra il 1950 e il 1960. Cfr. Emmanuel Levinas, Cahiers de captivité et autres inédits, . alla
nt. 11.
91. Emmanuel Levinas, «L'inspiration religieuse de l'Alliance», Paix et Droit, 8 (1935), p. 4.
92. Emmanuel Levinas, Cahiers de captivité et autres inédits, cit. alla nt. 11, p. 75. J. senza dubbio sta per
Juda?sme.
93. Ivi , p. 231.
94. Cfr. David Banon, «Levinas, penseur juif ou juif qui pense», Dialegesthai. Rivista telematica di filosofia [in
linea], 11 (2009), messo in linea il 5 luglio 2009. url: http://mondodomani.org/dialegesthai/dba01.htm
Simon Francesco Di Rupo
Il caso Sloterdijk. Il terzo incomodo
fra Beaufret e Heidegger sul problema
dell'umanismo
Come ridare un senso alla parola «umanismo»? Come salvare l'elemento di avventura che
comporta ogni ricerca, senza fare della filosofia una semplice avventuriera?
-- Jean Beaufret, lettera ad Heidegger, 10 novembre 1946
Lei mi chiede: comment redonner un sens au mot «Humanisme»? La domanda nasce
dall'intenzione di mantere la parola «umanismo». Io mi chiedo se ciò sia necessario. O non è
ancora abbastanza evidente il male che recano tutte le denominazioni di questo genere? Certo, già
da molto tempo si diffida degli «ismi». Ma il mercato dell'opinione pubblica ne richiede sempre di
nuovi.
-- Martin Heidegger, Lettera sull'umanismo
1. Sloterdijk oltre Beaufret e Heidegger con le parole di Zarathustra
La contemporaneità, per ciò che riguarda lo sguardo della filosofia, rappresenta sempre un
orizzonte inesauribile e sfuggente insieme, una stella polare di fronte alla quale ogni sapere è
destinato a fare i conti.
Nell'epoca del cosiddetto «post-moderno» questo orizzonte della contemporaneità si è opacizzato e
sgretolato via via fino a profilarsi come scenario -- o meglio come serie di scenari -- piuttosto che
come panorama nella sua precisa accezione di visione-del-tutto (pan-orào). La costante attuale
delle filosofie della storia consiste proprio nel congedo da impostazioni speculative tese
all'onnicomprensività: sparito il pan-logismo (Hegel), è sparito con esso il pan-orama.
Una frammentarietà di questo tipo ha da una parte modificato sostanzialmente il piano di lettura
della storia come narrazione e teleologia per introdursi in un piano di depotenziamento del primato
ontologico; da un'altra ha garantito una libertà di movimento all'interno del pensiero, con il
proposito di indagare genealogicamente un concetto -- fosse anche quello di «storia» -- anziché
prenderlo come presupposto in una sistematica lettura teoretica con pretese di coerenza logica
universale.
Un quadro di queste tinte è quello notoriamente costituito dalla comparsa della filosofia di
Nietzsche. La sua eredità è ben lontana dall'essere sopita e, un esempio particolare nell'ottica della
attuale filosofia della storia, lo incontriamo nella figura di Peter Sloterdijk (Karlsruhe 1947), di cui
in questa sede si prende in considerazione Regole per il parco umano, controversa relazione del
settembre 1999 ora contenuta in Non siamo ancora stati salvati. Saggi dopo Heidegger.1
Sloterdijk colleziona in questo libro una serie di saggi che hanno sì come perno le riflessioni di
Heidegger, ma, come suggerisce il sottotitolo, si tratta di saggi dopo Heidegger e non su Heidegger:
caratteristica che introduce all'intenzione dell'autore di superare il piano meditativo heideggeriano
a favore di uno sguardo più spiccatamente antropologico, come ora vedremo. Il sottotitolo di
Regole per il parco umano, invece, è emblematicamente Una risposta alla «lettera
sull'umanismo» di Heidegger, il che balza direttamente all'occhio come una sorta di presa di
posizione da «terzo incomodo» rispetto allo scambio epistolare fra Beaufret e Heidegger cui
sinteticamente ci si riferiva nelle citazioni in esergo. Ma andiamo per gradi: si accennava al debito
nietzscheano, e ci si riferiva più precisamente alla centralità data dallo stesso Sloterdijk alle parole
dello Zarathustra de La virtù che rende meschini, delle quali le più altisonanti sono:
Io passo in mezzo a questa gente e tengo gli occhi aperti: costoro son diventati più piccoli e
diventano sempre più piccoli; -- ma in ciò consiste la loro dottrina sulla felicità è la virtù. [...]
Alcuni di loro vogliono, ma i più sono soltanto voluti [...] Virtù è per loro ciò che rende modesti e
mansueti: a questo modo trasformarono il lupo in cane, e l'uomo stesso nel miglior animale
domestico dell'uomo.2
È sulla scorta di questa illustre citazione che Sloterdijk fonda il nucleo della sua interrogazione
circa l'umanismo. Assumendo la prospettiva di Nietzsche, il nostro filosofo solleva la questione se
l'umanismo, di fondo, non sia sempre stato il nome dato alla storia di un addomesticamento e
allevamento dell'uomo, per cui questi uomini «soltanto voluti» siano l'effetto di un
rimpicciolimento rappresentato da «un rapporto necessario tra leggere, stare seduto e
tranquillizzarsi».3 Ma non bisogna inquadrare questa riflessione come una denuncia pseudomarxista che ravvisi una sorta di sopruso strutturale nelle forme pedagogiche della società, né
quindi, in un'ottica per cui l'umanismo sia un «oppio per i popoli», i quali devono
programmaticamente emanciparsi, magari assumendo un programma politico che Sloterdijk profili
nella sua filosofia. Nulla di tutto questo. Infatti, leggendo Non siamo ancora stati salvati, non
troveremo mai particolari proposte, bensì complesse (e a volte oscure) prese di visione di un
crocevia della storia dell'uomo fra una umanità allevata in una maniera e un'umanità che si alleverà
diversamente in un futuro non troppo lontano. Questo tono fatale delle pagine di Sloterdijk
rispecchia la fortuna e al tempo stesso la sfortuna dei concetti da lui tirati in ballo, nella misura in
cui prestano il fianco a facili entusiasmi, fraintendimenti come aspre critiche.4
È così infatti che, paradossalmente, mentre Sloterdijk dichiara di volersi allontanare da quello che
considera un eccesso di «meditazione pastorale» di Heidegger, cita con non poca devozione un
passo di Nietzsche che non primeggia certo per una teoresi cartesianamente «chiara e distinta»,
sebbene anzi proprio di «discorso teoretico sull'uomo» Sloterdijk parli descrivendo a margine la
sua citazione. Paradosso che lascerebbe l'idea per cui il nostro filosofo non sia che un nietzscheano
nutrito da interessi di pedagogia negativa e distopia, ravvisabili là dove dice: «inizia ad albeggiare
l'orizzonte dell'evoluzione, anche se in modo ancora confuso e inquietante»5, punto che fa chiosa
proprio al debito che Sloterdijk riconosce nei confronti di Nietzsche, 6 ovvero quella lucidità con cui
questi ha rifiutato quella «falsa ingenuità di cui si circonda l'uomo buono della modernità»,7 per
effetto di un sospetto verso ogni cultura umanistica, che altro non sarebbe che il velo della
domesticazione dell'umanità. Nietzsche delimita così lo spazio in cui si giocherà la partita (se non
si sta già giocando ora) fra gli allevatori dell'uomo piccolo della tradizione e gli allevatori dell'uomo
potenziato. L'intelligenza di Sloterdijk qui sta nel non identificare il secondo modello con una
proposta di Zarathustra, bensì attribuendo alla parola di quest'ultimo un valore mediano (e forse
ben più rilevante!) di intuizione dello spazio stesso fra le due modalità di allevamento; del resto egli
stesso non si pronuncia espressamente a favore del secondo modello, preferendo piuttosto
sottolineare l'importanza del pensiero pericoloso che è proprio di quella intuizione nei confronti
della storia che legittima gli enigmi di filosofi come Heidegger, Nietzsche e per finire, potremmo
dire, anche come Sloterdijk stesso.8
2. «Duemilacinquecento anni di effetto-Platone»
Ma è proprio qui che tutto parrebbe consegnare il discorso sloterdijkiano ad una fin troppo
semplice figura di epigono del percorso Nietzsche-Heidegger che ha introdotto il '900, che lo
scritto del 1999 fa sentire tutto il peso di un secolo in più di tumulti filosofici e di problematiche
umanistiche, non ultima quella della tecnica.
Il tempo di prendere la rincorsa con un originale e curioso riferimento all'antico Platone ed ecco
che Sloterdijk ci catapulta nel cuore del bivio della nostra epoca di confusione sulla natura
dell'uomo e nel cuore del suo «pensiero pericoloso», il quale, con il concetto di umanità come
parco umano, vede Platone stesso come primo antropotecnico. Questa che a prima visione pare
una provocazione forzata, ha invece per Sloterdijk una sua profonda legittimità dal momento in cui
il Politikòs di Platone9 non è «significativo solo perché mostra, in modo più chiaro di altri, ciò che
l'antichità intendeva realmente per pensiero [...] La portata incommensurabile di questo scritto e
il suo posto nella storia del pensiero sull'uomo, consistono innanzitutto nel fatto che il testo si
sviluppa come un colloquio di lavoro tra allevatori».10 Qui Sloterdijk si riferisce al dialogo fra lo
straniero e il giovane Socrate, ritenendolo fortemente elitario e con scopi manovrieri nei confronti
della società, poiché essi «parlano della comunità umana come di un giardino zoologico»,11 forti
di una considerazione dell'uomo sotto l'ottica della sua animalità da controllare, ma nei limiti
imposti dalla caratteristica cooriginaria proprio all'animalità: la naturale tendenza a produrre un
effetto parco; ovunque essi vivano «gli uomini devono farsi un'opinione sulle regole della
conduzione di sé»12, e il parere a riguardo dei due dialoganti sfocia nella tesi per cui l'allevatore
(per usare il vocabolario di Sloterdijk) deve essere non solo di grado superiore, ma di specie
superiore. La critica al sofista, infatti, avviene dal momento in cui si ritiene mendace e affabulatore
il suo pretendere parità con «il gregge» per ottenere il consenso, mentre l'onestà dell'allevatore
platonico starebbe nel considerarsi differente e «farebbe capire discretamente che lui, poiché
agisce con saggezza, è più vicino agli dèi di quei confusi esseri viventi che custodisce».13 Il
paradosso per il bene dell'umanità consisterebbe quindi, per l'interpretazione che Sloterdijk ha di
Platone, nel fatto che l'allevatore si pone su un piano di differenza antropologica -- se non
addirittura ontologica.
Per il lettore che oggi guarda indietro ai ginnasi umanistici dell'epoca borghese e all'eugenetica
nazista e contemporaneamente getta già uno sguardo verso l'epoca biotecnologica, è impossibile
misconoscere l'esplosività di queste riflessioni.14
Qui Sloterdijk si rivolge al lettore, ma senza particolari intoppi siamo disposti a credere che parli
anche per sé stesso. In questa constatazione a metà fra il diaristico e il colloquiale, la possibilità che
l'uomo sia da sempre solo l'effetto di una regolamentazione di un parco colpisce l'autore stesso che
ne parla, con l'enfasi tipica di una tragedia:
Dopo duemilacinquecento anni di effetto Platone, ora sembra che non solo gli dèi, ma anche i saggi
si siano ritirati, e che ci abbiano lasciati soli, con la nostra sconsideratezza e le nostre mezze
conoscenze su tutto.15
Il tono nichilistico che qui l'autore adotta è confidenziale, vicino alle preoccupazioni dei nostri
tempi. In una parola: umano. La freddezza impersonale con cui pronuncia il suo pensiero
pericoloso sulla storia dell'uomo come storia della domesticazione (come quello di Nietzsche e di
Platone), accompagnata proprio da questa sensibilità più preoccupata che preoccupante, tardano e
fondamentalmente ridimensionano l'idea che potremmo farci di uno Sloterdijk post-umanista;
definizione generalmente associatagli su cui il presente lavoro vuole ragionare con il beneficio del
dubbio.
3. Il bivio del cupio dissolvi
A dieci anni di distanza dalla stesura del testo Regole per il parco umano, oggi, disponiamo della
possibilità di ridiscutere i termini in cui si svolgono le sue tematiche al di fuori delle prime reazioni
che all'epoca suscitò, fra riverberi mediatici enfatizzanti e demonizzazioni di rimbalzo. Ma oltre al
privilegio storiografico del tempo che passa e rende più tiepido qualsiasi scandalo, a soccorrere il
tentativo di obiettività del nostro lavoro è proprio la struttura del testo Non siamo ancora stati
salvati. Saggi dopo Heidegger,16 il quale, con una forma appunto piuttosto heideggeriana,
presenta una collezione di saggi con una successione non arbitraria. Non a caso infatti, in
un'operazione che voglia meglio contestualizzare il saggio cui ci si sta maggiormente riferendo, si
può fare cenno a due passaggi chiave dell'intero volume, uno precedente a Regole per il parco
umano e uno successivo, due passaggi in cui il pensiero sulla storia attuale appare ben più definito,
o forse più complesso rispetto alla semplice storia della domesticazione sin qui accennata.
Nel capitolo L'ora del crimine del mostruoso la storia dell'uomo viene vista in un'ottica per cui lo
stato attuale è lo stato del superamento della modernità tramite la «globalizzazione come
produzione del presente permanente sulla Terra»,17 idea per cui Sloterdijk ritiene doveroso
precisare (come largamente fa il pensiero pos-moderno) che il pensiero contemporaneo sulla storia
attuale deve staccarsi dalle strutture delle filosofie della storia tradizionale, sottolineando che gli
uomini «non vogliono fare la storia [...] ma hanno invece intenzione di concluderla»,18 come se il
leitmotiv della modernità fosse la iperproduzione di un presente da ipostatizzare all'insegna di una
autoriflessività in grado di rendere quel parco umano il luogo in cui il problema di una fine e di un
fine termini nella coincidenza dell'una con l'altro. Il crimine del mostruoso corrisponderebbe di
fatto proprio a questo -- sebbene l'ambiguità del termine tedesco ungeheuer («mostruoso»;
«enorme»; «smisurato») lasci molte porte aperte all'interpretazione.19
La condizione che però fa da specchio alla modernità sta nel bivio di fronte al quale la strada per
l'epoca successiva presenta due vie: verso la catastrofe o verso la continuità. Sotto la prima vanno
incluse le forme tradizionali dell'apocalisse delle epifanie teologiche al fianco dell'ipotesi di disastri
biosistemici, verso le quali Sloterdijk non nutre particolare inclinazione, liquidandole rapidamente
a favore della seconda via, in cui per «continuità» va intesa la legittimità del processo di
domesticazione e allevamento dell'uomo secondo il prospetto cui si riferisce Regole per il parco
umano. Ma a soccorrerci per meglio inquadrare questa prospettiva, imponente quanto poco chiara
(e poco chiarita) dobbiamo fare riferimento, come sopra annunciato, a un capitolo precedente,
ossia Aletheia o la miccia della verità, in cui si comprende come il passaggio alla «continuità» viva
nel momento attuale una stagione di stallo, per cui «l'uomo è legato oggi alla sua immagine di
fabbricatore che non sa convincere sul banco degli imputati e deve ascoltare le requisitorie dei
pubblici ministeri, che gli imputano la sua hybris, la sua sopravvalutazione di sé [...] la sua
semicompetenza semicriminale nella presa di potere tecnologico sulla Terra».20 Questa
«diffidenza» del mondo attuale nei confronti delle proprie potenzialità creative non deve però
essere considerata come una categoria psicologica, ma come il clima della nostra epoca
contrassegnata da una secolarizzazione che ha congedato le forme tradizionali di definizione della
trascendenza per inaugurare il primato della tecnica.21 La creatività totalmente spoglia da
inibizioni storiche ha i suoi tempi. Anche qui le parole di Zarathustra tornano curiosamente vicine,
quando in Sulle Isole Beate egli sostiene che non può esservi dio altrimenti non sarebbe possibile
creare.22
Ma la cosa più curiosa pare piuttosto essere l'evenienza a partire dalla quale l'uomo si
risveglierebbe dal torpore umanista per poter creare -- con la tecnica -- senza più riserve:
Il lato della natura naturans, attraverso un sapere tecnico creativo, diventerà più virulento che mai
sotto la pressione di un disastro ecologico o demografico incombente [...] L'accusata volontà di
potenza sarà citata nelle prossime sessioni processuali in qualità di soccorritrice nella miseria [...]
L'experimentum mundi potrebbe ancora riuscire, come sempre in modo temporaneo e regionale,
solo se il nostro calendario si lacerasse per far apparire una verità finora latente.23
La curiosità di questa evenienza non sta nel tono profetico discutibile o meno che si voglia, quanto
piuttosto, ad un occhio più acuto, nel fatto che in un altro momento (sopra citato) Sloterdijk ponga
un bivio fra la possibilità di una catastrofe o la via della «continuazione», mentre in questa sede
egli fa coincidere i due momenti come necessariamente richiamati. Questa, è lecito dirlo, è una
incoerenza che non permette al nostro filosofo di comunicarci un pensiero esatto su questo bivio. Il
tono profetico riesce così addirittura a non esserlo abbastanza. Nel frattempo, però, poco sotto a
questo intoppo, l'intelligenza di Sloterdijk nel porsi fuori da una pericolosa adesione si manifesta in
lucide parole:
Nel suo infausto colloquio con lo Spiegel Heidegger aveva detto: «Ormani solo un dio ci può
salvare». Dopo tutto ciò che oggi sappiamo, la parola dio dovrebbe essere sostituita
dall'espressione «la capacità di creare nature». Ma questa espressione suona così entusiastica che
ci rende piuttosto perplessi riguardo a questo oracolo di Heidegger. Perché essa acquisisca un
senso praticabile, bisognerebbe allora ritradurla in un'espressione come «la capacità di cooperare
con le nature». La cooperazione presuppone avvedutezza e relativizzazione di sé rispetto all'altro.
[...] La società mondiale sarà una società dell'avvedutezza o non ci sarà affatto.24
È incredibilmente densa questa pagina di Sloterdijk in cui dalla prospettiva di un experimentum
mundi fondamentalmente inevitabile si passa a un responsabile richiamo a una forma di
«avvedutezza» e «relativizzazione di sé». Il rischio di una società mondiale che non ci sia affatto è
in Sloterdijk motivo di suggestione alla pari con le potenzialità della creatività umana. Questo
peculiare cupio dissolvi, questa paradossalità può essere vista come insufficienza teoretica, ma allo
stesso tempo ci offre un ritratto esistenziale del pensatore del «mostruoso» che ha ben poco di
post-umano. Le incoerenze sono ancora umane e la bellezza di uno stupore e di una meraviglia di
un uomo -- come dell'uomo in generale -- di fronte all'inesplorabilità totale del reale, negativo o
positivo che sia, sono qualcosa di simile alle parole di San Paolo nella Lettera ai Filippesi, 1, 23-24:
Sono messo alle strette tra due scelte: il desiderio di morire (cupio dissolvi) ed essere con Cristo
[...] ma d'altra parte è più necessario, per voi, che resti nella carne.
4. Sloterdijk umano troppo umano
Il problema che ora si pone, alla luce di queste incoerenze, sta nell'inquadrare quale tipo di
contributo Sloterdijk ci consegna nel pensiero contemporaneo sui problemi che la tecnica ci
sottopone. Si è visto finora, fra le considerazioni a margine di tratti salienti e le riflessioni
nell'apparato di note, come l'idea di uno Sloterdijk totalmente post-umanista debba essere
affrontata con cautela. La tiepidezza malinconica delle conclusioni cui volgono i capitoli di Non
siamo ancora stati salvati, così come la puntualità con cui Sloterdijk si sottrae a un'adesione
all'eugenetica o ad approfondimenti più curati nei punti più cocenti sono ancora elementi troppo
poco consistenti per poter parlare di apologia dell'eugenetica o di un manifesto del postumanesimo.
Si prendano due esempi molto chiari: il primo riguarda la mancanza di una fondazione chiara del
concetto di abbrutimento: cosa intende Sloterdijk quando dice: «chi oggi si interroga sul futuro
dell'umanità e dei media umanizzanti, vuole in fondo sapere se c'è una speranza di
padroneggiare le attuali tendenze all'imbarbarimento dell'uomo»?25 Altrove egli dice
giustamente: «L'umanista stesso dovrebbe perdersi almeno una volta nella folla schiamazzante,
solo per chiarire che anche lui è un uomo e che perciò può venire contagiato dall'abbrutimento
[...] il senso di questi media risiede nel disintossicarsi dalla propria possibile bestialità».26 La
valorizzazione di una filosofia en plein air come quella cui si riferiva Günther Anders è
apprezzabile, ma allo Sloterdijk (a cui peraltro manca la biografia «in mezzo alla folla» dinamica e
ispirata di Anders) manca tutta la cura con cui Anders tratta del passaggio da homo faber a homo
materia27 per concentrarsi esclusivamente sulle noie e gli scrupoli di un ideale homo faber, salvo
sporadici cenni a pericoli che invece meritano il beneficio di riflessioni di più ampio respiro: il
cupio dissolvi, altrimenti, risulta essere un fragile esercizio di immobilità speculativa.
Questo non gli permette, di fatto, di poter ragionare a fondo su cosa sia l'abbrutimento, e
soprattutto su cosa questo sia diventato, il che lo pone in una posizione intermedia fra umanismo e
post-umanismo che può condizionare ben poco nella nostra presente considerazione sulla
condizione dell'uomo o su ciò che dovrebbe essere la sua condizione futura: dopotutto,
l'abbrutimento, proprio perché pericolo incessante, è una forma suscettibile di presentarsi sotto
diverse forme nella storia, e non è, come Sloterdijk vorrebbe presentarci, una baratro sempre
identico per ogni uomo male allevato. In questo il nostro pensatore dimostra di non avere una
psicologia molto diversa dal discorso fra lo straniero e il giovane Socrate cui si richiama alla fine di
Regole per il parco umano.
Il secondo esempio di incoerenza di Sloterdijk risiede nella mancata costruzione di un pensiero
eticamente direzionato a supplire ai pericoli della nostra epoca: si ricordi esemplarmente il
richiamo ad un pericolo di una società inesistente senza «avvedutezza». Il pensatore tedesco mette
in tavola, sapientemente, tutte le carte su cui può giocarsi la validità di un intervento atto a
modificare il modello di «allevamento» dell'uomo futuro, salvo poi, però, ritirare la mano quando
con profonda coscienza umanista, sottolinea la necessità di una forma cautelare nei confronti della
cooperazione fra le nature, senza tuttavia fare alcun cenno su quale sia una minima occasione di
supporto a questa cautela, quale sia l'indirizzo che questa cautela debba prendere: il saggio di cui ci
si sta occupando è intitolato Regole per il parco umano, ma di regole o indirizzi etici non si parla
mai. I detrattori moralmente condizionati si sono concentrati fin troppo su questo titolo, ma a ben
guardare i contenuti del saggio, il grande difetto di Sloterdijk sta proprio nel non essersi
pronunciato fino in fondo in materia, lasciando così alla superficie i gradimenti come piuttosto le
malevolenze dei lettori con più voce in capitolo. Leggere Sloterdijk accompagnato da Jonas, Apel,
Gadamer, Anders, Mumford, Ratzinger, Severino, a questo punto, è il proposito migliore per lo
studioso della nostra epoca e dei risvolti tirati in ballo in questa sede; se non altro il contributo di
questo particolare filosofo può estendersi ad una forma di «allievo del sospetto» (per clonare il
modo in cui Ricoeur si riferisce a Marx, Nietzsche e Freud) da confrontare con i «maestri dello
sguardo», per così dire, che si è appena elencati.
In ultima analisi l'idea conclusiva con cui si può considerare il pur coraggioso lavoro di Sloterdijk
nel rimettere in ballo concetti heideggeriani e nietzscheani è che il nuovo regime post-epistolare e
post-umanistico che il pensatore tedesco dichiara essere la tratta della trasmissione del sapere
attuale, non è né cominciato né continuato con il suo contributo, ancora (comprensibilmente!)
legato ad una forma di trasmissione letteraria, ad una logica spettatoriale nei confronti dei
cambiamenti della storia e a inquietudini sane e non fraintendibili sui pericoli cui la nostra natura
umana è rivolta, che siano per mano nostra o per mano di un destino enigmatico -- verso il quale
l'umanismo e le sue mille, continue forme ancora hanno molto da indagare.
Note
1.
P. Sloterdijk, Non siamo ancora stati salvati. Saggi dopo Heidegger (trad. it. Anna Calligaris e Stefano
Crosara), Milano 2004, Bompiani.
2.
F.W. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, in Opere, Adelphi, Milano, 1964 sgg., vol.VI, t.I, pp. 203-206.
3.
P. Sloterdijk, Non siamo ancora stati salvati. Saggi dopo Heidegger (trad. it. Anna Calligaris e Stefano
Crosara), Milano 2004, Bompiani, p. 256.
4.
Critica inaugurata da accuse formulate da Reinhard Mohr né Der Philosoph Peter Sloterdijk propagiert
«pränatale Selektion» und «optionale Geburt»: Gentechnik als angewandte Gesellschaftskritik. Seine jüngste
Rede über «Menschenzucht» trägt Züge faschistischer Rhetorik, «Der Spiegel», 6 giugno 1999, in cui si ritiene
la tematizzazione di Sloterdijk al livello di una «visione di orrore fascista». Disputa notoriamente proseguita fra
Sloterdijk e Habermas sul piano mediatico a furia di frecciate sulla reciproca antipatia professionale e non. Si
noti esemplarmente l'implicito riferimento a Sloterdijk in J.Habermas, Il futuro della natura umana, Torino,
Einaudi 2002, pp. 24-25: ««un pugno di intellettuali psichicamente crollati [che] cerca di leggere il futuro nei
fondi di caffè di un «post-umanesimo» naturalisticamente declinato [...] Le fantasie nietzschiane di questi
auto-promotori per il momento servono soltanto a soddisfare spettacoli mass-mediatici». L'idea che a dieci
anni di distanza ci possiamo fare su questa disputa è che proprio il processo mass-mediatico di questo affaire
Sloterdijk abbia imploso, come accade per ogni disputa mediatica, la sua importanza limitatamente al periodo in
cui è nata. D'altro canto, porre la questione su un piano storiografico di critica filosofica a riguardo, ora,
significherebbe creare senza alcuna legittimità una differenziazione fra i due pensatori su una base arbitraria, o
nel migliore dei casi, parziale. In questa sede si ritiene perciò valido considerare il contributo del pensiero di
Sloterdijk isolatamente da ogni nemesi forzata con altri pensieri e da circoscriversi alla posizione che incarna
sullo sfondo del discorso sull'umanismo di Heidegger, nella consapevolezza, peraltro, che un serio confronto con
Habermas meriti approfondimenti che questo studio non può né vuole soddisfare.
5.
P. Sloterdijk, Non siamo ancora stati salvati. Saggi dopo Heidegger (trad. it. Anna Calligaris e Stefano
Crosara), Milano 2004, Bompiani, p. 260.
6.
«Chi ha abbastanza fiato per rappresentarsi un'epoca in cui Nietzsche sarà storicizzato così come lo era
Platone per Nietzsche?», Ibidem.
7.
Ivi, p. 257.
8.
Questo punto potrebbe, insieme ad altri, scagionare da accuse estremiste di «fascismo» nei confronti del nostro
autore, il quale va piuttosto giudicato per debolezze filosofiche all'interno del suo discorso, anziché per i risvolti
dottrinali che potrebbe avere e che, onestamente, non pare proprio avere nemmeno come presupposti e
tantomeno come interessi. In questo senso, il «pensiero pericoloso» non lo è per quanto possa portare a fare,
ma per quanto esso stesso disfaccia all'interno di metodologie tradizionali nella considerazione della storia da
parte dei filosofi. Anche la filosofia ha i suoi panni sporchi da lavare in famiglia. Potremmo osare dicendo che
questa sia abbastanza una costante nel pensiero del post-moderno, della post-histoire, le quali, coerenti con il
loro percorso di «pensieri deboli», non vanno di molto oltre al pensiero stesso.
9.
Platone, Politico, trad. di A. Zadro, in Opere complete, Laterza, Bari 1982. Le parti a cui Sloterdijk fa maggiore
riferimento sono situate nel vol.II, 265b-c, pp. 267-268.
10. P. Sloterdijk, Non siamo ancora stati salvati. Saggi dopo Heidegger (trad. it. Anna Calligaris e Stefano
Crosara), Milano 2004, Bompiani, p. 261.
11. Ibidem.
12. Ivi, p. 262.
13. Ibidem.
14. Ivi, p. 265.
15. Ibidem.
16. Titolo originale Nicht gerettet. Versuche nach Heidegger, Suhrkamp, Franfurt am Main, 2001, tradotto e
pubblicato in italiano nella edizione finora citata di Bompiani del 2004.
17. P. Sloterdijk, Non siamo ancora stati salvati. Saggi dopo Heidegger (trad. it. Anna Calligaris e Stefano
Crosara), Milano 2004, Bompiani, p. 303.
18. Ibidem. Per una precisa collocazione di queste tematiche post-metafisiche sulla fine della storia si veda
l'eccellente studio A. Rizzacasa, L'eclisse del tempo. Il fine e «la fine» della storia, Città Nuova, Roma 2001.
19. L'idea che ci si fa a riguardo è che il termine «mostruoso» crei più difficoltà di quante ne possa scansare. La
traduzione con «smisurato» o «enorme», invece, ci suggerisce uno spazio di interpretazione ben più aperto,
dove quest'enormità e smisuratezza giustifica ancora il beneficio del dubbio se la produzione umana o il suo
destino al di là della volontà siano di fatto prospettive imprigionabili dalla nostra attuale comprensione, e se
quindi ciò non lasci qualche spiraglio alla nostra prudenza, che con un sano scetticismo può essere l'unico
baluardo per non abbracciare troppo frettolosamente dottrine sul post-umano come piuttosto dottrine di fede
tradizionali per absurdum.
20. P. Sloterdijk, Non siamo ancora stati salvati. Saggi dopo Heidegger (trad. it. Anna Calligaris e Stefano
Crosara), Milano 2004, Bompiani, p. 237.
21. Cfr. E. Severino, Essenza del nichilismo, Adelphi, Milano 1982.
22. Cfr. F.W. Nietzsche, Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno, Adelphi, Milano 1976, pp. 9496.«Dio è una supposizione; ma io voglio che il vostro supporre non si spinga oltre i confini della vostra
volontà creatrice [...] Dio è un pensiero che rende storte tutte le cose dritte e fa girare tutto quanto è fermo».
Rimane da osservare come certi collegamenti vadano fatti con grande cautela, un secolo dopo sufficienti
strumentalizzazioni del pensiero di Nietzsche da tiranni, eugenetisti o detrattori. Nietzsche deve rimanere, nella
nostra considerazione, la più alta forma di lettura del crocevia della nostra storia, e non come una scrittura di
questa. Un mondo che congeda i suoi dèi con sbalorditiva unitarietà non può essere responsabilità di uno scritto
o di un (seppur grandissimo) pensatore. Vorrebbe dire che l'umanismo come sistema di diffusione del sapere e
«allevamento» funziona definitivamente; e ciò paradossalmente stride, a proposito, con l'idea proprio di
Sloterdijk per cui l'umanismo come scambio epistolare del sapere sia finito da tempo -- e Sloterdijk fa un uso
ampio del termine «epistola» per intenderlo come l'attività di comunicazione di chi è sapiente, cfr. P. Sloterdijk,
Non siamo ancora stati salvati. Saggi dopo Heidegger (trad. it. Anna Calligaris e Stefano Crosara), Milano
2004, Bompiani, p. 243. «L'era dell'umanismo nazional-borghese è giunta a compimento perché l'arte di
scrivere lettere [...] non sarebbe più sufficiente a tenere insieme il filo tele comunicativo tra gli abitanti di una
moderna società di massa [...] questi fondamenti sono decisamente post-letterari, post-epistolari e di
conseguenza post-umanistici».Tuttavia Sloterdijk non ammette mai di essere anch'egli in pieno in questa
insufficienza.
23. P. Sloterdijk, Non siamo ancora stati salvati. Saggi dopo Heidegger (trad. it. Anna Calligaris e Stefano
Crosara), Milano 2004, Bompiani, p. 238.
24. Ibidem [corsivo mio].
25. Ivi, p. 244.
26. Ivi, p. 245.
27. G.Anders, L'uomo è antiquato. Sulla distruzione della vita nell'epoca della terza rivoluzione industriale, Bollati
Boringhieri, Torino 1992. Si veda ad esempio p. 15.