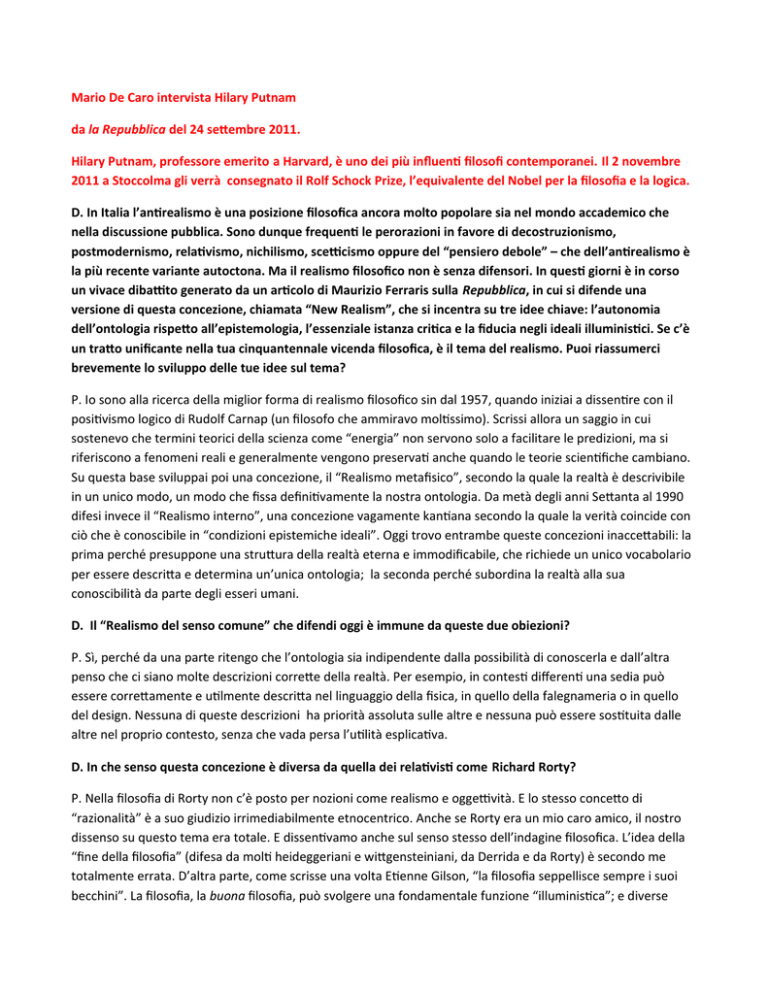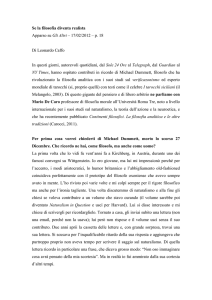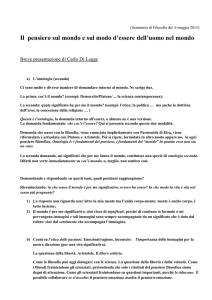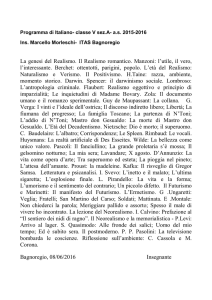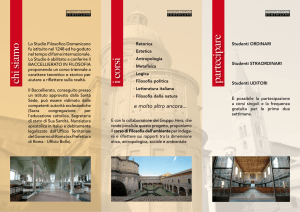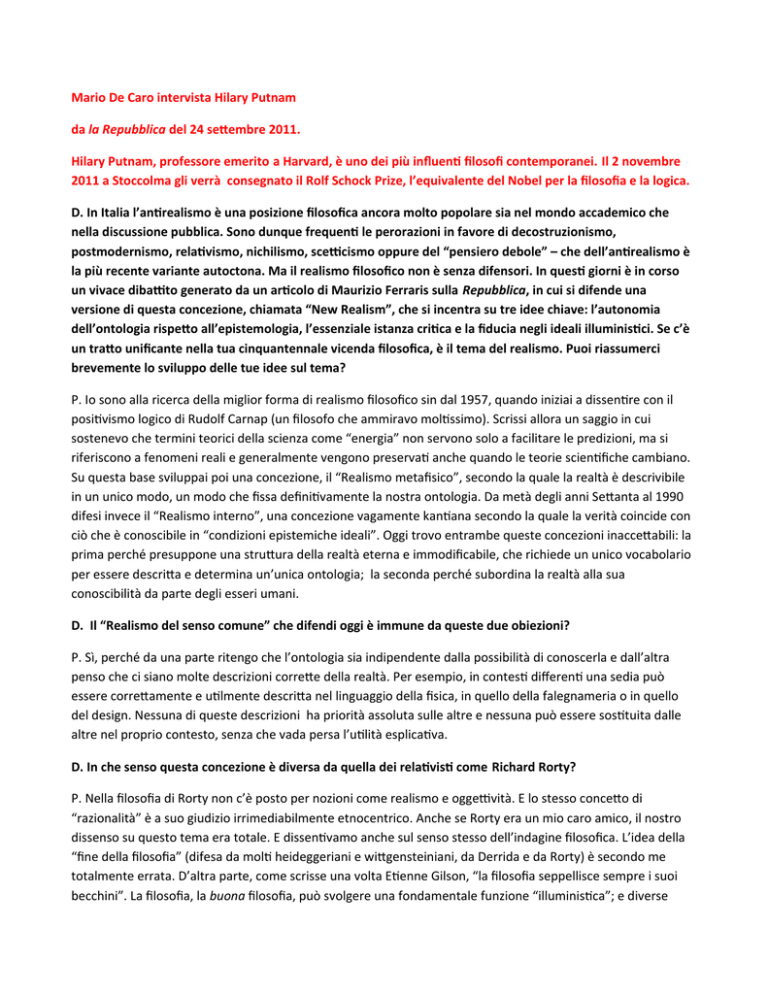
Mario De Caro intervista Hilary Putnam
da la Repubblica del 24 settembre 2011.
Hilary Putnam, professore emerito a Harvard, è uno dei più influenti filosofi contemporanei. Il 2 novembre
2011 a Stoccolma gli verrà consegnato il Rolf Schock Prize, l’equivalente del Nobel per la filosofia e la logica.
D. In Italia l’antirealismo è una posizione filosofica ancora molto popolare sia nel mondo accademico che
nella discussione pubblica. Sono dunque frequenti le perorazioni in favore di decostruzionismo,
postmodernismo, relativismo, nichilismo, scetticismo oppure del “pensiero debole” – che dell’antirealismo è
la più recente variante autoctona. Ma il realismo filosofico non è senza difensori. In questi giorni è in corso
un vivace dibattito generato da un articolo di Maurizio Ferraris sulla Repubblica, in cui si difende una
versione di questa concezione, chiamata “New Realism”, che si incentra su tre idee chiave: l’autonomia
dell’ontologia rispetto all’epistemologia, l’essenziale istanza critica e la fiducia negli ideali illuministici. Se c’è
un tratto unificante nella tua cinquantennale vicenda filosofica, è il tema del realismo. Puoi riassumerci
brevemente lo sviluppo delle tue idee sul tema?
P. Io sono alla ricerca della miglior forma di realismo filosofico sin dal 1957, quando iniziai a dissentire con il
positivismo logico di Rudolf Carnap (un filosofo che ammiravo moltissimo). Scrissi allora un saggio in cui
sostenevo che termini teorici della scienza come “energia” non servono solo a facilitare le predizioni, ma si
riferiscono a fenomeni reali e generalmente vengono preservati anche quando le teorie scientifiche cambiano.
Su questa base sviluppai poi una concezione, il “Realismo metafisico”, secondo la quale la realtà è descrivibile
in un unico modo, un modo che fissa definitivamente la nostra ontologia. Da metà degli anni Settanta al 1990
difesi invece il “Realismo interno”, una concezione vagamente kantiana secondo la quale la verità coincide con
ciò che è conoscibile in “condizioni epistemiche ideali”. Oggi trovo entrambe queste concezioni inaccettabili: la
prima perché presuppone una struttura della realtà eterna e immodificabile, che richiede un unico vocabolario
per essere descritta e determina un’unica ontologia; la seconda perché subordina la realtà alla sua
conoscibilità da parte degli esseri umani.
D. Il “Realismo del senso comune” che difendi oggi è immune da queste due obiezioni?
P. Sì, perché da una parte ritengo che l’ontologia sia indipendente dalla possibilità di conoscerla e dall’altra
penso che ci siano molte descrizioni corrette della realtà. Per esempio, in contesti differenti una sedia può
essere correttamente e utilmente descritta nel linguaggio della fisica, in quello della falegnameria o in quello
del design. Nessuna di queste descrizioni ha priorità assoluta sulle altre e nessuna può essere sostituita dalle
altre nel proprio contesto, senza che vada persa l’utilità esplicativa.
D. In che senso questa concezione è diversa da quella dei relativisti come Richard Rorty?
P. Nella filosofia di Rorty non c’è posto per nozioni come realismo e oggettività. E lo stesso concetto di
“razionalità” è a suo giudizio irrimediabilmente etnocentrico. Anche se Rorty era un mio caro amico, il nostro
dissenso su questo tema era totale. E dissentivamo anche sul senso stesso dell’indagine filosofica. L’idea della
“fine della filosofia” (difesa da molti heideggeriani e wittgensteiniani, da Derrida e da Rorty) è secondo me
totalmente errata. D’altra parte, come scrisse una volta Etienne Gilson, “la filosofia seppellisce sempre i suoi
becchini”. La filosofia, la buona filosofia, può svolgere una fondamentale funzione “illuministica”; e diverse
forme di filosofia possono svolgere questo ruolo in maniere differenti. Con le loro argomentazioni rigorose, i
filosofi analitici possono aiutarci ad evitare varie forme di irrazionalità; ma anche le riflessioni sulle modalità
della nostra esistenza e su come dovremmo vivere (le riflessioni che si trovano per esempio in Kierkegaard,
Thoreau, Emerson, Marx e Sartre) sono una componente essenziale della filosofia. In entrambi i casi la filosofia
può svolgere un’importante funzione critica e contribuire così alla nostra emancipazione.
D. Tornando alla questione del realismo, un aspetto cruciale del tuo itinerario filosofico è che hai sempre
difeso l’idea che le nostre migliori teorie scientifiche non sono solo un utile strumento per fare predizioni,
come pensano i convenzionalisti e gli strumentalisti, ma ci dicono veramente com’è fatto il mondo.
P. Ho sempre creduto che la scienza possa descrivere correttamente il mondo naturale, anche nelle sue
componenti non osservabili. Abbiamo ottime ragioni, ad esempio, per pensare che gli elettroni non siano solo
costrutti teorici ma che esistano veramente anche se non sono osservabili.
D. Questo tema è interessante, perché vasti filoni della cultura italiana – dallo spiritualismo allo storicismo,
dal materialismo dialettico al pensiero debole – hanno spesso tentato di svilire le pretese conoscitive della
scienza. Contro la tesi che la scienza non è che un complesso di utili convenzioni, tu hai presentato il famoso
“argomento del miracolo”. Puoi dirci di cosa si tratta?
P. L’idea di base è che il realismo scientifico sia l’unica visione filosofica che non rende il successo esplicativo e
predittivo della scienza un vero e proprio miracolo. Infatti, se fosse vero l’antirealismo – se cioè le entità
teoriche postulate dalle nostre migliori teorie scientifiche non esistessero – come potremmo spiegare il fatto
innegabile che queste teorie funzionano così bene, che esse ci forniscono spiegazioni e predizioni così efficaci?
Non si tratterebbe forse di una miracolosa coincidenza?
D. Un cavallo di battaglia degli antirealisti sono i fatti sociali, ovvero i fatti la cui esistenza dipende senza
dubbio dalle nostre pratiche. Gli antirealisti sostengono che i fatti sociali, essendo meri costrutti o
convenzioni, non hanno alcuna realtà indipendente e per questo non possono essere valutati
oggettivamente. Come pensi di questo ragionamento?
P. Usiamo un esempio. La storia della sessualità è un campo di studi iniziato da Foucault, a cui Arnold Davidson
ha dato contributi fondamentali studiando gli “stili di ragionamento”. In particolare, nel trattare il tema
dell’omosessualità, Davidson ha mostrato come agli inizi essa fosse trattata come una “perversione”, come un
“peccato”, senza che se ne desse alcuna interpretazione medica. Più tardi si tentò di spiegare questa presunta
perversione ipotizzando anomalie genitali. Ma quando si scoprì che i dati anatomici non confermavano questa
tesi, i medici postularono deformazioni anatomiche nel cervello. In seguito, verso la fine dell’Ottocento, queste
spiegazioni furono prima integrate e poi sostituite da teorie che trattavano l’omosessualità come un sintomo
nevrotico: e ciò diede origine a nuovi usi del concetto di omosessualità. Oggi, infine, non si parla più di malattia
ma di un fenomeno psicologico. Prima dell’epoca psichiatrica si parlava di “peccati” (come la sodomia); oggi
invece una frase come “un omosessuale può non compiere mai atti omosessuali” è diventata intelligibile. E
nessuna persona mentalmente aperta direbbe più che l’omosessualità è una malattia o il sintomo di una
malattia!
D. In Italia la cosa non è così pacifica, purtroppo! Comunque, un antirealista ti risponderebbe che questi dati
confermano la sua posizione.
P. È vero che per Davidson molti “fatti” relativi alla natura umana sono costruzioni sociali. Ma nei suoi studi non
c’è assolutamente nulla che impedisca di ricostruire queste vicende in una prospettiva realistica. Ciò che se ne
desume è che studiando i fenomeni sessuali abbiamo progressivamente superato vari errori (anche di carattere
morale, come le persecuzioni contro gli omosessuali), giungendo gradualmente a una comprensione più precisa
e corretta di quei fenomeni. E questo modo di porre le cose, che a me pare convincente, è perfettamente in
linea con il realismo filosofico.