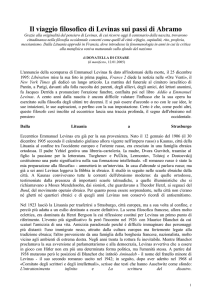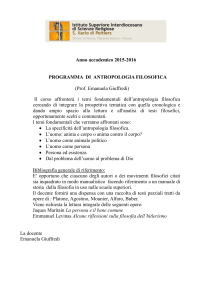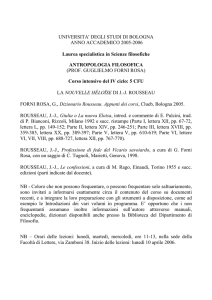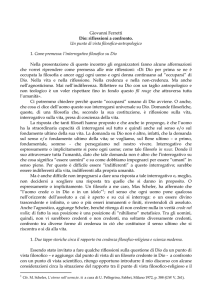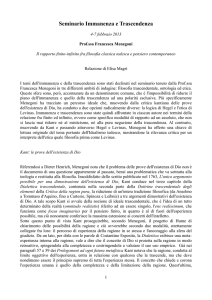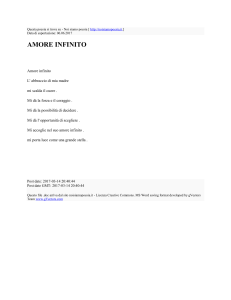Mirko Di Bernardo
Emmanuel Levinas: la metamorfosi del femminile
come via che conduce all'«altrimenti che essere»?
1. Premessa
Dolcezza, ospitalità, passività, vulnerabilità, verginità, alterità, questi tratti femminili per
eccellenza, secondo la tradizione, sono aspetti caratterizzanti del pensiero di Emmanuel Levinas, il
quale nel suo percorso filosofico cerca di ridefinire l'identità del soggetto mettendo in questione il
Logos greco, razionalità arida ed avvilente. Il primato dell'ontologia, secondo il nostro autore, è il
paradigma dell'Occidente: da Parmenide ad Heidegger, infatti, non c'è mai stata la possibilità della
singolarità. In Totalità e Infinito, capolavoro del 1961, Levinas scrive:
Filosofia del potere, l'ontologia, come filosofia prima che non mette in questione il medesimo, è
una filosofia dell'ingiustizia. L'ontologia heideggeriana che subordina il rapporto con Altri alla
relazione con l'essere in generale [...] resta all'interno dell'obbedienza dell'anonimo e porta,
fatalmente, ad un'altra potenza, al dominio imperialista, alla tirannia. [...] L'essere prima dell'ente.
L'ontologia prima della metafisica- cioè la libertà (sia anche quella della teoria) prima della
giustizia. È un movimento nel medesimo prima dell'obbligo nei confronti dell'altro.1
Configurandosi come fagocitazione dell'altro, l'ontologia fino ad Heidegger si delinea, secondo
Levinas, come una filosofia della potenza che porta al dominio ed alla sopraffazione del prossimo.
Alla violenza teorica dell'approccio ontologico, infatti, corrisponde, sul piano pratico,
l'annientamento della dignità e della libertà dell'uomo e l'intolleranza verso il diverso, tanto che lo
stesso Heidegger nel 1933 aderirà al nazismo; scelta quest'ultima che determinerà il radicale
distacco di Levinas dal filosofo tedesco.
Ogni teoria della conoscenza è un processo di identificazione, l'alterità dell'ente o oggetto (il
termine latino è ob-jectum, cioè «ciò che resiste», «ciò che si oppone») è ricondotto alle categorie
del soggetto; l'intelletto umano illumina gli oggetti grazie all'essere e poi se ne appropria.
Conoscere significa determinare, comprendere (da cum-capio), concettualizzare, dimostrare (il
termine latino è de-monstro, cioè trarre dall'oscurità l'oggetto e renderlo intelligibile), ma anche
violentare perché l'oggetto trascendente viene inglobato dalla coscienza che lo rende immanente.
Nella teoria della conoscenza, da Cartesio in poi, il soggetto si esplica come attività, posizione e
dominio.
L'intelligenza diventa ontologia, cioè capacità dell'uomo di intelligere l'essere.
Ma in questo senso, secondo Levinas, il pensiero occidentale è egologia, primato e prevaricazione
del medesimo nei confronti dell'altro, cioè annullamento di ogni differenza nell'universalità
dell'essere.
L'uomo, per dirla con Heidegger, è Da-sein, esserci; il ci (da) indica il fatto che l'uomo è sempre in
una situazione ed in rapporto attivo nei suoi confronti, egli è manifestazione dell'essere, ovvero
l'unico essente che ha il dono del logos; tuttavia non c'è differenza sessuale in Heidegger poiché il
Da-sein è neutro. L'esserci che comprende l'essere è già compreso dall'essere e la manifestazione di
quest'ultimo avviene nel tempo, ovvero in ciò che segna la dimensione del limite.
Poiché l'essere accade nel tempo, quest'ultimo diviene allora l'«orizzonte dell'essere». Queste sono
le ultime parole di Essere e Tempo di Heidegger, capolavoro del 1927 in cui l'autore scrive che la
forma suprema di libertà del soggetto umano consiste nell'«essere per la morte».
Ciò che caratterizza l'essere-per-la morte autenticamente progettato sul piano esistenziale può
essere riassunto così: l'anticipazione svela all'esserci la dispersione nel si-stesso e... lo pone innanzi
alla possibilità di essere se stesso, in una libertà appassionata, affrancata dalle illusioni del si,
effettiva, certa di se stessa e piena d'angoscia: la libertà per la morte.2
L'angoscia, sentimento di nullificazione, è il preavviso della morte che Heidegger definisce come
l'«Impossibilità di ogni possibilità»; l'uomo, infatti, di fronte alla minaccia di questo limite
insuperabile, prende coscienza della sua finitezza e così, accettandola, è finalmente in grado di
vivere autenticamente.
Fin dal saggio del 1935 L'evasione, Levinas si domanda se per dire l'umano sia possibile
intraprendere un'altra strada rispetto a quella dell'essere: «Si tratta di uscire dall'essere per una
nuova via».3
Nel percorso levinassiano la continua tendenza all'evasione dall'anonimato, dalla neutralità e da se
stessi (come identità definite), lascia intravedere «l'immagine dell'ebreo errante come figura
ontologica»: nell'uscire fuori di sé, infatti, ogni uomo incontra l'altro. Un cammino che, fedele
all'intenzione ebraica del Dabar (il cui significato è sia «parola» che «evento»), ci conduce verso
una «Patria nella quale non siamo mai nati». Esodo, partenza, de-costruzione e de-posizione di un
soggetto che nella sua autonomia dice e pensa ogni cosa a partire da sé.4
Nel 1974 con Altrimenti che essere o al di là dell'essenza, Levinas sembra riuscire definitivamente
nella sua impresa; lo stesso Derridà, nel saggio del 1980 En ce moment même dans cet ouvrage me
voici, confrontandosi con il capolavoro di Levinas, riconosce «un effetto di alterità» che va al di là
della stessa tematica che l'opera tenta di mettere in luce:
Comment donc écrit-il ? Comment ce qu'il écrit fait-il ouvrage et œuvre dans l'ouvrage ? Que fait-il,
par exemple et par excellence, quand il écrit au présent, dans la forme grammaticale du présent,
pour dire ce qui ne se présente pas et n'aura jamais été présent, le dit présent ne se présentant
qu'au nom d'un Dire qui le déborde, au-dehors et au-dedans, infiniment, comme une sorte
d'anachronie absolue, celle d'un tout autre qui, pour être incommensurablement hétérogène à la
langue du présent et au discours du même, y laisse pourtant une trace: toujours improbable mais
chaque fois déterminée, celle-ci et non una autre ?5
Levinas nella pratica della sua scrittura ha accettato il rischio della «negoziazione obbligata» (la
contaminazione originaria ed inevitabile dell'altro con lo stesso, con la lingua dello stesso che è
espressione del sistema culturale e del mondo) e ha scritto un testo in cui l'alterità, oltre ad essere
oggetto delle sue argomentazioni, è la ragione stessa del suo essere all'opera.
Qui il problema del nostro autore consiste nel pensare una trascendenza dell'Io, che lo liberi dalla
sua stessa identità:
Altrimenti che essere. [...] Si tratta di pensare la possibilità di uno sradicamento dall'essenza. Per
andare dove?
Per andare verso quale regione? Per attenersi a quale piano ontologico? Ma lo sradicamento
dall'essenza contesta il privilegio della questione: dove? Esso significa il non luogo. L'essenza
pretende di ricoprire e di recuperare ogni ec-cezione; la negatività, la nientificazione e già, dopo
Platone il non essere che in un certo senso è.
Bisognerà perciò mostrare che l'eccezione dell'altro dell'essere, al di la del non essere, significa la
soggettività o l'umanità, il se stesso che respinge le annessioni dell'essenza. Io unicità, al di fuori di
ogni paragone, perché al di fuori della comunanza del genere e della forma, che non trova riposo
neppure in sé, in-quieto, che non coincide con sé. [...] Unicità senza luogo, senza l'identità ideale
che un essere trae dal Kerigma che identifica gli aspetti innumerevoli della sua manifestazione,
senza l'identità dell'io coincidente con sé- unicità che si ritrae dall'essenza-uomo.6
Levinas ha dunque ridefinito l'uomo: il sé, la soggettività umana, infatti, è pensabile non come
essente ma solo come «altrimenti che essere».
Alla luce di tutto ciò alcune questioni restano in sospeso, quale è per esempio il significato di
questo «non-luogo»? Come si giunge all'«unicità dell'io che non coincide con sé»? In questo lavoro
c'è un punto di vista diverso rispetto a quello presente negli altri testi di Levinas; qui è possibile
intuire ciò che è all'origine dell'eticità e dell'umano, cioè il punto nevralgico verso cui convergono
gli sforzi del filosofo lituano.
La tesi che ci proponiamo di sviluppare in queste pagine è un tentativo, forse troppo audace, di
andare oltre lo stesso Levinas, o per lo meno, di cercare di far luce su alcuni punti enigmatici del
suo pensiero. Ripercorrendo il suo itinerario filosofico, interrogheremo i testi cercando di
rintracciare quei frammenti sparsi, simili a fili sottilissimi che restano sospesi ai margini di un
tessuto logoro, che, una volta connessi, possano indicarci la presenza di una traccia: il nonintenzionale che rinvia ad un «altrove» o ad un «altrimenti», cioè ad una significanza che cerca di
sfuggire alla luce. In un certo senso contro le stesse intenzioni dell'autore, cercheremo di sondare
quel «non-luogo» di fronte al quale lo stesso Levinas ha taciuto, praticamente tenteremo di varcare
la soglia dell'«indicibile», luogo del «già» e del «non ancora», dove il silenzio è immediatamente
predisposizione all'ascolto che si qualifica come «il luogo per eccellenza della verità, dove ciò che è
ascoltato responsabilizza verso l'agire morale».7
Noi riteniamo che per cogliere ancora più in profondità il significato dell'«altrimenti che essere»
sia fondamentale analizzare l'itinerario e la metamorfosi del femminile presente in alcuni lavori di
Levinas. In un certo senso le risposte relative alle domande precedenti sono legate al concetto di
femminilità che, nella sua enigmaticità, è da sempre oggetto di analisi critiche disparate e, a volte,
opposte tra loro. A nostro giudizio il femminile costituisce la via in grado di condurci verso il cuore
del pensiero del nostro autore.
2. Il femminile come mistero
Dopo lo scritto L'evasione e alcune riflessioni sull'ebraismo, la prima opera di Levinas dove si
delinea un suo pensiero autonomo (i primi sono saggi su Husserl ed Heidegger) è il testo
Dall'Esistenza all'Esistente, opera pubblicata nel 1947, concepita ancor prima della guerra e poi
estesa quasi completamente durante la prigionia. In questo lavoro compare per la prima volta il
semantema del femminile:
L'alterità d'altri che deve spezzare il carattere definitivo dell'Io non può essere colta con l'aiuto di
nessuna delle relazioni che caratterizzano la luce. Possiamo già anticipare dicendo che il piano
dell'eros ci permette di intravederla, che l'altro per eccellenza è il femminile, grazie a cui un
retromondo prolunga il mondo.8
Il femminile appare dunque come alterità, trascendenza, ovvero come ciò che rompe la continuità
della luce (quindi il dominio del soggetto conoscente); tuttavia non viene spiegato in che senso
l'eros ci permette di intravedere l'«alterità d'altri» interrompendo, così, la neutralità dell'identico.
Quale è, infatti, la relazione che si instaura tra l'eros ed il carattere definitivo dell'io?
Nel testo Il Tempo e l'Altro, pubblicato nel 1948 e contenente lo stenogramma di quattro
conferenze che furono tenute da Levinas nel 1946-47 durante il primo anno del suo insegnamento
al College Philosophique, c'è il tentativo di liberare l'io nei confronti di sé.
L'io, l'ipostasi è libertà, l'esistente è padrone della sua esistenza e, elemento ancora più rilevante,
questo dominio è maschile; Levinas, infatti, giunge addirittura a definirlo come «virile potere del
soggetto». «L'ipostasi del soggetto, dunque, si presenta come "virilità", "fierezza" e "sovranità"».9
Presto però quell'intimità del sé all'io in cui si risolvono tutte le esperienze del soggetto è spezzata
dall'evento della morte la quale costituisce un vero e proprio trauma per l'identità dell'io: il
soggetto, infatti, si scopre in relazione diretta con l'ignoto, relazione che, non avvenendo nella luce
della coscienza, eccede ogni indagine fenomenologica. La morte accade, non è assunta, essa ci
rende passivi ed è proprio in questa passività radicale che il nostro autore intravede la fine della
virilità:
Nell'approssimarsi della morte, l'importante è che ad un certo momento non possiamo più potere;
è proprio per questo che il soggetto perde la sua stessa sovranità di soggetto.10
L'approssimarsi della morte, pertanto, costituisce l'istaurarsi del rapporto con un futuro che non
sarà mai presente: la trascendenza assoluta dell'a-venire. Nell'evento della morte si annuncia, così,
un'alterità irriducibile all'identità del soggetto: la relazione con l'Altro (autrui) diviene relazione
con un mistero. Levinas individua il prototipo di questa relazione nell'eros:
Io penso che il contrario assolutamente contrario, la cui contrarietà non è modificata in nulla dalla
relazione che si può stabilire tra esso ed il suo correlativo, la contrarietà che permette al termine di
restare assolutamente contrario, è la femminilità.11
A giudizio del nostro autore, dunque, la differenza sessuale si situa al di fuori della divisione logica
in generi ed in specie (in netta opposizione all'unità dell'essere proclamata da Parmenide); il
femminile, infatti, ci permette di leggere la realtà in termini di molteplicità negando così la
possibilità di convertire un termine nell'altro: il maschile, quindi, non si ottiene negando il
femminile.
La differenza dei sessi non è neppure la dualità di due termini complementari, poiché due termini
complementari presuppongono una totalità pre-esistente. [...] L'altro in quanto altro non è qui un
oggetto che diventa nostro, o che finisce per identificarsi con noi, esso al contrario si ritrae nel suo
mistero. [...] La trascendenza della femminilità consiste nel ritrarsi altrove, movimento opposto al
movimento della coscienza, ma non è, per questo, inconscio o sub-conscio, e non vedo altra
possibilità se non quella di chiamarlo mistero.12
In questo periodo dell'itinerario levinassiano, il femminile si presenta come l'«alterità per
eccellenza», il «mistero» che sfugge ad ogni tentativo di presa della coscienza intenzionale; qui non
abbiamo a che fare con un esistente, bensì con l'evento dell'alterità la cui essenza è presente nella
relazione originale dell'eros, relazione che non è possibile tradurre in termini di potere: il
femminile, infatti, permette a Levinas di dare una definizione del soggetto fondata sulla sua
passività. In alcune pagine successive il nostro autore afferma che nell'eros non c'è né
l'«afferrare», né il «possedere», né il «conoscere» l'altro, ma lo «scacco» di tutto questo.13
Il femminile, infatti, rappresenta la «trascendenza temporale di un presente verso il mistero
dell'avvenire»; questa relazione si realizza nel faccia a faccia con altri (autrui) e costituisce, a
giudizio del nostro autore, l'effettiva realizzazione del tempo. In altre parole, l'evento del femminile
come mistero, ovvero lo squarcio dell'avvenire nella continuità del presente, diviene la condizione
stessa dell'accadere del tempo; semplificando, potremmo anche dire che per Levinas il tempo è
l'altro.
Questa conclusione è la prima sintesi del pensiero levinassiano di quegli anni: il femminile è
dunque un «modo di essere che consiste nel sottrarsi alla luce, un modo di esistere nel nascondersi
del pudore».14
Temi questi che conducono al capolavoro del 1961, Totalità e Infinito, nel quale il femminile
apparirà in forma differente. Questo argomento sarà ampiamente sviluppato più avanti, per ora
però proseguiamo l'analisi di questa prima fase del pensiero levinassiano in cui appare evidente
l'ottica maschile e conservatrice con cui l'autore presenta l'alterità indicandola come femminilità.
Quest'aspetto venne immediatamente notato da Simone De Beauvoir che nello stesso anno della
pubblicazione delle conferenze, commentò così:
Suppongo che Levinas non dimentichi che la donna è anche di per sé coscienza, ma è degno di nota
che egli adotti un punto di vista maschile senza porre in evidenza la reciprocità del soggetto e
dell'oggetto.
Quando scrive che la donna è mistero è sottinteso che ella è mistero per l'uomo. Cosicché questa
descrizione che vorrebbe obbiettiva è in realtà un'affermazione del privilegio maschile.15
Secondo le analisi di De Beauvoir, il maschile, per determinare se stesso come soggetto, nega al
femminile la possibilità di essere a sua volta soggetto definendolo «altro per eccellenza» ed
impedendo altresì alla donna di fare dell'uomo un essere relativo, cioè altro da sé: il maschile,
dunque, definendo il femminile in relazione a sé, pensa di determinare il femminile in sé e proietta
su quest'ultimo delle esigenze teoriche senza però elaborare un contenuto positivo.
Anche se nell'opera Il Tempo e l'Altro Levinas distingue la sua posizione da quella romantica e
dichiara di non voler disconoscere le pretese legittime del femminismo, ad un primo esame, egli
sembra guardare l'alterità con un'ottica prettamente maschile ed in un modo forse troppo evidente
per non esserne cosciente.16
Viene spontaneo chiedersi, dunque, se il semantema del femminile nell'itinerario del pensiero di
Levinas non nasconda un significato più alto rispetto alla semplice analisi socio-politico-culturale
che De Beauvoir gli riserva. Seguendo questa linea è lo stesso Levinas che in una intervista del
1985, sembra indicarci la via da percorrere:
All'epoca del mio piccolo libro intitolato Il Tempo e l'Altro, pensavo che la femminilità fosse una
modalità dell'alterità -- questo altro genere -- e che la sessualità e l'erotismo fossero questa non
indifferenza all'altro, irriducibile all'alterità formale dei termini all'interno di un insieme. Oggi
penso che bisogna risalire più a monte e che l'esposizione, la nudità e la domanda imperativa del
volto d'altri, costituiscono questa modalità che il femminile stesso già suppone: la prossimità del
prossimo è l'alterità non formale (Intervista raccolta nel febbraio 1985 dal settimanale Construire
[Zurigo] da L. Adert e J-Ch. Aeschlimann).17
Indubbiamente tra gli anni 1947-48 e la fase successiva del pensiero filosofico di Levinas, il
concetto di femminilità subisce una metamorfosi misteriosa: dall'eros inteso come «non
indifferenza all'altro», si passa al tema del volto. Quale relazione sussiste, dunque, tra il femminile
ed il volto d'altri? Levinas ritiene che la differenza sessuale rappresenti un problema importante, la
divisione dell'umanità in uomo e donna non è solo una questione biologica; pur tenendo sempre
presente che l'eros non è l'agape e che quest'ultimo non nasce dal primo, nel concetto di
femminilità si intravede una polisemia: da un primo legame diretto con la dimensione erotica, il
significato del femminile sembra ora oscillare verso il piano etico, dall'amore che diventa
godimento a ciò che presuppone la responsabilità per altri. Quale connessione sussiste, allora, fra il
mistero del femminile e la responsabilità per altri?
Ed infine, come muta il semantema del femminile nelle opere successive del nostro autore? Per ora
lasciamo queste domande in sospeso.
3. Ospitalità e verginità
La polisemia del femminile risulta evidente in Totalità e Infinito, lavoro presentato da Levinas nel
1961 (all'età di 56 anni) come tesi di dottorato. Il fine dell'opera, le tematiche ed il lessico
evidenziano una continuità con quelle di Il Tempo e l'Altro; qui, però, la critica è rivolta al pensiero
della totalità inteso come paradigma dell'occidente che viene scardinato dal desiderio dell'infinito:
movimento che va dal mondo all'«altrove», all'«altrimenti», all'«assolutamente altro». La vera
rottura con la totalità avviene grazie all'idea d'infinito che scompiglia la coscienza e l'intenzionalità;
quest'eccedenza, infatti, è data dal fatto che la realtà oggettiva di cogitatum va al di là della realtà
formale della cogitazione. L'idea d'infinito, quindi, mette in relazione il pensiero umano con l'unico
ideatum di cui si può avere solo un'idea: la distanza che si crea tra ideatum ed idea costituisce il
contenuto dello stesso ideatum, ovvero l'infinito. Ciò rovescia il carattere attivo e dominante
dell'intenzionalità permettendo, altresì, al nostro autore, di rintracciare nella passività originaria la
condizione autentica del soggetto.18
Secondo la prospettiva levinassiana, infatti, a questa riflessione teoretica corrisponde, nella
fatticità, l'esistente che stravolge le strutture del soggetto conoscente e che diviene, in tal modo, la
figura centrale di Totalità e Infinito: ecco dunque il delinearsi dell'epifania del volto d'altri.
Nell'opera or ora accennata, infatti, il volto viene presentato da Levinas come il senza contesto e
l'incontenibile, ovvero senso solo per sé irriducibile ad ogni adeguazione e ad ogni presa; la sua è
una venuta che fa avvenimento e che implica un'imprevedibilità radicale, egli, pertanto, eccedendo
costantemente l'ordine della coscienza intenzionale, mette in questione la volontà di sapere e di
dominio di chi gli è di fronte.19
La relazione con il volto è immediatamente etica, comandamento morale: «Tu non ucciderai», ecco
il suo primo messaggio (Trascendenza e altezza 1962). Il volto si colloca nell'esteriorità, cioè al di
fuori della totalità e dell'essere, infatti, secondo il nostro autore, tendere all'esteriore significa
tendere all'infinito. Il volto è «nudo», è «povero», è «misero», è trascendenza, ovvero «visitazione
da un altrove». Il rapporto con lui è metafisica (non più scienza del comportamento), ovvero
immediatamente comandamento etico, «discorso», «faccia a faccia»:
Il volto d'altri distrugge ad ogni istante, e oltrepassa l'immagine plastica che mi lascia, l'idea a mia
misura e a misura del suo ideatum -- l'idea adeguata. Non si manifesta in base a queste qualità, ma
kath'auto. Si esprime. [...] Andare incontro ad altri nel discorso significa accogliere la sua
espressione nella quale egli va continuamente al di là dell'idea che un pensiero potrebbe portare
con sé. Significa dunque ricevere da altri al di là della capacità dell'io; ciò che significa esattamente:
avere l'idea dell'infinito. [...] Il rapporto con altri o il discorso è un rapporto non allergico, un
rapporto etico, ma questo discorso accolto è un ammaestramento.20
In questo passo è esplicito il ribaltamento di tutta la tradizione del pensiero: l'idea d'infinito che
produce desiderio assume l'aspetto del volto; dall'autonomia del sapere si giunge all'eteronomia
della responsabilità per altri.
Per Levinas, dunque, l'etica è il luogo del senso, essa, infatti, viene prima di tutto (prima della
cultura, dell'economia e dell'essere nella sua totalità), e non a caso è definita con il termine di
«filosofia prima»; tuttavia il senso si esprime nel volto dell'altro che diviene così la significanza
stessa della significazione: il viso, infatti, immediatamente comandamento etico, esprime la
precedenza della metafisica sull'ontologia. Tra me e l'altro non c'è reciprocità, il volto è
insegnamento, origine del discorso, appello incessante che «investe» la mia libertà e che mi
costringe alla responsabilità.
È importante evidenziare, in virtù della tesi che ci accingiamo a sviluppare in queste pagine, la
frequenza con cui, nel testo levinassiano, è presente la parola «accoglienza»: essa, infatti, esprime
il primo movimento verso altri. Per poter pensare l'etica, dunque, risulta necessario concepire la
possibilità dell'accoglienza poiché senza di essa non c'è volto. Alla luce di tutto ciò, a nostro avviso,
solo l'ospitalità costituisce quell'evento fondamentale in grado di trasformare la ricettività in
relazione etica. La sproporzione or ora accennata, infatti, mette in luce la «legge dell'ospitalità»: la
ragione, in quanto accoglimento dell'idea d'infinito, diviene passiva e «riceve» trasformandosi,
così, in accoglienza e quindi in ospitalità.21
Nella prospettiva levinassiana, dunque, fin da ora è evidente come quest'ultimo termine risulterà
fondamentale una volta connesso con il concetto di femminilità, tuttavia ci sembra opportuno, per
ragioni di chiarezza espositiva, fare un passo indietro e procedere con ordine.
In questa panoramica generale, infatti, quale è il posto che il nostro autore riserva al femminile?
La femminilità compare in due momenti diversi del tragitto: il primo è situato nella sezione
seconda (Interiorità ed Economia) in particolare nel capitolo «La dimora», mentre il secondo è
posto nell'ultima sezione (Al di là del Volto).
A nostro avviso, dunque, risulta rilevante segnalare come nell'architettura di Totalità e Infinito la
femminilità compaia prima dell'argomentazione sul volto ed immediatamente dopo. Rispetto ai
testi precedenti, infatti, il femminile non è più l'«assolutamente altro», ma, nello stesso tempo,
appare evidente il suo legame diretto con la trascendenza del volto. Analizzando queste prime
riflessioni, quindi, possiamo anticipare già il fatto che, all'interno della misteriosa metamorfosi del
pensiero levinassiano, la femminilità reciterà un ruolo tutt'altro che marginale...
Nel capitolo dedicato alla dimora, Levinas presenta alcune riflessioni sul raccoglimento:
L'intimità che è già presupposto della familiarità è un'intimità con qualcuno. L'interiorità del
raccoglimento è una solitudine in un mondo che è già umano. Il raccoglimento si riferisce ad
un'accoglienza.22
Qui il nostro autore descrive i luoghi dell'interiorità come per esempio l'a-casa-propria, l'intimità
e la familiarità, ovvero i luoghi specifici in cui si realizza l'ospitalità. La dimora, infatti, sancisce la
separazione dall'«elementale» (c'è quindi un'interruzione delle risposte immediate stimolate dalla
natura), è rifugio, dà sicurezza e consente all'uomo di poter progettare; tuttavia essa non è soltanto
il luogo del possesso (dove vengono conservate le cose), altresì costituisce il luogo dell'interiorità
(la soggettività umana), dell'intimità (rapporto col mondo sotto forma di godimento, familiarità in
cui si svolge la vita) ed infine la condizione di possibilità della donazione. Dal per sé della
separazione, quindi, si è giunti al fuori di sé della donazione; il raccoglimento costituisce la
possibilità dell'accoglienza ospitale: apertura della porta della propria casa al volto dell'altro che,
nella sua umile-maestà, implora, supplica e, contemporaneamente, esige una risposta totale. Ma
che cosa consente questo cambiamento radicale?
L'altro la cui presenza è discretamente un'assenza e a partire dal quale si attua l'accoglienza
ospitale per eccellenza che descrive il campo dell'intimità, è la donna. La donna è la condizione del
raccoglimento, dell'interiorità della casa e dell'abitazione. [...] L'abitazione non è ancora la
trascendenza del linguaggio. Altri che accoglie nell'intimità non è il voi del volto che si rivela in una
dimensione di maestà -- ma appunto il tu della familiarità: linguaggio senza insegnamento,
linguaggio silenzioso, intesa senza parole, espressione nel silenzio. L'io-tu nel quale Buber scorge la
categoria della relazione interumana non è la relazione con l'interlocutore, ma con l'alterità
femminile.23
Il femminile si presenta, quindi, come ciò che fa di una casa luogo d'accoglienza. La donna è
l'«accoglienza ospitale per eccellenza», la sua alterità è mutata rispetto a quella presentata in Il
Tempo e l'Altro, infatti nell'intimità della dimora non c'è più una trascendenza, bensì c'è il tu della
familiarità: la relazione con il femminile, quindi, rende possibile il discorso, ma ancora non è il
«faccia a faccia». La donna è immanenza, discrezione, «presenza che è un'assenza», condizione di
possibilità dell'ospitalità: grazie all'alterità femminile, quindi, siamo in grado di accogliere il volto
dell'altro quasi totalmente. Quest'ultima, però, è segnata dalla mancanza della possibilità del
linguaggio, cioè la trascendenza del discorso, ovvero l'«ammaestramento» a partire dall'altezza del
volto. L'essere femminile comunica nel silenzio ed il suo è, comunque, un linguaggio umano;
secondo il nostro autore, infatti, pur non essendo un uomo, la donna resta umana permettendo,
altresì, un'accoglienza in cui il linguaggio che sottace resta una «possibilità essenziale»:
La casa che fonda il possesso, non è possesso nello stesso senso delle cose mobili che può
raccogliere e custodire. Essa è posseduta perché è da sempre luogo di ospitalità per il suo
proprietario. Il che ci rinvia alla sua interiorità essenziale e all'abitante che la abita prima di ogni
abitante, all'accogliente per eccellenza, all'accogliente in sé -- all'essere femminile.24
L'«accogliente in sé» accoglie nella demarcazione prima descritta, cioè senza trascendenza del
linguaggio; questo limite sembra sancire il confine tra il «pre-etico» e l'«etico», come se ci fosse
una accoglienza per eccellenza, un'accoglienza ospitale, «in sé», prima dell'etico. Il pre-etico, con
cui si sta indicando la dimora dell'essere femminile, non è entrato ancora nella dimensione etica,
luogo in cui la «legge dell'ospitalità» è realizzata: l'ospite che riceve («host»), che accoglie e che si
crede il proprietario della propria casa, in realtà è un ospite invitato e ricevuto («guest»). Egli
riceve dalla propria casa quell'ospitalità che crede di offrire, colui che riceve è ricevuto a casa
propria come in una «terra d'asilo».25
Queste analisi ci rimandano ad un discorso più profondo. La terra che crediamo nostra in realtà
appartiene a Dio, noi siamo soltanto degli stranieri, le nostre case sono alloggi di passaggio e i
proprietari sono originariamente degli inquilini: nulla è effettivamente in nostro possesso.
Rosenzweig, nella Stella della Redenzione, cita un versetto del Levitico (25, 23) che lo stesso
Levinas riproporrà in vari testi (ciò contribuisce a mettere in luce il legame profondo che unisce i
due filosofi), esso ci sembra emblematico:
Nessuna terra sarà irrevocabilmente alienata, poiché la terra è mia, poiché voi non siete che
stranieri, domiciliati presso di me.26
La casa non è posseduta, essa è ospitale per il suo stesso proprietario il quale è già un «guest».
La precedenza dell'accoglienza e del raccoglimento è la femminilità stessa: il femminile è, dunque,
presentato da Levinas come interiorità.
Da questo discorso emerge la metamorfosi della soggettività umana, infatti la dimora evoca la
posizione dello stesso soggetto: io scopro che dietro alla mia apparente condizione di solitudine si
cela una compagnia originale, diremmo quasi pre-originale (questo tema sarà approfondito più
avanti), un 'interiorità che mi accoglie ed in virtù della quale posso aprire le porte del mio cuore
all'altro, a chi mi è di fronte, al volto che mi invoca e mi mette in questione con la sua venuta. Se
posso donare, amare, uscire da me fino a negare me stesso è perché qualcuno mi ha amato in modo
pre-originale, amo perché sono amato; quel qualcuno è l'essere femminile che, da alterità
trascendente e distante (Il Tempo e L'Altro), diviene ora presenza silenziosa nella dimensione
interiore del soggetto, ma presenza inquietante poiché, svelando all'io il suo stato di passività
originaria, si trasforma in condizione dell'etica. In accordo con Levinas, dunque, risulta possibile
affermare che ogni singolo uomo, in realtà, è ospite di se stesso: ogni soggetto, infatti, da padrone
della propria casa diviene ospite. L'identità umana, quindi, subisce una trasformazione dal suo
interno: la via che traccia il femminile è quella che porta ad una trascendenza all'interno dello
stesso Io.
In Addio ad Emmanuel Levinas, Derridà definisce Totalità ed Infinito come un «trattato
sull'ospitalità»; analizzando gli ultimi passi relativi al capitolo «La Dimora», lo stesso Levinas
sembra confermare questa tesi:
Il raccoglimento in una casa aperta ad altri -- L'Ospitalità -- è il fatto concreto ed iniziale del
raccoglimento umano e della sua separazione, coincide con il desiderio d'altri assolutamente
trascendente. [...] La relazione con altri non si produce al di fuori del mondo, ma mette in
questione il mondo posseduto. La relazione con altri, la trascendenza, consiste nel dire il mondo ad
altri. [...] Non è una visione d'altri ma una donazione originaria.
[...] La visione del volto non si separa da questa offerta costituita dal linguaggio. Vedere il volto
significa parlare del mondo. La trascendenza non è un'ottica ma il primo gesto etico.27
Ospitalità, volto, desiderio d'altri e donazione originaria, esprimono l'accoglienza dell'altro, il «sì»
all'altro dove quest'ultimo si sottrae ad ogni forma di tematizzazione.
L'ospitalità è il termine che indica l'apertura al volto, ciò che lo accoglie, infatti, è un «sì» all'altro
che si costituisce come risposta al sì dell'altro, un sì che diviene appello in virtù della risposta
responsabile del medesimo. Il mio sì non è un inizio poiché l'infinito dell'altro è stato accolto preoriginariamente: il mio «sì» è sempre preceduto dal «sì» dell'altro, «l'accoglienza è sempre
accoglienza dell'altro», insomma si comincia con il rispondere.28
La soggettività è divenuta così responsabilità, risposta possibile a partire da un'accoglienza
silenziosa, diremmo quasi misteriosa, quella del femminile: «accoglienza per eccellenza» e
condizione dell'etica stessa. Indicare l'essere femminile come il «pre-etico» non significa
evidenziarne una mancanza (il non accesso all'etica), bensì riconoscere il ruolo di primo piano che
la femminilità recita nell'opera levinassiana. Se l'etica è il fondamento del senso e la realizzazione
stessa dell'autenticità dell'umano, allora la femminilità, essendo la condizione dell'accoglienza,
dell'ospitalità e della responsabilità, diviene il nucleo della stessa identità dell'uomo; essa, infatti, è
alla base della metamorfosi della nuova soggettività che Levinas propone. La femminilità, dunque,
appare nell'itinerario del nostro autore come la via che conduce alla ridefinizione stessa
dell'umano.
Ma, ancora una volta, alcune questioni restano aperte, per esempio con «essere femminile»
Levinas intende le donne empiriche o qualcos'altro? In Alterità, le metamorfosi del femminile da
Platone a Levinas, testo dedicato a Simone De Beauvoir, Anna Maria Verna presenta una critica
femminista al pensiero filosofico occidentale inteso come dominio della virilità («legge del
medesimo») sul femminile presentato come differenza (ovviamente in funzione del maschile).
l'autrice, pur riconoscendo il tentativo di Levinas di porsi fuori e contro la cultura dominante,
accusa il filosofo di non essere riuscito a modificare il femminile come concetto. Secondo la
scrittrice, infatti, Levinas destruttura ciò che era stato dato per fondamentale e propone una
soggettività diversa rispetto a quella della tradizione, tuttavia ciò non è per lei sufficiente poiché, a
suo giudizio, egli si muove pur sempre all'interno di tematiche date tanto da non intaccare le
«ossessioni monosessuali maschili».29 Ecco un passo emblematico tratto dal suo testo:
In tutta la sua opera, Levinas parla dell'accoglienza che il medesimo deve all'altro, di come l'altro
mette in discussione il medesimo. Quando il medesimo e l'altro diventano uomo e donna, la teoria
si rovescia, tanto da far pensare che gli altri (il povero, lo straniero) siano riconosciuti non in
quanto creature, ma in quanto uomini (maschi). La donna infatti, rivela la propria alterità nella
dolcezza e nell'impossibilità di mettere in causa l'uomo. Se la donna fosse l'assolutamente altra, o
semplicemente un'altra rispetto al soggetto maschile, vi sarebbe la guerra.30
Nella parte finale della sua critica, Anna Maria Verna attribuisce al femminile levinassiano la
caratteristica di «alterità dipendente» in opposizione diretta al maschile che, invece, è colui che
«crea il linguaggio» e «definisce l'escatologia». Quest'analisi complessiva pone il problema del
femminile su un piano sociale, culturale, politico, insomma esclusivamente empirico. Il femminile
è ogni donna concreta, quindi è inteso esclusivamente come realtà ontica. Secondo la nostra tesi,
invece, Levinas non può essere definito all'interno della dicotomia maschilismo-femminismo; il suo
messaggio cerca di andare al di la dell'aspetto socio-politoco-culturale (posto in un orizzonte
immanente e legato alla realtà empirica); egli, infatti, accede alla dimensione etica, accetta un
«compromesso con la lingua», usa la logica occidentale creando un'implosione del logos stesso e ci
pone di fronte ai limiti della logica umana, ma, nello stesso tempo, la demarcazione presentata è
già contatto con un al di là, cioè con un incondizionato. Il femminile, allora, ci conduce verso quel
«non-luogo» di cui si è accennato nella premessa; comunque, è lo stesso Levinas che, nel capitolo
«La Dimora», previene ogni possibile critica femminista:
Il femminile è stato incontrato in questa analisi come uno dei punti cardinali dell'orizzonte in cui si
situa la vita interiore -- e l'assenza empirica dell'essere umano di sesso femminile in una dimora,
non cambia niente alla dimensione della femminilità che vi resta aperta appunto come accoglienza
della dimora.31
Un'analisi attenta dell'itinerario levinassiano potrebbe condurci a risultati opposti rispetto a quelli
delle critiche femministe; il femminile inteso come «ospitalità assoluta», «accoglienza per
eccellenza», «origine pre-etica dell'etica», diverrebbe una realtà meta-empirica all'interno di un
discorso etico che va al di la dell'ontologia. Il femminile, pertanto, pur essendo una categoria
ontologica eccede l'empirico trasformandosi, così, in una sorta di icona-simbolo del metaempirico. Derridà spiega così questo passaggio fondamentale di Levinas:
l'accoglienza, origine anarchica dell'etica, appartiene alla dimensione di femminilità e non alla
presenza empirica di un essere umano di sesso femminile. [...] L'accoglienza assoluta,
assolutamente originaria, anzi pre-originaria, l'accoglienza per eccellenza è femminile, ha luogo in
un luogo non appropriabile, in un'interiorità aperta il cui maestro o proprietario riceve l'ospitalità
che in seguito vorrebbe dare.
L'ospitalità precede la proprietà [...].32
L'origine anarchica dell'etica, l'ospitalità che precede la proprietà ed il luogo di quest'interiorità
misteriosa, sono temi che Levinas esplicherà in opere successive quali: Umanesimo dell'altro uomo
(1972) e Altrimenti che essere (1974). È singolare che le critiche femministe non prendano mai in
considerazione questi due testi, probabilmente perché il termine «femminile» non è presente;
eppure è proprio lì, a nostro giudizio, che Levinas elabora l'autenticità ed il senso ultimo della
femminilità, infatti è proprio lì che, sondando l'origine anarchica dell'etica, il nostro autore, fa
ingresso nella «dimensione autentica della femminilità». Comunque sia, questo tema sarà
argomentato nel prossimo paragrafo, per ora torniamo a Totalità e Infinito.
Nella sezione «Al di là del volto», Levinas affronta il tema della morte; in gioco c'è la possibilità
stessa della soggettività: è forse possibile per l'io vincere l'assurdità della morte? Levinas risponde
così:
Dobbiamo dunque indicare un piano che, nello stesso tempo presuppone e trascende l'epifania
d'altri nel volto; piano di cui l'io va al di là della morte e si libera anche del suo ritorno su di sé.
Questo piano è quello dell'amore e della fecondità, in cui la soggettività si pone in funzione di
questi movimenti.33
Dunque la risposta del nostro autore è positiva, l'amore vince la morte grazie alla fecondità che
rappresenta la prosecuzione della relazione erotica.
L'erotico è presentato dal nostro autore come «l'equivoco per eccellenza» e la sua originalità sta nel
fatto che in esso coincidono bisogno e desiderio, cioè sia la possibilità di godere dell'amata, sia
quella di «andare al di là del discorso»; pertanto da un lato c'è la spinta al godimento ed al
possesso, dall'altro c'è una tensione a trascendere l'«amata» verso un al di là lontano.
In Difficile libertà, testo del 1963, Levinas riconosce che nell'erotismo e nel sentimento amoroso si
produce «la partecipazione del presente al futuro». L'amore (eros), col suo dinamismo, ci conduce
al di là dell'amato e del presente: in ciò, infatti, consiste la sua finalità autentica. Tuttavia, dopo la
«disobbedienza originale», secondo il nostro autore, c'è stata la separazione tra voluttà e
procreazione ed è per questo motivo che noi le troviamo in successione nel tempo. 34
La vera essenza dell'amore era la fecondità, ma ora ciò che attira gli innamorati è la voluttà: in ciò
consiste l'ambiguità. Il femminile qui è incontrato come «amata»:
L'amore tende ad altri, tende ad esso nella sua debolezza. La debolezza [...] qualifica l'alterità
stessa. Amore significa tenere per altri, dare aiuto alla sua debolezza. In questa debolezza come
nell'aurora, sorge l'amato che è amata. [...] L'epifania dell'amata è una cosa sola con il suo regime
di tenerezza-commossa.35
Il femminile appare dunque come «amata», «debolezza», «tenerezza», «commozione», ma anche
possibilità di fraintendimento nella voluttà. L'eros, tuttavia, non è possesso: la relazione amorosa
permette la vittoria sulla morte poiché cerca ciò che è assolutamente futuro, nella loro unione,
infatti, il medesimo e l'altro «generano il figlio». La relazione con il figlio, dunque, mette in
rapporto l'io con la trascendenza dell'avvenire, ripristinando così la relazione con l'infinito nella
dimensione temporale. Stando così le cose, nella paternità, l'io si libera di sé senza cessare di essere
io; la relazione padre-figlio, infatti, implica una «rottura» ed un «ricorso»: mio figlio è uno
straniero, pur essendo altri è me, ma, nello stesso tempo, non è opera mia, né mia proprietà. Io non
possiedo mio figlio, in qualche maniera io sono mio figlio.
In questa sezione, terminando con la paternità, il percorso di Levinas sembra molto simile a quello
presentato nelle conferenze di Il Tempo e l'Altro, anche qui infatti la prospettiva assunta dal nostro
autore è decisamente maschile. Il femminile è qui presentato come «violabile e inviolabile», è
«debolezza», «tenerezza» e «vulnerabilità», aspetti questi ultimi che la tradizione attribuisce
inequivocabilmente alla donna. La stessa fine dell'opera, inoltre, sembrerebbe confermare questa
tesi: l'individuazione della paternità come relazione ultima con l'infinito, infatti, mette in luce la
prevalenza del dominio maschile sulla femminilità.
Spesso, però, le cose non sono come sembrano... Secondo la nostra analisi, infatti, nella sezione «Al
di la del volto», sono presenti degli elementi che differenziano quest'ultima parte dalle conferenze
del 1948 e che ci permettono, altresì, di rintracciare alla base della stessa soggettività umana una
dimensione femminile; ciò è intrinseco nel passo seguente:
L'amata che può sì essere compresa ma che resta intatta nella sua nudità, al di là dell'oggetto e del
volto, e così al di la dell'ente, si mantiene nella verginità. Il femminile essenzialmente violabile ed
inviolabile, l'eterno femminino è il vergine o una continua ripresa della verginità, l'intoccabile
persino nel contatto della voluttà, nel presente-futuro. [...] La vergine resta incomprensibile, muore
senza omicidio, va in estasi, si ritira nel suo avvenire, al di là di ogni impossibile promessa
all'anticipazione. Al fianco della notte come ronzio anonimo del c'è si apre la notte dell'erotico,
dietro la notte dell'insonnia, la notte del nascosto, del clandestino, del misterioso, patria del
vergine, che, nello stesso tempo, è scoperto dall'eros e sfugge all'eros [...].36
Il femminile appare qui come «continua ripresa della verginità»: l'amata rimane integra nella «sua
nudità», «resta incomprensibile» ed infine «si ritira nel suo avvenire». Ancora una volta la
femminilità traspare come mistero, enigma che sfugge ad ogni tentativo di presa. Simbolo di questo
movimento è, senza ombra di dubbio, l'atto della carezza cui Levinas riserva uno studio
particolareggiato: essa, infatti, è «un modo d'essere del soggetto» il quale non può inglobare l'altro
da sé poiché «ciò che è accarezzato non è toccato». Qui è intrinseco il rimando all'assenza dell'altro,
all'impossibilità di fondersi con lui e all'attesa dell'avvenire. Tutto ciò, a nostro avviso, esprime una
tensione verso l'«indicibile» che «si alimenta all'infinito» e che trova la sua realizzazione nella
fecondità la quale, però, scaturisce dalla verginità. Mentre in Il Tempo e l'Altro il femminile è
semplicemente un futuro misterioso, inconoscibile ed enigmatico, nel passo sopra citato ha inizio
una metamorfosi della stessa identità femminile: l'amata non è solo diversa dall'amato, essa
comincia a possedere dei tratti suoi propri: essa è verginità. Dietro a questo termine
apparentemente legato ancora ad una tradizione andro-centrica, si nasconde, a nostro giudizio,
l'inizio di un processo che porterà alla lacerazione della «legge del medesimo» (quindi della
prospettiva virile) dal suo stesso interno.37
La verginità impedisce il cambiamento (non sublimato) di direzione verso il maschile
conservando, così, la pura essenza femminile. La verginità produce fecondità, ma,
contemporaneamente, esprime la stessa tensione del corpo verso la maternità (non a caso questo
tema sarà trattato in Altrimenti che essere, opera in cui la prospettiva maschile sarà
definitivamente abbandonata); la donna, quindi, nella verginità diviene offerta del luogo dove
nascere, ma anche possibilità di rinascita come umanità nuova.
L'esperienza della verginità consiste nella presa di coscienza del fatto che non si può pensare l'altro
senza affermare un destino che dipende da un «altrove», infatti per entrare in rapporto con l'altro
si deve accettare una distanza che non è posta dal medesimo. Il «sì» all'altro è, secondo la nostra
prospettiva, l'anticipo dell'eterno nel mondo presente: la verginità, infatti, è traccia della presenza
dell'altrove in questo mondo poiché costituisce il richiamo alla responsabilità e l'inizio, nel
presente, della redenzione.
La responsabilità, il «sì» che conferma l'assenso pre-originario di fronte al volto, è il gesto
dell'ubbidienza nella sua essenzialità ed implica il passaggio attraverso l'immolazione per l'altro da
cui scaturisce una fecondità senza limite; ecco, dunque, dove termina la verginità nella sua
autenticità: la condizione di verità di un rapporto è il sacrificio, l'uomo non può fare a meno che
rispondere alla chiamata dell'infinito, rispondere ad un ascolto pre-originario che si traduce nella
testimonianza di una gratuità che precede ogni tempo ed ogni luogo. La testimonianza, infatti, è
amore verginale poiché fa sentire accolto e amato chiunque entri nella nostra casa. A nostro
giudizio dunque la verginità costituisce l'autenticità stessa dell'umano e, presentandosi come
appello all'«altrimenti che essere», rappresenta la via che conduce all'umanità dell'uomo e alla vita
etica, ovvero al raggiungimento della Santità.
Stando a queste analisi, quindi, la verginità, anche se in modo latente, sembra unire
inscindibilmente il mistero del femminile e la responsabilità per altri: ospitalità, responsabilità e
verginità, infatti, rappresentano i nuclei tematici in virtù dei quali, implicitamente, in Totalità e
Infinito, il femminile rimette in questione il maschile impedendogli, così, di essere inteso come
autonomia.
Se nelle conferenze dell'opera Il Tempo e l'Altro la paternità chiudeva il percorso levinassiano,
diversamente in Totalità e Infinito questa conclusione viene affiancata anche dalla presenza del
femminile che apre inequivocabilmente nuove prospettive sulla soggettività umana:
In quanto se stesso, l'io, attraverso la relazione con altri nella femminilità, si libera della propria
identità, può essere altro a partire da sé come origine. Sotto le specie dell'io, l'essere può prodursi
come ciò che ricomincia all'infinito, cioè per essere esatti, come infinito.38
Il femminile, dunque, ci mette in relazione con l'origine; la sua presenza, infatti, diviene la
condizione essenziale per scoprire le tracce di un infinito che ci precede: luogo dell'indicibile,
dell'indeterminato, dell'incondizionato, potremmo anche definirlo come dimensione
dell'«originario».39 Tornano qui gli interrogativi posti nella premessa come quello circa il «non
luogo» o dimensione «pre-originaria» dell'ascolto, ma anche quello relativo alla non coincidenza
dell'io con sé. Tali questioni ci rimandano direttamente ad Altrimenti che essere opera in cui
Levinas perviene alla ridefinizione del soggetto umano attraverso una nuova dimensione di
femminilità. Per il momento, tuttavia, resta ancora priva di risposta una domanda fondamentale:
in che modo, infatti, il femminile ci conduce all'altrimenti che essere?
Questo tema costituirà il punto focale nel quale convergeranno le riflessioni dei prossimi paragrafi.
4. Anarchia
In Altrimenti che essere la terminologia ed il tema del femminile scompaiono misteriosamente, le
ragioni possono essere ricercate nella diversa prospettiva che il testo assume: il problema non
consiste più nell'individuare una trascendenza verso l'altro (come in Il Tempo e l'Altro e
parzialmente in Totalità e Infinito), bensì nel raggiungere una trascendenza all'interno dello stesso
io poiché solo quest'ultima può liberare la soggettività dal legame con la sua identità. Questa
coincidenza dell'io con sé, è quindi, per il nostro autore, la radice di ogni violenza; l'essenza, infatti,
interpretata come interessamento, si presenta come «conatus degli enti»:
Esse è interesse. L'essenza è interessamento. [...] L'interessamento dell'essere si drammatizza negli
egoismi in lotta gli uni contro gli altri, tutti contro tutti, nella molteplicità di egoismi allergici che
sono in guerra gli uni contro gli altri e, così, insieme. [...] L'essenza è così l'estremo sincronismo
della guerra.40
L'interessamento, quindi, costituisce la negazione e la sospensione di ogni forma di gratuità, infatti
qui la trascendenza diviene mera apparenza. Se nelle opere precedenti il punto nevralgico era il
rapporto medesimo-altro, nel capolavoro del 1974 è la stessa soggettività umana ad essere messa in
questione: si passa dall'essente all'altrimenti che essente.
In questa prospettiva, dunque, il tema dell'altro perde la sua priorità divenendo secondario; appare
chiaro, quindi, il motivo per cui il termine «femminile» risulti completamente assente: in questo
lavoro, infatti, il pensiero di Levinas sembra condurci verso nuovi orizzonti. Altrimenti che essere
rappresenta il tentativo di mostrare come anche nell'identità umana si realizzi la rottura
dall'essenza, frattura che ha la peculiarità di precedere l'ontologia e di essere accaduta in un
passato mai stato presente; ciò è evidente nelle analisi che vengono dedicate alla relazione tra
«dire» e «detto»:
Il dire precisamente non è un gioco. Anteriore ai segni verbali che esso coniuga, anteriore ai sistemi
linguistici e ai riflessi semantici -- prefazione alle lingue -- esso è prossimità dell'uno all'altro,
impegno dell'approssimarsi, la significanza stessa della significazione. [...] Il dire originale o preoriginale, il discorso della pre-fazione, annoda un intrigo di responsabilità. Ordine più grave
dell'essere e anteriore all'essere. Rispetto ad esso l'essere ha tutte le apparenze di un gioco. Gioco o
distensione dell'essere libero da ogni responsabilità in cui tutto il possibile è permesso. 41
Il dire sì presenta come la «significanza stessa della significazione», «ordine più grave dell'essere e
anteriore all'essere», esso è un atto in cui l'io si espone e si volge verso l'altro. Il dire, quindi, è
responsabilità, presupposto di ogni informazione, significato che precede la cultura, la lingua,
l'estetica e l'economia: esso rappresenta l'etica nella sua origine anarchica poiché è al di qua
dell'essere, è il pre-originario, ovvero luogo in cui la dimensione dell'ascolto
si trasforma in responsabilità incondizionata per l'altro. Il detto, invece, costituisce
l'interessamento, il gioco dell'essere, la coincidenza pacifica dell'identità con sé, esso prende corpo
solo nel contesto del dire e favorisce la comprensione del reale nella sua totalità.
Parallelamente al rapporto dire-detto, Levinas utilizza altre formule linguistiche come la dicotomia
«interessamento-disinteressamento», ma il nucleo semantico non sembra mutare. Da un lato
troviamo l'ontologia, neutralità e anonimia dell'essere, finta trascendenza, sistema linguistico che
nel tradurre il dire lo tradisce, egoismo e guerra; dall'altro l'etica, «gratuità integrale» che si
riferisce ad una «gravità estrema», momento in cui la continuità dell'essenza si inverte rinviando
ad un linguaggio pre-originale, al dire, alla responsabilità.42
Ma come è possibile che il dire costituisca un «ordine più grave dell'essere ed anteriore all'essere»?
Tornano qui gli interrogativi riguardanti il tema del «non-luogo» o dimensione pre-originale;
quale legame sussiste, infatti, tra il «dire pre-originale» e la responsabilità? Per rispondere a
queste domande è necessario fare un passo indietro e considerare alcune pagine dell'Umanesimo
dell'altro uomo, testo del 1972, in cui Levinas torna sul tema dell'interiorità, dimensione
fondamentale anche in vista delle tematiche che saranno sviluppate definitivamente in Altrimenti
che essere.
Ma l'accoglienza pre-originale, l'«accoglienza per eccellenza» che «ha luogo in un'interiorità
aperta» non appartiene forse alla dimensione di femminilità?43 Certamente, tuttavia quali siano le
conseguenze ultime di queste affermazioni risulterà chiaramente più avanti; intanto possiamo solo
anticipare che, in un certo senso, è la stessa femminilità a condurci verso il pre-originale (o
anarchia) perché ne conserva le tracce.
Nella sezione «Umanesimo ed Anarchia», il nostro autore mette in luce la precarietà dell'uomo: la
crisi dell'umanesimo nasce dall'esperienza del fallimento dell'azione umana. Quest'ultima consiste
nel fatto di «incominciare» e si compie all'interno della libertà della coscienza: ogni contenuto di
coscienza, infatti, essendo stato presente almeno per un istante è «rammemorabile». Tutto si
svolge nell'immanenza della coscienza intenzionale dove il senso si dà solo in riferimento all'essere,
alla luce che proiettata sull'oggetto vince la sua resistenza; il diverso entra nell'unità di un genere
dando luogo, così, ad un processo di omogeneizzazione continua. Stando così le cose, la ragione si
presenta come «archeologia», cioè tensione verso la scoperta dell'origine, luogo che contiene in sé i
primordi dell'essere e della verità; tutto ciò che entra nell'io cosciente, infatti, si riduce a
manifestazione e diviene presente. L'intelligibilità del soggetto, quindi, consiste nel ritorno
all'origine: movimento che costituisce il «porsi del sé».44 L'io qui è un'identità identificante, «il
suo uscire da sé è un restare presso sé per adeguare l'essere»:
Ma già nel ricorso all'infinito del sollen, che deriva dal soggetto posto come io, origine di se stesso o
libertà, si annunzia lo scacco incluso nell'atto umano e sorge l'anti-umanesimo che ridurrà l'uomo a
mezzo, necessario all'essere per potersi riflettere o mostrare nella sua verità, ossia nel
concatenamento sistematico dei concetti. [...] Non è possibile trovare un senso (un senso alla
rovescia, è vero, ma il solo autentico qui) alla libertà medesima, partendo proprio da quella
passività dell'uomo in cui sembra che appaia la sua inconsistenza?45
Tra l'umanesimo (secondo cui l'uomo è misura dell'essere) e l'anti-umanesimo (riduzione
dell'uomo a mezzo dell'essere), Levinas sceglie un'altra strada: il senso, infatti, non nasce né dal
«porsi del sé» come origine, né dall'essere dell'ente o dal sistema. Il nostro autore propone un
concetto radicale di passività: si tratta di una passività anteriore al piano ontologico, «anteriorità
pre-originaria e metafisica»; appare evidente, quindi, come da questo stato di passività che abita
l'umano scaturisca in realtà la stessa possibilità di trovare un senso alla libertà.46 Levinas,
pertanto, si domanda se cercare l'identità umana nella passività radicale non significhi sopprimere
il soggetto abbandonandolo così alla fatalità o al determinismo, ma la sua risposta è negativa
poiché l'alternativa libero-non libero non ha significanza ultima; infatti la soggettività non si ferma
all'originario, se così fosse saremmo esclusivamente nella dimensione del «cominciare», luogo
della libertà dell'io. Diversamente, per il nostro autore, prima della libertà o della necessità vi è
qualcos'altro:
L'al di là o pre-originario o il pre-liminare designano -- per abuso linguistico, naturalmente -- la
soggettività anteriore all'io, anteriore alla sua libertà e alla sua non-libertà. Soggetto pre-originario,
oltre l'essere, in sé. [...] L'interiorità è il fatto che nell'essere l'incominciare stesso sia preceduto, ma
che ciò che precede non si presenti al libero sguardo che l'assumerebbe, non si faccia mai né
presente, né rappresentazione; qualcosa è già passato sopra la testa del presente, non ha
attraversato il cordone della coscienza e non si lascia recuperare; qualcosa che precede l
'incominciare e il principio, qualcosa che è anarchicamente, malgrado dell'essere, inverte o precede
l'essere. Ma si tratta poi di qualcosa?47
Entra in gioco qui il concetto di an-archia, cioè mancanza di inizio, l'intenzionalità non è assoluta
ed escludente nella sua attività, c'è qualcosa che non è ricondotta a lei e quindi non può essere
portata a presenza; la coscienza non può né auto-comprendersi, cioè non può essere oggetto di se
stessa, né auto-giustificarsi: la sua attività nasce da una passività, una durata che è fuori
dall'attività dell'io, «temporalità del tempo che sfugge, attraverso il suo lasso, ad ogni attività di
rap(ri)presentazione».48 Qui il capovolgimento di Levinas diviene radicale: dall'attività della
coscienza intenzionale si passa alla pura passività del pre-intenzionale, non-luogo dell'indicibile e
dell'interiorità. Il pre-intenzionale o non-intenzionale, dunque, è una passività immediata ed il suo
primo caso è l'accusativo; la coscienza è accusata e responsabile della sua stessa presenza, il sé non
è più io: nella sua immediatezza, infatti, la coscienza è colpevolizzata del suo ritardo (non si può
segmentare l'istante) verso altro. Qui si tratta di una passività inassumibile che si nomina per
abuso linguistico, «un rovescio che non si può rivoltare», siamo nella dimensione che Kant
definirebbe come «incondizionato», termine che rimanda all'indeterminabile, cioè alla dimensione
del non-oggetto e dell'infinito; ecco perché Levinas si domanda se ciò che precede l'incominciare
sia definibile come»qualcosa», ovviamente la risposta è negativa perché se così non fosse saremmo
di nuovo nell'orizzonte dell'essere.
Qui si sta cercando di sondare l'indefinibile, «non-luogo» in cui infinito e nulla sembrano
coincidere nell'assoluta mancanza di forme. In questa dimensione riemerge con vigore il senso del
mistero che pervade l'umano e grazie al quale è possibile balbettare (tradendolo) qualcosa
dell'ineffabile; è proprio qui, infatti, che la femminilità risulterà fondamentale, ma procediamo con
ordine. Nella prospettiva levinassiana il pre-intenzionale (o non-intenzionale) diviene traccia di un
silenzio pre-originario dell'io in cui la dimensione dell'ascolto resta la condizione ultima di
possibilità della responsabilità etica, così, a nostro giudizio, l'interiorità umana diviene «offerta
come dimora per la parola». Il parlare diviene, dunque, elemento divino; la parola, infatti, è
manifestazione oggettiva di una dimensione trascendente: ora essere io consiste nel dover
rispondere del proprio diritto d'essere.
L'ineffabile o l'incomunicabile dell'interiorità, che non si lascia contenere nel detto -- è una
responsabilità anteriore alla libertà. L'indicibilità dell'ineffabile si descrive come il pre-originario
della responsabilità per gli altri, come responsabilità anteriore ad ogni libero impegno, prima
ancora di descriversi come incapacità di apparire nel detto.49
Da «archeologia» ad «anarchia», la soggettività umana ha il suo senso al di là dell'essere perché
essa incarna la presenza di una responsabilità senza inizio e anteriore a qualsiasi impegno. Il preoriginario è «dire» e significa responsabilità: scoprirsi, esporsi ed essere pronti ad espiare la
violenza subita per colpa altrui. Il soggetto assume una responsabilità per la quale non aveva preso
nessuna decisione, ma da cui non può sfuggire; egli, infatti, prima ancora di essere intenzionalità, è
responsabilità incondizionata ed ostaggio insostituibile degli altri (questo sarà uno dei temi
principali di Altrimenti che essere). La soggettività del soggetto non spicca sull'essere in virtù
dell'arbitrio, ma a causa di una «suscettibilità pre-originaria» che ridefinisce drasticamente
l'umano.50 Non siamo più degli io, ma dei sé: il soggetto nasce come risposta; dal parlare al
rispondere in virtù di un ascolto «immemorabile». Dal piano teoretico (dicibile, ordine del sapere,
presenza e rappresentazione) del detto (fondazione dell'essere che è nell'essere), si passa a quello
pratico (etica, faccia a faccia e discorso) del dire (responsabilità anteriore alla libertà), interiorità
ineffabile che non si lascia contenere e che non giunge mai a manifestazione in modo completo.
Alla luce di tutto ciò, considerando il tema dell'interiorità, per altro centrale nell'Umanesimo
dell'altro uomo, la metamorfosi della prospettiva levinassiana si manifesta in tutta la sua evidenza.
In Totalità e Infinito, infatti, dominava la rilettura dell'idea d'infinito cartesiana, lo stesso
sottotitolo dell'opera (Saggio sull'esteriorità) ci rimandava ad una dilatazione nello spazio; lì c'era
l'individuazione di una distanza: l'io che «pensa più di quanto possa pensare» rappresentava in
realtà la separazione stessa. Nell'idea d'infinito, infatti, il pensiero umano si rende conto che la
distanza tra ideatum ed idea costituisce il contenuto dell'ideatum stesso, ovvero l'infinito.51
Nell'Umanesimo dell'altro uomo e due anni più tardi in Altrimenti che essere, Levinas sostituisce
l'ampliamento spaziale con una regressione temporale ponendosi così sulle tracce di un passato che
non è mai stato presente ed in cui ogni tentativo di rammemorazione risulta impossibile. Se il
nucleo centrale del testo del 1961 era l'esteriorità, dimensione incarnata dal volto, cioè l'infinito, ciò
che è al di là dell'essere e della totalità; nell'Umanesimo dell'altro uomo, invece, prevale
l'interiorità, non-luogo della soggettività anteriore all'io o «soggetto pre-originario oltre l'essere, in
sé»:
L'interiorità non si descrive in termini spaziali di alcun genere, come il volume di una sfera
avviticchiata e suggellata ad un altro, ma che, formata come coscienza, si rifletterebbe ancora nel
detto e apparterrebbe così allo spazio comune a tutti, all'ordine sincronico; neanche se
appartenesse alla regione più segreta della sfera.52
L'interiorità appare qui come quell'«al di là che non può essere descritto in termini spaziali» poiché
se fosse così si ricadrebbe nell'«ordine sincronico» e nel detto. La dimensione dell'interiorità
implica una passività inassumibile, ineffabile ed incomunicabile, quindi una trascendenza
incontrovertibile. Questo passo sembra sancire una differenza abissale con le considerazioni che,
undici anni prima, lo stesso Levinas aveva dedicato al tema dell'interiorità in Totalità e Infinito.
Nella sezione seconda dell'opera suddetta, infatti, il nostro autore aveva individuato nella dimora il
luogo dell'interiorità, lì emergeva chiaramente il legame con lo spazio, ma non solo: l'a-casa
propria, l'intimità e la familiarità che costituivano l'interiorità, in realtà presupponevano l'essere
femminile, condizione dell'accoglienza e dell'ospitalità. La donna, quindi, in accordo a Levinas,
faceva di una casa «luogo d'accoglienza», l'essere femminile infatti era «accoglienza ospitale per
eccellenza», discrezione, «accoglienza ospitale in sé prima dell'etico» e, soprattutto, ciò che
rendeva il proprietario della casa un «guest». Alla luce di tutto ciò, possiamo affermare che le
analisi levinassiane di Totalità e Infinito presentano l'idea secondo cui la dimensione
dell'interiorità è la femminilità stessa.53
La dimora lascia intravedere la metamorfosi dello stesso soggetto, infatti l'«host» si scopre «guest»
e scorge le tracce di una compagnia pre-originale, cioè un'interiorità che lo ha accolto in un passato
immemorabile: L'io è ospite di se stesso perché è donato a se stesso. Stando così le cose, il
femminile che è presenza silenziosa nella dimensione interiore del soggetto, svela all'io il suo stato
di passività originaria pur restando immanenza legata alla dimensione spaziale dell'abitazione.
In Totalità e Infinito Levinas aveva anticipato già il fatto che il femminile non è una realtà
empirica, bensì «uno dei punti cardinali in cui si situa la vita interiore». La dimensione di
femminilità, quindi, veniva intesa qui come «accoglienza della dimora».54
Nell'Umanesimo dell'altro uomo l'interiorità diviene trascendenza. Pur non essendo mai citato,
infatti, appare chiaramente come il femminile ci conduca verso la trascendenza dell'io, cioè verso
un nuovo concetto di interiorità che implica una passività pre-originale in cui la soggettività diviene
responsabilità; tuttavia, se prima lo era a partire da un'accoglienza silenziosa, quella del femminile,
condizione dell'etica stessa, ora la sua trasformazione avviene prima del tempo, cioè prima della
possibilità di dire «sì». Questa responsabilità anarchica implica un'ubbidienza anteriore al
ricevimento di ordini, essa precede la presentazione del comandamento che obbliga alla
responsabilità, cioè libera l'io da sé ordinandolo all'altro:
La passività è l'essere dell'al di là dell'essere, del Bene, che il linguaggio ha tutte le ragioni di
circoscrivere --tradendo, naturalmente, come sempre -- in queste due parole: non-essere; la
passività è il luogo -- o più precisamente, il non-luogo -- del Bene, il suo far eccezione alla regola
dell'essere, sempre scoperto nel Logos, il suo eccettuarsi dal presente. [...] È la responsabilità che
oltrepassa la libertà, vale a dire la responsabilità per gli altri. È la traccia di un passato che si nega
al presente e alla rappresentazione, traccia di un passato immemorabile.55
L'interiorità, passività inassumibile, è il «non-luogo» del Bene, ovvero «traccia di un passato
immemorabile» identificato dal nostro autore come «l'essere dell'al di là dell'essere». La
trascendenza diviene qui struttura etica, il richiamo platonico è evidente: come il Bene al di là
dell'essenza (epékeina tes ousìas) non può essere espresso in termini di essere (infatti il linguaggio
nel tentativo di portare alla luce l'ineffabile, lo tradisce) poiché il primo precede il secondo, così il
comandamento indicato da Levinas non può essere posto a livello di coscienza (quindi di arbitrio)
in quanto essa gli è posteriore; questa prescrizione è elezione immediata alla responsabilità.
Se in Totalità e Infinito la dimora, in cui la figura della donna recitava il ruolo fondamentale
dell'accogliente per eccellenza, era una casa assegnata attraverso la scelta di un'elezione,
nell'Umanesimo dell'altro uomo l'interiorità diviene una breccia sul passato anarchico, momento
in cui l'io è scelto e si costituisce pre-originariamente come risposta: prima di essere volontà,
infatti, l'io diventa me ed è anarchicamente sottomesso al Bene. Nell'Umanesimo dell'altro uomo,
la dimensione di femminilità che in Totalità e Infinito compariva come «condizione pre-etica
dell'etica» e «accoglienza della dimora», diviene origine anarchica dell'etica, accoglienza preoriginaria che «ha luogo in un luogo non appropriabile ed in un'interiorità aperta»; essa diviene
elezione al Bene, responsabilità anarchica ed incondizionata, trascendenza che lascia dietro di sé le
tracce di una gratuità infinita:
Proprio in questa prospettiva, aperta dall'irrecusabile responsabilità per gli altri -- o dalla positività
del Bene -- sarà possibile, forse, dire la creazione ex nihilo: passività che esclude persino la
recettività, perché nella creazione ciò che sarebbe in grado di assumere, al livello minimo, l'atto -come materia che assume, grazie alle sue potenze, la forma che la permea -- non sorge se non dopo
che l'atto creatore sia stato compiuto. Tesi che non ha la pretesa -- o la debolezza -- di arrivare a
coincidere con l'affermazione dogmatica della creazione.56
Attraverso la femminilità siamo giunti ad una dimensione di passività originaria che rinvia alla
possibilità di pensare la gratuità e la misericordia infinita della creazione dal nulla, momento in cui
l'io è donato a se stesso: la creatio ex nihilo, infatti, comporta la pienezza di un amore (agape) in
virtù del quale l'origine anarchica dell'etica e l'accoglienza assoluta trovano il loro senso ultimo. La
femminilità che ci ha condotto verso l'anarchia, diviene traccia di una dimensione pre-originale a
partire da cui scaturisce la possibilità del senso; pertanto, a nostro giudizio, risulta possibile
individuare nell'origine anarchica dell'etica il luogo stesso della femminilità.
Levinas non introduce la creazione come «concetto ontologico», cioè non vuole partire dal dato per
risalire alla causa prima; la nozione di creazione non può essere neanche una tesi che finisca per
coincidere con un'«affermazione dogmatica» poiché se così fosse l'io si presumerebbe increato e
quindi in grado di contestare la creazione stessa. Essa non può essere rappresentata perché non è
mai stata presente nella coscienza, tuttavia, noi, attraverso la passività inassumibile dell'interiorità,
possiamo scorgerne le tracce. La creaturalità del soggetto si colloca nell'ambito di una
responsabilità anarchica che supera la libertà, quindi l'io in quanto creatura è un ente situato nella
trascendenza che gli impedisce di essere ricondotto ad una totalità. Nella creazione, infatti,
l'infinito, contraendosi, produce l'essere e quindi si ritira dalla dimensione ontologica per lasciare
un posto all'«essere separato».57 La contrazione creatrice dell'infinito è gratuità; grazie ad essa,
quindi, l'uomo si pone come assoluto, ovvero come «per sé senza essere causa sui»: la creazione,
infatti, implica la limitazione dell'infinito creatore per favorire la libertà della creatura. 58
Dalla creatio ex nihilo, dunque, scaturisce la possibilità per il soggetto di essere inizio a se stesso;
paradossalmente, per il nostro autore, la separazione, l'interiorità, lo psichismo e persino l'ateismo
recano in se stessi l'affermazione di una gratuità pre-originaria di cui ogni essere umano,
inconsapevolmente, conserva le tracce. La creazione, infatti, dona all'uomo la possibilità di porsi
come auto-realizzazione continua e quindi come libertà, ma essa lascia alla creatura la traccia di
una «dipendenza eccezionale»: il dipendente trae da questa dipendenza, che è relazione, la sua
stessa indipendenza.59 Stando così le cose, Levinas, evitando di trattare in termini di ontologia il
rapporto tra Dio e la creatura, sviluppa l'idea secondo cui «un essere libero affonda le sue radici
nell'infinito di un Dio».60
In questa nuova prospettiva, dunque, muta anche il concetto di libertà: essa non consiste più nel
primato del soggetto (autonomia), bensì si presenta come «investitura». Nel contatto Benesoggetto, infatti, il primo si incide sul secondo trasformando la libertà in elezione alla
responsabilità; così, il fine di ogni uomo consiste ora nel divenire ostaggio dell'altro. Il soggetto,
infatti, prima di essere in riferimento all'essere si rapporta alla sua elezione: non si parte più
dall'essere, ma dal Bene. Ciò nonostante, l'io incarnato, presente nell'essere come volontà
ubbidiente, costituisce la tentazione di separarsi dal Bene: il momento in cui il soggetto pensi a se
stesso è la possibilità del male, cioè l'egoismo dell'io che si pone come la propria origine negando
così la possibilità della creazione. Nell'«interessamento» c'è l'illusione di aver rotto l'anarchica
sottomissione al Bene, ma il male, secondo il nostro autore, non può «disdire ciò che il soggetto
non ha mai negoziato» infrangendo così «la passività della soggezione pre-liminare»: il male,
infatti, è al secondo posto, ovvero è posteriore al Bene.61
La bontà anarchica può cedere il posto all'idiosincrasia, questo accade spesso e significa
dimenticare ciò che precede l'origine, ma, secondo Levinas, questa dimenticanza resterebbe
seconda e confermerebbe ciò che rimuove e nega: l'odio, l'inospitalità e la responsabilità
condizionata dall'arbitrio testimoniano che tutto inizia con il loro contrario, cioè con l'ospitalità
incondizionata e con la responsabilità indeclinabile; tuttavia alcune questioni restano aperte.
Come può, altresì, l'umano ridefinirsi scovando la via che lo condurrà al «disinteressamento» e
quindi vincere il conatus essendi trovando le tracce del dire ad esso anteriore, responsabilità preistorica ed anarchica? È possibile per l'io riscattare quella gratuità anarchica che lo ha preoriginariamente donato a se stesso rendendolo, così, ostaggio di tutti? Ed infine, che rapporto
sussiste tra la misericordia infinita della Creatio ex nihilo e la dimensione di femminilità? Tali
questioni saranno affrontate considerando alcuni passaggi di Altrimenti che essere, opera
fondamentale nell'itinerario levinassiano.
5. Altrimenti che essere
Nel capolavoro del 1974, il nostro autore giunge definitivamente ad individuare quella «nuova via»
che, fin dal saggio L'Évasione, aveva costituito la stella polare della sua prospettiva filosofica; è
davvero possibile vincere il conatus essendi trovando così le tracce di una responsabilità anarchica?
Secondo la nostra tesi è proprio in questo capovolgimento epocale che, anche se indirettamente e
senza nessun riconoscimento esplicito da parte di Levinas, risulta fondamentale la dimensione di
femminilità; in un certo senso potremmo anticipare già che sussiste un legame non poco rilevante
tra la femminilità e l'altrimenti che essere, ma è meglio fare un passo indietro e procedere con
ordine.
Il nucleo di Altrimenti che essere è espresso impeccabilmente dalle riflessioni che, nel 4º capitolo,
il nostro autore dedica al tema della sostituzione, punto in cui l'itinerario levinassiano sembra
giungere al suo esito ultimo. La maggior parte di questo capitolo era già comparsa nel 1968 nella
Revue philosophique de Louvain con il titolo di «La substitution», ma è lo stesso Levinas che,
respingendo l'idea secondo cui Altrimenti che essere fosse solo una raccolta di articoli, nella «Nota
preliminare», ci tiene a precisare che il libro in questione ha preceduto nella sua prima redazione i
testi pubblicati e che proprio il capitolo 4º ne costituisce la parte centrale.62 La sostituzione,
secondo il nostro autore, rappresenta la vera risposta alla domanda sull'autenticità dell'umano,
infatti è proprio lì che la soggettività ritrova il suo senso ultimo: se in Totalità e Infinito venivano
individuati possibilità e limiti di una trascendenza verso cui il soggetto era in tensione, in
Altrimenti che essere la stessa trascendenza, situandosi nel cuore dell'umano, diviene fonte
generatrice di senso capace di trasformare la soggettività in struttura etica. Qui risulta rilevante la
nozione di anarchia la quale è direttamente connessa al mistero della sofferenza: il dolore, infatti,
scaturisce dall'interruzione dell'auto-possesso dell'io. Il pre-intenzionale, cioè il fatto stesso che
qualcosa preceda la coscienza e l'attività del soggetto pur riguardandolo nella sua interiorità, pone
l'io in una condizione di scacco e di vertigine di fronte ad un abisso: egli scopre con sconcerto di
non essere né padrone, né principio di se stesso, infatti qualcosa eccede le sue possibilità e si
presenta come mistero indecifrabile, indicibile ed inquietante; silenzio soffocante che incombe su
di lui in quanto angoscia dell'ignoto. Questa invisibile presenza, traccia di un'origine anarchica,
diviene allora «contatto», «persecuzione» ed «ossessione»:
Irriducibile alla coscienza, anche se la sconvolge -- e, così tradita, non tematizzata nel detto in cui
essa si manifesta -- l'ossessione attraversa la coscienza controcorrente, inscrivendosi in essa come
estranea: come squilibrio, come delirio, disfacendo la tematizzazione, sfuggendo al principio,
all'origine, alla volontà, all'archè che si produce in ogni barlume di coscienza. Movimento, nel
senso originale del termine, anarchico. [...] L'anarchia arresta il gioco ontologico che, precisamente
in quanto gioco, è coscienza in cui l'essere si perde e si ritrova e, così, si chiarisce. [...] L'impresa
dell'altro si esercita sul medesimo al punto di interromperlo, di lasciarlo senza parole: l'anarchia è
persecuzione. L'ossessione è persecuzione: qui la persecuzione non costituisce il contenuto di una
coscienza divenuta follia; esso designa la firma secondo la quale l'io si addolora, che è una
defezione della coscienza.63
Nella coscienza, quindi, trova luogo la passività dell'ossessione, un patire che affonda le sue radici
al di là della stessa coscienza, qui si sta parlando di una «messa in questione anteriore
all'interrogazione» e di «una responsabilità al di là del logos della risposta», cioè di una
persecuzione che trova il suo senso ultimo nell'ambito di un'elezione pre-originaria che l'io subisce
e dalla quale scaturisce una responsabilità incondizionata verso il mondo; io non posso non andare
incontro all'altro, non posso esimermi dal testimoniare la Parola ascoltata, cioè non posso fare a
meno di trasformarmi in dono per il prossimo: ecco la vera persecuzione! È proprio nel mistero
della sofferenza che trovano la loro unione responsabilità e persecuzione; infatti la capacità di
soffrire da parte di altri (la persecuzione subita) diviene la maniera principale in cui l'io esercita la
responsabilità, «come se la persecuzione attraverso altri fosse al fondo della solidarietà con
altri».64
Come è possibile che ciò avvenga? Da dove proviene la disfatta dell'auto-referenzialità dell'io?
Levinas individua la fonte da cui si genera ogni gesto di solidarietà nel rovesciamento della
soggettività che sospende l'avida autonomia dell'io; anche la gentilezza più semplice come quella
del saluto, infatti, reca con sé la traccia dell'«altrimenti che essenza»:
Il subire a causa di altri è pazienza assoluta solo se questo a causa di altri è già per altri. Questo
transfert -- altro che interessato, altrimenti che essenza -- è la soggettività stessa. Presenti la
guancia a chi lo percuote e sappia saziarsi anche di oltraggi [Lam. 3,30] ; chiedere nella sofferenza
subita questa sofferenza (senza fare intervenire l'atto che sarebbe l'espressione dell'altra guancia),
non significa trarre dalla sofferenza una qualche virtù magica di riscatto, ma passare, nel trauma
della persecuzione, dall'oltraggio subito, alla responsabilità per il persecutore, e in questo senso,
dalla sofferenza all'espiazione per altri.65
Alla luce di queste considerazioni, la soggettività ora si presenta come «rigetto verso sé» e
responsabilità di ciò che gli altri fanno o soffrono. L'unicità dell'io, pertanto, consiste nel fatto di
portare su di sé l'intera colpa dell'umanità, ma questa condizione di passività illimitata si
percepisce solo in quanto persecuzione; senza quest'ultima, infatti, «l'io solleverebbe la testa e
coprirebbe il sé».66 Questa nuova soggettività prospettata da Levinas, presentandosi come
coincidenza dell'altro nel medesimo senza che quest'ultimo lo inglobi, risulta a tutti gli effetti una
non-identità; pertanto la responsabilità dell'ossessione, cioè la responsabilità per altri, consiste
nell'uscire da sé disintegrando l'identità stessa. L'io che in Totalità e Infinito si era scoperto
«ospite» ora diviene «ostaggio di tutti»:
L'ipseità, nella sua passività senza archè dell'identità, è ostaggio. La parola io significa eccomi,
rispondente di tutto e di tutti. La responsabilità per gli altri non è stata un ritorno a sé, ma una
contrazione esasperata che i limiti dell'identità non possono trattenere.67
Il momento cardine della ridefinizione dell'umano è, per Levinas, il gesto del sacrificio estremo che
costituisce la rottura autentica con l'ontologia e, di conseguenza, con la coincidenza dell'io con sé.
Nell'incontro con altri il soggetto scopre la sua pre-originaria responsabilità, tuttavia l'autentica
responsabilità verso qualcuno è attuabile soltanto «sostituendosi» a questi, cioè attraverso
l'immolazione. Solo grazie al sacrificio della propria vita, infatti, è possibile realizzare la
trascendenza all'interno dell'io e quindi uscire definitivamente dall'ontologia. L'altrimenti che
essere, secondo il nostro autore, consiste proprio nel «disinteressamento», cioè nel farsi carico
della miseria, della sofferenza dell'altro e persino della responsabilità che questi può avere nei
confronti del medesimo; gesto quest'ultimo che è espresso dalla condizione di ostaggio, emblema
della nuova soggettività: l'io ha sempre un grado di responsabilità in più, la responsabilità per la
responsabilità dell'altro; ossessione e persecuzione le cui conseguenze conducono all'offerta di sé.
Ricapitolando potremmo dire che l'idea di espiazione per altri significa un altrimenti che essere e
giustifica definitivamente il motto platonico che guida Levinas fin dalle sue prime opere: il Bene al
di là dell'essere. Ciò riguarda anche l'essere proprio, infatti la perdita della coincidenza dell'io con
sé, nel gesto estremo del sacrificio, significa la morte dell'io come compimento di un'adesione
totale di quest'ultimo al Bene che precede l'essere, che elegge l'io in un passato mai stato presente e
che rende il soggetto unico nella sua condizione di ostaggio. Per realizzare veramente se stesso
rispondendo all'appello pre-originario che si incarna nella chiamata inscritta nel volto dell'altro, il
soggetto non può che negare il suo arbitrio offrendosi totalmente ad altri: soltanto in questa
responsabilità di ostaggio è possibile scorgere le tracce dell'assoggettamento anarchico al Bene; la
precedenza della responsabilità sulla libertà (intesa come arbitrio), infatti, rivela proprio la bontà
del Bene. L'io, quindi, attraverso il percorso levinassiano, si riduce a «susceptio pre-originaria» e
«passività anteriore ad ogni recettività».68 La passività dell'io, nella passione, è spinta al suo limite
estremo, pertanto la «sostituzione di ostaggio» costituisce l'unicità autentica del soggetto: l'io può
sostituirsi a tutti, ma nessuno può sostituirsi a lui. La soggettività levinassiana, dunque, è ostaggio,
responsabilità, sottomissione ed espiazione anteriore all'iniziativa della volontà, essa infatti, regge
l'universo nella passività della convocazione che diviene così persecuzione indeclinabile e
sottomissione al sacrificio; ma, poiché non c'è sacrificio senza immolazione, l'elezione anarchica
alla responsabilità conduce l'io verso la spogliazione e la morte per la vita dell'altro. L'assunzione
volontaria della morte come via per la vita consente, allora, di trasformare l'odio e l'allergia nei
confronti dell'altro in ospitalità incondizionata la cui radice è la responsabilità anarchica.
La responsabilità è sempre addossamento a se stessi e mai ad un altro, così il perseguitato è
responsabile della sofferenza che subisce nonostante la sua innocenza. Alla luce di tutto ciò,
sorgono degli interrogativi inquietanti... In cosa consiste, per esempio, la colpevolezza che qui è in
gioco? Quale è il senso della sofferenza che la persecuzione causa all'io?
In Altrimenti che essere non c'è una risposta chiara ed esplicita a queste domande, per il nostro
autore, infatti, è impossibile conoscere il luogo da dove proviene la persecuzione poiché la stessa
responsabilità che rende l'io ostaggio, è il risultato di un'elezione avvenuta in un passato assoluto in
cui il soggetto neppure esisteva. L'io, infatti, non è contemporaneo della creazione ed il mondo non
si modella a seconda dei suoi progetti. Stando così le cose, risulta chiaro il motivo per cui, nelle
pagine di Levinas, siano assenti riflessioni sull'origine del male.69
Ciò nonostante, nella sua condizione di ostaggio, l'io scorge una traccia; è come se la sofferenza
nascondesse dietro la sua tragicità una possibilità ulteriore di senso: la possibilità della salvezza.
A tal riguardo, una nota di Levinas potrebbe risultare decisiva:
L'incarnazione del sé e le sue possibilità di dolore gratuito devono essere comprese in funzione
dell'accusativo assoluto del sé, passività al di qua di ogni passività in fondo alla materia che si fa
carne [...].
Ma bisogna percepire nel carattere anarchico della sofferenza, una sofferenza a causa di ciò che la
mia sofferenza ha di pietoso, che è una sofferenza per Dio che soffre della mia sofferenza. Traccia
anarchica di Dio nella passività.70
L'uomo nella passività della sofferenza scopre la traccia di Dio, cioè di un «valore unico» che non
può darsi mai come tema, concetto o rappresentazione e che appartiene ad un «passato assoluto»
ed «irriducibile a presenza», cioè ad una dimensione anarchica.71 Secondo Levinas il termine Dio
risulta dicibile solo per abuso linguistico ed è proprio per questa ragione che, nell'opera in
questione, esso si trova raramente. Questa prospettiva, insieme al fatto che il perseguitato è
accusato prima della libertà e quindi prima di una sua possibile colpa, ci permette di escludere
l'interpretazione della sofferenza come punizione: la vittima è caratterizzata da un'«inconfessabile
innocenza».
Al contrario di quanto si possa pensare, l'innocenza della vittima rinvia alla «bontà della
creazione»; infatti la persecuzione implica un'elezione senza mediazione dell'essere e rinvia ad un
passato assoluto in cui una misericordia infinita, nella sua contrazione anarchica, crea l'io
donandolo a se stesso. Pensare Dio nell'ottica levinassiana significa scorgere le tracce di una
gratuità pre-originale o valore unico che elegge l'io prima che quest'ultimo sia in grado di volerlo. A
questo valore è impossibile sfuggire, il soggetto porterà per sempre le tracce di quel contatto come
un timbro indelebile nella propria interiorità:
l'impossibilità di sfuggire a Dio (che almeno in questo, non è un valore fra valori) abita in fondo
all'io come sé, come passività assoluta. Passività che non è soltanto la possibilità della morte
nell'essere, la possibilità dell'impossibilità, ma impossibilità anteriore a questa possibilità,
impossibilità di sottrarsi; suscettibilità assoluta, gravità senza alcuna frivolezza, nascita di un senso
nell'ottusità dell'essere, di un poter morire sottomesso al sacrificio.72
La passività che abita l'umano, per il soggetto che è nell'essere, non è solo possibilità della morte,
ma un'«impossibilità anteriore», «suscettibilità assoluta», comando che giunge da un altrove e che
rende l'io «imparentato» con il Bene.73 È per questo che il male, pur presentandosi alla coscienza
dell'io come persecuzione, nello stesso tempo, diviene condizione di possibilità per la salvezza del
soggetto: l'io è eletto alla persecuzione, ma, contemporaneamente, è salvato da quest'ultima.
Nella sofferenza la coscienza prova sdegno ed orrore nei confronti del male rivelando,
indirettamente, la propria associazione al Bene. Dall'orrore e dall'ossessione causati dalla gratuità
del male che colpisce l'io innocente, si giunge così al Bene, cioè alla possibilità stessa della teofania
richiamata, per altro, dalla «scrittura impronunciabile» con cui termina Altrimenti che essere
(questo punto sarà analizzato fra poco).
Il capovolgimento del male si realizza attraverso la misericordia dell'innocente, infatti nel
sacrificio, offerta di sé in sostituzione dell'altro, il dolore trova il suo senso nel perdono. Sofferenza
e morte sono oltrepassate dalla misericordia, pertanto il sacrificio riposa non nel dolore, ma nella
pienezza della gratuità dell'amore (agape). La compassione umana è un sentimento di debito,
infatti non si può rispondere alla creazione dal nulla con la stessa gratuità, l'unica via umana di
riscatto consiste nell'assumere su di sé il male dell'altro come offerta, cioè come risposta al dono
dell'elezione pre-originaria.
L'io levinassiano, quindi, non ha più una dimensione propria, il se stesso è messo in questione
dall'altro: la soggettività trova la sua ridefinizione nella negazione del sé e nel fatto che l'io si mette
in cammino verso un tempo che non è più il suo, ma dell'altro. Pertanto, solo nel sacrificio l'umano
introduce nell'essere la pienezza del senso; infatti è proprio nella gratuità che trova vera luce il
mistero dell'uomo: essa è pienezza di senso che sconquassa l'essere nell'evento del dono di sé.
Attraverso il mistero della sofferenza siamo giunti alla verità della misericordia; in questo modo si
passa dal silenzio umano, momento in cui il soggetto si pone come essere separato (psichismo e
ateismo), a quello divino in cui l'io, negando se stesso per far posto all'altro, nella sua incondizione
di ostaggio scopre la traccia di Dio:
In questa opera che non cerca di restaurare nessun concetto decaduto, la de-stituzione e la desituazione del soggetto non restano senza significato: dopo la morte di un certo dio abitante dietro
ai mondi, la sostituzione dell'ostaggio scopre la traccia -- scrittura impronunciabile -- di ciò, che
sempre già passato -- sempre esso (il) -- non entra in nessun presente e a cui non convengono più i
nomi designanti gli esseri, né i verbi in cui risuona la loro essenza -- ma che, pro-nome, segna col
suo sigillo, tutto ciò che può portare un nome.74
Questo è il punto di arrivo di Levinas: la possibilità della redenzione si gioca attraverso il sacrificio
dell'io che nel dono della propria vita riscatta la sua elezione pre-originaria trasformandosi, così, in
dono per l'altro. Nella sostituzione è possibile scoprire la traccia di Dio che, assente e distante,
diviene presente in virtù dell'azione umana che gli rende testimonianza nella misericordia; ma è
proprio qui che il filosofo lituano sembra interrompersi... Il cuore di Altrimenti che essere, infatti,
sembrerebbe esaurirsi nella dinamica del disinteressamento sviluppata dall'autore nel corso
dell'opera in questione, allora verrebbe spontaneo chiedersi come mai, all'interno di un'indagine
sul femminile, ci si sia soffermati a lungo sulla sostituzione e sull'anarchia; temi, questi ultimi, che
non sembrerebbero affatto legati con le analisi sull'essenza femminile. Alla luce del percorso fin qui
esaminato, la connessione dell'altrimenti che essere con la dimensione di femminilità presentata
più volte in queste pagine, risulterebbe infondata, sia per l'assenza del termine, poiché nell'opera in
questione il femminile non è mai citato, sia per l'evidente inconsistenza semantica; tuttavia alcune
questioni restano aperte. Tenerezza, pietà, responsabilità e misericordia, termini questi ultimi che
rimandano ad una dimensione pre-originaria, non sono forse espressioni di un linguaggio
tipicamente femminile?
Nell'ultima pagina di Altrimenti che essere (alcune righe prima della citazione precedente),
Levinas, quasi involontariamente, fa trasparire dalle sue considerazioni alcuni indizi che, una volta
analizzati, potrebbero favorire nuovi orizzonti possibili di indagine:
Per il poco di umanità che orna la terra è necessario un allentamento dell'essenza al secondo grado:
nella giusta guerra alla guerra, tremare -- ancora fremere -- in ogni istante, a causa di questa
giustizia stessa. È necessaria questa debolezza. Era necessario quest'allentamento senza viltà della
virilità per il poco di crudeltà che le nostre mani ripudieranno.75
Queste ultime frasi di Levinas, oltre a sintetizzare tutto il suo percorso filosofico, presentano alcuni
punti enigmatici che, una volta analizzati e connessi con altri frammenti sparsi in tutta la sua
opera, potrebbero risultare indizi importanti in vista di un'interpretazione alternativa sul senso
profondo dell'altrimenti che essere.
Nel passo sopra citato, l'urgenza del nostro autore consiste sempre nell'uscire dall'ontologia
invertendo la tendenza dell'essenza (la cui massima espressione consiste nello scontro e quindi
nella guerra), ma i termini usati per descrivere questo «disinteressamento» ci appaiono
quantomeno sorprendenti: il capovolgimento passa attraverso «la debolezza». Quest'ultima
costituisce la via che conduce verso un «allentamento dell'essenza»; secondo Levinas infatti, è
grazie ad essa che l'avversione al conatus essendi diviene una «giusta guerra alla guerra». Ma la
«debolezza» non è tradizionalmente uno dei tratti femminili per eccellenza?
La frase immediatamente successiva sembra eliminare ogni possibile dubbio. Quello che
precedentemente era stato definito come «allentamento dell'essenza» ora diviene «allentamento
senza viltà della virilità»: la debolezza come risposta possibile alla violenza della guerra è messa in
opposizione alla virilità, tipico tratto maschile caratterizzato dalla potenza, dall'attività e dal
possesso. È come se Levinas ci stesse dicendo che tutto il suo percorso consiste nel passaggio da un
punto di vista maschile ad uno femminile e che la gratuità, espressa in molteplici forme (perdono,
prossimità, responsabilità, espiazione per altri), costituisce la pura dimensione femminile radicata
nel cuore di ogni essere umano. Se queste supposizioni fossero vere, allora il senso autentico
dell'umano, secondo Levinas, sarebbe profondamente connesso con la femminilità. Ma ospitalità,
misericordia, responsabilità e sacrificio, in fondo nascondono ancora un residuo di maschilismo
oppure appartengono effettivamente ad un linguaggio femminile?
Diverse sono le testimonianze che meriterebbero di essere citate, tuttavia ci limiteremo ad evocare
esclusivamente tre voci.
Carolina Carriero, nell'articolo dal titolo: Il paradigma della corporeità nel pensiero femminile:
l'oblazione come oltrepassamento della responsabilità etica verso l'altro, conclude le sue analisi
affermando che «il pensiero femminile diviene il riflesso della capacità umana d'amare».76
Secondo l'autrice, infatti, l'amore che Adamo provò nei confronti di Eva lo condusse verso «una più
profonda comprensione di sé e del proprio destino», fino al punto che, nello stesso istante in cui la
guardò, egli acquistò «la vocazione a morire a sé per essere amore per l'altro». Alla luce di queste
nuove considerazioni, le forme di gratuità ed in particolare l'immolazione per altri, non solo
appartengono ad un linguaggio femminile, ma sono generate addirittura da un'originaria
dimensione di femminilità: è da Eva, infatti, che si origina l'amore che Adamo sente accadere
dentro di sé e soltanto a partire da quel momento egli è realmente in grado di dare la vita per lei.
Queste conclusioni trovano conferma nei risultati di alcune ricerche scientifiche svolte da Carol
Gilligan, la quale, in un noto studio del 1982 (Con voce di donna: etica e formazione della
personalità), caratterizzando l'etica maschile in termini di giustizia, diritti, norme e l'etica
femminile in termini di responsabilità, compassione ed interdipendenza, giunse a distinguere la
natura delle due etiche in virtù dei diversi percorsi di evoluzione psicologica che ciascun sesso
intraprende. Secondo Gilligan lo sviluppo dell'identità maschile è molto diverso da quello
femminile, infatti per l'uomo la «separazione» e l'«individuazione» sono profondamente connesse
allo sviluppo dell'identità sessuale, laddove per la donna sono in diretta opposizione. Ciò è spiegato
dal fatto che, mentre per lo sviluppo dell'io maschile è essenziale la «separazione» dalla madre, per
quello femminile risulta fondamentale l'«attaccamento»; sicché, mentre i maschi sono minacciati
dall'«intimità» e tenderanno quindi ad avere problemi di rapporto, le donne risultano intimorite
dalla «separazione» e avranno problemi di «individuazione».77
Attraverso queste analisi, dunque, risulta evidente il motivo per cui un'etica caratterizzata dalla
sensibilità ai sentimenti, dalla compassione e, soprattutto, dalla responsabilità per gli altri, sia
considerata come femminile: l'evoluzione della donna non passa, come quella dell'uomo, attraverso
il perseguimento di valori astratti, universali ed impersonali (cioè la formazione canonica di una
coscienza morale), bensì attraverso la capacità di immedesimarsi negli altri e nelle loro sofferenze.
Alla luce di queste considerazioni, quindi, l'estremo gesto del sacrificio su cui si incentra Altrimenti
che essere, appare sempre più come il compimento di un percorso proteso verso la piena
realizzazione di un'etica femminile.
A questo punto ci sembra opportuno evocare la voce di Giovanni Salmeri che, nell'articolo dal
titolo: L'altro e la misericordia. L'itinerario del femminile in Levinas (del quale in queste pagine
c'è molto più che una semplice citazione), in virtù delle teorie di Gilligan, giunge a prospettare
un'interpretazione dell'itinerario levinassiano suggestiva e, per certi aspetti, rivoluzionaria:
Se questa ipotesi è fondata [le teorie di Gilligan], bisognerebbe concludere che il mutamento di
prospettiva adottato da Levinas nel passaggio da Totalità e Infinito ad Altrimenti che essere ha
ottenuto i suoi effetti in modo ancora più perfetto di quanto esplicitamente dichiarato: la
femminilità scompare -- è vero -- da una considerazione esplicita, perché non viene più tematizzata
la trascendenza verso l'altro, ma il fatto che la trascendenza ora avvenga nel soggetto fa sì che la
femminilità venga descritta dentro ad esso, venga anzi identificata con la soggettività stessa, come
se l'umanità stessa non fosse pensabile senza una matrice di femminilità -- di tenerezza e di
accoglienza -- alla sua base.78
Secondo questa tesi, alla quale noi ci associamo, il femminile spinge Levinas a riformulare la stessa
nozione di soggettività umana fino a scorgere in essa le tracce di una misericordia anarchica che, da
sempre presente e mai tematizzabile, costituisce il mistero profondo dell'umano. Secondo questa
prospettiva, infatti, alla base della nuova soggettività levinassiana ci sarebbe una matrice femminile
pre-originaria riscontrabile nell'accoglienza, nella responsabilità e nella prossimità. In parte, ciò
sarebbe confermato da Totalità e Infinito, opera in cui Levinas individua la condizione di
possibilità della stessa ospitalità umana in un'accoglienza pre-originaria (o gratuità anarchica) di
cui il soggetto può scorgere solo una traccia. Pur accettando queste analisi, restano da chiarire
alcune questioni. Per esempio, alla luce di questa nuova dimensione di femminilità quale
diverrebbe il significato autentico dell'«altrimenti che essere»? La femminilità sarebbe in un certo
senso connessa con la misericordia infinita della creazione dal nulla?
6. Misericordia e Shekhinah
In «Essenza e disinteressamento» (1º cap. di Altrimenti che essere), Levinas spiega che l'altrimenti
che essere non equivale né all'essere altrimenti, né al non essere poiché «l'essere dell'essere domina
lo stesso non essere»; infatti tra i due si crea una sorta di «dialettica speculativa» secondo cui il
vuoto lasciato dal non essere è subito riempito dall'anonimia del c'è. Per il nostro autore, quindi, il
problema della trascendenza non risiede nella falsa dicotomia essere-non essere, bensì in una
differenza radicale che eccede i due termini in questione: l'altrimenti che essere o «altro
dell'essere», pertanto, implica una «differenza al di là di quella che separa l'essere dal nulla» e
questa differenza è trascendenza.79
Alla luce delle considerazioni levinassiane e, soprattutto, della tesi secondo cui la femminilità venga
identificata con la stessa soggettività, Giovanni Salmeri, nel suo articolo, pone una domanda che, a
nostro avviso, risulta fondamentale per il prosieguo della presente trattazione:
Insomma: se l'altrimenti fosse inteso come negazione, ciò che si otterrebbe sarebbe ancora una
volta l'anonimità, il neutro, ma non è allora così confermata l'ipotesi prima formulata, che cioè nel
pensiero di Levinas, più meno coscientemente, sia la femminilità (qui intesa come capacità di
compassione e di tenerezza) ad evitare che l'universalità dell'essere si rivolti nell'indecifrabilità di
un brusio?80
Questa domanda raggiunge il cuore di Altrimenti che essere e quindi il senso ultimo del percorso
filosofico di Levinas; infatti, se queste ipotisi fossero fondate, la femminilità non rappresenterebbe
soltanto una via in grado di condurci verso l'altrimenti che essere, bensì costituirebbe l'essenza
stessa della nuova soggettività: paradossalmente l'altrimenti che essere andrebbe a coincidere con
la stessa femminilità.
A questo punto verrebbe spontaneo chiedersi quale sia, all'interno delle opere di Levinas, il vero
significato del termine femminilità o dimensione femminile e, soprattutto, se l'ipotesi presentata
prima attraverso l'articolo di Giovanni Salmeri possa essere legittimata da alcuni dati.
Per quanto riguarda il senso della femminilità saremo più chiari in seguito, per ora possiamo solo
dire che compassione, responsabilità, ospitalità e misericordia implicano l'essenza femminile;
invece per ciò che concerne la questione delle prove, è lo stesso Levinas che nel corso delle sue
opere ci lascia degli indizi preziosi.
È come se ci trovassimo di fronte ad un percorso, quello levinassiano, che pur giungendo ad un
vero e proprio ribaltamento del paradigma occidentale, lasci, tuttavia, alcuni fili pendenti che, una
volta connessi, possano favorire nuovi possibili orizzonti di interpretazione.
L'ipotesi di Salmeri è corroborata da almeno quattro indizi.
Il primo si trova nella metamorfosi dell'io in relazione con il tempo.
In Il Tempo e l'Altro il soggetto era posto di fronte ad una trascendenza che rimandava ad un
futuro assoluto: l'assolutamente altro che metteva in questione l'io era rappresentato dal
femminile. L'esistente, nella sua coincidenza con sé, era padrone della sua esistenza e questo
dominio veniva identificato con il maschile («virile potere del soggetto», «virilità»e «sovranità», Il
tempo e l'altro, p. 27); tuttavia l'interruzione di questa tendenza (che in Altrimenti che essere sarà
definita come «allentamento senza viltà della virilità», p. 229) avveniva grazie al femminile inteso
come «alterità per eccellenza» e «mistero» che sfugge ad ogni tentativo di presa della coscienza;
così il femminile diveniva la «trascendenza temporale di un presente verso il mistero
dell'avvenire». In questo periodo il nostro autore giunge ad identificare il tempo con l'alterità
femminile; alla luce di ciò, secondo l'ottica levinassiana, nel momento stesso in cui Eva viene
creata, Adamo non solo è in grado di dire io poiché instaura la sua prima relazione autentica, ma, e
questa è la vera novità, attraverso il rapporto con Eva egli, per la prima volta, entra in relazione con
il tempo: è come se Levinas ci stesse dicendo che, per il maschile, il tempo nasce con la comparsa di
un tu femminile. Questo punto di vista ancora palesemente maschile, cambierà radicalmente nel
corso delle sue opere.
In Totalità e Infinito il femminile, pur essendo immanenza, diviene «l'accogliente per eccellenza»
che abita la dimora prima di qualsiasi altro abitante; solo in virtù della presenza femminile, infatti,
è possibile un'interiorità.
Qui il tempo che in precedenza veniva inteso come futuro assoluto trascendenza ed esteriorità,
sembra mutare improvvisamente e divenire quindi una dimensione interiore proiettata verso il
passato; esso comincia ad abitare l'io nella sua profondità e tutto questo grazie alla relazione intima
io-tu con la femminilità. (Si veda il paragrafo 3 del presente articolo).
Nell'Umanesimo dell'altro uomo ed in Altrimenti che essere, pur scomparendo il termine
«femminile», resta comunque la riflessione sul tempo. Se in Totalità e Infinito l'interiorità
rappresentata dall'abitazione era qualcosa di immanente, ora essa rinvia ad un passato mai stato
presente, non luogo dell'elezione pre-originaria della soggettività e quindi della passività radicale
del soggetto. Il tempo qui diviene proiezione al passato assoluto e quindi possibilità di pensare alla
misericordia infinita della creazione, pertanto esso, di nuovo trascendenza, abita l'io e lo destruttura dall'interno. Se in tutti i testi di Levinas la femminilità è legata all'interiorità e al tempo,
allora possiamo affermare che anche in Altrimenti che Essere, pur non essendo mai nominata, essa
sia la radice da cui si genera la nuova identità del soggetto.
Secondo queste considerazioni, dunque, grazie alla metamorfosi del tempo, si giunge ad un essere
maschile (Il tempo e l'Altro in cui l'auto-possesso dell'io era identificato con il maschile), ad un
altrimenti che essere femminile (Umanesimo dell'altro uomo e Altrimenti che essere).81
Seguendo questo percorso levinassiano, attraverso la regressione nel tempo, si giunge così ad
individuare la traccia di Dio («scrittura impronunciabile»), ovvero ciò che è «sempre già passato e
non entra in nessun presente». Ma allora non è forse possibile azzardare l'ipotesi che senza
l'essenza femminile non si giunge alla «scrittura impronunciabile»?
Ad ampliare il dubbio scaturito da quest'ultima domanda c'è un secondo indizio ancora più
ambiguo: la diversa considerazione della materialità.
Se in Il Tempo e l'Altro essa era imputata dell'«incatenamento a sé della soggettività», adesso essa
viene intesa come incarnazione, cioè diviene la stessa possibilità di una identità intesa come
sostituzione. In Altrimenti che essere la sensibilità diviene «esposizione all'altro», segno di una
possibilità originaria che rovescia la persistenza dell'essenza. Il corpo diventa condizione di
possibilità per la prossimità, poiché è grazie ad esso che l'io può avvicinarsi all'altro e così «dare la
propria pelle».82
In ultima analisi, quindi, si passa dalla pesantezza della materia intesa come causa della solitudine
(Il Tempo e l'Altro), alla prossimità dove si realizzano ospitalità e misericordia (Altrimenti che
essere). Posto che il sacrificio della sostituzione appartiene ad un linguaggio femminile (si vedano
le considerazioni di Gilligan e Carriero), è possibile affermare che è grazie all'essenza femminile che
nell'altrimenti che essere (sostituzione dell'io che vince l'ontologia) si giunge ad intravedere la
traccia di Dio. Secondo questa nostra tesi, infatti, il femminile diviene addirittura la via che
conduce alla misericordia di Dio; ma questo sarà chiaro più avanti.
Il terzo indizio è costituito dal tema della misericordia.
Se essa in Totalità e Infinito veniva affidata completamente al figlio, il quale, con la sua nascita,
rappresentava l'annullamento della colpa insita in modo necessario nell'identificazione con sé (cioè
una «nuova storia perdonata»), in Altrimenti che essere la misericordia diviene espressione della
sostituzione.83
L'essenza, nella sua serietà di persistenza nell'essenza, colma ogni intervallo del nulla che verrebbe
ad interromperlo. Essa è una compatibilità rigorosa in cui, secondo un'espressione banale, nulla si
perde e nulla si crea. [...] La libertà nel senso autentico non può essere che una contestazione di
questa compatibilità attraverso una gratuità. Questa gratuità potrebbe essere la distrazione
assoluta del gioco senza conseguenze, senza tracce ne ricordi, di un puro perdono. O al contrario
responsabilità per altri ed espiazione.84
Qui il perdono (o misericordia) è messo a confronto con l'espiazione e la responsabilità per altri;
ma esso in quanto simbolo di una nuova soggettività non è forse la risposta dell'io alla gratuità preoriginaria dell'elezione al Bene?
Questa sostituzione che esprime l'originaria dimensione femminile del soggetto non costituisce
forse l'immagine di una misericordia infinita da cui è scaturita la creazione stessa?
In Altrimenti che essere il perdono, espresso dalla sostituzione, porta un nome preciso: diviene
espressione dell'amore materno; la madre, infatti, non è forse l'emblema della passività e della
responsabilità di fronte all'evento del concepimento del figlio? Questo tema costituisce il quarto
elemento della nostra trattazione.85
Nel nostro itinerario, il tema della maternità è forse quello più suggestivo poiché riunisce in sé tutti
gli altri punti e ci consente così di raggiungere il cuore della nostra tesi. Già in Difficile libertà
Levinas si era soffermato sull'importanza del ruolo che la donna ricopre nella vita e nella società
umana alla luce della sua matrice giudaica.
In questo testo infatti, a differenza di Altrimenti che essere, sono presenti continui riferimenti alla
Bibbia ebraica, al Midrash e al Talmud; pertanto, in tale contesto culturale, il ruolo del femminile
in generale e la figura della madre in particolare, assumono una connotazione specifica:
Senza la donna l'uomo non conosce né bene, né aiuto, né gioia, né benedizione, né perdono: niente
di ciò di cui un'anima ha bisogno! [...] Niente di ciò che trasforma la vita naturale in etica, niente di
ciò che permette di vivere una vita, nemmeno la morte che si muore per un altro. Certi dicono che
l'uomo senza la donna diminuisce nel mondo l'immagine di Dio. E questo ci conduce verso un'altra
dimensione del femminile: la maternità.86
Queste parole di Levinas sono a dir poco sorprendenti, infatti non solo egli indica nella femminilità
la via che conduce verso la scoperta del Bene e della misericordia, ma, addirittura, fa di essa la
condizione stessa della realizzazione dell'etica nel mondo. A questo punto riteniamo opportuno un
ulteriore chiarimento: nell'ottica ebraica la femminilità aumenta nel mondo l'immagine di Dio
specialmente se si considera la particolare dimensione femminile rappresentata dalla maternità,
poiché essa costituisce la salvezza dell'umanità e permette di «compiere Israele» moltiplicando
l'immagine di Dio inscritta sul volto degli uomini. Questa affermazione non si limita soltanto a
mettere in luce la funzione biologica della madre, bensì evidenzia una prospettiva escatologica. La
maternità, infatti, rimanda al messianismo: grazie ad essa è possibile eccedere i rapporti familiari
ed intravedere un destino che trasformerà il mondo rivelando l'imminenza d'Israele. Questo
destino che si apre sul mondo è la presenza di Dio in mezzo agli uomini, cioè l'evento della
redenzione che implica la realizzazione della giustizia sulla terra. È come se Levinas ci stesse
dicendo che la redenzione, fine ultimo dell'umanità, non possa avvenire senza una matrice
femminile. Può forse esserci giustizia senza misericordia, ospitalità e responsabilità? Ed inoltre,
qual è il senso autentico della frase levinassiana secondo cui la maternità salverebbe l'umanità
aumentando l'immagine di Dio nel mondo?
Cercheremo di rispondere a queste domande considerando le riflessioni sulla maternità che
Levinas sviluppa in Altrimenti che essere, opera quest'ultima che, alla luce del percorso effettuato
in quest'articolo, ci darà il quadro generale del significato profondo della femminilità nell'itinerario
filosofico del nostro autore.
A differenza di Totalità e Infinito in cui, attraverso la figura del padre, era stato oggetto di analisi
dettagliate il rapporto di generazione, in Altrimenti che essere le riflessioni di Levinas convergono
sulla maternità la cui essenza non è più la relazione con l'esistenza di un se stesso (il figlio) che
tuttavia è un altro, bensì il sostituirsi a quest'ultimo in virtù della compassione, della tenerezza e
della misericordia, ovvero di tratti tipicamente femminili:
Il sì del mantenersi e del perdersi o del ritrovarsi non è un risultato, ma la matrice stessa delle
relazioni, o degli avvenimenti, che esprimono questi valori pronominali. E l'evocazione della
maternità in questa metafora ci suggerisce il senso proprio del se stesso. Il se stesso non può farsi,
esso è già fatto di passività assoluta e in questo senso vittima di una persecuzione che paralizza
ogni assunzione che potrebbe svegliarsi in esso per porlo per sé, passività del legame già annodata
come irreversibilmente passata, al di qua di ogni memoria, di ogni richiamo.87
La maternità, questo termine è usato diverse volte da Levinas nel corso dell'opera, costituisce una
metafora preziosa per cogliere il senso dell'umano ed il movimento che il nostro autore definisce
«ricorrenza», cioè il movimento del se stesso. La ricorrenza indica la passività pre-originaria del
soggetto, il se stesso infatti non è nato di sua iniziativa; questa condizione permette al soggetto di
prendere coscienza della propria creaturalità senza il contatto diretto con un creatore. Il
parallelismo del se stesso con la figura della madre appare evidente: entrambi, infatti, hanno in
comune la passività. L'io ha un'indole materna e questo segna una differenza singolare con le altre
opere di Levinas in cui non compare questo termine ma quello di femminilità; perché questo
cambiamento? Sicuramente perché rispetto alla femminilità la maternità indica una specifica
relazione con l'altro (il figlio) che manca alla prima. Il nucleo della metafora è proprio la relazione
con il prossimo: essa infatti rinvia ad una responsabilità tanto pre-originaria (anarchica) quanto
incondizionata (gratuita) e che giunge da un passato immemorabile (torna qui l'indizio del tempo).
La madre è eletta perché crei la prima dimora per il figlio, così l'io, divenendo offerta della dimora
per l'altro, accoglie la Parola trasformandosi nel primo ambito in cui tutto è di Dio, del Dio che è
presente tra noi come traccia attraverso il volto dell'altro uomo. La madre «dà luogo al luogo»,
permette a qualcuno di usufruire delle sue viscere per farsi carne, qualcuno che ancora non
conosce, ma che già ama incondizionatamente; il concepimento di un figlio è un evento che accade,
quella presenza trascende l'attività dell'io rendendolo passivo. L'amore materno si genera nella
totale passività, esso è pura gratuità. Dal ventre della donna passa la ridefinizione della soggettività
umana: è soltanto dopo l'evento del «sì», infatti, che l'io si trasforma in soggettività nuova. Il «sì»
della madre consiste in un abbandono al mistero, essa riconosce una presenza più grande di sé e
nella sua risposta all'evento del concepimento aderisce ad una responsabilità immensa: nel suo
«sì» c'è il farsi carico dell'altro, qualcuno che non è me ma che si genera in me. Questo sì è libertà,
cioè capacità di aderire al mistero di un comando che invade la nostra vita in un tempo che non è
mai stato presente, appello cui abbiamo già risposto e verso il quale siamo sollecitati a non poter
far finta di niente. La madre non può non dire «sì» di fronte a colui che si è incarnato nel suo seno,
il rifiuto resterebbe sempre nella sua coscienza come invocazione e grido della vittima che,
reclamando giustizia, condanna quell'azione riprovevole. La disubbidienza al comando, infatti,
permane nella «cattiva coscienza dell'atto compiuto».
Il «sì» della madre segna la giustizia perfetta della creatura di fronte al comando del creatore; nella
maternità c'è la presa di coscienza del fatto che dall'uso della libertà del soggetto scaturisce un
destino. Per Levinas l'io responsabile regge l'universo, nella responsabilità materna, infatti, è
espressa quella fedeltà alla parola che ridefinisce l'umano.
Grazie al soggetto materno scopriamo che l'altezza dell'uomo consiste nel riconoscere in una realtà
umana (il volto) una presenza che giunge da un altrove. Il «sì» all'altro diviene così risposta ad un
mistero, il femminile ci conduce proprio lì. La maternità ci pone dinanzi al mistero di un passato
assoluto. Ricapitolando lo sviluppo del tema della maternità riteniamo opportuno proporre una
sintesi efficace attraverso le parole di Giovanni Salmeri:
La soggettività umana può essere descritta a partire dalla maternità perché l'io è responsabile
dell'altro così come una madre è responsabile del figlio, perché l'io viene «colpito» ed è ostaggio
dell'altro così come una madre è ostaggio del proprio figlio, perché l'io si sostituisce all'altro così
come una madre si sostituisce al figlio -- cioè indipendentemente da ogni calcolo e al di fuori di
ogni reciprocità.88
Stando così le cose, nel semantema della maternità appare evidente la compresenza di tutti gli
elementi prima citati (relazione temporale, misericordia, materialità). Essa, infatti, implica una
proiezione verso il passato che mantiene un carattere di estraneità maggiore rispetto al futuro: il
concepimento non è scelto liberamente, bensì la madre è passiva e responsabile al di là della sua
volontà. Alla maternità risulta connessa la materia poiché quest'ultima non è la «tragedia della
solitudine» (Il Tempo e l'Altro, pp. 29-30), bensì ciò che, attraverso la sostituzione, consente
all'uomo di essere materno fondando un'etica basata sul perdono, sulla responsabilità,
sull'ospitalità e sul sacrificio poiché l'io prima di essere annodato al proprio corpo è già ostaggio di
tutti. La materia quindi, è ciò che permette il sacrificio, ciò che consente la spogliazione dell'io e
l'apertura radicale all'altro. Infine, la condizione di ostaggio non implica forse la misericordia?
«È in nome della condizione di ostaggio che nel mondo ci può essere pietà, perdono, compassione e
prossimità».89
Da ciò risulta evidente che non c'è maternità senza passività, senza misericordia, senza materialità
e senza responsabilità. La nuova soggettività di Levinas, quindi, si presenta come ostaggio, cioè
come madre di tutti, sicché la maternità giunge a designare quella responsabilità anarchica di ogni
essere umano, cioè l'altrimenti che essere-femminile.
Per rispondere alla domanda di Giovanni Salmeri, possiamo affermare che la femminilità
costituisce la vera dimensione interiore del soggetto e che l'umanità intesa da Levinas non è
pensabile senza gratuità, pertanto nella responsabilità, nella misericordia e nell'ospitalità
incondizionata si cela una matrice di femminilità che abita il cuore dell'umano.
L'altrimenti che essere è femminilità, non una donna empirica, bensì una dimensione metaempirica che esprime la gratuità: della donna, infatti, sappiamo quanto prima poiché in Il Tempo e
l'Altro viene identificata nel mistero ed in Altrimenti che essere in un'assenza, tuttavia ciò che è
radicalmente cambiato è il soggetto. L'io scardina la coincidenza con sé offrendo la propria vita:
ecco la maternità. Il soggetto è madre poiché nel dono di sé è implicita la gratuità del generare, cioè
il poter essere terra feconda per il prossimo e quindi l'offerta di sé come vittima in sostituzione
dell'altro.
L'uomo diviene immagine dell'ebreo errante che nell'uscita da sé del proprio esilio ed in virtù
dell'evento di un incontro, «è chiamato verso la Terra Promessa da abitare nella forma del dono»
(Carolina Carriero, si veda la nota 7); così l'io in quanto madre, dà luogo attraverso le sue viscere
(rachamim) all'«essere per la nascita»: ecco, dunque, il delinearsi del senso autentico dell'umano!
La morte raggiunta attraverso il sacrificio, costituisce quel mistero verso cui conduce la maternità:
il dono di sé come dimora per l'altro oltrepassa la stessa fine poiché in quest'atto di gratuità
estrema avviene la vera e propria frantumazione della finitudine.
La condizione del sacrificio nel suo significato più profondo si presenta, quindi, come percezione
del nulla: tutto sembra finito, l'io è stato sconfitto e sembra aver fallito; ma è proprio attraverso
questo nulla della sofferenza estrema che passa la salvezza. L'immolazione diviene l'atto supremo
della creatura che si restituisce completamente al suo creatore e ciò costituisce il riscatto della
creazione espresso da una misericordia incondizionata: ecco la dimensione autentica del
femminile. Secondo la nostra tesi, dunque, la nuova soggettività (l'altrimenti che essere) è
misericordia che riscatta il dono della creazione attraverso l'offerta di sé per l'altro.
Altrimenti che essere, a nostro avviso, tenta di mettere in luce l'autentica dimensione di
femminilità, la quale consiste nella misericordia che si manifesta nel per-dono (il quale implica un
dono super), nella compassione e nella sostituzione.
Il vocabolo greco da cui ha origine il nostro termine italiano «misericordia» è «oiktìrmon» il quale
traduce l'ebraico «rahamin» che significa «utero». Ancora una volta il legame tra la misericordia e
la femminilità risulta esplicito.
In Difficile libertà Levinas scrive:
La donna, la fidanzata, non è la riunificazione -- in un essere umano -- di tutte le perfezioni della
tenerezza e della bontà che sussisterebbero in se stesse. È come se il femminile ne rappresentasse la
manifestazione originaria, la dolcezza in sé, l'origine di tutta la dolcezza della terra.90
Con queste parole Levinas toglie definitivamente ogni ombra di dubbio sul senso della femminilità,
egli infatti riconosce esplicitamente che il femminile trascende la donna in carne ed ossa situandosi
al di là di una semplice categoria ontica.
Alla luce di tutto ciò, dunque, la femminilità può essere interpretata, a nostro avviso, come la via
che conduce all'altrimenti che essere, cioè al di là dell'ontologia e quindi verso il cuore della
trasformazione della soggettività.91 Dicendo questo non stiamo ripetendo con fedeltà il pensiero di
Emmanuel Levinas, ma stiamo cercando di dire ciò che il nostro autore non poteva affermare.
Infatti, dire che l'altrimenti che essere è femminilità non è in un certo senso ricadere nel concetto,
nella definizione e quindi nell'ontologia? Certamente, pertanto spetta esclusivamente al lettore (noi
ci consideriamo tali) cercare delle possibili connessioni tra i molteplici frammenti che l'opera
levinassiana lascia dietro di sé; sembra quasi che il nostro autore non ne sia consapevole e che, così
facendo, permetta alla sua opera sia di non chiudersi mai in una trattazione sistematica, sia di
lasciare tracce continue di una significanza ulteriore che nel momento in cui si rivela è già
dissimulata.
Il femminile, quindi, non riunifica in una persona umana la dolcezza, la bontà e la misericordia,
bensì è l'origine --anarchica -- di esse. In un certo senso la femminilità, in quanto misericordia,
diviene traccia di un non-luogo che precede l'essere: essa, grazie all'azione umana, giunge perfino a
costituire l'essenza dell'inversione del conatus essendi poiché, per Levinas, la misericordia viene
prima della giustizia e la responsabilità prima della libertà.
Detto ciò, restano da chiarire alcuni punti importanti come, per esempio, la relazione della
femminilità con la «scrittura impronunciabile» ed il ruolo della maternità nella redenzione
dell'umanità. Perché la maternità conduce l'umanità verso la salvezza aumentando l'immagine di
Dio nel mondo? La femminilità in Levinas conduce davvero a Dio?
Per rispondere a queste domande occorre un'immersione nel contesto culturale giudaico del nostro
autore, il quale in un bel passaggio di Difficile libertà scrive:
L'eterno femminino, che tutta un'esperienza amorosa sorta nel medioevo conduce da Dante fino a
Goethe, nel giudaismo è assente. Mai la donna assumerà aspetto divino. Né Vergine Maria, né
Beatrice. La dimensione intima è aperta dalla donna e non dal senso dell'altezza. Dell'esistenza
femminile sarà trattenuta senza alcun dubbio la misteriosa interiorità, per sentire come una
fidanzata il sabato, la stessa Torah e qualche volta la Sekinah, la presenza divina presso gli
uomini.92
Qui Levinas è molto chiaro: nel giudaismo rabbinico la donna non assume mai sembianze divine,
tuttavia apre la «dimensione intima», il femminile infatti implica una «misteriosa interiorità»che
permette di sentire intimamente la Torah e la Shekhinah.
Quest'affermazione è molto importante perché ci conferma il fatto che il comandamento preoriginale che in realtà consiste in un insegnamento (Buber e Rosenzweig hanno tradotto il termine
Torah con il vocabolo tedesco Weisung che significa «insegnamento») è possibile coglierlo
attraverso un'intimità, un'accoglienza, cioè una dimensione femminile.
Per quanto concerne la Shekhinah, ci sembra opportuno un approfondimento.93
Nel giudaismo rabbinico questo termine indica la divina presenza, cioè l'immanenza di Dio nel
mondo: il termine Shekhinah (che proviene dal verbo «shakhan» il cui significato è «abitare»,
«dimorare»), infatti, significa letteralmente «abitare nel tempo e nello spazio»; esso, quindi,
implica Dio colto in termini spazio-temporali. La Shekhinah è una presenza reale non verificabile,
ci sono dei momenti nella storia dell'uomo in cui essa è maggiormente presente e abita certi luoghi
specifici, ma ciò avviene quando si compie un'azione morale nei confronti di qualcuno. Essa
esprime la modalità in cui Dio si avvicina al suo popolo (specialmente nell'esilio) e quindi è
contraddistinta da tratti di umiltà: nonostante la diaspora il popolo ebraico non è stato mai
abbandonato da Dio (si veda: Es 24, 16; Es 40, 34-35; Re 8, 10-12; Ez 10, 3-4; Sal 18, 12). Nell'esilio
Dio è presente in mezzo a Israele, la Shekhinah, dunque, è connessa con l'antico vagare nel deserto
del popolo ebraico, proprio li infatti dimorava la divina presenza (Es 40, 34-38): un abitare che è
legato alla pietà, alla misericordia e all'ospitalità.
Nel Salmo 91, 15 Dio appare vicino al giusto, lo accompagna ovunque vada, è con lui in ogni sua
tribolazione, egli porta in braccio l'innocente che è perseguitato. Ma questo non costituisce forse un
farsi carico della sofferenza altrui pieno di tenerezza?
In tutte le angosce.
Non un inviato né un angelo,
ma egli stesso li ha salvati;
con amore e compassione
egli li ha riscattati;
li ha sollevati e portati su di sé,
in tutti i giorni del passato (Is 63, 9).
Dio è vicino ad ogni uomo, solo nella negazione dell'io si fa veramente esperienza del mistero che
circonda l'umano: questo mistero è femminile. Nella sofferenza e nel sacrificio, svuotandoci di noi
stessi ci riempiamo di Dio. La Shekhinah è tenerezza e presenza divina che condivide persino
l'esilio, ma è anche preavviso dell'imminenza della Terra Promessa. Essa si avvicina ad Israele
attraverso la pietà e la misericordia divenendo così il volto femminile di Dio. La Shekhinah
costituisce l'aspetto femminile di Dio, qualcuno l'ha addirittura definita come Dio-donna o Diomadre.
Ripensando ai precedenti passi di Difficile libertà in cui la maternità veniva indicata come via di
salvezza per l'umanità e per il compimento di Israele, ciò che accomuna Dio e la maternità è
proprio la misericordia infinita di cui la Shekhinah è manifestazione. La madre ha misericordia
incondizionata verso il figlio così come Dio nutre un'assoluta pietà per le sue creature: la vera
somiglianza tra Dio e l'uomo, quindi, è costituita proprio dalla misericordia che la maternità
esprime. Quest'ultima è in grado di simboleggiare la salvezza dell'umanità perché indica una strada
precisa: quella della redenzione. Essa è fondamentale per l'ebraismo (non solo per esso poiché
anche nel cristianesimo essa assume un ruolo di primo piano) e orienta tutta l'opera di Levinas
facendola divenire un vero e proprio cammino verso la salvezza dell'uomo. La redenzione, infatti,
diverrà ora il cuore della nostra trattazione: la dimensione femminile (implicita nell'altrimenti che
essere), infatti, non è forse profondamente legata con l'evento della redenzione?
La parte finale del presente lavoro si incentrerà proprio su quest'ipotesi.
Alla luce delle considerazioni sulla Shekhinah, ci sembra rilevante, per il proseguo della nostra
trattazione, proporre alcune riflessioni su Is 66, 16, versetto biblico in cui è la stessa Shekhinah ad
essere giudicata: essa è giudicata nel fuoco, cioè Dio subisce e sperimenta ciò che avviene nel
mondo. Pur essendo presente nel mondo essa non riesce ad impedire la sofferenza, la sopraffazione
e la morte che continuano a predominare. «Con il fuoco infatti il Signore farà giustizia su tutta la
terra», in queste parole sono implicite alcune considerazioni importanti: il Signore prima di essere
giudice è giudicato dal fuoco della salvezza non avvenuta, infatti se non fosse giudicato non sarebbe
salvato e non salverebbe; la misericordia, quindi, è una giustizia che salva, mentre la giustizia da
sola condanna. Tutto ciò sembra lo sfondo di alcune riflessioni che Levinas espone nel corso di
un'intervista pubblicata in Tra noi. Saggi sul pensare-all'altro. In quell'occasione il nostro autore
era giunto ad una conclusione interessante: sussiste un rapporto stretto tra carità e giustizia poiché
la carità risulterebbe impossibile senza la giustizia e quest'ultima si deformerebbe senza la carità.
Le conseguenze affascinanti cui queste affermazioni potrebbero condurci, divengono ancora più
evidenti alla luce della risposta del nostro autore ad una domanda del giornalista riguardante
l'entità della relazione tra giustizia e amore:
La giustizia sorge dall'amore. [...] L'amore deve sempre sorvegliare la giustizia. Nella teologia
ebraica -- io non sono guidato esplicitamente da questa teologia -- Dio è Dio della giustizia, ma il
suo attributo principale è la misericordia. Nel linguaggio talmudico Dio si chiama sempre
Rachmana, il misericordioso: tutta questa tematica è studiata nell'esegesi rabbinica. Perché vi sono
due racconti della creazione? Perché l'eterno -- chiamato Elohim nel primo racconto -- ha voluto
anzitutto (certamente tutto ciò è solo apologia) creare un mondo appoggiandosi solo sulla giustizia.
Esso però non avrebbe retto. Il secondo racconto, in cui appare il tetragramma, attesta l'intervento
della misericordia.94
Pur riconoscendo di non essere guidato esplicitamente dalla teologia ebraica, Levinas, dal punto di
vista filosofico, resta comunque legato alla matrice culturale giudaica. Il suo intento non è quello di
formulare una teologia, bensì quello di ridefinire l'umano a partire da una misericordia che lo abita
da un tempo immemorabile.
Giustizia e carità non possono essere separate, infatti non può esserci l'una senza l'altra: la giustizia
nasce dall'amore (agape) ed il Dio della giustizia è presente nel mondo in quanto misericordia.
Riflettendo sul racconto della creazione esposto da Levinas, una questione resta aperta: perché un
mondo creato sulla sola giustizia non avrebbe retto? Perché la giustizia da sola condanna e
l'umanità non avrebbe alcuna possibilità di salvezza. Soltanto in un mondo in cui ci sia
misericordia, in cui la Shekhinah possa essere giudicata con il fuoco e quindi salvata, può esserci la
possibilità della redenzione. La giustizia che si genera dalla misericordia è una giustizia eccezionale
poiché invece di punire, assolve.
Se Carol Gilligan identificava l'etica maschile con la giustizia universale, le norme, l'astrazione, il
diritto e l'etica femminile con l'interdipendenza, la cura, la compassione e la pietà, allora la
giustizia di cui parla Levinas rappresenta il risultato di un percorso che passa dal maschile
(giustizia universale che condanna) al femminile (giustizia che nasce dalla misericordia e che
salva); così, da queste considerazioni, emerge il profondo legame che unisce la femminilità con
l'evento della redenzione. Quest'ultima, infatti, trova la via della sua realizzazione autentica nel
sacrificio: l'immolazione per altri, dunque, diviene il gesto estremo in cui l'io, nella sostituzione, si
svuota totalmente di se e si riempie di Dio; proprio in ciò consiste il riscatto della creazione. Se
quest'ultima, infatti, implicava la contrazione dell'infinito, cioè il ridimensionamento del Creatore
che lascia il posto alla creatura, allora, la redenzione, consisterà proprio nel riconsegnare a Dio la
stessa creazione: offrendo il proprio corpo come dimora, infatti, è come se nel mistero della carità
Dio divenisse presente e, così, dimorasse nel mondo. Aprire totalmente il finito all'infinito: ecco la
redenzione. Essa dunque consiste nella dinamica attraverso la quale l'uomo riesce a realizzare il
regno di Dio sulla terra; solo così infatti, è possibile una giustizia che nasca dalla misericordia. Ma
la misericordia non è la forma per eccellenza della femminilità? Certamente. Attraverso la
femminilità infatti, si giunge alla verità più alta: la gratuità del dono. Dio crea l'uomo donandolo a
se stesso, lo elegge al Bene, poi nella Shekhinah soffre con lui, lo assiste e viene persino giudicato
insieme a lui; a sua volta l'uomo, attraverso l'incontro con il volto dell'altro uomo, si scopre
ostaggio, cioè pre-originariamente responsabile di tutti e così, nel sacrificio della propria vita, si
trasforma in dono per l'altro riscattando la misericordia infinita della creazione, una misericordia
che aveva spinto l'infinito a limitarsi per lasciare un posto all'essere separato. Paradossalmente la
salvezza dell'uomo passa attraverso il nulla; infatti è dal nulla della sofferenza che si riceve il tutto.
Il termine «uomo» viene dal vocabolo latino «humus» che significa «terra», per Levinas, infatti, la
Terra Promessa è ogni uomo poiché ogni essere umano, in quanto eletto, è chiamato a realizzare il
regno di Dio sulla terra, cioè un mondo in cui ci sia misericordia. La logica del dono, inoltre,
implica la gratuità: Dio, pertanto, è accolto in noi come misericordia e dono solo nella misura della
consapevolezza del nostro demerito, della nostra condizione di debito e della nostra distanza
infinita da lui, cioè nel riconoscersi come nullità; ma anche la creazione è dal nulla... Il nulla
diviene qui punto di riferimento imprescindibile: è da esso che si origina tutto e, al contempo, è
attraverso di esso che tutto acquista un senso (per l'uomo la salvezza passa proprio attraverso il
nulla).
Stando così le cose, il sacrificio dell'io se da un lato costituisce l'esperienza del nulla poiché tutto
sembra finito, dall'altro salva dal nulla stesso, infatti solo attraverso la sostituzione egli scopre la
«scrittura impronunciabile», traccia di Dio per la quale tutto riacquista un senso. In questo modo,
però, il significato profondo dell'altrimenti che essere appare intrinsecamente connesso con
l'evento della redenzione. La «scrittura impronunciabile» incontrata grazie alla dimensione
femminile (quella compassione che spinge l'io a sostituirsi all'altro), non potrebbe forse costituire,
in un certo senso, l'identificazione del nome di Dio con la misericordia?
Levinas preferisce tacere riguardo al nome di Dio, egli si limita a riconoscere una traccia, una
«scrittura impronunciabile» che resta significante pur essendo privata del suo contenuto. Ciò è
spiegabile in virtù degli obiettivi che l'autore si pone: egli non vuole cadere nel tranello di un certo
tipo di teologia (l'onto-teologia) da cui prende le distanze, egli infatti non intende dimostrare
l'esistenza o la non esistenza di Dio; ciò che viene indagato invece è la significazione di questo
termine, ovvero una significanza che rompe la fenomenalità. Se si andasse oltre questo limite, il
rischio sarebbe quello di ricadere nell'ontologia, infatti prendere coscienza di Dio e parlare di lui
significa già inglobarlo in un sapere, in un concetto, in una determinazione; ma l'infinito non è
l'indeterminabile per eccellenza in quanto eccede la stessa possibilità della determinazione?
Secondo il nostro autore, l'ontologia porta con sé la grande colpa di aver ridotto il termine Dio ad
un vocabolo vuoto, cioè ad un semplice suono della voce, in luogo di un pensiero che spiegasse la
totalità della realtà. Dunque il pericolo della ricaduta nelle maglie del concetto impone a Levinas di
restituire a Dio il posto che gli spetta attraverso il silenzio, un silenzio che implica, nell'assenza di
ulteriori riflessioni, la possibilità di scorgere qualcosa di diverso dall'esperienza, dal sapere e dalla
coscienza intesa come attività: l'accoglienza autentica dell'assoluto che avviene attraverso l'incontro
con il volto. In Di Dio che viene all'Idea, testo del 1982, Levinas scrive:
Ma come se il volto dell'altro uomo, che d'improvviso mi interpella e mi ordina, fosse il nodo
dell'intrigo stesso del superamento da parte di Dio dell'idea di Dio e di ogni idea in cui egli sarebbe
ancora preso di mira, visibile e conosciuto ed in cui l'infinito sarebbe smentito dalla
tematizzazione, nella presenza o nella rappresentazione. [...] Responsabilità senza pre-occupazione
di reciprocità: devo rispondere di altri senza occuparmi della responsabilità d'altri al mio riguardo.
Relazione senza correlazione o amore del prossimo che è amore senza Eros. Per-l'altro uomo e da
qui a-Dio!95
In questo passo c'è la sintesi di tutto il pensiero di Levinas, l'unica «relazione senza correlazione» è
proprio l'accoglienza del volto, una presenza che mette in questione l'io poiché lo pone di fronte al
mistero di un passato immemorabile, non-luogo di un'elezione pre-originaria in cui il soggetto,
responsabile della responsabilità dell'altro, si scopre ostaggio di tutti, passività estrema e pazienza,
cioè sostituzione: proprio in ciò consiste l'unicità dell'eletto.
Grazie al volto che traduce l'idea dell'infinito in etica, Levinas è in grado di dire Dio altrimenti, cioè
non nei limiti dell'ermeneutica (attraverso simboli, metafore, cifre), dell'esperienza e del concetto,
bensì attraverso la gratuità dell'accoglienza; così il volto, in quanto possibilità della moralità, indica
il senso dell'accoglienza e ci consente di andare al di là dell'ontologia (qui intesa come
determinazione, sapere e conoscenza) scoprendo l'autentica idea di Dio (l'idea dell'infinito), cioè un
pensiero che pensi più di quanto possa pensare e che ecceda le stesse capacità del cogito.
Attraverso la prossimità, definita da Levinas «amore senza Eros», si giunge a-Dio, questo termine
implica ancora una volta un'ospitalità (l'infinito che abita il finito da un tempo primordiale) cioè
«Dio-che-viene-all'idea come vita di Dio» (che è proprio l'idea d'infinito), prospettiva,
quest'ultima, che realizza il rovesciamento del teoretico nell'etico.
L'idea dell'infinito, dunque, eccede l'ontologia perché è al di là dell'essere e quindi altrimenti che
essere; ma il sacrificio di sé non esprime forse la dimensione femminile?
La femminilità, cuore della nuova umanità, ci ha condotti verso un modo di guardare Dio
radicalmente diverso da quello della totalità espresso dalla filosofia occidentale; essa, infatti,
implica l'ottica della responsabilità, aspetto indiscutibile della visione biblica dell'etica.
Per raggiungere la salvezza, l'io deve divenire per-l'altro, cioè deve sostituirsi al prossimo morendo
a se stesso poiché solo in quella dimensione di altezza si scorge il vero nome di Dio: misericordia. A
nostro avviso, dunque, solo nell'amore del volto dell'altro l'io incontra Dio!
In queste nostre riflessioni stiamo cercando di andare al di là dello stesso Levinas tramite gli indizi
che egli ha lasciato (volontariamente?) nelle sue opere. Tornando alle nostre considerazioni, è
come se il nostro autore ci stesse dicendo che: da un lato Dio è amore che non può non amare e
misericordia che non può non sentire tenerezza verso la miseria delle sue creature, dall'altro che
l'uomo ad immagine di Dio, o il suo essere nella traccia di Dio, significa, per la creatura,
trasformarsi in dono ed amare come il creatore ama. Proprio in ciò consiste la dimensione
femminile del riscatto. Il riscatto della creazione che avviene attraverso l'altrimenti che essere,
implica dunque la femminilità intesa come misericordia.
Se il desiderio dell'uomo è quello di diventare come Dio (Gen 3, 59), nell'incontro con il volto d'altri
è possibile intraprendere la via per «diventare Dio». L'essenza di Dio è misericordia (Sir 2, 18)
poiché «quale è la sua grandezza, tale è la sua misericordia», ma quest'ultima costituisce l'autentica
dimensione di femminilità che abita l'umano e che l'altrimenti che essere tenta di mettere in luce.
In conclusione potremmo dire che Dio misericordioso ci è presentato come padre, ma anche come
madre, infatti la sua giustizia non è di condanna, ma di condono ed egli non giudica, bensì
giustifica! Ma il fulcro di tutto ciò è, ancora una volta, proprio nella misericordia; infatti per essa
accade la creazione ed in essa avviene la Redenzione. L'uomo deve sostituirsi a Dio non nella
conoscenza o nel potere, ma soltanto nell'amore, solo allora sarà come lui: il primo grande
sacrificio, infatti, è di Dio poiché solo una misericordia infinita poteva limitare se stessa per
favorire la molteplicità del creato. L'uomo nel suo amore di debito nei confronti di Dio (donando se
stesso) restituisce all'infinito la sua gloria; così l'unico limite al male presente nel mondo è la
misericordia e l'unico limite alla misericordia di Dio è quello che nasce dal nostro grembo
(rachamim) e che, ancora una volta, è femminile.
7. Conclusione
Secondo Luce Irigaray risulta fondamentale (per l'ordine simbolico che ne scaturisce) affrontare la
questione della trascendenza poiché senza un riferimento di questo tipo, cioè una genealogia
divina, la genealogia femminile resta incompleta. Secondo l'autrice proprio la legge del medesimo
ha impedito alla donna di costituirsi come soggetto, cioè «altro da altro» o «altro come
eterogeneo».96 La donna, infatti, viene definita come «altro» in funzione del medesimo poiché, a
differenza dell'uomo il cui rapporto con l'origine resta invariato (per mantenere la sua identità
l'uomo ripropone con le donne il rapporto che ha con la madre), entrando nella legge del medesimo
rompe il suo legame con l'origine e quindi con la possibilità di fondare la propria identità. Stando
così le cose, ogni teoria del soggetto risulta essere maschile e la donna, assoggettandovisi, rinuncia
inconsapevolmente alla propria specificità che è possibile rintracciare esclusivamente nella fase
pre-edipica. Le donne possono rappresentare autonomamente (nella dimensione simbolica) il loro
rapporto con la madre fino alla fase edipica, momento in cui la bambina perde il suo desiderio
originario senza che questo abbia avuto un riconoscimento nell'ambito culturale; così, restando
priva della possibilità di costituirsi come identità (come «altro dall'altro»), si subordina al desiderio
maschile. Per uscire da questo circolo vizioso, la donna, secondo Irigaray, deve ricercare modi di
simbolizzazione autonomi dal simbolico monopolizzato dal maschile che, ponendosi come
medesimo, fa della donna l'altro. L'uomo rispondendo alla sua «volontà di onnipotenza», nega
l'esistenza della specificità sessuale femminile imponendo alla donna la sua immagine di
femminilità. Così il complesso di Edipo, secondo l'autrice in questione, non serve ad articolare la
differenza dei sessi, bensì a far entrare la donna in un sistema di valori che non sono i suoi ma degli
uomini. In questo modo, la psicoanalista afferma la specificità del rapporto della donna con la sua
origine: la donna, infatti, emancipandosi da un discorso maschile ne determina uno suo proprio
ponendosi a sua volta come medesimo. Questo concetto di specificità serve infatti all'autrice anche
per evidenziare l'inconsistenza di «caratteristiche femminili culturalmente, socialmente,
economicamente valorizzate» perché legate alla maternità; il femminile, pertanto, in accordo ad
Irigaray, non può essere ridotto esclusivamente a maternità e maternage. In questo contesto,
anche la trascendenza ed in particolare l'idea di Dio che la tradizione ha da sempre presentato
attraverso le Sacre Scritture (ad esempio l'identificazione di Dio come padre), rientrano nel
dominio e nell'egemonia del maschile: il percorso di un divino patriarcale, pertanto, avrebbe
limitato il corso storico della genealogia femminile.
È come se alla base della genealogia femminile ci fosse una genealogia divina, infatti solo in un
rapporto diretto e autentico con la trascendenza la donna può raggiungere la sua identità specifica.
Alla luce di queste considerazioni, il percorso di Levinas sembrerebbe ancora legato ad una legge
simbolica maschile; egli infatti definendo il femminile come «alterità per eccellenza», «mistero»,
ospitalità, passività, maternità e tenerezza, mette in risalto quei tratti che la tradizione da sempre
attribuisce alla donna.
Nel tentativo di scagionare Levinas dall'accusa di maschilismo, possiamo dire, tuttavia, che il suo
intento non è quello di individuare la specifica identità della donna, poiché alla fine del suo
itinerario (come abbiamo già accennato), di essa si sa quanto prima, cioè molto poco; infatti si
passa da un mistero (Il Tempo e l'Altro) ad un'assenza (Altrimenti che essere).
Il vero obbiettivo del nostro autore è quello di ridefinire l'umano, ogni essere umano, scoprendo nel
cuore della nuova identità una matrice femminile che non ha nulla a che vedere con l'aspetto
sociale, politico, psicologico e culturale della donna come categoria ontica. La femminilità, infatti,
pur essendo una categoria ontologica, costituisce altresì la via che conduce ad una dimensione
etica. Levinas, dunque, come abbiamo già accennato, intende il termine femminile come una
dimensione meta-empirica che trascende la donna in senso stretto, tale dimensione è costituita
dalla misericordia che abita ogni essere umano (sia gli uomini che le donne) e che rappresenta la
premessa per uscire dall'ontologia conducendo, così, la soggettività a vincere l'egoismo dell'essere
per porsi come altrimenti che essere, cioè ospitalità incondizionata che riscatta la contrazione pre-
originale dell'infinito. Qui il soggetto, simbolicamente, può essere inteso come una madre che,
eletta nel concepimento, pur di dare alla luce il figlio dona la propria vita. Levinas andando al di là
dell'ontologia e scoprendo il fondamento del senso nell'etica, si situa al di là di ogni possibile critica
maschilista o femminista e scopre nella misericordia la vera traccia di Dio nel mondo, un Dio che
non è privilegio ed esclusiva di un solo sesso, bensì un «Valore Unico» e «significante» di ogni
essere umano.
Stando così le cose, potremmo dire che il femminile, nell'itinerario levinassiano, diviene la via in
grado di condurci verso l'al di là dell'essere e quindi verso l'altrimenti che essere.
Riassumendo le considerazioni presentate nel corso di queste pagine, dunque, è possibile
rintracciare alcuni punti determinanti relativi alla metamorfosi della femminilità. In Il Tempo e
l'Altro il femminile era individuato dal nostro autore come alterità trascendente che implicava la
propensione verso un futuro assoluto. In Totalità e Infinito la donna diviene il «tu» della
familiarità, essa implica l'immanenza ed esprime una dimensione di accoglienza legata ancora allo
spazio ed al tempo (la dimora rappresenta l'interiorità umana). Nell'Umanesimo dell'altro uomo la
dimensione di femminilità rinvia all'origine anarchica dell'etica, cioè ad un'accoglienza originaria
ed assoluta; qui l'interiorità che in Totalità e Infinito era possibile grazie alla presenza femminile,
diviene la via che conduce ad un non-luogo o dimensione anarchica, cioè al mistero di un passato
mai stato presente di cui è possibile scorgere una traccia: la femminilità, quindi, implica la
possibilità della gratuità infinita della creazione.
In Difficile libertà, la figura della maternità rappresenta la nuova identità umana: l'altro nel
medesimo, cioè responsabilità incondizionata che porta al sacrificio di sé. Nell'immolazione
l'umano diventa dimora del divino, infatti la Shekhinah è la presenza femminile di Dio, un Dio che,
grazie alla redenzione dell'uomo, torna ad abitare il mondo. Questa prospettiva, anche se in termini
diversi, viene sviluppata dal nostro autore in Altrimenti che essere dove la dimensione di
femminilità diviene riscatto della creazione, infatti nell'offerta di sé per l'altro c'è la negazione
dell'uomo che fa posto al divino, ospitalità estrema che riscatta la contrazione dell'infinito. Levinas,
in una delle pagine più belle di Altrimenti che essere, descrive così la gloria dell'infinito:
Eccomi come testimonianza dell'infinito, ma come testimonianza che non tematizza ciò che
testimonia e la cui verità non è verità di rappresentazione, non è evidenza. Non vi è testimonianza - struttura unica, eccezionale alla regola dell'essere, irriducibile alla rappresentazione -- che
dell'infinito.
L'infinito non appare a colui che ne fa testimonianza. Al contrario è la testimonianza che
appartiene alla gloria dell'infinito. È attraverso la voce del testimone che la gloria dell'infinito si
glorifica.97
La misericordia della creazione è riscattata dall'uomo che vive, il quale, divenendo il testimone
della creazione stessa, glorifica l'infinito. La gloria di Dio, quindi, è l'altrimenti che essere, ma il
sacrificio estremo che questo gesto implica non è forse la misericordia? E la misericordia non è
forse la dimensione autentica della femminilità?
Dio si ritrae dopo essersi rivelato nel Libro e, da un passato assoluto, continua l'opera della
Redenzione attraverso l'uomo che è sollecitato a rispondere alla Rivelazione. Stabilire un regno di
giustizia è il compito affidato all'uomo; ma la giustizia non è preceduta dalla misericordia?
Se la Redenzione, come abbiamo visto, passa attraverso la femminilità, perché in Altrimenti che
essere il femminile non è mai citato?
Una possibile risposta a questa domanda è contenuta nell'articolo di Maria Grazia Fasoli (Inferno
al Dio delle madri) che, nella ricerca di un «volto femminile di Dio», giunge al di là di un «sentito
dire» cogliendo il «mistero familiare», un'alterità incomprensibile alla quale risulta possibile dare
del «tu»:
Nessuna proiezione patriarcale, ma neppure -- al contrario -- matriarcale può espropriare Dio del
suo mistero. Ovvero può razionalmente garantire la tensione comunionale tra l'uomo -- maschio e
femmina -- e Dio. Il femminile di Dio è un altro nome per dire il suo mistero. Anzi è il volto in
ombra del padre, oscurato dalle mediazioni patriarcali.98
Riportando queste considerazioni all'interno dell'opera levinassiana si comprende come, se da un
lato il nostro autore cerca di uscire dall'essere (rappresentato dalla virilità e dall'egoismo)
attraverso la misericordia (dimensione femminile), dall'altro identificare l'altrimenti che essere con
il concetto di femminilità significherebbe ricadere nell'ontologia e limitare così il mistero della
redenzione.
Possiamo solo scorgere una traccia di Dio proprio perché dire qualcosa di lui significherebbe
limitare la sua infinitezza, pertanto la femminilità svolge la funzione di condurre l'umano dinanzi al
mistero di Dio perché solo nella misericordia è possibile scoprire le sue tracce; tuttavia non è
possibile andare oltre: il femminile può arricchire il mistero divino di altri nomi ma non può dire
Dio imprigionandolo nella finitezza di un concetto.
Attraverso il maschile ed il femminile, quindi, Levinas giunge al di là dei semplici generi, infatti la
dimensione femminile non appartiene soltanto alle donne, l'altrimenti che essere non costituisce
una definizione della donna in senso specifico, ma di tutta l'umanità (uomini e donne) affinché nel
cuore di ogni uomo ci sia ancora quella misericordia che costituisce la vera condizione della
giustizia! Con la femminilità, quindi, si giunge al mistero di Dio che, dopo la Rivelazione, nella sua
assenza e distanza assoluta, permane accanto all'uomo lasciando una traccia del suo passaggio.
Il Dio dei padri ed il Dio delle madri [...] lasciano il posto al mistero di Dio che parla agli uomini e
alle donne, ugualmente e differentemente. La rivelazione può darsi come sollecitudine paterna o
come cura materna, può incrociare l'uno o l'altro ordine simbolico, assumere analogicamente
connotati dell'uno o dell'altro genere, ma entrambi li trascende. Ovvero entrambi li chiama
all'auto-trascendimento, che è liberazione e redenzione.99
Nell'evento straordinario della Redenzione, dunque, la femminilità, espressa nella sua dimensione
più alta dalla misericordia, si auto-trascende testimoniando, così, la gloria dell'infinito con la sua
assenza, un'assenza che, in Altrimenti che essere, testimonia l'infinito con il silenzio divino del
sacrificio per altri. Proprio questo silenzio ci conduce al di là di ogni possibile pensiero, parola,
concetto o rappresentazione e così è possibile tornare a quella dimensione pre-originale dell'ascolto
da cui tutto ha avuto origine.100
Note
1.
Levinas, E., Totalità e Infinito. Saggio sull'esteriorità, Jaca Book, Milano 2004, pp. 44-45.
2.
Heidegger, M., Essere e Tempo, Longanesi, Milano 1971, par. 53.
3.
De l'Évasion, «Recherches Philosophiques», 5 (1935-36), pp. 373-90, trad. ital. Dell'evasione, Elitropia, Reggio
Emilia 1984.
4.
Magnanimo, A., Emmanuel Levinas, disponibile su World Wide Web http://filosofia.net. Si veda anche Riva, E.,
«Emmanuel Levinas», Filosofia e dintorni, disponibile su World Wide Web http://filosofiaedintorni.net.
5.
La citazione è presente nell'articolo di Levesque, C., «Deux lectures d'Emmanuel Levinas», Studi francesi, 38, 12 e si riferisce a: Derrida, J., «En ce moment même dans cet ouvrage me voici» (1980), in Psyché. Invention de
l'autre, Paris, Galilée, coll. «La Philosophie en effet», 1987, pp. 165-166. Per un ulteriore approfondimento si
veda anche: Stichauer, P., «Levinas et le sexe faible», Sens-public, http://sens-public.org.
6.
Levinas, E., Altrimenti che essere o al di là dell'essenza, Jaca Book, Milano 1983, pp. 11-12.
7.
Carriero, C., «Il paradigma della corporeità nel pensiero femminile: l'oblazione come oltrepassamento della
responsabilità etica verso l'altro». Dialegesthai. Rivista telematica di filosofia, 2001,
http://mondodomani.org/dialegesthai/.
8.
Levinas, E., Dall'Esistenza all'Esistente, Marietti, Casale Monferrato 1986, p. 77.
9.
Levinas, E., Il Tempo e l'Altro, Il Melangolo, Genova 1987, p. 27.
10. Ibidem, p. 45.
11. Ibidem, pp. 54-55
12. Ibidem, pp. 55-57.
13. Ibidem, p. 59.
14. Derrida, J., Addio a Emmanuel Levinas, Jaca Book, Milano 1998, pp. 102-103.
15. De Beauvoir, S., Il secondo sesso, Il Saggiatore, Milano 1999, p. 29.
16. Levinas, Il Tempo e l'Altro, p. 57.
17. Derrida, Addio a Emmanuel Levinas, p. 105 (nota 35).
18. Per un ulteriore approfondimento di questo tema si veda Levinas, E., Di Dio che viene all'idea, Jaca Book,
Milano 1997 (2a ed.), p. 85 (in particolare il cap. «Dio e la filosofia»).
19. Per uno studio più approfondito sul tema del volto si veda: Baccarini, E., Levinas. Soggettività e Infinito,
Studium, Roma 1985 (cap. 3, p. 42).
20. Levinas, Totalità e Infinito. Saggio sull'esteriorità, pp. 48-49.
21. Derrida, Addio a Emmanuel Levinas, pp. 83-103.
22. Levinas, Totalità e Infinito. Saggio sull'esteriorità, p. 158.
23. Ivi.
24. Ibidem, pp. 161.
25. Derrida, Addio a Emmanuel Levinas, pp. 101-103.
26. Rosenzweig, F., La Stella della Redenzione, Marietti, Casale Monferrato 1985, p. 321.
27. Levinas, Totalità e Infinito. Saggio sull'esteriorità, pp. 176-179.
28. Derrida, Addio a Emmanuel Levinas, pp. 84-85.
29. Verna, A.M., Alterità, le metamorfosi del femminile da Platone a Levinas, Giappichelli, Torino 1990, p. 10.
30. Ibidem, p. 213.
31. Levinas, Totalità e Infinito. Saggio sull'esteriorità, p. 161.
32. Derrida, Addio a Emmanuel Levinas, pp. 106-107.
33. Levinas, Totalità e Infinito. Saggio sull'esteriorità, p. 259.
34. Levinas, E., Difficile libertà, Jaca Book, Milano 2004, pp. 57-58.
35. Levinas, Totalità e Infinito. Saggio sull'esteriorità, pp. 263.
36. Ibidem, pp. 265-266.
37. Verna, Alterità, le metamorfosi del femminile da Platone a Levinas, pp. 226-227.
38. Levinas, Totalità e Infinito. Saggio sull'esteriorità, pp. 281-282.
39. Per approfondire il tema dell'«originario» si veda Baccarini, E., «La passione del filosofo: pensare l'originario»,
Dialegesthai. Rivista telematica di filosofia, 1999, http://mondodomani.org/dialegesthai/.
40. Levinas, Altrimenti che essere, p. 7.
41. Ibidem, pp. 8-9.
42. Ibidem. p. 9.
43. Rimandiamo qui a Levinas, Totalità e Infinito. Saggio sull'esteriorità, pp. 157-159 (cap. «La dimora»).
44. Levinas, E., Umanesimo dell'altro uomo, Il Nuovo Melangolo, Genova 1998, pp. 111-112.
45. Ibidem, p. 112.
46. Ibidem. pp. 113-114.
47. Ibidem, p. 115.
48. Levinas, E., Tra Noi. Saggi sul pensare all'altro, Jaca Book, Milano 1998, pp. 169-191 (si veda «Dall'Uno
all'Altro. Trascendenza e tempo»).
49. Levinas, Umanesimo dell'altro uomo, p. 116.
50. Levinas, Umanesimo dell'altro uomo, p. 117.
51. Levinas, Totalità e Infinito, pp. 158-159.
52. Levinas, Umanesimo dell'altro uomo, p. 115.
53. Levinas, Totalità e Infinito, p. 161 (riportiamo la citazione nel paragrafo 3 «Ospitalità e verginità»).
54. Ivi.
55. Levinas, Umanesimo dell'altro uomo, pp. 121-122.
56. Ibidem, p. 123 (nota 19).
57. Levinas, Totalità e Infinito, p. 105.
58. Ibidem, pp. 301-302.
59. Ibidem, p. 106.
60. Ibidem, p. 301.
61. Levinas, Umanesimo dell'altro uomo, p. 125.
62. Si veda Levinas, Altrimenti che Essere o al di là dell'essenza, pp. 1-2.
63. Ibidem, pp. 126-127.
64. Ibidem, p. 128.
65. Ibidem, p. 139. Questa citazione è presente anche in: Salmeri, G., «Salvati da che cosa? La sostituzione vicaria in
Girard e Levinas». Dialegesthai. Rivista telematica di filosofia, 2004, http://mondodomani.org/dialegesthai/.
Quest'articolo sviluppa il tema del senso della sofferenza in Levinas con particolare riguardo ad Altrimenti che
Essere.
66. Levinas, E., Altrimenti che Essere o al di là dell'essenza, p. 140.
67. Ibidem, p. 143.
68. Ibidem. p. 154.
69. Per quanto concerne l'origine del male: Levinas, Di Dio che viene all'idea, p. 157. In particolare il testo
«Trascendenza e male» (si veda la nota 11).
70. Levinas, Altrimenti che essere o al di là dell'essenza, p. 147 (nota 21).
71. Levinas, Umanesimo dell'altro uomo, p. 122.
72. Levinas, Altrimenti che essere o al di là dell'essenza, p. 162.
73. Levinas, Umanesimo dell'altro uomo, p. 122.
74. Levinas, Altrimenti che essere o al di là dell'essenza, p. 229.
75. Ivi.
76. Carriero, «Il paradigma della corporeità nel pensiero femminile: l'oblazione come oltrepassamento della
responsabilità etica verso l'altro», nota 4.
77. Gilligan, C., Con voce di donna: etica e formazione della personalità, Feltrinelli, Milano 1991 [or. 1982], pp. 3637. Questo punto è approfondito in: Salmeri, G., «L'altro e la misericordia. L'itinerario del femminile in
Levinas», Dialegesthai. Rivista telematica di filosofia, 2003, nota 8, http://mondodomani.org/dialegesthai/.
78. Salmeri, «L'altro e la misericordia. L'itinerario del femminile in Levinas», par. 4.
79. Levinas, Altrimenti che Essere, p. 6.
80. Salmeri, «L'altro e la misericordia. L'itinerario del femminile in Levinas», par. 4.
81. Per quanto riguarda Il Tempo e l'Altro, si veda il par. 2 del presente articolo, mentre nei parr. 4 e 5 sono
approfonditi rispettivamente temi trattati da Levinas nell'Umanesimo dell'altro Uomo ed in Altrimenti che
Essere.
82. Levinas, Il Tempo e l'Altro, pp. 29-30. Questo tema è affrontato più volte in: Salmeri, «L'altro e la misericordia.
L'itinerario del femminile in Levinas», p. 2 e par. 4 (nota 8).
83. Levinas, Altrimenti che essere, p. 96.
84. Ibidem, pp. 158.
85. Salmeri, «L'altro e la misericordia. L'itinerario del femminile in Levinas», p. 13 (nota 9).
86. Levinas, Difficile libertà, p. 55.
87. Levinas, Altrimenti che essere o al di là dell'essenza, pp. 130-131. Per un ulteriore approfondimento su questo
tema si veda: Salmeri, «L'altro e la misericordia. L'itinerario del femminile in Levinas», pp. 7-10.
88. Salmeri, «L'altro e la misericordia. L'itinerario del femminile in Levinas», par. 4.
89. Levinas, Altrimenti che essere o al di là dell'essenza, p. 148.
90. Levinas, Difficile libertà, pp. 54-55.
91. Salmeri, «L'altro e la misericordia. L'itinerario del femminile in Levinas», par. 4.
92. Levinas, Difficile libertà, p. 59.
93. Per quest'approfondimento vedi «Studi ecumenici», Istituto di studi ecumenici S. Bernardino, Castello
(Venezia), anno 23, n. 3, luglio-settembre 2005.
94. Levinas, Tra noi. Saggi sul pensare-all'altro, p. 142.
95. Levinas, E., Di Dio che viene all'idea, Jaca Book, Milano 1997 (2a ed.), p. 13.
96. Irigaray, L., Speculum. L'altra donna, Feltrinelli, Milano 1977. Si veda per un ulteriore approfondimento: Verna,
Alterità, le metamorfosi del femminile da Platone a Levinas, pp. 226-230.
97. Levinas, Altrimenti che essere o al di là dell'essenza, pp. 183-184.
98. Fasoli, M.G., «Inferno al Dio delle madri», Dialegesthai. Rivista telematica di filosofia, 1999,
http://mondodomani.org/dialegesthai/.
99. Ivi.
100. Si veda: Baccarini, E., Levinas: Soggettività e Infinito, Studium, Roma 1985, pp. 183-184 (nota 12).
Giovanni Salmeri
L'altro e la misericordia. L'itinerario del femminile
in Levinas
1. L'eccezionalità del femminile
Di fronte a tante opere dell'età contemporanea scritte da un punto visuale esplicitamente
femminile, le conferenze su Il tempo e l'altro del 1946-47 di Emmanuel Levinas vanno annoverate
tra le poche che assumono consapevolmente una prospettiva maschile. La circostanza è così
interessante che merita non solo di essere approfondita, ma anche di essere scelta come punto di
partenza di una riflessione che potrebbe portarci lontano.1
Il titolo delle conferenze intende far allusione alla tesi che in polemica con l'opera maggiore di
Heidegger viene qui sviluppata: il tempo non è «l'orizzonte dell'essere» (così le ultime parole di
Essere e tempo), ma piuttosto la relazione del soggetto con l'altro. Nei termini della successiva
riflessione di Levinas, evocata nella prefazione del 1979, ciò significa che il tempo sarebbe una
modalità dell'«al di là dell'essenza». Se il confronto con Essere e tempo risulterebbe certo
ingeneroso visto il carattere dichiaratamente rapsodico e provvisorio delle riflessioni di Levinas,
sicuramente più equo può essere l'accostamento con l'analoga conferenza di Heidegger su Il
concetto del tempo. In entrambi i casi lo stesso punto nevralgico della filosofia teoretica viene
scelto come chiave per progettare una comprensione della soggettività umana -- e di qui dell'intero
problema dell'essere.
Un confronto tra le due prospettive, che peraltro non sarebbe affatto infedele alle intenzioni di
Levinas, porterebbe qui troppo lontano. Ci contentiamo allora di osservare il punto nevralgico
costituito dalla riflessione sulla morte. Se in Heidegger l'«essere per la morte» è la forma suprema
di libertà del soggetto umano, che può accettare autenticamente la sua temporalità solo
progettandosi in riferimento ad essa, in Levinas l'avvicinarsi della morte nella sofferenza è
l'istaurarsi del rapporto con l'estraneità più totale, con un futuro che non diventerà mai presente e
dunque mai conoscibile (pp. 55-61, it. 41-45). Ma se la morte è la solidificazione più inconfutabile
dell'effetto del tempo sul soggetto umano, ciò significa capovolgere il senso di quest'ultimo: non più
l'orizzonte donde comprendere che cos'è l'essere umano, ma piuttosto che cosa egli non è, ovvero
che capacità e necessità abbia d'incontrare ciò che è assolutamente altro e inconoscibile («relazione
con il mistero», dice anche Levinas). D'altra parte, così viene anche neutralizzata l'antica
determinazione del tempo come «immagine mobile dell'eternità», che nascostamente
continuerebbe ad operare anche laddove, come in Heidegger, la finitudine è ammessa come
qualcosa che limita l'esistenza umana anziché permetterle di entrare in rapporto con ciò che è altro.
Ma dove si realizza originariamente tale rapporto con l'altro? Questo è il tema che Levinas affronta
nella sua quarta e ultima conferenza:
Esiste una situazione in cui l'altro non abbia soltanto l'alterità come l'inverso della sua identità, non
obbedisca soltanto alla legge platonica della partecipazione, in cui ogni termine contiene lo stesso e
per ciò stesso contiene l'altro? Non c'è una situazione in cui l'alterità venga portata da un essere a
titolo positivo, come essenza? Qual è l'alterità che non entra puramente e semplicemente
nell'opposizione delle due specie dello stesso genere? Io penso che il contrario assolutamente
contrario, la cui contrarietà non è colpita in nulla dalla relazione che può stabilirsi tra esso e il suo
correlativo, la contrarietà che permette al termine di restare assolutamente altro, è il femminile (p.
77, it. 56).
Secondo Levinas sono diverse le caratteristiche che pongono questa alterità su un piano
eccezionale. Anzitutto essa non risulta da una distinzione puramente logica, ma ha un contenuto
empirico semplicemente non deducibile razionalmente. In secondo luogo, il femminile non si
ottiene semplicemente negando il maschile, ciò che consentirebbe una sorta di conversione di un
termine nell'altro. In terzo luogo, i due termini non sono complementari, perché non suppongono
una totalità preesistente, né riescono effettivamente mai a crearla (il che sarebbe appunto l'aspetto
patetico del rapporto sessuale). È abbastanza evidente (sia detto per ora per inciso) come queste
analisi segnino un ulteriore congedo dall'analitica esistenziale di Heidegger, in cui il Dasein è
programmaticamente indifferente alla differenza sessuale.2
Indicare l'alterità come femminilità tradisce una voce maschile in una maniera troppo evidente per
non essere consapevole. La cosa venne prontamente osservata da Simone de Beauvoir, che fece di
Levinas l'espressione par excellence del «privilegio maschile».3 Ma non sarebbe allora molto
semplice generalizzare i termini del discorso, renderlo insomma reciproco, traendo anche spunto
dall'occasionale uso dell'espressione «differenza dei sessi» proprio nelle stesse pagine? La
conclusione sarebbe un po' frettolosa. Lo stesso Levinas, ancora nella prefazione scritta nel 1979
(praticamente alla fine del suo itinerario filosofico) si mostra circospetto, quando a proposito della
femminilità come alterità osserva: «bisognerebbe vedere in qual senso ciò si possa dire della
maschilità o della virilità, cioè della differenza dei sessi in generale» (p. 14, it. 14). Il discorso de Il
tempo e l'altro si sviluppa del resto con riflessioni sul carattere «altro» della femminilità, a partire
dalla natura specifica di questa. Questo discorso è reso formalmente necessario dal rifiuto di
considerare, come abbiamo visto, maschile e femminile come due opposti o come due
complementari: con queste premesse, il tema della «differenza sessuale» non può essere affrontato
se non sulla base di una determinazione concreta di entrambi i termini.
Se le premesse sono promettenti, gli sviluppi delle analisi sul «mistero del femminile» lasciano
perplessi. Leggendo le poche pagine dedicate al tema è difficile reprimere l'impressione di avere a
che fare con banalità vagamente conservatrici, un po' dogmatizzate dalla patina fenomenologica
che le avvolge:
L'altro in quanto altro non è qui un oggetto che diviene nostro o che diviene noi stessi; esso al
contrario si ritira nel suo mistero. [...] Ciò che mi importa in questa nozione del femminile non è
solo l'inconoscibile, ma un modo d'essere che si sottrae alla luce. [...] La maniera di esistere del
femminile è nascondersi, e questo fatto di nascondersi è precisamente il pudore. [...] La
trascendenza del femminile consiste nel ritirarsi altrove, movimento opposto al movimento della
coscienza. Ma non è per questo incosciente o subcosciente, e non vedo altra possibilità che
chiamarlo mistero (pp. 78-81. it. 56-59).
Certo: Levinas dichiara esplicitamente di non voler «ignorare le legittime pretese del femminismo
che suppongono tutta la conquista della civiltà» (p. 79, it. 57), e distingue chiaramente la sua
posizione da quella «romantica». Ma il problema è un altro: attribuire proprio alla femminilità,
cioè in concreto alla modalità d'essere delle donne, le caratteristiche dell'«altro» per eccellenza
potrebbe significare da una parte irrigidire la maschilità nel ruolo di soggetto, dall'altra (e questo è
più grave) proiettare sull'essere femminile delle pure esigenze teoriche (derivabili dal suo status di
altro), non sfiorando neppure la ricerca di una determinazione positiva.4
Che del resto la determinazione della femminilità sia a questo stadio ancora affetta da una certa
instabilità risulta da un ulteriore elemento: la trattazione che riceve la materia. Levinas cita con
evidente disapprovazione l'identificazione platonica della femminilità con la materia (p. 88, it. 63),
e contemporaneamente assegna a quest'ultima il ruolo di sancire la solitudine del soggetto. L'unità
indissolubile tra l'esistente e il suo esistere (il sorgere dell'«ipostasi» che interrompe l'anonimità
dell'«essere») avrebbe infatti il suo sigillo nella materialità, descritta come «la tragedia della
solitudine», «l'infelicità dell'ipostasi» (pp. 38, 39, it. 29, 30). D'altra parte, ancora una volta in
polemica con Heidegger, il primitivo rapporto con il mondo è definito non come «strumentalità»
(per la quale, sospettiamo con un po' d'ironia, Levinas cita ad esempio il pulsante dello
sciacquone), ma come «nutrimento»: il mondo è per l'uomo anzitutto un «insieme di nutrimenti»
(p. 45, it. 34), a partire dai quali si definisce il suo primitivo rapporto di «godimento». Si può
pensare che qui differenti elementi preziosi siano ancora irriconosciuti nella loro unità? Forse si
può ipotizzare che nell'identificazione platonica della femminilità con la materialità sia all'opera
una duplice sottovalutazione, maschilista e idealista, che avrebbe bisogno di un duplice
capovolgimento più che di una negazione. E la materia non è anzitutto proprio l'unico medium per
uscire fuori di sé? e il nutrimento non è anzitutto il rapporto con la madre prima che il rapporto
con il mondo? Per ora lasciamo queste domande in sospeso.
2. Debolezza e tenerezza
Fatto sta che nell'armonica architettura di Totalità e infinito, pubblicato più di una ventina d'anni
dopo, il tema del femminile viene rielaborato in forme notevolmente differenti. Ciò è tanto più
degno di nota in quanto l'intento fondamentale dell'opera, e anche in buona misura il repertorio di
temi e la terminologia, coincidono con quelli delle conferenze su Il tempo e l'altro. Ciò che muta
più vistosamente è il punto di partenza, che ora è costituito da una più generale critica al pensiero
della «totalità», che Levinas trae dichiaratamente da Franz Rosenzweig. Ma se in questi l'obiettivo
polemico era principalmente Hegel, ora esso si estende fino a diventare l'intero corso principale del
pensiero europeo: «Il volto dell'essere che si rivela nella guerra si fissa nel concetto di totalità che
domina la filosofia occidentale. In essa gli individui sono ridotti ad essere i portatori di forze che li
comandano a loro insaputa. Gli individui traggono da questa totalità il loro senso (invisibile al di
fuori di questa totalità stessa)» (p. X, it. 20). Ma il pensiero della totalità viene radicalmente
spodestato dal desiderio dell'infinito che costituisce da parte sua un movimento altrettanto tipico
del pensiero filosofico: in esso l'io va alla ricerca di ciò che esso non è e che solo l'Altro può offrire.
Questo significa riconoscere un primato all'etica, perché l'Altro è colui che mi costringe alla
responsabilità e a partire dal quale soltanto la mia libertà è «investita». Così potrebbe essere
riassunta la tesi fondamentale di Totalità e infinito.
Ma appunto, dov'è ora il posto della femminilità? Essa ora compare in due tappe distinte
dell'itinerario. La prima si trova verso la fine della sezione dedicata ad «Interiorità ed economia».
In essa Levinas intende mostrare come l'Infinito, al contrario della totalità, permette ed esige che
l'Io abbia separazione ed interiorità: il rapporto con l'Infinito che si annuncia nell'altro consiste
proprio nel fatto che questo si «contrae» per lasciare all'io la possibilità di esistere senza essere
inglobato. Questa esistenza separata è a sua volta quella che permette che vi sia qualcosa come
un'interiorità, che non sia il semplice canale di passaggio per il raggiungimento di una verità
universale (come nella reminescenza platonica). Dal punto di vista dell'esistenza, tale esigenza
d'interiorità, che fa tutt'uno con la soggettività umana, si realizza nell'abitazione. In essa deve
avvenire un duplice movimento a prima vista contraddittorio: da una parte la «sospensione delle
reazioni immediate sollecitate dal mondo» (p. 129, it. 157), dall'altra la conferma del proprio
rapporto con il mondo sotto forma di «godimento»: ma questa è proprio la «dimensione di
interiorità a partire dalla familiarità intima in cui si immerge la vita» (p. 130, it. 158), dimensione
che esige l'incontro con qualcuno. È qui che entra in gioco il femminile:
Perché l'intimità del raccoglimento possa prodursi nell'ecumenicità dell'essere è necessario che la
presenza d'Altri non si riveli soltanto nel volto che si fa strada attraverso la propria immagine
plastica, ma che si riveli, contemporaneamente a questa presenza, nel suo ritiro e nella sua assenza.
Questa contemporaneità non è una costruzione astratta della dialettica, ma proprio l'essenza della
discrezione. E l'Altro la cui presenza è discretamente un'assenza e a partire dal quale si attua
l'accoglienza ospitale per eccellenza che descrive il campo dell'intimità, è la Donna. La donna è la
condizione del raccoglimento, dell'interiorità della Casa e dell'abitazione (p. 130, it. 158).
D'altra parte, è solo il raccoglimento che rende possibile l'accoglienza, quell'aprire le porte della
propria casa che appare ancora una volta il gesto di una donna.
La seconda presenza del femminile in Totalità e infinito si trova alla fine dell'itinerario, nella
sezione «Al di là del volto». Qui Levinas si confronta con il tema della morte: se esso viene
preventivamente anestetizzato in un pensiero della totalità (questa l'intuizione iniziale della Stella
della redenzione di Rosenzweig), nella prospettiva dell'Infinito richiede una risposta del tutto
diversa. Ora in questione è una violenza che pare che «riduce al silenzio la soggettività» (p. 231, it.
259), proprio quella soggettività che l'Infinito permette nella sua «separazione». È possibile per l'Io
andare al di là della morte? La risposta di Levinas è positiva, ed è significativo che essa riutilizzi
proprio lo stesso contesto che era prima servito a caratterizzare l'interiorità che rende possibile la
soggettività: il superamento della morte avviene infatti nella fecondità, che è il prolungamento
intrinseco della relazione d'amore. Il femminile viene dunque qui incontrato sotto la figura
dell'Amata:
L'amore tende ad Altri, vi tende nella sua debolezza. La debolezza non rappresenta qui il grado
inferiore di un attributo qualsiasi, la deficienza relativa di una determinazione comune a me e
all'altro. Anteriore alla manifestazione degli attributi, essa qualifica l'alterità stessa. Amare significa
temere per altri, dare aiuto alla sua debolezza. In questa debolezza, come nell'aurora, sorge l'Amato
che è Amata. Epifania dell'Amato, il femminile non viene ad aggiungersi all'oggetto e al Tu,
preliminarmente dati o incontrati al neutro, il solo genere che la logica formale conosca. L'epifania
dell'Amata è una cosa sola con il suo regime di tenerezza (p. 233, it. 263).
È l'incontro con l'Amata che permette la fecondità e quindi la vittoria sulla morte, ma esso è avvolto
in quella che Levinas denuncia con forza come un'ambiguità: l'Eros è certo proiezione verso un
aldilà sempre più lontano, ma anche spinta al godimento e all'appropriazione. Il volto femminile è
debolezza, tenerezza e commozione, ma anche possibilità di fraintendimento nella voluttà e nella
profanazione. Attraverso la femminilità risulterebbe dunque filtrato per eccellenza l'equivoco della
soggettività umana.5
Sono tali posizioni coerenti o anche solo compatibili con quelle espresse ne Il tempo e l'Altro?
Ancora nel 1982, Levinas dichiarava di non «rinnegare» queste ultime. È tuttavia evidente che tale
continuità non esclude un'evoluzione precisa e palpabile: la femminilità in Totalità e Infinito viene
trattata non più come l'alterità in assoluto, ma piuttosto come il punto di riferimento dal quale la
concretezza del rapporto con l'altro si produce nella maggiore potenzialità -- e ambiguità. Si
potrebbe dire che la lezione della femminilità, con tutta la differenza abissale che essa porta con sé,
è già stata imparata e, seppure compaia esplicitamente solo dalla metà dell'indagine in poi, in
realtà ne determina le movenze fin dall'inizio. La prima allusione al rapporto d'amore compare in
effetti fin dalla prima pagina, dove il «desiderio» viene distinto dal «bisogno» con l'aiuto di una
sobria allusione all'incontro dell'amore:
Il desiderio metafisico non aspira al ritorno, perché è il desiderio di un paese nel quale non siamo
mai nati. Di un paese straniero ad ogni natura, che non è stato la nostra patria e nel quale non ci
trasferiremo mai. Il desiderio metafisico non si fonda su nessuna parentela preliminare. Infatti si
parla troppo alla leggera di desideri soddisfatti o di bisogni sessuali o, ancora, di bisogni morali e
religiosi. Perfino l'amore è allora considerato alla stregua della soddisfazione di una fame sublime.
Un linguaggio di questo tipo è possibile solo perché la maggior parte dei nostri desideri, compreso
l'amore, non è pura (p. 3, it. 32, cors. nostro).
Insomma: la netta identificazione dell'alterità con la femminilità si scompone in Totalità e infinito
in una costellazione di temi: c'è anzitutto il volto d'Altri con la sua fusione di debolezza e sublimità,
c'è la «casa» dove il soggetto costruisce nei rapporti familiarità la sua interiorità, c'è l'eros
attraverso cui l'io si proietta al di là del tempo nel tempo infinito della fecondità. Se l'analisi della
femminilità ne Il tempo e l'altro intendeva quindi contestare Heidegger, il discorso di Totalità e
Infinito se ne fa ancora più essenzialmente lontano: le conseguenze di una riflessione filosofica
sulla femminilità vengono incorporate nella stessa struttura del discorso filosofico e poste
all'origine dei movimenti fondamentali della soggettività. In questo senso, per quanto l'immagine
del femminile possa apparire pregiudiziale, essa implicitamente rimette in questione anche la
maschilità, sottraendole la possibilità di essere concepita come una possibilità autonoma: il
maschile è tale solo nell'intimità resa possibile dal femminile.
Che rapporto ha tutto ciò con la questione ontologica, il cui primato Totalità e infinito vuole
spodestare in nome dell'originarietà dell'etica? Come Levinas stesso riconobbe, affermare l'alterità
come femminilità significa anzitutto affermare l'impossibilità d'incontrare l'altro
indipendentemente dai contenuti vitali della sua esistenza, un po' come la «sostanza» di cui
parlava Locke, un sostrato enigmatico e privo di contenuti: ma privo di contenuto perché
artificialmente svuotatone, nel quale quindi non bisogna stupirsi di non trovare alla fine ciò che fin
dall'inizio è stato soppresso. Ma non era questa la connotazione dell'«il y a» dalla quale Levinas
intende dissociarsi? Questa assonanza merita di essere presa sul serio. Come abbiamo accennato,
l'analisi de Il tempo e l'altro prendevano le mosse dall'emergere della concretezza dell'esistenza
umana, l'«ipostasi», dall'anonimità silenziosa e opprimente del brusìo dell'essere, quell'anonimità
in cui Levinas vede imprigionato il discorso di Heidegger.
Ma a che cosa corrisponde questa nozione nel discorso di quest'ultimo? Le dichiarazioni di Levinas
sono un poco oscillanti. Nella prefazione alla seconda edizione di Dall'esistenza all'esistente
Levinas avverte, echeggiando del resto le considerazioni di Heidegger stesso nella Lettera
sull'umanismo, che il bersaglio non è l'«es gibt» («si dà»): «["Il y a" è un] termine
fondamentalmente distinto dall'"es gibt" heideggeriano. Non è mai stato né la traduzione, né la
copia a buon mercato dell'espressione tedesca e delle sue connotazioni di abbondanza e
generosità». Ma nel breve testo della «Firma» del 1963, pubblicata in Difficile libertà, Levinas
sembra dubitare di questa distinzione: «Nessuna generosità che pare conterrebbe il termine
tedesco "es gibt" si manifestava in esso tra il 1933 e il 1945. Bisogna che sia detto!» (p. 375, it. 43).
Più costante sembra la proposta d'identificare l'«il y a» con il «Sein» di Heidegger: ciò avviene tra
l'altro proprio in Totalità e infinito, dove il paragrafo conclusivo che dichiara guerra «Contro la
filosofia del Neutro» denuncia la «neutralità impersonale» dell'«essere dell'ente» di Heidegger che
trascinerebbe la filosofia di questi verso un «materialismo vergognoso» (pp. 278-9, it. 306-7). Ma
anche tale corrispondenza è problematica (lo notò tra gli altri Derrida): l'essere è certo sempre
l'essere di qualcosa, non una forza opaca e bruta da cui, come un'increspatura, si coagulerebbero i
singoli enti. Se la presa di distanza sembra insomma giustificabile sulla base di una vaga tonalità
del pensiero di Heidegger, più difficile è individuare un bersaglio preciso.
Ma non potrebbe questo trovarsi, un po' obliquamente, proprio nel fatto che l'analisi del Dasein,
dalla quale secondo le movenze del primo Heidegger dipende il chiarimento della domanda
sull'essere, prescinde dalla considerazione della maschilità e della femminilità? è un caso che un
essere anonimo viene così efficacemente caratterizzato da Levinas come «neutro», che
etimologicamente significa «né maschile né femminile»? È ovvio che prescindere non equivale a
negare (ogni discorso con pretese filosofiche, se non ogni discorso in assoluto, è costretto a
prescindere da innumerevoli fattezze per poter aspirare all'universalità). Il problema è se
l'omissione della differenza sessuale non faccia dimenticare qualcosa di essenziale ad una pure
elementare determinazione dell'umano, fino a gettarlo, insieme con l'essere nel quale è implicato,
in un'impermeabile nebbia, in cui l'essere-nel-mondo non riuscirebbe mai a raggiungere, parimenti
per uomini e donne, né l'intimità di una casa né l'emozione di un'accoglienza. Ecco un'ipotesi che,
seguendo il discorso di Levinas, ci sarà preziosa.6
3. La trascendenza dell'io
Se già in Totalità e Infinito il femminile appariva ridimensionato nella sua funzione apparente, tale
movimento sembra giungere al suo esito ultimo in Altrimenti che essere. Il tema, e con esso la
terminologia che lo esprimeva, è praticamente scomparso. Il motivo può essere cercato anzitutto
nella differente impostazione del discorso, sulla quale il primo capitolo, «Essenza e
disinteressamento», può darci sufficienti indicazioni. Prendendo le mosse, grazie al lessico
platonico del Sofista, dal problema della trascendenza come passaggio all'«altro dell'essere»,
Levinas chiarisce la natura «violenta» di ogni essenza. Non si tratta di denunciare la presunta
natura violenta del discorso sull'essere (cosa che qui a Levinas sembra importare poco), ma di
rilevare come la stessa «essenza», interpretata come «interessamento», sia la radice di ogni
violenza:
Positivamente, [l'interessamento] si conferma come conatus degli enti. E la positività cosa può
significare d'altro se non questo conatus? L'interessamento dell'essere si drammatizza negli
egoismi in lotta gli uni contro gli altri, tutti contro tutti, nella molteplicità di egoismi allergici che
sono in guerra gli uni contro gli altri e, così, insieme. La guerra è il gesto o il dramma
dell'interessamento dell'essenza (pp. 4-5, it. 7).
Controbilanciando le pagine finali (281-4, it. 313-5) di Totalità e Infinito dedicate al tema, ora
Levinas si mostra scettico pure verso l'ideale della pace: benché ovviamente preferibile alla guerra,
anch'essa, come risultato di compensazioni e mediazioni, esprime la stessa autoaffermazione
dell'«essenza» che si manifesta nella guerra. Si tratta di una presa di distanza molto significativa
per misurare il grado di approfondimento, a volte quasi parossistico, cui Levinas sottopone le
analisi degli anni precedenti, tentando di purificarle e smascherarne ogni più piccola ambiguità.
Insomma: il problema non consiste più soltanto nell'individuare una trascendenza verso l'Altro,
che ora non sarebbe più ritenuta abbastanza «trascendente», ma nel pensare una trascendenza
dell'Io stesso, della soggettività, che la liberi dell'incatenamento alla sua identità, fonte prima di
ogni violenza. Le prime indicazioni fornite non possono che essere evocative:
Si tratta di pensare la possibilità di uno sradicamento dall'essenza. Per andare dove? Per andare
verso quale regione? Per attenersi a quale piano ontologico? Ma lo sradicamento dall'essenza
contesta il privilegio incondizionato della questione: dove? Esso significa il non-luogo. L'essenza
pretende di ricoprire e di recuperare ogni ec-cezione; la negatività, la nientificazione e, già dopo
Platone, il non-essere che «in un certo senso è». Bisognerà perciò mostrare che l'eccezione
dell'«altro dall'essere», al di là del non-essere, significa la soggettività o l'umanità, il sé stesso che
respinge le annessione dell'essenza. Io unicità, al di fuori di ogni paragone perché al di fuori della
comunanza, del genere e della forma, che non trova più riposo in sé, in-quieto, che non coincide
con sé (pp. 9-10, it. 12).
La dialettica Stesso-Altro, che dominava finora, si vede così contestata fin dal primo elemento: il
«sé», l'umanità, la soggettività umana, è pensabile solo non come essente, ma come «altrimenti che
essente». Certo spontaneamente e inevitabilmente tende all'essere, all'autocomprensione neutra e
sistematica parallela all'autoaffermazione esistenziale, ma nel suo gesto iniziale è altra da esso. È
evidente che in questa nuova impostazione non c'è più spazio per un'alterità concepita
esplicitamente come femminilità, semplicemente perché è il tema stesso dell'Altro che diventa in
una certa misura secondario, o comunque non più prioritario in un mutato punto di vista. 7
L'impresa di Levinas può sperare di essere convincente, di non essere liquidata come un'utopia
morale surrettiziamente vestita da antropologia, solo nella misura in cui mostra concretamente tali
rapporti di precedenza. Ciò avviene per esempio nelle analisi che vengono dedicate al rapporto tra
«Dire» e «Detto»: che il secondo prenda corpo solo nel contesto del primo è evidente. Ma laddove
il secondo consente e incoraggia una comprensione sinottica della realtà (trasportando dunque nel
campo dell'essere), il primo è un atto in cui la persona si espone, si mette in gioco, si «rivolge» a
qualcun altro. Questo «rivolgere» può essere inteso pure nel senso in cui si «rivolta» un vestito,
cioè si fa diventare esteriore e dunque non più confinato nel tranquillo dominio dell'interiorità ciò
che sarebbe altrimenti una pacifica identità con sé. Anche in questo caso, come in quello prima
notato della pace, le analisi che qui abbiamo riassunto (e forse anche ridetto con una certa libertà)
riprendono temi consueti del pensiero di Levinas, radicalizzandoli però in una direzione nuova.
Ma il centro di Altrimenti che essere, come dichiarato dall'autore stesso nella «Nota preliminare»,
è la riflessione sulla «sostituzione» che domina il capitolo quarto. Se volessimo tentare di
esprimerne il nucleo come esito dell'itinerario di pensiero di Levinas, potremmo più o meno dire
così: l'autentico atto di trascendenza della persona è l'incontro con l'altro in cui viene scoperta la
propria originaria responsabilità; ma essere responsabile di un altro, «rispondere» di ciò che egli
fa, è possibile solo «sostituendosi» a lui, cioè vivendo la sua esistenza nella propria. Dalla
trascendenza di cui parlava Totalità e infinito, la trascendenza verso l'altro, si passa così a
concepire una trascendenza all'interno di sé. Ma questa è una perdita dell'«essere», della
coincidenza con sé: se l'uomo è definito essenzialmente come essere morale (il che in fondo vale
certo non solo in Levinas, ma più o meno da Socrate in poi), sostituirsi ad un altro significa un
altrimenti che essere, e soltanto giustifica in senso radicale quello che fin dal tempo di
Dall'esistenza all'esistente è il motto platonico che guida Levinas: il «Bene al di là dell'essere», e ciò
anche riguardo all'essere proprio. Tutto ciò crediamo che ridimensioni efficacemente l'accusa al
discorso levinasiano di costituire non una descrizione dell'esperienza umana comune, ma piuttosto
l'assolutizzazione di un'esperienza eccezionale: una critica singolarmente superficiale che funziona
egualmente bene ovunque l'uomo venga ritenuto qualcosa di più che «vestigium coiti aliquamdiu
permanens» (Schopenhauer).
4. Il soggetto materno
Molte delle analisi che Levinas conduce potrebbero essere a prima vista definite come riscritture
del concetto di empatia, che proprio nella scuola fenomenologica, grazie alla penna di Edith Stein,
avevano ricevuto approfondimenti di prim'ordine. Il parallelo va limitato notando che per Edith
Stein l'empatia è essenzialmente una via di riconoscimento dell'altro, mentre per Levinas la
sostituzione costituisce il nucleo originario dell'esperienza etica. Tale distinzione non va tuttavia
esagerata: se ciò di cui parla Levinas non è conoscenza, non è perché la contraddica, ma piuttosto
perché se ne situa alle spalle, prima che le inevitabili architetture del «Detto» intervengano a
cristallizzare il gesto del «Dire» (la coppia concettuale prima introdotta ora ci è molto utile). Non
sono contrarie al conoscere misericordia, pietà, compassione, tenerezza, responsabilità:
semplicemente sono più originarie, o meglio ancora (l'ossessione terminologica non è qui
ingiustificata) sono pre-originarie, perché rimandano più ad uno spazio vuoto e accogliente nel
proprio essere che ad un fondamento stabile.8
Ma -- non è questo un linguaggio tipicamente femminile e ben poco maschile? Già l'interesse di
una donna come Edith Stein potrebbe mettere sull'avviso, ma l'elenco delle testimoni può essere
molto allungato. Tra le numerose voci che potrebbero essere evocate, scegliamo quella di Carol
Gilligan, che nel suo celebre studio del 1982 distingueva la natura di un'etica maschile da quella di
un'etica femminile caratterizzando la prima in termini di diritti, norme, giustizia, la seconda in
termini di cura, responsabilità, interdipendenza. Si tratta di priorità differenti che sono
caratteristiche di ciascun sesso, dato che affondano le proprie radici nei differenti percorsi di
evoluzione psicologica:
Per il bambino e per l'uomo la separazione e l'individuazione sono legate in modo decisivo
all'identità di genere, in quanto per lo sviluppo dell'identità maschile è essenziale la separazione
dalla madre. Per la bambina e per la donna, invece, i problemi di femminilità o di identità
femminile non dipendono dall'aver realizzato la separazione dalla madre o dal progredire del
processo di individuazione. Poiché la mascolinità si definisce attraverso la separazione e la
femminilità si definisce attraverso l'attaccamento, l'identità di genere maschile risulta minacciata
dall'intimità, mentre l'identità di genere femminile è minacciata dalla separazione. Perciò i maschi
tendono ad avere problemi di rapporto, e le femmine problemi di individuazione (Con voce di
donna: etica e formazione della personalità, Feltrinelli, Milano 1991 [or. 1982], p. 36).
In questo modo si rivelerebbe non soltanto l'unilateralità delle teorie morali (e dell'evoluzione
morale) che hanno il proprio fulcro sul perseguimento di valori astratti e universali, ma anche delle
analisi psicologiche, Freud in testa, che, dopo aver preso come punto di riferimento l'evoluzione
maschile, giungono a giudicare quella femminile come «malriuscita». Essa non passa infatti per la
canonica formazione di una coscienza morale («Super-Io» se si vuole) inesorabile e impersonale,
ma piuttosto si mantiene essenzialmente sensibile ai sentimenti, alla tenerezza, alla capacità
d'immedesimarsi negli altri e vivere come proprie le loro gioie e sofferenze: tutti aspetti che
fatalmente alla percezione etica maschile possono apparire immaturi e umorali.
Se questa ipotesi è fondata, bisognerebbe concludere che il mutamento di prospettiva adottato da
Levinas nel passaggio da Totalità e Infinito ad Altrimenti che essere ha ottenuto i suoi effetti in
modo ancora più perfetto di quanto esplicitamente dichiarato: la femminilità scompare -- è vero -da una considerazione esplicita, perché non viene più tematizzata la trascendenza verso l'altro; ma
il fatto che la trascendenza ora avvenga nel soggetto fa sì che la femminilità venga descritta dentro
ad esso, venga anzi identificata con la soggettività stessa, come se l'umanità stessa non fosse
pensabile senza una matrice di femminilità -- di tenerezza e di accoglienza -- alla sua base. Esistono
almeno due indizi che corroborano questa interpretazione.
Il primo si trova nella diversa considerazione della «materialità»: se ne Il tempo e l'altro essa
veniva, come abbiamo visto, addebitata dell'incatenamento a sé della soggettività, ora essa, intesa
come «incarnazione» diventa la possibilità stessa di una soggettività intesa come sostituzione. Le
analisi andrebbero qui seguite attentamente fino a percorrere l'intero campo della sensibilità.
Completando le analisi di Totalità e infinito (come esplicitamente notato a p. 92, it. 93, nt. 8),
Levinas ora legge la sensibilità come «esposizione all'altro», dunque segno di una passività
originaria e inversione del conatus essendi. Ma ovviamente un soggetto sensibile non è altro che un
soggetto realizzato nella materia, avente un corpo tramite cui può avvicinarsi (diventar
«prossimo») all'altro e incontrarlo nei suoi bisogni:
È perché la soggettività è sensibilità -- esposizione agli altri, vulnerabilità e responsabilità nella
prossimità degli altri, l'uno-per-l'altro, cioè significazione -- e la materia è il luogo stesso del perl'altro [...] -- che il soggetto è di carne ed ossa, uomo che ha fame e che mangia, viscere in una pelle
e, così, suscettibile di dare il pane della propria bocca o di dare la propria pelle (p. 95, it. 96).
Non potrebbe dunque questa dislocazione della materia, trascinata, via dalla pesantezza
dell'esistenza dove si affaccia la solitudine del dolore (Il tempo e l'altro), alla vicinanza dove
avvengono la condivisione e la misericordia, essere proprio uno degli squarci di una femminilità
innestata nel cuore dell'umano? Certo, il facile gioco etimologico mater -- materia (tanto facile,
però, che rischia di passare inosservato) deve essere guardato sempre con un po' di distacco: ci si
potrebbe ancora una volta chiedere se sia lecita questa riconduzione, o se essa non nasconda in
fondo ancora un residuo di maschilismo.
Ma a ridimensionare il dubbio c'è un secondo indizio meno ambiguo: nel capitolo sulla
sostituzione, in un paio di occasioni cruciali, Levinas usa direttamente il termine «maternità». La
prima volta la metafora viene esplicitamente evidenziata come la più preziosa per comprendere il
senso del «sé stesso», di quel movimento che Levinas chiama la «ricorrenza»: esso indica quella
passività del soggetto che è anteriore a qualsiasi coscienza di sé, che permette di percepirsi come
«creatura» indipendentemente da, anzi senza, la percezione di un «creatore»: «il sé stesso non è
nato di sua propria iniziativa» (p. 133, it. 132). In questo contesto Levinas spiega:
Il si del «mantenersi» o del «perdersi» o del «ritrovarsi» non è un risultato, ma la matrice stessa
delle relazioni, o degli avvenimenti che questi verbi pronominali esprimono. E l'evocazione della
maternità in questa metafora ci suggerisce il senso proprio del sé stesso. Il sé stesso non può farsi,
esso è già fatto di passività assoluta e, in questo senso, vittima di una persecuzione che paralizza
ogni assunzione che potrebbe svegliarsi in esso per porlo per sé, passività del legame già annodata
come irreversibilmente passata, al di qua di ogni memoria, di ogni richiamo (pp. 132-3, it. 131).
L'unico modo in cui l'osservazione di Levinas può essere intesa sembra questo: il «sé stesso» ha un
carattere «materno» in quanto, così come appunto la madre, ha una natura eminentemente
passiva. Ma perché evocare la maternità e non semplicemente la femminilità? È evidente che la
maternità indica un rapporto con l'altro (il figlio) che manca alla femminilità in quanto tale. Ma
sarebbe fuorviante fermare la propria attenzione sul punto di partenza della metafora: come il
seguito del discorso mostra, il rapporto che interessa non è quello nei confronti «delle relazioni, o
degli avvenimenti», ma piuttosto del prossimo, che richiama alla responsabilità prim'ancora che ce
se ne possa accorgere o ce se ne possa ricordare, dunque per così dire da un passato immemorabile.
La funzione del tempo è qui simile a quella intravista in Il tempo e l'altro (che Levinas in effetti non
manca di citare), ma viene proiettata verso il passato, che ancora più del futuro mantiene il suo
carattere di totale estraneità e improgrammabilità, per lo meno quando non sia considerato il
semplice correlato di una reminescenza in cui ancora il soggetto celebrerebbe la sua rivincita.9
Un paio di pagine dopo, Levinas riprende lo stesso termine in una dichiarazione lapidaria:
«L'identità ingiustificabile dell'ipseità si esprime in termini come me, io, sé stesso e -- tutto questo
lavoro tende a mostrarlo -- a partire dall'anima, dalla sensibilità, dalla vulnerabilità, dalla
maternità e dalla materialità che descrivono la responsabilità per gli altri» (p. 135, it. 133). Il nesso
che viene stabilito con la responsabilità è chiarificatore e ci permette questa parafrasi: la
soggettività umana può essere descritta a partire dalla maternità perché l'io è responsabile
dell'altro così come una madre è responsabile del figlio, perché l'io viene «colpito» ed è ostaggio
dell'altro così come una madre è ostaggio del proprio figlio, perché l'io si sostituisce all'altro così
come una madre si sostituirebbe al figlio -- cioè indipendentemente da ogni calcolo e al di fuori di
ogni reciprocità. È in questo modo che Levinas, seppure in una sola frase, può recuperare in un
colpo quel mondo del sentimento che così difficilmente riusciva a farsi strada nelle opere
precedenti: «È in nome della condizione di ostaggio che nel mondo ci può essere pietà,
compassione, perdono e prossimità» (p. 150, it. 148). La materia è dunque mater non perché
l'uomo da essa provenga e debba distaccarsi (questo sarebbe proprio il meccanismo psicologico
dell'evoluzione maschile da cui Levinas si affranca), ma piuttosto perché permette all'uomo di
essere «materno», prima che l'ontologia creata dallo spirito stabilisca la supremazia di un'etica
fondata sulla giustizia universale.
Da tutto ciò è evidente che quello che qui interessa a Levinas non è il rapporto di generazione in sé.
Questo era stato già oggetto di analisi dettagliate (e molto profonde) alla fine di Totalità e Infinito,
dove però ne veniva individuato il protagonista il padre, non la madre. Nella sezione «Al di là del
volto» la generazione del figlio, prendendo le mosse dal rapporto erotico, veniva studiata come ciò
che è capace dall'interno di rompere l'intimità e la conseguente ambiguità del rapporto a due. Il
figlio è un altro sé stesso che tuttavia è un altro, e questo è appunto il senso della generazione.
L'essenziale della maternità invece non è più la relazione con l'esistenza del figlio, ma verso di
questi il sentimento, la partecipazione emotiva, il lasciarsi commuovere, l'inevitabilità del
«sostituirsi». Insomma: il discorso di Levinas procede come se il figlio fosse correlativo al solo
padre, mentre la maternità disegnasse il dover essere di ogni persona, fin nel suo intimo, e quindi,
prima ancora del suo «essere» maschile, il suo «altrimenti che essere» femminile. Dicendo così,
non stiamo ripetendo alla lettera Levinas, ma stiamo riannodando alcuni fili pendenti, esplicitando
così quell'ultimo trait-d'union che Altrimenti che essere sembra non avere ancora il coraggio di
fare.
Il filo che stiamo riannodando è in realtà anche un altro. Esso si trova nelle pagine in cui Levinas
intende distinguere l'«altrimenti che essere» non solo dall'«essere altrimenti», ma pure dal «non
essere»:
Nemmeno non-essere. In questo caso passare non equivale a morire. L'essere e il non-essere si
chiariscono mutuamente e sviluppano una dialettica speculativa che è una determinazione
dell'essere. O la negatività che tenta di respingere l'essere è subito sommersa dall'essere. Il vuoto
che si crea si riempie subito del sordo e anonimo fruscìo del c'è, così come il posto lasciato vacante
da chi muore si colma del mormorìo dei postulanti (p. 6, it. 6).
Insomma: se l'«altrimenti» fosse inteso come negazione, ciò che si otterrebbe sarebbe ancora una
volta l'«anonimità», il «neutro», Ma non è allora così confermata l'ipotesi prima formulata, che
cioè nel pensiero di Levinas, più meno coscientemente, sia la femminilità (qui intesa come capacità
di compassione e di tenerezza) ad evitare che l'universalità dell'essere si rivolti nell'indecifrabilità
di un brusìo?
5. Ancora misericordia
È da porre seriamente in dubbio (sia detto con rammarico) che il discorso di Levinas sia facilmente
integrabile, malgrado le tenui proteste di quest'ultimo, nel variegato sforzo per compensare le
donne della marginalità in cui tanta storia mondiale le ha costrette e le costringe. Che
«femminismo» sia il nome di un nobile e rispettabile movimento, ma «maschilismo» solo di una
rozza prepotenza, non è purtroppo una stranezza linguistica. Il significato delle parole è anche la
traccia della storia che sono costrette a sopportare e del futuro che propongono. E il peso della
storia non dovrebbe mai proibire lo slancio dell'utopia, in questo caso la ricerca di un futuro in cui
sia restituito e assicurato il valore della femminilità, e dunque anche la maschilità possa tornare a
giocare il suo ruolo con serenità, svanita la prepotente illusione di rappresentare il modello
dell'umanità tout-court, un'illusione che attraversa la storia della cultura occidentale da Aristotele
a Freud.
Più in generale, è difficile credere che il lungo itinerario di Levinas, che abbiamo tentato di
ricostruire e interpretare, abbia qualcosa di veramente significativo da dire in vista di una
«determinazione filosofica» della femminilità. Ma è questo il compito più urgente? è sicuro che
abbiamo bisogno di definizioni filosofiche del maschile e del femminile? non si trasforma
fatalmente ogni definizione in un'assegnazione di compiti e in un criterio di giudizio e pregiudizio?
Ci sembra che la morale della storia che abbiamo ricostruito sia completamente diversa. Alla fine,
della donna sappiamo esattamente quanto prima (lo scrivente associa inevitabilmente la sua voce
maschile a quella di Levinas): da un «mistero» (Il tempo e l'altro) ad un'assenza (Altrimenti che
essere) il progresso non pare molto. Tuttavia, dell'essere umano si ha l'impressione che si è capito
molto di più: perché questi -- ne parliamo come fosse un personaggio in una storia a puntate -- si è
lasciato interrogare e provocare dal femminile, da ciò che ha trovato irriducibilmente differente. In
altre parole, la strada tracciata da Levinas suggerisce quanto sia prezioso fare i conti con l'altro per
comprendere sé, e attraverso lo specchio della differenza interrompere la catena della continuità
con sé stessi.
Ciò non significa usare l'altro come una sponda per poi ritornare a sé stessi (secondo il mito di
Ulisse tante volte citato da Levinas per prenderne le distanze), ma piuttosto ottenere un senso di
libertà più originario di quello del libero arbitrio: la possibilità di ricominciare in maniera nuova la
propria identità, non più predeterminati dal peso del proprio passato. Quasi come se
l'«intersoggettività», sotto cui è facile catalogare frettolosamente anche il pensiero di Levinas, fosse
in fondo una scala che può esser gettata via dopo l'uso. È in questo modo che vogliamo interpretare
il lungo itinerario in cui l'incontro con il «femminile», per quanto possa essere ritenuto filtrato da
stereotipi e pregiudizi, di fatto ha spinto il discorso di Levinas a riformulare la stessa nozione di
soggettività umana: fino a scoprire dentro di essa, come la sua possibilità da sempre presente e
però fino ad allora non tematizzata, la capacità di percepire e vivere dolori e gioie degli altri come
proprie, di essere sempre nuovi non in nome dell'originalità ma in nome della misericordia -usiamo volentieri questo termine per rispettare la contestabile ma comprensibile diffidenza di
Levinas verso le ambiguità dell'«amore».
È solo questa novità che consentirebbe d'infrangere un concetto di «essere» che altrimenti,
perennemente preoccupato solo di essere identico a sé stesso, deve ben presto, malgrado qualsiasi
intenzione contraria, ridursi ad una nebbia anonima e prendere congedo da ogni sorpresa e da ogni
emozione. Tra esse c'è, forse al primo posto, quella commozione che mostra una madre verso il suo
bambino, per il quale lei stessa è il primo e fondamentale nutrimento, commozione viscerale che è
l'unica che permette all'umanità di esistere e ad immagine della quale è concepibile ogni minuscolo
atto di condivisione.10 Se Hannah Arendt ha scoperto, di fronte a tante «meditazioni della morte»
filosofiche e religiose, quanto sia fondamentale la «nascita» per comprendere la carica di novità
insita nella presenza umana del mondo, Levinas fornisce i materiali per cominciare a pensare
quanto ogni gesto di misericordia segni una rinascita dell'umano: un ingresso nella coscienza di
qualcosa prima inesistente e improgrammabile (sentimenti altrui, ora nella propria pelle), un
ingresso che contemporaneamente riconosce l'altro ed è perciò in grado di farlo realmente
«nascere», di farlo cioè entrare come soggetto in un mondo. Tutte le volte in cui con evidente
timore e tremore Levinas si è avvicinato all'idea del «morire per un altro», la forma estrema e
irreversibile della compassione, ha avvicinato in effetti alla riflessione la possibilità che una tale
fine del soggetto rappresenti, pure indipendentemente da qualsiasi promessa d'immortalità (e forse
ancor meglio prima di essa), un capovolgimento del linguaggio della morte: come se il significato
fosse il contrario di ciò che letteralmente viene detto.
Che tutto ciò stia all'origine dell'eticità e dell'umano, e non ne sia né una decorazione sentimentale
né un'opzionale eccellenza, ci pare che sia il punto focale verso cui convergono in fin dei conti, in
maniera più o meno espressa e cosciente, gli sforzi di Levinas. In ogni caso, questa è l'idea con cui
simpatizziamo. Che la misericordia sia all'origine della responsabilità, che il perdono sia all'origine
della giustizia, che il «porgere l'altra guancia» sia all'origine della pace: tutto ciò non significa
sostituire l'etica e la politica con i buoni sentimenti, ma solo richiedere che la ragione che individua
innocenze e colpe, stabilisce e ristabilisce l'eguaglianza, determina e tutela gli equilibri della
convivenza, abbia già contenuti e moventi che coincidono con quell'esperienza reale più
elementare che (almeno la psicologia qui è d'accordo) spinge l'intero corso della vita. Forse questa
è anche la grande lezione della dottrina platonica dell'eros, che, malgrado i sospetti di cui viene
fatta oggetto da parte di Levinas, è pur sempre congiunta inseparabilmente a quell'idea del «bene
al di là dell'essere» grazie alla quale è consentito non rassegnarsi a ciò che c'è e sperare che ci sia
ancora misericordia.
Note
1.
Le opere di Levinas cui faremo dettagliatamente riferimento sono le seguenti: Le temps et l'autre, PUF, Paris
1983 (Il tempo e l'altro, trad. it. di Francesco Paolo Ciglia, Il melangolo, Genova 1987); Totalité et infini. Essai
sur l'extériorité, Nijhoff, La Haye 1961 (Totalità e infinito. Saggio sull'esteriorità, trad. it. di Adriano Dell'Asta,
Jaca Book, Milano 1980); Autrement qu'être ou au-delà dell'essence, Nijhoff, La Haye 1974 (Altrimenti che
essere o al di là dell'essenza, trad. it. di Silvano Petrosino e Maria Teresa Aiello, Jaca Book, Milano 1983);
Difficile liberté, Albin Michel, Paris, 2ª ed. 1976 (Difficile libertà, trad. it. di Giancarlo Penati, La Scuola, Brescia
1986, che contiene però una minima parte del testo originale). A queste opere faremo riferimento con il solo
numero di pagina dell'originale francese e della traduzione italiana; questa tuttavia la ritoccheremo senza darne
avviso ovunque ci sembri opportuno.
2.
«La peculiare neutralità del titolo "il Dasein" è essenziale, perché l'interpretazione di questo essente va condotta
prima di ogni concrezione effettiva. Questa neutralità significa anche che il Dasein non è nessuno dei due sessi.
Ma questa asessualità non è l'indifferenza del vuoto nullo [...], ma l'originaria positività e potenza dell'essenza.
[...] Questo Dasein neutrale non è mai l'esistente; il Dasein esiste solo sempre nella sua concrezione effettiva.
[...] Il Dasein in generale nasconde l'intima possibilità per la disseminazione effettiva nella corporeità e quindi
nella sessualità» (Metaphysische Anfangsgründe der Logik im Ausgang von Leibniz, in Gesamtausgabe,
Klostermann, Frankfurt a. M., vol. 26, 2ª ed. 1990, pp. 172-3: il testo riproduce un corso del 1928, quindi
praticamente contemporaneo ad Essere e Tempo). La posizione di Heidegger non avrebbe nulla di sorprendente
se non fosse inserita all'interno di un discorso filosofico che valorizza così profondamente la dimensione
esistenziale dell'essere umano. Così, il Dasein desessualizzato rischia pericolosamente di avvicinarsi al «man»
dell'impersonale, che però significativamente mantiene estenuata la traccia della sua etimologia maschile -- alla
quale con una certa liceità il contemporaneo linguaggio femminista tedesco può contrapporre il neologismo
«frau» (frau sagt come man sagt).
3.
Così commenta Simone de Beauvoir nello stesso anno della pubblicazione delle conferenze: «Suppongo che
Levinas non dimentichi che la donna è anche di per sé coscienza. Ma è degno di nota che egli adotti
deliberatamente un punto di vista maschile senza porre in evidenza la reciprocità del soggetto e dell'oggetto.
Quando scrive che la donna è mistero, è sottinteso che ella è mistero per l'uomo. Cosicché questa descrizione che
vorrebbe essere obiettiva è in realtà una affermazione del privilegio maschile» (Le deuxième sexe, Gallimard,
Paris 1949; trad. it., Il secondo sesso, Il Saggiatore, Milano 1999, p. 29, nt. 3); il senso del «privilegio maschile»
sembra qui identificarsi con l'assumere per ovvio e obiettivo il punto di vista dell'uomo: «La donna appare
essenzialmente al maschio un essere sessuato: la donna per lui è sesso, dunque lo è in senso assoluto. La donna
si determina e si differenzia in relazione all'uomo, non l'uomo in relazione a lei; è l'inessenziale di fronte
all'essenziale. Egli è il Soggetto, l'Assoluto: lei è l'Altro» (p. 16).
4.
Che quest'ultima preoccupazione sia tutt'altro che aliena dalle intenzioni di Levinas, risulta dal fatto che egli, in
un'intervista del 1985, dichiara che ciò che rimane dell'identificazione tra alterità e femminilità nelle opere
posteriori (nello specifico Totalità e infinito) è l'idea che l'«altro» va sempre pensato non formalmente, ma nel
suo contenuto specifico («Intention, Ereignis und der Andere», in Humanismus des anderen Menschen, trad.
ted. di Ludwig Wenzler, Felix Meiner, Hamburg 1989, p. 135). Ma appunto, in una femminilità definita
sostanzialmente come alterità (tanto il «pudore» quanto il «mistero» ne costituiscono traduzioni in una
prospettiva erotica) l'esigenza di un contenuto reale sembra soltanto posta e non ancora soddisfatta. A meno che
l'«alterità» qui non significhi in realtà qualcosa di più e di diverso rispetto a ciò che Levinas stesso intende e
dice: che è ciò che tenteremo di mostrare.
5.
Che il discorso condotto presta il fianco a sospetti ancor più pesanti di vent'anni prima, è appena il caso di
notarlo. È infatti facile accusare le analisi di Levinas di solidificare stereotipi sociali perlomeno discutibili: il
sesso femminile come quello «debole», la donna come essere essenziale «sessuato» (il che significherebbe che
solo con il suo apparire sarebbe possibile qualcosa come la «voluttà»), la sua localizzazione nella «casa», e così
via. Tutto ciò potrebbe essere ancora una volta riassunto nella semplice osservazione che il discorso è condotto,
dall'inizio alla fine, da un punto di vista maschile. Il giudizio non muterebbe se volessimo prendere in
considerazione anche il saggio quasi coevo «Le judaïsme et le féminin» (in Difficile liberté, pp. 50-60), nel quale
pure Levinas, enunciando sotto forma di esegesi della tradizione ebraica molte idee che filosoficamente trovano
spazio in Totalità e infinito, protesta che si tratta di «idee più antiche dei princìpi in nome dei quali la donna
moderna lotta per la sua emancipazione, ma verità di tutti questi princìpi» (p. 57). Alle obiezioni «femministe»
contro Levinas è possibile timidamente replicare che in effetti, come noteremo, anche il maschile viene
ridefinito e ripensato a causa del riferimento al femminile. Ma la nostra opinione è che il vero valore
dell'itinerario di Levinas si mostri soltanto a partire dalla sua meta, che si trova in Altrimenti che essere.
6.
È facile sospettare un motivo per lo meno inconscio della messa tra parentesi della differenza sessuale: essa non
è un elemento specifico dell'essere umano, dal momento che lo accomuna a tutti gli animali superiori. Se il
sospetto è fondato, c'è da osservare che in questo modo viene ripetuta la stessa torsione compiuta da Aristotele
nella sua determinazione dell'uomo come animal rationale. Il pericolo di essa non consiste tanto nel pensare
l'uomo a partire dall'animalità (come ritiene Heidegger nella Lettera sull'umanismo), ma tutt'al contrario nel
non pensarla abbastanza. Ciò è eccellentemente mostrato nell'esordio dell'Etica Nicomachea, in cui proprio
movendo implicitamente da questa definizione la felicità umana viene cercata in ciò che non può essere
animale. È una strategia che da una parte permette ad Aristotele di teorizzare l'esaltante ideale
dell'athanatízein, il «comportarsi da immortali», dall'altra lo costringe però a reintrodurre per semplice
accostamento tutto il capitolo sulla philía: i fondamenti di essa sfuggono alla pura dimensione razionale e sono
ravvisati da Aristotele stesso, quasi obtorto collo, nell'amore coniugale e in quello parentale, due forme che,
analogicamente e mutatis mutandis, evidentemente si trovano anche negli altri animali.
7.
In questo modo, alla fin fine Levinas concede a Kierkegaard più credito di quanto fosse disposto a dargli
all'epoca di Totalità e infinito: «L'assolutamente Altro -- la cui alterità è superata dalla filosofia dell'immanenza
sul piano, che si pretende comune, della storia -- conserva la sua trascendenza in seno alla storia. Lo Stesso è
essenzialmente identificazione nel diverso, o storia, o sistema. Non sono io a rifiutarmi al sistema, come pensava
Kierkegaard, è l'Altro» (p. 10, it. 38). Ma Altrimenti che essere costituisce proprio il tentativo di mostrare come
anche l'Io si rifiuta «al sistema», come anche in esso si realizzi quella frattura dall'essenza che non è anzitutto
«ontologica» perché avviene prima dell'ontologia e ne rimescola le carte. In questo slittamento, che peraltro
rimane fedele alle intenzioni iniziali nel momento in cui ne sposta l'obbiettivo all'indietro, quale sia l'effettivo
debito nei confronti di Kierkegaard è difficile dirlo. Fatto sta che Levinas cita proprio questi come colui che più
di ogni altro seppe pensare l'«umiliazione di Dio», l'idea che, riformulata in termini orizzontali, sta al cuore
della sostituzione come interpretazione della soggettività in Altrimenti che essere.
8.
Il rapporto viene del resto stabilito da Levinas stesso in una breve osservazione: «La responsabilità per l'altro,
per ciò che non è cominciato in me, responsabilità nell'innocenza di un ostaggio -- la mia sostituzione ad altri è
il tropo di un senso che non si limita all'empiria dell'avvenimento psicologico, di una Einfühlung o di una
compassione che, in nome di questo senso, significano» (p. 161, it. 158 [ma con traduzione errata]). Nel
momento stesso in cui si vuole distinguere lecitamente la nozione di sostituzione dall'empatia, si dichiara
implicitamente che la seconda è condizionata dalla prima e ne costituisce per così dire il risvolto conoscitivo ed
empirico.
9.
Un'ulteriore conferma: in questa nuova prospettiva è coerente lo slittamento che subiscono le considerazioni sul
perdono. Se esso in Totalità e Infinito veniva affidato quasi come un simbolo al figlio (il figlio con la sua nascita
rappresenta una nuova storia «perdonata», cioè senza il carico del passato e della colpa che l'identificazione con
sé rende inevitabile), in Altrimenti che essere daccapo il perdono ottiene il suo posto, citato per nome, come
un'espressione della sostituzione «materna». Ciò è evidente nella dichiarazione prima citata e anche qualche
pagina oltre, quando Levinas mette in parallelo (benché in maniera non del tutto chiara) il «puro perdono» con
la «responsabilità per altri ed espiazione» (p. 161, it. 158). Queste considerazioni e altre simili rendono difficile
accettare l'interpretazione proposta da Adriaan Peperzak nella sua ottima «Introduzione ad Altrimenti che
essere», dove il senso del discorso di Levinas viene reso così: «[Il soggetto,] come una madre, porta l'altro
dentro di sé, senza fondersi con lui» (Emmanuel Levinas, Adriaan Peperzak, Etica come filosofia prima,
Guerini, Milano 1989, p. 128). È vero che Levinas stesso parla di una «gestazione dell'altro nel medesimo» (p.
135, it. 132), ma proprio per avvertire che malgrado ciò questo rapporto non è equiparabile ad un concepimento
liberamente scelto e assunto. Privilegiare questa immagine rischia dunque da una parte di aggirare il linguaggio
di Levinas nelle sue intenzioni dichiarate (passività, responsabilità), dall'altra di ridurlo, appunto, ad
un'immagine, che sfuma nella retorica il corposo richiamo ad una originaria dimensione «femminile»
dell'essere umano.
10. Formulando la questione in questi termini, è facile pensare al «principio responsabilità» di Hans Jonas.
Anch'esso viene giustificato facendo appello alle cure dei genitori per il bambino: senza di esse l'umanità non
potrebbe evidentemente sussistere. Ma ciò significa che a questa forma assolutamente elementare di
responsabilità bisogna fare appello per spiegare quelle via via più complesse e istituzionalizzate, fino a ritenere
la responsabilità stessa l'autentico principio dell'eticità. Come ulteriore e forse ancora più notevole elemento di
vicinanza può essere citato il superamento della «legge di Hume» (separazione tra dati di fatto e imperativi
morali) che per Jonas si realizza nel neonato: egli è, ma contemporaneamente significa un tu devi per i propri
genitori; è difficile non vedere qualcosa di analogo (soprattutto dopo tutto ciò che abbiamo detto dell'itinerario
di Levinas) nel comandamento «non uccidere» che per Levinas è il significato stesso del volto dell'altro. Ma
malgrado tutte le somiglianze, l'andamento del discorso di Levinas tollererebbe molto difficilmente le esatte
architetture e distinzioni di piani di Jonas, teso com'è alla ricerca di un nucleo di significato unico e originario, a
suo modo «evidente» prima di ogni teoresi.
Matteo Penati
Levinas nelle pieghe della fenomenologia
Il pensiero filosofico levinasiano nasce e si sviluppa intrecciandosi strettamente con la filosofia
fenomenologica. Intreccio fatto di continuità e di rotture. Rotture che comunque non
«frantumano» l'orizzonte fenomenologico e rotture che rompono con la fenomenologia. Proprio
questo intreccio, questo rapporto costante col pensiero di Husserl e Heidegger, questo «tenersi in
equilibrio» sul crinale della fenomenologia da parte di Levinas è oggetto delle analisi di questo
lavoro. La domanda che implicitamente lo orienta e lo guida è la seguente: può Levinas dirsi
fenomenologo?1 Lui stesso, infatti, rivendica per sé, se non la lettera, almeno lo spirito della
fenomenologia. Tenterò di articolare brevemente una risposta a questa domanda.
Se si dovesse caratterizzare con un motto quello che è stato lo scopo dichiarato della
fenomenologia, si ricorrerebbe al famoso «andare-ritornare alle cose stesse». Analizziamo
brevemente questo «slogan».
Da una parte l'«andare-ritornare» può essere inteso in due modi diversi: attivamente, ed allora si
hanno le husserliane intuizione e (ri)costituzione del dato;2 passivamente, e così si ottiene
l'esposizione levinasiana, la quale si manifesta in differenti forme etiche: ossessione, prossimità,
investitura, elezione, soggezione, anarchia... .3 Dall'altra parte, le «cose stesse» possono darsi in
due modi differenti: adeguatamente, ma questa per Husserl è una modalità esclusiva della
coscienza; in-adeguatamente, e tale in-adeguatezza, che si basa su una serie di successivi e
potenzialmente infiniti adombramenti, è la caratteristica propria dell'originario apparire degli
oggetti reali, i quali sono suscettibili di essere completati tramite «approcci» successivi, ma con
una «completezza sempre incompleta»4 ed imperfetta perché mai compiuta. Dunque, si può dire
che per la fenomenologia l'inadeguatezza caratterizza l'«altro in quanto altro», dove dire «altro in
quanto altro» significa presentare l'oggetto come identico e adeguato anche se la serie delle
successive percezioni non è -- per necessità -- completa.5 Ma è proprio l'«in quanto» -- che
caratterizza quello che Levinas definisce come Detto -- a venir criticato dal nostro Autore, poiché si
basa su di un eidos e così presuppone l'universale prima del particolare. E sussumere il particolare
nell'universale vuol dire, per Levinas, neutralizzare le differenze che fanno sì che l'altro sia altro -violentandolo. Si potrebbe notare, per inciso, che l'estraneo -- l'altro -- può essere compreso come
tale unicamente all'interno di un orizzonte di familiarità.6 Proprio perché ha qualcosa in comune
con me posso incontrarlo e scoprire cosa ci separa facendo sì che sia altro da me.7 Ma torniamo a
Levinas; egli introduce una distinzione tra quell'ente che è possibile indicare come «altro in quanto
altro» ed Autrui che è l'«assolutamente altro» -- autrui: pronome indefinito invariabile -: il primo
si situa nel campo dell'oggettualità, mentre il secondo in quello della trascendenza. In realtà
Husserl poneva, in qualche modo, anche gli oggetti sul piano della trascendenza:
Ci sono degli oggetti -- e tutti gli oggetti trascendenti, tutte le «realtà naturali» incluse sotto il
titolo di natura o di mondo rientrano in questo gruppo -- che non possono essere date, con una
determinazione integrale ed un'intuitività ugualmente integrale, in alcuna coscienza chiusa, finita.
Tuttavia il dato perfetto della cosa è presente in quanto «Idea» (in senso kantiano); questa idea
designa un sistema, assolutamente determinato ed il suo eidos, che regola lo sviluppo indefinito
d'un apparire continuo.8
Idea kantiana, quindi non attualmente posseduta. Sembrerebbe, così, che già Husserl avesse
concepito l'alterità dell'altro, ma in realtà egli ha posto l'accento sull'inadeguazione dell'oggetto
reale -- rispetto all'idea -- e non tanto sull'alterità come tale -- cioè originariamente irriducibile e
irrappresentabile.9 In questo senso Levinas parla di trascendenza immanente, in opposizione alla
quale introduce una trascendenza forte, intesa come rottura dell'orizzonte: in La signification et le
sens afferma che, per la fenomenologia, la significazione ideale implica una duplice referenza alla
totalità, alla totalità dell'oggetto colto nella sua unità e alla totalità dell'essere che rende possibile il
cogliere l'oggetto identificato in quanto identico in se stesso.10 È proprio con questa seconda
totalità che rompe la trascendenza levinasiana: Autrui non è significativo perché posto all'interno
di una rete di relazioni significative, ma perché il suo volto è autosignificanza per eccellenza -«non si situa nella luce di un altro ma si presenta da sé nella manifestazione che deve solo
annunciarlo».11 Con la rottura dell'orizzonte si passa, nelle intenzioni di Levinas, da un linguaggio
-- il Detto -- nel quale l'altro è inteso in quanto altro ad un linguaggio -- il Dire -- dove l'altro non è
più situato in alcun rapporto, fosse pure il rapporto inadeguato che caratterizza per Husserl gli
oggetti reali:
Porre fine alla coestensione ["coesistenza" nella traduzione italiana] del pensiero e della relazione
soggetto-oggetto, significa lasciare intravedere una relazione con l'altro che non sarà né
un'intollerabile limitazione di colui che pensa, né un semplice assorbimento di quest'altro in un io,
sotto forma di contenuto [di pensiero]. Là dove ogni Sinngebung [donazione di senso] era l'opera
di un io sovrano, l'altro, infatti, non poteva che essere assorbito in una rappresentazione. Ma in una
fenomenologia nella quale l'attività della rappresentazione totalizzante e totalitaria è già superata
nella sua propria intenzione, nella quale la rappresentazione si trova già posta all'interno di
orizzonti che, in qualche modo, essa non aveva voluto, ma che non tralascia -- diventa possibile una
Sinngebung etica, cioè essenzialmente rispettosa dell'Altro.12
Per questo, afferma Levinas, perché si dà un'intenzionalità che si dirige verso l'altro, ma è da questi
messa in scacco, anche nella fenomenologia è presente la nozione di rispetto: «Secondo lo stesso
Husserl, nella costituzione dell'intersoggettività, intrapresa a partire dagli atti oggettivanti,
appaiono bruscamente delle relazioni sociali, irriducibili alla costituzione oggettivante che
pretendeva di cullarle al suo ritmo».13 In realtà questo rispetto fenomenologico non è tanto
primariamente un'attitudine etica, quanto piuttosto metodologica: un «andare alle cose stesse»,
cioè a quello che le cose sono senza aggiungervi nulla -- ed in questo senso rispettarle.14 Questo
vuol dire che la Sinngebung «rispettosa» è diretta sugli oggetti e sul mondo, e non sull'altro uomo,
che viene colto tramite l'analogia, che costituisce propriamente il bersaglio di Levinas nella sua
difesa della soggettività individuale.15 Si può dire, a mio avviso, che, comunque, fino a questo
punto il nostro Autore non ha ancora fatto il passo decisivo verso una rottura con la fenomenologia.
Perciò per quanto esposto fin qui si può essere d'accordo con chi sostiene che con Levinas si ha una
«rottura della fenomenologia» e non una «rottura con la fenomenologia».16 Ma solo fino a questo
punto del percorso. Levinas però non è solo questo. Ovviamente ci sono altri aspetti del suo
pensiero che lo accomunano a Husserl,17 ma ciò che mi preme mettere in evidenza ora è il fatto
che, dalla rottura dell'orizzonte ad opera di Autrui, trae conseguenze che implicano una rottura
con la fenomenologia.
È vero che è stata la stessa fenomenologia, con l'introduzione dell'idea dell'orizzonte come
condizione della fenomenalità, a porre le basi, da un lato, per un pensiero che pensasse al di là dei
limiti e delle condizioni di visibilità dell'orizzonte e, dall'altro, per una caratterizzazione
dell'assoluta alterità come rottura dell'orizzonte. Se a questo aggiungiamo che l'altro come alter
ego ha, per Husserl, un significato proprio in quanto alter, cioè al di fuori di me, e ultimamente
distante da me, possiamo capire come Levinas, unendo questi due aspetti, concluda che l'alterità
assoluta è positivamente significativa. In realtà, per Husserl, l'altro è positivamente significativo in
quanto «alter ego», cioè per analogia. Mi spiego meglio. Per la fenomenologia l'io incontra un nonio che si rivela essere un alter ego, caratterizzabile così attraverso attributi positivi in quanto il
soggetto può ad esso applicare quei caratteri che lui stesso avrebbe «se fosse là», al posto di quello:
il «non-io» si rivela essere un «altro-io»:18 ma, appunto, altro perchè per Husserl, l'altro-io è colto
come altro, visto che non si dà adeguazione fra il me e il me visto là.19 Invece,
fenomenologicamente, non è possibile caratterizzare in modo positivo quell'altro che è «situato» al
di fuori dell'orizzonte, il quale è altro diversamente rispetto all'alter ego. Come si può descrivere o
parlare di questo «altro che è assolutamente altro», cioè al di là dell'orizzonte del soggetto? Ci sono
sostanzialmente tre possibilità. La prima è di dirne in termini positivi, basandosi sull'analogia -- di
proporzione o di attribuzione che sia -- ed è ciò che storicamente hanno fatto la metafisica classica
ed ogni sua ripresa. La seconda è di parlarne negativamente. La terza è non dirne nulla. Levinas
pretende invece di parlarne in termini positivi, ma senza prendere in considerazione l'analogia,
anzi condannandone l'utilizzo; infatti l'alterità da lui considerata è intesa come alterità assoluta nel
senso di assolta da ogni mediazione e relazione. Ma questo è possibile? Come parlare di qualcosa
che non ha assolutamente nulla in comune con me? E la sofferenza dell'altro come mi appare?
Come posso capire che egli soffre?20 Come può qualcuno che è totalmente altro da me muovermi
alla diaconia, come può coinvolgermi e mettermi in questione?21 Levinas non vuole descrivere
Autrui a partire dall'io, ma pretende di determinare il senso dell'io partendo da Autrui. Per poterlo
fare ci deve essere qualcosa che sia comune ai due. Altrimenti come potrebbe Autrui anche solo
«sfiorare» il soggetto? E allo stesso modo, come si intenderebbe un'affermazione come questa:
«"Grazie a Dio" io sono autrui per gli altri»?22 Autrui è, per Levinas, termine etico e non
ontologico, dunque, una reciprocità -- un'analogia direi -- si dà, nonostante quello che dichiara il
nostro Autore, anche al di fuori del piano dell'essere, anche al di là dell'essere. Autrui, quindi, è
inteso da Levinas come nuova alterità. Autrui negativamente «definito» come «ciò che io non
sono».23 È possibile però, per Levinas, superare l'orizzonte delle determinazioni negative e dire
dell'altro, per esempio, come del povero, del debole ... -- tutte figure che ne indicano la marginalità
all'interno del mondo. Questo assolutamente altro -- ineffabile ed inafferrabile -- si presenta,
paradossalmente, nel volto dell'altro uomo, volto che, comunque, è elemento della quotidianità -qui sta il paradosso.24 Ma il volto, appunto, è ciò che «è presente nel suo rifiuto di essere
contenuto»,25 «cifra» di un Autrui che è infinitamente trascendente ed estraneo, e sul quale non si
può assolutamente potere.26 E, afferma Levinas, «manifestarsi come volto significa imporsi
[corsivo dell'Autore] al di là della forma, manifestata e puramente fenomenica [corsivo mio],
presentarsi in un modo irriducibile alla manifestazione, [...] senza mediazione».27 Non si rischia
così di tornare ad un «surrogato» della posizione kantiana? Se il volto non appare, se esso non è un
oggetto intenzionale per l'io, se non è dato significa che non è un fenomeno. La forma del volto -- la
bocca, gli occhi... -- è il fenomeno che appare e che maschera il volto nella sua nudità. Se si fa
astrazione dalla forma -- la quale interessa alle scienze, come ad esempio all'anatomia -- si ottiene
un «resto»: la prossimità dell'Altro. Così, ciò che Levinas chiama viso non è una parte
dell'organismo -- che come tale sarebbe percepibile e rappresentabile -; è qualcosa che va oltre ogni
capacità intellettuale del soggetto. Si capisce come il volto non faccia originariamente parte del
«mondo proprio» del soggetto, se per «mondo proprio» si intende o la totalità degli oggetti in
riferimento al soggetto stesso, o l'orizzonte all'interno del quale si manifestano i fenomeni. Ciò che
il volto fa è precisamente il portare scompiglio in questo ordine mondano.28 Levinas parla a
questo proposito di enigma29 in contrapposizione al fenomeno30 -- e tuttavia senza nesso col
fenomeno come si darebbero lo scompiglio e l'enigma? -. Fenomeno è l'oggetto che ha un
significato in base ad un contesto ed al legame che lo riferisce a ciò che esso non è:31 con l'idea
dell'orizzonte la fenomenologia determina la significazione essenzialmente come referenziale.32
Enigma indica sia un «modo di manifestarsi senza manifestarsi», per semplice accenno,
ritraendosi subito dall'ambito fenomenologico dopo averlo scompigliato -- «scompiglio assoluto»
indica il fatto possibile in cui l'alterità trascendente irrompe nell'Identico senza essere da questo
ricompressa nel suo ordine: il volto significa da sé -- sia un modo di significare che può essere
riconosciuto solo «se si vuole», liberamente, dato che non si impone con la propria presenza
disvelata, ma «mantenendo l'incognito».33 Se è così, l'epifania del volto come visitazione significa
in modo stra-ordinario, come comando -- «non uccidere» -- che s'impone alla coscienza
capovolgendone l'intenzionalità in responsabilità. Il volto significa positivamente come appello alla
responsabilità, in termini etici, muovendo l'io alla diaconia -- che poi è ciò che definisce il soggetto
stesso. Fuori dal piano fenomenologico c'è l'enigmatico, che si sottrae al logos kerygmatico -- cioè
all'intenzionalità tematizzante enunciante ed annunciante. Mentre l'esperienza di un dato
fenomenologico tende a chiarificarsi e a completarsi tramite successive appercezioni, l'enigma si
sottrae nel momento stesso in cui si offre allo sguardo: si sottrae mentre si dona.34 Questo perché
se Autrui è altro di un'alterità radicalmente altra, allora essendo l'io presente -- per definizione -,
quello non può che essere assente. Da un lato, dunque, il fenomeno che si mostra nella sua
luminosità alla ragione, dall'altro l'enigma che si sottrae ad essa e che significa pur senza farsi
significato oggettivamente tematizzato sul piano fenomenico dell'essere: cosa può rappresentare
tutto questo se non una critica all'idea stessa di fenomeno?
Mi chiedevo se non si fosse sul punto di tornare ad una posizione kantiana -- con tutte le aporie di
Kant: da un lato il fenomeno come ciò che è conoscibile, dall'altro il noumeno come ciò che è
solamente pensabile, dove il pensare resta sul piano della mera idealità, ed il conoscere coniuga
l'idea con l'intuizione -- cioè con l'esperienza.35 L'enigma mi sembra, in fondo, essere una sorta di
noumeno.36 E perché abbia un fondamento più solido quello che dico, ricordo che, in Liberté et
commandement,37 Levinas parlava di una «fenomenologia del noumeno».38 Ma questa è una
contraddizione! Come si può fare una fenomenologia di ciò che si può solo pensare? Si ricordi che il
volto è il «concretizzarsi» dell'idea dell'infinito, ovvero di quell'idea che caratterizza quel pensiero
che pensa -- e non che conosce -- più di quanto possa pensare. Ed infatti, ad un certo punto il
nostro Autore abbandona la descrizione fenomenologica, per utilizzare termini etici. E se il
fondamento non è colto su base fenomenologica, non si capisce come potrebbe derivarne una
fenomenologia.
Si può ultimamente dire che Levinas percorre la strada che unisce l'io e l'altro in entrambi i sensi di
marcia: dall'io all'altro, seguendo la strada della fenomenologia; ma allorché determinerà l'alterità
di Autrui in termini etici e positivi, inizierà la via di ritorno all'io -- che porterà ad una soggettività
umana avente il senso ultimo nel suo «dissolversi» per l'altro -- seguendo un percorso che non è
più definibile fenomenologico, in quanto l'al di là dell'essere, fondamento di ogni senso e infine
dell'essere stesso, non è più colto e coglibile in termini fenomenologici.
In un certo senso Levinas ha compiuto lo stesso tentativo di Heidegger, quello di «saltare» e
superare la metafisica contemporanea. Ma mentre per far ciò il suo «maestro» è tornato alla radice
greca dell'Occidente, il nostro Autore ha attinto soprattutto a quella ebraica, che inevitabilmente
doveva condurlo ad una rottura con la fenomenologia.39
Note
1.
Cito qui di seguito i lavori dedicati a questo tema generale o più specificatamente al problema dei rapporti tra
Levinas e Husserl o Levinas e Heidegger. In lingua italiana. Saggi: F. P. Ciglia, «Emmanuel Levinas interprete di
Husserl e di Heidegger nel primo decennio della sua speculazione», Filosofia, 1983, n. 34, pp. 113-127; F.
Guerriera Brezzi, «Pensare altrimenti la differenza: Levinas e Heidegger», Aquinas, 1983, n. 26, pp. 459-483; la
raccolta a cura di P. A. Rovatti, Intorno a Levinas, Milano 1987. Libri: F. Camera, L'ermeneutica tra Heidegger
e Levinas, Brescia 2001; I. Poma, Le eresie della fenomenologia, Napoli 1996; G. Sansonetti, Levinas e
Heidegger, Brescia 1998. In lingua francese. Saggi: F. Aubay, «Conscience, immanence et non-présence: E.
Levinas, lecteur de Husserl», Alter, 1993, n. 1, pp. 283-318; R. Bernet, «Deux interprétations de la vulnérabilité
de la peau (Husserl et Levinas)», Revue Philosophique de Louvain, 1997, n. 95, pp. 437-455; J. Colette, «Levinas
et la phénoménologie husserlienne», Les Cahiers de la Nuit Surveillée, 1984, n. 3, pp. 19-36; J. Colléony,
«Heidegger et Levinas: la question du Dasein», Les Etudes Philosophiques, 1990, n. 4, pp. 313-331; J. de Greef,
«Levinas et la phénoménologie», Revue de Métaphysique et de Morale, 1971, n. 76. pp. 448-465; J. -L. Lannoy,
«"Il y a" et phénoménologie dans la pensée du jeune Emmanuel Levinas», Revue Philosophique de Louvain,
1990, n. 88, pp. 369-394; A. Münster, «L'autre dans la phénoménologie de Husserl chez Sartre et chez
Emmanuel Levinas, ou de l'alter ego vers le désir d'autrui» (in A. Münster, La différence comme nonindifférence. Ethique et altérité chez Emmanuel Levinas, Paris 1995, pp. 49-68) G. Petitdemange, «L'un ou
l'autre. La querelle de l'ontologie: Heidegger-Levinas» (in J. Rolland (co.), Emmanuel Levinas, Paris 1984, pp.
37-49); S. Strasser, «Antiphénoménologie et phénoménologie dans la philosophie d'Emmanuel Levinas», Revue
Philosophique de Louvain, 1977, n. 75, pp. 101-124. Libri: Y. Murakami, Levinas phénoménologue, Grenoble
2002. In lingua inglese. Articoli: S. Benso, «Of Things face-to-face with Levinas face-to-face with Heidegger»,
Philosophy Today, 1996, n. 40, pp. 132-141); L. Bouckaert, «Ontology and Ethics: Reflections on Levinas'
Critique of Heidegger», International Philosophy Quaterly, 1970, n. 10, pp. 402-019; R. A. Cohen, «Levinas,
Rosenzweig, and the phenomenologies of Husserl and Heidegger», Philosophy Today, 1988, n. 32, pp. 165-178;
S. Gans, «Ethics or ontology: Levinas and Heidegger», Philosophy Today, 1972, n. 16, pp. 117-121: C. D. Keyes,
«An evaluation of Levinas's Critique of Heidegger», Research in Phenomenology, 1972, n. 11, pp. 121-142; A.
Peperzak, «Phenomenology -- Ontology -- Metaphysics: Levinas' Perspective on Husserl and Heidegger», Man
and World, 1983, n. 16, pp. 113-127. Tra tutti questi lavori, però, sono pochi quelli che rispondono alla domanda
che ci siamo posti.
2.
Così si esprime J. de Greef riguardo l'intuizione: «Ora l'intuizione è [...] interamente linguaggio proclamatorio
che nomina l'identità dell'oggetto pretendendo come unica [nel senso di unitaria] la molteplicità delle
prospettive» («Levinas et la phénoménologie», cit. nota 1, p. 455). E sulla costituzione del dato: «Il pensiero
fenomenologico preferisce la coscienza teoretica ricostituente il dato» (ibidem, p. 451).
3.
Sono questi per J. de Greef i «termini che esprimono questa passività, passività di una coscienza che non è
origine, che non è sujet de, ma sujet à» (ibidem, p. 462 n. 1).
4.
Ibidem, p. 451.
5.
Dire «questa è una casa» significa affermare che l'ente «X» che ho di fronte ha tutte le caratteristiche essenziali
per essere definito come una «casa», pur senza che io l'abbia analizzato completamente ed in ogni suo dettaglio.
Il problema sarà quello di individuare quali e quante siano «tutte» quelle caratteristiche che un oggetto deve
avere per poter essere determinato come appartenente ad una certa categoria di enti, ma questo problema esula
dal presente lavoro.
6.
Per una più approfondita analisi in questa direzione si veda A. Fabris, Paradossi del senso. Questioni di
filosofia, Brescia 2002, in particolar modo le pp. 25-28 dedicate al «nesso costitutivo di "estraneo" e
"familiare"».
7.
Essere nella differenza non è essere nella distanza, nell'impossibilità della comunicazione? Se la differenza è
assoluta sì. Ad esempio: la sofferenza, come posso vederla sul volto di Autrui se prima non l'ho provata io stesso
e proprio per questo so nominarla? Devo averla provata, qualsiasi sia stata la sua intensità; solo così posso poi
declinarne l'intensità tramite una rielaborazione mentale. Infatti, la differenza può essere solo differenza di
qualcosa che è comune. L'estraneo, il diverso, può essere compreso come tale solo ed unicamente entro un
orizzonte di familiarità. Ed in questo orizzonte è compreso come tale: in quanto estraneo può, cioè, esercitare la
propria potenzialità dirompente nei confronti delle abitudini e delle attese che contraddistinguono la sfera del
familiare, e dunque modificarla profondamente, riconfermando o deludendo particolari aspettative. Questo vuol
dire, addirittura, che, se l'estraneo è comprensibile come tale solo a partire da un orizzonte di familiarità, sul
quale tuttavia è in grado di incidere per trasformarlo, allora lo stesso elemento familiare non può mai essere
considerato pienamente tale, poiché mantiene una «riserva di estraneità» che permette di guardarlo con occhi
di volta in volta nuovi. Tuttavia questa alterità risulta sempre inserita all'interno di quella familiarità previa
che mi consente di comprendere che l'estraneo è estraneo.
8.
E. Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, I, «Jahrbuch», I,
1913, pp. 350-351.
9.
Si veda quanto dice J. de Greef, «Levinas et la phénoménologie», cit. nota 1, p. 460.
10. «La signification et le sens» (in Revue de Métaphysique et de Morale, 1964, n. 69, pp. 125-156) p. 129.
11. «La trace de l'autre», pubblicato in Tijdschrift voor Filosofie, 1963, n. 25, pp. 605-623; raccolto poi in En
découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger (EDE), Vrin, Paris 1967, 187-202; trad. ital. Scoprire
l'esistenza con Husserl e Heidegger, a cura di F. Sossi, Raffaello Cortina, Milano 1998. Ho citato dalle pp. 226229. Si veda F. Salvarezza, Emmanuel Levinas, cit. nota 1, pp. 119-121.
12. La ruine de la représentation, EDE, p. 135 dell'edizione francese.
13. Ibidem, è la continuazione del passo precedente, e la conclusione dell'articolo.
14. Si veda J. de Greef, Levinas et la phénoménologie, cit. nota 1, pp. 461-463.
15. In realtà Levinas fraintende l'analogia. Ora, questa si delinea secondo due possibili direzioni: una onticaorizzontale ed una metafisica-verticale. La prima è l'analogia di proporzionalità, nella quale ad essere
importante è la somiglianza fra i modi d'essere e non fra i soggetti di questi modi. Ma dove si situa la condizione
di possibilità di un confronto tra proporzioni? A ben vedere, se fra i soggetti delle proporzioni non vi fosse una
parentela ontologica i loro modi d'essere sarebbero incomparabili, ed il quarto termine resterebbe un'assoluta
incognita. Si situa a questo punto il passaggio dall'uso costitutivo delle proporzioni al loro uso regolativo. Nel
primo caso si raggiunge con esattezza alla conoscenza dell'incognita. Nel secondo si ha solo una regola per
cercare il quarto termine: all'esattezza si sostituisce l'approssimazione, campo dell'ermeneutica, la quale non
costituisce una comprensione definitiva e piena dell'altro. Levinas fraintende dunque l'analogia, riducendone
ogni modalità a quella di proporzionalità. Ma se si presta attenzione si può vedere come anche da questo lato si
dà solo somiglianza e non piena adeguazione: dire che «l'apprensione intellettuale è una visione dell'oggetto»
non è come affermare che «6: 3 = 4: 2». Si deve dunque ammettere che si danno due tipi di proporzionalità:
quella analogica e quella matematica. Levinas, nella sua critica, sembra ricondurre ogni analogia -- unione di
identità e di differenza -- alla proporzionalità matematica. In realtà l'analogia, in quanto tale, ha come uno dei
suoi fronti un altro -- campo ontico -- e tutt'altro -- piano metafisico -: l'analogia, quindi, mantiene e
«salvaguarda» le differenze. A ben vedere, lo stesso Husserl non usa il termine «analogia», anzi rifiuta
recisamente un «ragionamento per analogia» -- si veda, come esempio, questo passo tratto dalle Cartesianische
meditationen (Kluwer Academic Publisher B. V. 1950; trad. it. Di F. Costa, Meditazioni cartesiane, Milano
1997): «È chiaro [...] che solo una somiglianza [corsivo mio], interna alla mia sfera di primordialità, tra quel
corpo e il mio può fare del primo un altro [corsivo dell'Autore] corpo. Vi sarebbe quindi una certa appercezione
di somiglianza [corsivo mio] ma non mai, in ogni caso, un ragionamento per analogia» (p. 131 dell'edizione
italiana). È comunque chiaro che questo fatto deriva dai precedenti matematici di Husserl, il quale, così come
Levinas, considera l'analogia solo nella sua accezione di analogia di proporzionalità. Ed è questa l'analogia che
rifiuta.
16. È di questo parere F. Oggero che, in Levinas: lo sfondamento etico della fenomenologia e la testimonianza etica
(in I. Poma, Le eresie della fenomenologia, cit. nota 1), scrive: «Con Levinas siamo [...] alla "rottura della
fenomenologia". Si tratta di una krisis o di un'eresia della fenomenologia che intende superare definitivamente
il primato della coscienza fenomenologica. E tuttavia non si tratta in Levinas di una rottura con la
fenomenologia. Ciò dipende dal fatto che la rottura del soggetto, ossia della coscienza che attraverso il sapere si
fa inizio e fine del senso, si pone nella forma della rottura etica. Se da un lato questa non concede al soggetto
fenomenologico alcun escamotage teoretico, che gli consenta di coniugare ancora in qualche modo la propria
identità e il proprio farsi secondo al senso dell'Altro, dall'altro essa non gli impone nemmeno una non-identità
risultante dal suo soggiogarsi, ancora teoreticamente, a un senso de-soggettivante. La rottura etica dischiude,
infatti, un senso assolutamente soggettivante. In altre parole: la rottura del soggetto non impone al soggetto di
rompere con se stesso, ma solo di rompere la propria auto-soggettivazione teoretica, per aprirsi alla
soggettivazione etica ad opera dell'assolutamente Altro» (p. 70).
17. Si veda S. Strasser, Antiphénoménologie et phénoménologie dans la philosophie d'Emmanuel Levinas, cit. nota
1, pp. 118-124, nelle quali, dopo essersi chiesto come mai tanti hanno la ferma convinzione che il pensiero
levinasiano è, malgrado tutto, fenomenologico, elenca le somiglianze tra quello ed il pensiero husserliano. Ne
ricordo solo alcune: entrambe sono filosofie del soggetto; per tutte e due il tempo svolge un ruolo significativo;
Levinas ha una cura per la ricerca delle origini nascoste di tutto ciò che si mostra, che è tipicamente
fenomenologica; entrambi i pensieri sono caratterizzati da un radicalismo inesorabile contro il senso comune.
Sarà forse dovuto a questo elenco, posto alla fine del suo articolo, il fatto che Strasser termini dicendo che «in
fondo possiamo legittimamente concludere che l'impressione di tanti che considerano Levinas un
fenomenologo, non è un azzardo. La sua filosofia presenta, effettivamente, alcuni tratti, sia positivi che negativi,
che caratterizzano i pensatori fenomenologici. Essa è una fenomenologia, ma una fenomenologia di un nuovo
genere. Forse bisognerebbe precisare questa conclusione: Levinas ha cambiato l'ottica fenomenologica
aggiungendovi una dimensione di profondità.» Questo nonostante in apertura avesse affermato: «Io sono
convinto che la filosofia di Levinas differisce essenzialmente da tutti quelli che sono conosciuti come
fenomenologhi» (p. 101). Ma una nuova fenomenologia come quella levinasiana è ancora, essenzialmente,
fenomenologia?
18. Si veda la V delle Cartesianische Meditationen, cit. nota 15.
19. Mentre nell'autoriflessione tra l'intenzionalità e l'intenzionato si dà adeguazione, non così avviene se
l'intenzione mira all'altro-io posto là.
20. Infatti, se vedo la sofferenza di Autrui, significa che egli è un fenomeno, ma Levinas dice proprio che Autrui -- e,
quindi, anche Autrui sofferente -- non è un fenomeno.
21. La filosofia inizia con la meraviglia, dicevano gli antichi. E la meraviglia è l'altro che mi «smuove», mi stimola.
Ma questo significa che l'altro fa presa su di me, ma per poterlo fare dobbiamo avere qualcosa in comune che
permetta il contatto. Ho detto «l'altro fa presa su di me»: io sono passivo come dice Levinas. Il totalmente altro
o non lo colgo o se lo colgo è perché si declina in forme che mi competono: ad esempio, Dio si comunica
attraverso la Parola e l'Incarnazione.
22. Autrement qu'être ou au-delà de l'essence, Martinus Nijhoff, La Haye 1974; traduzione italiana Altrimenti che
essere o al di là dell'essenza, a cura di S. Petrosino e M. T. Aiello, Jaca Book, Milano 1983. Ho citato da p. 198
dell'edizione francese.
23. Ibidem, p. 182.
24. Su questo tema si veda F. P. Ciglia, Un passo fuori dall'uomo, Padova 1988, pp. 180-207.
25. Totalité et Infini. Essai sur l'extériorité, La Haye 1961; traduzione italiana Totalità e Infinito. Saggio
sull'esteriorità, a cura di A. Dall'Asta, Jaca Book, Milano 1980. Ho citato da p. 199 dell'edizione francese.
26. Neppure uccidendo l'altro io ho potere su di lui, o meglio ho potere solo sulla sua parte sensibile, corporea; ma il
volto fa a pezzi il sensibile, mettendo in scacco ogni tentativo di omicidio. Io posso annientarlo, ma il suo «no»
rimane (ibidem, pp. 203-206).
27. Ibidem, p. 205.
28. Si veda S. Strasser, Antiphénoménologie et phénoménologie dans la philosophie d'Emmanuel Levinas, cit. nota
1, pp. 109-110.
29. In Greco «detto oscuro» o «allusivo».
30. Si veda «Énigme et phénomène», pubblicato in Esprit, 1965, n. 33, pp. 1128-1142 e successivamente raccolto in
En découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger, cit. nota 11, pp. 203-216.
31. Si ricordi quanto dice Hegel: «Sotto un unico e medesimo riguardo, l'oggetto è piuttosto il contrario di se stesso:
è per sé in quanto è per altro. Ed è per altro in quanto è per sé» (Phänomenologie des Geistes, Sämtliche Werke,
Stuttgart 1927; traduzione italiana di De Negri, Fenomenologia dello spirito, Firenze 1960, I, p. 104).
32. Si veda J. de Greef, Levinas et la phénoménologie, cit nota 1, p. 463.
33. EDE, cit. nota 11, pp. 241-242. Si veda anche G. Ferretti, La filosofia di Levinas, Torino 1996, pp. 171-189 e, più
sotto, la nota seguente.
34. S. Strasser in Antiphénoménologie et phénoménologie dans la philosophie d'Emmanuel Levinas, cit. nota 1,
esemplifica in questo modo: «Poc'anzi ho sentito la prossimità dell'Altro; ma ora la esamino. Noto il colore dei
suoi capelli, il timbro della sua voce, il carattere dei suoi movimenti. Tutto ciò lo vedo, lo tematizzo, ne posso
parlare. Allora, in fondo, cosa ho fatto? Ho esaminato la traccia dell'Altro [corsivo dell'Autore]. Ma la traccia è
un vuoto, una mancanza, un'assenza; mi rinvia a qualcosa (o qualcuno) che è definitivamente, irrevocabilmente
passato. Io mi domando se l'Altro è stato veramente presente "dentro" tutti questi dati, grazie a tutti questi dati
che io ho appena notato. Lo posso credere, ma non sono obbligato a credervi. Vi è la questione di una decisione
piuttosto che di un'evidenza costringente. L'enigma si tiene nel chiaro-scuro; è dunque il contrario del
fenomeno che, sotto il sole della ragione, deve trasformarsi in un'evidenza perfettamente intelligibile [corsivo
mio] (pp. 111-112).
35. Su Kant si veda V. Melchiorre, Analogia e analisi trascendentale. Linee per una nuova lettura di Kant, Milano
1991, pp. 70-71.
36. Proprio per questo, a mio avviso, pur essendo giusto quanto dice F. Salvarezza nel suo libro Emmanuel Levinas,
cit. nota 1, riprendendo Derrida, non vale la conclusione a cui giunge: «Pensare con rigore la Ur-impression
husserliana vuol dire per Levinas questo: pensare la coscienza al suo livello fondamentale, come apertura
all'altro in quanto ospitalità; ed è questa verità ferrea, che Derrida definisce "legge implacabile", a guidare ogni
atto di apertura tematizzante, rendendolo anzitutto possibile. L'identità infatti è fin da subito ospitalità,
l'essenza della coscienza è anzitutto una de-situazione del soggetto, una destituzione di sé. Prima ancora di
essere apertura di sapere e misura di com-prensione, è un'interruzione di sé, un malgrado sé nell'urgenza di
una destituzione che porta all'altro. "Ecco una mutazione, un salto, un'eterogeneità radicale ma discreta e
paradossale che l'etica dell'ospitalità introduce nella fenomenologia". Levinas, si potrebbe dire, ha cambiato
l'ottica fenomenologica aggiungendovi una dimensione di «profondità»: in questo senso egli è e resta
fenomenologo, fosse pure per il rigore con cui si è spinto per consumare a fondo le aporetiche difficoltà in cui
Husserl si era imbattuto» (p. 139). Fin qui è vero che Levinas è fenomenologo, ma non lo è più allorché parla
dell'assolutamente altro come di un enigma-noumeno determinandolo in termini positivi -- e non puramente
negativi come, ad esempio, «vuoto», «mancanza», «assenza». E, se l'assolutamente altro è il senso ed il
fondamento della soggettività stessa, come può la sua filosofia essere una fenomenologia? Non metto in dubbio
che sia iniziata come tale, ma ad un certo punto Levinas si è spinto oltre, uscendo dalla fenomenologia.
37. Pubblicato in Revue de Métaphysique et de Morale, 1953, n. 58, pp. 264-272. Ora in Liberté et commandement,
Paris 1994, pp. 27-48; traduzione italiana in E. Levinas -- A. Peperzak, Etica come filosofia prima, Milano 1989.
38. «Liberté et commandement», Revue de Métaphysique et de Morale, cit. nota precedente, p. 270.
39. Con questo non voglio affermare che egli non si rifaccia agli antichi Greci: Aristotele, Plotino e soprattutto il
Platone dell'Idea di Bene ritornano più volte all'interno dei suoi scritti. Ma se si presta attenzione si vedrà come,
per Levinas, pure la Somma Idea platonica sia insufficiente: il Bene è infatti strettamente legato al Sole -- e
quindi alla luce -- e poi, è pur vero che non è un'eidos come invece lo sono le altre idea platoniche, e pur tuttavia
risulta essere un'idea: idea somma, ma pur sempre idea e, dunque, dal puntto di vista levinasiano possibile
vittima dell'analogia. L'innominabile Dio ebreo, di contro, non può che porsi al di là dell'essere e del non-essere,
al di là della loro dialettica. Dialettica che, cifra della metafisica tradizionale, è presente nello stesso Heidegger.
E proprio questa visione di Dio rompe con l'analogia: Dio come il totalmente, l'assolutamente altro, a tal punto
che perfino la Rivelazione è prima di tutto «discorso di Dio» più che «discorso su Dio»: Dio lo si può ascoltare,
ma non descrivere a partire dal soggetto, dal Me che è di fronte all'Egli. Non se ne può neppure pronunciare il
Nome: Dio come pronome, dice Levinas. Tutto questo non ci porta a dire di un divorzio, nel pensiero del filosofo
francese, tra filosofia e religione. Anzi. Per Lèvinas etica e religione sono strettamente unite, di più: identificate.
Infatti, se Dio si mostra nella traccia, l'uomo per andargli incontro non deve fare oggetto di analisi questa traccia
-- che, non essendo segno, non è neppure oggettivabile --, ma avvicinarsi ad essa, dunque al volto -- etica, ma
pure religione come rapporto tra essente ed essente. Ancora, Levinas sostiene che il primo Dire -- Dire come
esposizione: etica -- «è certo solo una parola. Ma è Dio» -- religione, quindi (Langage et proximité, in En
decouvrant l'existence avec Husserl et Heidegger, Paris 1967; trad. it. Scoprire l'esistenza con Husserl e
Heidegger, a cura di F. Sossi, Raffaello Cortina, Milano 1998, pp. 275-276). Non vale, infatti, per Levinas, la
differenza pascaliana tra il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe ed il dio dei filosofi.
Giovanni Ferretti
Dal sacro al santo. La trascendenza teologica non
violenta in Emmanuel Levinas
1. Dal sacro al santo
La trascendenza non è un tema marginale nel pensiero di Levinas. A ben vedere, infatti, l'interesse primario
di Levinas non è l'etica ma proprio la «trascendenza». E ciò, nonostante il successo della famosa formula
«l'etica è la filosofia prima», con cui è stato sintetizzato il suo pensiero. 1 Successo peraltro giustificato,
perché, a suo avviso, l'unico luogo possibile della trascendenza è appunto l'etica. La seguente citazione dice,
con grande chiarezza, entrambe le cose.
È la significazione dell'oltre, della trascendenza e non l'etica che il nostro studio ricerca. Esso la trova
nell'etica.2
È peraltro opportuno leggere anche il seguito della citazione:
Significazione, perché l'etica si struttura come l'uno-per-l'altro; significazione dell'al di là dell'essere, poiché
al di fuori di ogni finalità in una responsabilità che sempre si accresce -- dis-interessamento in cui l'essere si
disfa del suo essere (Ibid.).
Il tenore di questo testo ci permette fin d'ora d'osservare che della trascendenza a Levinas non interessa tanto
dare una prova o una dimostrazione razionale, peraltro giudicata impossibile e controproducente, quanto di
farne emergere la «significazione»: cioè il modo di darsi o anche di «prodursi», secondo la valenza che a
questo termine egli dà fin da Totalità e Infinito3 per indicare sia l'attuarsi sia l'esporsi, rivelarsi; potremmo
anche dire: il suo particolarissimo modo di fenomenizzarsi.
Le forme di trascendenza che gli stanno particolarmente a cuore sono due: quella del «volto d'Altri», cioè
dell'altro uomo, e quella della «soggettività responsabile», cioè di me medesimo, in prima persona. Entrambe
sono però da lui intese ed indagate come voci enigmatiche o «tracce» della trascendenza dell'Infinito, di Dio,
l'assolutamente trascendente perché «al di qua» e «al di là» della trascendenza umana, quella del volto come
quella del soggetto responsabile. La cadenza di fondo della filosofia di Levinas è quindi non solo la
trascendenza umana, ma la trascendenza teologica, significazione ultima della trascendenza umana stessa.
Questa, infatti, per un verso è come il «tempio o teatro» (DVI, p. 93), in cui Dio può «prodursi», e per altro
verso da Dio è sorretta e giustificata nella sua caratteristica di soggetto creato «separato» o autonomo.
L'itinerario della ricerca di Levinas circa la significazione della trascendenza teologica, può, in prima
approssimazione, ben sintetizzarsi nella formula «dal sacro al santo», da lui utilizzata come titolo della
raccolta di cinque nuove letture del Talmud pubblicata nel 1977.4 Le varie forme sacrali della trascendenza
(come ad es. quella descritta da R. Otto in Il sacro, del 1917, ove il sacro è presentato come il numinoso
irrazionale in cui convergono il tremendum e il fascinans)5 implicano una relazione con Dio intesa in termini
di «partecipazione» totalizzante, che spersonalizza e paralizza il soggetto umano, e in questo senso gli fa
«violenza».6 Così avverrebbe nelle religioni «mitiche», o del «sacro», descritte da Levy Bruhl nei suoi studi
sulla religiosità primitiva,7 ma anche nella più diffusa pratica religiosa e nelle stesse correnti misticheggianti
della religiosità ebraica, da cui Levinas prende ripetutamente le distanze preferendo, nell'ebraismo, quella
corrente spirituale che si nutre soprattutto dello studio dei testi biblico-talmudici.8
In uno dei primi saggi della raccolta Difficile liberté, dal titolo Une religion d'adultes, risalente al 1957,9 egli
già chiaramente prospetta il passaggio dal «sacro» al «santo» come l'ideale dell'ebraismo e quindi anche lo
scopo dell'educazione religiosa ebraica.
Per l'ebraismo, il fine dell'educazione consiste nell'instaurare un rapporto tra l'uomo e la santità di Dio e nel
mantenere l'uomo in questo rapporto. Ma tutto il suo impegno [...] consiste nel comprendere questa santità
di Dio in un senso che la rompe col significato numinoso di questo termine, quale appare nelle religioni
primitive ove i moderni hanno spesso voluto vedere la fonte di ogni religione. Per questi pensatori, il
possesso dell'uomo da parte di Dio, l'entusiasmo, sarebbe la conseguenza della santità o del carattere sacro di
Dio, l'alfa e l'omega della vita spirituale. L'ebraismo ha disincantato il mondo, l'ha rotta con questa pretesa
evoluzione delle religioni a partire dall'entusiasmo e dal sacro. L'ebraismo resta estraneo ad ogni ritorno
offensivo di queste forme di elevazione umana. Esso le denuncia come l'essenza dell'idolatria.
Il numinoso o il sacro avvolge e trasporta l'uomo al-di-là dei suoi poteri e dei suoi voleri. Ma una vera libertà
è lesa da questi surplus incontrollabili. Il numinoso annulla i rapporti tra le persone facendo partecipare gli
esseri, sia pur nell'estasi, ad un dramma che non hanno voluto, ad un ordine in cui si sprofondano. Questa
potenza, in qualche modo sacramentale del divino, appare all'ebraismo come offensiva della libertà umana e
come contraria all'educazione dell'uomo, che resta azione su di un essere libero. Non che la libertà sia un fine
in sé. Ma essa resta la condizione di ogni valore che l'uomo possa raggiungere. Il sacro che mi avvolge e mi
trasporta è violenza (DL, pp. 31-32; tr. it. cit., pp. 30-31).
E Levinas rileva la vicinanza di questo ebraismo con l'Occidente, ossia con la filosofia, parimenti gelosa
dell'indipendenza umana; fino a rischiare l'ateismo, pur di superare questo concetto numinoso del sacro.
È grande gloria per il creatore aver eretto sui suoi piedi un essere che l'afferma dopo averlo contestato e
negato nelle suggestioni del mito o dell'entusiasmo; è grande gloria per Dio aver creato un essere capace di
cercarlo o di ascoltarlo da lontano, a partire dalla separazione, dall'ateismo. [...] Il monoteismo sorpassa e
ingloba l'ateismo, ma è impossibile a chi non ha raggiunto l'età del dubbio, della solitudine e della rivolta
(DL, p. 34; tr. it. cit., p. 32).
La critica alla concezione sacrale di Dio in nome dell'autonomia del soggetto umano, è quindi spinta da
Levinas fino ad usare provocatoriamente il termine di «ateo» per designare e rivendicare la consistenza
propria dell'essere separato dell'io e si concretizza nel contrapporre alla «violenza» spersonalizzante del
sacro quella relazione del finito con l'infinito che egli chiama «relazione metafisica»,10 sottolineando che la
paradossalità di tale relazione consiste nel fatto -- difeso con vigore nella sua originalità, soprattutto contro
Hegel -- che in essa i termini, pur entrando in relazione, si sciolgono dalla relazione, mantenendo così la loro
autonoma consistenza. Il che salvaguardia la trascendenza assoluta di Dio ma anche l'autonomia e la libertà
dell'umano, la sua «separatezza».
Si può chiamare ateismo questa separazione talmente completa che l'essere separato si mantiene
assolutamente solo nell'esistenza, senza partecipare all'Essere dal quale è separato. [...] Si vive al di fuori di
Dio, a casa propria, si è io, egoismo (TI, pp. 56-57).
La relazione metafisica è l'alba di un'umanità senza miti. Ma la fede epurata dai miti, la fede monoteistica,
presuppone, a sua volta, l'ateismo metafisico (TI, p. 75). Porsi di fronte all'assoluto da atei, significa
accogliere l'assoluto epurato dalla violenza del sacro (TI, p. 75).
Ma vale la pena di leggere più compiutamente questo testo di Totalità e infinito, ricchissimo per il nostro
tema, ove è bene caratterizzato il senso della purificazione della trascendenza divina dalla «violenza del
sacro» in nome della sua «santità».
Nella dimensione di maestosità in cui si presenta la sua santità -- cioè la sua separazione -- l'infinito non
brucia gli occhi che si fissano su di lui. Parla, non ha il formato mitico che non sarebbe possibile affrontare e
che terrebbe prigioniero l'io nelle sue reti invisibili. Non è numinoso: l'io che l'avvicina non è né annientato
dal suo contatto, né trasportato fuori di sé, ma resta separato e mantiene le distanze. Solo un essere ateo può
porsi di fronte all'altro e subito assolversi da questa relazione. La trascendenza si distingue da un'unione con
il trascendente, per partecipazione. [...] L'idea dell'infinito, la relazione metafisica è l'alba di un'umanità
senza miti. [...]
Porre il trascendente come straniero e povero significa impedire alla relazione metafisica con Dio di attuarsi
nell'ignoranza degli uomini e delle cose. [...] La sua epifania consiste nel sollecitarci attraverso la sua miseria
nel volto dello straniero, della vedova, dell'orfano. [...]
Non può esserci alcuna «conoscenza» di Dio a prescindere dalla relazione con gli uomini. Altri è proprio il
luogo della verità metafisica, indispensabile al mio rapporto con Dio. Non ha affatto il ruolo del mediatore.
Altri non è l'incarnazione di Dio, ma appunto attraverso il suo volto, nel quale è disincarnato, la
manifestazione della maestosità nella quale Dio si rivela. [...] La relazione etica si definisce, a differenza di
qualsiasi relazione con il sacro, escludendo tutti quei significati che essa prenderebbe all'insaputa di chi la
mette in atto. [...] Tutto ciò che non può essere ricondotto ad una relazione interumana rappresenta non la
forma superiore ma una forma più che mai primitiva della religione (TI, pp. 75-77, con corr. alla tr.).
Passare «dal sacro al santo» significa, quindi, cercare d'intendere Dio non più sullo sfondo di una realtà
numinosa che comprime e spersonalizza l'uomo con la sua potenza, che gli fa violenza, bensì sullo sfondo
delle relazioni etiche interpersonali, in termini «etici», ossia ad un tempo come l'assolutamente altro,
separato, «santo» -- secondo il significato ebraico primario di santità come separatezza -- ma anche come il
Bene assoluto, all'origine della bontà delle relazioni umane e accessibile solo a partire dalle relazioni umane.
«La dimensione del divino si apre a partire dal volto umano» (TI, p. 76). Ne segue che, secondo Levinas, i
concetti teologici sono vuoti senza il riferimento all'etica, così come per Kant i concetti sono vuoti senza il
riferimento all'intuizione empirica.
2. Dall'ontologia all'etica
La preoccupazione di salvaguardare l'autonoma consistenza del soggetto umano, presente nello svincolare
l'idea di Dio da quella del sacro, dalla violenza del sacro, guida Levinas anche nella critica -- più
specificatamente filosofica -- all'ontologia quale orizzonte ultimo del senso e quindi anche come orizzonte sul
cui sfondo pensare Dio. Egli si trova certamente in sintonia con le critiche di Heidegger all'onto-teologia, che
finirebbe per pensare Dio come ente tra gli enti, sia pur come l'ente sommo, l'ens perfectissimum, nel pieno
oblio della differenza ontologica tra enti ed essere. Ma ritiene che si debba andare oltre lo stesso invito,
rivolto da Heidegger alla teologia, di pensare e dire Dio sullo sfondo della riscoperta della verità dell'essere
nella sua differenza dagli enti.11 Per salvaguardare la trascendenza santa di Dio è necessario, a suo avviso,
cercare di pensare Dio «senza l'essere» (come dirà Marion), andando cioè oltre l'essere, nell'altrimenti-cheessere, come si sostiene, quale tesi centrale, nell'opera Altrimenti che essere (1974);12 tesi ripresa e
sviluppata nel saggio Dio e la filosofia (1975), ripubblicato nella raccolta Di Dio che viene all'idea (1982), di
cui costituisce il centro. Qui leggiamo:
Se l'intellezione del Dio biblico -- la teologia -- non raggiunge il livello del pensiero filosofico, non è perché
essa pensa Dio come ente senza esplicitare innanzitutto «l'essere di questo ente», ma perché, tematizzando
Dio, essa lo conduce nel percorso dell'essere, proprio mentre il Dio della Bibbia significa in maniera
inverosimile -- cioè senza analogia con un'idea sottomessa ai criteri, senza analogia con un'idea esposta
all'intimazione di mostrarsi vera o falsa -- l'al di là dell'essere, la trascendenza. [...]
Il problema che di conseguenza si pone e su cui ci concentreremo consiste nel domandarsi se il senso
equivale all'esse dell'essere, cioè se il senso che in filosofia è senso non sia già una restrizione del senso, se
non sia già una derivata, o una deriva del senso, se il senso equivalente all'essenza -- alle gesta dell'essere,
all'essere in quanto essere -- non sia già accostato all'interno della presenza che è il tempo del Medesimo;
supposizione che può giustificarsi solo tramite la possibilità di risalire a partire da questo senso, che si
presume condizionato, ad un senso che non si direbbe più in termini di essere, né in termini di ente (DVI, p.
78).
Perché -- ci possiamo domandare -- quest'impegno di Levinas a liberare Dio da «ogni contaminazione con
l'essere», mostrando che l'essere -- più propriamente le «gesta dell'essere», secondo quella verbalità dell'esse
che Heidegger avrebbe avuto il merito di risvegliare -- non può essere inteso come l'orizzonte ultimo del
senso e quindi come il luogo in cui Dio può propriamente venire all'idea? Fondamentalmente perché, a suo
avviso, già l'uomo, l'essente uomo, non può essere pensato sullo sfondo dell'essere senza venire
spersonalizzato nel c'è (il y a) anonimo (come si sostiene già in Dall'esistenza all'esistente, del 1947) ,13
senza essere subordinato ad una totalità da cui trarrebbe ogni suo senso perdendo la propria singolarità
irriducibile (come si sostiene in Totalità e infinito, del 1961), senza essere ridotto alla pur grandiosa funzione
di momento indispensabile nel dramma della manifestazione che compete all'essenza stessa dell'essere
(come spiegato in Altrimenti che essere, del 1974). E se l'ontologia, concepita quale orizzonte ultimo del
senso, risulta «violenta» per l'uomo,14 tanto più essa risulterà violenta per Dio; più propriamente per
l'autentica significazione di Dio e quindi per un'autentica relazione dell'uomo per Dio.
In Totalità e infinito, più in particolare, la critica all'ontologia totalitaria diviene anche critica della
concezione monolitica dell'essere parmenideo, che pensa la perfezione dell'essere in termini di completa
unità. Una concezione che sfocia nella visione dell'Uno divino come autosufficiente e soddisfatto di sé, che
penserebbe soltanto se stesso e nei cui confronti gli esseri molteplici e separati sarebbero come una
decadenza dall'essere vero e proprio, una limitazione dell'essere. A tale paradigma ontologico parmenideo,
Levinas contrappone il paradigma (ontologico) della creazione, da intendersi non tanto come produzione
causale da parte di un artefice sommo, quanto, appunto, come situazione di «separatezza» degli esseri creati
nei confronti dell'essere divino infinito e, al tempo stesso, d'effettiva relazione di specifica dipendenza.
L'ideale di un essere attuato dall'eternità e che pensa solo a se stesso non può servire da paradigma
ontologico di una vita, di un divenire, capaci di un Desiderio sempre rinnovato, di società. [...] Il fatto che ci
possa essere qualcosa che è più dell'essere o al di sopra dell'essere si traduce nell'idea di creazione che, in
Dio, supera un essere eternamente soddisfatto di sé (TI, p. 223).
Un Bene al di là dell'essere e al di là della beatitudine dell'Uno -- ecco come si potrebbe enunciare un
concetto rigoroso della creazione (TI, p. 301).
All'ontologia monolitica parmenidea, violenta nei confronti dell'uomo e nei confronti di Dio, Levinas
contrappone prima, in Totalità e infinito, un'ontologia pluralista e relazionale pensata in termini etici, e poi,
in Altrimenti che essere, addirittura un trascendere etico del soggetto responsabile che la rompe con
l'orizzonte stesso dell'essere, avventurandosi, appunto, nell'altrimenti che essere, ove soltanto si trova la
significazione ultima del senso. Una significazione non più esprimibile in termini di essere ma solo in termini
di dis-inter-esse, cioè d'uscita dall'essere, d'evasione etica dall'essere; ove anche la terminologia ontologica è
forzata a trasformarsi in terminologia etica, come nel caso della «differenza» ontologica che si trasforma in
«non in-differenza» etica. Per questo Levinas sostiene, e questo fin da Totalità e infinito, che la vera e
propria «filosofia prima», ovvero l'origine e l'orizzonte ultimi del senso, non è l'ontologia ma l'etica. 15 E, di
conseguenza, che non è possibile pensare Dio, il senso primo ed ultimo della realtà (o meglio, della
«significazione»), in termini di essere ma solo in termini etici, di trascendenza etica.
3. La non violenza della relazione etico-teologica
Pensare Dio in termini etici non aprirà però la strada ad una nuova forma di violenza sull'uomo? Evitata la
violenza della trascendenza religioso-sacrale e della trascendenza metafisico-ontologica, non si cadrà nella
violenza dell'imperativo etico eteronomo, che s'imporrebbe alla libertà umana come semplice trascrizione
secolarizzata del Dio numinoso che dal monte Sinai imponeva la sua legge tra tuoni, lampi e fulmini? 16
Fin dalla prima frase di Totalità e Infinito Levinas mostra di essere ben cosciente di questo rischio, che
peraltro Nietzsche aveva ampiamente denunciato, soprattutto in riferimento all'etica imperativa di Kant.
«Tutti ammettono facilmente -- osservava -- che la cosa più importante è sapere se non si è vittime della
morale» (si l'on n'est pas le dupe de la morale = se non si è presi in giro, burlati, dalla morale) (TI, p. 19).
L'avvertenza estrema di questo rischio è ben presente sia nella descrizione della fenomenologia del «volto»,
che comanda in modo incondizionato di «non uccidere», ma anche d'«amare incondizionatamente»
(fenomenologia svolta soprattutto in Totalità e Infinito), sia nella descrizione della soggettività umana,
responsabile fino alla «soggezione» ad altri, alla «sostituzione» e alla «espiazione» per i loro delitti, nel «disinter-esse» più completo (fenomenologia svolta soprattutto in Altrimenti che essere). A tale rischio egli cerca
sempre di sfuggire con vigile attenzione.
Nella fenomenologia del volto tale attenzione si concentra nel rilevare come nel «volto» d'Altri noi
sperimentiamo la coincidenza paradossale d'Altezza (Maestà o Signoria) e di miseria, nudità, vulnerabilità.
D'Altezza, per l'incondizionatezza del comando, che vale senza attendere o pretendere la reciproca, e quindi
nella più completa asimmetria; e cresce all'infinito senza trovare mai compimento o soddisfazione, come nel
dinamismo del desiderio della bontà. Due caratteristiche, l'incondizionatezza e l'infinizione, che permettono
di rilevare nel volto d'Altri la «traccia» dell'Infinito, dell'Altissimo, la dimensione del divino. La «curvatura
dello spazio intersoggettivo», che situa Altri più in alto di me, «separato -- o santo -- volto» -- osserva
Levinas -- «significa l'intenzione divina d'ogni verità»; per questo egli si azzarda a dire: «questa «curvatura
dello spazio» è, forse, la presenza stessa di Dio» (TI, pp. 299-300).
Ma la particolare significazione teologica di tale traccia dell'Altissimo, che si può riscontrare nel volto d'Altri,
rischierebbe di presentarsi come violenta se la Maestà del volto non coincidesse con la sua miseria, nudità,
vulnerabilità; in altre parole, se non si offrisse indifesa al possibile oltraggio fino all'omicidio. Come una
compiuta fenomenologia del volto può mettere in luce, la cogenza dell'interpellazione etica che mi giunge dal
volto non è violenta, anzi è all'origine della relazione pacifica tra gli uomini, anche perché, lungi dall'imporsi
con la forza della sua potenza, s'impone per la sua stessa impotenza, miseria, vulnerabilità.
L'infinito paralizza il potere con la sua resistenza infinita all'omicidio, che, dura ed insormontabile, risplende
nel volto d'Altri, nella nudità totale dei suoi occhi, senza difesa, nella nudità dell'apertura assoluta del
Trascendente. Si tratta d'una relazione non con una resistenza grandissima, ma con qualcosa di
assolutamente Altro: la resistenza di ciò che non ha resistenza -- la resistenza etica (TI, pp. 173; 204).
Nell'interessante saggio Giudaismo e kénosi, del 1985,17 ma anche già nel saggio Dall'etica all'esegesi, del
1982,18 e, prima ancora, nel saggio Un Dieu Homme?, del 1968,19 nella miseria e nudità del volto Levinas
vedrà addirittura, con chiari e dichiarati accenti anche cristiani, la traccia dell'umiltà del divino che si
abbassa fino a noi, discende nell'uomo, nelle nostre idee, soprattutto nei piccoli e poveri, per farsi servire ed
amare in loro, fino a preferire d'essere soggetto all'arbitrio della violenza altrui piuttosto che apparire come
violento.20
In Totalità ed infinito, Levinas non giungeva ancora ad individuare, nella nudità e miseria del volto, la traccia
della kénosi del divino quale alternativa estrema non solo al sacro violento e all'autosufficiente beatitudine
dell'Uno, ma anche ad un'etica imperativa di natura violenta. Ma era già ben attento a mettere in luce come
l'imperativo etico che mi giunge eteronomamente dal volto d'altri, sintesi di Maestà e di miseria, lungi dal
violentare la libertà umana l'instaura, qualificandola con l'investitura nobiliare della responsabilità.
La presenza d'Altri -- eteronomia privilegiata -- non si oppone alla libertà ma l'investe (TI, p. 87). L'Altro,
assolutamente altro -- Altri -- non limita la libertà del Medesimo. Chiamandola alla responsabilità, la
instaura e la giustifica. La relazione con l'altro in quanto volto guarisce dall'allergia. Essa è desiderio,
insegnamento ricevuto e opposizione pacifica del discorso (TI, p. 202).
La tesi della libertà che nasce in quanto «investita dalla responsabilità», implica, per Levinas, che non esista
una libertà umana originariamente infinita e neutra rispetto al bene e al male. Se si desse una tale libertà -come in epoca moderna è stato ampiamente sostenuto -- ogni comando eteronomo le farebbe
inevitabilmente violenza, costringendola entro limiti non suoi. Se invece la libertà umana nasce e si coglie
nella sua natura più profonda, proprio in virtù dell'incontro con il volto d'altri, come fin dall'origine
«investita» o qualificata dalla responsabilità per altri, si può comprendere come l'imperativo etico non la
comprima ma l'instauri. In un certo modo come sostiene Kant, per il quale imperativo categorico e libertà si
richiamano a vicenda, in quanto il primo evidenzia la seconda, ne è la ratio cognoscendi, e la seconda rende
possibile il primo, ne è la ratio essendi. A ciò si aggiunge che per Levinas la responsabilità, che investe
originariamente la libertà, per natura sua s'accresce senza posa, all'infinito, secondo il dinamismo proprio del
desiderio della bontà, e quindi testimonia, in questa sua stessa infinizione, la presenza dell'infinito in lei. Una
presenza paradossale, come quella che Cartesio descrive a proposito dell'idea dell'Infinito, che è bensì in noi
ma che noi, esseri finiti, non possiamo in alcun modo contenere o adeguare; e proprio per questo tale idea
testimonia della trascendenza assoluta dell'infinito che ne sta all'origine.
Sulla testimonianza dell'infinito da parte della soggettività responsabile dell'uomo, Levinas ritornerà più
ampiamente in Altrimenti che essere, coniugandolo con i temi dell'ispirazione e della profezia. In quest'opera
viene in primo piano non più la trascendenza del volto altrui, ma la trascendenza della stessa soggettività
umana, responsabile d'altri nel più completo «dis-inter-esse» e per questo già oltre l'essere, già trascendenza
rispetto all'essere. Nella descrizione fenomenologica di questa responsabilità disinteressata, in cui consiste la
soggettività dell'uomo, il vero e proprio humanum che è in noi, che noi siamo, Levinas si spinge fino all'uso di
una terminologia talmente estrema o iperbolica, da rischiare la compromissione con l'etica sacrificale, che
esige e pratica il sacrificio di un soggetto umano -- quale capro espiatorio -- per la salvezza di molti.21 Una
terminologia che ha stupito lo stesso Ricœur, tanto da fargli pensare che in Levinas non si rendesse ragione
alle positive capacità di agire e d'accoglienza inerenti alla soggettività umana, fino a lasciarla passivamente
indifesa in balia di Altri come suo possibile carnefice. 22
A mio avviso questa deriva pericolosa non solo è del tutto estranea agli intenti di Levinas, ma è da lui
positivamente esclusa. La passività del soggetto responsabile, descritta in termini di sensibilità, prossimità,
sostituzione fino all'espiazione, va letta, infatti, sullo sfondo del concetto ebraico dell'elezione, che in
Altrimenti che essere viene in primo piano rispetto alla categoria della creazione, che campeggiava in
Totalità e Infinito. Ora l'elezione -- come impronta caratteristica d'ogni soggetto umano, dato che l'elezione
d'Israele è da intendersi, per Levinas, come rappresentativa dell'elezione d'ogni uomo -- dice di una scelta
pre-originaria o anarchica da parte del Bene; che è Bene proprio perché in modo del tutto gratuito, prima che
io potessi sceglierlo, già mi ha scelto alla responsabilità disinteressata per altri, senza alcun limite che non sia
quello che deriva dalla presenza del terzo, cioè di tutti gli altri volti che già urgono nel volto del fratello più
prossimo. Anche l'elezione, quindi, lungi dal violentare la mia libertà, l'instaura, la rende possibile per quello
che veramente è, liberandola dai vincoli di una soggettività egoisticamente e vitalmente accentrata su se
stessa, dallo statuto di un'esistenza individuale solitaria.
Quest'anteriorità della responsabilità in rapporto alla libertà significherebbe la Bontà del Bene: la necessità
per il Bene di eleggermi per primo, prima che io sia in grado di eleggerlo, cioè di accogliere la sua scelta. È
questa la mia susceptio pre-originaria (AE, p. 155).
La bontà è nel soggetto l'an-archia stessa; in quanto responsabilità per la libertà dell'altro, anteriore ad ogni
libertà in me, ma anche anteriore alla violenza in me che sarebbe il contrario della libertà, perché se nessuno
è buono volontariamente, nessuno è schiavo del Bene (AE, p. 173).
L'elezione alla responsabilità non fa, quindi, in alcun modo violenza alla libertà. Sia perché la costituisce
come tale e non le sopraggiunge in un secondo tempo, sia perché la libertà, originariamente investita dal
bene e quindi buona in radice, può rifiutarsi di fare il bene, di essere concretamente responsabile d'altri. Ma
così essa decade dal bene nel male, che non è originario come il bene, ma sempre inferiore, posteriore al
Bene. E non va dimenticato che, per Levinas, l'elezione alla responsabilità fino alla dedizione totale all'altro si
rivolge sempre e solo a me in prima persona, come «unico», ed io non posso predicarla e tanto meno imporla
ad altri, perché ciò sarebbe predicare il «sacrificio umano». 23
In verità, il tema dell'elezione da parte del Bene, di chiara ispirazione biblica, non è presente in Levinas quale
premessa teologica, bensì quale rimando fenomenologico a partire, appunto, dall'analisi dell'anarchia della
soggettività disinteressatamente responsabile.
Il problema della trascendenza e di Dio, e il problema della soggettività irriducibile all'essenza, irriducibile
all'immanenza essenziale, procedono insieme (AE, p. 22).
Procedono assieme proprio perché la seconda, la soggettività responsabile, rimanda alla trascendenza di Dio
almeno in due direzioni:
1.
verso il passato immemorabile, cui la passività assoluta del soggetto responsabile rinvia, senza
possibilità di ricomprendere tale passato nel presente della sua attività cosciente e libera, anche solo
col ricordo di averlo avuto un tempo presente. Il Bene, infatti, mi ha già da sempre scelto, prima che
intervenga una qualsivoglia attività cosciente o gesto di libertà.
2. verso il futuro infinito della Bontà: perché il soggetto responsabile rinvia all'infinito in virtù del
«senza fine» (AE, p. 175) del suo obbligo, che lungi dal diminuire con l'assolvimento, si «accresce
infinitamente» (AE, p. 179). La Bontà non è, infatti, un bisogno che si può appagare!
Per esprimere la natura di questo duplice rinvio, Levinas ricorre -- come già abbiamo accennato -- alle
categorie della testimonianza, dell'ispirazione, della profezia.
la testimonianza in contrapposizione allo «svelamento», che a suo avviso non può che riportare ogni
alterità all'immanenza del soggetto.24
l'ispirazione-profezia, per indicare che Dio viene all'idea e/o alla parola non come il tema di un
discorso, ma parlando nella parola stessa del soggetto che dice «Eccomi!» al prossimo, l'«Eccomi!»
della disponibilità totale, dell'esposizione, della sostituzione. 25
Né la testimonianza né l'ispirazione-profezia sono da intendere, secondo Levinas, come dimostrazioni
razionali dell'esistenza di Dio, bensì come modalità del suo manifestarsi.
Il soggetto come ostaggio non è stato né l'esperienza, né la prova dell'Infinito, ma la testimonianza
dell'Infinito, modalità di questa gloria, testimonianza che nessun svelamento ha preceduto (DVI, p. 97).
L'infinito non ha dunque gloria che attraverso la soggettività, attraverso l'avventura umana
dell'approssimarsi all'altro, attraverso la sostituzione all'altro, attraverso l'espiazione per l'altro (AE, p. 185).
Circa la particolare «significazione» della trascendenza di Dio, testimoniata dalla soggettività umana, ritorna
anche in Altrimenti che essere, come pure negli scritti successivi, la paradossale tensione d'Altezza e
d'umiliazione che abbiamo già visto caratterizzare la trascendenza divina significata nella trascendenza del
volto.
Anzitutto l'Altezza o separatezza straordinaria della trascendenza in cui il Bene si mantiene. Esso, infatti, non
solo non deve essere pensato come ciò che può essere oggettivato o tematizzato nei nostri discorsi, come ciò
che in qualche modo può darsi direttamente, ma neppure come quel termine ultimo del desiderio umano che,
platonicamente, ne costituirebbe come il «riempimento» o soddisfacimento adeguato. Anche in questo caso,
infatti, il Bene rischierebbe di essere per così dire riportato entro l'immanenza dell'orizzonte della
soggettività umana. Secondo Levinas, il Bene si mantiene nella sua assoluta trascendenza, separatezza,
santità, perché, lungi dall'attirare a sé il desiderio metafisico umano per soddisfarlo -- come nell'eros
platonico -- lo volge verso il prossimo, il non desiderabile per eccellenza, e solo così lo mantiene nel dis-interesse (trascendente) della bontà e si mantiene nella sua assoluta trascendenza separata o santa.
Nella trascendenza dell'Infinito cosa ci suggerisce il termine Bene? Perché il disinteressamento sia possibile
nel Desiderio dell'Infinito, perché il Desiderio al di là dell'essere, o la trascendenza, non sia un assorbimento
nell'immanenza che così farebbe il suo ritorno, occorre che il Desiderabile o Dio resti separato nel Desiderio;
come desiderabile -- prossimo ma differente -- Santo. Questo è possibile solo se il Desiderio mi ordina a ciò
che è il non-Desiderabile, all'indesiderabile per eccellenza, ad altri. Il rinvio ad altri è risveglio, risveglio alla
prossimità la quale è responsabilità per il prossimo, fino alla sostituzione ad esso. [...] Amore senza Eros
(DVI, p. 91) .26
La possibilità del Desiderio metafisico autentico, dell'«amore senza eros», suppone quindi che la natura del
Bene, «la bontà del Bene», consista nell'inclinare il movimento che esso suscita «per allontanarlo dal Bene ed
orientarlo verso altri e così solamente verso il Bene» (DVI, p. 92). L'Infinito, nella sua separatezza o santità, è
quindi Bene in senso eminente e precisissimo perché: «non mi riempie di beni, ma mi costringe alla bontà,
migliore dei beni da ricevere» (DVI, p. 92).27 Si tratta di una «costrizione» che, come già abbiamo visto, non
si contrappone alla libertà del soggetto, non la violenta, ma la suscita fin dall'inizio come libertà segnata
dall'«investitura» del Bene, dall'elezione del soggetto da parte del Bene alla responsabilità per altri, prima
ancora che si possano compiere le scelte concrete in cui si gioca il suo confermarsi nel bene o lo scadere nel
male.
Questa specialissima trascendenza etico-teologica non violenta del Bene si chiarisce e precisa ulteriormente
se si pensa che la soggettività umana, quale «tempio o teatro» (DVI, p. 99) della trascendenza stessa di Dio, è
proprio la soggettività che in Altrimenti che essere è intesa come «soggezione, sopportazione, sostituzione,
ostaggio, espiazione», termini che rimandano chiaramente alla famosa figura, descritta da Isaia (cfr. Isaia
53), del «servo di Jahvé» che porta su di sé i «nostri peccati». Nello sfondo di una soggettività di questo tipo,
in cui il subire violenza «a causa di altri» trapassa in subire «per altri», e quindi in «espiazione per altri»
(AE, p. 139), anche la trascendenza teologica, senza nulla perdere della sua Altezza, paradossalmente ne
mostra il vero volto trapassando in condivisione della sofferenza umana fino ad assumerla su di sé per
espiarla.
Nei saggi sopra citati, Un Dieu-Homme?, del 1968, Dall'etica all'esegesi, del 1982, Giudaismo e kénosi, del
1985, oltre al tema dell'umiliazione di Dio, che ci aiuterebbe a pensare la trascendenza del volto nudo e
indifeso d'Altri, Levinas introduce anche il tema della discesa di Dio nella sofferenza degli uomini, fino ad
assumerla su di sé in quella particolare forma di «sostituzione» che consiste nell'assumere il peso o
responsabilità dei loro peccati, fino ad espiarli in vece loro; e così ci aiuterebbe a scoprire anche il vero senso
della trascendenza della soggettività umana. Si badi, ciò non ha nulla di mitico o sacrificale. Non si tratta,
infatti, di redimere i peccati pagando un certo qual debito di sofferenza dovuto come pena alla giustizia
divina, quanto di accettare di portare su di sé, con amore disinteressato ed accogliente, la cattiveria altrui
senza ributtarla su altri, senza farla portare ad altri, e, solo così, di estinguerne la virulenza.
Il problema dell'uomo-Dio comporta, da una parte, l'idea dell'umiliazione che s'infligge l'Essere supremo,
della discesa del Creatore al livello della creatura, cioè dell'assorbimento nella passività più passiva
dell'attività più attiva. D'altro lato il problema comporta, come producentesi da parte di questa passività
spinta nella Passione al suo limite ultimo, l'idea d'espiazione per gli altri, cioè della sostituzione: l'identico
per eccellenza, ciò che non è intercambiabile, ciò che è unico per eccellenza, sarebbe la sostituzione stessa
(EN, p. 69).
E dopo aver osservato che queste idee, originariamente teologiche e valevoli incondizionatamente per la fede
cristiana, ed in certa misura per la fede ebraica, hanno anche una portata filosofica che può essere mostrata
fenomenologicamente, si dice:
Io penso che l'umiltà di Dio permette, fino ad un certo punto, di pensare la relazione con la trascendenza in
termini diversi da quelli dell'ingenuità o del panteismo; e che l'idea di sostituzione -- secondo una certa
modalità -- è indispensabile alla comprensione della soggettività (EN, p. 70).
Per un verso, quindi, l'idea cristiana -- ma presente anche nella sensibilità giudaica -- di Dio che si fa
sostituzione dell'uomo peccatore per espiare in sua vece, può servire, una volta riscattata
fenomenologicamente, per meglio comprendere la soggettività umana. Per altro verso, la comprensione
fenomenologica della soggettività umana in termini di sostituzione, può meglio farci comprendere la natura
non violenta, anzi assolutamente salvifica, della trascendenza divina.
4. Trascendenza nel modo della traccia e dell'enigma
La non violenza della trascendenza teologica si mostra, secondo Levinas, non solo nel suo contenuto
significativo, nella sua «significazione», ma anche nella modalità stessa del suo significare, cioè d'esibire il
proprio significato senza imporlo come un dato di fatto incontrovertibile o come un fenomeno che viene ad
intromettersi tra gli altri fenomeni della nostra vita quotidiana o delle nostre indagini scientifiche.
Come abbiamo visto, la trascendenza divina mi «visita»28 attraverso la trascendenza del volto dell'altro, che
implora ed esige a partire dalla sua signoria e miseria, ed anche attraverso la trascendenza della
testimonianza profetica della soggettività responsabile dell'uomo, che si dice nel suo stesso dire-esporsi ad
altri. Ma in entrambi i casi essa non s'impone come un fenomeno dato tra altri fenomeni, bensì lasciando nei
fenomeni -- che pur sconvolge -- solo una traccia del suo passaggio, una traccia che mi parla solo nel modo
dell'enigma.
La fenomenologia della traccia e dell'enigma, che Levinas sviluppa soprattutto nei celebri saggi La traccia
dell'altro, del 1963 ed Enigma e fenomeno, del 1965, è quanto mai ricca.29 Qui mi limiterò al modo di darsi
dell'enigma, partendo dagli esempi che egli adduce per chiarire il suo pensiero.
Hanno bussato e non c'è nessuno alla porta. Hanno davvero bussato? [...] Un diplomatico fa una proposta
esorbitante ad un altro diplomatico, ma i termini della proposta sono tali che, se si vuole, niente è stato detto.
L'audacia si allontana e si spegne nelle parole stesse che la sostengono e l'infiammano [...]. Un innamorato fa
un'avance, ma il gesto provocatore o seduttore, se si vuole, non ha interrotto la decenza dei discorsi e del
comportamento e se n'allontana con la stessa leggerezza con cui vi è penetrato. Un Dio si è rivelato su una
montagna o in un roveto che non si consuma o si è fatto dare testimonianza in alcuni Libri. E se quei libri ci
provenissero da sognatori? Cacciamo dalla mente l'appello illusorio! L'insinuazione stessa c'invita a farlo.
Dipende da noi o, più esattamente, dipende da me accettare o respingere questo Dio senza audacia (EDE, pp.
241-242).
Come si vede da questi esempi, si tratta, nell'enigma, 1) di un «modo di manifestarsi senza manifestarsi», per
semplice «accenno», ritraendosi subito dall'ambito del fenomeno dopo averlo scompigliato, e 2) di un modo
di significare che può essere riconosciuto solo «se si vuole», liberamente, dato che non s'impone con la
propria presenza disvelata, bensì come «mantenendo l'incognito». La scelta del termine «enigma» (nel senso
greco di «detto oscuro», o «allusivo»), fatto valere in contrapposizione al termine «fenomeno», vuole
appunto indicare queste due caratteristiche del particolare modo di significare della trascendenza: né per
presenza disvelata che s'impone, né per dimostrazione razionale inoppugnabile.
Per chiarire ulteriormente questo particolare contrasto tra senso significato nell'enigma e dato fenomenico
del senso, Levinas si rifà, a questo punto, al concetto kierkegaardiano di «verità perseguitata»: specialissimo
«modo della verità» non violenta, che va ben oltre quello della «verità universalmente evidente» o
incontrovertibile.
Il Dio di Kierkegaard che si rivela solo per essere perseguitato e misconosciuto, che si rivela solo nella misura
in cui è inseguito (pourchassé) [...] diventa il luogo stesso della verità. [...] «Verità perseguitata», non è
soltanto «consolazione» religiosa, ma il disegno originario della trascendenza (EDE, pp. 247-248) .30
La verità della trascendenza divina si offre, quindi, senza mai imporsi; scompiglia il mondo dei nostri
fenomeni d'essere, in cui ci troviamo come a nostro agio, senza mai lasciarsi afferrare dalle nostre categorie e
ricondurre all'oggettività del nostro ordine scientifico-concettuale; ci parla attraverso l'appello del volto altrui
e la testimonianza profetica del soggetto responsabile, ma con un dire che può essere udito solo da un
«orecchio all'agguato», incollato alla porta del linguaggio per ascoltare la significazione del suo dire
enigmatico e per ospitarlo a proprio rischio e pericolo; senza possibili garanzie «scientifiche», e proprio per
questo in piena libertà.
Si potrebbe, quindi, dire che la soggettività levinasiana, «compagna dell'enigma e della trascendenza» (EDE,
p. 250), è una forma di libera «coscienza credente», che si affida alla trascendenza nel momento stesso in cui
s'impegna a testimoniarla nell'esporsi, in completo dis-inter-esse, all'appello del volto altrui. E in questo suo
affidarsi alla trascendenza essa non perde se stessa né subisce violenza, ma realizza la propria realtà più
profonda, quell'elezione al Bene che in radice la costituisce.
In conclusione vorrei osservare come anche la «scrittura» di Levinas, i testi che egli ha prodotto, possono
essere intesi come testi-traccia, testi-enigma alla seconda potenza, cioè tracce di tracce, enigma d'enigmi. Nel
loro dire e disdire affannoso, sempre ritornante e sempre ritraentesi come le onde sulla spiaggia del mare,
come pure nelle esasperazioni iperboliche del linguaggio, che si spingono fino alla trasfigurazione dei termini
ontologico-filosofici in termini etici, d'appello etico (come ad esempio nel caso del termine heideggeriano
«differenza» ontologica che diviene «non in-differenza» etica), i testi di Levinas non intendono imporsi per il
rigore dimostrativo o convincere con l'abilità retorico-dialettica, quanto offrirsi come un invito a sciogliere
con lui, come lui, le tracce enigmatiche della trascendenza. Un invito che ci viene offerto come un dono, che
solo se vogliamo possiamo riconoscere come tale e liberamente accogliere/ospitare in noi stessi, divenendone
a nostra volta testimoni.
Note
1.
Cfr. ad esempio, il titolo delle due raccolte di saggi: E. Levinas -- A. Peperzak, Etica come filosofia prima, a cura
di F. Ciaramelli, Guerini e Associati, Milano 1989; E. Levinas. L'éthique comme philosophie première, Atti del
colloquio di Cerisy-la-Salle, 23 agosto -- 2 settembre 1986, a cura di J. Greisch -- J. Rolland, La Nuit Surveillée,
Cerf, Paris 1993.
2.
Cfr, E. Levinas, Di Dio che viene all'idea, a cura di S. Petrosino, trad. di G. Zennaro, Jaca Book, Milano 1983, p.
92n (d'ora in avanti citato con sigla DVI).
3.
Cfr. E. Levinas, Totalità e Infinito. Saggio sull'esteriorità, a cura di A. Dall'Asta, con introd. di S. Petrosino, Jaca
Book, Milano 19902, p. 23 (d'ora in avanti citato con sigla TI).
4.
Cfr. Du Sacré au Saint. Cinq nouvelles lectures talmudiques, Minuit, Paris 1977; tr. it. Dal Sacro al Santo.
Cinque nuove letture talmudiche, a cura di O. M. Nobile Ventura, con introd. di S. Cavalletti, Città Nuova, Roma
1985.
5.
Cfr. R. Otto, Das Heilige, 35ª ed., Beck, München 1936 (orig. 1917), tr. it. Il sacro. L'irrazionale nell'idea del
divino e la sua relazione al razionale, a cura di E. Buonaiuti, Feltrinelli, Milano 1966.
6.
Nel saggio Éthique et esprit, risalente al 1952 (cfr. E. Levinas, Difficile liberté. Essais sur le judaïsme, 3ª ed.,
«Le Livre de Poche», Albin Michel, Paris 2003, pp. 15-26; tr. it. a cura di S. Facioni, Difficile libertà, Jaca Book,
Milano 2004, p. 17-25, sigla DL), la violenza, che viene esclusa solo da quel complesso campo che tiene
strettamente uniti ragione, linguaggio ed etica: il campo dello spirituale, è descritta nei suoi svariati aspetti
come segue: «La violenza non si trova solo in un palla di bigliardo che ne urta un'altra, nell'uragano che
distrugge un raccolto, nel padrone che maltratta lo schiavo, in uno stato totalitario che avvilisce i suoi cittadini,
nelle conquiste di guerra che asserviscono gli uomini. È violenta ogni azione in cui si agisce come se si fosse soli
ad agire: come se il resto dell'universo ci fosse solo per ricevere l'azione; è violenta, di conseguenza, anche ogni
azione che noi subiamo senza esserne in tutto dei collaboratori. Quasi ogni causalità è in questo senso violenta:
la fabbricazione di una cosa, la soddisfazione di un bisogno, il desiderio e anche la conoscenza di un oggetto. Ed
anche la lotta e la guerra in cui altri è cercato nella debolezza che tradisce la sua persona. Ma la violenza è anche,
per buona parte, nel delirio poetico e nell'entusiasmo ove noi non offriamo che una bocca alla musa che se ne
serve per parlare; nel timore e nel tremore ove il sacro ci strappa da noi stessi; essa è nella passione, sia pure
dell'amore, che porta al fianco la ferita di una perfida freccia» (DL, pp. 20-21; tr. it. cit., p. 21).
7.
Levinas ha dedicato a Lévy-Bruhl il significativo saggio Lévy-Bruhl et la philosophie contemporaine, in «Revue
Philosophique de la France e de l'Étranger», cxlvii (1957), n. 4, pp. 556-569, ora anche in Entre nous. Essais sur
le penser-à-l'autre, Grasset, Paris 1991, pp. 53-65, con ampi riferimenti soprattutto alla fondamentale opera
sulla mentalità primitiva (cfr. L. Lévy-Bruhl, La mentalità primitiva, tr. it. di Carlo Cignetti, con un saggio di
Giuseppe Cocchiera, 2ª ed., Einaudi, Torino 1971).
8.
Il che non toglie che, come ultimamente ha rilevato Catherine Chalier, nel volume La trace de l'infini.
Emmanuel Levinas et la source hébraique, Cerf, Paris 2002, pp. 56, 64 e passim, Levinas s'ispiri anche a testi
chassidici.
9.
Cfr. Levinas, Difficile liberté, cit., pp. 27-46; tr. it. cit., pp. 27-41.
10. Per «metafisica», un termine che Levinas ricupera e rivaluta, anche in contrapposizione ad Heidegger e al suo
primato dell'ontologia (cfr. il celebre par. La metafisica precede l'ontologia, di TI, pp. 40-45), egli intende
essenzialmente il rapporto (di desiderio/aspirazione come di conoscenza, se potesse darsi, e di dipendenza
creaturale e/o etica ) con l'esteriorità o la trascendenza radicale; trascendenza rispetto all'orizzonte immanente
della soggettività, da un lato, e, dall'altro, rispetto al suo corrispettivo intenzionale, la totalità oggettuale ed
anche ontologica, cioè il mondo. Cfr.: «L'aspirazione all'esteriorità radicale, detta per questa ragione
metafisica...» (TI, p. 27). «»La vera vita è assente». Ma noi siamo al mondo. La metafisica sorge e si mantiene in
questo alibi. Essa è rivolta all'«altrove», e all'«altrimenti», e all'«altro»... Il desiderio metafisico tende verso una
cosa totalmente altra, verso l'assolutamente altro» (TI, p. 31).
11. Si ricordi anche solo il seguente celebre passo della Lettera sull'umanismo: «Solo a partire dalla verità
dell'essere si può pensare l'essenza del sacro. Solo a partire dall'essenza del sacro si può pensare l'essenza della
divinità. Solo alla luce dell'essenza della divinità si può pensare e dire che cosa debba nominare la parola «Dio»»
(Cfr. M. Heidegger, Lettera sull'«umanismo», in Segnavia, tr. it. a cura di F. Volpi, Adelphi, Milano 1987, p.
303).
12. E. Levinas, Altrimenti che essere o al di là dell'essenza, a cura di S. Petrosino e M. T. Aiello, con introd. di S.
Petrosino, Jaca Book, Milano 1983 (sigla AE).
13. Cfr. E. Levinas, De l'existence à l'existant, Vrin, Paris l9782 (orig. 1947); tr. it. Dall'esistenza all'esistente, a cura
di F. Sossi, con una premessa di P. A. Rovatti, Marietti, Casale Monferrato 1986.
14. Cfr. le celebri sferzanti espressioni usate in Totalità e infinito: «L'ontologia come filosofia prima è una filosofia
della potenza... dell'ingiustizia... porta, fatalmente, al dominio imperialista, alla tirannia...» (TI, p. 44).
15. «La morale non è un ramo della filosofia, ma la filosofia prima» (TI, p. 313). Quest'affermazione costituisce, in
qualche modo, la tesi di fondo della prima grande opera di Levinas, Totalità e Infinito, del 1961. Non si
dimentichi, però, che nella citazione il termine di «filosofia prima» è usato da Levinas non più nel senso
aristotelico di scienza delle strutture ultime dell'essere, e quindi di ontologia, bensì nel senso cartesiano e
husserliano di scienza del darsi ultimo del senso o dell'intelligibilità delle cose.
16. Così, ad esempio, sosteneva G. Vattimo, Il rischio della metafisica, «Aut-Aut», n. 273-274, 1996, pp. 22-23.
17. Ora in E. Levinas, À l'heure des nations, Minuit, Paris 1988, pp. 133-151; tr. it. a cura di Silvano Facioni, Jaca
Book, Milano 2000, pp. 131-149 (sigla HN).
18. Ivi, pp. 127-131; ed. it. cit., pp. 125-129.
19. Ora in Levinas, Entre nous. Essais sur le penser-à-l'autre, Grasset, Paris 1991, pp. 69-76 (sigla EN). Ivi già si
leggeva: «Il problema dell'uomo-Dio comporta, da una parte, l'idea dell'umiliazione che s'infligge l'Essere
supremo, della discesa del Creatore al livello della creatura, cioè dell'assorbimento nella passività più passiva
dell'attività più attiva. D'altro lato il problema comporta, come producentesi da parte di questa passività spinta
nella Passione al suo limite ultimo, l'idea d'espiazione per gli altri, cioè della sostituzione: l'identico per
eccellenza, ciò che non è intercambiabile, ciò che è unico per eccellenza, sarebbe la sostituzione stessa». E dopo
aver osservato che queste idee, originariamente teologiche e valevoli incondizionatamente per la fede cristiana,
hanno anche una portata filosofica che può essere mostrata fenomenologicamente, si dice: «Io penso che
l'umiltà di Dio permette, fino ad un certo punto, di pensare la relazione con la trascendenza in termini diversi da
quelli dell'ingenuità o del panteismo; e che l'idea di sostituzione -- secondo una certa modalità -- è
indispensabile alla comprensione della soggettività» (EN, pp. 69-70).
20. Oltre a molteplici passi biblici e talmudici, Levinas rimanda, in particolare, ai testi cristiani di Paolo nella
Lettera ai Filippesi, 2, 6-8 e del Vangelo secondo Matteo, 25, 31-46.
21. Cfr., per la delineazione e la critica di questa etica sacrificale, le famose opere di R. Girard, La violence et le
sacré, Grasset, Paris 1972; tr. it. La violenza e il sacro, a cura di O. Fatica e E. Czerkl, Adelphi, Milano 1982; Id.,
Des choses cachées depuis la fondation du monde, Grasset, Paris 1978; tr. it. Delle cose nascoste sin dalla
fondazione del mondo, a cura di R. Damiani, Adelphi, Milano 1983; Id., Le bouc émissaire, Grasset, Paris 1982;
tr. it. Il capro espiatorio, a cura di C. Leverd e F. Bovoli, Adelphi, Milano 1987.
22. Cfr. la critica che Ricœur rivolge a Levinas in Soi-même comme un autre, Seuil, Paris 1990; tr. it. Sé come un
altro, a cura e con introduzione di D. Iannotta, Jaca Book, Milano 1993.
23. Una preziosa precisazione in tal senso si trova in una nota di Altrimenti che essere in cui si legge: «L'Io della
responsabilità è me e non un altro, io a cui si vorrebbe accoppiare un'anima gemella dalla quale si esigerebbe
sostituzione e sacrificio. Ora, dire che Altri deve sacrificarsi agli altri, sarebbe predicare il sacrificio umano» (AE,
p. 159). E nella Prefazione del 1981 a ADV, p. 66 si legge: «La grande idea etica -- la più grande -- dell'esistenza
per il prossimo s'applica senza alcuna riserva a me stesso, l'individuo o persona che io sono. Ma essa non può
essere pensata fino ad esigere l'esistenza di un popolo martire». Nonostante la forte insistenza sulla sostituzione
sacrificale quale struttura stessa dell'Io, in Levinas non si trovano quindi tracce della «mentalità sacrificale» con
cui si giustifica il sacrificio di alcuni -- gli altri -- per il bene di tutti.
24. Celebre, su questo tema, il saggio di Levinas, Vérité du dévoilement et vérité du témoignage, in La
testimonianza (Archivio di filosofia), Cedam, Padova 1972, pp. 101-110, rielaborato come quinto capitolo di AE.
25. «L'Infinito non è davanti al suo testimone, ma come al di fuori o «all'inverso» della presenza, già passato, fuori
presa: retro-pensiero (arrière pensée) troppo alto per spingersi in prima fila. «Eccomi, in nome di Dio», senza
riferirmi direttamente alla sua presenza. «Eccomi» tout court! Nella frase in cui Dio viene per la prima volta a
mescolarsi con le parole, Dio è ancora assente. Essa non si enuncia in alcun «io credo in Dio». Testimoniare Dio
non è precisamente enunciare questa parola stra-ordinaria, come se la gloria potesse dimorare in un tema e
porsi come tesi o farsi essenza dell'essere. Segno dato all'altro di questa significazione stessa, l'«eccomi», mi
significa in nome di Dio al servizio degli uomini che mi riguardano, senza aver niente con cui identificarmi, se
non con il suono della mia voce o con la figura del mio gesto -- con il dire stesso» (AE, p. 187).
26. Il tema era già presente in Altrimenti che essere, anche se in questo saggio trova una tematizzazione più
esplicita. Si veda, ad esempio, questo passo: «Che nella sua bontà, il Bene declini il desiderio che suscita
inclinandolo verso la responsabilità per il prossimo, questo preserva la differenza nella non-indifferenza del
Bene che mi elegge prima che io lo accolga; questo preserva la sua illeità al punto da escluderla dall'analisi,
tranne la traccia che essa lascia nelle parole» (AE, p. 155).
27. In Totalità e Infinito, si parlava, in modo analogo, della paternità come del «dono del potere del dono» (TI, p.
277).
28. Per la centralità della categoria della «visitazione» cfr. il saggio La traccia dell'altro, del 1963, citato nella nota
seguente.
29. I due saggi, pubblicati per la prima volta rispettivamente in «Tijdschrift voor Filosofie», XXV (1963), pp. 605623 e in «Esprit», XXIII (1965), pp. 1128-1142, sono stati inseriti nella seconda edizione di En découvrant
l'existence avec Husserl et Heidegger, Vrin, Paris 1967, pp. 187-216 e sono stati tradotti nella raccolta La traccia
dell'altro, a cura e con postilla di F. Ciaramelli, Pironti, Napoli 1979, pp. 25-65. e poi in Scoprire l'esistenza con
Husserl e Heidegger, a cura di F. Sossi, Cortina, Milano 1998, pp. 215-251 (sigla EDE).
30. Sul tema kierkegaardiano della «verità perseguitata» si veda il saggio dedicato a Kierkegaard con il titolo di
Esistenza ed etica in Nomes propres, Fata Morgana, Paris 1976, pp. 99-109; tr. it. Nomi propri, con introd. e
note a cura di F. P. Ciglia, Marietti, Casale Monferrato 1984, pp. 81-89.
Francesca Nodari
Umanismo-antiumanismo in Levinas: dal Moi
all'Autrui attraverso «un paradosso che nulla lascia
intatto»
1. Umanesimo dell'altro uomo
Per Levinas un quesito rimaneva soltanto accennato nel Sartre di L'esistenzialismo è un
umanismo1 e addirittura interdetto nell'Heidegger de la Lettera sull'umanismo:2 quale posto trova
Autrui -- anzi, il per altri -- nel dibattito su umanismo e antiumanismo?
Levinas sembra tutto teso, con la sua paradossale filosofia, a risvegliare il pensiero occidentale da
quel letargo «d'immanenza» nel quale sembra essersi adagiato. Il per sé sartriano, da parte sua,
pare cullarsi nell'illusione di raggiungere il proprio compimento attraverso la messa in pratica della
sua dimensione costitutiva, il potere di nullificarsi. Ma di quale luce si irradia un umanismo, la cui
sola sicurezza sta nel porre l'esistenza prima dell'essenza e che, in fondo, rimane irretito nella
progettualità in cui il per sé è gettato?
Non promuove, forse, un'idea di uomo, che mettendo al centro l'animal rationale, in virtù della sua
libertà, lo imprigiona in una condanna dalla quale non è possibile riscattarsi e non meno gravosa di
quella toccata a Sisifo? Sartre non ci consegna, dunque, l'immagine di una soggettività
antinomicamente costretta ad essere libera? Non siamo noi -- tiene a precisare l'autore de
L'esistenzialismo è un umanismo -- soli e senza scuse?
Ciò che conta non è il contenuto della scelta dettata dai giudizi saldi e precisi dell'intelletto, ma
l'inevitabilità del dover scegliere, prescindendo da qualsiasi criterio. Secondo Sartre, non c'è una
morale in generale, ma un unico paradossale imperativo: «tu sei libero, scegli cioè inventa».3 Ma
così facendo, l'uomo non resta irretito nelle proprie opere?
Precisa Levinas, proprio ribattendo alle tesi sartriane:
Il soggetto non risalta sull'essere per una libertà che lo renderebbe padrone delle cose ma per una
suscettibilità preoriginaria, più antica dell'origine, suscettibilità provocata nel soggetto senza che
mai la provocazione si sia fatta presente o logos che si offra alla assunzione o al rifiuto e si ponga
nel campo bipolare dei valori. Per tale suscettibilità, il soggetto è responsabile della sua
responsabilità e incapace di sottrarsi ad essa senza conservare la traccia della sua diserzione.4
Paradossalmente, per Levinas, la passività pone il soggetto anteriormente alla dicotomia
libero/non libero:
L'abbrividire per opera del bene, la passività che è nel subire il bene, è una contrazione più
profonda di quella che si richiede nel movimento delle labbra che la imitano, quando articolano il
sì. L'etica fa qui il suo ingresso nel discorso filosofico, rigorosamente ontologico da principio, come
un'estrema inversione delle sue possibilità. E infatti, proprio muovendo da una passività radicale
della soggettività, siamo potuti giungere alla nozione di una responsabilità più vasta della libertà
(mentre solo la libertà avrebbe dovuto poter giustificare e limitare le responsabilità), di una
ubbidienza anteriore al ricevimento di ordini; movendo da questa concezione an-archica della
responsabilità, l'analisi -- forse per abuso linguistico -- ha nominato il Bene.5
Levinas intende ricondurre il senso alla sua dimensione autentica che è quella pre-originaria: aldilà
della contrapposizione tra libertà e non libertà (versus Sartre) e aldilà -- versus Heidegger -- di una
soggettività tale che: «nella sua esistenza, ne va di mezzo questa esistenza stessa» (Sein und Zeit) o
che, una volta proclamata la fine della metafisica, abita la luminosa radura dell'essere (Lettera
sull'umanismo).
Si tratta di pervenire ad un'ulteriore ulteriorità della soggettività, sfondando le barriere
dell'ontologia che si sono erette sempre più alte per difendere la centralità di un Moi, il quale sia
che lo si pensi nelle vesti cartesiane dell'io penso (dunque io posso), sia in quelle husserliane dell'io
trascendentalistico, sia in quelle sartriane del per sé o in quelle heideggeriane del Dasein o del
pastore dell'essere non ha mai scoperto la sua vera identità, l'identità -- dice Levinas -- di un eletto.
Le Moi è sempre stato sordo a quest'interrogativo, umile e alto come il volto di altri: «Se non
rispondo di me, chi è che risponderà di me? Ma, se rispondo solo di me, sono ancora io?». 6 L'Io
occidentale, con la sua costante brama di autoaffermarsi, ha continuato il suo ritorno a Itaca,
preferendo il conatus essendi all'«Opera», la quale
pensata radicalmente è un movimento del Medesimo verso l'Altro che non ritorna mai al
Medesimo. L'opera, pensata fino in fondo, esige una generosità radicale del movimento che nel
Medesimo va verso l'Altro. E per conseguenza, esige l'ingratitudine dell'Altro. La gratitudine
sarebbe precisamente il ritorno del movimento alla sua origine.7
Levinas non esita ad indicare nella malia autoreferenziale l'essenza stessa della filosofia occidentale
e argomenta:
Anche se la vita precede la filosofia, anche se la filosofia contemporanea, che vuole essere
antiintellettualistica, insiste sull'anteriorità dell'esistenza rispetto alla essenza, della vita rispetto
all'intelligenza, anche se in Heidegger, la gratitudine verso l'essere e l'ubbidienza si sostituiscono
alla contemplazione, la filosofia contemporanea si compiace nella molteplicità dei significati
culturali; e nel gioco infinito dell'arte, l'essere si libera dal peso dell'alterità. La filosofia sorge come
una forma sotto la quale si palesa il rifiuto di impegnarsi nell'Altro, l'attesa preferita all'azione,
l'indifferenza verso gli altri, l'allergia universale della prima infanzia dei filosofi.8
L'uomo, dunque, per Levinas, quale traspare dalle immagini che ne dà la filosofia contemporanea,
non ex-iste autenticamente. Il suo è uno slancio privo di verticalità: nello sforzo continuo di
tematizzare, di farsi, di com-prendere, rimane imbrigliato nell'indeterminato e spettralmente
neutro territorio de il y a. Dà per scontato la socialità, ricavandola analogicamente come Husserl
(ci si riferisce alla nozione di «appresentazione analogica» contenuta nella Quinta Meditazione
cartesiana), percependola luciferinamente come in Sartre, o semplicemente al proprio fianco nel
mondo ('l'essere con') come nell'Heidegger di Sein un Zeit. Ritorna, per Levinas, in questi pensatori
lo stesso paradigma, quello del verbo essere: da lì scaturisce, pur declinandosi in varianti
umanistiche o antiumanistiche, il senso. È proprio contro questa convinzione che si pone l'intero
contributo levinasiano.
L'ontologia è davvero fondamentale? L'egologia e il primato dell'identico schiudono
esaurientemente la significatività ultima, oppure, non costituiscono semplicemente il derivato di
un evento assolutamente stra-ordinario? La pudica signoria del volto che mi convoca e mi invoca,
non stravolge, forse, la coscienza destabilizzandola? Epochizzare la «sincronia» non è forse,
secondo Levinas, l'unico modo per virare aldilà dell'essere e per cogliere nel volto che parla, che
non si manifesta, ma significa dietro la presenza, la pre- originarietà an-archica? Cogliere nella
diaconia l'essere stesso dell'io, nella liturgia la gratuità nei confronti di Altri vuol dire introdurre
uno psichismo anteriore e sempre latente in qualsiasi atto intenzionale, benché sussista mio
malgrado e, proprio per questo, «declinato all'accusativo».
Umanismo dell'altro uomo rappresenta, per così dire, il punto di approdo dell'antropologia
levinasiana: consacrando l'etica come filosofia prima e assegnando al sapere un ruolo secondario e
derivato, costituisce altresì il testo in cui si acutizza maggiormente (non dimentichiamoci Alcune
riflessioni sull'hitlerismo del '34: il destinatario critico è il medesimo) il distacco da Heidegger. Pur
riconoscendogli il merito indiscusso di aver introdotto la differenza ontologica, gli rimprovera il
progressivo abbandono della soggettività che trova il suo acme negli ultimi scritti e le condizioni di
possibilità di questa radicalizzazione già in Sein und Zeit.
In una intervista del 1976 -- e raccolta in Tra noi -- Levinas è molto chiaro in proposito:
In Heidegger la relazione etica, il Miteinandersein, l'essere-con-altri, non è che un momento della
nostra presenza del mondo. Non occupa il posto centrale. Mit è sempre essere-accanto-a... non è
l'approccio al Volto, è zusammensein, forse zusammenmarschieren è [...] non potrei disconoscere
la grandezza speculativa di Heidegger. Ma nelle sue analisi gli accenti sono spostati altrove. Ripeto,
sono analisi geniali, ma cosa significa nella sua teoria della Befindlichkeit la paura per altri?
Secondo me è un momento essenziale: io penso appunto che temere Dio significhi anzitutto avere
paura per altri. La paura per altri non rientra nell'analisi heideggeriana della Befindlichkeit perché
in questa teoria -- molto interessante, della doppia intenzionalità -- ogni emozione, ogni paura è in
fin dei conti emozione per sé, paura del cane ma angoscia per sé. E il timore per l'altro? [...]
Evidentemente può essere interpretato come il timore per sé, con il pretesto che temendo per
l'altro io posso temere di trovarmi nella sua situazione. Tuttavia non è la stessa cosa il timore per
l'altro: la madre che ha paura per il bambino, o anche ciascuno di noi che ha paura per l'amico, che
teme per l'altro. (Ma qualsiasi altro uomo è amico, capisce?). Come, per caso, certi versetti del
capitolo 19 del Levitico che terminano con «E tu temerai Dio», riguardano i divieti di cattiva azione
relativa all'altro uomo. La teoria della Befindlichkeit non è forse troppo sbrigativa qui?9
Ciò che Levinas rimprovera ad Heidegger è il ruolo di com-prensione dell'essere che riserva al
Dasein, in nome di quell'oblio del quale ritiene colpevole l'intera filosofia occidentale. Infatti si
tratta di interrogare un chi, il quale, pur godendo del primato ontico, è relegato al compito di
interlocutore senza interlocutori nella sua Geworfenheit, ma anche capace di ostentare potenza,
triste preludio dell'orrore nazista e dell'adesione del filosofo tedesco al regime -- un errore
imperdonabile, dirà Levinas.
Ma sarà con la Lettera sull'umanismo del '46 che, decretando la sudditanza dell'umano all'essere
neutro, potrà ritenersi compiuta in Heidegger la pressoché totale rimozione del soggetto, per
lasciare il posto all'Ereignis des Seins -- all'apertura dell'essere come evento originario.
Ma l'apertura -- precisa Levinas -non è più l'essenza dell'essere che si apre per mostrarsi, non è la coscienza che si apre alla presenza
aperta e affidata a lei. L'apertura è il denudamento della pelle esposta alla ferita e all'oltraggio.
L'apertura è la vulnerabilità di una pelle offerta, nell'oltraggio e nella ferita, al di là di tutto ciò che
si possa mostrare, al di là di tutto ciò che dell'essenza dell'essere possa esporsi alla comprensione e
alla celebrazione. Nella sensibilità si pone allo scoperto, si espone un nudo più nudo di quello della
pelle che, forma e bellezza, ispira le arti plastiche: nudo di una pelle offerta al contatto alla carezza
che sempre -- persino equivocabilmente nella voluttà -- è sofferenza per la sofferenza dell'altro.10
Si profila, pertanto, una particolare tipologia di umanismo, una nuova immagine della soggettività:
essa è mossa dal desiderio dell'assolutamente Altro, il quale ha lasciato una traccia nel volto senza
forme dell'orfano, della vedova, dello straniero, eleggendomi ad una responsabilità «che non deve
nulla alla mia libertà, è la mia responsabilità per la libertà degli altri».11 È una soggettività che ha
avuto il privilegio di essere stata scelta, che ha ricevuto, in dono, un ordine o, se si preferisce dei
comandamenti:
Si legge nel Salmo 119, 10: «Sono straniero sulla terra; non mi nascondere i tuoi comandamenti»
[...] La differenza tra l'io e il mondo, si prosegue come obbligazione verso gli altri. Eco del dire
permanente della Bibbia: la condizione o -- incondizione -- di stranieri e di schiavi nel paese
d'Egitto avvicina l'uomo al suo prossimo. La differenza che si apre tra l'io e il sé, la non-coincidenza
dell'identico, è una primordiale non-indifferenza riguardo agli uomini.12
L'essenza è squarciata: il soggetto è senza identità, passività che si accresce; l'esistenza non è più un
da farsi in itinere, né la possibilizzazione di ogni possibilità, né lo stare estatico nella Lichtung
dell'essere.
L'Infinito non è più posto tra parentesi, passibile di tematizzazione o da raggiungersi, una volta
pervenuti alla verità dell'essere. Che lo si chiami Dio o Bene -- ma già nominandolo lo si tradisce,
costretti per abuso linguistico a farlo «entrare nel Detto» -- sta in un'anteriorità pre-originaria e
pre-logica aldilà o al di qua dell'essere.
Umanesimo dell'altro uomo è uno scritto in cui Levinas invita a intraprendere un rinnovamento
radicale del pensiero, a partire dalla messa in discussione del primato dell'identico -- abbia esso la
forma del «per sé» sartriano o della Differenza heideggeriana.
Forse proprio in questo, osserva Levinas, errò la filosofia di Atene: audace sì, ma non così
coraggiosa da mettere in discussione, quella che è divenuta una questione incontestabile: la
convergenza tra pensiero ed essere, ovvero il primato dell'ontologia, il misconoscimento dell'altro.
Pertanto l'usurpazione di un posto al sole -- l'autoaffermazione già stigmatizzata da Pascal13 del
conatus essendi -- è divenuta una prassi e la contestazione di questa teoria decisamente respinta e
messa «all'indice». In opposizione a questa sorta di a-priori, Levinas scrive:
Essere o non essere -- è proprio questo il problema? È questa la prima e ultima questione? L'essere
umano consiste davvero nello sforzarsi d'essere e la comprensione del senso dell'essere -- la
semantica del verbo essere -- è davvero la prima filosofia che si impone ad una coscienza?, la quale
sarebbe dall'inizio sapere e rappresentazione, e manterrebbe la propria baldanza nell'essere-per-lamorte?, si affermerebbe come lucidità di un pensiero che pensa fino alla fine, sino alla morte e
perfino nella sua finitudine -- già o ancora buona e sana coscienza che non si interroga nel suo
diritto d'essere -- sarebbe o angosciata o eroica nella precarietà della sua finitudine? Forse che
invece la prima questione non è sollevata dalla cattiva coscienza? La cattiva coscienza -- instabilità
diversa da quella con cui mi minacciano la mia morte e la mia sofferenza -- pone la questione del
mio diritto all'essere che è già la mia responsabilità per la morte di altri, interrompendo la
spontaneità, senza circospezione, della mia ingenua perseveranza.
Il diritto all'essere e la legittimità di questo diritto non si riferiscono in fin dei conti all'astrattezza
delle regole universali della legge, ma in ultima analisi, alla stregua di questa stessa legge e della
giustizia, al per l'altro della mia non-indifferenza alla morte alla quale -- oltre la mia fine -s'espone nella sua stessa dirittura il volto altrui.14
L'interrogativo sul perché l'essere e non il nulla, -- che soggiace tanto all'umanismo sartriano
quanto all'antiumanismo heideggeriano -- viene in Levinas sostituito dal seguente: come si
giustifica l'essere? L'etica è la sola risposta -- e l'umanismo dell'altro uomo la sua deontologia. Ma
questa soggezione della soggettività, la quale nella sua opera si approssima ad altri -- traccia
enigmatica o kenosi divina -- fino a farsi ostaggio e infinizione dell'infinito nella sua insostituibilità
e difficile libertà, non ci prospetta, forse, un'etica della santità? L'inevitabile ritorno al detto, alla
sincronia, al diritto non rischia di violare la purezza del Dire anarchico, riservandogli la disillusa
qualifica di situazione utopica oppure è davvero possibile e pensabile una socialità all'insegna della
saggezza dell'amore? E ancora la risposta che Levinas offre in merito al dibattito tra umanismo e
antiumanismo non ci prospetta, toccando il tema della giustificazione del rapporto ultimo tra etica
e metafisica, la necessità di indagare il rapporto di Levinas con Kant?
2. Un'ascendenza kantiana?
Dio, la morte e il tempo è un testo che raccoglie gli ultimi due corsi ufficiali tenuti da Levinas alla
Sorbona nell'anno accademico 1975-1976. Sono due cicli di lezioni in cui Levinas affronta temi
classici della storia della filosofia: La morte e il tempo, Dio e l'ontoteologia. Un confronto -- o
meglio, un corpo a corpo teoretico -- innanzitutto con Heidegger e Bloch, ma non esentandosi dal
dialogare anche Aristotele, Descartes, Kant, Hegel, Husserl e Fink.15
Il nostro interesse per questo libro nasce dal fatto che nelle sue pagine -- in cui risuona il fascino
della lezione orale -- ci pare si possa sorprendere il senso ultimo della riabilitazione levinasiana
della metafisica in quanto etica -- al di là della stessa lettera del testo, ove apparentemente compare
il concetto di filosofia prima ma non la parola metafisica.
Entriamo in medias res. I passi che più ci interessano sono dove il confronto con Heidegger diventa
una discussione con la sua lettura di Kant, canonizzata nel celebre Kant e il problema della
metafisica.16 Un testo, scrive Levinas, ove l'intera filosofia kantiana è ridotta «alla prima
esposizione radicale della finitezza dell'essere».17
Ma davvero la filosofia kantiana si lascia ridurre in questa sfera d'immanenza? Una domanda ove si
cela una domanda ancor più radicale: la questione dell'essere è davvero, come crede Heidegger e
con lui l'intera tradizione filosofica che pure lui critica, la domanda per eccellenza metafisica? Un
interrogativo che mostra come in Levinas la riabilitazione della metafisica faccia tutt'uno con la
riformulazione della stessa Grundfrage:
E se l'umanità non si esaurisce nel servizio dell'essere, allora dietro all'interrogativo: che cos'è
l'essere?, dietro all'angoscia per la mia morte, non sorge forse la mia responsabilità per l'altro (nella
sua enfasi: la mia responsabilità per la morte dell'altro, la mia responsabilità in quanto
sopravvissuto)?18
Come dire: non la questione dell'essere è alla base dello stupore filosofico, ma la questione che cos'è
l'uomo, che cosa posso fare per lui, nella sua anteriorità ontologica ed etica? E Levinas compie
questo spostamento appellandosi proprio a Kant, versus Heidegger:
Ma dei quattro interrogativi che, ad avviso di Kant, si pongono in filosofia (Cosa posso sapere?
Cosa debbo fare? Cosa ho il diritto di sperare? Che cos'è l'uomo), il secondo sembra superare il
primo di tutta l'ampiezza dei due seguenti. L'interrogativo cosa posso conoscere? porta alla
finitezza, ma cosa debbo fare? e cosa ho il diritto di sperare? si spingono oltre e in ogni caso non
verso la finitezza. Tali interrogativi non si riducono alla comprensione dell'essere, ma riguardano il
dovere e la salvezza dell'uomo.19
Come è possibile un senso senza ancorarsi all'idolo rassicurante dell'essere? Anzi, il senso non ha la
sua radice nel comandamento etico? Con un'audacia ermeneutica tutta rabbinica,20 Levinas
giunge a ritrovare un fondamento per questo suo azzardo teoretico addirittura nella Dialettica
trascendentale kantiana:
Nel secondo interrogativo [Cosa debbo fare?], se lo si comprende formalmente, non vi è alcun
riferimento all'essere. Che il senso possa significare in assenza di un riferimento all'essere, senza
far ricorso all'essere, senza comprensione di un dato essere, è proprio questo, il grande contributo
della Dialettica trascendentale della Kritik der reinen Vernunft.21
Ma questo Kant letto da Levinas non ha una tonalità affatto giudaica? Quasi che per Levinas il
primato del pratico kantiano fosse una variante della dottrina rabbinica del primato dell'ortoprassi,
dei mizwot:22
Kant rimette in questione la finitezza passando al piano pratico. C'è una modalità della
significazione pratica che resta -- a lato dell'accesso teorico all'essere -- accesso a un senso
irrifiutabile, accesso ad una significazione in cui il dopo-morte ha le sue proprie motivazioni. Vi è
indipendenza totale del pratico rispetto all'accesso cognitivo all'essere [...] Tratteniamo dal
kantismo l'idea di un senso che non è dettato da una relazione con l'essere. Non a caso questo
riferimento viene da una morale -- che certamente si dice razionale in ragione dell'universalità
della massima --, non a caso questo modo di pensare un senso al di là dell'essere è il corollario di
un'etica.23
Ma non è paradossale che Levinas sembri legittimare la sua riabilitazione della metafisica in
quanto etica -- in quanto antropologia, essendo la Grundfrage divenuta: Che cos'è l'uomo?, Cosa
debbo fare? -- appoggiandosi alla morale kantiana che, nel suo rivendicare innanzitutto
l'autonomia è sideralmente distante dall'eteronomia dell'etica levinasiana?24 Un paradosso, ci
sembra, apparente. Infatti, l'imperativo kantiano non è una radicalizzazione della Regola d'oro
giudaica? «Non fare al tuo prossimo ciò che detesteresti ti fosse fatto».25 Ma allora: l'eteronomia
dell'etica levinasiana -- il suo fondarsi sul primato dell'Altro: la vedova, l'orfano, il povero -- non è
un compimento di quel che di implicitamente giudaico v'è nella stessa etica kantiana?
In fondo, l'affermazione della metafisica in quanto etica non è un'interpretazione del «non detto»
della stessa Dialettica trascendentale -- nel suo riaffermare l'esigenza dell'oltre metafisico dopo la
distruzione fattane nell'Analitica?26 Appunto, in termini levinasiani, un senso che non s'appoggi
sull'essere ma sul dover essere -- in termini rabbinici: sul fare comandato dai mizwot (i precetti).
Scrive Levinas, nella lezione significativamente intitolata Kant e l'ideale trascendentale:
Ciò che Kant scopre nella Kritik der reinen Vernunft, e in particolare nella «Dialettica
trascendentale», è il fatto che il pensiero, senza per questo cadere nell'arbitrio, ma al contrario
proprio per soddisfare i bisogni della ragione, può non concludere nell'essere. Si tratta delle idee
trascendentali che si occupano «dell'incondizionato (che) rende possibile la totalità delle
condizioni» e mirano a «l'unità sintetica incondizionata di tutte le condizioni in generale» [...] Non
si tratta qui di dilatare la nozione di essere al di là delle cose, ma di porre un interrogativo radicale:
L'umano non è forse altrimenti che essere? L'essere è forse ciò che interessa di più l'uomo?27
Non appare quindi casuale che il seguito di Dio, la morte e il tempo rappresenti una ricapitolazione
delle categorie di Altrimenti che essere, ovvero del testo, dove Levinas ha giustificato le categorie
non ontologiche di una soggettività costitutivamente etica: «La significazione del Dire», «La
soggettività etica», «La soggettività come an-archia», «Libertà e responsabilità», «Lo straordinario della responsabilità», «La sincerità del Dire», «Gloria dell'Infinito e testimonianza»,
«Testimonianza ed etica», «Dalla coscienza al profetismo», «Fuori dall'esperienza: l'idea
cartesiana dell'Infinito», «Un Dio "trascendente fino all'assenza"».
Non sta qui la meta del tentativo levinasiano di partire da Atene per ritrovare le condizioni stesse
della filosofia -- della meta-fisica -- a Gerusalemme? Un cammino che è giunto a ridefinire l'oggetto
stesso dell'interrogazione filosofica: non più «Che cos'è l'essere?», ma «Cosa è l'altro uomo?». Una
ridefinizione che si ripercuote sull'identità stessa della metà tà physikà: è sì ancora un sapere
dell'Oltre, ma in quanto ora l'Oltre è nel volto dell'Altro -- epifania del divino in quanto sguardo di
colui che mi interpella nella sua anteriorità e indeducibilità. In questo senso ci pare che l'impresa
levinasiana metta capo ad un chiasmo -- meglio: ad un circolo rabbinicamente ermeneutico -- tra
etica, filosofia prima e antropologia. Ma non ne va qui dello stesso giudaismo di Levinas? La cosa
stessa del suo pensiero non tocca l'essenza stessa del suo ebraismo?
Note
1.
J.-P. Sartre, L'esistenzialismo è un umanismo, tr. di G. Re Mursia, Mursia, Milano 1990. Su Sartre cfr. S.
Moravia, Introduzione a Sartre, Laterza, Bari 1982.
2.
M. Heidegger, Segnavia, a cura di F. Volpi, Adelphi, Milano 1987, pp. 267-315. Su Heidegger, G. Vattimo,
Introduzione a Heidegger, Laterza, Bari 1980.
3.
J.-P. Sartre, L'esistenzialismo è un umanismo, cit., p. 49. Sulla morale sartriana cfr. le belle pagine di M. Meletti
Bertolini, La conversione all'autenticità. Saggio sulla morale di J.-P. Sartre, Franco Angeli, Milano 2000.
4.
E. Levinas, L'umanesimo dell'altro uomo, a cura di Alberto Moscato, il Melangolo, Genova 1985, p. 105.
5.
Ivi, p. 107.
6.
Ivi, p. 117.
7.
Ivi, p. 63.
8.
Ivi, pp. 61-62.
9.
E. Levinas, Tra noi. Saggi sul pensare-all'altro, a cura di E. Baccarini, Jaca Book, Milano 1998, «Filosofia,
giustizia e amore», pp. 137-156, qui pp. 151-152.
10. Umanesimo dell'altro uomo, cit., pp. 126-127.
11. Ivi, p. 110.
12. Ivi, p. 132.
13. Cfr. l'esergo di Altrimenti che essere o al di là dell'essenza, a cura di Silvano Petrosino e Maria Teresa Aiello, con
una introduzione di Silvano Petrosino, Jaka Book, Milano 1998.
14. E. Levinas -- A. Paperzak , Etica come filosofia prima, a cura di F. Ciaramelli, Guerini e associati, Milano 1989,
p. 59.
15. Per una presentazione analitica dei due corsi, cfr. le penetranti osservazioni contenute nella Introduzione di S.
Petrosino all'ed. citata del testo: pp. 9-37, nonché la Postfazione di Jaques Rolland, pp. 301-315. L'indagine più
analitica sul tema della temporalità in Levinas è contenuta nel breve ma chiarificante saggio di G. Sansonetti,
L'altro e il tempo. La temporalità nel pensiero di Emmanuel Levinas, Cappelli, Bologna 1985.
16. M. Heidegger, Kant e il problema della metafisica, ed. it. a cura di V. Verra, Bari, Laterza 1987. Cfr. G.
Sansonetti, Heidegger e Levinas, Morcelliana, Brescia 1998.
17. Dio, la morte e il tempo, cit., p. 103.
18. Ivi, pp. 102-103.
19. Ivi, p. 103.
20. Sulla particolare ermeneutica levinasiana, nella quale si intrecciano fino a con-fondersi istanze talmudiche e
imperativi più propriamente filosofici, ha scritto pagine molto perspicue Franco Camera, L'ermeneutica tra
Heidegger e Levinas, Morceliana, Brescia 2001.
21. Ivi, p. 104. Cfr. E Levinas, «Notes sur le sens», in Id., De Dieu qui vient à l'idée, Vrin Paris 1992, pp. 231-257;
Id., «Sulla significatività del senso», in Fuori dal Soggetto, ed. it. a cura di F.P. Ciglia, Marietti, Genova 1992.
pp. 93-99, ove si ha una stringente deduzione di come il «volto sia significatività dell'al di là». Quasi che,
potremmo dire, il Volto in Levinas prenda il posto dell'Idea kantiana nell'alludere alla Trascendenza.
22. Cfr., P. De Benedetti, Introduzione al giudaismo, cit., pp. 64 ss.
23. Dio, la morte e il tempo, cit., pp. 104-110.
24. Pagine molto belle sull'etica levinasiana tra autonomia ed eteronomia si possono trovare in E. Baccarini,
Levinas. Soggettività e Infinito, cit., pp. 156 ss.
25. Cfr. P. Ricœur, Tra filosofia e teologia: la Regola d'oro in questione, in «Humanitas» 2 (1995), pp. 269-276.
Sull'etica kantiana in rapporto al giudaismo è da ricordare il classico libro di H. Cohen, Religione della ragione
dalle fonti dell'ebraismo, ed. it. a cura di A. Poma, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 1994. G. Penati, in una
nota alla sua edizione commentata di Difficile libertà (cit., p. 83, n. 15) parla di una stretta vicinanza tra
l'interpretazione levinasiana dell'ebraismo come «etica» e quella di Cohen.
26. Per i problemi connessi al rapporto tra Analitica e Dialettica trascendentale: G. Riconda, Invito al pensiero di
Kant, Mursia, Milano 1996.
27. Ivi, pp. 214- 216.
Emilio Baccarini
La devozione del dire Dio altrimenti
1. La parola Dio e il suo significato
Nella 'Prefazione' a Di Dio che viene all'Idea,1 Levinas delinea il percorso e il metodo filosofico di
una ricerca volta alla possibilità di intendere il termine Dio come significante, concretezza
fenomenologica che prescinde dalla questione della sua esistenza, dall'assenso o meno dell'uomo e
dal senso stesso di questa alternativa. E poiché l'oggetto di studio è la 'parola' Dio, la metodologia
prescelta è quella fenomenologica che indaga la sedimentazione del senso nella coscienza
osservando cosa vi accade in relazione a tale parola. La descrizione delle circostanze
fenomenologiche, della loro congiuntura positiva e della 'messa in scena' di ciò che si dice in forma
di astrazione, opera una ridefinizione della fenomenalità oltre la datità. In tale descrizione si cerca
infatti un tipo di concretezza che non coincide affatto con l'esistenza del 'contenuto Dio'.
Da qui la complessità dell'indagine levinasiana: se cum capio è prendere-con, il concetto nella
comprensione, è davvero possibile pervenire a una conoscenza di Dio? Se inoltre l'infinitezza
confina ogni attività della coscienza nell'impossibilità del suo stesso esercizio, forse anche il
'termine' Dio finisce per annullarsi nell'assenza di ogni significanza? E, in ultimo, come poterlo
pensare ancora oltre il registro della percezione e della coscienza, ovvero entro un orizzonte diverso
dal sapere ontologico da sempre volto a una totalità che riduce l'altro all'identico? È cioè possibile
un pensiero altro, al di qua dell'assimilazione e della integrazione, che non riconduca al già
conosciuto l'assoluto nella sua novità smarrendolo nella continuità della totalizzazione?
Entro l'orizzonte tradizionale del pensiero, interamente risolto tra esperienza e conoscenza, la
novità resterebbe l'alterità dell'assoluto esposta nella totalizzazione del sapere. Ma è qui che
Levinas pone una questione radicale chiedendosi se davvero non possa esistere, sotto il regime del
pensiero, qualcosa di diverso dalla conoscenza e dall'esperienza. Sarebbe questo un sapere
altrimenti, capace di accogliere la novità dell'assoluto senza ridurlo all'assimilazione o
all'integrazione; un pensiero che, oltre la tradizionale corrispondenza tra noesis e noema, stabilisca
tra soggetto e oggetto una «relazione senza correlativi», una relazione assolutamente paradossale,
dove cioè, secondo l'intento fenomenologico è oltrepassato il momento dossico. Tra l'atto della
coscienza e il suo contenuto vi è infatti tutta l'eccedenza dell'idea di Dio, dato che non si può
parlare di Dio né come soggetto né come oggetto di conoscenza, eccedenza che, sfuggendo
all'adeguazione del visibile e alla mira intenzionale, rende illegittime le stesse metafore di visione e
intenzione.
Levinas procede gradualmente attraverso questa proliferazione di domande, spesso riannodate nel
punto di inizio, entro la consapevolezza che sempre «le questioni relative a Dio non si risolvono con
delle risposte in cui l'interrogazione cessa di risuonare, in cui si placa pienamente».2 La questione
cruciale, etica e quindi teoretica, riguarda proprio questa presa di coscienza che implica, già
nell'atto di afferrare e ap-prendere l'oggetto, la sua riduzione all'immanenza entro l'appercezione
trascendentale dell'Io penso. Ma come dire Dio altrimenti, spostandosi al di là della conoscenza
come 'determinazione', senza inabissare la parola in un sordo, perché vuoto, flatus vocis?
Ma che si può cercare di diverso dalla coscienza e dall'esperienza -- di diverso dal sapere -- sotto il
regime del pensiero, affinché accogliendo la novità dell'assoluto, esso non la spogli della sua novità
proprio in nome del suo stesso accogliere? Quale è questo pensiero altro -- né assimilazione, né
integrazione -- che non ricondurrebbe al 'già conosciuto' l'assoluto nella sua novità e non
comprometterebbe la novità del nuovo facendolo appassire nella correlazione tra pensiero ed
essere che il pensiero instaura? Sarebbe necessario un pensiero che non sia più costruito come
relazione che collega il pensatore al pensato oppure sarebbe necessaria, in questo pensiero, una
relazione senza correlativi, un pensiero non-costretto alla rigorosa corrispondenza tra ciò che
Husserl chiama noesi e noema, non-costretto all'adeguazione del visibile alla mira intenzionale alla
quale esso risponderebbe nell'intuizione della verità; sarebbe necessario un pensiero in cui non
fossero più legittime le metafore stesse di visione e di intenzione.3
È questa la possibilità di un pensiero radicalmente altro. La sua formulazione deve poggiare
sull'idea-di-Infinito-in-noi che solo da Dio può provenire, tanto è al di là dei limiti produttivi del
pensiero umano. Contrariamente alle idee che, sempre a misura dell'oggetto intenzionale
(ideatum), hanno presa su di esso, e contrariamente alle idee per le quali il pensiero coglie
progressivamente il mondo, tale idea di Infinito, già in Descartes, eccede la stessa possibilità del
cogito.
Nell'esperienza quotidiana, l'affermazione della finitezza presuppone una capacità di misurazione
in cui il finito stesso non sia misura di sé. Allo stesso modo possiamo dire che una cosa è imperfetta
solo se la rapportiamo, realtà o concetto che sia, con una possibile idea di perfezione che proviene
da molto lontano. Nel nostro intelletto l'idea di infinito, in senso matematico, si sviluppa come idea
negativa del non-finito, svincolata da un possibile oggetto infinito posto a contenuto dell'atto in cui
diviene tale. Eppure Levinas riflette sull'ideatum coniugando, nel suo pensare Dio, un cogitatum
eccedente le stesse capacità della cogitatio tra impossibilità della determinazione e capacità di
pensare più di quanto si pensi. In apparenza siamo di fronte a una contraddizione poiché o il
pensato è commisurato all'attività del pensiero o è la stessa possibilità del pensare a venirne
preclusa. È però l'eccezionalità e l'eccedenza del termine Dio a interrompere la correlazione
intenzionale, in modo che lo stesso riempimento della cogitatio non trovi più legittimazione
neppure nelle metafore della visione e dell'intenzione.
Una provocazione etica e teoretica, questa di Levinas, in cui l'idea di Infinito nella relazione a-Dio
che è pura pazienza si affida alla passività della de-ferenza del soggetto. Ed è proprio questo il
pensiero più profondo cui pervenire, il modo originario di essere in quanto essere votato all'altro,
assoluta non-coincidenza e nuda devozione senza attesa di ritorno.
Ma cosa significa realmente pensare al di là di ciò che si pensa?4 Se il pensato non è commisurato
all'attività del pensiero, siamo infatti dislocati fuori da tale atto e la stessa idea dell'Infinito viene
«de-portata, non potendo sfociare, non potendo arrivare ad un fine, a nulla di finito».5 Il pensiero
svincolato dalla fase della coscienza -- ma non nel senso psicologico di un'involuzione
nell'inconscio -- si volge verso il dis-interessamento che, come relazione senza influsso su un essere
né anticipazione d'essere, si configura come pazienza e de-ferenza oltre ciò di cui ci si prende
carico.
Diacronico è l'Assoluto che si situa oltre la sincronia della conoscenza: mai stato presente, mai
rappresentato nel passato e mai lo potrà essere nel futuro. Ciò che non è possibile presentare, ciò di
cui non c'è memoria, appartiene a un passato che mai potrà tornare in presenza, è, per definizione
immemoriale. In tale diacronia del tempo è la pazienza il pensiero più profondo del nuovo,
anteriore a ogni attività della coscienza e gratuito come una devozione che sarebbe già rinnegato
nella sua trascendenza quando ci si ostinasse a creare nella sua dia-cronia e nella procrastinazione
non l'eccedenza -- o il Bene -- della gratuità e della devozione, ma un'intenzionalità, una
tematizzazione e l'impazienza di un afferrare.6
A-Dio: presenza dell'Infinito in noi, presenza che accade -- ancora la pazienza, la passività -- nella
relazione con l'altro uomo nella piena diacronia e asimmetria della sua trascendenza. Quando il suo
volto parla del comandamento venuto non si sa da dove.
Esistere significa allora 'essere votati' come 'devozione' a-Dio e responsabilità radicale verso l'altro,
senza preoccupazione di reciprocità, perché qui Dio esce dalla sua idea ed entra nella concretezza
dell'esistenza. Dal punto di vista originario l'io si trova inserito da sempre entro questa dinamica,
prima di qualsiasi scelta, in modo che la stessa libertà diviene un'investitura7 alla responsabilità
che viene dall'altro. Si opera così un ribaltamento della coscienza che significherà la ridefinizione
dell'identità dall'essere se stesso all'autre dans le même o pour l'autre homme e da qui a-Dio. In
prospettiva teoretica Levinas compie qui una rigorosa indagine sulla struttura formale della
soggettività per deformalizzarla in favore del valore del monoteismo, ovvero del Dio biblico che,
come Assoluto, non lascia spazio ad altre rappresentazioni. Il volto dell'altro, infatti, diviene
comandamento etico non perché visione ma perché visitazione dell'assolutamente Altro. L'idea
dell'Infinito garantisce così anche l'esteriorità quale impossibilità, ontologica e gnoseologica, di
ricondurre l'alterità alla totalità. Procedendo dall'indagine fenomenologica della coscienza si
approda così alla sua messa in discussione nella 'riduzione' alla veglia, affezione subita dall'io che
rimanda a un'alterità rispetto alla stessa identità di Dio.
Husserl rimprovera a Descartes d'aver riconosciuto con precipitazione, nel cogito, l'anima, cioè una
parte del mondo, mentre il cogito condiziona il mondo. Parimenti potremmo contestare questa
riduzione all'ontologia del problema di Dio, come se l'ontologia e il sapere fossero l'ultima ragione
del senso. Nella struttura straordinaria dell'idea dell'Infinito, l'a-Dio non significa forse un intrigo
spirituale che non coincide né col movimento segnato dalla finalità, né con l'auto-identificazione
dell'identità, tale che essa si de-formalizzi nella coscienza di sé?8
Levinas ha dunque recuperato da Descartes l'idea dell'Infinito rielaborandola dentro la prospettiva
fenomenologica e precisandola come deformalizzazione della coscienza in imperativo morale,
passaggio dall'orizzonte teoretico a quello preliminare dell'etico, un etico che, proprio per la sua
preliminarità, prenderà il posto non del dover essere, bensì quello dell'essere e, quindi, si proporrà
come 'filosofia prima'. La deformalizzazione è infatti il processo in cui l'idea di Dio si svincola
dall'orizzonte teoretico per abbracciare quello etico divenendo imperativo morale nei confronti di
chi è a noi prossimo. Anche l'altro è infatti deformalizzato e in tal senso sfugge alla possibilità di
essere oggettivato da un pensiero che lo com-prenda nella neutralizzazione dell'alterità nel
medesimo. Tale manifestatività significò per Levinas, almeno fino al 1961, con Totalità e Infinito, la
tutela dell'esteriorità dell'altro: legato all'Infinito, il volto altrui non è ricondotto né alla totalità
dell'essere né all'intenzionalità di un atto conoscitivo. Esso è sempre al di là del conoscibile e al di
là del dicibile.
L'idea dell'Infinito 'accade' nella concretezza di una relazione interpersonale in cui il soggetto,
sconvolto dall'interpellanza etica del volto altrui, in forza dell'estraneità che parla di un
comandamento, risponde nella forma della socialità. Non si tratta qui di una responsabilità
contratta mediante un'esperienza storica, poiché l'esperienza dell'Infinito, esperienza sui generis
non è mai stata presente, né mai lo sarà. Essa è piuttosto il modo d'essere costitutivo e originario
del soggetto umano che, da sempre responsabile dell'altro, sempre è in ritardo sulla personale
responsabilità. Non sono infatti io a poter scegliere, io che resto passivo davanti all'epifania del tuo
volto.
La fenomenologia dell'idea dell'Infinito in me, in tal senso, accade in quella relazione con l'altro
che infine è la mia stessa relazione a-Dio, passaggio compiuto da Dio stesso perché il Dio-cheviene-all'idea è la sua stessa vita.
Ma come se il volto dell'altro uomo, che d'improvviso 'mi interpella' e mi ordina, fosse il nodo
dell'intrigo stesso del superamento da parte di Dio dell'idea di Dio e di ogni idea in cui Egli sarebbe
ancora preso di mira, visibile e conosciuto e in cui l'Infinito sarebbe smentito dalla tematizzazione,
nella presenza o nella rappresentazione. Non è nella finalità di una mira intenzionale che io penso
l'infinito.9
Nella cultura biblica, ebraica e cristiana, il volto dell'altro è stato da sempre riconosciuto come
luogo privilegiato del riflesso di Dio, Sua immagine e somiglianza. Soltanto in questa accezione il
termine immagine lo troviamo riferito a Dio in modo diretto e non velato, in virtù del fatto che
soltanto l'uomo sembra esserne l'immagine legittimata. E Dio non chiede soltanto di essere
contemplato nella sua assoluta bontà ma ci sollecita anche alla responsabilità etica per l'altro
uomo. La libertà umana si dispiega così come l'investitura a una responsabilità giunta dall'altro,
come già in Totalità e Infinito, nel rovesciamento della soggettività che è ribaltamento della
coscienza. L'appello e la responsabilità segnano l'eccedenza di un pensiero che pensa più di quanto
pensi, prima ancora di riconoscere che anche l'altro è originariamente votato a me, poiché qui vi è
una
responsabilità senza preoccupazione di reciprocità: devo rispondere di altri senza occuparmi della
responsabilità d'altri al mio riguardo. Relazione senza correlazione o amore del prossimo che è
amore senza eros. Per-l'altro uomo e da qui a-Dio!10
Il ribaltamento della coscienza stravolge dunque l'identità: dall'essere se stessi si passa all'essere
per l'altro e da qui a-Dio, trasformando l'io-nominativo nel sé-accusativo, ovvero da sempre
'accusato'poiché il chi interpellato è un soggetto da sempre responsabile. Il Dio infinito non lascia
spazio a rappresentazioni che non siano il volto dell'altro: questi solo è la Sua icona, ogni altra
rappresentazione costituisce idolatria. Il volto dell'altro che all'improvviso mi interpella è il nodo
dell'intrigo, del superamento da parte di Dio dell'idea stessa di Dio nella concretezza della Sua
presenza.
La deformalizzazione della soggettività riabilita il valore del monoteismo contro le varie forme di
fondamentalismi religiosi, garanzia dell'esteriorità dell'altro -- a cui rimanda il sottotitolo di
Totalità e Infinito, 'Saggio sull'esteriorità' -- contro la riduzione totalizzante del suo volto a un atto
conoscitivo. Abbandonato l'orizzonte ontologico e prima di approdare a quello teoretico, il
comandamento etico diviene la radicale messa in questione dell'io a partire dalla sua struttura
originaria.
2. La pazienza dell'Infinito: vegliare sul prossimo
La riduzione trascendentale è la modalità teoretica in grado di destare il soggetto da un
atteggiamento naturale a quello fenomenologico, presupposto essenziale di quello personale, etico
e trascendente. Se il passaggio allo stato di veglia non provenisse dall'oggetto, l'io cosciente
continuerebbe infatti ad affermare la centralità dell'io.
L'idea di una passività originaria della coscienza conduce Levinas, contro l'interpretazione
freudiana dell'inconscio, a mantenere l'io sempre distinto dal contenuto dei propri atti, mai
disperso nella mera fatticità dell'esistenza. Il sonno, e il referente oggettivo di cui è segno, è infatti
definibile solo in rapporto alla veglia perché soltanto in sé è racchiusa, da sempre, la possibilità del
risveglio. Allo stesso modo dobbiamo ritenere che l'idea infinita non possa essere abbracciata
dall'intenzionalità della coscienza, poiché mai può divenirne contenuto. Nessun uomo può
avanzare la pretesa di conoscere altri secondo la modalità dell'oggettivazione e della riduzione
all'identico: l'alterità è infatti la prima manifestazione dell'idea infinita che rivela il volto dell'uomo,
non solo come immagine di Dio, ma come 'traccia'.11 È perché il soggetto conoscente non può
circoscrivere con l'intenzionalità l'altro uomo, ovvero non può avere verso questi una coscienza
attiva, che la sua passività diviene la condizione di possibilità dell'ascolto, del mutuarsi dell'io in un
sé capace di accogliere il volto altrui come provocazione etica alla risposta.
Il metodo fenomenologico permette a Levinas di risalire agli elementi pre-intenzionali della
coscienza oltre l'indagine husserliana delle strutture pre-categoriali, ancora legate alla modalità
teoretica dell'adeguazione dell'oggetto al soggetto conoscente.12 Non è infatti possibile alcuna
riduzione del volto altrui poiché questo è concreta manifestazione dell'Infinito. Mediante l'epochè
riferita alla coscienza ci spostiamo dal piano gnoseologico dell'essere a quello altrimenti della
veglia, soglia in cui il custode è tenuto sveglio da qualcosa d'altro di cui egli stesso è responsabile.
La riduzione trascendentale permette così di ridefinire la coscienza dislocandola dall'essere in sé
all'essere liberata da sé. Se l'idea dell'Infinito sfugge all'intenzionalità è infatti necessario
dimostrare l'esistenza di qualcosa che sia oltre l'intenzionalità stessa: il pre-intenzionale custodisce
il senso della parola Dio. Nel saggio Dalla coscienza alla veglia a partire da Husserl, del 1974, il
risveglio viene descritto come una non permanenza nel Medesimo, un non-stato che mette in
questione il soggetto disubriacandolo dalla presunzione di essere assoluto.
Il risveglio è l'io che dorme e non dorme per il quale accade tutto ciò che, nell'immanenza stessa,
accade; cuore risvegliato, non-essente, non-stato nella profondità degli stati d'animo somigliantisi
nella propria identità, insonnia o battito nell'ultimo recesso dell'atomo soggettivo.
Questa vigilanza dell'io che viene dagli abissi della soggettività che trascende la propria
immanenza, da questo de profundis dello spirito, questa esplosione nel cuore della sostanza, questa
insonnia, in Husserl, si descrive certamente come intenzionalità. L'io-in-veglia, veglia sull'oggetto,
resta attività oggettivante anche nella propria vita assiologica o pratica. La disubriacatura del
risveglio qui dipende dall'alterità dell'oggetto, dall'urto del reale.13
Il modo in cui Levinas legge Husserl nel passaggio dalla coscienza alla veglia entro il processo di
identificazione -- riconduzione dell'alterità nell'identità -- o più in generale dell'intenzionalità,
segna anche il passaggio dall'ordine teoretico a quello etico. Il dato più rivelante dell'indagine
levinasiana è infatti il fondamento etico a partire dal quale la domanda non può più essere
omologata entro una quantificazione universalizzante, entro una filosofia della totalità.
Nell'indagine levinasiana la riflessione sulla soggettività non procede, diversamente da Husserl, dal
'fatto' della coscienza, ma dalla domanda sulla stessa fatticità del fatto, di derivazione
heideggeriana. Tale ontologia della fatticità rinvia alla passività quando, entro l'attività
intenzionale della donazione di senso o attività riflessiva della coscienza, si riconosce il preintenzionale come insonnia o l'altrimenti che essere. L'identità non è infatti pensata come
adeguazione di sé con se stessa, piuttosto appare sproporzionata rispetto a sé, lacerata da una
presenza che «lo avvolge come se dell'Infinito si potesse avere un'idea, cioè come se Dio potesse
stare in me».14 Come se [als ob] è la sproporzione testimoniata dalla presenza in me dell'idea
dell'Infinito, prima della tematizzazione che attesta «un-'di più'-risvegliante-nello-stesso-tempoun-'di meno'-che esso scompiglia o ispira»,15 secondo questa nuova definizione dell'identità.
Mentre la coscienza è la presenza del soggetto a se stesso, l'insonnia è infatti il soggetto che ha
perduto tale padronanza di sé perché tenuto sveglio da una dimensione altra che lacera o ispira
l'immanenza, comportando una duplice 'inadeguazione'del soggetto rispetto all'identità con sé e
con ciò che lo trascende. Tale trascendenza è quel come se, quel più che abita un meno che sveglia
la coscienza al di là di sé rinviandola a una sproporzione o suscezione dell'Infinito.
La passività rinvia così a una diacronia non sincronizzabile, ovvero a un passato non
sincronizzabile che possiamo anche intendere come veglia senza intenzionalità. In tal senso la vera
libertà sarà non tanto un 'libero in sé' quanto un 'libero da sé' che prorompe nell'incontro con
l'altro, ovvero nella radicale responsabilità etica per l'altro uomo. Quando, nella dimensione del
non-intercambiabile (la sostituzione etica dove l'io si fa carico del tu senza prenderne il posto) nella
stessa condizione di 'ostaggio', a cui si spingerà Altrimenti che essere, io sono unico ed eletto.
Il volto dell'altro non è infatti interno all'orizzonte della fenomenicità perché esso stesso non è un
fenomeno, non appartiene cioè all'ordine della rappresentazione e della conoscenza.
Chiediamo se la ragione, sempre ricondotta alla ricerca del riposo, dell'appagamento, della
conciliazione -- implicando sempre l'ultimità o la priorità del Medesimo -- non si assenti, già
attraverso questo, dalla ragione vivente. Non che ragione equivalga alla ricerca di una uguaglianza
con sé -- di una adeguazione a sé -- che sarebbe migliore dell'adeguazione già raggiunta. Contro
questo romanticismo superato e ingiustificabile, come quello che preferisce la guerra alla pace, il
classicismo della pienezza è bello nella sua lucidità. Ma noi chiediamo se la lucidità -- perfezione
del conoscere -- è la veglia più desta; anche se bisognerebbe confessare che la vigilanza stessa
chiede di essere riconosciuta con lucidità; noi chiediamo se la veglia è una nostalgia dell'uguale e
non una pazienza dell'Infinito; chiediamo se di conseguenza, come vigilanza e veglia, la ragione
non è lo scompiglio del Medesimo da parte dell'Altro -- risveglio che si scrolla dallo stato di veglia -scompiglio del Medesimo da parte dell'Altro nella differenza che, precisamente non-indifferenza,
non si presta alle avversità e alle riconciliazioni nelle quali la comunità, per quanto formale essa
sia, scatena il movimento dialettico.16
La peculiarità della riflessione levinasiana è proprio in questo indagare su un termine
fenomenologicamente significativo -- l'idea dell'Infinito -- accogliendo il trascendente quando si
manifesta nell'elaborazione dei limiti della coscienza. Contro l'idealismo, incapace di ammettere
una coscienza che non sia immediatamente adeguazione con se stessa, Levinas scava nella fatticità
della coscienza pervenendo al pre-intenzionale che è presenza non-intenzionale entro la coscienza.
Nel passaggio al prossimo, infine, la ridefinizione della soggettività come pour l'Autre comporta la
liberazione da se stessa per l'idea dell'Infinito che implica la sacralità dell'Altro. Anche Husserl
procedeva da qui per descrivere la soggettività trascendentale che sradica l'Io dal suo isolamento
nel sé, ma in tale riduzione continuava a pensare la relazione tra Dio e l'altro in termini di
conoscenza. In fondo la fenomenologia husserliana dell'intersoggettività resta di natura
squisitamente teoretica; anche la dottrina dell'alter ego, nella quinta meditazione cartesiana, si
volge alla possibilità di conoscere l'altro entro l'apoditticità della 'riduzione'.
Mai la filosofia, partendo dalla presenza dell'essere, se ne risveglierà o ne dirà il risveglio in termini
diversi da quelli del sapere, mai ridurrà il sapere dell'ontologia ad una delle modalità del risveglio
in cui già si configurano modalità più profonde; mai penserà la veglia -- e il risveglio in cui la veglia
vive -- come Ragione senza intenderla nella conoscenza, senza ridurre alla manifestazione del
senso la sua stessa significanza. Risvegliarsi dalla presenza e dall'essere significherà, per essa, una
avventura dello spirito solo come profusione di immagini in libertà, poesia o sogni, ebbrezza o
sonno.17
Rivendicando il valore dell'eteronomia etica contro quella autonomia che la tradizione filosofica ha
scelto a fondamento della moralità, come la normativa kantiana, Levinas si impegna dunque per
una nuova definizione della soggettività. Qui ritroviamo la stessa difficoltà di esprimersi in un
modo altro dall'ontologia che ritroviamo in Altrimenti che essere o al di là dell'essenza, opera
pubblicata nello stesso anno 1974. Al centro vi è sempre l'idea dell'Infinito che resta una
concretezza, eccedente e diacronica ma mai vuota come l'essere neutro heideggeriano. In tal senso
la vita non è affatto un'estasi ma un entusiasmo, una veglia sospinta nella veglia di un nuovo
risveglio fino alla categoria biblica del santo. Nella fede ebraica, e qui il riferimento a Rosenzweig è
esplicito, la santità è infatti l'espressione dell'essere per l'altro mosso dal suo essere in sé di fronte
a Dio.
La prospettiva ebraica di Rosenzweig è assunta da Levinas, nel passaggio dal mistico al santo, entro
la ridefinizione dell'in-sé del soggetto nell'essere-per-l'altro. Poichè mai il mistico realizza
pienamente l'umano. In certo senso è il volto dell'altro l'espressione della possibilità profetica
realizzata nella risposta-responsabilità alla sua presenza, in quell'«Eccomi» che fa del soggetto
l'unico, l'eletto. Nella ridefinizione levinasiana della prossimità Dio diventa così la possibilità del
risveglio nella visitazione-evento del volto dell'Altro traccia di Dio.
Ancora una volta l'idea dell'Infinito e il volto, come metafisica dell'evento, presentano assonanze
poiché se l'uomo è imago Dei allora non rimanda a Dio ma è la traccia di Dio. A partire dalla
sproporzione dell'idea dell'Infinito, eccedenza che incrina il potere oggettivante della ragione, si
dischiude infine il desiderio come aspirazione senza teleologia, anelito a un oltre mai raggiungibile.
A partire dal pre-intenzionale, non dal pre-categoriale, è il volto altrui che paradossalmente diviene
l'oggetto di una indagine fenomenologica priva di oggetto: esso è la pura esteriorità non
riconducibile neppure all'interiorità. La sua torsione fenomenologica, da cui si sviluppa Altrimenti
che essere o al di là dell'essenza, procede dal riconoscimento etico dell'ulteriorità dell'altro che da
sempre eccede l'ordine conoscitivo e di fronte a cui sono sempre in ritardo.
3. Verso un modo altro di dire Dio
Il saggio Dio e la Filosofia,18 affronta la questione del rapporto tra Dio e la ragione filosofica
ricorrendo all'idea dell'Infinito nell'uomo (mutuata, come si è detto, da Descartes e rielaborata
nella 'Prefazione' dell'opera Di Dio che viene all'idea). Dopo aver contestualizzato le diverse
occasioni in cui il contenuto del testo era già stato presentato, Levinas si avvia verso una teologia
fondamentale per dire Dio altrimenti volgendosi infine all'idea di Desiderio e di Bene.
Il primo passo è il riconoscimento che non è possibile andare al di là del pensiero, secondo la
citazione aristotelica posta ad apertura del primo paragrafo: «Non filosofare, è ancora
filosofare».19 Il logos non si è infatti mai fermato alla mera descrizione del reale ma da sempre
ambisce alla comprensione ultima che sappia rendere ragione delle cose. Ogni pensiero, anzi l'atto
stesso del pensare, è in tal modo costretto dalla stessa filosofia a giustificarsi dinanzi a essa, alla sua
pretesa di essere scienza delle cause prime.
La pretesa filosofica alla totalità risale all'equivalenza parmenidea di essere e pensiero. L'essere, e
qui Levinas pensa ad Heidegger, non è il neutro ma la sua verbalità che rinvia alle gesta d'essere
presenti nelle sue differenti manifestazioni. Tale verbalità non è soltanto il suo contenuto, piuttosto
è l'anima della vita del pensiero tale che, oltre le gesta d'essere, non ci sarebbe nulla oltre la
coincidenza dell'essere con il suo accadere. È questa perfetta coincidenza a stabilire che nulla sia
pensabile al di là di ciò che modifica una preliminare appartenenza alle gesta d'essere. Non è
pertanto il pensiero a rischiarare l'essere, piuttosto è questo a costituire la luce del pensiero.
La riflessività del verbo -- tra phainomai e logos -- ci dice, infatti, come l'essere, pure non
apparendo, nel suo mostrarsi permette al fenomeno di lasciare apparire l'essere stesso
manifestandolo. La radura, la luce che filtra nel fitto bosco illuminandolo (Lichtung), ci porta
molto lontani dall'idea kantiana che siano le categorie a costituire la luce del fenomeno. Anche la
conclusione cui perviene Heidegger è però distante dal percorso di Levinas: 'mostrarsi' e
'illuminarsi' sono infatti verbi riflessi e non dovrebbero condurre a un'idealizzazione trascendentale
ove il senso è generato dal soggetto conoscente. Husserl insegnava che era ancora l'oggetto, colto
nel suo mostrarsi come contenuto della coscienza, a generare il senso mentre la coscienza non
creava ma semplicemente rivelava il suo contenuto. Soltanto in questo diverso orizzonte,
'mostrarsi'e 'illuminarsi'possono avere senso, dal momento che non può mostrarsi ciò che senso
non possiede. Il gesto d'essere, riferibile alla categoria dell'intelligibilità, ha infatti una intelligibilità
che concerne l'essere e non il pensiero generato dall'incontro con un soggetto intellettuale.
Ma se la filosofia -- la ragione -- manifesta ciò che ha un senso, e Dio ha un senso, possiamo
dedurre che la filosofia manifesti Dio? In quanto pensato, infatti, Dio è portato entro le gesta
d'essere divenendo un prodotto dell'essere, un ente o, al massimo, un suo sinonimo. Siamo ormai
distanti dal Dio biblico che, non riducibile a un'idea, né vera né falsa, significa come assolutamente
trascendente, al di là dell'essere e dell'essere pensato. La storia della filosofia occidentale ha così
operato la distruzione della trascendenza e nel suo compendio, nella logica o filosofia dello Spirito
di Hegel, non resta che l'immanenza e la deportazione della trascendenza al di là dell'essere e
dell'essenza. Da qui l'urgenza del pensiero di Levinas volto a individuare un altrimenti di essere
che, nel legame essere-conoscere, diviene un altrimenti che sapere e altrimenti che conoscere.
Tutto ciò che è può essere conosciuto e detto ma entro un processo in cui l'immanenza resta una
legge interna poiché, il conosciuto, è tale soltanto entro un atto del conoscere. Tutto ciò che è
conosciuto è infatti comprehensum, abbracciato dall'intelletto e da questo limitato.
La teologia razionale, aspirando a dire qualcosa di Dio entro l'orizzonte razionale, si esprime
mediante avverbi come 'eminentemente' o 'per eccellenza'; nel passaggio alla domanda radicale
quid Deus sit non è però più in grado di fornire alcuna risposta. In ultimo non resta che il ricorso
all'analogia dell'eminenza anche se il concetto di Dio continua a restare vincolato all'ontologia e
all'orizzonte razionale: il tema, in quanto contenuto del discorso, rimanda sempre a qualcosa di
argomentabile.
La filosofia non può oltrepassare le sue possibilità.
La pensabilità del Dio trascendente sembra infatti soggiacere, nella tradizione filosofica
occidentale, a una angusta alternativa tra la sua riduzione all'immanenza -- onticizzazione e
gnoseologizzazione -- e la sua riduzione all'assurdità nella negazione della sua stessa pensabilità.
In realtà già Kant aveva affermato l'impossibilità di una formulazione teoretica del concetto di Dio,
salvo poi recuperarlo nella sua indagine sulla Ragion pratica. Sostenere, con M.me Delhomme, che
«il concetto di Dio non è un concetto problematico, non è affatto un concetto»,20 è ancora
rifiutare, per la tesi che quod est reale est etiam rationale e viceversa,21 la stessa trascendenza del
Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe.
Ciò che la Bibbia eleva al di sopra di ogni comprensione non avrebbe ancora raggiunto la soglia
dell'intelligibilità!
Il problema che di conseguenza si pone e su cui ci concentreremo consiste nel domandarsi se il
senso equivale all'esse dell'essere, cioè se il senso che in filosofia è senso non sia già una restrizione
del senso, se non sia già una derivata, o una deriva del senso, se il senso equivalente all'essenza -alle gesta dell'essere, all'essere in quanto essere -- non sia già accostato all'interno della presenza
che è il tempo del Medesimo; supposizione che può giustificarsi solo tramite la possibilità di risalire
a partire da questo senso, che si presume condizionato, ad un senso che non si direbbe più in
termini di essere, né in termini di ente.22
Al di là della riduzione all'immanenza o all'assurdità Levinas rinviene la possibilità di un senso
altro rispetto all'equivalenza tra essenza e senso. Nel tempo del medesimo, che è quello della
presenza, della conoscenza e della rappresentazione, non è infatti possibile un'idea di Dio perché
mai Dio è stato presente ad alcun atto del soggetto conoscente. E la filosofia insegna che noi
possiamo conoscere soltanto l'oggetto che è stato presente al soggetto, ovvero nella presenza che è
lo stesso tempo del medesimo, dell'identificazione e della vittoria sulla resistenza dell'oggetto
mediante l'adeguazione. Il senso di Dio non è pertanto dicibile in termini di essere o di ente,
piuttosto bisogna individuare una modalità altra dalla correlazione tra soggetto e oggetto nel
presente e nella rappresentazione. Questa, infatti, tra ri-presentazione di ciò che è stato presente e
rappresentazione (Vorstellung) come frequentazione della presentazione, è strutturata in modo
tale da escludere Dio come sua interna possibilità.
Senza volgerci verso una apofatica indicibilità di Dio e senza rinunciare alla ragione filosofica,
Levinas ci sollecita a cercare se oltre l'essere non si mostri un'intellegibilità preliminare allo stesso
essere, verso una sua modalità che sia altrimenti che essere. Ogni atto di conoscenza, per
definizione, si compie infatti nella riduzione dell'esteriorità all'immanenza dello stesso atto
conoscitivo, senza poterne mantenere la trascendenza come tale. Di Dio non è infatti dato il
concetto.
La stessa trascendenza non ha intelligibilità, soltanto può essere colta nel presente della coscienza e
quindi divenire immanente. Abbandonare la via dell'episteme non conduce necessariamente al
regno della doxa o della pistis, che ancora parla il linguaggio dell'essere, quanto a
dubitare dell'opposizione formale stabilita da Yehuda Halevi e ripresa da Pascal tra il Dio di
Abramo, Isacco e Giacobbe da una parte, Dio invocato senza filosofia nella fede, e il dio dei filosofi
dall'altra: è dubitare che questa opposizione costituisca un'alternativa.23
In realtà un discorso su Dio richiede una permanenza nella trascendenza. La dialettica
trascendentale di Kant ci suggerisce la trascendenza come differenza, la cui figura è un'isola che
vive della sua distinzione dall'oceano e che a tale infinità di distinzione pure la ragione ancora
desidererebbe volgersi.24 Entro il recinto delle possibilità intellettive, nei confini protetti ma
angusti dell'isola, le determinazioni intellettuali sono possibili finché non anelano alla fonte,
spingendosi verso quell'incondizionato che non abita l'isola.25 Ma l'incondizionato dell'oceano, che
pure è fondamento del teoretico, è ancora al di là del teoretico.
4. La passività della coscienza come possibilità dell'idea di Infinito
L'immanenza è già intrinsecamente correlata all'ontologia che, come discorso sull'essere, concerne
l'essere così come si manifesta negli enti. La loro differenza è intesa a partire dalle stesse differenze
che il soggetto coglie in essi. È infatti Parmenide, come abbiamo già detto, a fondare, con il noein
kai einai to auto, la possibilità dell'intelligibilità. Eppure, proprio come la vastità dell'oceano si
estende intorno e oltre l'isola di Kant, la verità dell'essere non è mai in sé conoscibile, restando
criterio di veridicità al di là del pensiero. E infatti la prospettiva classica riporta all'adeguazione il
rapporto tra essere e verità.
Nella sua ricerca Levinas riflette su tale manifestazione dell'essere, intendendola come
manifestazione della manifestazione e verità della verità in virtù della verbalità dell'essere, per la
quale l'essere stesso si manifesta e agisce sul soggetto. È infatti sempre l'essere ad apparire e non il
soggetto a ex-ducere. Ed è per questo motivo che la filosofia trova nella manifestazione la sua
materia e la sua forma. In tal senso è possibile ristrutturare il tema del sapere, procedendo dalla
manifestazione della manifestazione che sempre accade in un soggetto. La dinamica del sapere è
infatti comprensibile solo a partire dalla coscienza, la cui specificità sfugge alla sua definizione
entro un concetto di sapere che, al contrario, già la suppone.
La coscienza-di è uno stato di insonnia -- veglia o vigilanza -- che, inquietata dall'Altro, Levinas
intende come «passività dell'Ispirazione o soggettività del soggetto liberato dall'ubriacatura del suo
essere».26 Non procede da un'attenzione intesa nel senso classico, dal momento che in
fenomenologia essa è un essere tenuti svegli da qualcosa che ci richiama. Come una macchia di
inchiostro su una superficie bianca, qualcosa di profondamente diverso cattura la nostra
attenzione: nessuna coscienza intenzionale decide qui cosa accogliere nel proprio orizzonte. È la
passività della coscienza, il pre-intenzionale, che è, però, anche il non intenzionale, a fondare la
possibilità che in essa si dia qualcosa: l'idea di Infinito che non le appartiene e non è prodotta
dall'intenzionalità. Essa è la stessa presenza di un Altro nel Medesimo che, hegelianamente, non
nega il Medesimo -- pena la neutralizzazione della sua stessa identità -- secondo la logica, qui
capovolta, della riduzione all'identico della realtà circostante. Entro la coscienza, infatti, l'altro così
presente non annulla il medesimo ma piuttosto lo desta: è un di più nel di meno.
La veglia non conosce intenzionalità perché non possiede un contenuto: senza noema e senza
punto di riferimento è infatti assoluto dis-interessamento, indeterminazione, pazienza dell'Infinito.
La metafisica è dunque sempre ciò che si annuncia come totalmente al di là e che il soggetto, nella
sua passione dell'originario, coglie nella sua passività come in-determinabile. Una passività che
rinvia al patire di una coscienza che, per definizione, è invece
identità del Medesimo, presenza dell'essere, presenza della presenza. Occorre pensare la coscienza
a partire da questa enfasi della presenza. La presenza si dà solo come ritorno della coscienza a se
stessa, fuori dal sonno e, in ciò, la coscienza risale all'insonnia; anche se in questo ritorno a se
stessa, in forma di coscienza di sé, non è che dimenticanza dell'Altro che risveglia il Medesimo
dell'interiore, anche se la libertà del Medesimo non è ancora che un sogno risvegliato. La presenza
si dà solo come un'incessante ripresa della presenza, come un'incessante rap-presentazione. Il
senza-posa della presenza è una ripetizione, la sua ripresa, la sua appercezione di
rappresentazione. La ri-presa non descrive la rap-presentazione. È la rap-presentazione che è la
possibilità stessa del ritorno, la possibilità del sempre o la presenza del presente.27
La coscienza può risvegliarsi soltanto se qualcosa interrompe la sua immanenza. Tuttavia è
intelligibile solo ciò che rientra nella capacità determinante e determinativa del soggetto, ovvero
soltanto ciò che è immanente. Ecco perché conoscere, in senso proprio, significa pervenire a una
proposizione vera i cui contenuti sono frutto di un'adeguazione. Ora, essendo la coscienza finita, la
stessa adeguazione potrà concernere soltanto enti finiti: intelligibilità e finitezza sono orizzonti
correlati, anche nel finito ideale, in cui il referente oggettivo deve essere finito per essere elaborato
in un'idea. Ne consegue che dell'infinito non possiamo avere alcuna conoscenza intesa come
adeguazione, piuttosto lo rinveniamo come presenza non rappresentativa del soggetto congiunta a
un passato mai stato presente e condannata all'impossibilità della sua rappresentazione. Una
presenza immemoriale, così potremmo allora definire l'Assoluto, poiché solo l'immemoriale è
autenticamente trascendente: radicalmente libero dalla memoria e dal suo essere contenuto
immanente alla coscienza.
Negata la possibilità di un giudizio determinante sulla metafisica, ove la determinazione
alluderebbe alla finitezza dell'immanenza, Levinas riconosce il dato metafisico come un'eccedenza
del più nel meno procedente dalla manifestazione dell'assoluto (e non dal discorso in cui questo si
manifesterebbe). È piuttosto l'umana passione dell'originario a collocare l'originario al di là del
limite, nel preliminare, che poi è anche la possibilità della determinazione del limite stesso e
l'impossibilità delle umane capacità intellettive. Eppure l'uomo ha questa passione, patisce tale
passività accogliendo un messaggio che proviene dall'originario, da un altrove mai stato presente.
Negarla nella riduzione all'immanenza è negare la metafisica stessa, la sua disponibilità a essere
recepita solo nella passività della coscienza.
Ma come dire l'altrove? Nuovamente siamo sospinti nella passività del soggetto, ora detta
affettività, nel senso precipuo di un'affezione patita dall'uomo che rinvia, oltre l'uomo, alla
passività dell'altrove. Ripercorrendo la tradizione filosofica occidentale ci imbattiamo in un
complesso di affermazioni e proposizioni legate al tema fenomenologico della manifestazione. La
teologia della rivelazione, infatti, intende quest'ultima come manifestazione (rischiando di ridurre
la trascendenza all'immanenza); la teologia dialettica mantiene invece il Totalmente Altro.
Ma, appunto, come possiamo delimitare nel tema del discorso la stessa eccedenza del discorso?
È possibile che il termine Dio sia giunto alla filosofia a partire da un discorso religioso. Ma la
filosofia -- anche se lo rifiuta -- intende questo discorso come quello delle proposizioni che
riguardano un tema, cioè che hanno un senso riferendosi ad uno svelamento, ad una
manifestazione di presenza. I messaggeri dell'esperienza religiosa non concepiscono altra
significazione di senso. La «rivelazione» religiosa è immediatamente assimilata allo svelamento
filosofico -- assimilazione che anche la teologia dialettica mantiene. Non si sospetta minimamente
che un discorso possa parlare altrimenti che per dire ciò che è stato visto o inteso al di fuori, o
provato interiormente. Da subito l'essere religioso interpreta il suo vissuto come esperienza. Suo
malgrado esso già interpreta Dio, di cui pretende fare esperienza, in termini di essere, di presenza e
di immanenza.
Ne consegue tale questione preliminare: il discorso può significare altrimenti che significando un
tema? Dio significa come tema del discorso religioso che nomina Dio -- o come discorso che per
l'appunto, almeno di primo acchito, non lo nomina, ma lo dice ad un titolo diverso dalla
denominazione o dall'evocazione? .28
Dire Dio a partire da Dio: è anche questa l'originalità del pensiero levinasiano che supera la
tentazione filosofica di procedere da un discorso umano che ne implicherebbe l'ontologizzazione.
Se il significato di un discorso è dato dalla presenza dell'oggetto nella coscienza, mediante
l'adeguazione, è ovvio che di Dio, proprio per la sproporzione ontologica, non è possibile dire nulla.
Ma poiché Dio vi é presente come affezione passiva, evento di un tempo fuori dal tempo, è possibile
dire Dio dalla sua evocazione.
Il pensiero dell'Infinito sa risvegliare la coscienza operando una frattura nel cogito e, sedando
l'opposizione dell'adaequatio rei et intellectus, lo desta dal suo sonno dogmatico lasciando la
coscienza riposare nell'oggetto. Descartes vorrebbe rendere ragione della presenza dell'idea
dell'Infinito in noi ponendola tra le idee innate, ovvero considerandola un effetto che, rispetto alla
causa, non può non avere almeno altrettanta consistenza ontologica. In tal senso effettua il
passaggio dall'idea all'esistenza dell'Infinito, passaggio lecito solo in riferimento a Dio perché solo
in Lui essenza ed esistenza coincidono.
Dunque non ogni pensato è contenuto nella coscienza. L'eccedenza dell'idea di Dio travalica il
limite del pensiero ponendoci di fronte a un dato evidente, che il pensiero scopre in sé come
ulteriorità che lo in-abita, al di là dell'approccio soggettivo e dell'assenso razionale o dogmatico.
Ovviamente non è ancora Dio ma la sua idea che l'uomo porta in sé come Infinito.
È noto che la singolarità eccede la verbalità, potendo dire soltanto la species. Per definizione il
concetto racchiude infatti un'intera classe di oggetti: il particolare cade nella non dicibilità, contro
l'universalità della conoscenza scientifica. All'agnosticismo, quale possibile risvolto dell'eccedenza
dell'idea di Dio, si ribatte che la capacità dell'Infinito è chiaramente riflessa nel perenne desiderare
dell'uomo, in quel patire l'originario che attesta la profondità di un subire che non comprende
alcuna capacità,
che non sostiene più alcun fondamento, in cui si arena ogni processo di investimento ed in cui
saltano le catene che chiudono i recessi dell'interiorità. Immissione senza raccoglimento, che
devasta il suo luogo come un fuoco divoratore, che catastrofizza, nel senso etimologico del termine,
il luogo. Abbagliamento in cui l'occhio sopporta più di quanto sopporti; bruciatura della pelle che
tocca e non tocca ciò che, attraverso l'afferabile, brucia. Passività o passione in cui si riconosce il
Desiderio, in cui il «di più nel di meno» risveglia con la sua fiamma più ardente, più nobile e antica
un pensiero votato a pensare più di quanto pensi.29
Dall'idea dell'Infinito Levinas è giunto al Desiderio quale sinonimo di Bene, non provocato dal
soggetto che desidera ma da sempre inserito nell'orizzonte del desiderabile. Immersi in questo
infinito siamo tratti fuori dalla continuità dell'ontologia verso l'al di là dell'essere. Non è questa la
dinamica dell'eros platonico, non è cioè il bisogno che può essere colmato nell'unione di
abbondanza e privazione, piuttosto è un godimento come 'accrescersi della fame'. Ed è in tale
capovolgimento che avviene la trascendenza, lo sradicamento dall'essere nel disinteressamento del
Desiderio.
Sempre prossimo ma differente è Dio, il Santo, a restare separato come Desiderabile. L'Infinito che
si trascende nel finito mi ordina il prossimo senza esporsi a me, lasciando l'io soggetto a un ordine
che lo sovrasta prima di essere inteso e che pure realizza nella sua azione. Prima dell'ascolto, in
questa radicale trascendenza che oltrepassa l'oggettivazione e il dialogo, vi è l'esecuzione profetica.
Note
Queste riflessioni sono nate all'interno di un seminario universitario che si interrogava sulle modalità di dicibilità di Dio
in Levinas. Abbiamo interrogato lo scritto del 1982 consapevoli che la questione è molto più complessa, ma né lo spazio
di un seminario, né un contributo a un'opera collettiva possono render conto di tale complessità.
1.
E. Levinas, De Dieu qui vient à l'idée, Paris 1982 tr. it., Di Dio che viene all'idea, Milano 1983. Ci serviremo in
seguito della traduzione italiana confrontandola di volta in volta con il testo francese e di cui si dà la pagina in
corsivo. Citeremo con la sigla DVI.
2.
Ibid., pp. 9-10; 8.
3.
Ibid., pp. 10-11; 9.
4.
In Totalità e Infinito, ed. it., Milano 1980, Levinas aveva presentato proprio in questi termini la possibilità
dell''apertura' metafisica.
5.
DVI, p. 11; 10.
6.
Ibid.
7.
Su questa nozione aveva già insistito Totalità e Infinito, cit., p. 84 sgg.; ma anche in Altrimenti che essere, ed.
it., Milano 1983, tutto il capitolo 4 dedicato alla Sostituzione, può essere letto in questa prospettiva.
8.
DVI, p. 12; 11 nota.
9.
Ibid., p. 13; 12.
10. Ibid.
11. Su questo tema resta fondamentale il saggio La traccia dell'altro in Scoprire l'esistenza con Husserl e
Heidegger, Milano 1998, e anche la ripresa che Levinas ne fa in Umanesimo dell'altro uomo, Genova 1998.
12. Un'indagine a parte meriterebbe questo problema del non intenzionale e della cattiva coscienza a cui il filosofo
franco-lituano ha dedicato molteplici saggi raccolti in Tra noi. Saggi sul pensare-all'altro, Milano 1998.
13. E. Levinas, Dalla coscienza alla veglia a partire da Husserl, in DVI, pp. 41-42; 48-49.
14. Ibid., p. 43; 51.
15. Ibid, nota 24.
16. Ibid., p. 49; 58-59.
17. Ibid., p. 47; 56.
18. DVI , pp. 77-101; 93-127.
19. Levinas inizia così il suo percorso tra metafisica e ontologia: «Il discorso filosofico dell'Occidente rivendica
l'ampiezza di un inglobamento e di una comprensione ultima. Esso costringe ogni altro discorso a giustificarsi
davanti alla filosofia», op. cit., p. 78; 94.
20. J. Delhomme, Pensée Interrogative, 1954, citata da Levinas, op. cit., p. 79; 96.
21. È in questo senso che il neopositivista circolo di Vienna afferma che Dio non ha un senso, non essendo verificato
e né verificabile e definendo da qui l'insensatezza di tutte le proposizioni metafisiche.
22. E. Levinas, Dio e la filosofia, op. cit., p. 79.
23. Ibid., p. 80; 96-97.
24. Si veda quanto scrive Kant nella Critica della ragion pura (P. I - L. II - Cap. III) quando inizia a parlare della
distinzione di tutti gli oggetti in fenomeni e noumeni.
25. Può risultare di grande interesse, per comprendere meglio l'orizzonte di riferimento di Levinas, leggere il
Troisième portique intitolato L'homme et l'infini nell'opera L'ame de la vie di Rabbi Hayym de Volozine, pp. 117
sgg.
26. Ibid., p. 81; 99.
27. Ibid., pp. 81-82; 99-100.
28. Ibid., pp. 84-85; 103-104.
29. Ibid., pp. 89-90; 110-111.
Edoardo Toniolatti
Etica e giustizia in Emmanuel Levinas. Dal
comando alla Legge
Solo da poco l'attenzione di chi studia il pensiero di Levinas si è spostata dal problema dell'etica a
quello della giustizia. Nonostante ciò, sempre più numerosi -- fra tutti, per citarne uno solo, Miguel
Abensour -- sono ormai coloro che tentano un approccio interpretativo all'opera del filosofo lituano
utilizzando come chiave di lettura le categorie concettuali di una teoria della giustizia, spostando
così l'accento dalla dimensione etica a quella politica.
Causa principale di questa nuova lettura è sicuramente la consapevolezza crescente che il vero
cuore pulsante di tutto il pensiero levinasiano, nonché la sua possibilità di sviluppo più feconda,
risiedano proprio nella tensione che si instaura fra etica e giustizia, fra il mondo della
responsabilità e quello dell'equità. Risulta infatti sempre più pressante l'esigenza di una rilettura di
tale pensiero alla luce della figura del terzo, elemento realmente centrale per una corretta
comprensione di Levinas, ma scarsamente preso in considerazione nelle tradizionali
interpretazioni del suo pensiero.
Bisogna dire che sono effettivamente pochi i passi in cui l'autore orienta l'analisi direttamente in
questa direzione, ma si tratta comunque di testi la cui importanza non può essere trascurata, testi
indirizzati soprattutto a mostrare le conseguenze importantissime dell'irrompere del terzo sulla
scena della relazione io-Altri.
La relazione etica è una relazione a due, si inscrive in quella che Levinas chiama «socialità intima»,
quella socialità cioè in cui c'è spazio solo per il soggetto e per Altri che si approssima con la carica
sconvolgente del suo volto. Questa situazione di relativa semplicità viene però problematizzata al
livello più profondo dalla comparsa di un ulteriore attore sulla scena, quel terzo che non è Altri e
che anzi il rapporto con Altri esclude. La relazione etica e la responsabilità per Altri escludono la
presenza del terzo, poiché costituiscono la base di un rapporto esclusivo di elezione e
insostituibilità del soggetto. Il terzo uomo, dice Levinas,
turba questa intimità: il mio torto verso di te, che io posso riconoscere interamente partendo dalle
mie intenzioni, si trova oggettivamente falsato dai tuoi rapporti con lui, che mi restano segreti,
poiché, a mia volta, io sono escluso dal privilegio unico della vostra intimità. Se riconosco i miei
torti verso di te, posso, persino col mio pentimento, ledere il terzo.1
È da qui che emerge allora la necessità di riconsiderare tutto il percorso proposto da Levinas, e non
per esaminare ciò che potrebbe essere un'alternativa al rapporto etico -- come se ci fosse da un lato
la mia dimensione relazionale con Altri e dall'altro quella che riguarda invece il terzo, gli altri -- ma
per un motivo ben più radicale.
nella relazione con altri io sono sempre in relazione con il terzo. Ma esso è anche il mio prossimo. A
partire da questo momento la prossimità diviene problematica: occorre paragonare, pesare,
pensare, occorre fare della giustizia, sorgente della teoria.2
Non si può prescindere dall'importanza del terzo semplicemente perché non si può prescindere dal
terzo. Levinas lo afferma molto chiaramente: in realtà la situazione etica non si presenta mai,
perché non possiamo uscire dalla socialità allargata che già da sempre ci circonda. È allora evidente
il motivo per cui l'irruzione del terzo non solo suggerisce, ma costringe ad analizzare sotto una
nuova luce tutto ciò che era stato proposto all'interno dell'orizzonte dell'etica.
Le direzioni verso cui questo riesame si articola sono principalmente tre: innanzitutto, è necessario
analizzare a fondo ciò che differenzia Altri dal terzo, con conseguente problematizzazione dei temi
della prossimità e del volto. Da questa prima differenziazione discenderà, in secondo luogo, quella
che separa etica e giustizia, per cui si cercherà di delineare, dell'una e dell'altra, le diverse
prospettive e i diversi ambiti. Infine sarà intrapresa l'analisi della questione a nostro giudizio più
problematica e feconda, della tensione cioè che deve generarsi fra queste due dimensioni,
necessaria per riempire di senso l'una e l'altra e per fornire una chiave di lettura davvero adeguata
all'intero edificio levinasiano.
1. Il terzo e la socialità
La differenza fra Altri e il terzo si inscrive all'interno del quadro di rapporti che li legano al
soggetto, rapporti che non sono solo diversi, ma provocano anche una serie di mutamenti reciproci.
Punto di partenza è sicuramente il rapporto con Altri, il più noto tema levinasiano, di cui non
possiamo in questa sede che richiamare i passaggi fondamentali quali il risveglio al comando del
volto, la responsabilità, la sostituzione, tutti momenti finalizzati alla descrizione del particolare
rapporto che si crea fra l'io e Altri, rapporto in cui l'io si trova chiamato dall'altezza inscritta nel
comando del volto a prendersene cura, a essere responsabile della sua nudità.
È a questo punto -- come abbiamo visto -- che si inserisce il problematico ruolo del terzo,
intrusione inevitabile che complica la situazione etica fino a renderne necessario il superamento.
L'etica infatti esclude il terzo, dunque nel momento in cui quest'ultimo appare ci troviamo costretti
a riesaminare la posizione e il carattere di Altri.
L'irrompere del terzo pone il soggetto di fronte alla paradossale situazione di trovarsi al cospetto di
due alterità che possono entrambe a buon diritto rivendicare la pretesa ad essere volto che
comanda: a questo punto il problema investe il soggetto, perché è il soggetto a dover decidere quale
delle due diverse alterità sia Altri e quale invece receda al ruolo di terzo. Decisione impossibile
però, dal momento che Altri esclude il terzo: infatti il soggetto si trova nella necessità di dover
considerare non solo il suo rapporto con le due alterità, ma anche e soprattutto la relazione che
coinvolge le due alterità fra di loro. Dunque il soggetto non può più assumere una responsabilità
infinita per una delle alterità che ha di fronte, perché ciò vorrebbe dire attuare una violenza nei
confronti dell'alterità così esclusa. È allora lo stesso concetto di responsabilità universale ad essere
messo in crisi: comprendiamo dunque che l'universalità della responsabilità riguarda Altri nella
sua interezza, non la totalità de «gli» altri. È una responsabilità, si può dire, intenzionata verso una
seconda persona singolare, non plurale.
Da questa situazione ingestibile il soggetto può uscire solo ridimensionando i contorni di
trascendenza di Altri. Ciò non vuol dire tradire il principio -- basilare in tutta l'opera di Levinas -dell'irriducibilità e dell'incoglibilità dell'altro, quanto piuttosto «mettere fra parentesi» il comando
significato dal suo volto, sottrarsi cioè a quella subordinazione immediata e ineludibile a cui il
soggetto viene chiamato nella responsabilità; senza questo presupposto è infatti impossibile uscire
dall'inevitabile violenza che subirebbe il terzo, perché è anch'egli «prossimo» del soggetto.
bisogna che ormai io metta a confronto; che io metta a confronto gli incomparabili, gli unici.
Nessun ritorno al «per sé di ciascuno». Ma bisogna giudicare gli altri. Nell'incontro del volto, non
c'è stato da giudicare: l'altro, l'unico non sopporta il giudizio, immediatamente mi precede, gli
debbo obbedienza. Giudizio e giustizia sono necessari non appena compare il terzo. Proprio in
nome dei doveri assoluti nei confronti del prossimo, è necessario un certo abbandono
dell'obbedienza assoluta che egli invoca.3
Ecco che allora emerge tutta la problematicità insita nella nozione di «prossimità»: prossimo, per il
soggetto, è infatti Altri, con la convocazione che il suo volto significa, ma anche il terzo, che proprio
tale convocazione giunge a rimettere in discussione. È quindi necessario distruggere l'asimmetria
fra Altri e il soggetto, un'asimmetria su cui poggia tutta l'etica di Levinas ma che tuttavia va
rimossa proprio perché con il sopraggiungere del terzo si verifica l'ingresso nella socialità allargata,
autentica, dunque fra eguali: l'etica non si gioca fra eguali, perché si regge sulla responsabilità e
sull'altezza del volto d'Altri, ma con l'arrivo del terzo è necessario «comparare gli incomparabili»,
dunque rivendicare l'uguaglianza.
Se la nozione di prossimità viene problematizzata in questo modo, passando cioè dal prossimoAltri che mi convoca alla responsabilità e mi subordina al suo comando ad un prossimo-altro che
racchiuda in sé sia l'alterità «depotenziata» dell'altro sia quella del terzo, qualcosa di analogo va
sostenuto anche per la nozione di volto, centrale anch'essa nel percorso levinasiano.
Il volto è, nella prospettiva etica, ciò che il soggetto incontra come simbolo dell'irriducibilità
dell'altro, ciò nella cui nudità si annuncia da un lato la possibilità della morte e dell'omicidio -dunque l'estrema debolezza -- e dall'altro invece tutta l'altezza del comando e della convocazione
alla responsabilità, tutta la potenza del «Tu non ucciderai» -- dunque l'assoluta forza. L'apparire
del terzo costringe a ridimensionare il ruolo del volto, ma solo per ciò che riguarda il secondo punto
messo in evidenza: il volto deve necessariamente perdere -- o quantomeno vedere ridotta -- la
potenza del proprio comando, ma ciò non vuol dire pregiudicarne la simbolicità relativa
all'irriducibilità dell'altro al medesimo. Dunque è sì necessario «comparare gli incomparabili»,
presupporre l'uguaglianza, ma è altrettanto necessario inscrivere questa uguaglianza nel quadro di
separazione e differenza che l'analisi fenomenologia del volto -- si pensi a Totalità e Infinito -- ci ha
mostrato come irrinunciabile e imprescindibile.
2. Etica e giustizia
Da questa prima distinzione fra Altri e il terzo non può essere separata quella che si riflette sulle
rispettive dimensioni di riferimento, cioè l'etica da un lato e la giustizia dall'altro. Se si può
sostenere che l'apparizione del terzo costringa ad una «riduzione» di Altri, la distinzione fra etica e
giustizia si basa piuttosto sull'astrattezza e sulla formalità che contraddistinguono la legge -- che
nasce nel quadro della politica e della giustizia -- in opposizione al comando del volto nell'etica.
Il comando del volto si basa infatti sulla particolarità della situazione in cui si trovano coinvolti i
due attori, l'io e Altri, facendo leva soprattutto sull'insostituibilità dell'io che risponde alla chiamata
alla responsabilità. Il comando del volto è «Tu non ucciderai», perché è proprio l'io concreto ad
essere chiamato in causa, è un comando che si rivolge a me e in quanto elezione mi designa come
insostituibile. Non deve esserci reciprocità, quindi non è prevista una formalizzazione del comando
che possa far posto ad un'inversione dei ruoli o ad una applicabilità universale astraendo dagli
individui in gioco. Proprio perché si riferisce a me il comando non intende essere valido per
chiunque convincendomi così, in maniera procedurale, della sua giustezza: esso mi convoca e mi
reclama prima che io possa rispondere, prima ancora quindi che io possa interrogarmi sul suo
valore e sulla sua validità. Di conseguenza esso non mi chiede di astrarre dalla mia dimensione
esistenziale e di ridurmi, ad esempio, semplicemente a soggetto giuridico: è tutto me stesso ad
essere convocato e soggetto all'ordine della responsabilità, non io-in quanto..., bensì
semplicemente io.
Ma con l'apparire del terzo e della società emerge la necessità di giudicare, di «comparare gli
incomparabili», quindi nasce il bisogno della formalità della norma, che sia applicabile in generale
indipendentemente dai termini presi in considerazione: la funzionalità della legge che astrae dai
soggetti permette infatti di rispondere all'esigenza di reciprocità che la società introduce,
consentendo dunque lo scambio di ruoli e l'uguaglianza che l'etica non solo non presupponeva, ma
di cui anzi non presupponeva neanche la possibilità. Ecco perché allora il comando «Tu non
ucciderai» deve far posto alla formula della legge astratta: «Non si deve uccidere», legge svincolata
dai soggetti chiamati in causa in quel «si» di cui con particolar forza va sottolineata l'impersonalità.
Il passaggio dal comando alla legge si concretizza, dal punto di vista politico, nella categoria dello
Stato: e proprio esaminando questa nuova nozione ci troviamo subito di fronte ad un'interessante
alternativa teorica rispetto al tradizionale schema hobbesiano.
Lo Stato della giustizia proposto da Levinas non nasce infatti da una limitazione della guerra
permanente di tutti contro tutti, come appunto nello schema di Hobbes, bensì da una limitazione
della responsabilità per l'altro. Cioè, Levinas pone come fenomeno originario non il conflitto, ma la
prossimità: in questo modo può tracciare un'alternativa fra lo «Stato di Cesare» e lo «Stato di
Davide».
Così, da un lato, lo «Stato di Cesare» -- Roma -- costruito sul modello di Hobbes. Una città che
conosce la pace, ma sotto il segno del «contro», «il diritto degli uomini contro i loro simili»; si
tratta della pace degli Imperi, «uscita dalla guerra» e che «riposa sulla guerra». Dall'altro lato, lo
Stato di Davide -- Gerusalemme -- che proviene da una fraternità originaria, irriducibile e capace di
far nascere una pace della prossimità, sotto il segno del per-l'altro. Anche se Israele non ignora la
violenza nella storia, per esso non è da questa violenza che ha origine lo Stato, nonostante le prove
del senso comune, ma piuttosto dall'evento etico dell'incontro.4
Necessariamente lo Stato porta con sé la violenza, perché richiede un ridimensionamento di Altri
che, visto all'interno della prospettiva etica, non è altro se non una violenza nei suoi confronti. Ma
si tratta di quel minimum di violenza richiesto dalla realtà della situazione sociale allargata in cui
già da sempre ci troviamo e in cui non possiamo tener conto del terzo che sopraggiunge.
Ciò che l'etica reputa violenza finisce con l'essere la condizione della possibilità della giustizia.
Questo però non vuol dire disconoscere tout-court l'etica, il volto e l'alterità d'Altri: ciò che è stato
detto all'interno della prospettiva etica non va rigettato, ma posto in relazione feconda con ciò che
emerso nel quadro della giustizia e del sopraggiungere del terzo.
3. Fra etica e giustizia. Il posto del soggetto
Giungiamo così alla necessità di riflettere sui punti di collegamento che costellano il rapporto fra le
due dimensioni dell'etica e della giustizia. Fino ad ora infatti sembra si tratti di due elementi
strutturalmente diversi, che nascono dal bisogno di affrontare situazioni radicalmente distinte
quali l'incontro con Altri e la nascita della società con il sopraggiungere del terzo. Il rapporto
sembra dunque scarsamente problematico, poiché come abbiamo visto più volte -- e come Levinas
non si stanca di ripetere -- Altri esclude il terzo, e viceversa, aggiungiamo noi, il terzo esclude Altri.
In realtà il problema è molto più complesso, soprattutto per un elemento fondamentale cui
abbiamo accennato all'inizio della nostra analisi.
io non vivo in un mondo in cui c'è un solo «primo venuto»; nel mondo c'è sempre un terzo:
anch'egli è il mio altro, il mio prossimo.5
E ancora:
In un certo senso, anche se l'uomo mi perseguita, debbo rispondere, non posso lasciarlo alla sua
responsabilità. Ma l'uomo che perseguita e che io posso avere da perdonare, tocca anche il terzo.
Qui devo difendere il terzo perseguitato, prima del persecutore. In realtà, concretamente, non si
esce mai da questa situazione.6
Dunque noi ci muoviamo sempre nell'ambito della giustizia, del politico, perché l'altro ha sempre
accanto a sé il terzo: la nostra dimensione di riferimento è la socialità allargata, la società autentica,
perché il terzo è sempre presente -- o presente in quanto assente --, e comunque è colui che deve
essere sempre preso in considerazione e ci spinge verso il giudizio, verso la giustizia. Non si esce
mai dall'ambito della giustizia, dunque non si entra mai in quello dell'etica; ma in questo la
dimensione etica non rischia di presentarsi solo come una sorta di «esperimento mentale», come la
descrizione di una «situazione limite» che però è al soggetto preclusa in ogni modo?
Le conseguenze di questo problema sono molto rilevanti, perché ci portano a dubitare dell'effettiva
validità di tutta la struttura etica del pensiero di Levinas -- peggio, ci danno l'impressione che la
dimensione etica così lungamente analizzata non sia altro in realtà che la descrizione di un vuoto,
di un qualcosa che non può essere, sostanzialmente un nulla. E tale dubbio investe inevitabilmente
tutti i fondamenti su cui si basa la prospettiva etica, costringendoci quindi anche a rilevare l'aporia
perfino in Altri e nel volto, che finiscono con il risultare anch'essi semplici chimere inesistenti.
Come si può infatti vedere Altri e il suo volto, se Altri non esiste, e se il suo volto altro non è che le
linee e i contorni del suo viso, quindi un semplice dato fisico?
Un primo suggerimento sulla direzione verso cui indirizzarci per trovare una soluzione a questa
aporia ci viene dal seguito della riflessione sullo Stato e sulla distinzione fra Stato di Cesare e Stato
di Davide su cui ci siamo già soffermati.
Nell'ipotesi levinasiana, lo Stato è permanentemente attraversato, investito da una
sursignificazione. Lo Stato nella sua effettività non cessa di indicare un al-di-là di se stesso. Ciò
vuol dire riconoscere che l'ipotesi di Levinas ci rivela l'implicito dello Stato e dentro questo
implicito ci mostra «il superamento dell'intenzione nell'intenzione stessa». Lo Stato contiene un
più, o un sovrappiù che lo supera, un orizzonte sconosciuto che tocca all'analisi fenomenologia far
risorgere e mettere in scena. Secondo questa sursignificazione che abita lo Stato, vi è nello Stato più
che lo Stato. Ed è perché c'è nello Stato più che lo Stato che esso tende ad autosuperarsi, ad aprire
la via a questo al-di-qua, altrimenti detto a questo sovrappiù che lo attraversa e lo porta ad
estendersi al-di-là di sé stesso.7
La dimensione politica trova quindi nella relazione etica il modello con cui confrontarsi e da cui
trarre fondamento. La politica deve quindi orientarsi sull'etica e trasportare sul proprio piano i
principi della fratellanza responsabile, per poter in questo modo instaurare quello Stato di Davide
che così tanto ricorda un'utopica civitas Dei.
Ma il problema è risolto solo in parte, perché ancora nulla è stato detto a proposito dell'effettiva
presenza, nell'autentica prospettiva-di-vita del soggetto, della dimensione etica, che continua a
proiettarsi come un vuoto artificiosamente riempito.
Le riflessioni su cui ci siamo appena soffermati ci forniscono però un indizio. Le tensione che deve
generarsi fra etica e politica ci rimanda infatti a ciò che Kant dice a proposito della legge morale, da
cui traiamo come prezioso suggerimento la nozione di ideale regolativo.
È allora proprio in questa direzione che deve orientarsi la nostra comprensione della dimensione
etica. Dobbiamo infatti prendere atto, e non possiamo farne a meno, del non verificarsi mai della
situazione etica: l'altro non è mai Altri, perché la presenza «già sempre presente» del terzo non
permette ad Altri e al suo volto di convocarmi alla responsabilità universale con il loro ineludibile
comando, ne spezza la suprema autorità. È quindi vero che, possiamo dire, Altri non esiste, ma è
proprio la nozione di ideale regolativo a permetterci di recuperarne la forza e la validità. Bisogna
infatti trasferire la nostra riflessione da un piano ontologico ad un piano deontologico, un piano
che quindi abbandoni l'orizzonte dell'essere -- esigenza basilare in tutto l'itinerario filosofico di
Levinas -- verso il dover-essere in cui propriamente si inscrive l'etica. È allora alla luce delle
categorie del dover-essere che dovremo leggere ciò che viene detto di Altri, del volto e del suo
comando: non come una descrizione di ciò che è, ma come una prescrizione di ciò che deve essere.
Altri e il suo volto sono allora simboli del comando stesso: il soggetto non incontra mai, a rigore,
Altri e il suo volto, bensì sempre l'altro -- che, pur nell'irriducibilità della sua alterità, non ha l'
«altezza» che mi comanda di Altri; ma in questo incontro con l'altro il soggetto deve comunque
pensare Altri, deve cioè considerare l'altro, che ha sempre di fronte, come se fosse Altri, che invece
non ha di fronte mai.
In questo senso Altri e il volto devono essere «ideale regolativo»: non reali, dunque, ma ideali che
orientino la relazione del soggetto con l'altro, rappresentazioni iperboliche -- termine spesso
associato alla proposta levinasiana -- tramite cui il soggetto possa tendere ad adeguare l'essere al
dover-essere, l'ontologico al deontologico. Levinas stesso ripete in più punti che il volto non è un
fenomeno, non né una forma plastica o un ritratto, non è il viso che vedo di fronte a me
nell'incontro con l'altro, ma è il simbolo del suo essermi prossimo, è il significato che esso deve
ricoprire per il soggetto che lo incontra: è la sua simbolicità ad essere allora fondamentale, il suo
fungere da rimando ad una dimensione ideale, quella etica, che non è reale ma che sul reale deve
esercitare la sua influenza e con il reale deve generare una tensione che porti il soggetto sulla via
dell'azione giusta. Con una sorta di gioco di parole, si può dire che il volto non è il volto, ma deve
essere il volto, che l'altro non è Altri, ma deve essere Altri.
È questa tensione fra reale e ideale che può allora riempire di senso l'azione del soggetto, perché è
tale tensione che permette il sorgere dell'azione giusta, quell'azione cioè che si svolge non sul piano
dell'etica -- anche perché, si pensi ad esempio a ciò che viene detto in Totalità e Infinito, la
categoria chiave dell'etica non è l'attività ma la passività -- ma sul piano della giustizia, senza però
dimenticare l' «imperativo categorico» che l'etica, nella sua iperbolicità, prescrive.
Levinas lo dice chiaramente: «L'impossibilità di uccidere non è reale, è morale»,8 dunque ideale:
nella tensione fra questi due piani si disegna l'azione giusta del soggetto, perché il terzo è entrato in
gioco e ha causato un ripensamento -- e un parziale abbandono -- del comando. Al comando si
obbedisce, l'azione giusta invece si compie: è allora anche la tensione fra la passività dell'etica e
l'azione della giustizia a fornire senso autentico al ruolo del soggetto. È infatti lo statuto della legge
nella sua differenza rispetto al comando che ci permette di intravedere in essa un elemento basilare
che sottolinea il ruolo attivo del soggetto, cioè il suo essere frutto di autonomia.9
Giungiamo così ad un ulteriore punto problematico, che concerne appunto il ruolo del soggetto. È
all'interno del suo agire che si inscrive infatti la parte più complessa della questione relativa al
rapporto fra Altri e il terzo.
Nella prospettiva etica, di fronte ad Altri, il soggetto si trova schiacciato dall'altezza del comando
del suo volto, preso in ostaggio dalla chiamata alla responsabilità che Altri gli impone come
inevitabile, fino al culmine della sostituzione e della responsabilità universale. Abbiamo visto come
l'emergere del terzo costringa il soggetto a ridimensionare questa responsabilità, portandola fuori
dal piano dell'etica. Si pone allora come evidente nodo problematico il destino di questa
responsabilità universale, la domanda relativa cioè alla sua effettiva permanenza anche sul piano
della giustizia, e -- in caso di risposta affermativa -- a quali necessarie modifiche vada incontro in
questo passaggio. È infatti in questa tematica che si inserisce il problema del soggetto, perché il suo
ruolo sarà evidentemente determinato dalle forme che l'agire responsabile assumerà nel suo
trasferimento sul piano della giustizia.
All'interno della società allargata, in cui il terzo ha già fatto la sua comparsa, si verifica un
cambiamento di senso riguardo alla responsabilità universale: se infatti nell'etica abbiamo visto
come tale nozione fosse relativa all'universalità degli aspetti di Altri di cui essere responsabile, ora
invece il soggetto si trova a dover essere responsabile dell'altro e del terzo e del legame che fra loro
si crea. È una responsabilità quindi che si limita, da un lato, perché deve ridimensionare la potenza
del comando del volto, ma dall'altro si estende, poiché si trova a dover considerare anche «gli altri»
che non sono Altri, e di cui il terzo è simbolo. È allora un nuovo senso quello che investe la nozione
di responsabilità universale, perché ora cade nel suo ambito l'universalità dei membri della società
e dei loro rapporti; e si tratta qui di una responsabilità autenticamente politica, sottratta sì al
comando ma rispettosa della legge, non più basata sull'asimmetria fra il soggetto e Altri ma
costruita a partire dall'uguaglianza dei membri, che rimangono alterità irriducibili ma
necessariamente passibili di giudizio.
E la conseguenza più rilevante per il soggetto sarà allora quella di ricadere inevitabilmente
all'interno della propria responsabilità: se devo essere responsabile di tutti, non più solo dell'altro
in quanto Altri, devo allora essere responsabile anche di me stesso, non posso più subordinarmi al
comando del volto di Altri, perché devo agire alla luce della legge, concretizzazione della
responsabilità universale, quindi anche della mia responsabilità per me stesso.
Bisogna tornare al soggetto, bisogna tornare all'essere; non con un gesto semplice e aproblematico,
ma tenendo ben presente l'ideale del momento etico e la tensione con l'essere che esso genera.
Il modo di pensare qui proposto non consiste nel misconoscere l'essere e neppure nel trattarlo,
secondo una pretesa ridicola e sdegnosa, come cedimento di un ordine o di un Disordine superiore.
Ma è a partire dalla prossimità che l'essere assume, al contrario, il proprio giusto senso. Nei modi
indiretti dell'illeità, nella provocazione anarchica che mi ordina all'altro, s'impone la via che
conduce alla tematizzazione e a una presa di coscienza: la presa di coscienza è motivata dalla
presenza del terzo affianco al prossimo avvicinato; anche il terzo è avvicinato; la relazione tra il
prossimo e il terzo non può essere indifferente all'io che si approssima. È necessaria una giustizia
fra gli incomparabili. È necessario dunque un paragone tra gli incomparabili e una sinossi; messa
insieme e contemporaneità; è necessaria una tematizzazione, un pensiero, una storia e una
scrittura. Ma bisogna comprendere l'essere a partire dall'altro dell'essere. Essere, a partire dalla
significazione dell'approssimarsi, è essere con altri per o contro il terzo; con altri e il terzo contro
sé. Nella giustizia contro una filosofia che non vede al di là dell'essere, che riduce, abusando del
linguaggio, il Dire al Detto e ogni senso all'interessamento. La Ragione, alla quale si attribuisce la
virtù di fermare la violenza per raggiungere l'ordine della pace, suppone il disinteressamento, la
passività o la pazienza. In questo disinteressamento, quando la responsabilità per l'altro è anche
responsabilità per il terzo, si configurano la giustizia -- che confronta, raccoglie e pensa -- la
sincronia dell'essere e la pace.10
In questa prospettiva ci troviamo allora di fronte ad un soggetto nuovo, che trova la possibilità
dell'azione giusta sia sotto la guida della legge, sia nell'ideale del comando.
E questa situazione «a metà» del soggetto, teso fra il comando e la legge, diventa a nostro parere
ben evidente nel momento in cui ci riallacciamo a quanto precedentemente detto a proposito del
passaggio dal comando alla legge, dal «Tu non ucciderai» al «Non si deve uccidere». Il soggetto che
si trova ad agire nella dimensione della giustizia, tenendo però ben presente l'ideale regolativo
dell'etica, oscilla infatti fra il «Tu» dell'insostituibilità e dell'elezione e il «Si» che invece lo riduce a
soggetto eguale agli altri, e questa tensione può essere esplicitata e simbolizzata se proseguiamo il
percorso della formula aggiungendo un passaggio successivo.
Il soggetto della legge non può infatti essere semplicemente il fattore astratto ed impersonale che
verrebbe dalla legge stessa richiesto, proprio perché ora dobbiamo considerare il richiamo ideale
che la dimensione dell'etica esercita su di esso; se non teniamo conto di questo, il «Si» della legge
non è più semplicemente impersonale, ma diventa spersonalizzante. Invece, anche la legge ha un
destinatario ben preciso, ed è il soggetto immerso nella comunità, un soggetto -- abbiamo visto -responsabile di tutti e anche di sé, un soggetto cosciente e consapevole di sé e del proprio ruolo. Ma
allora il «Non si deve uccidere» diventerà «Io non devo uccidere»: l'accento verrà nuovamente
spostato sul soggetto, ma in un modo profondamente diverso rispetto al momento etico. Nella
dimensione etica, infatti, era il soggetto nella sua interezza ad essere convocato alla responsabilità
come unico ed insostituibile, ma sotto il segno della passività: il comando si esprime nel «Tu». Ora,
invece, la situazione è cambiata: è sempre il soggetto nella sua interezza ad essere chiamato
all'azione giusta da parte della legge, ma è un soggetto che si è riappropriato di sé e della sua
attività, un soggetto fra gli altri e non più solo al cospetto di Altri, un soggetto quindi che non deve
più solo aspettare passivamente il comando ma può dire «Io», riconoscendo e valorizzando la
propria attività. È l'io che interiorizza la legge, che in quanto tale non prevede più la passività di chi
riceve l'ordine ma l'attività del cittadino che agisce secondo la legge dell'autonomia.
4. Conclusione
È dunque emersa nel corso della nostra analisi una serie di punti notevoli nel corso della nostra
analisi, che ci hanno permesso di comprendere in maniera più approfondita alcuni nodi
problematici dell'opera levinasiana scarsamente sviluppati dalla critica tradizionale, come il tema
del terzo, la tensione fra etica e giustizia, la dimensione politica, il complesso ruolo del soggetto.
Riteniamo che l'interpretazione da noi così fornita possa inoltre essere utilizzata con profitto per
rispondere ad una serie di critiche mosse a Levinas da molteplici direzioni, colpevoli -- a nostro
avviso -- di non aver tenuto nella giusta considerazione la distinzione basilare fra Altri e il terzo, fra
etica e giustizia che qui ci siamo sforzati di sottolineare in maniera il più possibile chiara e precisa.
Ciò non vuol dire però non riconoscere dei punti deboli, o addirittura delle mancanze nella
proposta di Levinas: specialmente su una di queste vorremmo ora richiamare l'attenzione, dal
momento che ci sembra utile per completare il quadro del nostro discorso.
La distinzione fra Altri e il terzo risulta essere, potremmo dire, oppositiva: il terzo cioè si pone
come opposto escludente di Altri, il suo ruolo è alla fine quello di far precipitare Altri dall'altezza
dell'asimmetria per condurlo -- e ridurlo -- nella dimensione della giustizia. Ma con ciò non
sarebbe del tutto esatto dire che Altri è «figura dell'etica» e il terzo «figura della giustizia», perché,
se è pur vera la prima affermazione, non lo è la seconda: sul piano della giustizia non compare
infatti solo il terzo, ma «gli altri», i membri della società allargata nella loro totalità. Il terzo è
dunque la figura di passaggio, nodo cruciale della tensione fra etica e giustizia in quanto «figura di
crisi» per entrambe le dimensioni: non è infatti possibile trovarlo nell'etica, ma bisogna riconoscere
che non è neanche la figura chiave della giustizia, poiché in questa dimensione il quadro di
riferimento è offerto dall'altro «de-enfatizzato» della società allargata, dal «voi» seconda persona
plurale in cui il terzo, in qualche modo, è già incluso.
Qui arriviamo però al problema: manca infatti, in Levinas, un'analisi dell'alterità nel suo
particolare modo di darsi all'interno del quadro della giustizia, come un altro che quindi non sia
Altri ma non sia neanche il terzo. Manca in Levinas un'analisi dell'altro della giustizia, e non è un
caso, a nostro parere, che proprio in questa direzione si orientino ultimamente autori che si sono
dedicati con attenzione allo studio di Levinas, segno di una sensibilità diffusa a proposito dei nodi
più problematici di un pensiero che continua a suscitare fascino e suggestione. Si pensi, oltre al già
citato Abensour, al Derrida di Politiche dell'amicizia:11 emerge chiaramente la necessità di pensare
l'alterità senza dimenticare le pagine di Levinas, ma senza dimenticare neppure da un lato le
esigenze della dimensione politica e sociale in cui lo stesso Levinas situa l'agire umano, dall'altro il
bisogno di ricondurre il centro del discorso alla possibilità dell'azione giusta -- dunque all'attività -da parte del soggetto -- dunque all'io.
È allora in questa direzione che deve muoversi, a nostro giudizio, chi voglia davvero raccogliere
l'eredità di Levinas, evitando le secche dell'essere così come quelle dell'etica per non rimanere
bloccato in una dimensione come nell'altra. In questo modo potranno essere utilizzati davvero i
suggerimenti del filosofo lituano riguardo ai due problemi che risultano essere i veri temi di sfida
per quegli autori che -- a nostro avviso -- meglio hanno raccolto gli spunti delle teorie del
postmoderno: l'intersoggettività e la svolta verso la dimensione del politico. L'intreccio di questi
due temi sarà allora il punto nodale su cui rivolgere l'attenzione, per poter portare avanti la
riflessione oltre quei limiti per i quali Levinas, pur senza essere riuscito a percorrerla pienamente,
ha tracciato una possibile via.
Note
1.
E. Levinas, L'io e la totalità, in Entre nous. Essais sur le penser-à-l'autre, Grasset, Paris 1991; tr. it. Tra noi.
Saggi sul pensare all'altro, a cura di E. Baccarini, Jaca Book, Milano 1998, p. 47.
2.
Id., Domande e risposte, in De Dieu qui vient à l'idée, Vrin, Paris 1982; tr. it. Di Dio che viene all'idea, a cura di
S. Petrosino, trad. di G. Zennaro, Jaca Book, Milano 1983, p. 106.
3.
Id., Dialogo sul pensare all'altro, in Entre nous..., cit., p. 252-253.
4.
M. Abensour, L'Etat de la justice, in Magazine Littéraire, n. 419, aprile 2003, p. 56, traduzione nostra.
5.
E. Levinas, Filosofia, giustizia e amore, in Entre nous..., cit., p. 138.
6.
L. Ghidini, Dialogo con Emmanuel Levinas, Morcelliana, Brescia 1987, p. 54.
7.
M. Abensour, cit., p. 57, traduzione nostra.
8.
E. Levinas, Éthique et esprit, in Difficile Libertè. Essais sur le judaïsme, Albin Michel, Paris 1963; tr. it. parziale
Difficile Libertà. Saggi sul giudaismo, traduzione, introduzione e note a cura di G. Penati, La scuola, Brescia
1986, p. 23, traduzione nostra.
9.
Si confrontino ad esempio le pagine dedicate al tema della sostituzione in Altrimenti che essere [E. Levinas,
Autrement qu'être ou au-delà de l'essence, Nijhoff, La Haye 1974; tr. it. Altrimenti che essere o al di là
dell'essenza, a cura di S. Petrosino e M.T. Aiello, con introduzione di S. Petrosino, Jaca Book, Milano 1983, p.
123-163]: tale problema designa una dinamica bidirezionale, cioè da un lato il tentativo di sostituirsi all'altro
assumendosi la responsabilità di ogni sua azione o in-azione, dall'altro la necessità di «portare l'altro dentro di
sé», interiorizzando il comando e trasformandolo così in una norma che il soggetto, certo sempre debitore
originariamente nell'incontro, possa successivamente «trovare in sé». Ma questo processo presuppone
diacronia, ripetizione, storia: elementi che ci permettono di comprendere come proprio qui, al culmine della
sostituzione e del suo paradosso, ci troviamo nel momento decisivo del passaggio dall'etica alla giustizia. La
responsabilità universale deriva infatti dal sostituirsi all'altro in ogni suo aspetto, ma è proprio questa nozione di
responsabilità universale ad essere stata messa in crisi dal terzo: è quindi chiaro che è qui, nel nesso
problematico che si instaura fra il terzo e la responsabilità universale la chiave del passaggio dall'etica alla
giustizia.
10. E. Levinas, Autrement qu'être..., cit., p. 21-22.
11. J. Derrida, Politiques de l'amitiè, Éditions Galilée, Paris 1994; tr. it. Politiche dell'amicizia, traduzione di G.
Chiurazzi, Raffaello Cortina Editore, Milano 1995.
Tiziana Portera
L'il y a levinasiano e i suoi presupposti
interpretativi
1. Appunti metodologici
La ricerca delle suggestioni provenienti a Levinas dall'ebraismo esegetico, talmudico e posttalmudico, non può certo dirsi di tipo «dimostrativo». È mia convinzione che la ricchezza
semantica dei testi della tradizione ebraica costituisca una «fonte» alla quale non si attingerà mai
abbastanza nell'individuazione dei punti di riferimento non ancora esplicitati dell'ispirazione
levinasiana, ma non disponiamo a tale riguardo di attestazioni storiografiche che si riferiscano alle
particolarissime fonti che tratterò, se non talmente deboli o generiche da valere semplicemente
come indizi e non come «prove».
I prossimi paragrafi avranno come riferimento primo il substrato che precede -- e insieme
accompagna -- l'accoglimento del materiale testuale, il piano di sfondo che ha prodotto le fonti
stesse per come la critica le considera, e che vive e si ripropone nei testi e nella cultura che reggono
la vita religiosa del popolo del Libro.
Certo, sarà un percorso che a tratti coinvolgerà le opere d'ispirazione e di sollecito del pensiero
levinasiano nella maniera più classica del confronto stilistico e contenutistico, ma senza perdere di
vista la radice prima della composizione scritturale ebraica: affrontare e vivere interpretativamente
la parola e il reale.
E riguardo all'intimo legame tra testo, modalità genetiche del testo stesso e creazione filosofica,
poco è permesso di cercare nella direzione della «verifica» storiografica. Nessuna intervista, o
nessuno scritto autobiografico, ci restituisce la certezza che una tal nozione derivi, o sia
condizionata nei suoi caratteri definitori, dal particolare modo «ebraico» di pensare il termine
biblico o post-biblico che più gli assomiglia concettualmente (o sotto altri rispetti), ma che può non
essere in sé né filosofico né teologico.
L'intento che mi propongo è dunque di verificare secondo quali modalità e obiettivi determinate
unità semantiche subiscano, all'interno del pensiero levinasiano, delle trasformazioni in direzione
critico-teorica, e di determinare quali nuclei fondamentali permangano all'interno di una globalità
concettuale configurata ormai in veste spiccatamente filosofica.
Le modalità attraverso cui mi accingo a rinvenire e valutare tali elementi, sono fondamentalmente
estranee allo stile critico che ha caratterizzato finora i commenti e le analisi riguardanti il pensiero
di Levinas, e si indirizzano ad un piano d'indagine che è di rado frequentato dalla critica filosofica.
Ma credo che il tentativo interpretativo che propongo possa essere sostenuto da corrette verifiche
testuali e da opportune valutazioni critiche. Non perderò comunque di vista la razionalità filosofica
che conduce Levinas in ogni sua espressione teoretica, né l'esigenza dell'autore di tener viva
l'appartenenza al contesto culturale all'interno del quale si esprime e al quale, soprattutto, si
rivolge.
2. Esistenza senza evento. Paradosso e metafora
L'opera da cui muoveremo per inoltrarci all'interno del percorso critico del quale ho appena
tracciato il metodo è De l'existence à l'existant, prima opera interamente «propositiva» di Levinas.
Soddisfa appieno i requisiti dello scritto filosofico-critico, e per quanto -- per intenti e bagaglio
terminologico -- sia rivolta alle tematiche fenomenologico-esistenziali dalle quali trae alimento e si
sviluppa, tuttavia, ritengo che sia possibile tentare di rintracciare all'interno di quest'opera dal
linguaggio «occidentale», tracce di quello sfondo culturale che, pur rendendosi più evidente nella
produzione più matura, sottende al pensiero levinasiano fin dagli esordi.
In particolare, applico l'indagine semantica al concetto cardine di De l'existence à l'existant, che in
francese è indicato dall'espressione il y a, e che rivelerà, a seguito delle nostre verifiche, un
contributo alla sua formazione che ne mitiga fortemente la filiazione dal dialogo con l'ontologia
occidentale -- heideggeriana in particolare -- individuata dalla totalità della storiografia come
principale referente.
Lo stesso Levinas non può fare a meno di convogliare la nozione di il y a all'interno di
un'intenzione polemica che coinvolge l'intero percorso ontologico compiuto dalla Filosofia e di far
riferimento, coerentemente alla linea anti-heideggeriana dichiarata in De l'existence à l'existant, al
simile es gibt di Sein und Zeit. Occorre però non sovrapporre -- attraverso un'ottica identificatrice - le finalità e le modalità d'utilizzo del concetto di il y a, con le matrici genetiche che hanno
contribuito alla sua formazione. Per fare chiarezza sulla complessa concettualità che sostiene la
definizione dell'il y a, è bene rivolgersi direttamente al testo levinasiano.
L'estremizzazione dei toni relativi al peso ontologico, all'egemonia opprimente dell'essere sul
soggetto,1 caratterizza la produzione del 1946-7, biennio che vede la genesi di De l'existence à
l'existant e Le Temps et l'Autre. Si fanno più evidenti, rispetto alle opere precedenti, le prese di
posizione originali e si accentua il tono polemico nei confronti dei maestri tedeschi Husserl e
Heidegger.2
De l'existence à l'existant eredita dallo scritto del '35, De l'évasion, principalmente il tema
dell'uscita dall'essere (ora estremizzato e ricondotto alle radici del discorso ontologico sull'il y a) e
la sovrapposizione dei piani fenomenologico e teoretico nell'andamento espositivo.
Levinas, fin dall'Introduction dichiara che De l'existence à l'existant,
tenta di avvicinarsi all'idea dell'essere in generale nella sua impersonalità per analizzare poi la
nozione di presente e la posizione in cui sorge, all'interno dell'essere impersonale, come per effetto
di un'ipostasi, un essere, un soggetto, un esistente (EE 18).3
Permane in De l'existence à l'existant un'intenzione fenomenologica purificata, rivisitata, dalle
critiche mosse ad Husserl negli scritti degli anni trenta. La via fenomenologica viene adesso
utilizzata -- nella consapevolezza di un pensiero filosofico autenticamente originale -- per produrre
una tematizzazione, già tentata in De l'évasion, delle fondamentali determinazioni esistenziali.
La ricerca del concreto di matrice husserliana e la necessità di ripensare il rapporto essere-tempo
secondo prospettive che non possono più presentarsi come pre-heideggeriane, danno luogo ad
un'indagine esistenziale che richiede una nozione di essere alternativa, legata ad un'esigenza di
distacco dall'impostazione ontologica quale la si rinviene in Sein und Zeit.
Il cuore teoretico dell'inversione della differenza ontologica è l'il y a, l'essere privato di ogni
determinazione, anonimo ed impersonale. Da esso si distacca -- secondo una modalità soltanto
apparentemente «temporale» -- il soggetto, l'ipostasi.
La nozione di il y a è sì molto simile ad un risultato d'epoché, ma il suo estremo non è un ideale,
ma un esistenziale. Non soltanto il principio dell'indagine fenomenologica è esperenziale, lo è
anche il suo prodotto.4
Là dove il gioco incessante delle nostre relazioni con il mondo è interrotto, non si incontra, come a
torto si potrebbe pensare, né la morte, né «l'io puro», ma il fatto anonimo dell'essere. La relazione
con il mondo non è sinonimo dell'esistenza. Quest'ultima è anteriore al mondo. [...] parlare di
relazione, in questo caso, non è appropriato. Presuppone dei termini, e quindi dei sostantivi. E li
presuppone coordinati ma anche indipendenti. La relazione con l'essere le assomiglia solo in modo
molto vago. È una relazione per analogia. Infatti, l'essere verso il quale la scomparsa del mondo ci
rende vigili non e né una persona, né una cosa, né la totalità delle persone e delle cose. È invece, il
fatto che si è, il fatto che il y a. [...] è già esistendo che [colui che è] assume proprio questa
esistenza. Ma nonostante ciò, è vero che, nel fatto d'esistere [...] si compie un evento diverso e
preliminare di partecipazione all'esistenza, un evento di nascita (EE 26).
L'il y a, nel quale «si trovano ad essere confuse l'esistenza soggettiva di cui parla la filosofia
esistenziale e l'esistenza oggettiva del vecchio idealismo» (EE 20-21), opprime e costringe in una
«morsa soffocante come la notte». La sensazione che ne deriva «È il mal d'essere» (EE 28).
Levinas propone, attraverso questa nuova nozione di essere al neutro, una distinzione tra ciò che
esiste ed esistenza, che trova fondamento nell'al di qua dalla separazione alternativa tra essere e
nulla.
«L'il y a nous tient totalement» (EE 21). E questo possesso non diviene per il soggetto angoscia di
fronte al nulla della morte, ma orrore dinanzi alla presenza assoluta dell'essere impersonale privo
di ogni determinazione.
È del tutto originale la dialettica tra stasi e dinamicità, tra eternità, tempo e istante che sta alla base
del rapporto tra il y a e ipostasi. Una dialettica che costituisce la condizione imprescindibile
dell'indagine teoretica, e che è tale già dall'Introduzione ai termini stessi del problema filosofico
affrontato da De l'existence à l'existant:
La difficoltà di separare essere ed «essente» e la tendenza a considerarli l'uno nell'altro, non sono
di certo casuali. Derivano dall'abitudine di situare l'istante, atomo del tempo, al di là di ogni evento.
La relazione tra «essente» e «essere» non pone in relazione due termini indipendenti. L'«essente»
ha già fatto un patto con l'essere; non lo si può isolare. Esso è. Esercita già sull'essere lo stesso
dominio che il soggetto esercita sull'attributo. E lo esercita in quell'istante che, per l'analisi
fenomenologica, è indivisibile [indécomposable] (EE 16).
L'istante al quale Levinas si riferisce in queste righe non costituisce il tempo nel quale si realizza il
cominciamento, in cui trova spazio l'inizio dell'esistente. La prospettiva dalla quale si pone l'autore
oltrepassa la posizione della localizzazione cronologica e del dimensionamento temporale.
Continua Levinas nell'Introduction:
Ci si può chiedere se questa aderenza tra l'«essente» e l'essere sia semplicemente data nell'istante,
e se non sia invece realizzata mediante lo stare [la stance] stesso dell'istante; se l'istante non sia
l'evento stesso attraverso il quale nell'atto puro, nel puro verbo essere, nell'essere in generale, si
pone un «essente», un sostantivo che se ne rende padrone; se l'istante non sia la «polarizzazione»
dell'essere in generale. Il cominciamento, l'origine, la nascita, offrono proprio una dialettica in cui
questo evento in seno all'istante diviene sensibile. [...] L'istante non è un blocco, è articolato. È
grazie a questa articolazione che si differenzia dall'eterno che è semplice e estraneo all'evento (EE
16-17).
Evento ed eterno si differenziano in virtù della capacità del primo -- della quale è priva la
dimensione dell'eternità -- di «articolarsi», ovvero di accogliere in sé un'attività d'essere.
Quest'ultima è intesa quale atto peculiare della creatura (ipostasi) sorta nella passività. L'istante
impone -- nella sua determinazione di evento -- al soggetto sorto nell'istante stesso, di esercitare la
propria «padronanza» sull'essere.
Tale costituzione del soggetto -- insieme attiva e passiva -- riflette il carattere stesso del
cominciamento, il quale
non solo è, ma si possiede attraverso un ritorno su se stesso. Mentre si dirige verso la propria meta,
contemporaneamente, il movimento dell'atto si ricurva verso il proprio punto di partenza; proprio
per questo mentre è, si possiede. [...] Il suo essere si sdoppia in un avere che al tempo stesso è
posseduto e possiede. Il cominciamento dell'atto è già un'appartenenza e una cura di ciò a cui esso
appartiene e di ciò che gli appartiene. In quanto si appartiene può conservarsi, trasformarsi esso
stesso in un sostantivo, in un essere (EE 35-36).
La tangenza tra essente ed essere non si dà nell'istante, ma è lo stare dell'istante stesso. Esso non è
evento all'interno del tempo infinito: nell'eternità non se ne produce alcuno, al modo in cui senza
istante non ha luogo, nell'essere indefinito (indeterminato e senza accadimento come il tempo
eterno) la concretizzazione, l'ipostatizzazione del soggetto.
Che l'istante possa essere definito come polarizzazione dell'essere in generale, non significa che
l'evento che esso stesso costituisce ne derivi o ne venga prodotto. L'agente che è l'istante, al di là
dell'essere stesso -- inteso nella sua generalità --, deve a sé la polarizzazione dalla quale scaturisce,
e non ad una contrazione, o ad una delimitazione, compiuta dall'essere impersonale.
L'istante realizza -- transitivamente -- «l'aderenza tra l'essente e l'essere», ma è una realizzazione
che non va interpretata quale produzione oggettuale. La genesi dell'esistente avviene sia nel
(all'interno del) presente che col presente. La realizzazione alla quale Levinas si riferisce è la
«determinazione d'esistenza» effettuata in un presente capace di dare e possedere l'esistente
stesso.
Dunque, la realizzazione è sia un compimento di che un'attribuzione di realtà a. La «semplicità»
dell'eterno -- identificata con la sua estraneità all'evento -- ha il significato della incapacità ad
assumere in sé la duplice valenza posseduta dall'istante: quest'ultimo può insieme costituire in sé e
generare l'evento, «essere atto» e «stare» dando luogo all'esistente.5
Ecco allora che il verbo porre viene a perdere la carica oggettivante posseduta nell'idealismo per
assumere il significato di produzione di un evento, l'effetto della cui «polarizzazione» non è da
concepire come causato, ma come indistinguibile dalla sua sorgente.
Questo il sorgere dell'ipostasi dall'il y a nella sua difficoltà di venire da sé e insieme di procedere
dall'essere impersonale, di prendere esistenza in quell'istante che non è ancora una determinazione
temporale e nel farsi strada verso la coscienzialità con il peso ontologico sulle spalle. Il linguaggio
di Levinas -- lo abbiamo visto -- è «difficile», intriso com'è di termini fenomenologici e insieme di
concetti lontani tanto dalla fenomenologia quanto dal pensiero più autenticamente heideggeriano.
È un dire filosofico complesso, che concretizza spesso in immagini o metafore quel che è
impossibile comunicare nella lingua della filosofia senza che ne risulti una concettualità in sé
contraddittoria, o senza che venga comunicata un'idea talmente rarefatta nei suoi contorni da
sembrare più inafferrabile che nella sua espressione figurale.
Torniamo all'il y a. Cosa indicano, al di qua del soggetto ipostatico, le metafore visive che ci
indirizzano al c'è?
La notte e l'indistinzione oggettuale che segnalano l'il y a sono antecedenti alla comparsa del
«protagonista», l'ipostasi. È allora lecito chiedersi «che cosa è l'il y a»? Si può essere spettatori di
quel che ci precede? Si, se siamo spettatori esistenziali: conosciamo l'il y a perché in qualche
maniera, o in una certa misura, lo sperimentiamo.
Le «tracce» del nostro incontro o della nostra provenienza dall'il y a sono la pigrizia, lo sforzo,
l'insonnia. Ovvero i sintomi della mescolanza dell'indole dinamica dell'io coscienziale con qualcosa
di assolutamente immobile, indistinto e amorfo. L'il y a non è dotabile di definizione, appunto
perché niente è in esso distinguibile. Immobilità e privazione di eventi. Stasi eppure esistenza.
Il paradosso di un'immobile permanenza d'essere, a fronte di una vitalità generata al suo interno,
rappresenta la via per una comprensione non razionale, direi anzi istintuale, di quel che l'il y a
costituisce nel pensiero levinasiano. È la necessità di scontrarsi con la difficoltà della
comunicazione di un paradosso, che induce, quasi costringe, Levinas a ricorrere alle metafore
uditive o visive.
Quel che c'è, che è esistenza senza evento, e che è tuttavia lontano dall'essere immobile
dell'Ontologia quale classicamente lo conosciamo, rappresenta senza dubbio un paradosso tale da
richiedere al linguaggio un nuovo termine che non sia esistenza o essere, e che insieme li contenga
e li superi entrambi. Bisogna trovare il modo di dire che qualcosa c'è, ma cheè privo di
determinazioni, che non è ancora qualcosa eppure -- appunto -- c'è. Serve un verbo... anzi non
proprio un verbo, perché questo qualcosa che è non diviene. E non basta un nome, un sostantivo,
perché questo «essere» è pur talmente assoluto e pesante che riesce a schiacciare l'agitarsi
ipostatico, ed è tanto ingombrante da costituire un ostacolo tenace alla liberazione del soggetto.
Non siamo di fronte al fondo oscuro che sempre ci appartiene, al negativo che fa da contraltare
all'esistere quotidiano. L'il y a è di più. La sua attività è solo implicita, tanto da apparire inespressa,
è più «incombente» che effettivamente attualizzata. Il potere che deriva all'il y a dal suo stesso
modo d'essere è il potere paralizzante della notte, non l'abisso della privazione d'essere, ma la
presenza dell'oscurità che rende più angoscioso -- esattamente «terribile» -- il vuoto che è lì fuori
dalla nicchia nella quale troviamo riparo. Notte non è che il nome trovato a quell'insieme di
assenze, dalla luce alla vitalità, in cui nulla accade.
Abbiamo visto dunque come l'il y a entri a pieno titolo nel complesso dei termini che segnano, in
Levinas, la contrapposizione ai fondamenti teorico-ontologici della Filosofia della Totalità: quanto
di provenienza ebraica è presente nella forza mostrata da questo termine nel gioco demolitore
dell'«essere occidentale»? Quanto ha contribuito l'esser ebreo di Levinas nel fargli «trovare» il
termine che mancava, corrispondente a una nozione tanto distante da un verbo quanto da un
nome. È servita l'esperienza di studioso talmudista?
3. La verbalità e l'essere nell'ebraico biblico
La verifica richiede, innanzitutto, un'analisi della natura della verbalità ebraica, costitutivamente
differente da quella appartenente al nostro pensare «greco», e la cui peculiarità si riflette
esemplarmente nelle forme del verbo essere. Trascuro qui il percorso filosofico ebraico che molto
risente dell'influenza di questo particolare intendimento dell'essere, sia che lo consideriamo come
verbo, sia che lo pensiamo ontologicamente. Un approfondimento simile ci condurrebbe molto
lontano, e già le premesse fatte premono perché trattiamo l'argomento nella sua centralità.
Tratteggio dunque quasi subito, dopo qualche accenno al verbo essere nella lingua ebraica, lo
statuto terminologico dell'espressione yeš (c'è).
In via preliminare va chiarito come nella lingua dei Testi Sacri il verbo differisca da quello che
caratterizza le lingue indoeuropee. Difatti, esso deficia sia dei modi che dei tempi quali noi li
concepiamo.6 Il verbo ebraico denota, fondamentalmente, la completezza o incompletezza
dell'azione. Queste due caratteristiche vengono espresse, rispettivamente, dal perfetto e
dall'imperfetto, i quali, possedendo principalmente tale carattere denotativo, mostrano soltanto
secondariamente il proprio valore temporale. L'uso del participio, dell'infinito e dell'imperativo è
simile a quello delle nostre lingue classiche.
Il verbo mira soprattutto ad indicare la qualità dell'azione. Quest'ultima si esprime attraverso sette
differenti forme verbali che ne segnalano, ad esempio, la passività, l'intensità o la forza causativa.
Vale la pena di specificare che l'analisi della struttura testuale dell'ebraico biblico operata dalla
storiografia critica ha spesso condotto a quelli che il Barr definisce i luoghi comuni della linguistica
ebraica:7 la natura «dinamica» dell'ebraico, la centralità del verbo nell'espressione, il
fondamentale contrasto tra una costitutiva predominanza del senso del movimento (anche in
forme verbali che letteralmente indicano stasi) a fronte di un opposto pensiero «armonico», che
apparterrebbe, invece, alla cultura greca.8 Tali aspetti non sarebbero in realtà talmente
preponderanti da farne dei principi assoluti da applicare al mondo linguistico ebraico in maniera
radicale.
La questione rilevante è se sia fondato il presupposto secondo il quale è «assolutamente certo che
le lingue sono espressione del pensiero caratteristico dei popoli».9
È ad esempio convinzione di Boman che sia una peculiarità della lingua ebraica la caratteristica del
verbo di esprimere sempre una qualche forma di movimento.10 L'attività sarebbe significata dal
verbo anche quando questo indica uno stato d'immobilità o di quiete. Boman ne deduce che,
all'interno della cultura rispecchiata dalla lingua semitica, la relazione tra quiete e movimento è
intesa in maniera profondamente differente da quella espressa dalle lingue indoeuropee: non esiste
soggetto che sia del tutto privo di movimento. Anzi, «per gli ebrei un essere assolutamente privo di
movimento è nulla; [...] solo quell'essere che sia in intimo legame con qualcosa di attivo, con
qualche cosa in movimento è per loro reale».11
Contro questa direzione interpretativa -- secondo la quale nella mentalità ebraica «perfino il
pensiero riguardante ciò che è immutabile era profondamente impregnato dal pensiero riguardante
l'azione dinamica»12 -- Barr definisce illegittima l'opposizione fra «il fatto linguistico del verbo
ebraico che può indicare lo stato e/o il movimento e il fatto di natura logica o psicologica che noi
facciamo fra le due categorie dello stato e del movimento».13 Inoltre, le sovrapposizioni
semantiche tra stasi e attività sono presenti anche in altre lingue, per esempio nell'inglese, senza
che la distinzione logica ne sia per questo indebolita.14
Ecco un esempio scelto dal Barr sulla base di un verbo (yašab: stare seduto, sedersi) eletto dal
Boman a centro dimostrativo della propria teoria: allorché Dio viene definito come «yošeb hakkerubim», ossia «seduto sui cherubini», il senso del verbo non possiede alcunché di dinamico:
precisa Barr, Dio né «si sedeva», né «prendeva posto».
Ciò ci mostra che la possibilità di usare lo stesso verbo per indicare significati differenti «non
costituisce alcuna prova che la mentalità ebraica fosse incapace di distinguere in qualche modo
questi significati e che, di conseguenza, abbia un qualche valore il fatto che lo stesso verbo venga
usato ad indicare sia lo stato che il movimento».15 Dunque, dedurre l'incapacità di pensare un
essere assolutamente privo di movimento dall'utilizzo, nella lingua comune, di forme verbali di
ambigua espressione semantica, significa effettuare una forzatura ed introdurre una categoria
filosofica nell'ambito di un'indagine linguistica.
La questione è ulteriormente complicata dalla suddivisione, nella lingua ebraica, tra verbi stativi è
verbi attivi. I primi segnalano uno stato (e non una passività), i secondi indicano un'azione, una
mutazione, un evento.
Conformemente alle proprie posizioni critiche, Barr e Boman interpretano questa caratteristica in
maniera opposta: per il primo la distinzione è grammatico-morfologica, per il secondo concettuale.
Ma quest'ultima differenziazione non è intesa nel senso classico al quale ci siamo riferiti poco
sopra: il Boman effettua addirittura un capovolgimento delle caratteristiche distintive tra verbi
stativi e verbi attivi. L'azione indicata dai verbi stativi non è «statica». È anzi una permanenza
d'attività, uno stato di continuo divenire. Si tratta di un'attività «interna» al soggetto, potremmo
dire «non operativa», ma comunque dinamica.
Ho ritenuto opportuno riportare, nei termini essenziali, la polemica Barr-Boman per mostrare, in
maniera esemplificativa, attraverso quali presupposti teorici si possa affrontare la questione
dell'essere -- e del suo corrispettivo verbale -- all'interno del linguaggio biblico.
Il Boman appartiene al complesso della teologia biblica moderna che considera il pensiero ebraico
incapace di sviluppare e possedere un concetto di essere distinguibile da «questo qualcosa che
esiste», ovvero di concepire l'astratto corrispettivo dell'esistente. Questo giudizio si basa, oltre che
su indagini contenutistiche, sulla mancanza nella lingua di un termine che indichi, appunto,
l'essere distinto da ciò che esiste.
Hâyâh è il verbo che più è simile al nostro essere. Non siamo però in presenza di una piena
identificazione semantica: hâyâh viene utilizzato molto raramente come copula, più
frequentemente significa «accadere», «divenire». In più, in ebraico, l'uso della frase nominale fa sì
che non si ricorra alla copula, e dunque a una forma del verbo essere, per porre in relazione
soggetto e predicato.16
Quanto esposto finora, riguardo alle diverse modalità di interpretazione del verbo ebraico e alle
caratteristiche di hâyâh, ci è utile per poter meglio comprendere il nucleo di interesse principale, la
particella yeš con le sue particolarità semantiche, termine ebraico che permette di impiantare un
approfondimento di ricerca riguardo al discorso «ontologico» di De l'existence à l'existant.
4. L'il y a letto alla luce delle potenzialità semantiche di yeš. Impersonalità e averbalità
Quelle che da un punto di vista «occidentale» potrebbero essere definite le deficienze del verbo
essere (es. la rarità nell'espressione della copula), vengono supportate, all'interno del sistema
linguistico ebraico, dall'uso preponderante delle frasi nominali e dalle particelle yeš e 'ain (o 'ìn).
L'espressione indeclinabile yeš, che ha il significato di c'è,17 è di difficile definizione: «certamente
non è un verbo, ha alcune caratteristiche del nome e può essere resa in una traduzione
estremamente letterale con 'essere', 'esistenza'».18 Nel linguaggio concreto, il significato più
frequente è quello espresso da frasi del tipo «c'è un Dio in cielo»",19 nelle quali indica
un'«esistenza di», un «esserci» ma anche un «essere presente» nel senso opposto all'espressione
«essere assente».
Può segnalare anche la semplice localizzazione, come in «c'è un piatto sulla tavola»20 o -quest'esempio appartiene al Barr come i precedenti -- «in questo luogo c'è Yahweh».21 Le frasi che
ho appena riportato non permettono la traduzione di yeš con «esiste», come invece accade in «c'è
un Dio in cielo», proposizione in cui è evidente l'indicazione di esistenza.22
Ora, se la particella yeš non è esattamente un'espressione verbale, né tantomeno un sostantivo, né
un avverbio di luogo, è perché riunisce in sé le sfumature appartenenti a tutte queste componenti
grammaticali. Indica un'«esistenza di» senza che questa esistenza possa essere identificata con la
forma d'essere espressa dal verbo, e il cui corrispondente negativo 'ain ha il significato di «non
esiste».
L'indeclinabilità e l'invariabilità di yeš possono autorizzarne una lettura in chiave impersonale e,
contemporaneamente, «esistenziale» come accade nel caso dell'il y a levinasiano? Credo di sì. Ed
ecco di seguito le motivazioni per le quali propendo per una soluzione affermativa.
È vero che una corretta analisi semantica di yeš deve tener presente la sua distanza dalla verbalità
vera e propria. E tuttavia è pur vero che la traduzione con c'è, alla quale siamo costretti per
approssimarci il più possibile al concetto che yeš indica in ebraico, esprime palesemente la
componente verbale. D'altronde, l'uso che ne viene fatto all'interno del Testo Biblico non può non
imporre una traduzione siffatta.
Quali implicazioni comporta, a livello concettuale ed in relazione alle problematiche già esposte
relative al rapporto verbalità-essere, questa intersecazione tra espressione d'esistenza e nonverbalità nella particella yeš?
Il fatto che esista una comune parola ebraica per «c'è», e che, anche se non è proprio un nome,
tuttavia non è nemmeno con ogni certezza un «verbo dinamico», dovrebbe costituire una seria
difficoltà per coloro i quali hanno pensato, fondandosi sul primato e sul dinamismo del verbo nella
lingua ebraica a un senso dinamico dell'«essere» presso gli Ebrei; e quelli che così pensano hanno,
comunque, l'obbligo di prendere debitamente nota dell'esistenza di questa parola.23
Non ritengo opportuna l'estremizzazione che afferma «che il problema se gli Ebrei avessero il senso
di un 'puro' essere come distinto dall'esistenza attiva, non ha niente a che vedere col problema se la
loro lingua abbia o meno le parole per poter esprimere questo 'puro' essere!».24 Ma, tuttavia,
segnalo -- pur con cautela -- la posizione critica per la quale non esistono fondate motivazioni per
affermare che dalla sfera semantica di yeš si debba escludere il significato di «esistenza».25
Nei contesti frasali in cui non viene indicata da yeš alcuna affermazione di esistenza, ciò avviene in
virtù dell'originale elemento dimostrativo che inerisce geneticamente alla particella, e che «rende
naturalissima la sua connessione con determinazioni locali».26
Se «non esiste alcun motivo linguisticamente valido perché esse [yeš e 'ain] non dovrebbero
avvicinarsi ad indicare l'esistenza e la non esistenza assolute almeno in certi contesti»,27 risulta
una sorta di ambiguità semantica per la quale un non-verbo esprime un'esistenza che «si trova» e,
contemporaneamente, «è». Ma trovarsi ed essere, come esistere, sono nella nostra lingua delle
forme verbali, e non delle particelle indeclinabili. Una volta effettuata la traduzione dalla lingua
biblica, l'ambiguità alla quale abbiamo fatto cenno sparisce e la peculiarità del testo ebraico diviene
invisibile.
È il caso di notare poi come, in virtù dell'indeclinabilità della particella, non si possa attribuire ad
essa quel dinamismo che frequentemente -- come abbiamo avuto modo di verificare -- si attribuisce
alle forme verbali ebraiche anche qualora queste appartengano alla forma «stativa».
In sintesi, per affermare che qualcosa «c'è», o «esiste», l'ebraico non ricorre ad un verbo, ma ad
un'espressione la cui verbalità (ma non dinamicità) è soltanto implicita.
Siamo in presenza, dunque, di un'affermazione d'esistenza privata della verbalità attribuibile a ciò
di cui si sta predicando l'esistenza. Contemporaneamente, yeš possiede una marcata componente
«locale». Ecco allora le sfumature semantiche di yeš: esiste, esiste qui, si trova, è presente, c'è.
Quest'ultima espressione comprende, sinonimicamente, tutte le altre.
Yeš non coniuga un esistente, né unisce un soggetto ad un predicato. Ciò perché in nessun caso la
particella si utilizza direttamente in riferimento ad una modificazione del soggetto o per indicare
un mutamento di luogo o di stato.
L'esser-ci indicato da yeš convoglia la sfumatura semantica della localizzazione nel senso dello
stare-esistere, ma senza che tale essere o esistere ne significhi una qual forma di divenire o di
trasformazione. Non a caso ho utilizzato la polemica di Barr contro Boman per incanalare un
dibattito di stampo prevalentemente linguistico all'interno di una più ampia riflessione sulla
presunta, ineliminabile, componete «dinamica» della verbalità ebraica. La disputa fa sorgere il
dubbio che l'affermazione di una sorta di dinamicità assoluta, attribuibile indistintamente a tutte le
forma verbali ebraiche, sia in realtà l'estremizzazione di una tendenza che è sì presente all'interno
della lingua ebraica, ma che non è preponderante come spesso si è sostenuto. È più corretto credo,
senza per questo introdurre nel nostro discorso delle affermazioni di principio, pensare la lingua
nella sua evidente elasticità e concretezza.
Se la struttura linguistica ebraica permette di indicare un concetto «verbale» con una particella
indeclinabile che non è un verbo, ciò può darci delle indicazioni di massima sul modo ebraico di
concepire la dinamicità e l'essere, ma di certo non possiamo dedurre da ciò né che «l'ebreo»
pensasse per nozioni statiche né che non fosse in grado di pensare se non per concetti dinamici.
Quel che a noi interessa è cercare le sfumature che la particella in questione possiede allo scopo di
verificare se è possibile applicare ad essa una «lettura di tipo talmudico», e fare della potenzialità
semantiche di una parola ebraica lo spunto per un pensiero filosofico anti-greco.
Torniamo agli aspetti semantici di yeš cercando di tirare le somme di quanto detto finora. Se pur è
corretto che indichi l'esistenza,28 non è da trascurare che questa differisca da quella espressa dal
nostro «essere» per un'assoluta privazione di dinamicità e per un difetto di declinabilità. La
componente statica di yeš è poi accentuata dalla sfumatura «locale» in essa implicita,29 il che la
rende grammaticalmente più vicina ad un avverbio che ad un verbo.
Volgendoci a Levinas cercando di rintracciare segni dell'elaborazione di yeš nell'il y a, e in
relazione alla staticità «locativa» dalla quale deriva, in yeš, la coniugazione dello stare-esistere con
l'esser-ci, è il caso di segnalare che già in De l'évasion, in cui viene proposto un accostamento
singolare al «problema dell'essere in quanto essere», Levinas si esprime -- prima ancora che
apparisse il concetto di il y a -- in questi termini: «La verità elementare che c'è dell'essere (il y a de
l'être) -- dell'essere che vale e che pesa -- si rivela in una profondità che misura la sua brutalità e la
sua serietà» (DE 365).
Quel che qui rende interessante questa espressione di De l'évasion è che l'uso di il y a mostra di
possedere una funzione non semplicemente frasale: l'espressione impersonale viene utilizzata per
sottolineare la presenza assoluta e il gravame ontologico, per affermare l'esistenza di un essere
«esperito», il cui peso è oltre che disagio interiore anche certezza ontologica.30
Che, nella frase citata, «il y a» faccia parte integrante di un'espressione teoretica è testimoniato
dall'uso del corsivo, che non si limita a être, né viene esteso a tutta la frase, ma che riguarda la
concentrazione dei termini che significano la presenza ingombrante e «certa» dell'essere.31 Questa
stessa assoluta presenza verrà poi concentrata nella sintesi del semplice il y a di De l'existence à
l'existant, che ha meno «compromissione con l'essere» e vede invece potenziata l'insita omogeneità
statica e impersonale.32
L'il y a non soltanto è a-verbale, ma contagia con la sua inamovibilità l'esistente che da esso non ha
évasion.
E se verbalità significa attività, è proprio nell'agire nel tempo che il soggetto ipostatico è
indebolito.33 Si tratta dell'estinzione del soggetto che non deriva dal subire un'attività esterna, ma
dall'essere assorbiti, inglobati nella irremissibile negatività dell'anonimicità.
Scrive Jean-Luc Lannoy a proposito:
L'il y a è determinato come la gravità stessa dell'esistenza che ricorda al soggetto la sua artificiosità
(facticité) senza nome e la sua inassumibile contingenza. È il punto limite -- non fenomenico e al di
fuori del linguaggio -- di un esistere senza esistente, di un mormorio anonimo che si afferma e si
impone al di là del potere della negazione e che assorbe i tentativi d'evasione che suscita.
Il soggetto è relato all'il y a secondo una passività che è anteriore (non solo temporalmente) alla
responsabilità della sua assunzione.
Questa passività è la traduzione di una esposizione all'essere anonimo che vira in un intrico con
esso, di una aderenza all'essere [...] che investe il soggetto e immobilizza la sua intimità più
propria.34
Ripercorrendo e confrontando i significati di yeš e la pregnanza concettuale di il y a, potremmo
definire quest'ultimo come «l'evoluzione filosofica» del primo termine. L'il y a possiede difatti i
caratteri della particella ebraica trasformati in nozioni teoretiche.
Nel complesso della speculazione di De l'existence à l'existant, la nozione di il y a è il cardine del
successivo discorso sull'uomo e la base della polemica anti-ontologica che sarà una costante del
pensiero levinasiano. Azzardare l'ipotesi che un elemento teorico così sfaccettato possa provenire
da un'amplificazione concettuale di un termine ebraico con infinite potenzialità, ma in concreto
estremamente semplice e di uso frequente in una lingua «povera» e immediata, può destare
qualche perplessità. E ciò soprattutto nella mentalità critica che vuole la filiazione del teoretico dal
teoretico, e che non guarda di buon occhio supposizioni concernenti l'influenza di elementi e
strutture di pensiero non filosofici sul pensare prettamente speculativo.
Una severa interpretazione del testo filosofico vuole, a ragione, che una nozione filosofica venga
trattata per quel che è: un originale che va confrontato con i precedenti ispiratori e integrato
criticamente con la visione globale del sistema filosofico in esame. La formazione culturale
dell'autore è, in una prospettiva siffatta, importante; ma non bisogna mai dimenticare che si tratta
innanzi tutto di un filosofo, e che se stiamo leggendo e criticando un pensiero speculativo
rischiamo di fare un torto al pensiero stesso cercando di rinvenirvi tracce di elementi appartenenti
ad altre sfere del sapere, sia pure rivisitati e ricontestualizzati all'interno di un sistema filosofico.
Nel caso di Levinas la critica filosofica ha ritenuto necessario, opportunamente, di cercare molte
delle matrici genetiche nell'Ebraismo. Spingersi però ad affermare che anche i nuclei teoretici
espressi con terminologia fenomenologica o metafisica possano essere definiti -- secondo ottiche
evidentemente alternative -- anch'essi di filiazione ebraica è di certo diverso dal far derivare, ad
esempio, dal cosiddetto rigorismo della Torah la primarietà dell'etica nel pensiero dell'alterità.
Nel particolare del rapporto yeš/il y a, sarebbe superficiale affermare che il secondo è
semplicemente la traduzione del primo. Si tratta in realtà di un'evoluzione in direzione filosofica:
dalla parola nella sua essenzialità originaria alla sua connotazione in nozione complessa. Il
processo si avvia mediante la scomposizione delle caratteristiche prime del termine e la successiva
conduzione degli elementi che ne derivano in ambito teoretico.
La lettera, il significato primo, è «c'è». Dalla lettera ricaviamo gli elementi secondari, o meglio,
ulteriori: impersonalità, inamovibilità, congiunzione di affermazione d'esistenza e di localizzazione,
a-verbalità. Alcuni aspetti sono legati alla semplice funzione grammaticale, altri
all'approfondimento semantico. Ma sono caratteristiche che appartengono anche all'il y a
dell'opera levinasiana del '47. Appaiono elaborate in un linguaggio che è di certo quanto di più
lontano dal dire ebraico, sia nella struttura che nella terminologia; ma le peculiarità del
corrispondente ebraico sembrano trasferirsi alla versione francese in forma di definitori teoretici,
di connotazioni filosofiche. È come se -- non dico ancora che così è -- l'analisi scompositiva
applicata alla minuta parola ebraica avesse generato le caratteristiche prime e irrinunciabili dell'il y
a di De l'existence à l'existant. Ma perché ciò possa ritenersi plausibile occorre pensare il testo
ebraico non come un semplice spunto, né come una limpida fonte di suggerimenti.
È invece necessario concepire la parola come fa un talmudista, un esegeta che da un singolo
vocabolo sa far fuoriuscire i significati che la lettera a prima vista non possiede. Il talmudista non
traduce semplicemente, ma osserva il termine che esamina da più punti di vista, attraverso le
ottiche offerte da più livelli interpretativi, e ciò soprattutto quando (come nel caso di yeš) un
vocabolo è talmente poliedrico e versatile da suggerire al commentatore più di una lezione al di là
di quella letterale.
Così yeš non solo significa il y a, ma può divenire, sotto il martello interpretativo del
talmudista/filosofo, la sintesi dei suoi aspetti secondari e mostrare così, in sé, tutte quelle
caratteristiche che, divenendo contorni definitori, disegneranno l'esistenza impersonale teorizzata
in De l'existence à l'existant.
Note
1.
La terminologia levinasiana è, in De l'existence à l'existant, ancora condizionata dalla prevalenza -- se non
concettuale, certamente semantica -- del termine essere. Nelle opere successive l'uso delle espressioni
ontologiche sarà più prudente e, comunque, teoreticamente giustificato.
2.
Come opportunamente nota Giuliano Sansonetti, «Nella fase che stiamo analizzando, il pensiero di Lévinas,
perlomeno dal punto di vista formale e di approccio alle questioni, appare ancora fortemente influenzato da
Heidegger, anche se già l'ontologia sviluppata in EE si propone come un'esplicita presa di distanza dal pensatore
tedesco. [...] Tuttavia è più di un semplice schema formale ad indurre Lévinas a riproporre la tematica della
temporalità in stretta connessione con il problema ontologico. Si tratta piuttosto della consapevolezza del punto
di non-ritorno rappresentato, per questo aspetto, da SuZ; dell'impossibilità, in altre parole, di pensare l'essere
ed il tempo in forma separata per raggiungere solo in seguito a porsi il problema delle loro rapporto. [...] La
necessità di pensare unitariamente l'essere ed il tempo e di concepire i due termini all'interno di questa
connessione scaturisce, per il filosofo francese, direttamente dall'esigenza di pensare il tempo in modo
originario e non come 'degradazione dell'eternità'. [...] non devono tuttavia essere minimizzate le conclusioni in
buona parte originali a cui EE perviene. Per di più sono esse a costituire la base su cui poggia il discorso in
ordine alla temporalità di TA» (Giuliano Sansonetti, L'altro e il tempo. La temporalità nel pensiero di
Emmanuel Lévinas, Bologna, Cappelli, 1985, pp. 24-25).
3.
«Del resto il principio essenziale del metodo che adottiamo è proprio quello di analizzare a fondo l'istante, di
cercarne la dialettica che si inoltra in una dimensione ancora insospettata» (De l'existence à l'existant [EE],
Paris, Vrin, 1984, p. 42).
4.
Trattando dell'il y a Levinas presenta metaforicamente come notte, buio e altre figure d'indeterminatezza e
impersonalità, e attraverso le realtà fenomenico-esistenziali di fatica e pigrizia, un'assolutezza d'essere che è in
realtà ante-fenomenica: l'il y a è, in tal senso -- come si esprime Lawton -- il frutto di un'esperienza prepersonale: «Levinas vuole descrivere in termini fenomenologici un avvenimento, un'esperienza in qualche
misura pre-personale [...] che è dedotta piuttosto che vissuta» (Philip Lawton, Levinas' Notion of the 'There Is',
«Tijdschrift voor Filosofie», 3 1975, p. 481).
5.
D'altronde, «Il fatto di esistere [...] è dualità. L'esistenza manca essenzialmente di semplicità» (EE 37).
6.
Intendo tale mancanza non come una privazione, ma quale componente strutturale propria della lingua ebraica.
Il confronto con le lingue indoeuropee ha il solo scopo di rendere più agevole la comprensione delle funzioni
verbali.
7.
James Barr, Semantica del linguaggio biblico, Bologna, Il Mulino, 1961.
8.
Il Boman viene indicato dal Barr come il massimo rappresentante di questa corrente critica, con la sola
eccezione di un'attenuazione conciliativa dell'antitesi radicale ebraismo/grecità. Cfr. Thorleif Boman, Den
semitiske enknings egenart, «Norsk Teologisk Tidskrift», XXXIV 1933, pp. 1-34; id. Das Hebräische Denken im
Vergkeit mit dem Griechischen, Göttingen, 1952.
9.
Barr, op. cit., p. 24.
10. Non è mia intenzione prendere alcuna posizione in merito a questioni di critica linguistica, ma evidenziare in
quali sensi il sistema verbale ebraico possa essere interpretato più o meno conformemente all'universo
concettuale che gli è proprio: espongo, a proposito, le tesi contrarie del Boman e del Barr quali semplici esempi
storiografici. La scelta degli autori ha scopi esplicativi e non presuppone alcuna preferenza all'interno del vasto
panorama critico. Va tuttavia segnalato che l'opera del Boman, inizialmente favorevolmente accolta, è
fortemente influenzata da una concezione del linguaggio spiccatamente idealistica, oltre che da un taglio
psicologistico. Cfr. Mauro Perani, La concezione ebraica del tempo: appunti per una storia del problema,
«Rivista Biblica», 26 1978, p. 408.
11. Boman, op. cit., pp. 27-31.
12. Barr, op. cit., p. 76.
13. Ibidem.
14. Ma «l'illustrazione linguistica del contrasto esistente fra pensiero ebraico e pensiero greco è ottenuta non
attraverso un esame documentato e accurato della lingua ebraica, ma attraverso l'uso errato di categorie logiche
che non possono essere applicate al greco (o ad altra lingua europea) come a nessun'altra lingua» (ivi, p. 96).
15. Ibidem.
16. La frase così costruita sarà di per sé indipendente da precisi riferimenti cronologici.
17. Yeš viene tradotto con there is in inglese e con es gibt in tedesco.
18. Barr, op. cit., p. 89.
19. Ibidem.
20. Ibidem.
21. Ivi, p. 91
22. Ricordo che in nessun caso yeš viene usato con funzione di copula.
23. Ivi, p. 90.
24. Ivi, pp. 90-91.
25. Cfr. ivi, p. 91.
26. Ivi, p. 92.
27. Ivi, p. 93.
28. Ivi, p. 89.
29. Con ciò non intendo sovvertire il principio di una preponderante componente «dinamica» tipica della lingua
ebraica, ma fare dell'eccezione costituita da yeš il punto d'appoggio di una riflessione sull'assolutezza di tale
principio e sulla capacità di alcune forme semantiche di esprimere quel che si presume concettualmente assente
dalla mentalità ebraica.
30. Così in EE: «Le fait essentiel de la spiritualité humaine ne réside pas dans notre relation avec les choses qui
composent le monde, mais est déterminée par une relation qui, de par notre existence, nous entretenons d'ores
et déjà avec le fait même qu'il y a de l'être, avec la nudité de ce simple fait» (EE 19).
31. Nelle pagine di «Recherches Philosophiques», 5 1935-36, fascicolo che accoglie De L'évasion, l'espressione il y a
appare spesso, ed assume i connotati di una vera e propria espressione filosofica. Ma il senso è, in ogni caso,
quello «letterale» del semplice c'è, e non assume in alcun luogo la radicalità levinasiana caratteristica di EE. È il
caso di ricordare all'interno della pubblicazione del '35 sono presenti, quali autori, R. Poirier, H. Lévy-Bruhl, X.
Zubiri e G. Bataille. Le sezioni tematiche che accolgono gli articoli sono le seguenti: Méditations sur le temps,
De l'être et du savoir, De l'existence et de l'être.
32. Riguardo alla privazione della verbalità nell'il y a, lo stesso Levinas specifica che la corrispondenza con la forma
tedesca è formale e non sostanziale. Il senso del verbo geben è sottratto all'il y a, che non significa «la gioia di
ciò che esiste, l'abbondanza, un po' come l''es gibt' heideggeriano», «Al contrario 'il y a' per me -- afferma
Levinas -- è il fenomeno dell'essere impersonale: 'il'» (Éthique et Infini. Dialogues avec Philippe Nemo,
Librairie Arthème Fayard et Radio-France, 1982, p. 37). Cfr. Edouard Pontremoli, Sur l'«il y a» qui n'est pas
«Es gibt», «Etudes Phénoménologiques», 13-14 1991, pp. 165-187.
33. Questa passività, che è profondamente differente alla futura passività assolutamente passiva dell'etica
levinasiana, è radicale, nel senso che non è tramutabile, come nell'esistenzialismo, in alcuna forma di attività.
34. Jean-Luc Lannoy, «Il y a» e phénoménologie dans la pensée du jeune Lévinas, «Revue philosophique de
Louvain», 1990, p. 372.
Giacomo Bonagiuso
La soglia dell'esilio.
Asimmetrie di tempo e spazio nel Nuovo Pensiero
Il deserto, escludendo la dimora, apre alla erranza fondamentale dell'uomo l'infinito altrove. Qui,
nessun qui ha senso. E quando la voce umana s'eleva in questo centro annullato, avviene sempre,
in seno ad ogni parola, un combattimento tra Presenza e Assenza ed è l'Assenza che vince.
G. Bounoure, Edmond Jabès. La demeure et le livre, «Mercure de France», gennaio 1965.
1. Parricidio e alterità. Essere altrimenti e Altrimenti che essere
Queste note a margine1, lungi dal pretendere d'esaurire, o soltanto approssimare, la scorta critica
sul problema dell'alterità -- che è di certo il clinamen sul quale il Nuovo Pensiero, di matrice neoebraica,2 ha imbastito la propria proposta filosofica, anche prima della tragica esperienza della
shoà -- tendono esclusivamente ad annunciarne gli ambiti, nella consapevolezza di mancare ad
ogni possibile risposta esaustiva, come anche ad una definizione circostanziata dell'argomento. Si
cercherà soltanto di tratteggiare, almeno per grandi linee, i contorni della questione -- i suoi
margini, per dirla con Jabès -- così come essi s'inscrivono -- a partire proprio dalla loro origine
socratico-platonica -- all'interno di un certo ambito del pensiero filosofico contemporaneo; in
seguito si tenterà di fornire alcuni elementi utili a predisporre un possibile discorso su due figure -la soglia e il confine -- che ci sembrano rivelative del percorso ermeneutico che intendiamo offrire
prendendo spunto dalle opere di Franz Rosenzweig, Emmanuel Levinas ed Edmond Jabès.
Ed infatti, lo scenario della contemporaneità -- assunta qui come una categoria di permanenza ed
insistenza della domanda filosofica, piuttosto che come una semplice e tranquillizzante epoca
storica -- pur rilevando, al pari di ogni tempo, i segni della propria crisi, sembra comunque
caratterizzarsi per una sorta di fuga dal problema del senso. Tale fuga, alla fine, se sclerotizzata
come il tragitto principe di certa filosofia della complessità, rischia davvero di precipitare le
questioni stesse del senso e della ricerca in quel baratro senza ritorno qual è il nichilismo. Appare
evidente, almeno crediamo, che per crisi qui non s'abbia da intendere tanto un improbabile
ripiegamento della storia su se stessa, quanto uno sforzo di decifrazione dei macro-contesti e dei
micro-contesti in cui la stessa domanda filosofica attinge ogni risorsa di senso. Per questo, siamo
convinti che non possa darsi filosofia se non nella contemporaneità del senso e della percezione.
Sono questi, infatti, i prerequisiti che restituiscono l'orrido abisso postmoderno della complessità
verbale, al suo stato di prisma gravido, nel quale la contraddizione si fa risorsa e capacità di
questione. Si tratta, è vero, di intendere la filosofia come domanda, piuttosto che come esito
strutturato di matrice sistematica; e si tratta anche di corroborare la forza questionante del
filosofare come l'imprescindibile movimento di ogni vita -- per dirla col Socrate dell'Apologia -degna d'esser vissuta.
Perdendo di vista, infatti, il tema umano del senso delle cose -- e cioè, in campo etico, delle
relazioni, dei contesti valoriali, delle dinamiche intrasoggettive ed extrasoggettive --, si rischia
davvero di far smarrire alle categorie del pensiero filosofico l'ambito stesso all'interno del quale ha
la sua genesi profonda una delle esigenze più feconde della filosofia: l'alterità. Fuori dalle mode
epocali, infatti, il taglio obliquo della differenza -- in grado di spezzare l'autosufficienza del
pensiero ma anche di restituire capacità di parola alla dinamica di ogni pensare -- consegna
davvero la filosofia ad una profonda e invincibile responsabilità; e, si badi, non tanto ad una
responsabilità, per così dire, oggettiva -- una sorta di sguardo lungo gettato sulle cose, che ne
sancisca in qualche modo il possesso o la custodia --, quanto ad una responsabilità antropologica,
che nasce sotto gli auspici della crisi laddove intravede, intuisce o tocca l'altro-dal-pensiero, in
luogo dell'altro-del-pensiero.
Certo, riconoscere la realtà di questi specchi infranti, non più validi all'auto-celebrazione dell'iopenso, dell'io-posso e dell'io-voglio, significa ammettere l'urgenza di una conversione. Una
conversione che trae dal teologico soltanto la denominazione formale, perché essa, infatti, è una
sorta di movimento continuo tra ciò che io posso portare a me -- come dato di coscienza e persino
come soggetto di diritto, paritario se non proprio stereotipato in una griglia normalizzante -- e ciò
che non posso portare a me, semplicemente perché non-è-come-me, né tantomeno, forse, è-unaltro-me.
Indubbiamente, quel movimento, insieme epistemologico ed etico, che comprende, senza soluzione
di continuità, la ricerca/eros dell'altro e la fuga/riconoscimento dall'altro, è leggibile come
questione filosofica proprio a partire da quell'originario e fruttuoso momento di contaminazione
ontologica ed esistenziale che è il «parricidio«operato da Platone nei confronti del maestro
Parmenide;3 è qui, infatti -- nell'ibridazione suprema di un gesto «meticcio«che abbraccia in
spirale virtuosa il movimento dell'ontologia e il disconoscimento/riconoscimento filiale --, che il
lògos comincia a caricare su di sé la responsabilità di pensare, e di dire, l'altro: come èteron e come
àllos.4
Pensare e dire il non-essere, oltrepassando in senso drammatico il divieto parmenideo, significa
quindi -- forse già originariamente in senso pienamente ellenico --, pensare e dire un altro essere, o
meglio, un essere-altro, che mette in questione la totalità dell'essere, costringendo (o convincendo) il lògos a farsi dià-logos, la parola a farsi dis-corso, il tragico a farsi sentimento.
Il lògos monista degli Eleati, infatti, nega l'altro dall'essere e, con esso, anche la realtà del
movimento -- e, quindi, anche la verità del tempo -- poiché considera l'essere come un «Uno», un
Tutto immobile ed eterno. Se l'essere è un Tutto originario, ogni movimento si riduce ad una sorta
di apparenza. Un Tutto, infatti, non può muovere oltre se stesso; ogni tensione, ogni desiderio, ogni
conversione, ogni appello, gli sono negati in quanto implicherebbero un passaggio da ciò che è a ciò
che non è. Ma ciò che non è, appunto, non è; poiché nulla vi è oltre l'essere del Tutto.5
Con il parricidio platonico, il lògos è, in certo qual modo, costretto a convertirsi al riconoscimento
di un'alterità originaria, non posta dall'essere -- seppur vissuta, ancora nell'essere, come
chorismòs, e quindi anche come differenza --, ad una sorta di essere plurale ab origine. Esso potrà
articolare la sua prima parola nei termini di un appello, di una interlocuzione, di una chiamata, e
dunque di un movimento, di una tensione. Il lògos, dunque, non sarà più il garante tout court
dell'autoreferenzialità, quanto piuttosto colui che apre la comunicazione, colui che chiama l'altro
(fosse anche il vuoto assoluto che l'esitenzialismo sartriano ha dipinto come inferno), colui che
interpella, colui che si rivolge all'altro da sé, anche nel mancare di ogni altro, sia per l'impossibilità
di determinarne la posizione, sia anche per l'improprietà del sistema di coordinate in cui l'altro
non-si-pone, non-si-dà. Il lògos si riscopre, dunque, e proprio a partire da questa indisponibilità
dell'altro, già in Platone (ed anche sulla scorta della filosofia socratica) come dià-logos.
È evidente che un tale lògos, già plurale nel suo aver bisogno dell'altro -- e del tempo nel quale
rivolgersi all'altro che già da sempre gli è posto di fronte come assente, indisponibile ovvero
trascendente --, lungi dall'essere originariamente un'arrogante posizione di sé, sarà principalmente
discorso, narrazione. Certo, egli potrà indubbiamente porre se stesso come un «Uno«assoluto, ma
potrà farlo solo in quanto avrà risolto il discorso originario in monologo, la parola che chiama e
riconosce, in parola che esclude e disconosce, la pluralità in totalità. In altri termini, concesso pure
che non ci sia altro oltre se stesso, sarebbe proprio questo nulla a far da sfondo necessario alla voce
di chi, disconoscendo dice, negando afferma, ponendo se stesso si circoscrive come tra, come
infra.
Non a caso, la forma originaria del lògos poetico assume le vesti dell'eroe tragico. Un eroe solitario
e chiuso in se stesso, incompreso ed incomprensibile nelle ragioni profonde del suo dolore e della
sua colpa. Si pensi ad Edipo, dal cui incesto e dal cui parricidio si scatenano vicende tragiche
infinite. Un tale eroe resta assolvibile dall'etica contemporanea -- in tale direzione sembra andare
anche la lettura offerta dalla Nicomachea6 -- sul versante dell'intenzione: egli non sa, infatti, che
l'uomo sul carro è suo padre e che la regina vinta, che egli sposa, è sua madre. E tuttavia, per l'ethos
dei tragici greci, la sua colpa si staglia come hybris nei confronti delle divinità originarie del sangue
e della terra.
Proprio per questo, quando il lògos, con Platone -- o forse, secondo recenti letture, già con Socrate7
-- si scopre come dià-logos, e la parola rinviene la sua originaria vocazione discorsiva e narrativa, al
tragico si affianca il sentimentale. Ma il sentimento che anima la narrazione, rispetto alla catarsi
invocata dalla tragedia, è un syn-titemi, un con-sentire, un «sentire insieme«che si fa racconto del
proprio e dell'altrui mondo, per ciò che se ne può ipotizzare o presumere, che sfida
l'imperscrutabile della vita con le armi della relazione. Si narra, infatti, sempre di qualcuno e per
qualcuno: quell'altro senza il quale il racconto -- come anche il tempo del suo accadere -- non ha
più alcuna ragion d'essere.
L'alterità, dunque, entrata nella prassi della filosofia già con Socrate, e nella scrittura a partire da
un atto teoretico forte -- qual è sicuramente un «parricidio«8 --, inscrive nel dominio dell'essere
una sorta di frattura, una ferita originaria che, aprendo un varco nella totalità esclusiva ed
escludente dell'essere del tutto, rende instabile la signoria di un lògos monovalente ma, anche, il
potere reale di comprensione dell'altro e delle sue ragioni. Qui, com'è evidente, il piano ontologico
dell'essere risulta infranto proprio dall'irruzione di una soggettività plurale, dialogica, relazionale;
una soggettività che, quindi, ha da reinterpretare il rapporto Io-Tu fondato classicamente (o, forse,
solo «occidentalmente») sulla prevalenza e originarietà dell'Io.9
Infatti, l'alterità dell'altro essere può venire intesa dalla filosofia non solo come una sorta di alterego, una specie di riflesso identitario del «Sé», un altro essere identico all'essere dell'Io che lo
pensa, ma anche come un essere altrimenti -- o addirittura un altrimenti che essere10 -- che
rischia davvero di mettere in crisi le categorie di comprensione sulle quali la filosofia ha costruito la
sua sistematicità prospettica e simmetrica, nonché il suo rigore epistemologico.
In effetti, il pensare all'alterità come altrimenti che essere, piuttosto che come un essere altrimenti,
è rivelativo di una differenza sostanziale che il gioco di parole rischia di rendere soltanto estetica.
La questione dell'alterità intesa come un essere altrimenti, in certo qual modo, salvaguarda ancora
l'unicità dell'essere in cui questa differenza ontologica è articolata. Infatti, la metafisica platonica -pur inscrivendo nell'essere il taglio obliquo della differenza e dell'alterità (la dialettica tra èteron e
àllos cui si faceva riferimento prima) -- resta pur sempre una metafisica del fondamento e
dell'essenza. L'essere altrimenti è, in buona sostanza, l'essere visto solo da una prospettiva
differente, l'essere determinato da qualità, quantità, relazioni e modalità diverse. In tal senso, la
dialettica per il riconoscimento, di stampo hegeliano, rappresenta una ripresa della differenza
inscritta nell'identità di essere e pensiero. Secondo Hegel, infatti, il vero è quell'intero che diviene
tale dal punto di vista logico-gnoseologico -- ma che è già tale sul versante onto-teologico -attraverso una dialettica, per così dire, interna; attraverso un procedere che è, in verità, un
arretrare; attraverso un mediare dialettico che è un giungere/retrocedere all'essenza. Ogni fuori di
sé è così inteso come una sorta di movimento apparente che trova la sua vera ragione precipitando
in «un risultato calmo».
La prospettiva di pensiero all'interno della quale, invece, è maturata la provocazione dell'altrimenti
che essere, rifiuta -- come si sta cercando di mostrare -- la questione del fondamento e dell'essenza
come radice di senso dell'essere.
Inoltre, la scoperta di un essere-altro -- che ha, in tutta evidenza fenomenologica e antropologicoculturale, ragioni-altre e logiche-altre rispetto a quelle attraverso le quali il lògos lo pensa e lo dice
-- come interlocutore inquietante di un Io che ha superato il narcisismo del rispecchiamento -- e
che è dunque pronto al trauma (o al desiderio) dell'incontro11 con un altro talmente altro da
essergli trascendente (cioè sussistente a prescindere dall'Io) -- inscrive nel pensiero, nel linguaggio
e nella morale una sorta di cuneo: per la prima volta, infatti, si rende visibile alla filosofia la
possibilità di un altro linguaggio, di un altro pensiero e di un'altra morale.
La storia dell'essere diventa quindi frastagliata al pari di una Teogonia, fitta di diramazioni e
racconti incrociati, di affluenti ed esiti incerti. Ora, è proprio questo cuneo, questa sorta di scheggia
originaria che, pur facendo crollare il fondamento di quella totalità intesa come «Uno«armonico e
monovalente, ri-fonda il lògos come dià-logos originario e la filosofia come originaria narrazione.
Inoltre, se è vero che già a partire da Socrate e Platone è possibile ridiscutere la questione
dell'identità e dell'alterità, oltre ogni esito eleatico, la stessa filosofia non ha affatto da ridisegnare
interamente il suo statuto, quanto piuttosto da operare una sorta di passo indietro rispetto agli esiti
più sorprendenti dei vecchi e nuovi idealismi, per riscoprire la sua originaria vocazione
ermeneutica, narrativa e dialogica.
Il novecento filosofico ha ridiscusso a lungo tale questione, facendone spesso «il problema«centrale
del Nuovo Pensiero. Insomma, il problema dell'essere -- abbandonata la chiave monistica di
matrice parmenidea e di esito idealistico -- si dirama ulteriormente; l'essere-altro di un altro essere
«di cui«il lògos vuol fare concetto, si traduce in ultima analisi nell'altrimenti che essere «con cui«il
lògos vuol fare discorso.
All'interno di questa nuova prospettiva del pensiero si ridefiniscono anche gli argini della filosofia e
della comunicazione. Dalla messa in questione dell'ontoteologia dell'essere-Uno, il pensiero
filosofico approda ad un'etica originaria che si assume la responsabilità12 di un dia-logo tra
«irrelati«che sperimentano in modo asimmetrico la trascendenza, tra «altri«che sono ancora in
grado di coltivare lo stupore tipico del filosofare, in quanto sorretti nella loro relazione da una
trascendenza che disarma il loro potere di porre o deporre l'altro e le sue, spesso intraducibili,
ragioni.
La filosofa si traspone, quindi, in una vera attesa di senso da parte di un altro effettivamente in
grado di sorprendere l'Io. Un altro la cui rivelazione etica diventa, per l'Io, imprescindibile atto di
responsabilità. Ma anche l'alveo della comunicazione viene ridefinito dalla ripresa di questo nuovo:
ad un tragico inteso come esperienza limite dell'Io posto a confronto con la tracotanza della hybris
e con l'ineluttabilità della Moira, si affianca quel sentimento inteso come condivisione e riscatto,
come apertura alla rivelazione di senso che l'altro è, e dunque, anche come pentimento e
redenzione.
2. Asimmetrie di tempo e spazio. La soglia e il confine
Ora, è proprio a partire da questo nuovo, tuttavia, che il problema dell'alterità -- così ridisegnato
sotto i profili della filosofia e della comunicazione -- dischiude ulteriori problemi che rischiano di
stemperare l'autenticità di questo novum, rendendone la prassi e la frequentazione irrealizzabili e
dunque utopiche.
Insomma, se il nuovo che l'essere attende come dono e rivelazione dall'essere Altro, diventasse solo
lo sterile pegno di un meccanismo governato dalla regola del do ut des, e quindi solo una questione
di prevedibilità quantitativa, la verità della relazione finirebbe per dileguarsi, lasciando trasparire
di fronte al soggetto soltanto la pallida ombra di un alter-ego. D'altro canto, se questo dono, questa
rivelazione di senso, si consumasse nell'attesa messianica d'una pro-messa -- che è sempre e
comunque da venire e mai un possesso certo o una «ripresa«del finito13 -- la filosofia rischierebbe
di cadere in una sorta d'esigenzialismo di matrice mistica.
La soglia e il confine -- come figure d'un possibile rapporto -- descrivono proprio quest'imbarazzo;
esse non rispondono, ancora, alla domanda del lògos su che cos'è questo spazio e che cos'è questo
tempo che uniscono e separano l'essere dall'altrimenti-che-essere, ma cercano di ridisegnare la
scena del confronto.
E, d'altra parte, è quantomeno da segnalare la proposta filosofica -- maturata appunto nell'ambito
del cosiddetto pensiero neo-ebraico -- che vuole se non altro esporre in tutta la sua fecondità la
paradossalità sopra esposta, ricercando una nuova domanda per la filosofia; una domanda che
rinunci, nella sua premessa, all'essenza della cosa -- indagata tramite il che-cos'è di matrice greca -per cercare piuttosto il com'è andata della relazione, tipico della narrazione figurata del pensiero.
Le immagini della soglia e del confine, infatti, approcciano -- tramite la differenza contenuta nella
loro semantica -- al medesimo spazio-tempo di relazione: quello che unisce e separa l'Io dall'Altro
[d'ora in poi, con Altro/i in maiuscolo intendiamo l'altrimenti che essere], il point of view
sull'essere dell'uno e sull'essere dell'altro. Il confine riprende questo iato come cesura, come ferita;
esso si stabilisce nell'essere come «parte», come «frontiera». Il confine, dunque, separa, rende altri
tutti coloro che si riguardano attraverso di esso. Il confine è sì valicabile, frequentabile dall'una
all'altra parte, ma è proprio nel frequentarlo come spazio da varcare che lo si dilata come spazio
della lontananza.
Il confine come cum finis, come parte rispetto ad un'altra parte, è dunque l'immagine di una
distanza che si realizza nella prossimità. Una distanza qualitativa, ché in verità il confine non ha
dimensione né estensione fisica concreta: esso è, di fatto, una co-appartenenza, un co-dominio, un
comune (cum munus) che -- proprio in quanto comune -- separa, divide e, proprio per questo,
rende traducibili il proprio e l'altrui. Ma la traduzione che il confine implica -- linguistica,
esistenziale, economica, culturale, artistica -- è sempre una trans-duzione d'essere e di senso,
poiché implica un portare l'altrui all'interno del proprio. Proprio per questo il confine è la frontiera,
il fronte del proprio, il limite del possesso, e l'inizio, al tempo stesso, del possesso che Altri hanno
su altro.
Il confine è, dunque, il limite inconsistente del proprio -- che proprio in forza di questa
inconsistenza è da proteggere --, e, per ciò stesso, esso si inscrive come il cominciamento del nonproprio. Non a caso, la parte, il fronte, che la frontiera separa, è anche lo spazio della guerra,
dell'aggressione e della violenza. E che altro è la guerra se non il fallimento di ogni traduzione?
La soglia, invece, pur rappresentando su un altro registro semantico quella stessa linea di
comproprietà tra il proprio e l'altrui, e non nascondendosene i tratti di conflittualità e di contesa
originaria, addita più da vicino l'immagine della porta e della casa. La soglia, infatti, traspone il
concetto di ferita originaria dall'ambito geopolitico degli stati a quello esistenziale della dimora. Il
proprio designato dalla soglia è quello che l'Io ha costruito e, in un certo senso, inventato, al di qua
della propria porta di casa. Alla soglia afferiscono, infatti, l'immagine della custodia -- piuttosto
che quella della difesa -- ma anche, e soprattutto, l'immagine dell'ospitalità -- piuttosto che quella
della traduzione --.
La soglia implica la frequentazione della via d'uscita e di quella d'entrata, l'esodo e il ritorno, la
galuth (l'esilio veterotestamentario, ma anche, significativamente, in lingua ebraica, la rivelazione)
e il nòstos (il ritorno periglioso di Ulisse a Itaca). Anch'essa è un'inconsistenza. La soglia, infatti,
non esiste se non come membrana d'osmosi; essa è, al tempo stesso, l'inquietudine dell'uscir fuori
da Sé e la festa per essersi trovati finalmente in una nuova casa (su questa nuova casa, diremo in
seguito appoggiandoci a Levinas). La soglia è il rischio che ogni partire porta seco e la
rassicurazione del ritorno. La soglia, inoltre, è sempre in limine rispetto alla porta, così come la
porta è in limine rispetto alla casa.
E tuttavia, se fosse pur vero che ogni uscire da sé comporti sempre e comunque un ritorno a casa -ché, come usa dire, si parte sempre per tornare, e si torna sempre per partire --, è vero altresì che la
casa alla quale si ritorna è sempre e in qualche modo diversa rispetto a quella che si è lasciata, così
come colui che torna, ritorna diverso da quello che ha intrapreso il viaggio.
E comunque: è davvero possibile articolare una dialettica convincente tra l'essere e l'altrimentiche-essere, tramite la figura della soglia?
Poniamo per un istante che l'essere sia il padrone di casa. Egli, per se stesso, potrà certo rinunciare
ad ospitare Altri nelle viscere del proprio -- facendolo accomodare nella propria casa, tra le proprie
poltrone, le proprie seggiole, la propria caraffa e il proprio caffè -- e potrà sicuramente andargli
incontro sulla soglia. Così, Altri, sulla soglia, non sarà più estraneo, ovvero ostile, ma straniero,
esule, così come esule e straniero si presenterà -- sulla soglia, come in procinto di lasciare il
proprio -- il padrone di casa. Infatti, sulla soglia, per un istante, il proprio è sospeso.
Ma che succederà allorquando, nell'intesa tra due, compaia d'improvviso il «terzo». Ovvero: che
succederà quando, oltre alla comprensione tipica della filosofia, sulla soglia si presenterà anche
l'esigenza della comunicazione? Quando l'essere e Altri dovranno comunicare al «terzo«quel
proprio che ciascuno ha in qualche modo sospeso?
«Sotto lo sguardo della terza persona, sia esso rivolto verso l'esterno oppure verso l'interno, tutto si
congela in oggetto», è questa la sentenza habermasiana che sembra gravare su ogni comunicazione;
su ogni sguardo lungo che il soggetto tenti davvero di gettare al di là di se stesso, e che rischia di
cristallizzare in oggetto tutto ciò che incontra.14 Quanto questo sguardo possa oggettivare Altri,
ovvero quanto la ratio del soggetto possa davvero conoscere, piuttosto che riconoscere, il Volto
nella sua trascendenza assoluta, è la questione par excellence che l'etica del Secondo Novecento ha
consegnato ad una riflessione futura.
Qui basti notare come lo iato sottile che s'incide tra conoscenza -- ovvero: un atto teoretico del
soggetto nei confronti di un altro soggetto, descritto e definito come simmetrico e paritario, e
quindi ridotto ad oggetto, o di un oggetto propriamente detto -- e riconoscimento -- ovvero: un atto
etico gravato dalla responsabilità per un Volto nudo che posso distruggere ma non togliere, che
posso uccidere ma non mediare -- è la cartina di tornasole cui tornano i due scenari della filosofia
della differenza: il primo, quello che da Platone, attraverso Hegel giunge fino a Nancy; e il secondo,
quello che da Aristotele, tramite l'ultimo Schelling, giunge fino a Levinas.
Se è precipuo dovere del pensiero filosofico non dimenticare il monito kantiano dell'altro inteso
come fine dell'atto morale e mai come semplice mezzo, è parimenti vincolante -- per la ricerca
filosofica -- tratteggiare quest'Altro come «assolutamente altro», e non come un me-stesso
rovesciato, come un altro-Io (e si noti, davvero, come la parola Io, sovrapposta alla parola altro,
distrugga ogni differenza che Altri potrebbe recare), al quale mi legano diritti che sono per lui
doveri, e doveri che sono per lui diritti.
Riconoscere, nell'accezione responsabilizzante che abbiamo cercato di descrivere, significa, per il
pensiero, mettersi in discussione, aprirsi alla multiformità anche culturale dell'ambiente e delle
società, alle cifre lessicali delle civiltà e ai tempi (agli eventi) delle rivelazioni. Riconoscere significa,
dunque, riconoscere come Altro e non già come un altro me stesso. Se ciò comporti anche
quell'arretramento di campo di cui si è discusso prima, è fattore da determinare in relazione a
quanto l'egologia fondamentale (e talvolta fondamentalista) ha proceduto nell'esproprio dell'altrui
spazio, nel disinteressamento per l'altrui tempo.
Certo, con l'ingresso del «terzo», nota già Levinas, si manifesta anche il bisogno di regole.
Si tratta dell'apparizione del terzo. Poiché c'è il terzo. Mi chiedo talvolta se esso non si giustifichi
così: rendere possibile una responsabilità per altri dis-interessata, esclude la reciprocità; ma altri
sarebbe senza dedizione all'altro? Qui occorre un terzo. Comunque sia, nella relazione con altri, io
sono sempre in relazione con il terzo. Ma esso è anche il mio prossimo. A partire da questo
momento la prossimità diviene problematica: occorre paragonare, pesare, pensare, occorre fare
la giustizia, sorgente della teoria. Il recupero delle Istituzioni -- e della teoria stessa -- della
filosofia e della fenomenologia: esplicitare l'apparire -- tutto questo avviene, secondo me, a partire
dal terzo. Il termine «giustizia«è in effetti molto più a suo posto là dove è necessaria non la mia
«subordinazione«ad altri, ma l' «equità». Se è necessaria l'equità, allora è necessario il paragone e
l'uguaglianza; l'uguaglianza tra ciò che non si paragona. E di conseguenza il termine «giustizia«si
applica molto di più alla relazione con il terzo che non alla relazione con altri.15
Abbiamo bisogno di leggi, di un buon diritto che tuteli la comunicazione e metta regole al nostro
fare; ma si tratta dell'istituzione di una «giustizia«che sfocia in «equità», sancendo, appunto,
l'eguagalianza de jure e de facto rispetto allo sguardo del terzo, giammai tra ciò che non è possibile
paragonare.
Come a dire: bisogna che l'etica originaria dell'incontro sia suffragata dal diritto e dalla politica.
Affinché quell'utopia (da ou-topos, non luogo) che la soglia originariamente evoca (poiché il dialogo si fa sempre inter-logo e i due diventano molti all'interno di un mondo sempre più globale),
possa diventare una differente utopia (da eu-topos, luogo felice).
3. Per una fenomenologia dello sradicamento. Lo straniero jabesiano
Il chiosare queste riflessioni minime, presentando una pur provvisoria ricognizione sulla
«scrittura«di Jabès,16 scrivendo quindi di Jabès, costituisce forse una irriguardosa forzatura, un
tentativo di esclusione dello sguardo laico del suo pensiero, della sua poesia, una geometrica
edificazione di ponti concettuali tra la parola, il silenzio e la parola-altra, e quindi un tentativo di
esorcizzare l'abissale questione del «niente», del «vuoto«che abita i margini della scrittura
jabesiana.
Inutile, forse, sottolineare, come qui si voglia intendere «laico«nel suo significato originariamente
greco, ovvero «aperto». E mai aggettivazione sembra, in effetti, calzare meglio con la riflessione di
Jabès, espressa talvolta tramite il modulo della poesia, tal altra tramite il modulo del Cahier, del
quaderno, tal altra ancora tramite il margine stesso della pagina del Livre, che descrive -- o meglio,
evoca -- quel senso di «interpretazione coinvolgente«in grado di sfiorare il conflitto. Difatti,
chiunque si imbatta nella scrittura jabesiana incontrerà, in primo luogo, il vuoto piuttosto che il
pieno, il silenzio invece che la parola, il margine piuttosto che la scrittura. Ma vuoto, silenzio e
margine sono, in effetti, caratteri propri del segno di Edmond Jabès, e questo al di là di ogni facile
retorica che ne confini il senso ad una sorta di edificazione religiosa o, peggio, di catarsi
esistenziale.
Vorremmo solo notare, in via preliminare, che l'interpretazione e il conflitto, entrambi evocati dalla
scrittura/lettura jabesiana, si riferiscono in maniera quasi duale alla prassi, oramai storicizzata, del
Nuovo Pensiero (Das Neue Denken). Se è vero, com'è vero, che Jabès scoprì, o comunque mise a
tema, il suo «ebraismo«in un secondo momento rispetto alle categorie portanti della sua opera, ciò
consente di riconoscere proprio in queste categorie il segno «laico«dell'interpretazione, ma
consente anche di restituire al pensiero ebraico una sorta di centralità filosofico-ermeneutica,
laddove invece si è spesso soliti negargli ogni consistenza, relegandone gli ambiti esclusivamente
alla mistica o alla prassi liturgica delle scuole rabbiniche. Certamente, la scrittura, per Jabès, è
sempre in qualche modo una lettura; così come una traduzione (e, forse, anche una tradizione)
comporta sempre un tradimento iniziale, o comunque ne porta a termine uno, nella misura in cui
si riferisce conflittualmente ad una pluralità di lettori e di vissuti.
Scrivere su Jabès è dunque una metabasi, un traslare in «città«il pensiero nato, o comunque
riconosciutosi, nel «deserto», un costruire sistemi viari, «boulevards«e «avenues»,17 all'interno di
un costrutto prettamente evocativo. Scrivere di Jabès è quindi, forse, una indebita traduzione
spaziale di un pensiero che origina dal tempo, una localizzazione cardinale di un percorso che -lungi dall'essere un moto da A a B -- è un esodo da sé che sfiora l'alienazione intemporale del
deserto.
Proprio per questo, scrivere su Jabès, scrivere di Jabès, comporta una necessaria inscrizione del
lettore nella sua stessa lettura, se è vero che «scrivere«e «leggere«in ebraico differiscono per
null'altro che una sfumatura della medesima radice,18 e se è vero che quel «margine«cui Jabès
stesso allude come soglia della propria scrittura è una sorta di viaggio valido soltanto nel suo essere
frequentato dall'altro: «Io non è l'altro. È io. Scavare questo Io: tale è il compito che ci spetta».19
Certo, il deserto, dove «non vi sono [...] né vicoli, né strade«ma, al momento, «orme appena
accennate rapidamente cancellate«20 è luogo enigmatico. Ed è enigmatico non tanto per
l'apparente esotismo del viaggio che esso sembra additare, quanto per ragioni più profonde che
rinviano alla scansione del vissuto di chi lo abita rispetto a quelle di chi, semplicemente, lo visita.
Infatti, che il deserto sia un luogo disorientante è questione facilmente deducibile dall'esperienza
del viandante che lo attraversa proveniendo da una terra e mirando ad un'altra terra. Ma il deserto
jabesiano non è un inter-regno, all'interno del quale transitare in vista d'altro, quanto piuttosto
l'erranza stessa dello straniero e del libro.21
Se occorresse un'immagine al niente, la sabbia ce la darebbe. Polvere dei nostri legami. Deserto dei
nostri destini. Per lo sradicato, l'albero è un elemento del paesaggio che non lo trattiene.22
E ancora:
La parola insediamento, per me, è una parola sprovvista di senso. Quando la sento pronunciare, la
mia reazione immediata è quella di evitare di tenerne conto, come se si trattasse della parola di una
lingua barbara, di cui non avvertire che le mancanze.23
È paradossale ma, al contempo, è modulo eidetico da assumere come pre-requisito indispensabile
ad una quantomeno pertinente decifrazione della proposta jabesiana (anche se esso costituisce una
forzatura per il pensiero dell'Occidente, e quindi anche per la filosofia), il fatto che a fondare
l'essere-ebreo sia proprio quella categoria che il linguaggio occidentale esprime come mancanza,
come privatio.
Ovvero, nella prospettiva del deserto jabesiano, è l'insediamento, l'albero inteso come radice
innestata su un luogo, a descrivere una incomprensibile stanzialità, una malattia, una carenza; in
definitiva, proprio una mancanza. L'albero, la casa, la radice sono, rispettivamente, assenza di
movimento, difetto di transito, carenza di tramando e, quindi, a-fasia, a-grafia, a-storicità:
mancanza di voce e di scrittura. È dell'insediamento, dunque, che bisogna percepire le deficienze.
Non sono quindi il nomadismo e l'erranza a mancare della terra e delle radici, quanto
l'insediamento e la stanzialità a mancare del tempo dell'erranza.
Avvicinare in un luogo astratto -- luogo di nessun luogo -- un essere che sa perfettamente, e ve lo
ricorda, di non avere mai lasciato la sua città, la cui presenza familiare, inoltre, vi rende
immediatamente palese che vi erano le più grandi probabilità che andasse così; il fatto di abitare,
l'uno e l'altro, nello stesso quartiere e frequentare, alle stesse ore, i medesimi luoghi: tutto ciò è
abbastanza per paralizzarsi dal terrore, tanto il divario nello spazio e nel tempo, il radicale
cambiamento di situazione è importante, e intollerabile per lo spirito il brusco spaesamento. Forse,
non siamo mai unicamente là dove siamo.24
All'horror vacui, si sostituisce, quindi, una sorta di horror loci; allo spaesamento, come perdita del
centro, tipico del cosiddetto post-moderno -- vera malattia culturale di un Occidente che, a partire
da Nietzsche, ha messo in mostra con una certa sicumera la propria diagnosi, ma non con
altrettanta certezza l'appropriata terapia -- si affianca, all'opposto, il male dell'abitare, il dolore
dell'insistere in un luogo che prevarica il senso temporale del finito. Alla malattia dello
sradicamento, intesa dall'Occidente radicato, come perdita del luogo, si sostituisce quella del
radicamento, intesa dall'ebraismo sradicato proposto da Jabès, come perdita del tempo e dell'altro.
Quest'insofferenza per la radice è, peraltro, la stessa testimoniata dalle bellissime pagine
sull'ospitalità e la dimora, contenute in Totalità e Infinito, cui precedentemente ci eravamo riferiti
a proposito della novità della dimora cui si giunge per scelta:
La casa scelta è tutto il contrario di una radice. Essa indica un disimpegno, un'erranza che l'ha resa
possibile, che non è un di meno rispetto all'installazione, ma un sovrappiù della relazione con Altri
o della metafisica.25
Alla nostalgia di Ulisse, dunque, che descrive il periplo da Itaca ad Itaca, si affianca -- e, forse, si
contrappone -- la speranza di Abramo che, con il suo semplice «eccomi«(inanì), lascia Ur dei
Caldei per mai più ritornarvi.26 È dunque il taglio, la ferita, lo strappo della sedimentazione a
costituire il senso dell'abitare:
Pensare il taglio di sé perché possa pensarsi nel taglio; poiché cos'altro mai è il pensare, se non
troncare nodi, scioglierli, come ci si scioglie da un legame di troppo, come il secondo, di colpo, si
allontana all'eternità. La conoscenza avviene al prezzo di questa spoliazione.
[...]
Errare, nostra ultima possibilità? Certo, per chi sa bene che il nostro sostegno prestigioso, il
Sapere, gloria e vanto dell'uomo, è tanto irrisorio, quanto un filo di paglia nella tempesta. 27
Ma questo «errore«non va letto nella direzione di un pensiero debole, forte nella sua fondata
convinzione ermeneutica d'essere, al tempo stesso, debole quanto ai pensati e poderoso quanto alla
capacità di pensarli come tali; né tantomeno nella direzione neoidealistica di una teoria dell'errore,
pronta a suffragare con un esigenzialismo graduale le fasi pedagogiche di conquista di una verità
stabile, indiscutibile, incontraddittoria e, eo ipso, sicura. Questo «errore», semmai, andrebbe letto
collocandone le fibrillazioni in quel nesso tra etica e futuro -- la soglia tra tempo e altro -- che è (già
in Aristotele, ma anche in Levinas, Jabés, Rosenzweig e Buber, come dicevamo) innervata sul
desiderio inteso come òrexis e non soltanto come epitymìa.28
Pensa. Legati al tuo pensiero come ad una donna della quale tu sia follemente innamorato. Non
esiste pensiero senza desiderio.29
E il desiderio è inequivocabilmente legato al nome. Quello ebraico si scrive «sulla sabbia«30 e può
cambiare nell'incontro/scontro con la trascendenza; quello insediato e strutturato in un luogo e in
uno spazio mancanti di tempo, è una sorta di sigillo dell'esistenza.
Se, ad esempio, leggiamo l'episodio della Bereshìt ebraica (la nostra Genesi), laddove è narrata la
lotta di Giacobbe con l'angelo,31 ci ritroviamo catapultati in una sorta di conflitto temporale e
spaziale che determina il mutare dell'identità di Giacobbe in quella di Israele. In verità, l'episodio è
solo uno dei possibili esempi biblici che testimoniano la prassi del cambiamento del nome. Allo
stesso modo Yhwh aveva cambiato il nome di Abraham in Abramo, quello di Sarai in Sarah. La
prassi è, in vero, accolta da Gesù nei Vangeli. Così, anche il nome di Simone è mutato in Pietro.
Persino Paolo, prima d'essere accecato sulla via di Damasco possedeva un altro nome, Saulo.
Tuttavia, l'episodio citato all'inizio, quello di Giacobbe, è rivelativo di un suo specimen. Giacobbe,
ormai benedetto nel suo nuovo nome, Israel, benedice a sua volta, con un nome nuovo, lo spazio
circostante. «Allora Giacobbe chiamò quel luogo Peniel, perché disse: «Ho visto Dio faccia a faccia,
eppure ho avuto salva la vita«».32 In questo caso potrebbe davvero trattarsi del vero
riconoscimento dell'erranza, assurta non soltanto a categoria spazio-temporale (ché, in questo, la
migrazione di Abramo sarebbe già testimone di un percorso), ma perfino a categoria etica e
rivelativa. Se anche i luoghi, nell'orizzonte della Torah, perdono le loro catene, smettono cioè di
essere radici immobili, mancanti di tempo, e possono, con un nuovo battesimo, che è in verità è
una benedizione, diventare fluidi come il deserto, allora è possibile non lasciarsi imbrigliare nella
dimora, seppellire nella casa, come coloro che vivono esistenze statiche, conclamate da nomi
immutabili, immerse in un mondo di cose immobili, garantite da nomi identici:
Il loro nome, inciso su una lucida targa di rame, inchiodato all'entrata principale del condominio, è
la prova della loro esistenza, come esistono il filo d'erba e il sole, la luna e il chicco di riso, o come il
lombrico e il pesce guizzante.33
Bisogna quindi destrutturare, in qualche modo, la radicalità del legame allo spazio, alla terra e al
nome:
Abbattere le mura, non quelle che ci proteggono, ma quelle che ci dividono. Sordi ai richiami, ai
brusii, ai gemiti che ci giungono dall'esterno, consolidiamo i nostri rifugi. Passiamo da una casa
chiusa ad una casa ermeticamente sbarrata. E come potrebbe essere diversamente? Forse proprio
un qualunque luogo non equivale forse ad escludere, ad un tempo, il vicino?34
Proprio fondando (parola impossibile per l'Oriente nomade) la differenza (anche se proprio su
questo fondare-la-differenza, senza inscriverla nell'identità, come già accennato, il linguaggio della
filosofia sperimenta la propria impossibilità a dire) tra pieno e vuoto, tra nomadismo come
positum, e quindi come positivum, e radicamento come privatio, mancanza, errore vero, e per ciò
stesso mai erranza; proprio affidando alla parola il compito non già di riempire i varchi del silenzio,
né di otturare ogni feritoia tra le cose, ma di adattarvisi ed intesservisi, è possibile rendere in
qualche modo reale la soglia dell'esilio. «Nessuna barriera tra Niente e Niente«a descrivere uno
spazio che, a questo punto, è coabitato dal tempo. «35
Ma il «niente«cui Jabès allude è quanto di più pesante possa essere concepito dal pensiero
filosofico che ne ha sempre retto l'insidia lasciandone giocare la partita teoretica tra il divieto
parmenideo di ogni pronuncia,36 la tolleranza d'esistenza di matrice platonica37 e la polarità
ontologica di stampo hegeliano;38 il niente è l'esistente che non ha visibilità, ma che è di per sé
evidente; è un indecifrabile che continua tuttavia ad interrogare ogni esistente. Come dimenticare,
tra l'altro, che proprio 'En Sof (come ricorda Scholem), ovvero il nulla senza fine, è l'attributo più
alto che il pensiero ebraico possa tributare a Dio?39
Ma qui il nulla senza fine, l'abisso, non hanno a che fare con l'approdo della cosiddetta «teologia
negativa», scienza occidentale in grado di predicare di Dio tutto ciò che egli non è. Qui il nulla è di
fatto soggetto, non predicato. E il «non», più che delimitare la verbalità della definizione -dicendo, appunto, ciò che Dio non-è -- riguarda l'oggetto del pensiero; così l'ebraismo intende dire
ciò che è il nulla senza fine di Dio, anche tramite le forme semantiche del silenzio e della domanda.
Di fenomenologico, in tale appellazione, che non è mai ontologica, ma semmai dia-logica, restano
le evidenze performative dell'inter-esse, dell'essere-tra. Come a dire: non so chi sono quanto alla
mia essenza, non so chi sei quanto alla tua essenza, ma è bello parlare insieme e poter narrare, per
dirla con Buber, l'evento di questo incontro:
È visibile un sentimento. Provandolo, l'anima lo rende visibile ad altri, con il tramite del corpo che
ne testimonia, rivelandole, la forza o la leggerezza -- pianto o sorriso; ma esso è invisibile in quanto
puro sentimento -- desiderio, attrattiva, rivolta, rigetto o rimpianto --.
È visibile uno sguardo? Lo è nella misura in cui è a sua volta isto e rivelato a se stesso da tutto ciò
che vede, ma permane invisibile poiché l'essere o la cosa sono da lui colti solo nella loro discutibile
apparenza; e quest'ultima lo rinvia alla loro assenza, infinito vuoto ove si ammucchiano immagini e
figure controverse.
L'occhio muore non di ciò che ha visto, ma di ciò che non potrà mai afferrare.
È visibile una parola? Forma, paesaggi, colori che essa, formulandosi, fa scorrere sotto i nostri
occhi ce la rendono visibile; ma questi ultimi, essendo afferrabili solo mentalmente, e offrendosi
all'immaginazione, al sogno, al pensiero nello spazio invisibile da loro istituito, ci impediscono di
vederla.
[...]
È visibile la voce? Io non solo sento la mia voce. La vedo.
Sonore immagini della mia assenza.
È visibile un volto? Forse è proprio attraverso la sua originaria invisibilità -- quella del volto di Dio
-- che tentiamo, invano, di interrogarne i tratti.
La verità del volto è nella sua non somiglianza con se stesso: volto di un'assenza pazientemente
modellata [...].
[...]
Giudeite. Tutti i colori i speranza della giudeità; ma, anche, la sua dura solitudine e immemoriale
miseria di pietra spatriata.40
4. Esiti. Verso un'etica del conflitto?
Il volere ad ogni costo tirare le fila tra le diverse asimmetrie qui evocate -- quelle del volto, quelle
della soglia, quelle della dimora e quelle del deserto --, condizionate, per altro, da immagini che,
pur nel loro rilievo fenomenologico, assumono valore di testimonianza e di mediazione soggettiva,
riconduce l'indagine ad una sorta di punto morto dal quale è assai difficile evadere. E certo, evadere
da una sorta di evidenza fenomenologica -- cui abbiamo anche provato a dare i tratti della
temporalità etica e della spazialità nomade -- non è risultato glorioso per una filosofia in procinto
di perdere davvero tutta la carica di avvincente novità che l'incontro con l'Altro uomo -- e quindi
con quella trascendenza orizzontale che non è nella mia disponibilità di soggetto porre o deporre -può riservare.
Ma se incontrare davvero qualcuno, parlargli, comporta radicalmente una sorta di sospensione del
proprio e della radice, e quindi una sorta di coraggio suicida nel disporsi nei pressi di ciò che
abbiamo voluto chiamare la soglia dell'esilio, il suo contrario, ovvero il monologo sui massimi
sistemi, come usa dire, o la giaculatoria del proprio, poggiata su un fondamento che la filosofia
presuppone -- dichiarando invece, come nota Rosenzweig, d'essere la sola scienza priva di
presupposti41 -- rischia di diventare una sorta di schermo opaco, seppur tranquillizzante, che
chiude ogni orizzonte di comunicazione e di incontro. Certo, il Volto d'altri mi rende ostaggio di un
chi cui non posso neanche dare i tratti rassicuranti del Sé, dell'altro-Io, del soggetto simmetrico e
speculare che se guardato mi riguarda, se investito mi investe, se chiamato mi risponde. Un Altro,
che sia davvero altro, e non una maschera riflessa dell'identità del Sé, è non solo una scommessa
teoretica, ma, anche, una inquietudine etica.
In vero, infatti, il Volto -- e qui integro la prospettiva levinassiana, già sottoposta dallo stesso
Autore al vaglio della critica di paternalismo,42 con la stridente lettura rosenzweighiana
dell'alterità come conflitto -- mi parla, solo e se Io sono in grado di ascoltarlo, solo e se la mia
caparbietà -- venuta in luce come carattere, come proprietà (Eigenheit)43 irrelata, incapace di
ascolto perché non in grado di riconoscere alcun fuori di sé -- è in qualche modo stravolta da
un'esperienza limite che ne metta a dura prova l'autoreferenzialità.
Inutile dire come questa inquietudine dell'Altro, in Rosenzweig, appaia -- diversamente che in
Levinas -- come centrata sull'identità di un soggetto divenuto Sé, e non sulla priorità di un Volto
che mi tiene in ostaggio a prescindere dal mio prestargli ascolto. E tuttavia, per Rosenzweig,
l'indifferenza all'altro, all'esterno, al non-proprio, non ha i caratteri di una cattiva coscienza, di una
voluta esclusione dell'altro dall'orizzonte del proprio, dalla sfera del soggetto. Tutt'altro: l'Altro,
originariamente (prima cioè di ogni mediazione culturale), non mi appare, non mi riguarda
semplicemente poiché per me non c'è nessun altro. È il soggetto, quindi, a vivere una tara
gnoseologica e morale, che può diventare laica, aperta, solo nell'esperienza limite della
dissoluzione dell'Io, della sua fine.
È la morte -- il «qualcosa«della morte e non già il suo nulla -- a costituire, per Rosenzweig, quel
presupposto che la filosofia «dalla Ionia fino a Jena«44 dichiara candidamente di non aver mai
posto, e che la costringe ad essere idealistica (e, quindi, a metabolizzare l'altro come negativum, o
come ingranaggio del concetto). Ma se il presupposto della filosofia è la «paura della morte», il
fondamento essenziale di ogni sapere, l'essenza, precipita in una sorta di nulla relativo, dal quale
solo un atto di scelta, e perciò di libertà, può davvero uscire. E, difatti, anteriormente alla scoperta
della morte, l'uomo non vive affatto nel terrore; solo dopo, egli crea sistemi e dicotomie (come
quella tra anima e corpo) in grado di rassicurarlo sulla capacità del soggetto di permanere, di vivere
ancora.
Ma la morte, come esperienza, è preclusa all'orizzonte fenomenologico; anzi, essa è il limite che
determina tutti i limiti, la condizione che descrive ogni condizione, il presupposto di ogni esistenza.
In questo senso nascere significa, davvero ed essenzialmente, morire. L'esperienza della morte è
rivelata all'Io-sordo, al soggetto che s'è identificato caparbiamente con ogni spazio circostante,
nell'esteriorità del Volto altrui. È la morte dell'amico a rivelare al soggetto non solo il valore
dell'amicizia -- ché senza la scomparsa dell'amico l'Io non si accorgerebbe originariamente
nemmeno del suo valore -- ma anche il limite dell'esistenza.
Eppure la morte -- «maestra di serietà» (Alvorens Lœremester), per dirla con Kierkegaard45 -rivela, contestualmente, al singolo la soglia dell'altro. A ben vedere, i due momenti non sono
scindibili in schemi di priorità: la morte rivela la compagnia, l'alterità, nella fine dell'altro uomo,
così come rivela la mia stessa fine nel restituirmi la proprietà ed esclusività dello spazio violato
dall'altro. Non a caso, la maschera che thànatos porta in volto, per entrare in comunicazione con il
soggetto è -- secondo Rosenzweig -- quella di eros.
Cosa resta dunque del soggetto? Cosa dell'Altro? Queste domande, certo, tradiscono una priorità
che nessuna filosofia potrebbe mai tacitare, se è vero, come è vero, che da sempre l'interrogazione
umana si è rivolta al senso delle cose, al senso dell'esistenza. Resta, forse, solo quella trascendenza
che è già inscritta nel semitico «non ucciderai«e che già Antigone -- ponendo rimedio all'amnesia
della morte con la memoria e il rito -- chiamava, con il suo greco, physis.
Certo, se la physis di Antigone è tutt'uno con il suo corpo di donna (corpo che dà la vita
all'assolutamente estraneo concepito nel grembo), ed è altro da quel nòmos che può essere sancito
ma può anche essere tradotto o mutato, l'incontro con l'altro, con la sua trascendenza assoluta, non
potrà che assumere i tratti eccentrici -- eppure assolutamente istruiti a tutte le differenze -- di quel
conflitto che segna nel nome, ovvero nell'identità legata al tempo della rivelazione dell'Altro, e nel
corpo, ovvero nello spazio del proprio Sè:
Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui sino allo spuntare dell'alba. Vedendo che non ce la
poteva, lo toccò all'estremità del femore, e l'estremità del femore di Giacobbe si slogò mentre
lottava con lui. L'uomo gli disse: «Lasciami andare che è spuntata l'alba». E Giacobbe: «Non ti
lascerò finché non mi avrai benedetto». E l'altro: «Come ti chiami?».
Rispose: «Giacobbe». «Non Giacobbe sarai chiamato, ma Israele, poiché hai lottato con un essere
divino e con uomini e ce l'hai potuta». Giacobbe gli disse: «Dimmi il tuo nome». E l'altro: «A che
scopo me lo domandi? «E là lo benedisse.46
Ecco, forse, davvero non ogni uomo è Giacobbe; e tale, ogni uomo, come categoria, non potrebbe
affatto essere, poiché la soglia dell'identità ricadrebbe ancora sotto la giurisdizione del genus,
finendo per precipitare la discussione nel tema dell'astrazione. Ma il corpo di Giacobbe -- che è
corpo segnato, corpo infranto e claudicante, proprio in quanto corpo benedetto -- non è affatto
un'astrazione; non è qui preso come un simbolo. Esso, come il Visage di Levinas, il Du di Buber,
l'Étranger di Jabès, è kath'autò, trascendente rispetto a Dio e all'Altro, e per Dio e per l'Altro,
senza pretendere la simmetricità della relazione, quanto piuttosto solo una benedizione.
Una benedizione -- è opportuno ricordarlo ancora -- che segue, se non proprio consegue, all'atto
del domandare. La questione -- quintessenza dell'interrogazione -- è, dunque -- almeno nel tessuto
degli scenari qui presi in considerazione -- la vera soglia del nome proprio. Un nome che è proprio
nella misura in cui è cartina di tornasole della storia che viviamo (e dei segni che questa lascia sul
nostro corpo finito), e non, all'opposto, nella misura in cui si erge a salvaguardia dalla storia e dalle
sue ferite. Esso cambia e ci rappresenta, in quanto noi cambiamo per rappresentarci il tempo del
mondo ed agire nel nostro tempo.
Riconoscere questo significa, forse, seguitare la ricerca della filosofia su orme zoppicanti che mai
possono darci il possesso di una casa o la piena e tranquillizzante conoscenza dell'Altro, ma
semmai essere testimoni discrete del dolore e della sorpresa di una lotta notturna -- e quindi
addirittura priva della definizione dei contorni e dei confini data dalla luce -- volta a cambiarci il
nome e a cambiare, di conseguenza, anche il nome delle cose.
Note
1.
L'asse portante di questo saggio riassume, seppure in modo provvisorio, parte dell'itinerario di ricerca da me
condotto presso il Dottorato di Ricerca in «Etica e Antropologia. Storia e fondazione«dell'Università di Lecce.
Come tutte le ricerche, anche quella qui appena accennata è aperta ad ogni sorpresa, ad ogni scandalo, e
pertanto è percorsa interamente dal dubbio e della inconclusività. E tuttavia, in essa sono confluite anche le
suggestioni provenienti dagli studi paralleli da me condotti sui rapporti tra filosofia e cinema e tra filosofia e
poesia. Non a caso, il titolo del saggio è un «plagio cosciente«- e, perciò, un omaggio -- del titolo del bel volume
di poesie di A. Contiliano (La soglia dell'esilio, Prova d'Autore, Catania 2000). Proprio in quest'ottica di
riconoscimento per ogni radice di senso confluita nel mio percorso, mi preme consegnare al lettore, più che un
esito, un dubbio, più che una conclusione, un'ulteriore domanda. Davvero, forse, la profondità dell'animo
umano è così abissale da consentirci, piuttosto che una compiuta conoscenza dell'universale, semplicemente un
atto d'amore. Riflettere su questo, sul fatto stesso dell'esistenza -- e, dunque, continuare a fare filosofia --, senza
rendere asettica e artificiosa la parola, indisponibile ad ogni cambiamento, ad ogni metafora e ad ogni metabasi,
significa, forse, restare interi di fronte alla vita. Interi, come ibridi di paura e coraggio, di fronte all'esito stesso
del finito: quella morte, quella nostra morte, che, sola, restituisce senso ad ogni pur incompiuto atto d'amore.
Amiamo nel finito, come cifra del finito stesso. In questo, dunque, amiamo proprio perché possiamo morire.
Eppure -- come Er, il filosofo per eccellenza del mito platonico -- desideriamo ulteriormente perché siamo
incompiuti. Siamo uomini perché siamo consapevoli che la nostra essenza dice, forse non del tutto
contraddittoriamente, ad un tempo, della nostra stessa fine e del nostro infinito desiderio. Questo racconto,
questo narrare di impercettibili soglie, è quello che ho sempre trovato, inconclusivamente, nella stessa filosofia.
2.
L'opera di certo più rappresentativa di tale filone è quella di F. Rosenzweig, Das neue Denken. Eine
nachträgliche Bemerkung zum Stern der Erlösung in Id. Der Mensch und sein Werk. Gesammelte Schriften (in
seguito GS), Band III, Zweistromland. Kleinere Schriften zu Glauben und Denken, hrsg von R. und A. Mayer,
Martinus Nijhoff, Dortrecht 1984, pp. 139-161; tr. it. Il nuovo pensiero, Arsenale, Venezia 1983, ora anche in Id.,
La Scrittura. Saggi dal 1914 al 1929, a cura di G. Bonola, tr. it. di G. Bonola e G. Benvenuti, Città Nuova, Roma
1991, pp. 257-282. È pur vero che, «quasi conquistato da un desiderio di riconoscimento e di radicamento in una
tradizione comune, Rosenzweig elenca, in una sorta di discendenza, i filosofi della parola: Eugen Rosenstock,
Rudolf Ehrenberger, Hans Ehrenberg, suoi interlocutori epistolari, Victor von Weizsäcker, Martin Buber (in
particolar modo nell'opera Io e Tu), Florens Christian Rang e Ferdinand Ebner». G. Bonagiuso, L'eroe tragico e
la filosofia narrante. Franz Rosenzweig e la genesi del Nuovo Pensiero, «Idee», 52/53, 2003, p. 67. Non v'è
dubbio che al Nuovo Pensiero andrebbero ascritti anche filosofi come Emmanuel Levinas e pensatori irregolari
come Edmond Jabès, protagonisti anche loro della parte tematica di questo saggio.
3.
Com'è noto, la posizione filosofica della scuola d'Elea tendeva a negare ogni consistenza alla questione del nonessere. La celebre conclusione del poema parmenideo Sulla natura recita, appunto, che solo dell'essere è
possibile fare discorso e quindi avere conoscenza epistemologica. Coloro che ammettono anche l'esistenza del
non-essere sono definiti da Parmenide dìchranioi, bi-cefali; filosofi, cioè, che pensano con due teste, indecisi tra
l'essere e il nulla, impossibilitati, infine, a concepire alcuna proposizione scientificamente valida o
filosoficamente cogente. Cfr. Parmenide, Sulla natura (cit. in Simplicio, Phys., 117, 2) tr. it. di P. Albertelli in G.
Giannantoni (a cura di), I Presocratici. Testimonianze e frammenti, tomo I, Laterza, Roma-Bari 19791, p. 272.
Platone, per risolvere la questione del movimento -- considerato dagli eleati solo una mera apparenza --, si trova
costretto ad ammettere un passaggio dall'essere al non-essere. Tale asserzione, contraria all'assunto parmenideo
-- per altro espresso in forma oracolare e poetica e divenuto presso gli allievi una sorta di dogma da difendere --,
generò, appunto, il primo «parricidio«della storia della filosofia; un disconoscimento delle posizioni filosofiche
del proprio maestro che Platone opera nel Sofista. Cfr. Platone, Sofista, in Opere, tr. it. e a cura di G. Pugliese
Carratelli, Sansoni, Milano 1993, pp. 239-278.
4.
Cfr. Platone, Parmenide, pp. 333-366. Su questo punto, il mio saggio è debitore di talune intuizioni, ancora in
via di sviluppo, ad un incontro con il prof. Domenico A. Conci che, nel chiarire come l'idea di «alterità«debba
pensarsi in qualche modo come «irrelata», fondando se stessa proprio sull'irrelazione, mentre quella di
«diversità«sia comunque da pensare come legata ad un Io, ad un soggetto, rispetto al quale, comparativamente,
essa sia concepita, ha anche mostrato come -- e ciò a partire dalla sua fenomenologia «contrastiva«- le culture
vedano in modo diverso cose diverse. A parte il fatto, vero, ma spesso occultato da sistemi a prevalenza
egologica, che non tutte le culture posseggono l'Io -- quel particolare tipo di soggetto posto come akmé di un
percorso prospettico che tutto riconduce a sé, fondandosi come terminus ad quem e perfino come terminus a
quo dell'atto gnoseologico o morale -- e che la sua «invenzione«greca e occidentale non può darsi
semplicemente come una scoperta, o, peggio, come una conquista, rispetto alla quale tutto il resto sia da
considerarsi passato o, addirittura, involuto; a parte questo, dicevamo, nel costrutto contrastivo si configura
anche una interessante abrasione del continuo spazio-temporale che si regge sulla logica dell'impermanenza, in
favore di una temporalità profonda, svelata dalla messa in campo di un'epoché radicale inerente non solo gli
oggetti, ma anche l'idea di soggetto. Da questo percorso, assai carico di implicazioni filosofiche, deriva una
concezione del tempo basata sulla categoria di «ripetizione«che, in verità, Conci applica solo agli schemi
dell'universo mitico rituale, condizionandone la portata rivoluzionaria con una sorta di dichiarato limite
antropologico, ma che potrebbe invece rivelarsi estremamente cogente per i percorsi sull'alterità intrapresi dal
cosiddetto Nuovo Pensiero, ed essere quindi argomento potente anche in sede ontologica. Bisognerebbe, a tal
fine, legare l'analisi «contrastava«di tipo fenomenologico invocata da Conci, con la metafisica dell'altro uomo,
ovvero con l'etica come filosofia prima, anch'essa condotta con le metodiche fenomenologiche, o quantomeno
husserliane, da Levinas. In tal modo, forse, si potrebbe varcare il recinto d'obiezione descritto -- e, in verità,
spesso pedissequamente ricalcato -- da J. Derrida, Violence et métaphysique, essai sur la pensèe d'Emmanuel
Levinas, «Revue de Métaphysique et de Morale», 3-4, 1964; tr. it. di G. Pozzi, Violenza e metafisica. Saggio sul
pensiero di Emmanuel Levinas in J. Derrida, La scrittura e la differenza, Einaudi, Torino 20023, pp. 99-198.
Secondo Derrida, l'Altro come irrelazione resta non tanto un miraggio della filosofia levinassiana, quanto una
vera e propria violenza; l'asimmetria o dissimmetria di Totalità e infinito non reggerebbe, difatti, al compito di
sdoganare l'etica quale «filosofia prima». Certo, è quantomeno da notare come Derrida sottovaluti l'impatto
teoretico rivoluzionario delle categorie dell'esteriorità in Levinas, salvo poi utilizzarle a piene mani. Scrive
Conci: «La figura della ripetizione scandisce [...] da cima a fondo il tempo dell'universo mitico-rituale. Ma tal
figura deve essere radicalmente differenziata da quella del ritorno ciclico se [...] tale ripresa, come coincidenza
dell'inizio e della fine, è intesa ellenicamente come l'immagine mobile dell'identità noetica stessa. La ripetizione
mitico-rituale, infatti, retta, invece, dall'identità iletica, non è e non può essere pensata e vissuta dalle comunità
a fondamento sacrale come un accadere puntualmente periodico, automatico, necessitato e assicurato a priori
una volta per tutte. Solo l'esecuzione diligente, cerimonialmente sancita, di dròmena rituali [...] può esaudire,
forse, per ripetizione, la ripresa auspicata [...] dai devoti. E la ripresa, basata sull'identità iletica e non poetica,
deve essere invocata, propiziata impetrata, e quando avviene [...] la coniugazione reale tra vissuto sacrale e
vissuto profano [...] è una identità di tipo iletico. Essa si fonda su contenuti reali analoghi od omologhi ed
appare del tutto estranea a qualsivoglia automatismo necessitato che renderebbe, per altro, futile ed
intimamente contraddittorio l'evento rituale stesso». A chiosa di questa pagina, lo stesso Conci aggiunge,
anticipando l'obiezione che l'epistemologia rigida, fondata sulla non-contraddizione, potrebbe rivolgere ad un
simile discorso: «Il principio di non contraddizione è relato all'identità noetica e non a quella iletica e, quindi,
non può valere in alcun modo al di fuori di quella. La cosiddetta «possibilità di coniugare l'identico con il
diverso«- fondamento reale e logico di ogni evento metamorfico --, come si esprimerebbe un Occidentale,
poggia proprio sull'identità iletica e non implica alcuna presunta violazione del principio noetico dell'identità,
per altro assente nelle culture a base rivelativa». A. D. Conci, Tempi sacri e tempi profani di culture a
fondamento rivelativo. Analisi fenomenologiche, «Annuario filosofico», 17, 2001, p. 156.
5.
Sulla questione di nulla e ni-ente, in riferimento all'essere e all'ente, è ritornato M. Heidegger, Nietzsche, Verlag
Günther, Neske Pfullingen 1961, pp. 543-545; tr. it. di F. Volpi, Adelphi, Milano 1994, pp. 578-582.
6.
Cfr. Aristotele, Etica Nicomachea, 1109b 32 ss., 1111a 23, 1111b 7 ss., 1136a 32 ss., 1138a 9, 1152a 15; tr. it. di C.
Mazzarelli, Rusconi, Milano 1993, pp. 109-110, 114-115, 116-117, 216-217, 222-223, 284-285. Si tratta dei luoghichiave nei quali Aristotele chiarisce i criteri di discernimento riguardo alla volontarietà e alla involontarietà
delle azioni. Inutile ricordare come buratto indispensabile, per l'impianto Aristotelico, sia la figura della
proàiresis, della deliberazione, che è fortemente legata alla conoscenza dei fini. Appare chiaro come
l'imputabilità etica riguardi, in questo contesto, le azioni volontarie, ovvero quelle compiute nella chiara
coscienza dei fini e nella chiara attuazione, e nel trasceglimento, dei mezzi idonei a raggiungerli.
7.
Cfr. G. Modica, Dià-logos e inter-esse. Appunti sul senso di una medizione soggettiva, in G. Nicolaci -- P. Polizzi
(a cura di), Radici metafisiche della filosofia. Scritti per Nunzio Incardona, Tilgher, Genova 2002, pp. 243-253.
8.
«Il tema dell'alterità [grava] oggi proprio su queste due leve complementari: se per un verso esso attinge alla
questione del nomadismo e dell'erranza, e quindi al problema della rivelazione intesa come incontro sempre
nuovo con l'altro, della responsabilità come affidamento e custodia dell'uomo, dell'ambiente e dello stesso senso
delle cose, per altro verso esso ripercorre binari impensati -- seppure problematici -- proprio sul crinale
idealistico. [...] Si tratta di una tensione che rinvia la questione dell'alterità ad una dimensione assolutamente
platonica; l'èteron, ovvero l'essere altrimenti, che -- pur avendo così vasta eco nel pollachòs lègetai della
«filosofia prima«aristotelica -- sancisce di fatto una sorta di raddoppiamento del soggetto. Infatti, il soggetto
appare, in quest'ottica, come colui il quale ha la possibilità di porre a se stesso l'obiezione, ma anche,
contemporaneamente, come colui il quale è in qualche modo «soggetto«a quella stessa obiezione:
un'interessante rilettura di taluni esiti del platonismo che, a partire da Hegel, colloca la questione del negativo
all'interno della via dialettica della verità come inquietudine e, al tempo stesso, come segno del Sé come Altro».
G. Bonagiuso, La segreta voce del ventre. A proposito de Il ventriloquo di J. -L. Nancy, in corso di
pubblicazione su «Teoria», 2004.
9.
Su questo, cfr. ancora A. D. Conci, Tempi sacri e tempi profani..., p. 141.
10. Non a caso, l'opera filosofica nella quale questo problema è affrontato ex professo, s'intitola Altrimenti che
essere o aldilà dell'essenza. Cfr. E. Levinas, Autrement qu'être ou au-délà de l'essence, Martinus Nijhoff, Den
Haag 1978; tr. it. di S. Petrosino, Altrimenti che essere o aldilà dell'essenza, Jaca Book, Milano 1996. Esemplare,
in Levinas, anche la figura della «asimmetria», o «dissimmetria«etica: «Io sono responsabile di altri senza
aspettare il contrario, anche se mi dovesse costare la vita». Cfr. Id., Ethique et infini, Fayard, Paris 1982, p. 93;
tr. it. e a cura di E. Baccarini, Etica e Infinito. Dialoghi con P. Nemo, Città Nuova, Roma 1984, p. 112. E altrove,
ancor più incisivamente, aggiunge: «Altri passa sempre avanti. E ciò che ho chiamato, in linguaggio greco, la
dissimmetria della relazione interpersonale. Senza questo non una riga di ciò che ho scritto regge». E. Levinas,
De Dieu qui vient à l'idée, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris 1982; tr. it. di G. Zennaro, a cura di S.
Petrosino, Di Dio che viene all'idea, Jaca Book, Milano 1986, p. 108. La prospettiva dell'alterità diviene così
fondante all'interno del discorso etico. Rompendo la simmetricità e reciprocità della relazione etica di natura
mutualistica -- secondo la quale, Io non invado il tuo spazio se e poiché Tu non invadi il mio --, ed anche al costo
di fare dell'Io un ostaggio del volto altrui, Levinas realizza una sorta di fondazione dell'etica iuxta propria
principia. Solo che, in questo caso, il principio di fondazione non è concettuale (una norma), né simbolico (un
volto che rimanda a tutta un'umanità), bensì fattuale: il Volto d'altri, come significazione kath'autò, come
significante e significato assoluto, valido per se stesso, che non rimanda a niente oltre se stesso. Proprio perché
l'Altro non è un concetto né un simbolo, ciò che egli farà -- in quanto altro e non in quanto un-altro-Io -- non è
affar mio. Cfr. ivi, p. 117. L'etica investe, dunque, l'Io come responsabilità; come trascendenza assoluta. L'Altro,
il suo volto che non è il mio, non è in mio potere. La sua trascendenza è data dal fatto che il suo stesso apparire
non è in mio potere. È pur vero che Io posso togliere l'Altro, uccidendolo; ma quest'atto di per sé non lo cancella.
Anzi, proprio perché Io posso uccidere il volto, questo reclama la mia custodia. Dalla possibilità stessa
dell'omicidio emerge, in modo ancor più schiacciante, la trascendenza del volto e l'ineludibilità della
responsabilità etica.
11. Trauma, se si segue l'itinerario del Nuovo Pensiero scandito nel III libro della I parte di Der Stern der Erlösung
di Rosenzweig. Cfr. F. Rosenzweig, Der Stern der Erlösung in GS, Band II, Den Haag 1976, pp. 67-90; tr. it e a
cura di G. Bonola, La stella della redenzione, Marietti, Casale Monferrato 1985, pp. 65-87. Desiderio, se si
predilige la via levinassiana. Cfr. E. Levinas, Totalité et Infini. Essai sur l'extériorité, Martinus Nijhoff, Den
Haag 1961; tr. it. di A. Dall'Asta, a cura di S. Petrosino, Totalità e infinito. Saggio sull'esteriorità, Jaca Book,
Milano 1996, pp. 41 ss. e passim.
12. Sul nesso tra responsabilità e diacronia resto comunque debitore alla prospettiva di M. Signore, Per un'etica
della responsabilità come dia-cronia e an-archia, in Id., Questioni di etica e di filosofia pratica, Micella, Lecce
1995, pp. 29-49.
13. La ripresa va qui intesa in senso pienamente kierkegaardiano. Cfr. S. A. Kierkegaard, Gjentagelsen, in Samlede
Værker (di seguito SV), 14 voll., a cura di A. B. Drachmann, J. L. Heilberg e H. O. Lange, Copenaghen 19011906; tr. it. e a cura di D. Borso, La ripetizione, Guerrini e Associati, Milano 1991.
14. «Unter den Blicken der dritten Person, ob nun nach aussen oder nach innen gerichtet, gefriert alles zum
Gegenstand». J. Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne, Suhrkamp, Frankfurt a M. 19882, p. 347;
tr. it. di Emilio ed Elena Agazzi, Il discorso filosofico della modernità, Laterza, Roma-Bari 19913, p. 300.
15. Cfr. E. Levinas, Di Dio che viene all'idea, p. 106. Corsivi miei.
16. Di Edmond Jabés è ormai edita, in Italia, quasi la totalità delle opere d'interesse filosofico. Tra quelle che più
riguardano il presente saggio, ricordiamo: Le Livre des Questions, Gallimard, Paris 1963; tr. it. di C. Rebellato,
con prefazione di M. Cacciari, post-fazione di G. Scalia, Il libro delle interrogazioni I, Marietti, Casale
Monferrato 1985. Le Livre de Yukel, Gallimard, Paris 1964 e Le Retour au Livre, Gallimard, Paris 1965; tr. it. di
A. Rocchi Pullberg e di F. Santini, Il libro delle interrogazioni II e III, Marietti, Genova 1988. Le Livre du
Dialogue, Gallimard, Paris 1984; tr. it. di A. Prete, Il libro del dialogo, Pironti, Napoli 1987. Le Parcours,
Gallimard, Paris 1985; tr. it. di A. Folin, Il percorso, Pironti, Milano 1991. La Mémoire et la Main, Fata
Morgana, Montpellier 1987; tr. it. di D. Bisutti e A. Panicati, La memoria e la mano, Mondadori, Milano 1992.
Le Livre du Partage, Gallimard, Paris 1987; tr. it. di S. Mecatti e A. Panicati, Il libro della condivisione, Cortina
Raffaello, Milano 1992. Un Étranger avec, sous le bras, un livre de petit format, Gallimard, Paris 1989; tr. it. di
A. Folin, con uno scritto di P. A. Rovatti, Uno straniero con sotto il braccio un libro di piccolo formato, SE,
Milano 2001. Le Livre de l'Hospitalité, Gallimard, Paris 1991; tr. it. di A. Prete, Il libro dell'ospitalità, Cortina
Raffaello, Milano 1991. Colpevolmente latitante è, invece, in Italia, l'attenzione della critica filosofica su questo
interessantissimo autore. Prezioso è, per la trasversalità delle letture, il volume collettaneo, che riassume gli esiti
del Convegno di Cerisy-La-Salle dell'agosto 1987, Écrire le livre: autour d'Edmond Jabès, Champ Vallon,
Seyssel 1989, tradotto parzialmente in Italia col titolo Edmond Jabès. Alle frontiere della parola e del libro, a
cura di A. Folin, Il Poligrafo, Padova 1991. Pregio dell'edizione italiana è l'accurata nota bibliografica curata da
Enrica Manfredotti. Nella citazione dei passi di Jabès ho cercato di rispettare finanche la scansione e la
disposizione spaziale delle righe. Ho perfino cercato di segnare la gran mole di «virgolette» («) quasi mai chiuse,
ritenendo queste «aperture» del tutto consone all'impianto ermeneutico dell'Autore. Voglio qui anche far notare
come l'assenza del saggio di Derrida su Jabès, inserito nel già citato La scrittura e la differenza, dai riferimenti
ermeneutici del percorso critico, sia il frutto di una scelta tanto voluta quanto pensata. La sua presenza, come il
lettore potrà facilmente rilevare, è comunque «citata», per così dire, e contrario, all'interno del dettato.
17. E. Jabès, Uno straniero..., p. 31.
18. P. Stefani, Il nome e la domanda. Dodici volti dell'ebraismo, Morcelliana, Brescia 1988, pp. 45 ss.
19. E. Jabès, Uno straniero..., p. 25. Non meravigli affatto la tangenza, di sponda, di simili stilemi con i percorsi
levinassiani tracciati dalle opere più discorsive: «Affar mio è la mia responsabilità e la mia sostituzione iscritta
nel mio io, iscritta come io. L'altro può sostituirsi a chi vorrà, tranne che a me. È proprio per questo
probabilmente che siamo numerosi al mondo. Se invece di sostituirmi ad altri, aspetto che un altro si sostituisca
a me, ciò sarebbe di moralità dubbia, ma, di più, ciò distruggerebbe ogni trascendenza. Non si può lasciarsi
rimpiazzare per la sostituzione come non si può lasciarsi rimpiazzare per la morte». E. Levinas, Di Dio che viene
all'idea, p. 117. E prima: «È necessario che l'altro sia accolto indipendentemente dalle sue qualità, se deve essere
accolto come altro». Ivi, p. 104. E ancora: «La mia responsabilità per l'altro uomo [...] non proviene da un
rispetto votato all'universalità di un principio, né da una evidenza morale. È una relazione eccezionale in cui il
Medesimo può essere riguardato dall'Altro senza che l'Altro si assimili al Medesimo». Ivi, p. 28.
20. E. Jabès, Uno straniero..., p. 31.
21. «Allo straniero non domandare il luogo di nascita, ma il luogo d'avvenire». Ivi, p. 15. «Il deserto non si confida
che al deserto». Ivi, p. 14.
22. Ivi, p. 30.
23. Ivi, p. 31.
24. Ibid. E ancora: «Quel che separa [...] sono i muri, le ospitali case di pietra». Ivi, p. 36.
25. E. Levinas, Totalità e infinito..., p. 176.
26. Cfr. E. Baccarini, Ulisse e Abramo. Nostalgia e speranza, «Apeiron», 2, 2002, pp. 33-49. Sulla nostalgia di
Ulisse resta un classico il volume di V. Jankélévitch, L'irreversible et la nostalgie, Albin Michel, Paris 1974.
Sulla speranza di Abramo cfr. A. Sègal, Abraham. Enquête sur un patriarche, Puf, Paris 1995.
27. E. Jabès, Uno straniero..., p. 35.
28. Sulla centralità della orexis, il desiderio, in Aristotele, e non solo in campo etico, sono significativi gli studi di M.
Nussbaum, Terapia del desiderio, Vita e pensiero, Milano 1998 e Id., La fragilità del bene. Fortuna ed etica
nella tragedia e nella filosofia greca, Il Mulino, Bologna 1996, in particolare pp. 508-511. Oltre all'intero
impianto del De Anima -- all'interno del quale è espresso, in vero, il fulcro della dottrina della òrexis -Aristotele rivela anche un impiego specificatamente etico. Ho anche separato òrexis ed epitymìa non solo per
ragioni lessicali, ma in quanto l'originalità d'impianto della prima nozione costituisce, a mio avviso, l'anima
stessa del pensiero aristotelico, mentre l'utilizzo della seconda resta viziato dall'impiego originariamente
platonico, tendenzialmente negativo. Cfr. Aristotele, Etica Nicomachea, ?? 1094a 1-4, 1102b 32. ?, 414b 2. A
commento e problematizzazione, si veda l'ormai classico G. Rodier, Aristote. Traité de l'âme. Commentaire par
G. Rodier, Vrien-Reprise 1985, pp. 527-565. Sulla centralità del desiderio in Levinas è sufficiente richiamarsi al
«desiderio dell'invisibile«che costituisce il tratto peculiare del saggio sull'esteriorità. Cfr. E. Levinas, Totalità e
infinito..., pp. 31 ss. e passim. Il desiderio d'amore, descritto da Rosenzweig come rivelazione, contribuisce a
tracciare in maniera addirittura anticipatrice la fenomenologia del volto che sarà fatta propria da Levinas, e la
fenomenologia del nome proprio. Cfr. F. Rosenzweig, La stella della redenzione, pp. 167-201. Echi del desiderio
emergono anche in Buber a proposito della relazione tra Io e Tu. Cfr. M. Buber, Ich und Du in Das dialogische
Prinzip, Lambert Schneider, Heidlberg 1984; tr. it. di A. M. Pastore, Io e Tu, in Il principio dialogico e altri
saggi, a cura di A. Poma, San Paolo, Cinisello Balsamo 19973, pp. 111 ss.
29. E. Jabès, Uno straniero..., p. 36.
30. Ivi, p. 32.
31. Cfr. Bereshìt, 32, 25-32; tr. it. e a cura di Rav D. Disegni, Bibbia Ebraica. Pentateuco e Haftaroth, La Giuntina,
Firenze 20003, p. 58.
32. Ibid.
33. E. Jabès, Uno straniero..., p. 36. E ancora: «Se posso mettere in dubbio la veridicità del documento che attesta
la realtà vivente del mio essere, alla stessa stregua non posso forse domandarmi chi sia questo essere
dissimulato sotto questo nome? A meno che il nome, come quello di Dio, non sia così intimamente vuoto, che il
fatto di averne uno significhi soltanto far posto ad altri, tenuti in serbo». Ivi, p. 45.
34. Ivi, p. 37.
35. E. Jabès, Uno straniero..., p. 37.
36. Cfr. Parmenide, Sulla natura, in I Presocratici..., p. 278.
37. Cfr. soprattutto Parmenide e Sofista, in Platone, Opere.
38. Cfr. G. W. F. Hegel, Wissenschaft der Logik. Erster Teil. Die objektive Logik, mit einem Vorwort von Leopold v.
Henning, Duncker & Humboldt, Berlin 1841; auch erschienen als Reprint, Frommann/Holzboog, Stuttgart, Bad
Cannstatt 1965; tr. it. di A. Moni rivista da C. Cesa, Scienza della Logica, tomo I, Laterza, Bari 1981, pp. 52 ss.
«Se la dialettica hegeliana ha il suo presupposto nel fatto che «non v'ha nulla, nulla né in cielo né nella natura né
nello spirito [...] che non contenga tanto l'immediatezza quanto la mediazione», ovvero che, concretamente,
«non v'ha che la luce intorbidata e l'oscurità rischiarata», il momento della sintesi, logicamente antecedente e
ontologicamente prioritario, rischia di comprimere la reale autonomia del negativo. In altri termini, una
dialettica assoluta non può mantenere di fronte a sé una vera alterità, poiché quest'ultima finirebbe per
arrestare il momento della sintesi. Come il positivo e il negativo, nell'unità del dipolo, reduplicano se stessi
all'infinito nell'effrazione del magnete, allo stesso modo appare impossibile realizzare un reale superamento del
procedere della mediazione tramite una forzatura interna alla dialettica». G. Bonagiuso, La dimensione
dell'oltre. Tentazione mistica e utopia della storia in Franz Rosenzweig, «Filosofia e Teologia», 2, 2001, p. 315.
39. G. Scholem, Über einige Grundbegriffe des Judentums, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M. 1970; tr. it. Concetti
fondamentali dell'ebraismo, Marietti, Genova 19952, pp. 13-40. E poi, lo stesso Jabès: «Se potessimo dire la
trasparenza, potremmo pensare Dio». E. Jabès, Uno straniero..., p. 51.
40. Ivi, p. 41-42.
41. Cfr. F. Rosenzweig, La stella della redenzione, p. 6.
42. Si tratta dell'incontro tra Levinas e alcuni professori dell'Università olandese, tenutosi nel marzo del 1975
all'Università di Leyde. Cfr. E. Levinas, Domande e risposte in Id., Di Dio che viene all'idea, p. 117: «Quanto
all'obiezione che mi si potrebbe fare: questa idea di responsabilità implica un certo paternalismo, «tu sei
responsabile dell'altro e non importa che l'altro debba accettare la tua responsabilità». Io rispondo: ciò che
l'altro può fare per me, è affar suo. Se fosse affar mio la sostituzione non sarebbe altro che un momento dello
scambio e perderebbe la sua gratuità». Cfr. quanto già evidenziato, in particolare infra, nota 18.
43. Cfr. F. Rosenzweig, Der Stern Der Erlösung in GS, p. 68; tr. it. La stella della redenzione, p. 66.
44. Ivi, p. 12.
45. S. A. Kierkegaard, Ved en Grav, in SV; tr. it. e a cura di R. Garaventa, Accanto a una tomba, Il Melangolo,
Genova 1999, p. 42.
46. Bereshìt, 32, 25-31; tr. it. Bibbia Ebraica..., p. 58.

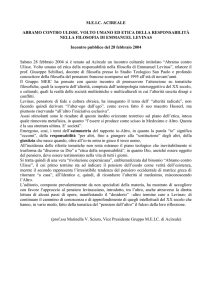
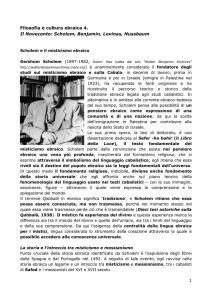
![[Appunti Antropologia Filosofica] – Vaccarini](http://s1.studylibit.com/store/data/000549956_1-e687a7284ee840838bdbec8daffa9ca5-300x300.png)