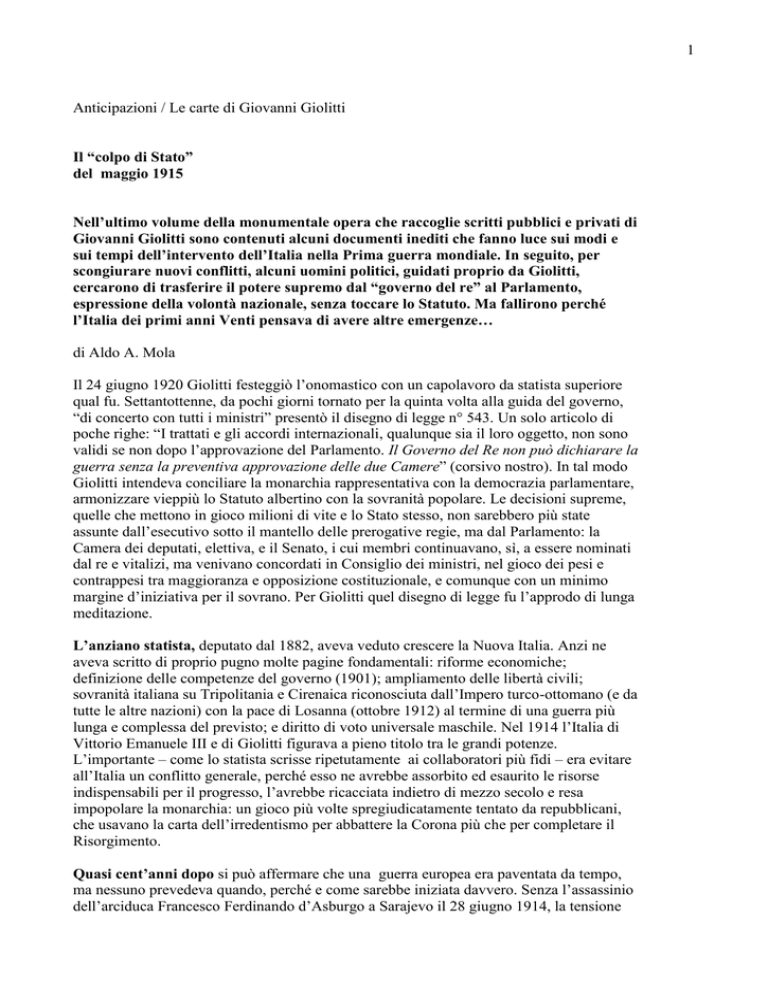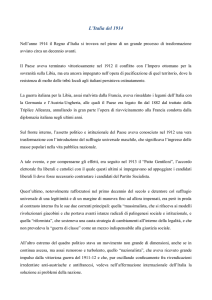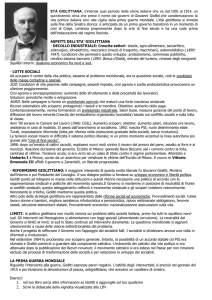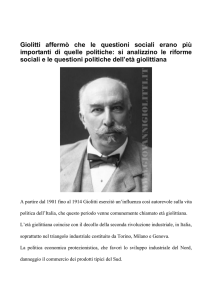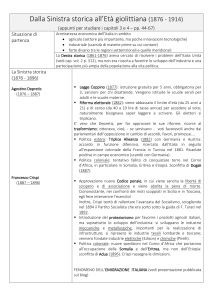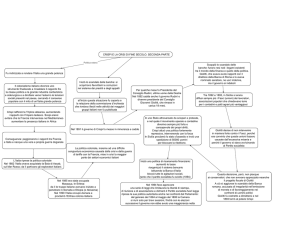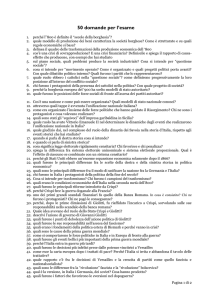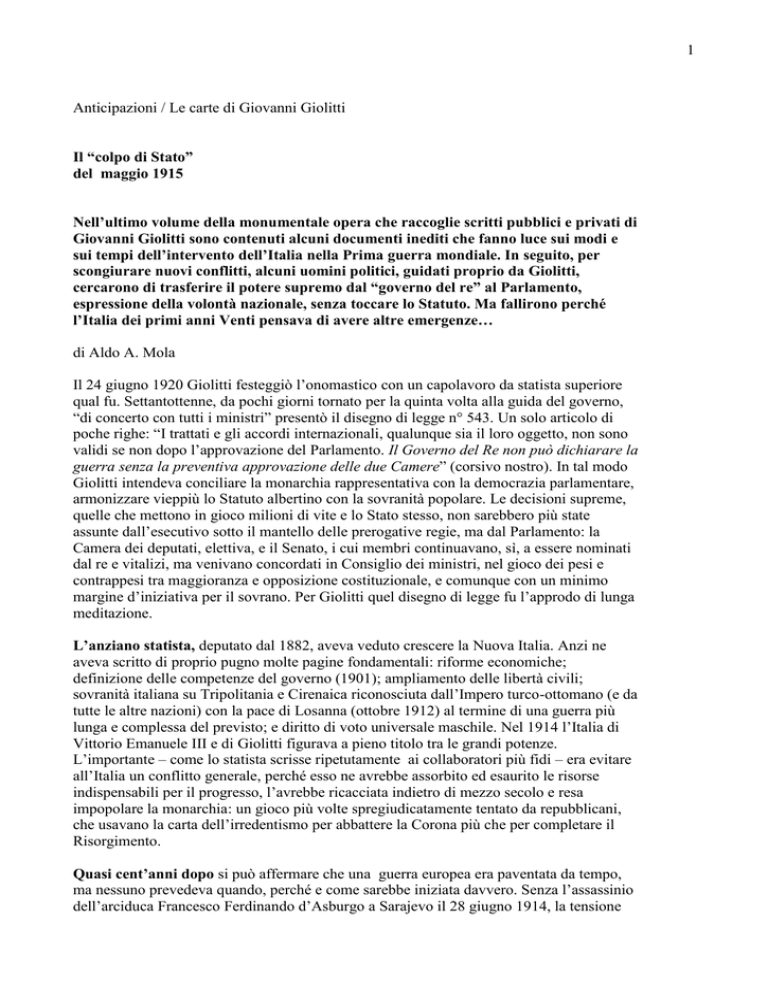
1
Anticipazioni / Le carte di Giovanni Giolitti
Il “colpo di Stato”
del maggio 1915
Nell’ultimo volume della monumentale opera che raccoglie scritti pubblici e privati di
Giovanni Giolitti sono contenuti alcuni documenti inediti che fanno luce sui modi e
sui tempi dell’intervento dell’Italia nella Prima guerra mondiale. In seguito, per
scongiurare nuovi conflitti, alcuni uomini politici, guidati proprio da Giolitti,
cercarono di trasferire il potere supremo dal “governo del re” al Parlamento,
espressione della volontà nazionale, senza toccare lo Statuto. Ma fallirono perché
l’Italia dei primi anni Venti pensava di avere altre emergenze…
di Aldo A. Mola
Il 24 giugno 1920 Giolitti festeggiò l’onomastico con un capolavoro da statista superiore
qual fu. Settantottenne, da pochi giorni tornato per la quinta volta alla guida del governo,
“di concerto con tutti i ministri” presentò il disegno di legge n° 543. Un solo articolo di
poche righe: “I trattati e gli accordi internazionali, qualunque sia il loro oggetto, non sono
validi se non dopo l’approvazione del Parlamento. Il Governo del Re non può dichiarare la
guerra senza la preventiva approvazione delle due Camere” (corsivo nostro). In tal modo
Giolitti intendeva conciliare la monarchia rappresentativa con la democrazia parlamentare,
armonizzare vieppiù lo Statuto albertino con la sovranità popolare. Le decisioni supreme,
quelle che mettono in gioco milioni di vite e lo Stato stesso, non sarebbero più state
assunte dall’esecutivo sotto il mantello delle prerogative regie, ma dal Parlamento: la
Camera dei deputati, elettiva, e il Senato, i cui membri continuavano, sì, a essere nominati
dal re e vitalizi, ma venivano concordati in Consiglio dei ministri, nel gioco dei pesi e
contrappesi tra maggioranza e opposizione costituzionale, e comunque con un minimo
margine d’iniziativa per il sovrano. Per Giolitti quel disegno di legge fu l’approdo di lunga
meditazione.
L’anziano statista, deputato dal 1882, aveva veduto crescere la Nuova Italia. Anzi ne
aveva scritto di proprio pugno molte pagine fondamentali: riforme economiche;
definizione delle competenze del governo (1901); ampliamento delle libertà civili;
sovranità italiana su Tripolitania e Cirenaica riconosciuta dall’Impero turco-ottomano (e da
tutte le altre nazioni) con la pace di Losanna (ottobre 1912) al termine di una guerra più
lunga e complessa del previsto; e diritto di voto universale maschile. Nel 1914 l’Italia di
Vittorio Emanuele III e di Giolitti figurava a pieno titolo tra le grandi potenze.
L’importante – come lo statista scrisse ripetutamente ai collaboratori più fidi – era evitare
all’Italia un conflitto generale, perché esso ne avrebbe assorbito ed esaurito le risorse
indispensabili per il progresso, l’avrebbe ricacciata indietro di mezzo secolo e resa
impopolare la monarchia: un gioco più volte spregiudicatamente tentato da repubblicani,
che usavano la carta dell’irredentismo per abbattere la Corona più che per completare il
Risorgimento.
Quasi cent’anni dopo si può affermare che una guerra europea era paventata da tempo,
ma nessuno prevedeva quando, perché e come sarebbe iniziata davvero. Senza l’assassinio
dell’arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo a Sarajevo il 28 giugno 1914, la tensione
2
sarebbe rimasta acuta e avrebbe attraversato crisi gravissime ma circoscritte: guerre “di
teatro” come era accaduto tante volte dal Congresso di Vienna del 1815. Dopo la guerra
russo-giapponese del 1904-1905 alta finanza e grande industria avevano investito capitali
giganteschi a sostegno della modernizzazione dell’impero zarista. Proprio i profitti erano
incompatibili con la guerra. A differenza di quanto pensava Lenin, l’imperialismo non era
affatto la fase suprema del capitalismo e comunque il capitalismo non era affatto in crisi.
Poteva rigenerarsi senza la catastrofe europea. Pure l’Impero turco-ottomano, il “grande
malato d’Oriente”, aveva troppi guai interni per volere la guerra.
Anche il governo di Roma sentiva da tempo venti di guerra, ma non aveva alcun interesse
a un conflitto generale. Con la pace di Losanna aveva appena concluso vittoriosamente
l’impresa di Libia. Al trattato difensivo con Vienna e Berlino (rinnovato anticipatamente
con durata decennale) univa accordi con Londra, Parigi e San Pietroburgo. Dalla nascita il
regno aveva alzato difese su tutte le frontiere, compresa quella con la Svizzera, e studiato
le conseguenze di possibili aggressioni da parte della Francia o dell’Impero austroungarico, perché la guerra rientrava tra le possibilità. Nulla però diceva che essa fosse
necessaria o una fatalità ineluttabile. Lasciato il governo nel marzo 1914 nella certezza
che poco o nulla sarebbe cambiato e convinto di tornare presto alla presidenza, da fine
giugno Giolitti si trovò invece a fare i conti con un mutamento drastico, dapprima
impercettibile poi inarrestabile. Ultimatum, mobilitazioni generali e dichiarazioni di
guerra, tra fine luglio e inizio agosto, lo colsero distratto, mentre era in viaggio di cura e di
vacanza tra la Francia e Londra, ove non aveva mai messo piede. Quando dalle minacce si
passò alle cannonate, il governo di Roma, presieduto da Antonio Salandra, dichiarò la
neutralità dell’Italia: decisione condivisa dalle personalità eminenti e da tutti i partiti a
eccezione dei nazionalisti, fautori dell’intervento a fianco degl’Imperi Centrali, Germania e
Austria-Ungheria, e degli irredentisti, corrivi, all’opposto, a chiedere la guerra contro
Vienna, il nemico storico, quasi si potesse entrare in conflitto con uno solo degli Stati
schierati in blocchi contrapposti. In pubblico e in privato Giolitti plaudì alla prudenza del
governo, esortandolo a provvedere agli interessi supremi dell’Italia e a propiziare il rapido
ritorno alla pace, preziosa per un Paese la cui economia dipendeva dall’importazione di
materie prime da tutti i contendenti e i cui emigrati si sarebbero trovati in condizioni
difficili quanto più il conflitto fosse durato e si fosse inasprito. Meno perspicace e reattivo
(forse per ricorrenti problemi di salute), dopo l’attentato di Sarajevo e per tutto il luglio
1914 Giolitti aveva escluso che davvero le Cancellerie mirassero alla guerra e quando
questa iniziò confidò nella lungimiranza del ministro degli Esteri, Antonino di San
Giuliano. Ma il 5 novembre 1914 s’insediò un secondo governo, profondamente rinnovato.
La novità vera fu però la formazione di un quadrumvirato occulto tra Salandra (premier),
Sonnino (Esteri), il ministro delle Colonie, Ferdinando Martini, e Salvatore Barzilai.
Quest’ultimo non era al governo ma tesseva i rapporti tra l’esecutivo e alcuni ambienti
influenti. Il quartetto accelerò il passo verso il capovolgimento delle alleanze e l’intervento
dell’Italia nella Grande Guerra a fianco di Regno Unito, Francia e Impero russo contro
l’Austria-Ungheria.
Come non aveva avvertito la marea montante della conflagrazione europea, così Giolitti
non percepì modi tempi e contenuti del processo in corso a Roma. Lo documenta il
carteggio inedito con Antonio Cefaly, suo amico carissimo e confidente, conservato parte
nell’Archivio Centrale dello Stato, parte nell’Archivio Storico del Senato e parte presso
privati. Nel settembre 1914 Giolitti si sottopose al “Mauriziano” di Torino a un intervento
chirurgico seguito da polmonite, venti giorni di ricovero, spossatezza: “una peripezia un
po’ noiosa”, commentò il 17 ottobre a Cefaly. Nei mesi seguenti precisò in modo
inequivocabile la sua linea: neutralità non incondizionata ma armata, nella certezza che si
3
potesse ottenere molto da Vienna senza l’alea di una guerra impossibile da circoscrivere a
uno solo dei contendenti del fronte austro-germanico. Angosciato dal suicidio dell’Europa
ormai in atto, il settantaduenne statista non vide o preferì non vedere quanto accadeva e gli
veniva segnalato dagli amici più fidi sul lavorio di ambienti che da mesi miravano a
portare l’Italia in guerra a fianco di Londra e Parigi.
Il 22 aprile 1915, in risposta all’ennesimo accorato appello di Cefaly a correre a Roma per
riprendere decisamente in pugno il corso degli eventi che si stava consumando al di fuori
del Parlamento e all’insaputa persino del governo, Giolitti rispose che non intendeva
recarvisi per non attizzare “quei pettegolezzi che tanto danno recano alla nostra vita
politica”. “Io, aggiunse, sono sempre fermamente persuaso che con trattative si può, e si
deve, evitare la guerra, e che prima condizione per la richiesta di trattative è che il governo
abbia la massima forza e si presenti colla sicurezza di avere il paese con sé. Credo poi così
evidenti i pericoli di una guerra, e così evidente l’impossibilità di prevedere quale sarà la
situazione politica in Europa anche a breve scadenza, che di fronte a così terribili incognite
non è possibile che il governo prenda risoluzioni avventate. La guerra durerà lungamente
sia che noi vi partecipiamo o no (...) La Germania, qualunque cosa avvenga sarà sempre
una potenza di primissimo ordine: quali conseguenze potrà avere per noi la impossibilità di
qualunque accordo con essa, la certezza anzi del suo odio per un secolo? Io credo che il
governo fa bene a insistere per avere le maggiori concessioni ma ho la più assoluta
certezza che non precipiterà alcuna risoluzione e che si rende conto dei veri sentimenti e
dei veri interessi del paese...”. Si sbagliava. Infatti, quattro giorni dopo, d’intesa con il Re
perfettamente informato di tutti i preliminari, l’ambasciatore d’Italia a Londra, Guglielmo
Imperiali di Francavilla, “invocato il santo nome di Dio, ed il suo patrocinio, con profonda
interna commozione”, firmò il patto che impegnava l’Italia a entrare in guerra “non oltre
trenta giorni” dalla stipula contro “tutti i nemici” (art. 2) delle potenze dell’Intesa:
l’Impero austro-ungarico, l’Impero di Germania (nei cui confronti l’Italia aveva debiti
storici e nessun contenzioso aperto) e i loro alleati (presenti e futuri). Quel giorno, con quel
patto venne tirato il dado senza che né il governo né il Parlamento né il Paese ne
conoscessero i termini.
La dichiarazione di guerra avvenne ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto albertino del 4
marzo 1848 in forza del quale il re “comanda(va) a tutte le forze di terra e di mare;
dichiara(va) la guerra; fa(ceva) i trattati di pace, d’alleanza, di commercio ed altri,
dandone notizia alle Camere tosto che l’interesse e la sicurezza dello Stato il permettano,
ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che imponessero un onere alle finanze, o
variazioni di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo l’assenso delle
Camere”. Il patto di Londra vaticinava ma non garantiva affatto variazioni del territorio
dello Stato (Trento, Trieste e altro) se non, come ovvio, in caso di vittoria. Di per sé,
quindi, esulava dai trattati da comunicare preventivamente alle Camere e da sottoporre al
loro assenso preventivo. Esso però esigeva oneri finanziari non certo superati dal
modestissimo concorso promesso dall’Intesa (art. XIV) e quindi andava approvato dal
Parlamento, al quale però non poté essere proposto perché in forza del suo art. 16 doveva
rimanere segreto sino alla sua efficacia, cioè non solo all’ingresso in guerra ma anche alla
sua attuazione. La decisione suprema fu dunque del “governo del re” al riparo dell’incipit
dell’articolo 5. Le clausole del patto rimasero ignote sino a quando, conquistato il potere
con la Rivoluzione d’Ottobre, il governo bolscevico aprì gli archivi dello Zar e lo
pubblicò. In tal modo Lenin fece sapere al mondo che tra le sue clausole (art. XV) vi era
l’esclusione della Santa Sede dal futuro congresso della pace: con buona pace dei cattolici
interventisti (pochi) e di quelli che servivano lealmente la Patria. Si apprese inoltre che tra i
territori promessi all’Italia in caso di vittoria il patto non comprendeva affatto la città
4
Fiume. Salandra, Sonnino e molti altri non l’avevano considerata necessaria. Il 3 maggio
1915 il governo denunciò il trattato difensivo del 1882 con Vienna e Berlino e, dopo una
temporanea remissione del mandato e frenetiche consultazioni per dar vita a una nuova
compagine, il 23 maggio dichiarò guerra all’Impero austro-ungarico in applicazione del
patto di Londra: parziale e molto sospetta agli occhi dei nuovi alleati (mai amici), che ne
controllarono a vista le mosse e in molti casi le tarparono le ali. La guerra contro la
Germania venne dichiarata infatti solo il 25 agosto 1916.
Giolitti non era affatto un pacifista. Era cresciuto nello studio della storia. Andava
orgoglioso del nonno materno, Gian Battista Plochiù, Legion d’Onore dell’Impero di
Napoleone I, e dello zio Alessandro Plochiù, promosso generale per il valore mostrato
nella battaglia di San Martino il 24 giugno 1859. Giolitti era il primo ministro che aveva
ordinato la guerra contro la Turchia e l’occupazione di Rodi e del Dodecaneso e aveva
fatto sapere che la guerra sarebbe durata a tempo indeterminato sino alla vittoria. Però
quello era un conflitto circoscritto, anche se più azzardato delle precedenti guerre e
spedizioni coloniali in Eritrea, Etiopia, Somalia e Cina. La conflagrazione europea era altra
cosa. Stava costando massacri e rovine immense e tutto lasciava prevedere che sarebbe
andata di peggio in peggio. Perciò Giolitti, consapevole delle risorse del Paese, riteneva
che l’intervento dovesse semmai essere rinviato al momento nel quale potesse risultare
davvero decisivo. Fu e rimase contrario all’intervento, anche se in pubblico tacque per non
alimentare divisioni. Anzi, dopo Caporetto, sin dal 2 novembre 1917 scrisse a Cefaly che
sarebbe andato a Roma anche se non vi fosse stato chiamato perché nessuno poteva stare in
disparte mentre la Patria era in pericolo. Anche prima di quella catastrofe, rifletté
sull’interpretazione che proprio l’amico calabrese aveva dato della condotta di Salandra:
“L’attuale guerra – scrisse Cefaly in un discorso da pronunciare al Senato, mai detto e
tuttora inedito – è l’effetto di un audacissimo colpo di Stato compiuto contro gli alti
poteri dello Stato medesimo (...) Al Parlamento si fece intendere che non v’era libertà di
fare altrimenti, giacché ci trovavamo dinnanzi ad una convenzione già stipulata colla
Triplice Intesa e di fronte al fatto compiuto ed il Parlamento si arrese e votò i pieni
poteri”. Cefaly separò le responsabilità del Re da quelle del primo ministro. Non mise in
discussione la Corona, che agli occhi suoi, come a quelli di Benedetto Croce, di Giustino
Fortunato e di altri meridionali, rappresentava l’agognata e faticata unità d’Italia. Tra il
1917 e il 1919 Giolitti disse esplicitamente che occorreva modificare l’articolo 5 dello
Statuto. Attaccò frontalmente le prerogative regie, come documentano i discorsi al
consiglio provinciale di Cuneo (14 agosto 1917) e di Dronero (2 ottobre 1919) per il
rinnovo della Camera del novembre 1919, riproposto nel citato “Carteggio” sulla scorta
del loro manoscritto. Il settantacinquenne statista vi denunciò sarcasticamente “la più
strana delle contraddizioni” dell’ordinamento politico italiano: non si poteva creare o
abolire una pretura o un impiego pubblico senza la preventiva approvazione del
Parlamento ma si poteva invece “per mezzo di trattati internazionali assumere, a nome del
paese, i più terribili impegni che portino inevitabilmente alla guerra; e ciò non solo senza la
approvazione del Parlamento, ma senza che né Parlamento né paese ne siano, o ne possano
essere, in alcun modo, informati”. Occorreva dunque la “riforma statutaria”: una sfida alla
Corona.
Tornato a capo del governo nel giugno 1920, lo statista presentò il disegno di legge che
conferiva al Parlamento il potere di dichiarare guerra. Non era necessario modificare lo
Statuto. Uomo del Risorgimento, ricordava che secondo la Carta albertina del 1848 la
bandiera era quella di Casa Savoia e che la sola religione dello Stato era la cattolica, ma
poi, solo con regio decreto e senza toccare lo Statuto, il Regno di Sardegna aveva adottato
il tricolore italiano e proclamato che la differenza di culto non costituiva discrimine tra i
5
cittadini. Pur in carenza di documentazione, possiamo ritenere con certezza che Giolitti
sottopose a Vittorio Emanuele III il testo di un disegno di legge che, sottoscritto dall’intero
governo, toccava le prerogative della Corona. L’iniziativa di Giolitti, sostenuta dall’intero
governo, non era un salto nel buio. La relazione sul disegno di legge avvertì che “i rapporti
internazionali danno luogo a troppo vaste interferenze, ed hanno troppe possibilità di
ripercussioni gravi e lontane, perché del loro orientamento non debba essere chiamato a
decidere, in pienezza di libertà e con perfetta cognizione di causa, per mezzo della sua
legittima rappresentanza, il popolo, che dovrebbe, poi, accettarne o subirne le
conseguenze...”. Precisò tuttavia che esulavano dalla discussione e dall’approvazione del
Parlamento “i provvedimenti urgenti che fossero per avventura resi necessari per la difesa
del territorio, giacché in tal caso straordinario la necessità suprema di respingere
un’aggressione, darebbe giustificazione di qualsiasi provvedimento”. Nessuna retorica
pacifistica, dunque: nessun capo reclinato sul ceppo di aggressioni nemiche. La salvezza
dello Stato rimaneva suprema regola sufficiente a imporre qualsiasi misura difensiva e
offensiva, in linea con la Res Publica romana. Però le Camere non trovarono tempo di
discutere e approvare il disegno di legge. Il V ministero Giolitti durò un anno. Il disegno
decadde e non venne più ripresentato da nessuno. E gli effetti si sarebbero visti vent’anni
dopo con la Seconda guerra mondiale
Nel 1852 Cavour aveva compiuto un primo passo: a parte politica estera e guerra (riservati
ai ministri del re) per rimanere in sella al governo non bastava l’incarico del re, gli
occorreva la fiducia del Parlamento. Dopo il maggio-aprile 1915 e le sue drammatiche
conseguenze Giolitti tentò il secondo passo – trasferire il potere vero: esteri e guerra –
dall’esecutivo al legislativo, ma fallì. La grande occasione andò perduta. Il re e il governo
rimasero incatenati e separati dal parlamento e dal Paese. Perciò molti previdero che le
sorti della monarchia sarebbero dipese da chi aveva l’investitura del re anziché il consenso
del Paese tramite il parlamento. La monarchia sarebbe durata solo in caso di vittoria del
“suo” governo. Simul stabunt, simul cadent. Come infatti accadde.
Aldo A. Mola
[email protected]