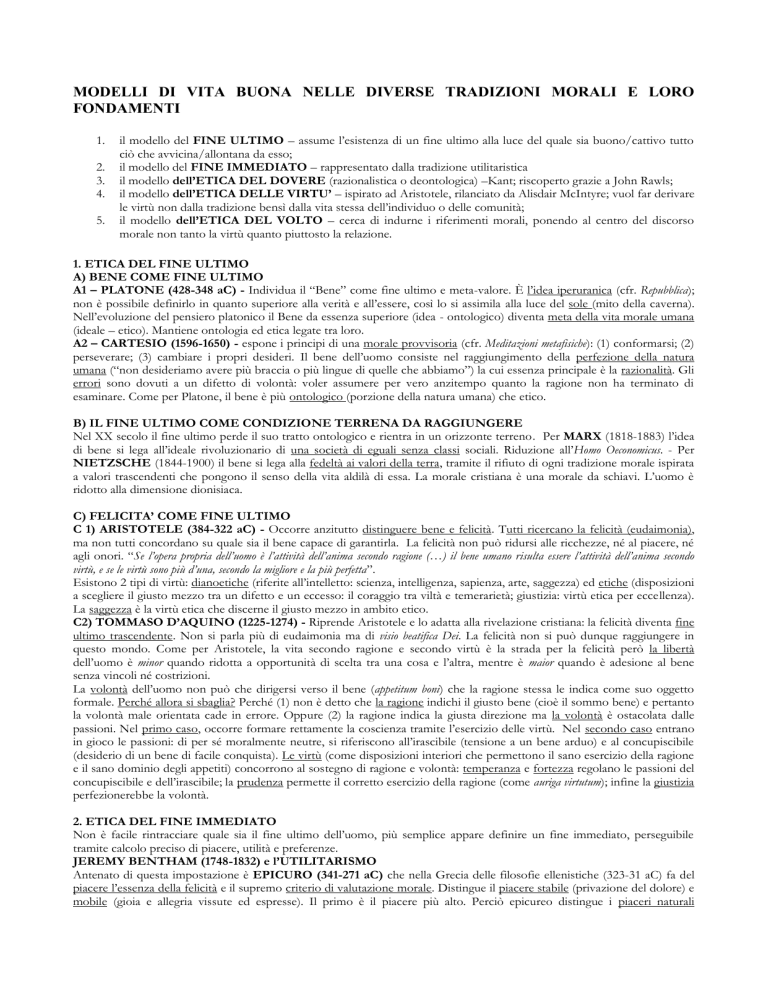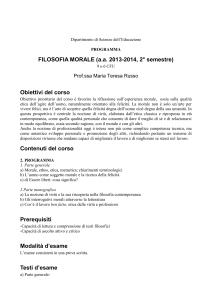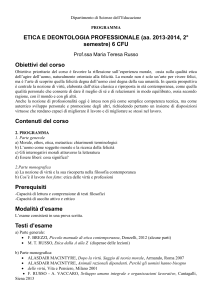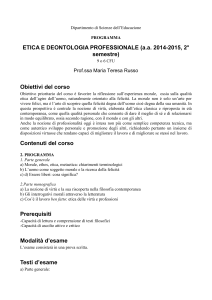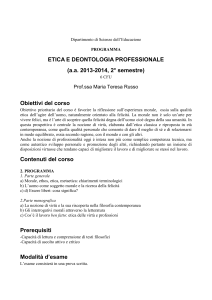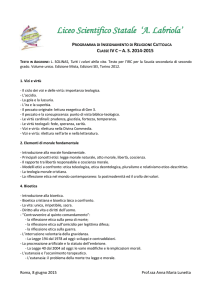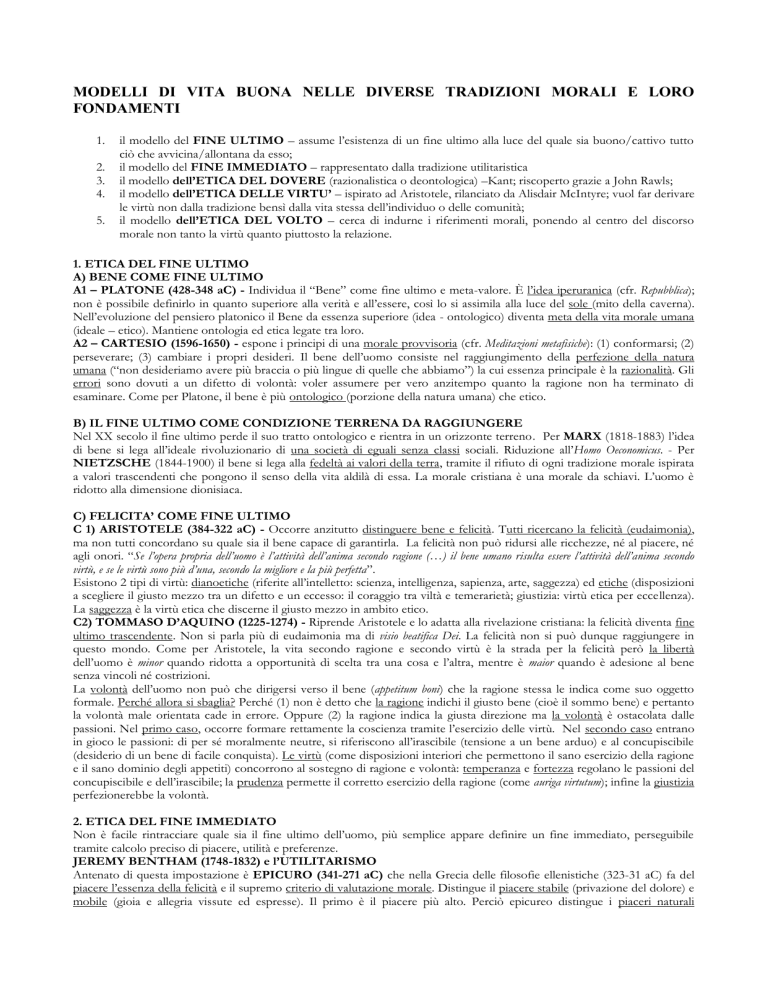
MODELLI DI VITA BUONA NELLE DIVERSE TRADIZIONI MORALI E LORO
FONDAMENTI
1.
2.
3.
4.
5.
il modello del FINE ULTIMO – assume l’esistenza di un fine ultimo alla luce del quale sia buono/cattivo tutto
ciò che avvicina/allontana da esso;
il modello del FINE IMMEDIATO – rappresentato dalla tradizione utilitaristica
il modello dell’ETICA DEL DOVERE (razionalistica o deontologica) –Kant; riscoperto grazie a John Rawls;
il modello dell’ETICA DELLE VIRTU’ – ispirato ad Aristotele, rilanciato da Alisdair McIntyre; vuol far derivare
le virtù non dalla tradizione bensì dalla vita stessa dell’individuo o delle comunità;
il modello dell’ETICA DEL VOLTO – cerca di indurne i riferimenti morali, ponendo al centro del discorso
morale non tanto la virtù quanto piuttosto la relazione.
1. ETICA DEL FINE ULTIMO
A) BENE COME FINE ULTIMO
A1 – PLATONE (428-348 aC) - Individua il “Bene” come fine ultimo e meta-valore. È l’idea iperuranica (cfr. Repubblica);
non è possibile definirlo in quanto superiore alla verità e all’essere, così lo si assimila alla luce del sole (mito della caverna).
Nell’evoluzione del pensiero platonico il Bene da essenza superiore (idea - ontologico) diventa meta della vita morale umana
(ideale – etico). Mantiene ontologia ed etica legate tra loro.
A2 – CARTESIO (1596-1650) - espone i principi di una morale provvisoria (cfr. Meditazioni metafisiche): (1) conformarsi; (2)
perseverare; (3) cambiare i propri desideri. Il bene dell’uomo consiste nel raggiungimento della perfezione della natura
umana (“non desideriamo avere più braccia o più lingue di quelle che abbiamo”) la cui essenza principale è la razionalità. Gli
errori sono dovuti a un difetto di volontà: voler assumere per vero anzitempo quanto la ragione non ha terminato di
esaminare. Come per Platone, il bene è più ontologico (porzione della natura umana) che etico.
B) IL FINE ULTIMO COME CONDIZIONE TERRENA DA RAGGIUNGERE
Nel XX secolo il fine ultimo perde il suo tratto ontologico e rientra in un orizzonte terreno. Per MARX (1818-1883) l’idea
di bene si lega all’ideale rivoluzionario di una società di eguali senza classi sociali. Riduzione all’Homo Oeconomicus. - Per
NIETZSCHE (1844-1900) il bene si lega alla fedeltà ai valori della terra, tramite il rifiuto di ogni tradizione morale ispirata
a valori trascendenti che pongono il senso della vita aldilà di essa. La morale cristiana è una morale da schiavi. L’uomo è
ridotto alla dimensione dionisiaca.
C) FELICITA’ COME FINE ULTIMO
C 1) ARISTOTELE (384-322 aC) - Occorre anzitutto distinguere bene e felicità. Tutti ricercano la felicità (eudaimonia),
ma non tutti concordano su quale sia il bene capace di garantirla. La felicità non può ridursi alle ricchezze, né al piacere, né
agli onori. “Se l’opera propria dell’uomo è l’attività dell’anima secondo ragione (…) il bene umano risulta essere l’attività dell’anima secondo
virtù, e se le virtù sono più d’una, secondo la migliore e la più perfetta”.
Esistono 2 tipi di virtù: dianoetiche (riferite all’intelletto: scienza, intelligenza, sapienza, arte, saggezza) ed etiche (disposizioni
a scegliere il giusto mezzo tra un difetto e un eccesso: il coraggio tra viltà e temerarietà; giustizia: virtù etica per eccellenza).
La saggezza è la virtù etica che discerne il giusto mezzo in ambito etico.
C2) TOMMASO D’AQUINO (1225-1274) - Riprende Aristotele e lo adatta alla rivelazione cristiana: la felicità diventa fine
ultimo trascendente. Non si parla più di eudaimonia ma di visio beatifica Dei. La felicità non si può dunque raggiungere in
questo mondo. Come per Aristotele, la vita secondo ragione e secondo virtù è la strada per la felicità però la libertà
dell’uomo è minor quando ridotta a opportunità di scelta tra una cosa e l’altra, mentre è maior quando è adesione al bene
senza vincoli né costrizioni.
La volontà dell’uomo non può che dirigersi verso il bene (appetitum boni) che la ragione stessa le indica come suo oggetto
formale. Perché allora si sbaglia? Perché (1) non è detto che la ragione indichi il giusto bene (cioè il sommo bene) e pertanto
la volontà male orientata cade in errore. Oppure (2) la ragione indica la giusta direzione ma la volontà è ostacolata dalle
passioni. Nel primo caso, occorre formare rettamente la coscienza tramite l’esercizio delle virtù. Nel secondo caso entrano
in gioco le passioni: di per sé moralmente neutre, si riferiscono all’irascibile (tensione a un bene arduo) e al concupiscibile
(desiderio di un bene di facile conquista). Le virtù (come disposizioni interiori che permettono il sano esercizio della ragione
e il sano dominio degli appetiti) concorrono al sostegno di ragione e volontà: temperanza e fortezza regolano le passioni del
concupiscibile e dell’irascibile; la prudenza permette il corretto esercizio della ragione (come auriga virtutum); infine la giustizia
perfezionerebbe la volontà.
2. ETICA DEL FINE IMMEDIATO
Non è facile rintracciare quale sia il fine ultimo dell’uomo, più semplice appare definire un fine immediato, perseguibile
tramite calcolo preciso di piacere, utilità e preferenze.
JEREMY BENTHAM (1748-1832) e l’UTILITARISMO
Antenato di questa impostazione è EPICURO (341-271 aC) che nella Grecia delle filosofie ellenistiche (323-31 aC) fa del
piacere l’essenza della felicità e il supremo criterio di valutazione morale. Distingue il piacere stabile (privazione del dolore) e
mobile (gioia e allegria vissute ed espresse). Il primo è il piacere più alto. Perciò epicureo distingue i piaceri naturali
(necessari e non) da quelli non naturali, per raggiungere atarassia (imperturbabilità dell’animo) e aponia (assenza di dolore
fisico).
Come Epicuro, BENTHAM nota che l’uomo agisce per ricercare il piacere e fuggire il dolore. La felicità sarebbe dunque la
somma totale dei piaceri, condizione di per sé inattingibile per l’uomo che sperimenta sempre un qualche dolore. Occorre
ripiegare dunque sulla ricerca del benessere: il massimo del piacere col minimo del dolore. Il piacere è oggetto di calcolo in
base ad alcune variabili: intensità, durata, certezza, prossimità, fecondità, assenza di dolore, estensione ad altre persone del
piacere. È un calcolo quantitativo, non legato a intenzioni bensì a conseguenze immediate dell’agire umano.
Il problema è conciliare gli interessi della collettività: Bentham rifiuta l’egoismo morale e sposa una prospettiva filantropica:
è convinto che il piacere del singolo dipenda anche dal piacere altrui (è uno dei parametri del calcolo…) e dunque che esista
una armonia naturale degli interessi (trasposizione morale del liberismo economico). La virtù è una: quella che porta a
massimizzare il piacere e l’utilità del maggior numero di persone. Ha dunque carattere meramente strumentale in vista di una
“utilità” dell’azione che di fatto coincide con il piacere.
DAL PIACERE ALLA PREFERENZA - Dopo Bentham, l’utilitarismo si sviluppa gradualmente, divenendo il modello
di filosofia morale di riferimento per la tradizione anglosassone. Si iniziano a distinguere qualitativamente i piaceri.
Problema: qual è il fondamento del criterio assiologico chiamato a discernere qualitativamente la superiorità di un piacere
rispetto a un altro? Si prosegue con l’introdurre l’esame delle preferenze soggettive, spostando al questione dal piacere alla
preferenza: Jonh Harsanyi ad esempio distingue preferenze sociali e antisociali, razionali e irrazionali, vere e manifeste. Altri
ricorrono all’intuizionismo: G.E. Moore sostiene che le preferenze utilizzabili sono quelle che si intuiscono essere buone,
ma il rischio di arbitrarietà e soggettivismo è altissimo.
OLTRE L’UTILITARISMO: CONSEQUENZIALISMO E PROPORZIONALISMO - Nella seconda metà del XX
sec. l’utilitarismo approda al CONSEQUENZIALISMO: dalla scelta del soggetto (di problematica valutazione) si passa ad
esaminare le conseguenze pratiche della scelta. A differenza di Bentham, si pone tra parentesi il soggetto stesso e si valuta
l’azione (e le sue conseguenze) in sé e per sé. Si tralasciano virtù e intenzioni e si esaminano solo azioni e circostanze: l’agire
diventa un “evento”.
Lo schema di ragionamento prevede che: (1) il piacere (soddisfare le preferenze individuali) è un bene; (2) il piacere si può
calcolare e tanto maggiore esso è, tanto maggiore è la moralità dell’azione che l’ha prodotto, (3) quindi per valutare la
moralità di una azione basta verificare quanto piacere essa produrrà. Ma quali conseguenze valutare?
Una applicazione del consequenzialismo è il PROPORZIONALISMO (Fuchs, Scholz): si parla di “bene premorale” che
diventa “bene morale” nel momento in cui si sviluppano le conseguenze: l’aborto ad esempio è un bene premorale: buono
quando salva la vita della madre, cattivo quando compiuto gratuitamente.
Osservazioni: tra i critici interni, Amartya Sen (premio Nobel per l’economia nel 1998) propone correttivi di natura
deontologica; tra i critici esterni citiamo John Rawls e l’etica razionalistica nel suo complesso.
3. ETICA DEL DOVERE
Evitando di incentrarsi su moventi eterogenei (fine ultimo o immediato) per valutare la moralità dell’azione, l’etica del
dovere fa dipendere quest’ultima dalla conformità a un “dovere”, una razionalità.
IMMANUEL KANT (1724-1804) - Senza libertà non c’è responsabilità dunque moralità: la libertà è un postulato
(necessario ma non dimostrabile) della moralità (ne è la ratio essendi). L’agire umano segue principi morali: massime e
imperativi ipotetici e categorici. La legge morale kantiana non è dunque definita da “cosa” è comandato ma da “come”, cioè
dall’avere una forma di legge universale, dunque dalla forma e dall’universalità. Esistono 3 formulazioni dell’imperativo
categorico tra cui il test di universalizzabilità. La legge morale è dunque autonoma. Ancora: una azione è legale se conforme
a una legge esteriore, mentre è morale se conforme alla legge di ragione interiore (intenzione). Nella Dialettica emergono due
ulteriori postulati morali oltre alla libertà: l’esistenza dell’anima immortale (che garantisce un tempo sufficiente per
raggiungere il perfezionamento morale che equivale alla massima virtù) e l’esistenza di Dio (garante della felicità
commisurata alla virtù raggiunta): così si garantisce la soluzione dell’aporia del Sommo Bene (virtù + felicità).
JOHN RAWLS (1922-2002) E LA RIPRESA DI KANT - Nel 1971 Rawls pubblica Una teoria della giustizia in cui riprende
una etica deontologica (deon = dovere) e la applica alla filosofia politica. Attinge al contrattualismo di Locke e Rousseau,
immaginando una “posizione originaria”, in cui vi sia un “velo d’ignoranza” che impedisca di verificare le conseguenze delle
decisioni prese (così si distacca dall’utilitarismo). Quanto concordato assume i connotati di un vero e proprio imperativo
categorico kantiano. Nella posizione originaria emergerebbero due principi: (1) l’eguaglianza nell’assegnazione di diritti e
doveri fondamentali (mettendo così insieme libertà e uguaglianza: la libertà del singolo deve essere la maggiore possibile,
compatibilmente con quella altrui); (2) le ineguaglianze economiche e sociali (ricchezza, potere…) sono giuste solo se
producono benefici compensativi per ciascuno e, in particolare, per i membri meno avvantaggiati della società.
Rispetto al secondo principio, afferma che le disuguaglianze sociali devono essere combinate in base a due criteri: (a) il
principio di differenza (il più grande beneficio dei meno avvantaggiati) che si collega al principio di maximin (massimo del
minimo); (b) il principio di riparazione (maggior attenzione ai nati con meno doti) che è una sorta di principio delle “pari
opportunità”.
Osservazioni: l’etica deontologica è detta razionale perché la ragione non è un mero strumento ma la fonte della legge morale.
Nel “fine ultimo” la ragione governa le passioni dell’uomo, nel “fine immediato” calcola utilità e piaceri, mentre nell’etica
deontologica la ragione esprime la moralità dell’uomo e di una collettività. Serrata e rigorosa, tiene poco conto dei limiti
dell’umano.
MODELLI DI VITA BUONA NELLE DIVERSE TRADIZIONI MORALI E LORO
FONDAMENTI
Definire dei modelli di vita buona – con tutti i limiti che questo tentativo comporta – permette di
classificare le diverse filosofie morali e comprendere gli odierni approcci ai problemi morali. E offre
altresì un aiuto al confronto tra l’etica cattolica e l’etica laica e i diversi modelli di riferimento cui esse si
ispirano. Modelli diversi significano infatti valori e principi diversi, ma anche diverse domande e
questioni.
Si possono definire 5 modelli di filosofia morale (3 definiti e 2 abbozzi):
6. il modello del FINE ULTIMO – di lunga tradizione, riferimento principale per la teologia
morale cattolica, assume l’esistenza di un fine ultimo alla luce del quale sia buono/cattivo tutto
ciò che avvicina/allontana da esso;
7. il modello del FINE IMMEDIATO – rappresentato dalla tradizione utilitaristica, con diverse
accezioni e varianti;
8. il modello dell’ETICA DEL DOVERE (razionalistica o deontologica) – il massimo
rappresentante è Kant; è stato riscoperto nel XX secolo grazie a John Rawls;
9. il modello dell’ETICA DELLE VIRTU’ – ispirato ad Aristotele, rilanciato da Alisdair
McIntyre; si differenza dal “fine ultimo” per il tentativo – tuttora in via di definizione – di non
far derivare le virtù dalla tradizione bensì dalla vita stessa dell’individuo o delle comunità;
10. il modello dell’ETICA DEL VOLTO – come l’etica delle virtù, parte anzitutto dalla vita
concreta delle persone e cerca di indurne i riferimenti morali, ponendo al centro del discorso
morale non tanto la virtù quanto piuttosto la relazione; ha avuto fortuna in ambito pedagogico
nell’odierno contesto multiculturale.
1. ETICA DEL FINE ULTIMO
Questo modello comprende tutte le etiche che ammettono un fine ultimo per l’essere umano in base al
raggiungimento del quale giudicare bene o male l’agire dell’uomo. La domanda che la precede è: qual è
il fine ultimo dell’uomo?
A) BENE COME FINE ULTIMO
A1 – PLATONE (428-348 aC)
Individua il “Bene” come fine ultimo e meta-valore. È l’idea iperuranica che sta al di sopra di tutte le
altre, fondamento dello stato ideale (cfr. Repubblica); non è possibile definirlo in quanto superiore alla
verità e all’essere, così lo si assimila alla luce del sole (mito della caverna) che è principio di vita (calore
per l’essere) e di conoscenza (luce per la verità).
Nell’evoluzione del pensiero platonico (cfr Filebo) si nota che il Bene da essenza superiore (idea ontologico) diventa meta della vita morale umana (ideale – etico). Il Bene è definito da bellezza,
proporzione e verità; è presente sia nel pensiero, sia nel piacere; mantiene ontologia ed etica legate tra
loro.
A2 – CARTESIO (1596-1650)
Il massimo esponente del razionalismo cartesiano espone i principi di una morale provvisoria (cfr.
Meditazioni metafisiche) proponendosi poi una fissazione definitiva cui non giungerà mai: (1) conformarsi
a usi e costumi del paese in cui si vive; (2) perseverare nei proponimenti morali assunti fino alla verifica
di essi (per uscire dal bosco, si deve sempre procedere diritto, non vagare in tondo…); (3) cambiare i
propri desideri piuttosto che aspirare invano a modificare la realtà esterna.
Il bene dell’uomo consiste nel raggiungimento della perfezione della natura umana (“non desideriamo
avere più braccia o più lingue di quelle che abbiamo”) la cui essenza principale è la razionalità. Questo
rimanda al Discorso sul metodo e all’importanza di ritenere vero solo l’idea evidente (chiara e distinta). La
perfezione morale ultima si raggiunge tramite gli atti virtuosi, cioè quelle azioni dell’animo che fanno
acquistare all’uomo una qualche perfezione. Poiché il metodo rende la ragione infallibile nella ricerca
della verità, gli errori sono dovuti a un difetto di volontà: voler assumere per vero anzitempo quanto la
ragione non ha terminato di esaminare.
Come per Platone, il bene è più ontologico (porzione della natura umana) che etico.
B) IL FINE ULTIMO COME CONDIZIONE TERRENA DA RAGGIUNGERE
Nel XX secolo il fine ultimo perde il suo tratto ontologico e rientra in un orizzonte terreno.
Per MARX (1818-1883) l’idea di bene si lega all’ideale rivoluzionario di una società di eguali senza classi
sociali, in cui il lavoro sia fonte di senso per tutti e non per i soli borghesi; la rivoluzione è una necessità
storica (“la borghesia produce da sé i propri seppellitori” – nascita della coscienza di classe e
materialismo storico) e si tratta solo di innescarla. Riduzione all’Homo Oeconomicus.
Per NIETZSCHE (1844-1900) il bene si lega alla fedeltà ai valori della terra, tramite il rifiuto di ogni
tradizione morale ispirata a valori trascendenti che pongono il senso della vita aldilà di essa. La morale
cristiana è una morale da schiavi (umiltà e perdono nati dal risentimento e dalla debolezza – cfr la
genealogia della morale). Più che necessità storica (Marx), è un evento mitologico legato all’avvento del
SuperUomo (cfr. Così parlò Zaratustra). L’uomo è ridotto alla dimensione dionisiaca (ebbrezza, istinto,
vitalismo) senza una reale aspirazione a libertà e destino eterno.
C) FELICITA’ COME FINE ULTIMO
C 1) ARISTOTELE (384-322 aC)
Occorre anzitutto distinguere bene e felicità: (1) bene indica la meta, felicità il cammino; (2) riguardano
due tradizioni filosofiche tra loro diverse: Platone e Aristotele; (3) perché il bene comprende la felicità
come una delle sue parti, ad esempio distinta dalla virtù (Kant).
Per Aristotele (cfr. Etica Nicomachea) tutti ricercano la felicità (eudaimonia), ma non tutti concordano su
quale sia il bene capace di garantirla.
La felicità non può ridursi alle ricchezze (sono un mezzo), né al piacere (instabile e proprio degli
animali), né agli onori (transeunti e dipendenti dagli altri). Essa consiste in una attività, più precisamente
nell’esercizio della virtù: “Se l’opera propria dell’uomo è l’attività dell’anima secondo ragione (…) il bene umano
risulta essere l’attività dell’anima secondo virtù, e se le virtù sono più d’una, secondo la migliore e la più perfetta”.
Esistono 2 tipi di virtù: dianoetiche (riferite all’intelletto: scienza, intelligenza, sapienza, arte, saggezza)
ed etiche (disposizioni a scegliere il giusto mezzo tra un difetto e un eccesso: il coraggio tra viltà e
temerarietà; giustizia: virtù etica per eccellenza). La saggezza è la virtù etica che discerne il giusto mezzo
in ambito etico.
C2) TOMMASO D’AQUINO (1225-1274)
Riprende Aristotele e lo adatta alla rivelazione cristiana: la felicità diventa fine ultimo trascendente. Non
si parla più di eudaimonia ma di visio beatifica Dei. La felicità non si può dunque raggiungere in questo
mondo.
Come per Aristotele, la vita secondo ragione e secondo virtù è la strada per la felicità poiché meglio
risponde alle esigenze della natura umana. Tommaso precisa però che la libertà dell’uomo è minor
quando ridotta a opportunità di scelta tra una cosa e l’altra, mentre è maior quando è adesione al bene
senza vincoli né costrizioni.
La volontà dell’uomo non può che dirigersi verso il bene (appetitum boni) che la ragione stessa le indica
come suo oggetto formale. Perché allora si sbaglia? Perché (1) non è detto che la ragione indichi il
giusto bene (cioè il sommo bene) e pertanto la volontà male orientata cade in errore. Oppure (2) la
ragione indica la giusta direzione ma la volontà è ostacolata dalle passioni.
Nel primo caso, occorre formare rettamente la coscienza tramite l’esercizio delle virtù (soprattutto
dianoetiche); il giudizio di coscienza si baserà su divina rivelazione (Scrittura) e legge naturale (iscritta
nell’uomo e nel cosmo).
Nel secondo caso entrano in gioco le passioni: di per sé moralmente neutre, si riferiscono all’irascibile
(tensione a un bene arduo) e al concupiscibile (desiderio di un bene di facile conquista). Se la ragione e
la volontà governano le passioni, esse possono diventare alleate nel perseguimento del bene.
Diversamente, ostacoleranno la volontà nel seguire le indicazioni della ragione. Le virtù (come
disposizioni interiori che permettono il sano esercizio della ragione e il sano dominio degli appetiti)
concorrono al sostegno di ragione e volontà: temperanza e fortezza regolano le passioni del
concupiscibile e dell’irascibile; la prudenza permette il corretto esercizio della ragione (come auriga
virtutum); infine la giustizia perfezionerebbe la volontà (come per Aristotele, la giustizia è il “volere
secondo ragione”).
Osservazioni: bene e fine ultimo non sono termini specifici di questo modello (anche Kant ne parla); le
virtù sono riferite al modello classico delle virtù cardinali (novità emergono invece in Mc Intyre); la
ragione è strumento (mentre nell’etica razionalista ha ruolo determinante); non si specificano sentimenti
e rapporti (come invece farà l’etica del volto).
2. ETICA DEL FINE IMMEDIATO
Non è facile rintracciare quale sia il fine ultimo dell’uomo, più semplice appare definire un fine
immediato, perseguibile tramite calcolo preciso di piacere, utilità e preferenze.
JEREMY BENTHAM (1748-1832) e l’UTILITARISMO
Con Bentham si entra nel cuore di un nuovo modello di filosofia morale che ruota attorno al calcolo di
piaceri e dolori per giudicare della moralità di un azione.
Antenato di questa impostazione è EPICURO (341-271 aC) che nella Grecia delle filosofie ellenistiche
(323-31 aC) fa del piacere l’essenza della felicità e il supremo criterio di valutazione morale. L’agire
umano tende a massimizzare il piacere e rifuggire il dolore. Distingue il piacere stabile (privazione del
dolore) e mobile (gioia e allegria vissute ed espresse). Il primo è il piacere più alto. Perciò epicureo
distingue i piaceri naturali (necessari e non) da quelli non naturali, indicando nei primi (naturali e
necessari: bere acqua per dissetarsi) i soli da soddisfare per raggiungere atarassia (imperturbabilità
dell’animo) e aponia (assenza di dolore fisico). Disciplina di vita, ascetismo, uso della saggezza per
discernere i desideri: questi sono i mezzi per raggiungere quella felicità immediata che è ben lontana
dall’edonismo di successive riletture della filosofia epicurea.
Come Epicuro, BENTHAM nota che l’uomo agisce per ricercare il piacere e fuggire il dolore. La
felicità sarebbe dunque la somma totale dei piaceri, condizione di per sé inattingibile per l’uomo che
sperimenta sempre un qualche dolore. Occorre ripiegare dunque sulla ricerca del benessere: il massimo
del piacere col minimo del dolore.
Il valore di una azione si lega dunque al piacere che essa genera: maggiore è il piacere, più l’azione è
buona. Il piacere è oggetto di calcolo in base ad alcune variabili: intensità, durata, certezza, prossimità,
fecondità, assenza di dolore, estensione ad altre persone del piacere. È un calcolo quantitativo, non
legato a intenzioni bensì a conseguenze immediate dell’agire umano.
Con questo approccio Bentham evita l’ascetismo (che considera buono l’agire che diminuisce la felicità:
è il caso, secondo Bentham, di moralisti e fanatici religiosi, mossi comunque dal piacere della fama o del
paradiso…) e l’emotivismo (che lega la valutazione morale al sentimento momentaneo, il quale è però
segno del piacere, vero movente – per Bentham – dell’agire umano).
Il problema è conciliare gli interessi della collettività: Bentham rifiuta l’egoismo morale e sposa una
prospettiva filantropica: è convinto che il piacere del singolo dipenda anche dal piacere altrui (è uno dei
parametri del calcolo…) e dunque che esista una armonia naturale degli interessi (trasposizione morale
del liberismo economico). Poiché tale armonia non sempre si riscontra, occorre una sanzione esterna o
un premio a opera del legislatore per promuovere l’utilità collettiva.
La virtù (disposizione ad agire acquisita con ripetizione degli atti) a differenza di Aristotele non
determina la moralità di una azione (che dipende solo dalle conseguenze in termini di piacere/dolore)
ma individua il grado di responsabilità dell’agente (un conto è rubare per istinto, oppure per un piano
preordinato). Non parla di elenchi di virtù poiché la virtù è una: quella che porta a massimizzare il
piacere e l’utilità del maggior numero di persone. Ha dunque carattere meramente strumentale in vista
di una “utilità” dell’azione che di fatto coincide con il piacere.
DAL PIACERE ALLA PREFERENZA
Dopo Bentham, l’utilitarismo si sviluppa gradualmente, divenendo il modello di filosofia morale di
riferimento per la tradizione anglosassone.
Si iniziano a distinguere qualitativamente i piaceri (John Stuart Mill afferma che i piaceri umani sono
diversi da quelli animali e pure diversi tra loro). Problema: qual è il fondamento del criterio assiologico
chiamato a discernere qualitativamente la superiorità di un piacere rispetto a un altro?
Si prosegue con l’introdurre l’esame delle preferenze soggettive, spostando al questione dal piacere alla
preferenza: Jonh Harsanyi ad esempio distingue preferenze sociali e antisociali, razionali e irrazionali,
vere e manifeste. Si elabora in proposito un test di universalizzabilità per eliminare quelle preferenze
soggettive che verrebbero meno se si estendessero a tutti gli individui. Ma è problematico
immedesimarsi realmente negli altri e valutare uno scenario così complesso. Altri ricorrono
all’intuizionismo: G.E. Moore sostiene che le preferenze utilizzabili sono quelle che si intuiscono essere
buone, ma il rischio di arbitrarietà e soggettivismo è altissimo.
Altre soluzioni al test di universalizzabilità sono venute dal proporre di valutare non i singoli
comportamenti (ut. dell’atto), ma almeno delle norme (utilitarismo della norma). Questo ha portato ad
esempio Richard Hare a distinguere due livelli di utilitarismo: quello della riflessione filosofica in senso
stretto (cui si applicherebbe l’ut. dell’atto) e quello del livello pratico quotidiano (ut. della norma).
OLTRE L’UTILITARISMO: CONSEQUENZIALISMO E PROPORZIONALISMO
Nella seconda metà del XX sec. l’utilitarismo approda al CONSEQUENZIALISMO: dalla scelta del
soggetto (di problematica valutazione) si passa ad esaminare le conseguenze pratiche della scelta. A
differenza di Bentham, si pone tra parentesi il soggetto stesso e si valuta l’azione (e le sue conseguenze)
in sé e per sé. Si tralasciano virtù e intenzioni e si esaminano solo azioni e circostanze: l’agire diventa un
“evento”.
Lo schema di ragionamento prevede che: (1) il piacere (soddisfare le preferenze individuali) è un bene;
(2) il piacere si può calcolare e tanto maggiore esso è, tanto maggiore è la moralità dell’azione che l’ha
prodotto, (3) quindi per valutare la moralità di una azione basta verificare quanto piacere essa produrrà.
Ma quali conseguenze valutare? Quali dipendono dal soggetto e quali no? G.E. Moore parla di
conseguenze “probabili”, ma con alto grado di soggettivismo. Henry Sidgwick parla invece di
conseguenze “previste”: ma questo crea un circolo vizioso tra piacere come conseguenze previste e
viceversa.
Mentre il tomismo introduce criteri per le azioni a “duplice effetto” (non voler il male, azione buona o
neutra come mezzo, proporzione tra fine voluto e non, necessità dell’azione), il consequenzialismo
riduce il problema al calcolo delle conseguenze positive che l’agire produce.
Una applicazione del consequenzialismo è il PROPORZIONALISMO (Fuchs, Scholz): si parla di
“bene premorale” (una azione o un evento considerato in sé, astraendo dalle conseguenze) che diventa
“bene morale” nel momento in cui si sviluppano le conseguenze: l’aborto ad esempio è un bene
premorale: buono quando salva la vita della madre, cattivo quando compiuto gratuitamente.
Osservazioni: l’etica del fine immediato, pur individuando in diversi elementi il fine immediato (utilità,
preferenza, piacere) alla fine si orienta sulla valutazione consequenzialistica delle azioni. Teorie diverse
sono accomunate dall’etichette di “utilitarismo”. Etica ed economia convergono nella ricerca di modelli
matematici per il calcolo delle preferenze collettive.
Tra i critici interni, Amartya Sen (premio Nobel per l’economia nel 1998) propone correttivi di natura
deontologica; tra i critici esterni citiamo John Rawls e l’etica razionalistica nel suo complesso.
3. ETICA DEL DOVERE
Evitando di incentrarsi su moventi eterogenei (fine ultimo o immediato) per valutare la moralità
dell’azione, l’etica del dovere fa dipendere quest’ultima dalla conformità a un “dovere”, una razionalità.
STOICISMO
La filosofia stoica precorre l’etica del dovere. Il cosmo è sostenuto da un ordine necessario ed eterno
(Logos) che si riflette anche nell’agire dell’uomo che è virtuoso quando vive “secondo natura” ovvero
secondo ragione. A differenza di Kant, il dovere morale non è solo formale ma assume contenuti
precisi: onorare genitori, famiglia, patria. Ricercano la apatia (assenza di emozioni) e l’atarassia (assenza
di turbamenti). Parlano del sommo bene come virtù (per Kant invece sarà virtù + felicità).
Lo Stoicismo, nelle sue diverse varianti (Zenone, Cleante, Crisippo) si configura dunque come un’etica
del dovere non formale, in cui la ragione non è ragione del singolo uomo ma Logos universale.
IMMANUEL KANT (1724-1804)
Vertice dell’Illuminismo, chiude l’epoca moderna e apre al Romanticismo. La ragione, criticata nei suoi
limiti, diviene però il criterio del ben conoscere e del ben agire.
Nella Critica della Ragion Pratica (1788) Kant distingue la dottrina degli elementi (principi) da quella del
metodo (applicazioni). La prima comprende l’Analitica (il corretto funzionamento della ragione etica) e
la Dialettica (contraddizioni e postulati).
Mentre nella conoscenza del mondo ragione e volontà concordano, nell’agire morale tra di esse si apre
lo spazio della libertà umana la quale deve voler seguire le indicazioni della ragione, ma non lo deve con
necessità, altrimenti si vanificherebbe ogni discorso morale. Senza libertà non c’è responsabilità dunque
moralità: la libertà è un postulato (necessario ma non dimostrabile) della moralità (ne è la ratio essendi).
L’agire umano segue principi morali: massime (consigliano al singolo) e imperativi (comandano per
tutti); questi ultimi si distinguono in ipotetici (valgono per tutti quelli che si propongono un certo fine:
se vuoi esser promosso, devi studiare) e categorici (valgono per tutti a priori: non uccidere).
La legge morale kantiana non è dunque definita da “cosa” è comandato ma da “come”, cioè dall’avere
una forma di legge universale, dunque dalla forma e dall’universalità.
Esistono 3 formulazioni dell’imperativo categorico:
1. agisci in modo che la massima della tua volontà possa sempre valere come principio di una
legislazione universale (test di universalizzabilità);
2. agisci in modo da trattare l’umanità nella tua e altrui persona sempre come un fine e mai come
un semplice mezzo
3. agisci in modo che la tua volontà possa considerare se stessa, mediante la sua massima, come
universalmente legislatrice.
La legge morale è dunque autonoma, indipendente da moventi eteronomi quali: la ricerca della felicità,
la volontà di Dio, l’obbligo di leggi del governo, il sentimento fisico del piacere, il sentimento morale,
l’educazione ricevuta, la ricerca della perfezione.
Ancora: una azione è legale se conforme a una legge esteriore, mentre è morale se conforme alla legge
di ragione interiore (intenzione). Unico sentimento ammesso: il rispetto per il dovere morale.
Nella Dialettica emergono due ulteriori postulati morali oltre alla libertà: l’esistenza dell’anima
immortale (che garantisce un tempo sufficiente per raggiungere il perfezionamento morale che equivale
alla massima virtù) e l’esistenza di Dio (garante della felicità commisurata alla virtù raggiunta): così si
garantisce la soluzione dell’aporia del Sommo Bene (virtù + felicità).
JOHN RAWLS (1922-2002) E LA RIPRESA DI KANT
Nel 1971 Rawls pubblica Una teoria della giustizia in cui riprende una etica deontologica (deon = dovere) e
la applica alla filosofia politica, con l’intento di legittimare il liberalismo abbandonando l’utilitarismo per
un contrattualismo come base etica generale. Dichiara egli stesso di ispirarsi a Kant per delineare una
società armonica e giusta in cui la legittima soddisfazione degli interessi si accompagni a una equa
distribuzione.
Attinge al contrattualismo di Locke e Rousseau, ma non presuppone uno stato di natura precedente,
bensì immaginando una “posizione originaria”, a monte dell’attuale sistema sociale, in cui vi sia un
“velo d’ignoranza” che impedisca di verificare le conseguenze delle decisioni prese (così si distacca
dall’utilitarismo). Il “velo” implica una sorta di amnesia per le preferenze personali rispetto all’interesse
collettivo: si tratta di una realtà virtuale in cui ogni attore agisce razionalmente e liberamente per
definire contratti fondativi dettati dalla giustizia in senso stretto, ignorando la propria posizione di
partenza e dunque condizioni che potrebbero ispirare parzialità o discriminazione. Quanto concordato
assume i connotati di un vero e proprio imperativo categorico kantiano.
Nella posizione originaria emergerebbero due principi:
(1) l’eguaglianza nell’assegnazione di diritti e doveri fondamentali (mettendo così insieme libertà e
uguaglianza: la libertà del singolo deve essere la maggiore possibile, compatibilmente con quella
altrui);
(2) le ineguaglianze economiche e sociali (ricchezza, potere…) sono giuste solo se producono
benefici compensativi per ciascuno e, in particolare, per i membri meno avvantaggiati della
società.
Rispetto al primo principio, Rawls precisa le libertà degli individui: politica, di parola ed espressione, di
pensiero, personale, di proprietà privata, dalla detenzione arbitraria.
Rispetto al secondo principio, afferma che le disuguaglianze sociali devono essere combinate in base a
due criteri: (a) il principio di differenza (il più grande beneficio dei meno avvantaggiati) che si collega al
principio di maximin (massimo del minimo) che prevede che le disuguaglianze siano ammesse solo se
contribuiscono a migliorare le aspettative del gruppo meno fortunato della società; (b) il principio di
riparazione (la società deve prestare maggior attenzione ai nati con meno doti o in posizioni sociali meno
favorevoli) che è una sorta di principio delle “pari opportunità”.
In The Laws of People (1999) Rawls applica la “posizione originaria” al diritto dei popoli e alle relazioni
internazionali ispirandosi ancora a Kant (cfr. Per la pace perpetua). Emergono però alcune difficoltà: paesi
diversi non hanno una stessa concezione di bene (come invece accade in una società) e i singoli popoli
si considerano liberi ed eguali con criteri differenti. Tuttavia Rawls elenca alcuni principi di giustizia
internazionale, tra cui eguaglianza tra i popoli, diritto di autodifesa e rispetto dei diritti umani. Può ogni
popolo partecipare a questo “contratto”? Rawls distingue 5 tipi di popoli: (1) popoli liberali (pronti ad
aderire ai principi internazionali); (2) popoli gerarchici decenti (non strettamente democratici ma pronti
ad aderire); (3) popoli fuorilegge (senza mire espansionistiche); (4) popoli non bisognosi di assistenza;
(5) popoli benevolmente autoritari (onorano i diritti umani ma non hanno procedure consultive). Solo i
primi due popoli potrebbero far parte di una “società dei popoli”. Notevole sforzo di analisi, ma i casi
concreti e attuali sono assai più complessi.
Osservazioni: l’etica deontologica è detta razionale perché la ragione non è un mero strumento ma la
fonte della legge morale. Nel “fine ultimo” la ragione governa le passioni dell’uomo, nel “fine
immediato” calcola utilità e piaceri, mentre nell’etica deontologica la ragione esprime la moralità
dell’uomo e di una collettività. Serrata e rigorosa, tiene poco conto dei limiti dell’umano.
4. ETICA DELLE VIRTU’
Si lega al modello del fine ultimo (Aristotele) ma cerca di dare un fondamento più esistenziale all’etica
filosofica, non riducendola a insieme di comandi, ma fondandola sui bisogni profondi dell’uomo.
IL RITORNO AD ARISTOTELE
PHILIPPA FOOT (1920-2010) è una delle prime rappresentanti del ritorno ad Aristotele che è il
cuore dell’etica delle virtù (cfr. La natura del bene, 2001). Il concetto di “bene” non può essere ridotto a
semplice predicato, come voleva G.E. Moore, ma ha una sua sostanzialità cui si accede nella vita
quotidiana. In generale, “buono” è ciò che favorisce lo sviluppo dell’umanità nel suo specifico, cioè la
capacità di distinguere vizi e virtù, in una parola: la moralità. Un giudizio morale non è asettico o
dettato dalla sola ragione ma nasce da bisogni e desideri umani, per cui (1) si allontana dall’idea di
doveri morali rigorosi e universali e (2) accosta sempre più l’etica alla natura umana.
ELIZABETH ANSCOMBE (1919-2001) propugna l ritorno all’etica delle virtù per evitare
l’utilitarismo (cfr. Modern Moral Philosophy, 1958) convinta che l’etica deontologica sia velleitaria e
oppressiva; propone di sostituire al concetto di “dovere morale” quello di “desiderio” e “bisogno”.
ALASDAIR McINTYRE (1929)
Con “Dopo la virtù. Saggio di teoria morale” (1981) McIntyre rilancia definitivamente l’interesse per le
virtù aristoteliche. A fronte di una crescente frammentazione etica, ritiene si debba riedificare l’intero
sistema.
Pars destruens - Avversa l’emotivismo (per cui ogni giudizio morale non è che espressione di un
sentimento o un’emozione), rileva i limiti dell’illuminismo (ha fallito nel voler dare fondamento
razionale alla morale), dichiara fallito l’utilitarismo (piacere e utilità sono termini troppo ambigui),
ritiene che il termine “individuo” abbia eclissato la prospettiva comunitaria che in passato aveva invece
fatto fiorire la virtù e i più alti ideali morali.
Pars construens – per costruire ex novo un sistema etico condiviso occorre partire dall’esistenza umana,
dalle “pratiche di vita” analizzando le quali si possono cogliere atteggiamenti e azioni virtuose. La
“pratica di vita” è a metà strada tra una tecnica (usare il pc) e una istituzione (lo stato).
Limiti di tale analisi: esistono pratiche di vita malvagie; il legame tra le virtù si fonda su una concezione
di vita come unità, altrimenti si frammenta; la definizione delle virtù è parziale (pazienza come virtù di
attendere: sì, ma non qualunque cosa…)
Le pratiche di vita vanno dunque inserite in una nozione di unità di vita. Ognuno di noi tende a creare
tale unità di esperienze raccontando la propria biografia e facendo emergere un ideale di “vita buona”
selezionando valori e virtù principali. Per raggiungere tale “unità di vita” occorre però opporsi alla
filosofia analitica (che considera le azioni in modo atomistico) e alla sociologia (che separa individuo e
ruolo) e sentirsi parte della vita degli altri e sentire gli altri parte della propria.
L’unità di vita dipende dunque anche dall’incrocio tra differenti unità di vita: la vita non è solo “mia”
ma appartiene al contesto familiare e sociale in cui maturano scelte e tradizioni.
La virtù appare alla fine ciò che indirizza al raggiungimento dei diversi valori interni alle pratiche,
favorisce l’unità di vita singola e nel suo inserirsi in una tradizione di comunità.
Osservazioni: si richiama ad Aristotele, ma in un contesto di concretezza, storicità e vita comune degli
uomini. È una “sensibilità” che si propone di essere via per riedificare un’etica universale.
5. ETICA DEL VOLTO
L’etica del volto o delle relazioni interpersonali, di grande impatto all’indomani dell’Olocausto, è più di
un’etica: è un’antropologia nuova che mette al centro le relazioni e non l’individuo. Ma è meno di
un’etica perché affida il giudizio morale al gioco delle relazioni, senza predeterminarlo troppo. Si
ricollega alla filosofia personalista di Emmanuel Mounier (1905-1950).
MARTIN BUBER (1878-1965) E IL PRINCIPIO DIALOGICO
Nella vita dello spirito non si può parlare di individuo senza fare riferimento alla sua relazione con gli
altri. Di fronte a un Io sta necessariamente un Tu, riconosciuto come altro da me ma con pari dignità. Il
Tu fa prendere coscienze a me stesso di essere Io. Le scienze naturali parlano dell’Esso, non dell’Io,
poiché considerano l’individuo al di fuori della relazione.
Al fondamento di ogni relazioni sta poi un Tu con la T maiuscola, un sommo analogato quasi
inafferrabile: è il Tu di Dio che da Adamo in poi ha sempre interpellato l’uomo. Tre relazioni dunque –
io-esso; io-tu; io-Tu – stanno alla base dell’essere umano rispettivamente inteso come soggetto, persona
e Figlio.
Alla luce del principio dialogico, il male è sempre la negazione dell’altro o la riduzione del tu ad esso.
Mantenere aperta la relazione e la comunicazione è la via per non “cosificare” se stessi e gli altri.
EMMANUEL LEVINAS (1905-1995) E L’ETICA DEL VOLTO
In Levinas il principio dialogico di Buber diventa etica del volto. Etica strettamente connessa ad
antropologia e viceversa.
La relazione può essere origine delle norme etiche. Il rapporto con l’altro lascia infatti emergere la
differenza tra gli esseri umani e la necessità di non inglobare l’altro in me: l’etica del volto è dunque
un’etica della differenza (vs tradizione occidentale fondata sull’Essere che annulla ogni differenza).
Se reggo lo sguardo e il volto dell’altro, allora ho stabilito con lui una relazione profonda, altrimenti o
mi sento ferito e dominato o cerco io stesso di dominare.
Esistono forme diverse di alterità: maschi e femmine (la differenza sessuale è alla base dell’eros);
genitori e figli (per prendere coscienza della propria origine); le diverse culture (apertura al
multiculturalismo).
L’altro interpella la mia responsabilità: il suo sguardo mi impone di non uccidere e di non usare
violenza, ma altresì di promuovere amicizia e relazione profonda. Qui sta il fondamento della giustizia:
oltre a me e all’altro c’è infatti anche un terzo e questa è l’immagine della società, in cui siamo chiamati
a considerare le relazioni con gli altri come fonte di responsabilità e appello alla singola coscienza, cui
non si prescinde neppure di fronte a norme di convivenza civile generali.
L’etica di Levinas si presenta come etica della santità: una tensione con orizzonte religioso, in cui anche
la teologia viene ricondotta all’antropologia, non in senso riduttivo, bensì come rilettura dell’esperienza
di Dio alla luce del principio di alterità e di responsabilità.