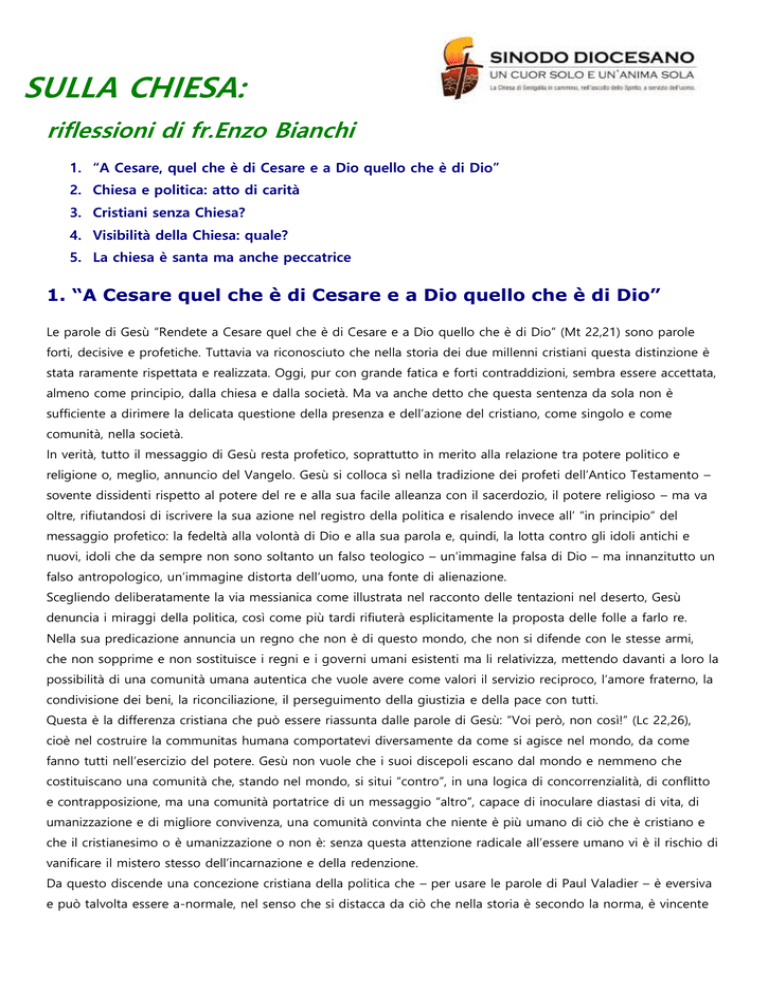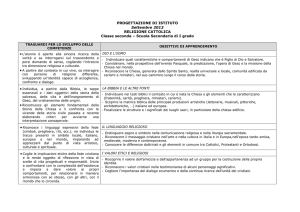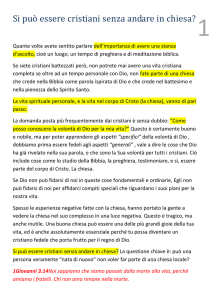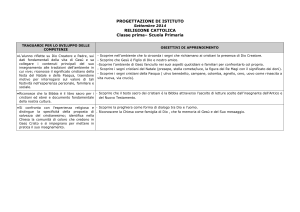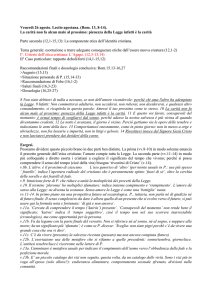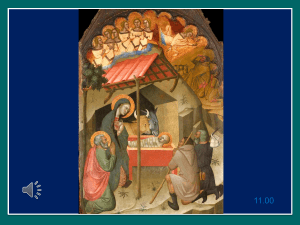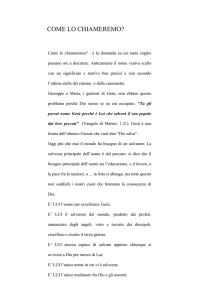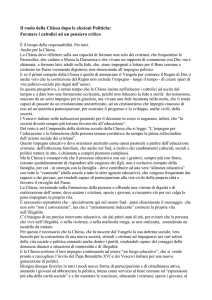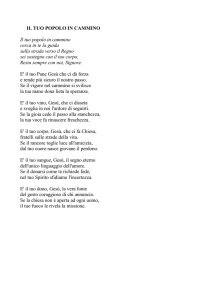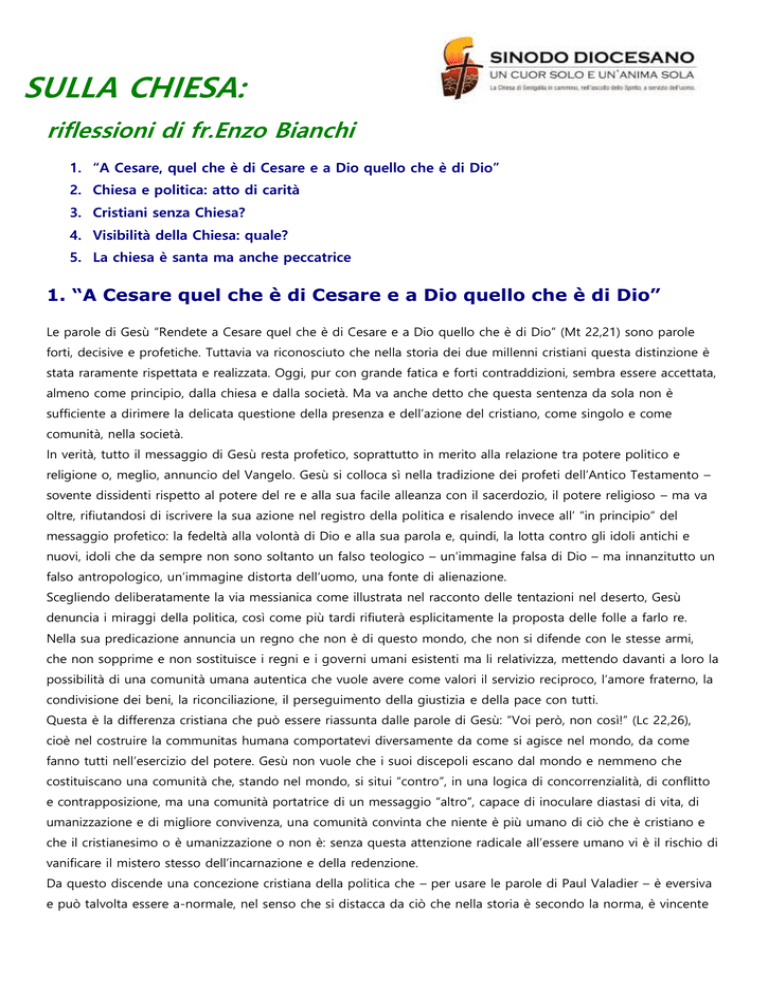
SULLA CHIESA:
riflessioni di fr.Enzo Bianchi
1. “A Cesare, quel che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio”
2. Chiesa e politica: atto di carità
3. Cristiani senza Chiesa?
4. Visibilità della Chiesa: quale?
5. La chiesa è santa ma anche peccatrice
1. “A Cesare quel che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio”
Le parole di Gesù “Rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio” (Mt 22,21) sono parole
forti, decisive e profetiche. Tuttavia va riconosciuto che nella storia dei due millenni cristiani questa distinzione è
stata raramente rispettata e realizzata. Oggi, pur con grande fatica e forti contraddizioni, sembra essere accettata,
almeno come principio, dalla chiesa e dalla società. Ma va anche detto che questa sentenza da sola non è
sufficiente a dirimere la delicata questione della presenza e dell’azione del cristiano, come singolo e come
comunità, nella società.
In verità, tutto il messaggio di Gesù resta profetico, soprattutto in merito alla relazione tra potere politico e
religione o, meglio, annuncio del Vangelo. Gesù si colloca sì nella tradizione dei profeti dell’Antico Testamento –
sovente dissidenti rispetto al potere del re e alla sua facile alleanza con il sacerdozio, il potere religioso – ma va
oltre, rifiutandosi di iscrivere la sua azione nel registro della politica e risalendo invece all’ “in principio” del
messaggio profetico: la fedeltà alla volontà di Dio e alla sua parola e, quindi, la lotta contro gli idoli antichi e
nuovi, idoli che da sempre non sono soltanto un falso teologico – un’immagine falsa di Dio – ma innanzitutto un
falso antropologico, un’immagine distorta dell’uomo, una fonte di alienazione.
Scegliendo deliberatamente la via messianica come illustrata nel racconto delle tentazioni nel deserto, Gesù
denuncia i miraggi della politica, così come più tardi rifiuterà esplicitamente la proposta delle folle a farlo re.
Nella sua predicazione annuncia un regno che non è di questo mondo, che non si difende con le stesse armi,
che non sopprime e non sostituisce i regni e i governi umani esistenti ma li relativizza, mettendo davanti a loro la
possibilità di una comunità umana autentica che vuole avere come valori il servizio reciproco, l’amore fraterno, la
condivisione dei beni, la riconciliazione, il perseguimento della giustizia e della pace con tutti.
Questa è la differenza cristiana che può essere riassunta dalle parole di Gesù: “Voi però, non così!” (Lc 22,26),
cioè nel costruire la communitas humana comportatevi diversamente da come si agisce nel mondo, da come
fanno tutti nell’esercizio del potere. Gesù non vuole che i suoi discepoli escano dal mondo e nemmeno che
costituiscano una comunità che, stando nel mondo, si situi “contro”, in una logica di concorrenzialità, di conflitto
e contrapposizione, ma una comunità portatrice di un messaggio “altro”, capace di inoculare diastasi di vita, di
umanizzazione e di migliore convivenza, una comunità convinta che niente è più umano di ciò che è cristiano e
che il cristianesimo o è umanizzazione o non è: senza questa attenzione radicale all’essere umano vi è il rischio di
vanificare il mistero stesso dell’incarnazione e della redenzione.
Da questo discende una concezione cristiana della politica che – per usare le parole di Paul Valadier – è eversiva
e può talvolta essere a-normale, nel senso che si distacca da ciò che nella storia è secondo la norma, è vincente
e più facilmente attestato. Nella storia, di fatto , religione e politica sono sovente andate di pari passo, l’una a
sostegno dell’altra, in un legame che è stato di connivenza e anche di complicità: si pensi solo alla res publica
romana, in cui la religione costringeva i cittadini alla devozione all’imperatore, o all’epoca costantiniana che dal iv
secolo è giunta in forme diverse fino al xix secolo, o ancora al potere temporale accordato ai papi, al
cesaropapismo prevalente nel mondo ortodosso, agli stati confessionali nelle aree di diffusione della riforma
protestante... Ma la fede cristiana urta contro tale concezione perché pretende di avere principi irrinunciabili e
non negoziabili nella vita personale del credente e in quella della comunità cristiana: il perdono e l’amore del
nemico, il ripudio della guerra, la difesa degli ultimi, la dignità di ogni persona vivente, l’accoglienza degli
stranieri…
L’anomalia cristiana appare dunque dove il Vangelo si oppone alla necessitas imposta da qualsiasi potere
mondano. Certo, la relazione tra politica e fede cristiana non è mai risolta definitivamente, non è mai statica: ma
questo è lo spazio della profezia, ossia di una parola liberante e umile capace di essere solidale con i fratelli e le
sorelle in umanità, a servizio della loro libertà e della loro umanizzazione.
Enzo Bianchi
2. Chiesa e politica.
«Amatevi come io vi ho amato» (Gv 13,34) è il «comandamento nuovo», cioè ultimo e definitivo, lasciato da
Gesù ai suoi discepoli. E in quel come c’è tutta l’esistenza di Gesù, l’esempio dato affinché ne seguissimo le orme
(cf. 1Pt 2,21): c’è il suo spendere la vita per gli altri fino alla fine, fino a donarla per gli amici e per tutti nella
libertà e per amore. Ora, questo comandamento che narra la specificità del cristianesimo richiede che il cristiano
non ami solo il prossimo, i suoi familiari, ma ami tutti coloro che incontra, e tra di essi privilegi gli ultimi, i
sofferenti, i bisognosi.
E’ alla luce di questo comandamento che il cristiano è chiamato anche a pensare alla forma “politica” – cioè
inerente il bene della polis – da dare all’uguaglianza, alla solidarietà, alla giustizia sociale. Se non ci fosse
un’esplicitazione anche politica dell’amore per l’ultimo, alla convivenza civile mancherebbe qualcosa di decisivo e
resterebbe evasa una grave responsabilità cristiana. Non dimentichiamo che Gesù ha risposto con un severo
ammonimento a chi lo interrogava sulle esigenze del regno: il giudizio per la vita o per la morte avverrà proprio
sul rapporto avuto qui e ora con l’essere umano nel bisogno, affamato, assetato, straniero, nudo, malato,
prigioniero (cf. Mt 25,31-46)!
La chiesa, quindi, nella sua missione evangelizzatrice ha il compito di indicare l’essere umano e la sua dignità
come criterio primo ed essenziale a un cammino di autentica pienezza di vita. Questo richiede che i cristiani
sappiano sì dare una testimonianza con la loro vita personale, ma sappiano anche rendere “eloquenti”,
comprensibili a tutti le loro convinzioni sulle esigenze di rispetto, salvaguardia e difesa della vita umana.
Allora, per esempio, di fronte alla guerra – che continua ad attirare i poteri politici e gli esseri umani – i cristiani
devono saper manifestare la loro contrarietà e la loro condanna, nella convinzione che “è alieno dalla ragione
pensare che nell’era atomica la guerra possa essere utilizzata come strumento di giustizia”, come profeticamente
ha indicato il magistero di Giovanni xxiii (cf. Pacem in terris 67), ripreso in diverse occasioni da Giovanni Paolo ii.
Analogamente i cristiani devono saper manifestare in modo eloquente la loro opzione in favore del rispetto della
vita dei popoli, minacciati anche da possibili catastrofi ecologiche; così come devono promuovere il rispetto
della vita di ogni persona che nasce sì da un uomo e da una donna, ma è innanzitutto voluta, pensata, amata da
Dio che la chiama alla vita (cf. Sal 139,13-16); il rispetto di ogni uomo e ogni donna dei quali ha senso ciascun
istante della vita, anche quelli segnati dalla sofferenza, fino alla morte vissuta come abbandono fiducioso nelle
mani di un Dio di amore. Occorre oggi da parte dei credenti creatività, fatica del ricercare e del pensare, capacità
di esprimersi su questi temi cruciali in termini antropologici comprensibili anche ai non cristiani…
Proprio per questa accresciuta difficoltà di linguaggio, l’azione dei cristiani nella polis non deve mai prescindere
dallo stile di comunicazione e di prassi: istanza fondamentale, perché lo stile è importante quanto il contenuto
del messaggio, soprattutto per noi cristiani. Già nei Vangeli si trova sulla bocca di Gesù un’insistenza maggiore
sullo stile che non sul contenuto dell’annuncio, che è sempre sintetico e preciso: «Non fate come gli ipocriti» (cf.
Mt 6,2.5.16); «Andate come pecore tra i lupi» (cf. Mt 10,16); «Imparate da me che sono mite e umile di cuore»
(Mt 11,29)... Sì, lo stile con cui il cristiano sta nella compagnia degli uomini è determinante: dal “come” dipende
la fede stessa, perché non si può annunciare un Gesù che racconta Dio nella mitezza, nell’umiltà, nella
misericordia, e farlo con stile arrogante, con toni forti o addirittura con atteggiamenti che appartengono alla
militanza mondana! E proprio per salvaguardare lo stile cristiano occorre anche resistere alla tentazione di
contarsi, di farsi contare, di esibire la propria forza… La fede non è questione di numeri ma di convinzione
profonda e di grandezza d’animo – si potrebbe dire parafrasando Ignazio di Antiochia (Ai romani iii,3) –, di
capacità di non avere paura dell’altro, del diverso, ma di saperlo ascoltare con dolcezza, discernimento e rispetto.
Dallo stile dei cristiani nel mondo dipende l’ascolto del Vangelo e la sua accoglienza come buona o come cattiva
comunicazione e, quindi, come buona o cattiva notizia.
3. CRISTIANI SENZA CHIESA?
Già da un po’ di anni si parla di “cristiani senza chiesa”, di “chiesa parallela”, di “scisma sommerso” per indicare
una realtà sempre più emergente: ci sono cristiani che, pur mantenendo la fede in Gesù Cristo come Signore e
Salvatore, rifiutano l’appartenenza alla chiesa, vivono etsi ecclesia non daretur, come se la chiesa non ci fosse. Ma
negli anni più recenti ancora, almeno in Europa, sembra crescere anche il numero di coloro che sentono la chiesa
quasi nemica, la percepiscono come ostacolo alla missione evangelizzatrice nel mondo, come una contraddizione
rispetto al vangelo. È un sentimento più forte di quello di Simone Weil che evocava la chiesa come “il grande
animale sociologico” di fronte al quale si fermava e non poteva entrare. Come è possibile questo fenomeno?
Un cristiano sa che la chiesa non può essere assente dalla sua fede, perché il suo io “credente” non può essere
solitario: unus christianus, nullus christianus, “un cristiano solo, nessun cristiano”, ripetevano con sapienza i padri.
Quando il cristiano confessa “io credo”, lo dice sempre personalmente, ma in comunione con altri, lo dice,
appunto, con la chiesa e sa che senza di essa egli non avrebbe potuto essere generato alla fede, innestato nella
vita stessa di Gesù e nutrito nel suo cammino quotidiano. E la chiesa non è forse il corpo di coloro che, chiamati
da Cristo e formando una comunità, costituiscono il corpo di Cristo nella storia? La chiesa dunque va accolta dal
cristiano come una madre e il cristiano deve sentire la propria filialità come un dono fatto da Cristo sulla croce a
tutti i discepoli – “Ecco tua madre!” – deve “prenderla con sé”, ritenerla tra i doni più preziosi (Gv 19,27).
Tuttavia occorre dire che assumere il mistero della chiesa e viverlo nel quotidiano non è un’opera che va da sé,
bensì l’esercizio di un amore che a volte costa, e costa molto. Sì, ci sono persone che amano la chiesa perché
conviene loro, ma non sanno cosa sia il vero amore che si deve avere per una madre, sposa del Signore, la quale
deve sempre essere fedele al suo Sposo. Amare la chiesa significa, a volte, soffrire per lei, desiderarla più fedele,
maggiormente plasmata dal vangelo, più conforme a Gesù Cristo. Animati da questo amore, nel corso della storia
fino ai nostri giorni molti cristiani hanno osato parole profetiche, hanno avuto il coraggio di far risuonare la
parola di Dio e le sue esigenze anche quando nessuno o pochi nella chiesa volevano ascoltare, hanno chiesto
anche alla chiesa di tornare, di convertirsi al suo Signore. E così, non solo hanno sofferto per lei, ma talvolta
hanno anche finito per soffrire a causa sua, perché in essa non mancano mai uomini segnati dalla complicità con
il mistero di iniquità.
Sì, a volte si constatano presenze che nella chiesa agiscono come “bande”, a volte si vedono emergere
corruzione, sete di potere, compromessi... Altre volte, più semplicemente e quotidianamente, si incontrano paure,
pigrizia, adulazione, silenzio omertoso... In questo caso il cristiano accetta di soffrire senza rassegnarsi e, se non
può parlare perché il silenzio gli viene imposto, sa urlare la verità persino con il silenzio. Ci sono ore e stagioni in
cui questa sofferenza si fa più forte e viene anche la tentazione di cedere al cinismo, di non credere più a
possibili primavere della chiesa, di non attendere più che, dove dovrebbe esserci almeno la ricerca faticosa della
santità, cessi la tranquilla sordità alla voce del vangelo. È l’ora della tentazione, ma occorre credere più che mai
alla fedeltà di Cristo al suo corpo, occorre amare questo “suo corpo” anche quando appaiono i segni del peccato,
come ha fatto Gesù. È l’ora di guardare a se stessi, ai propri peccati, ai propri tradimenti e non sentirsi migliori.
La chiesa è una comunione di santi, ma è anche sempre una solidarietà di peccatori: i peccati non generano mai
comunione ma divisione, separazione, perché sono opera del diavolo, il “divisore”; ma nel peccato noi possiamo
sentire la solidarietà. Sì, non siamo migliori dei nostri padri e dei nostri fratelli: la vera differenza è quella che
sembra imporsi tra peccatori manifesti e peccatori nascosti, tra quanti si pentono dei loro peccati e quanti li
negano, rigettandoli sugli altri. Ma agli occhi di Dio la realtà risplende nella sua verità più profonda: il suo
sguardo che discerne, giudica e usa misericordia è lo sguardo che dobbiamo acquisire se vogliamo leggere in
modo evangelico anche i momenti più sofferti della nostra appartenenza vitale alla chiesa.
4. Visibilità della chiesa: quale?
Scriveva Ignazio di Antiochia, all’inizio del II secolo, che “è necessario farsi vedere cristiani e non soltanto dire di
esserlo” (Ai magnesii IV,1). Queste parole non chiedono ai cristiani solo una coerenza tra la fede professata e il
modo di vivere, il comportamento, ma suggeriscono anche che i cristiani nel loro stare nel mondo, in mezzo agli
uomini non cristiani, devono avere una visibilità, che significa innanzitutto essere leggibili. Visibilità individuale e
visibilità collettiva, cioè comunitaria, ecclesiale, sono necessarie perché la fede non può essere relegata nell’intimo
o nel privato e perché la visibilità è la prima condizione per operare la missione, per portare la buona notizia alle
genti. Se prestiamo attenzione alla storia del cristianesimo, diventiamo consapevoli che fin dall’inizio, quando le
piccole comunità cristiane erano sparse, in diaspora e certamente minoritarie in mezzo alla grande massa dei
pagani, esse però erano minoranze creative, efficaci, capaci di eloquenza e di rendersi visibili anche nella
situazione di ostilità e di persecuzione in cui sovente venivano a trovarsi, almeno nei primi tre secoli.
Visibilità non significa esposizione ricercata, non significa inseguire la logica dell’apparire a ogni costo; tanto
meno può essere una programmata “ostensione” di personaggi cristiani. No, essa è semplicemente un fuggire la
tentazione della fuga hominum, che sovente diventa anche – come testimonia la storia – fuga ecclesiae,
tentazione del nascondimento ideologico che cela spesso un’ideologia non evangelica. I cristiani non possono
dimenticare le parole di Gesù: “Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città collocata sopra un
monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché faccia luce a tutti
quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre buone azioni
e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli” (Mt 5,14-16). Dunque Gesù richiede una presenza visibile e
pubblica dei discepoli tra gli uomini, una testimonianza che gli uomini “vedono” e che “si impone” per la sua
differenza rispetto alla mondanità. Si faccia però attenzione: queste parole non abilitano a pregare per essere visti
e ammirati dagli uomini, non consentono di ostentare il nostro fare la carità e il bene per essere lodati, secondo
il monito dello stesso Gesù: “Guardatevi dal praticare le vostre buone azioni davanti agli uomini” (cf. Mt 6,1-6)…
L’equilibrio tra l’essere visibili senza tentativi di nascondimento e senza esibire se stessi, ma dando fiera
testimonianza a Cristo, è delicatissimo e dipende in primo luogo dalla purezza del proprio cuore. Occorrono
vigilanza, retta intenzione, grande umiltà per assumere l’equilibrio della posizione richiestaci da Gesù. Ma
possiamo anche interrogarci sul come della visibilità dei cristiani: visibilità attraverso che cosa? Anche a questo
proposito la storia del cristianesimo è ricca di esempi. Innanzitutto la visibilità dei cristiani non è mai fine a se
stessa né spettacolare o tanto meno auto-promozionale, ma si esprime nell’azione sociale, nella diakonia della
carità nelle sue diverse forme: dalla più alta, quella della diakonia politica, alla più quotidiana che è il servizio,
l’aiuto all’ultimo che ci sta vicino. Non si dimentichi che nella chiesa primitiva molte conversioni avvenivano
grazie alla visione e alla conseguente persuasione che i cristiani si amavano reciprocamente ed erano capaci di
esercitare la carità concreta verso tutti.
E oggi, mentre viviamo in un mondo segnato dall’indifferenza verso il cristianesimo, stiamo attenti a non cercare
un rimedio in una visibilità esposta, eccessiva, mediatica, in una visibilità mondana artificialmente costruita. La
chiesa non è tra gli uomini per mostrare se stessa ma per fare segno al mistero di Cristo; essa non impone ma
propone; non chiede sguardi su di sé ma fa segno e indica Gesù Cristo.
La visibilità cristiana assolutamente necessaria è comunque quella “sacramentale”, nel senso della capacità di
esprimersi in segni leggibili e comprensibili dagli uomini di oggi, segni che rimandano a Cristo. La visibilità della
chiesa è necessaria perché in essa traspaia, emerga l’uomo e il Dio Gesù Cristo. Ancora oggi infatti, come ai
tempi dell’incarnazione, ci sono uomini e donne che dicono a chi segue il Signore: “Vogliamo vedere Gesù!” (Gv
12,21).
Enzo Bianchi
5. La chiesa è santa ma anche peccatrice
La Stampa, 28 maggio 2006
A volte accade che la convinzione di conoscere bene i linguaggi e i contesti propri alla dimensione della fede
cristiana finisce per forzare le interpretazioni e per attribuire a personalità ecclesiali orientamenti solo auspicati o
temuti. Per alcuni commentatori, in numero crescente sia all’interno che all’esterno della chiesa, adusi a osannare
Giovanni Paolo II da vivo, pare ora diventato un vezzo criticarlo a favore del suo successore: fenomeno spiacevole
cui già abbiamo assistito dopo la scomparsa di Paolo VI. Così, nel corso del viaggio di Benedetto XVI in Polonia,
un’ammonizione del pontefice rivolta al clero polacco è stata interpretata da alcuni come una correzione di rotta
se non addirittura una sconfessione rispetto a uno dei gesti più significativi compiuti da Giovanni Paolo II nel suo
lungo pontificato, una liturgia da lui fortemente voluta al cuore del Giubileo del 2000: la richiesta a Dio del
perdono per i peccati compiuti dai figli della chiesa nel corso della storia.
Vale la pena riprendere il passaggio del discorso, perché il messaggio che ne emerge con forza ha una portata
che va oltre i suoi destinatari immediati e coinvolge la presenza e la testimonianza dei cristiani nella società: “Il
Papa Giovanni Paolo II – ha affermato il suo successore – in occasione del Grande Giubileo ha più volte esortato i
cristiani a far penitenza delle infedeltà passate. Crediamo che la Chiesa è santa, ma in essa vi sono uomini
peccatori. Bisogna respingere il desiderio di identificarsi soltanto con coloro che sono senza peccato. Come
avrebbe potuto la Chiesa escludere dalle sue file i peccatori? È per la loro salvezza che Gesù si è incarnato, è
morto ed è risorto. Occorre perciò imparare a vivere con sincerità la penitenza cristiana. Praticandola,
confessiamo i peccati individuali in unione con gli altri, davanti a loro e a Dio. Conviene tuttavia guardarsi dalla
pretesa di impancarsi con arroganza a giudici delle generazioni precedenti, vissute in altri tempi e in altre
circostanze. Occorre umile sincerità per non negare i peccati del passato, e tuttavia non indulgere a facili accuse
in assenza di prove reali o ignorando le differenti pre-comprensioni di allora. Inoltre la confessio peccati, per
usare un’espressione di sant’Agostino, deve essere sempre accompagnata dalla confessio laudis – dalla
confessione della lode. Chiedendo perdono del male commesso nel passato dobbiamo anche ricordare il bene
compiuto con l’aiuto della grazia divina che, pur depositata in vasi di creta, ha portato frutti spesso eccellenti”.
Ora, a me pare che l’aver rivolto questa esortazione ai presbiteri di una chiesa che ha conosciuto negli anni
recenti della cattività la dolorosa ferita di alcuni membri del clero divenuti collaboratori attivi del regime che
opprimeva e anche perseguitava i cristiani, non solo non smentisce né corregge l’intuizione evangelica di
Giovanni Paolo II della confessione dei peccati, ma la riprende e la sviluppa in un contesto che è paragonabile a
quello conosciuto dalla chiesa dei primi secoli al termine delle persecuzioni: allora si pose con forza il problema
dei lapsi , cioè di quei credenti che di fronte all’infuriare della persecuzione avevano rinnegato la loro fede per
sfuggire alla morte o alle torture e, terminata la tormenta, si erano pentiti e avevano chiesto di essere riammessi
nella comunità cristiana. Anche allora vi era chi si rifiutava con forza di perdonare il fratello e negava la possibilità
che fosse accolto nuovamente nella comunione ecclesiale, ma alla fine prevalse la visione di chi, consapevole che
nessuno può dirsi “senza peccato” agli occhi del Signore, voleva che la chiesa intera si facesse segno visibile
dell’amore misericordioso del Padre che riabbraccia il figlio perduto e ritrovato.
Al contrario di quanti – non certo “vergin di servo encomio e di codardo oltraggio” – vogliono cogliere rivincite o
prese di distanza del papa nei confronti del suo predecessore in merito a tematiche oggetto di “legittimo
dissenso”, io vedo nell’esortazione di Benedetto XVI una profonda continuità sia con l’intuizione di Giovanni
Paolo II, sia con l’apporto dell’allora cardinale Ratzinger alla riflessione sul significato della celebrazione giubilare
della richiesta di perdono. Di fronte a quei cristiani che concepiscono una chiesa solo santa o che propongono
un perfettismo ecclesiologico, l’allora prefetto della Congregazione della fede aveva ricordato che tutta la
Scrittura e i padri della chiesa hanno avuto “la capacità della testimonianza e della confessione del peccato”, e
dunque del rimprovero profetico. La chiesa, infatti, fin dall’epoca neotestamentaria non ha mai perso
l’autocoscienza del peccato che la abita: essa è santa perché è corpo di Cristo, ma è peccatrice nei suoi figli,
sempre bisognosa di purificazione e di perdono. Certo negli ultimi secoli – finita la cristianità compatta e iniziato
il confronto e lo scontro tra chiesa e società – è apparsa l’autodifesa a oltranza da parte della chiesa, l’apologia
della società perfetta, e così l’atteggiamento di ammissione dei propri peccati si è affievolito e talvolta è venuto
meno: questo fa sì che alcuni cristiani continuino a temere gesti di confessione dei peccati commessi da membri
dell’unico corpo ecclesiale, non li colgano come atti legittimi, li ritengano inopportuni o addirittura li sviliscano
negando l’istanza evangelica che li suscita e scambiandola per preoccupazione di adeguarsi alla mentalità
mondana.
Con buona pace di chi si ostina a non capire, nel confessare quelle colpe Giovanni Paolo II non giudicava i
cristiani dei tempi passati, né riversava sui cristiani di oggi la colpa di quegli atti storici. Solo Dio giudicherà le
persone, ma le azioni delle persone devono essere giudicate, e di fatto lo sono, hanno sempre continuato a
esserlo, dal Vangelo eterno, capace di essere giudizio di Dio ieri, oggi e domani. Nel volere fortemente quella
liturgia penitenziale giubilare, il papa non giudicava nessuno, né dimenticava le circostanze attenuanti: come ha
appunto ricordato Benedetto XVI ai presbiteri polacchi, lo spirito dominante, le culture del tempo, i
condizionamenti ambientali hanno sempre influenza sugli attori dei gesti peccaminosi. La chiesa è anche
consapevole che alcuni cristiani, nel compiere tali azioni riprovevoli, agivano in buona fede, credevano di fare la
volontà di Dio e di servire la verità. Ma questo non significa che determinati atti non siano oggettivamente
contraddittori del Vangelo, dunque peccati; e se sono peccati, frutto di tentazione ieri, possono essere capaci di
seduzione ancora oggi.
Certo, come ha ricordato Benedetto XVI, la presenza del peccato non deve far chiudere gli occhi davanti alla
santità nella chiesa: non solo a quella dei santi canonizzati, ma anche a quella degli umili, dei cristiani comuni che
non appaiono, non fanno notizia ma che nell’ininterrotta catena della storia della santità hanno sempre vissuto il
comandamento nuovo dell’amore, fino all’amore del nemico. Ma, come dicevano i padri del deserto, “chi conosce
i propri peccati è più grande di chi fa miracoli e risuscita i morti!”. La chiesa che canta il Magnificat per la sua
santità, realizzata in lei dal Signore, sa anche cantare il Miserere per i peccati commessi dai cristiani… E’ questa la
confessio laudis cui papa Benedetto XVI invita la chiesa.