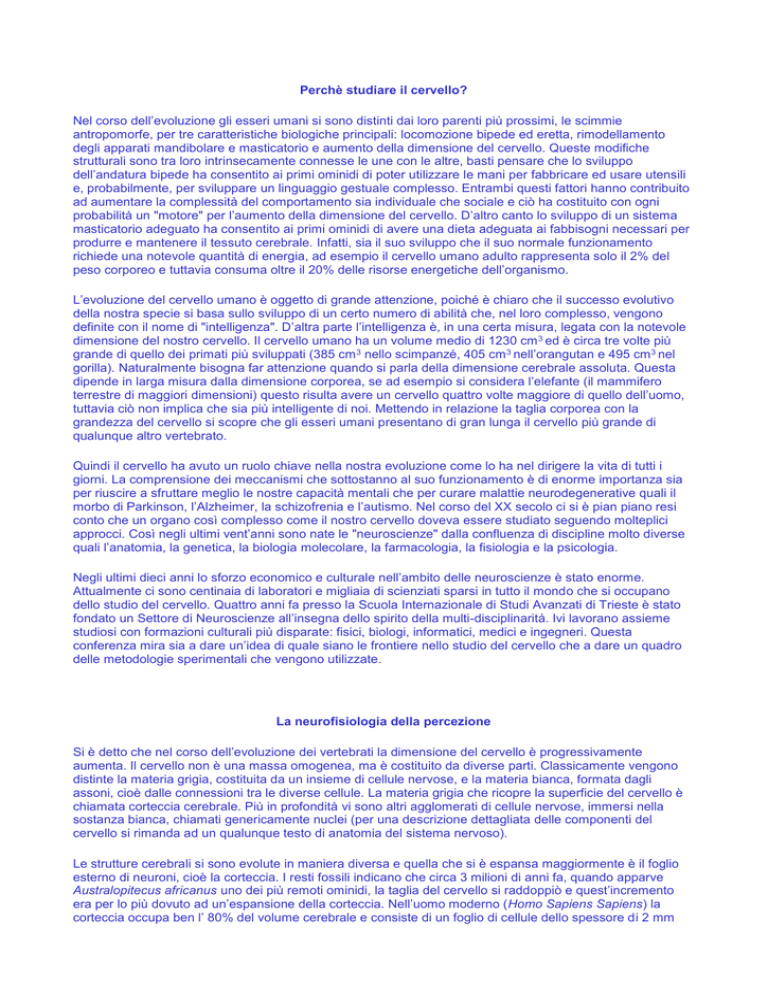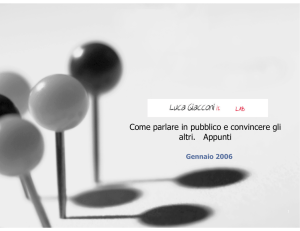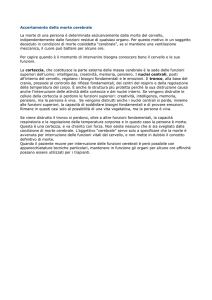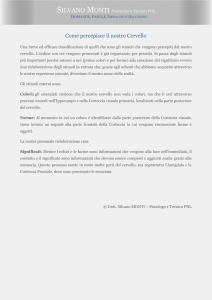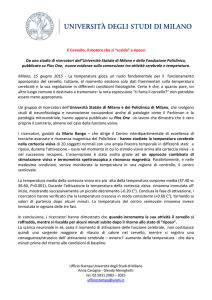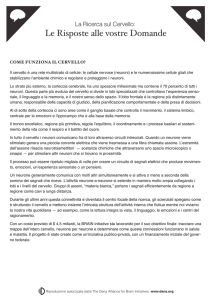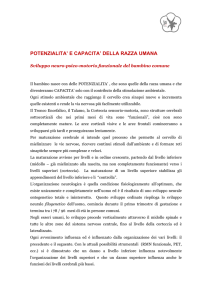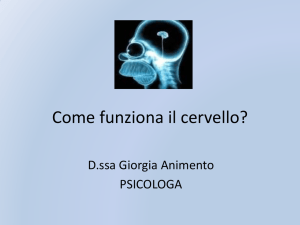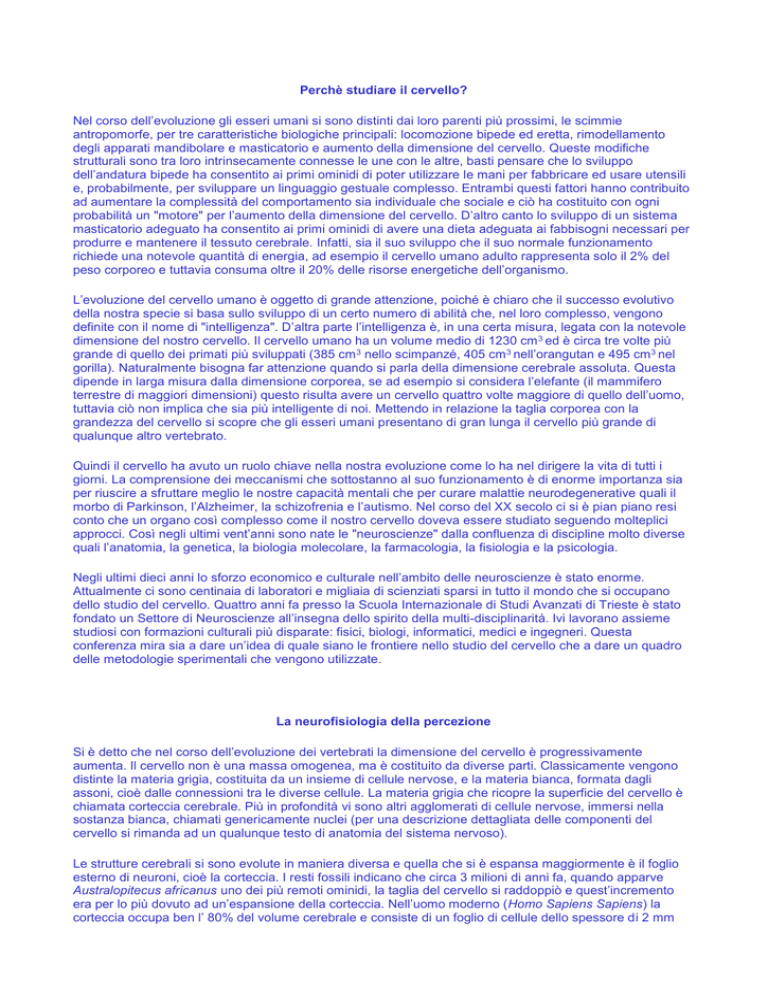
Perchè studiare il cervello?
Nel corso dell’evoluzione gli esseri umani si sono distinti dai loro parenti più prossimi, le scimmie
antropomorfe, per tre caratteristiche biologiche principali: locomozione bipede ed eretta, rimodellamento
degli apparati mandibolare e masticatorio e aumento della dimensione del cervello. Queste modifiche
strutturali sono tra loro intrinsecamente connesse le une con le altre, basti pensare che lo sviluppo
dell’andatura bipede ha consentito ai primi ominidi di poter utilizzare le mani per fabbricare ed usare utensili
e, probabilmente, per sviluppare un linguaggio gestuale complesso. Entrambi questi fattori hanno contribuito
ad aumentare la complessità del comportamento sia individuale che sociale e ciò ha costituito con ogni
probabilità un "motore" per l’aumento della dimensione del cervello. D’altro canto lo sviluppo di un sistema
masticatorio adeguato ha consentito ai primi ominidi di avere una dieta adeguata ai fabbisogni necessari per
produrre e mantenere il tessuto cerebrale. Infatti, sia il suo sviluppo che il suo normale funzionamento
richiede una notevole quantità di energia, ad esempio il cervello umano adulto rappresenta solo il 2% del
peso corporeo e tuttavia consuma oltre il 20% delle risorse energetiche dell’organismo.
L’evoluzione del cervello umano è oggetto di grande attenzione, poiché è chiaro che il successo evolutivo
della nostra specie si basa sullo sviluppo di un certo numero di abilità che, nel loro complesso, vengono
definite con il nome di "intelligenza". D’altra parte l’intelligenza è, in una certa misura, legata con la notevole
dimensione del nostro cervello. Il cervello umano ha un volume medio di 1230 cm 3 ed è circa tre volte più
grande di quello dei primati più sviluppati (385 cm 3 nello scimpanzé, 405 cm 3 nell’orangutan e 495 cm 3 nel
gorilla). Naturalmente bisogna far attenzione quando si parla della dimensione cerebrale assoluta. Questa
dipende in larga misura dalla dimensione corporea, se ad esempio si considera l’elefante (il mammifero
terrestre di maggiori dimensioni) questo risulta avere un cervello quattro volte maggiore di quello dell’uomo,
tuttavia ciò non implica che sia più intelligente di noi. Mettendo in relazione la taglia corporea con la
grandezza del cervello si scopre che gli esseri umani presentano di gran lunga il cervello più grande di
qualunque altro vertebrato.
Quindi il cervello ha avuto un ruolo chiave nella nostra evoluzione come lo ha nel dirigere la vita di tutti i
giorni. La comprensione dei meccanismi che sottostanno al suo funzionamento è di enorme importanza sia
per riuscire a sfruttare meglio le nostre capacità mentali che per curare malattie neurodegenerative quali il
morbo di Parkinson, l’Alzheimer, la schizofrenia e l’autismo. Nel corso del XX secolo ci si è pian piano resi
conto che un organo così complesso come il nostro cervello doveva essere studiato seguendo molteplici
approcci. Così negli ultimi vent’anni sono nate le "neuroscienze" dalla confluenza di discipline molto diverse
quali l’anatomia, la genetica, la biologia molecolare, la farmacologia, la fisiologia e la psicologia.
Negli ultimi dieci anni lo sforzo economico e culturale nell’ambito delle neuroscienze è stato enorme.
Attualmente ci sono centinaia di laboratori e migliaia di scienziati sparsi in tutto il mondo che si occupano
dello studio del cervello. Quattro anni fa presso la Scuola Internazionale di Studi Avanzati di Trieste è stato
fondato un Settore di Neuroscienze all’insegna dello spirito della multi-disciplinarità. Ivi lavorano assieme
studiosi con formazioni culturali più disparate: fisici, biologi, informatici, medici e ingegneri. Questa
conferenza mira sia a dare un’idea di quale siano le frontiere nello studio del cervello che a dare un quadro
delle metodologie sperimentali che vengono utilizzate.
La neurofisiologia della percezione
Si è detto che nel corso dell’evoluzione dei vertebrati la dimensione del cervello è progressivamente
aumenta. Il cervello non è una massa omogenea, ma è costituito da diverse parti. Classicamente vengono
distinte la materia grigia, costituita da un insieme di cellule nervose, e la materia bianca, formata dagli
assoni, cioè dalle connessioni tra le diverse cellule. La materia grigia che ricopre la superficie del cervello è
chiamata corteccia cerebrale. Più in profondità vi sono altri agglomerati di cellule nervose, immersi nella
sostanza bianca, chiamati genericamente nuclei (per una descrizione dettagliata delle componenti del
cervello si rimanda ad un qualunque testo di anatomia del sistema nervoso).
Le strutture cerebrali si sono evolute in maniera diversa e quella che si è espansa maggiormente è il foglio
esterno di neuroni, cioè la corteccia. I resti fossili indicano che circa 3 milioni di anni fa, quando apparve
Australopitecus africanus uno dei più remoti ominidi, la taglia del cervello si raddoppiò e quest’incremento
era per lo più dovuto ad un’espansione della corteccia. Nell’uomo moderno (Homo Sapiens Sapiens) la
corteccia occupa ben l’ 80% del volume cerebrale e consiste di un foglio di cellule dello spessore di 2 mm
che copre complessivamente una superficie di 0.5 m 2. Il fatto che la corteccia si sia espansa così
rapidamente suggerisce che essa abbia un buon "design" ovvero che sia in grado di espletare le sue
funzioni in maniera estremamente efficiente. Ma quali sono le funzioni della corteccia? Il compito basilare di
questa struttura cerebrale è quello di elaborare i dati sensoriali provenienti dall’ambiente esterno e formulare
delle opportune risposte motorie. Questa semplice affermazione nasconde la complessità dell’operato della
corteccia e tralascia il suo ruolo in compiti astratti, quali l’elaborazione di strategie complesse, le elaborazioni
artistiche e così via.
Ma come funziona la corteccia? Un secolo e mezzo di studi ha rivelato che regioni discrete della corteccia,
dette aree cerebrali, svolgono funzioni distinte. Vi sono aree specializzate nell’elaborazione delle
informazioni visive, aree specializzate nella produzione dei movimenti e molte altre. Naturalmente tali aree
sono tra loro interconnesse e si scambiano continuamente una gran mole di informazioni. Tutti i
comportamenti complessi, come progettare il nostro futuro, ricordare ciò che è accaduto un anno prima in
vacanza e provare delle emozioni sono il prodotto dell’azione concertata di molte aree cerebrali distinte. Il
funzionamento della corteccia può essere, quindi, paragonato a quello di un’orchestra nella quale diverse
sezioni strumentali, le aree, suonano assieme per produrre una sinfonia, i nostri comportamenti. Il concetto
di localizzazione delle funzioni cerebrali deriva da studi nei quali fu correlata il sito di una lesione corticale in
pazienti che avevano subito un trauma cerebrale con deficit specifici nel loro comportamento. La prima
dimostrazione di questo principio fu data da uno studioso francese, Pierre Paul Broca, alla metà del XIX
secolo. Egli vide che pazienti che presentavano un danno in una zona limitata della porzione anteriore
dell’emisfero cerebrale sinistro avevano perso la capacità di parlare normalmente: il loro eloquio era molto
più lento e i loro discorsi avevano uno stile telegrafico tuttavia essi mantenevano una buona capacità di
comprensione. Quindi danni localizzati causano dei difetti funzionali specifici, i pazienti descritti da Broca
vedevano, sentivano e si muovevano benissimo il loro problema era limitato alla produzione linguistica.
Se attualmente nessuno contesta più l’idea della specializzazione funzionale delle aree cerebrali è ancora
poco chiaro come ciascuna area riesca ad espletare il proprio compito e come facciano le diverse aree
cerebrali a collaborare per produrre comportamenti complessi. Domande quali "Come viene elaborata
l’informazione sensoriale proveniente dal mondo circostante?", o "Come vengono immagazzinati i ricordi?",
oppure ancora "Cosa succede nel nostro cervello quando rievochiamo una situazione vissuta in
precedenza?" sono ancora senza risposta certa. Uno dei modi in cui si è cercato di rispondere a queste
domande è registrando l’attività elettrica delle cellule nervose. I neuroni, infatti, comunicano tra loro
attraverso impulsi elettrici, detti anche potenziali d’azione. Qualunque input sensoriale viene tradotto in una
serie di impulsi che vengono poi inviati da una cellula nervosa all’altra per essere analizzati.
Negli anni ’20 fu messo a punto un sistema di registrazione dell’attività elettrica del cervello basato
sull’utilizzo di elettrodi che venivano applicati sulla superficie della corteccia. Tali elettrodi captavano
l’insieme delle risposte di decine di migliaia di neuroni. Inizialmente questa metodica fu utilizzata per studiare
la risposta nervosa ad uno stimolo sensoriale in macachi adulti. Si scoprì che toccando una parte del corpo
dell’animale, ad esempio una mano, si evocava una risposta in una zona ben delimitata della corteccia
parietale (sita posteriormente rispetto alla corteccia frontale) dell’emisfero cerebrale controlaterale.
Muovendo sistematicamente gli elettrodi lungo la corteccia parietale e trovando i siti in corrispondenza ai
quali la stimolazione di una parte del corpo produceva la massima risposta nervosa fu ottenuta una mappa
coerente della superficie corporea. In altre parole fu scoperta l’esistenza di una rappresentazione del nostro
corpo a livello dell’area cerebrale alla quale mettevano capo le informazioni tattili. Questa zona del cervello
fu perciò chiamata area sensoriale primaria. Tali rappresentazioni esistono in tutti i mammiferi. Nell’uomo
viene chiamata "homunculus sensoriale". L’homunculus non è una fedele riproduzione della forma del nostro
corpo ma è distorto. Le mani sono molto più grandi del tronco e la lingua è grande quanto i piedi. Queste
distorsioni riflettono l’importanza relativa nella percezione sensoriale delle varie parti del corpo in relazione
allo stile di vita. Nell’uomo, infatti, il linguaggio e la manualità sono abilità fondamentali. Successivamente
furono identificate nelle aree visive e uditive analoghe rappresentazioni delle superfici sensoriali, ovvero
della retina e della coclea.
Queste scoperte sebbene fondamentali per chiarire alcuni aspetti del funzionamento del cervello non
fornivano ancora una risposta a come uno stimolo sensoriale veniva elaborato all’interno di ciascuna
rappresentazione. Un passo fondamentale in questo senso fu lo sviluppo, alla fine degli anni ’50, di una
tecnica che consentiva la registrazione dell’attività di singoli neuroni. A tal scopo veniva inserito un sottile filo
di tungsteno, l’elettrodo, in corrispondenza dell’area da cui si voleva registrare. Nel cervello non ci sono
recettori per il dolore e quindi il soggetto (sia esso un ratto, una scimmia o un uomo) non prova alcuna
sensazione sgradevole durante la sessione di registrazione. L’elettrodo viene collocato in prossimità di una
cellula e capta i potenziali d’azione, o impulsi, che questa emette. Sfruttando questa tecnica si è potuto
cominciare a capire cosa fanno i singoli neuroni quando giunge loro un segnale dalla periferia, cioè dal modo
esterno.
Negli ultimi dieci anni sono stati fatti degli enormi progressi tecnologici che hanno portato ad una rivoluzione
nel modo di studiare il cervello. Qui ne verranno citati solo alcuni tra i più significativi.
Si è detto che mediante l’uso di elettrodi è possibile studiare le proprietà della risposta di singole cellule.
Tuttavia vi erano una serie di limitazioni tecniche, tra le quali l’uso di computer con processori troppo lenti,
che consentiva l’utilizzo di un solo elettrodo alla volta. In questo modo si poteva registrare da un unico sito
perdendo tutto "il contorno". Recentemente sono state sviluppate delle tecniche di registrazione nuove che
consentono l’impiego contemporaneo di numerosi microelettrodi, addirittura sino a un centinaio. In tal modo
possono venir raccolti simultaneamente molti più dati da zone adiacenti della stessa area corticale ed
ascoltare quindi una porzione più ampia dell’orchestra cerebrale.
Sicuramente tra le nuove tecniche quelle che consentono la visualizzazione dell’attività cerebrale di soggetti
umani in stato di veglia senza arrecare alcun danno sono tra le più affascinati. Una tra le prime ad essere
stata sviluppata è la tomografia ad emissione di positroni (PET). Il principio di funzionamento si basa
curiosamente su un’idea formulata da Charles Sherrington, premio Nobel per la medicina e la fisiologia nel
1890. Lui riteneva che la quantità di sangue che affluisce in una regione cerebrale dipende dal suo stato di
attivazione: quando l’area è attiva ve ne affluisce di più. Quindi, misurando il flusso sanguigno è possibile
stabilire quali aree sono attive in un certo istante. Allo scopo di misurare il flusso sanguigno si utilizza acqua
marcata radioattivamente, nella quale la molecola di ossigeno è stata sostituita da un isotopo radioattivo, in
genere l’ 15O, emittente positroni (i positroni sono particelle con la stessa massa degli elettroni ma con carica
opposta). Una piccola quantità del tracciante viene iniettata nella vena del braccio di un volontario e tramite il
circolo sanguigno, si distribuisce in tutto il corpo ed in particolare nelle zone più irrorate, tra cui il cervello. La
radioattività dell’acqua non è pericolosa in quanto l’ 15O ha un tempo di dimezzamento molto breve, attorno
ai 2 minuti, ed in circa 10 minuti tutto il campione iniettato decade in una forma non radioattiva. Inoltre le dosi
del tracciante sono molto basse. Per costruire delle mappe funzionali dell’attività cerebrale si paragonano
due situazioni: una nella quale il soggetto compie un certo test (stato funzionale) ed una nella quale non lo
esegue (stato di controllo). Quando il soggetto esegue il test le aree cerebrali coinvolte si attivano, vi
affluisce più di sangue e, di conseguenza, anche una maggiore quantità di acqua radioattiva. Confrontando
le immagini dello stato di controllo con quelle dello stato funzionale si possono stabilire quali regioni corticali
sono coinvolte nel processo studiato. La PET consente quindi di registrare simultaneamente l’attività di molte
aree cerebrali. Si deve sottolineare che sebbene con questa tecnica non si misuri direttamente l’attività
elettrica del cervello numerosi studi hanno confermato che il cambiamento di irrorazione delle regioni attivate
è strettamente collegata con la scarica delle cellule nervose.
Che cosa si può studiare utilizzando una tecnica di questo genere? Moltissimi processi cerebrali che erano
quasi inaffrontabili con i precedenti metodi di indagine. Un esempio della potenzialità della PET è quello
fornito dallo studio su ciò che avviene nella corteccia visiva quando ci si ricorda di un oggetto visto in
precedenza, condotto dall’équipe di Stephen Kosslyn alla Harvard University negli USA. Per comprendere il
valore di questo lavoro si deve premettere che il sistema visivo è formato da molte aree distinte che
elaborano il segnale visivo in maniera distinta. Nel macaco, un primate molto vicino all’uomo da un punto di
vista evolutivo, la corteccia visiva rappresenta circa il 50% dell’intera superficie corticale. In quest’ampia
zona dell’encefalo sono state identificate almeno una trentina di aree diverse coinvolte nei processi visivi.
Anche nell’uomo una notevole porzione del cervello è occupata da aree più o meno direttamente correlate
all’elaborazione dell’informazione visiva. L’area cerebrale che riceve gli impulsi nervosi direttamente dalla
retina, ovvero dall’organo sensoriale deputato alla "traduzione" degli stimoli luminosi in segnali elettrici, è
chiamata corteccia visiva primaria (V1). La V1 è anatomicamente connessa con molte aree visive di ordine
gerarchico superiore che compiono ulteriori analisi dell’input sensoriale. Per lungo tempo ci si era chiesti
cosa succede quando ci si immagina un oggetto. Cosa accade nel cervello: si attiva solo una
"rappresentazione verbale" dell’oggetto oppure anche una "rappresentazione visiva"? Kosslyn e colleghi
hanno potuto "fotografare" l’attività del cervello negli istanti nei quali soggetti umani rievocavano, ad occhi
chiusi, l’immagine di un oggetto che gli era stato mostrato in precedenza. In tal modo hanno potuto
dimostrare che vi è una significativa attivazione dell’area visiva primaria, oltre che di un certo numero di altre
aree visive. La loro scoperta implica che il ricordo di un oggetto induce l’attivazione delle stesse aree
cerebrali che sono attive quando vediamo l’oggetto stesso. In altre parole quando ci immaginiamo un
oggetto è come se lo rivedessimo anche se di fronte ai nostri occhi non c’è nulla.
Per concludere va citata un’altra tecnica sperimentale che ultimamente ha avuto un notevole impulso nelle
ricerche sul cervello, ossia la risonanza magnetica funzionale (fMRI). Al pari della PET, consente di ottenere
delle immagini dell’attività del cervello in vivo e in maniera non invasiva. Tuttavia la fMRI ha una risoluzione
spaziale molto migliore, in quanto si possono identificare i margini delle zone attivate con una precisione
dell’ordine di uno o due millimetri mentre con la PET l’errore si aggira sull’ordine del centimetro.
COME SI SVILUPPA IL NOSTRO CERVELLO?
Un cervello adulto umano ha un numero di cellule enorme, attorno ai 100 miliardi (o 1010 unità, per usare
una notazione più cara a fisici e matematici). I neuroni sono poi connessi gli uni con gli altri secondo schemi
specifici e molto complessi, in modo tale da consentire l’apprendimento, la memoria, la visione, il movimento
e tutte le altre funzioni mentali. Ma quest’organizzazione così complessa quando viene realizzata nel corso
della vita di un individuo? Nasciamo già con un cervello "adulto" oppure questo comincia a formarsi durante
la vita fetale e si completa con la crescita? Le ricerche degli ultimi quindici anni hanno dimostrato che gli
esseri umani nascono già con quasi tutti i neuroni che costituiranno il loro cervello adulto, tuttavia la massa
cerebrale è solo un quarto di quella che esso raggiungerà da adulto. La successiva crescita del cervello è
legata sia all’aumento della dimensione delle cellule nervose che all’incremento del numero delle loro
connessioni. In che modo si formano questi precisi collegamenti? Sono programmati geneticamente oppure
sono guidati dall’esperienza sensoriale?
Uno dei modelli sperimentali che sono stati utilizzati più spesso per questo tipo di ricerche è quello dello
sviluppo del sistema visivo in diverse specie mammiferi. Perché proprio il sistema visivo? Un primo
vantaggio è che è relativamente semplice manipolare l’esperienza visiva dei neonati ed osservare la risposta
comportamentale ai cambiamenti. In secondo luogo l’occhio dei mammiferi presenta piccole differenze da
specie a specie. Inoltre i neuroni visivi sono essenzialmente uguali a quelli presenti in altre parti del cervello.
Quindi, i risultati che si ricavano da tali studi sono presumibilmente applicabili agli esseri umani. Ma il più
importante vantaggio nell’usare questo sistema è che le proprietà di risposta dei neuroni corticali e le loro
interconnessoni nell’adulto sono abbastanza ben conosciute. In altre parole è possibile correlare
accuratamente la struttura anatomica del sistema visivo con la sua funzione. Com’è organizzato questo
sistema? L'organo sensoriale deputato alla trasduzione della luce in segnali nervosi, la retina, si trova
all’interno dell’occhio. Il compito di tutte le altre strutture dell'occhio è quello di focalizzare sulla retina le
immagini visive, con la minima distorsione possibile. Nella retina esistono delle cellule specializzate, i
fotorecettori, che captano la luce e la traducono in impulsi nervosi. Questi vengono inviati ad un’altra
categoria di neuroni retinici, le cellule gangliari, dalle quali hanno origine dei lunghi "cavi di connessione", gli
assoni, che mettono capo ad un nucleo sottocorticale, detto corpo genicolato laterale. Dalle cellule di questo
nucleo partono altre terminazioni nervose che portano l’informazione sensoriale nella corteccia visiva
primaria (o area V1). Questa regione si trova nella porzione più posteriore del cervello, il lobo occipitale. Nel
nucleo genicolato laterale, gli assoni delle cellule gangliari provenienti da ciascun occhio sono separati:
quelle provenienti da un occhio si alternano con quelle provenienti dall’altro. A loro volta gli assoni dei
neuroni del corpo genicolato laterale terminano in aree ristrette della corteccia visiva. Qui le terminazioni
corrispondenti all’occhio destro si alternano a quelle dell’occhio sinistro, formando le cosiddette "colonne di
dominanza oculare".
All’inizio della vita fetale, le cellule gangliari, i neuroni del nucleo genicolato laterale, e le cellule della
corteccia visiva non sono collegate tra loro. Per riuscire a stabilire il corretto schema di interconnessioni, gli
assoni di queste cellule nervose devono percorrere grandi distanze, (enormi se paragonate al diametro del
loro corpo cellulare), e devono evitare miliardi di falsi bersagli. Thomas Jessel della Columbia University,
negli USA, è stato uno dei primi a dimostrare che la prima fase dello sviluppo è geneticamente
programmata, ovvero è scritta nel DNA delle nostre cellule. I neuroni-bersaglio secernono delle molecole
specifiche, appartenenti alla classe delle neurotrofine (la cui "madre spirituale" è Rita Levi Montalcini, premio
Nobel per la Medicina), che attirano gli assoni in accrescimento. Questi ultimi si estendono sino a quando la
meta programmata viene raggiunta, dopo di che formano delle connessioni specializzate, dette sinapsi, con
un gran numero di cellule….alcune "giuste" ed altre "sbagliate". Infatti, il processo di riconoscimento
molecolare non è perfetto, consente agli assoni di neuroni lontani di trovare la "retta via", ma non indica
precisamente quali sono le cellule con cui stabilire delle connessioni sinaptiche. Al contrario vengono
formate un gran numero di sinapsi in sovrannumero che poi devono essere selezionate.
Questa è la condizione nella quale si trova un neonato quando apre per la prima volta gli occhi: le
connessioni nervose presentano uno schema circuitale immaturo, che assomiglia solo vagamente a quello
dell’adulto. Come avviene il successivo processo di selezione? In questa fase l’esperienza visiva gioca un
ruolo fondamentale. Un ottimo esempio per comprendere questo processo è fornito dalla formazione delle
colonne di dominanza oculare. Per visualizzare il loro sviluppo fu utilizzato il metodo del trasporto
transinaptico, cioè attraverso le sinapsi, di aminoacidi radioattivi. La metodica consiste nell’iniettare piccole
dosi di un aminoacido marcato con l’isotopo 14 del carbonio, nell’occhio di gatti di diverse età. Una volta
nell’occhio, l’aminoacido viene assunto da tutte le cellule retiniche, comprese quelle gangliari. Viaggiando
all’interno degli assoni delle cellule gangliari, il marker viene trasportato sino al corpo genicolato laterale e da
qui alla corteccia visiva. Il tessuto viene tagliato in fettine sottili e poi viene rivestito da un emulsione
fotografica e lasciato al buio per vari mesi. Infine la lastra viene sviluppata. Le zone marcate hanno un colore
chiaro, le altre un colore scuro. Analizzando le lastre si è visto che alla nascita le colonne di dominanza non
sono presenti, ovvero le fibre provenienti dal nucleo genicolato non si sono ancora segregate. Tale
separazione avviene completamente solo alla tredicesima settimana. Cosa la determina? n indizio
importante, in questo senso, è fornito dal fatto che se un occhio viene chiuso alla nascita, le corrispondenti
colonne corticali sono molto più piccole di quelle che si svilupperebbero normalmente….quindi la mancanza
dell’esperienza visiva influenza profondamente il corretto sviluppo della circuiteria cerebrale. In che modo
l’uso può produrre questi effetti? La spiegazione di questo fenomeno è basata su un meccanismo postulato
per la prima volta dallo psicologo canadese Donald Hebb alla fine degli anni ’50. Secondo Hebb, quando
due cellule sono spesso contemporaneamente attive la connessione sinaptica tra loro si rafforza. Il corollario
a questo "teorema" è che quando due neuroni non sono mai o quasi mai attivi nello stesso momento la loro
connessione si indebolisce. Gli studi condotti negli ultimi 15 anni dall’équipe di Lamberto Maffei all’Università
di Pisa e da quella di Michel Stryker e Carla Schatz dell’Università della California, negli USA, hanno
dimostrato che il processo di selezione delle sinapsi avviene proprio sulla base del meccanismo accennato
sopra. In che senso? Gli input visivi provenienti dalle cellule gangliari di un occhio, tendono ad arrivare alla
corteccia visiva tutti assieme eccitando sincronicamente il gruppo di neuroni con cui sono connessi "meglio".
Siccome le cellule gangliari di un occhio tendono a "sparare assieme" ad un certo gruppo di neuroni corticali,
questi "si legano assieme". Viceversa l’assenza di sincronicità nella scarica delle cellule gangliari dell’altro
occhio con quel gruppo di cellule corticale porta ad un indebolimento progressivo delle fibre di connessione.
Questi risultati sono stati replicati con altri sistemi sensoriali e quindi si ritiene che il modello di sviluppo del
sistema visivo sia applicabile a tutto il sistema nervoso. Quindi, durante lo sviluppo embrionale, il sistema
nervoso si organizza obbedendo ad uno schema insito nel nostro codice genetico, ma dopo la nascita viene
rimodellato dall’interazione con il mondo esterno. Da un punto di vista evolutivo questo modello di sviluppo
sembra essere una soluzione estremamente efficiente. In tal modo i geni non danno origine ad un sistema
nervoso "fisso", ma ad un sistema nervoso "flessibile" in grado di modificarsi, almeno in una certa misura, in
funzione delle informazioni che il mondo esterno gli "comunica". Ad esempio, si è a conoscenza di casi di
bambini che sono stati abbandonati nei boschi, da madri non troppo affettuose, e che sono stati allevati da
lupi (una testimonianza eccezionale è quella del film "Il ragazzo selvaggio" di F. Truffault). Questi bambini
non erano né in grado di parlare né in grado di camminare con una postura eretta. In generale il loro
comportamento era molto più simile a quello dei lupi che a quello degli esseri umani "normali". Questo
esempio dimostra chiaramente l’enorme influenza che l’ambiente in cui cresciamo esercita sul nostro
sistema nervoso e quindi sul nostro comportamento. Tuttavia, una volta che i bambini imparano a
camminare e a parlare, la struttura del cervello diviene relativamente permanente. Esiste perciò una finestra
temporale, detta "periodo critico", nella quale il sistema nervoso presenta un’enorme capacità di adattamento
agli stimoli esterni.
Ma cosa succede una volta superato il periodo critico? La struttura del cervello rimane stabile o si modifica
ancora? Fino ad una ventina di anni fa fisiologi e neurobiologi ritenevano che il sistema nervoso centrale dei
mammiferi potesse essere modificato soltanto durante la suddetta finestra temporale. Una volta superata
questa fase iniziale si supponeva che esso assumesse una configurazione stabile e che non potesse essere
più modificato. La stabilità dell’organizzazione cerebrale sembrava esser la base per una corretta
elaborazione dell’informazione sensoriale e per una corretta pianificazione ed esecuzione delle strategie
motorie. D’altra parte però etologi e psicologi, studiando il funzionamento del sistema nervoso da una
prospettiva "macroscopica", hanno da sempre constatato che il repertorio comportamentale di un organismo
adulto presenta un certo grado di plasticità. In altre parole gli animali sono in grado di apprendere e
memorizzare nuove esperienze anche quando hanno superato l’età dello sviluppo e tale proprietà sta alla
base delle loro capacità di sopravvivenza.
Vi era quindi una profonda divergenza tra una visione fissista del cervello ed una dinamica del
comportamento: come potevano aver luogo processi come l’apprendimento e la memorizzazione su un
substrato che non sembrava essere modificabile? Quali erano i meccanismi cellulari che erano alla base
della plasticità dei comportamenti degli animali adulti? L’apprendimento, ovvero il processo mediante il quale
si acquistano nuove conoscenze, e la memoria, ovvero il processo attraverso cui si conservano tali
conoscenze, non sembravano essere accessibili a livello cellulare o di tessuti ("microscopico"). Il divario tra
questi due approcci si sta via via assottigliando: i dati sperimentali raccolti nelle ultime due decadi ai più
diversi livelli hanno dimostrano che tutte le funzioni cerebrali possono essere modificate dall’esperienza. In
altre parole tutte le parti del cervello si modificano e si rinnovano continuamente nel corso della vita di un
individuo. Dal momento che ogni persona cresce e vive in ambienti diversi ed è quindi soggetta ad
esperienze diverse, la struttura del cervello di ognuno sarà plasmata in modi diversi ed unici. Ciò spiega
come mai due gemelli omozigoti, ovvero individui che possiedono lo stesso patrimonio genetico, possano
avere abilità e comportamenti diversi.
Tra i primi a dare una dimostrazione dei fenomeni di plasticità cerebrale vi furono M. Merzenich e colleghi,
dell’università della California a San Francisco. Essi presero in considerazione la rappresentazione della
mano nell’area somatosensoriale della corteccia di aoto (una scimmia notturna che vive in America Latina e
che fa parte della famiglia dei Cebidi) e dimostrarono che tale mappa corticale può essere modificata in
animali adulti in seguito all’amputazione chirurgica di una delle cinque dita della mano. Due mesi dopo
l’amputazione la zona della corteccia, che originariamente rispondeva alla stimolazione di quel dito, veniva
attivata dalla stimolazione delle dita intatte adiacenti. Ciò significava che un’alterazione del normale flusso di
informazioni sensoriali era in grado di indurre dei cambiamenti nella struttura anatomico-fisiologica del
cervello.
Più recentemente è stato dimostrato che il cervello viene modificato non solo quando l’attività sensoriale
afferente viene modificata in virtù di un danno ai recettori sensoriali periferici, ma anche nel corso
dell’apprendimento. T. Elbert e i suoi colleghi dell’università di Costanza in Germania hanno confrontato la
rappresentazione della mano nella corteccia somatosensioriale di violinisti di professione con quella di
soggetti che non avevano alcuna esperienza nel suonare strumenti ad arco. I violinisti usano il pollice della
mano sinistra per sostenere il collo del violino e le altre quattro dita della mano per muovere le corde dello
strumento. Questi compiti richiedono una notevole destrezza manuale e durante la loro esecuzione la
corteccia somatosensoriale controlaterale viene stimolata in continuazione. La mano destra, invece viene
usata per muovere l’arco, un compito molto meno complesso e che induce una stimolazione tattile minore.
Per ottenere le immagini della corteccia Elbert e colleghi hanno utilizzato la magnetoencefalografia (MEG),
una tecnica non invasiva che consente di registrare l’attività del cervello con una notevole risoluzione spaziotemporale. Il risultato è stato che la rappresentazione corticale delle dita della mano sinistra dei musicisti era
notevolmente ingrandita rispetto a quella dei soggetti di controllo, mentre la rappresentazione delle dita della
mano destra non differiva significativamente da quella dei controlli. Inoltre l’ingrandimento del territorio
corticale delle dita della mano sinistra era correlato con l’età alla quale i violinisti avevano cominciato a
suonare, per cui musicisti con un’esperienza di più lunga data avevano una rappresentazione della dita della
mano sinistra più estesa di quelli che suonavano da meno tempo.
Quindi i tessuti nervosi del cervello devono essere pensati come insiemi dinamici che vengono
continuamente modellati dall’esperienza sensoriale e dall’apprendimento. Ciò che deve essere spiegato in
dettaglio sono i meccanismi che stanno alla base di questo fenomeno. Attualmente molti laboratori, tra cui
quello in cui ho lavorato per 4 anni alla SISSA diretto da Mathew Diamond, stanno cercando lavorando per
raggiungere questo scopo. La comprensione dei meccanismi di plasticità potrebbe essere di fondamentale
importanza per mettere a punto terapie mediche che consentano la cura ed il recupero delle funzioni
cerebrali dopo danni del sistema nervoso centrale. Infatti, conoscendo i principi in base ai quali la corteccia
si riorganizza in seguito ad un trauma si potrà indirizzare tale processo in modo da minimizzare le
conseguenze negative del trauma stesso.
CHE FRUTTI PUO' DARE UN’INDAGINE NEUROPSICOLOGICA COMPARATA?
La neuropsicologia è una disciplina che studia il rapporto mente-cervello su una base prettamente
sperimentale, diversamente dai filosofi che adottano il metodo deduttivo. I neuropsicologi si occupano perciò
di quelle funzioni mentali "elevate" e cercano di calarle nella realtà organica del cervello. Naturalmente ciò
implica che il soggetto di studio sia sempre l’essere umano. I metodi che vengono utilizzati in questo tipo di
indagine sono diversi e vanno dall’intervista a soggetti alla visualizzazione dell’attività cerebrale con le
metodiche descritte in precedenza (PET, MRI).
Un esempio molto interessante delle domande a cui cercano di rispondere i neuropsicologi è quello del
"concetto di oggetto" nel bambino e nell’adulto. Ogni adulto ha un’idea precisa di cosa sia un "oggetto" e
delle sue caratteristiche. Noi sappiamo che gli oggetti non possono scomparire nel nulla, che non possono
cambiare arbitrariamente la loro forma e le loro proprietà, che, almeno sulla Terra, non possono rimanere
sospesi nel vuoto senza cadere e così via. Gli adulti, in genere, sanno anche categorizzare gli oggetti. Ad
esempio, quando vediamo un "oggetto" con 4 zampe, che miagola trotterellando allegro tra le nostre gambe
in cerca di cibo, sappiamo che è un gatto e non un’automobile. Ma queste conoscenze sono innate o
derivano dalla nostra esperienza? La risposta, a questo punto, è ovvia: derivano dall'esperienza. Se non
avessimo mai vissuto in questo mondo non potremmo avere alcuna teoria relativa agli oggetti che vi si
trovano. Con tutta probabilità un essere venuto da un altro pianeta sarebbe sorpreso, e magari spaventato,
di come si comportano gli oggetti sulla Terra. Allo stesso modo un bimbo uscito da poco dal grembo materno
(indubbiamente un altro mondo) è inizialmente disorientato o almeno così sembra. Ad esempio,
immaginiamo un esperimento molto semplice nel quale si possano mettere a confronto le abilità dell’adulto
con quelle di un bambino. Ammettiamo che vi sia un oggetto in un punto della stanza, per convenzione in A.
Dopo averlo guardato e averlo preso in mano, qualcun altro, sotto i nostri occhi, lo prende, lo sposta in un
altro punto della stanza (B) e lo copre con un pezzo di stoffa. Dovendolo riprendere, non avremmo
dubbi…basterà, arrivare nel punto B, sollevare il pezzo di stoffa e afferrarlo. Questo sarebbe il
comportamento di un qualunque adulto, ma non quello di un bambino di sette mesi. Questa scoperta risale
alla prima metà del novecento ad opera dello psicologo francese J. Piaget. Lui vide che, a quell'età, il
bambino continuava a cercare l'oggetto in A, anche se aveva visto benissimo che era stato spostato in B.
Perché il bambino si comporta così? Secondo Piaget, questo comportamento apparentemente assurdo si
poteva spiegare supponendo che il "mondo cognitivo" del bambino è diverso da quello dell’adulto. Mentre
l'adulto ha appreso che cosa sono gli oggetti e come "si comportano", il bambino ha ancora una concezione
non completa, quasi magica, dell'oggetto. Nell’idea di Piaget il bimbo ritiene che gli oggetti debbano
rimanere nei luoghi dove sono apparsi e non in quelli dove sono stati nascosti, il suo pensiero potrebbe
essere interpretato come segue: "Se l'oggetto prima era in A, deve per forza trovarsi ancora lì".
Tutto ciò sembrerebbe indicare l’esistenza di una differenza cognitiva fra l’adulto e il bambino, che molti
psicologi hanno spiegato invocando i differenti livelli di esperienza nel mondo di un adulto e un bambino. In
realtà esiste una spiegazione alternativa sostenuta da recenti studi neuropsicologici condotti da Patricia
Goldman-Rakic e Diamond negli USA. Questi studi indicano che la differenza fra l’adulto e il bambino non è
cognitiva, ma per cosi' dire fisica, ovvero che i comportamenti "anomali" del bambino sono da cercare nella
neuropsicologia dello sviluppo e non nella differenza del concetto di oggetto nel bambino e nell'adulto.
Che cosa deve fare una persona per svolgere correttamente il compito? Innanzitutto deve muovere la mano
in A e afferrare l’oggetto. Poi, per riprenderlo dopo che è stato nascosto in B, deve riprogrammare i
movimenti del braccio. Tuttavia, la riprogrammazione di un movimento è costosa, addirittura seccante.
Perciò per riuscire a cambiare la traiettoria, si deve prima inibire la voglia di spostare il braccio esattamente
come si era fatto poc'anzi. La spiegazione del fenomeno è tutta nella parola "inibizione". È stato dimostrato
che per inibire un'azione, un movimento, o anche un'emozione, è necessario che una specifica parte del
cervello, i lobi frontali, siano completamente sviluppati e funzionino correttamente. I bambini non hanno i lobi
frontali particolarmente sviluppati. È dunque possibile che il fallimento nel portare a termine il suddetto
compito sia legato alla sua incapacità ad inibire il movimento programmato precedentemente. Diamond e
Goldman-Rakic hanno dimostrato la validità di quest’ipotesi. Loro hanno notato una dissociazione fra la
direzione dello sguardo del bambino e il movimento del braccio: mentre lo sguardo è puntato correttamente
su B, il braccio si muove in A. In un certo senso "gli occhi sanno, ma le braccia non seguono". Il bambino
non può inibire il movimento, ma sa dove dovrebbe cercare l'oggetto. Allo scopo di capire se fossero proprio
i lobi frontali a giocare il ruolo principale in questo compito, i due scienziati, hanno lesionato i lobi frontali di
scimmie adulte e le hanno sottoposto il compito. Queste scimmie si comportavano esattamente come i
bambini "di Piaget".
Per concludere quella che era stata considerata una delle più importanti scoperte della psicologia cognitiva
dello sviluppo, è stata rianalizzata su una base diversa e ne è stata data un’interpretazione diversa e più
solida utilizzando un approccio di neuropsicologia comparata.