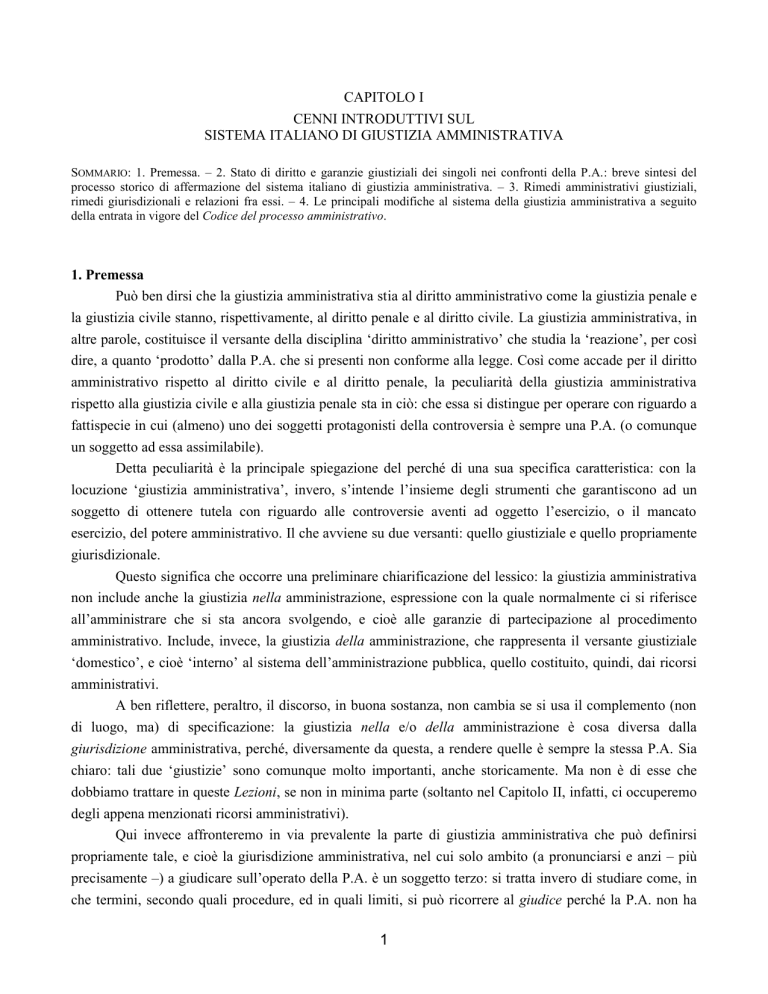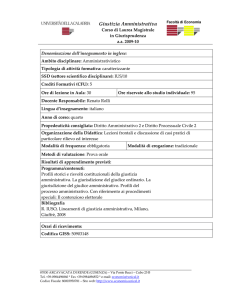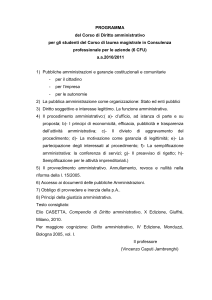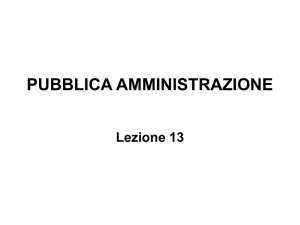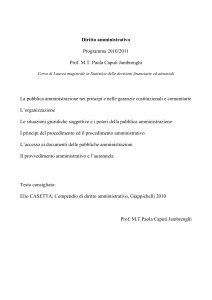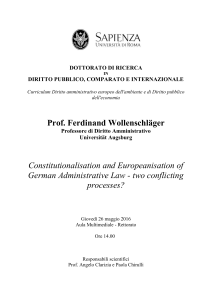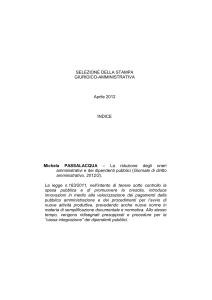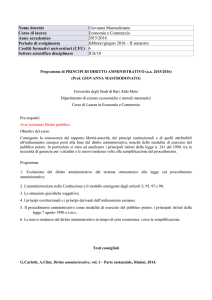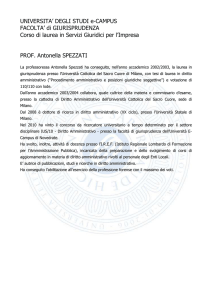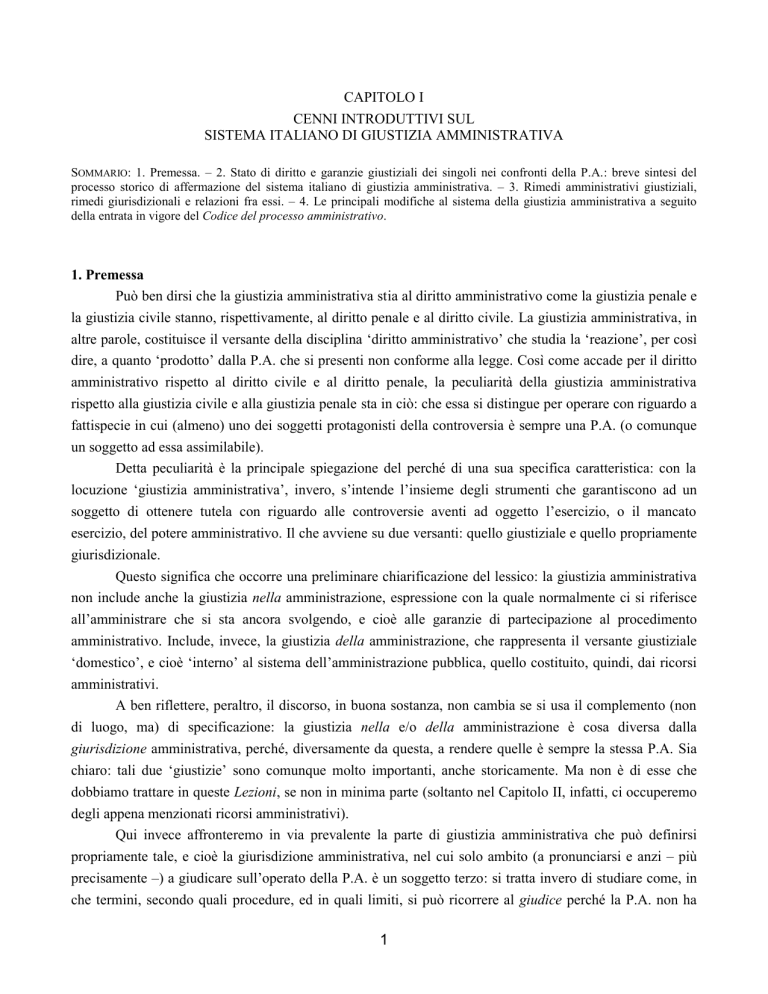
CAPITOLO I
CENNI INTRODUTTIVI SUL
SISTEMA ITALIANO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Stato di diritto e garanzie giustiziali dei singoli nei confronti della P.A.: breve sintesi del
processo storico di affermazione del sistema italiano di giustizia amministrativa. – 3. Rimedi amministrativi giustiziali,
rimedi giurisdizionali e relazioni fra essi. – 4. Le principali modifiche al sistema della giustizia amministrativa a seguito
della entrata in vigore del Codice del processo amministrativo.
1. Premessa
Può ben dirsi che la giustizia amministrativa stia al diritto amministrativo come la giustizia penale e
la giustizia civile stanno, rispettivamente, al diritto penale e al diritto civile. La giustizia amministrativa, in
altre parole, costituisce il versante della disciplina ‘diritto amministrativo’ che studia la ‘reazione’, per così
dire, a quanto ‘prodotto’ dalla P.A. che si presenti non conforme alla legge. Così come accade per il diritto
amministrativo rispetto al diritto civile e al diritto penale, la peculiarità della giustizia amministrativa
rispetto alla giustizia civile e alla giustizia penale sta in ciò: che essa si distingue per operare con riguardo a
fattispecie in cui (almeno) uno dei soggetti protagonisti della controversia è sempre una P.A. (o comunque
un soggetto ad essa assimilabile).
Detta peculiarità è la principale spiegazione del perché di una sua specifica caratteristica: con la
locuzione ‘giustizia amministrativa’, invero, s’intende l’insieme degli strumenti che garantiscono ad un
soggetto di ottenere tutela con riguardo alle controversie aventi ad oggetto l’esercizio, o il mancato
esercizio, del potere amministrativo. Il che avviene su due versanti: quello giustiziale e quello propriamente
giurisdizionale.
Questo significa che occorre una preliminare chiarificazione del lessico: la giustizia amministrativa
non include anche la giustizia nella amministrazione, espressione con la quale normalmente ci si riferisce
all’amministrare che si sta ancora svolgendo, e cioè alle garanzie di partecipazione al procedimento
amministrativo. Include, invece, la giustizia della amministrazione, che rappresenta il versante giustiziale
‘domestico’, e cioè ‘interno’ al sistema dell’amministrazione pubblica, quello costituito, quindi, dai ricorsi
amministrativi.
A ben riflettere, peraltro, il discorso, in buona sostanza, non cambia se si usa il complemento (non
di luogo, ma) di specificazione: la giustizia nella e/o della amministrazione è cosa diversa dalla
giurisdizione amministrativa, perché, diversamente da questa, a rendere quelle è sempre la stessa P.A. Sia
chiaro: tali due ‘giustizie’ sono comunque molto importanti, anche storicamente. Ma non è di esse che
dobbiamo trattare in queste Lezioni, se non in minima parte (soltanto nel Capitolo II, infatti, ci occuperemo
degli appena menzionati ricorsi amministrativi).
Qui invece affronteremo in via prevalente la parte di giustizia amministrativa che può definirsi
propriamente tale, e cioè la giurisdizione amministrativa, nel cui solo ambito (a pronunciarsi e anzi – più
precisamente –) a giudicare sull’operato della P.A. è un soggetto terzo: si tratta invero di studiare come, in
che termini, secondo quali procedure, ed in quali limiti, si può ricorrere al giudice perché la P.A. non ha
1
fatto ‘quel che doveva fare’, sia con i suoi atti, sia con i suoi comportamenti. E – come vedremo – non si
tratta di un solo giudice, perché, seppur per ragioni e con modalità diverse, è possibile adire tanto il giudice
amministrativo, quanto il giudice ordinario.
Dopo aver dato in questo Capitolo i cenni introduttivi sul sistema italiano di giustizia
amministrativa, brevemente descrivendo anche i tratti essenziali della sua evoluzione storica, e dopo aver
illustrato nel Capitolo II i ricorsi amministrativi, quelli cioè che possono esser proposti alla P.A. affinché
riveda il proprio operato, analizzeremo, dapprima, la disciplina costituzionale della giustizia amministrativa
(nel Capitolo III), e poi, a seguire, l’impianto generale della giurisdizione amministrativa (nel Capitolo IV),
il ricorso al giudice amministrativo (nel Capitolo V), il sistema delle impugnazioni (nel Capitolo VI),
l’azione di esecuzione del giudicato, o giudizio di ottemperanza, ed i vari riti speciali (nel Capitolo VII).
Il tutto, naturalmente, alla luce della entrata in vigore del Codice del processo amministrativo,
emanato con il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, per effetto del quale il quadro della giustizia amministrativa in
Italia è sicuramente cambiato in modo significativo, e anzi – occorre avvertire da subito – lo è al punto tale
che le sue esatte dimensioni e fattezze, proprio perché la evoluzione legislativa è ancora assai recente,
possono dirsi tutt’altro che compiutamente definite.
2. Stato di diritto e garanzie giustiziali dei singoli nei confronti della P.A.: breve sintesi del processo
storico di affermazione del sistema italiano di giustizia amministrativa
I tratti essenziali del sistema italiano di giustizia amministrativa trovano, oltre che radice,
spiegazione nelle vicende storiche che hanno portato, nella seconda metà dell’ottocento, alla unificazione
dello Stato.
Prima che l’Italia si unificasse – come è ben noto – sul suo territorio insistevano diversi Stati (che,
proprio per questo, vengono indicati col nome di ‘Stati preunitari’). Della vicenda abbiamo fatto cenno nel
corso di base, in occasione della illustrazione dell’assetto ordinamentale italiano (autonomistico), spiegando
le difficoltà incontrate in Assemblea costituente dai Padri fondatori per decidere la forma del nascente
Stato, dopo la deprecata parentesi del ventennio fascista.
Come abbiamo chiarito in quella sede, il dibattito, che si svolse intensamente, ebbe ad oggetto la
scelta fra gli unici due modelli di Stato conosciuti all’epoca, lo Stato centralizzato e lo Stato federale. I suoi
esiti – lo vedemmo – furono nel senso che, per il nuovo ordinamento statale, si scelse, quale tertium genus
tra le due, la strada dell’ordinamento regionale e delle autonomie locali.
I Padri fondatori – ricordiamolo – si ‘inventarono’ una nuova forma di Stato, un terzo modello rispetto ai due sino
ad allora conosciuti, proprio guardando alla storia che aveva preceduto la unificazione, considerando, cioè, le diversità
antropologico-culturali che connotavano i vari territori del Paese come un dato strutturale imprescindibile ed indefettibile
per la costruzione del nuovo assetto istituzionale: fu così che, accogliendo il pensiero sturziano, si pensò di costruire quel
nuovo modello di Stato che oggi conosciamo.
Tornando al momento precedente, quello della unificazione dell’Italia (che però – lo sappiamo –
non fu il risultato di un processo federativo, sortendo, a dir così, dalla ‘punta delle baionette’ degli uomini
2
che costituivano le ardimentose e temerarie truppe di Giuseppe Garibaldi), si pose il problema di come
amministrare la nuova entità statale, giacché ciascuno Stato preunitario aveva le sue leggi e i suoi modelli
istituzionali: sebbene questi fossero, per molti versi, fra loro similari, si rese comunque necessario
uniformarli.
Allo scopo, cinque anni dopo la conseguita unità, venne emanata la legge di unificazione
amministrativa, Legge 20 marzo 1865, n. 2248, che contiene sei Allegati, ognuno dei quali ha ad oggetto
uno specifico segmento dell’azione amministrativa da ‘uniformare’, dettando le regole con riferimento a
ciascuno di tali segmenti.
Nell’ordine gli Allegati sono i seguenti: «Legge sull’amministrazione comunale e provinciale» (All. A); «Legge
sulla sicurezza pubblica» (All. B); «Legge sulla sanità pubblica» (All. C); «Legge sul Consiglio di Stato» (All. D); «Legge
sul contenzioso amministrativo» (All. E); «Legge sui lavori pubblici» (All. F).
Con riguardo al tema che stiamo cominciando ad affrontare in questa sede, dobbiamo occuparci di
due di quegli Allegati: l’Allegato D, avente ad oggetto la disciplina del Consiglio di Stato, e l’Allegato E,
con il quale furono aboliti i Tribunali speciali «investiti della giurisdizione del contenzioso amministrativo»
(art. 1).
A ben riflettere, però, mentre l’Allegato D ha subìto talmente tante modificazioni, che oggi può
considerarsi in realtà quasi un documento storico, quello che in effetti ci interessa di più è l’Allegato E,
giacché, diversamente dall’altro, presenta ancora, dopo ormai quasi un secolo e mezzo, significative
ricadute sull’ordinamento vigente, soprattutto per effetto della sua successiva modifica, intercorsa, dopo
poco meno di cinque lustri, con la Legge 31 marzo 1889, n. 5992, che istituì la IV Sezione – la prima
giurisdizionale – del Consiglio di Stato.
Anche se dobbiamo precisare, con le parole di A. TRAVI, 2012, p. 31, che «La legge del 1889 si presentava
formalmente come legge di modifica dell’allegato D legge n. 2248/1865». La legge – ricorda F.G. SCOCA, La formazione
del sistema, in F.G. SCOCA (a cura di), 2011, Parte 1, La genesi del sistema delle tutele nei confronti della pubblica
amministrazione, pp. 3 ss., 9 – fu «coordinata con l’All. D alla legge del 1865 nel testo unico approvato con r.d. 2 giugno
1889, n. 6166».
Con l’Allegato E – dicevamo – furono aboliti i Tribunali del contenzioso amministrativo, i quali
costituivano l’assetto giurisdizionale degli Stati preunitari, occupandosi delle controversie avverso la P.A., e
dunque, appunto, della giustizia amministrativa; e furono «devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le
cause per contravvenzioni e tutte le materie» in relazione alle quali si facesse «questione di un diritto civile
o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorché siano emanati
provvedimenti del potere esecutivo o dell’Autorità amministrativa» (art. 2).
L’abolizione del contenzioso amministrativo aveva nelle intenzioni un obiettivo che, considerato
guardando alla essenza del suo significato, non può che essere condivisibile: siccome i giudici dei Tribunali
del contenzioso avevano un rapporto assai stretto, un vero e proprio legame istituzionale, con il potere
amministrativo, si voleva far sì che tutto il contenzioso con la P.A. venisse effettivamente, e sul serio,
deciso dall’unico vero giudice in allora esistente, il giudice ordinario. L’idea era, in poche parole, la
3
seguente: abolire i Tribunali così che ogni questione del contenzioso con la P.A. dovesse necessariamente
finire sotto la giurisdizione del giudice ordinario.
Come spiega A.M. SANDULLI, 1989, p. 1192, «La legge italiana del 1865 fu dunque ispirata (almeno nelle
dichiarazioni dei suoi fautori) dall’intento di veder realizzato in pieno il principio della sottoposizione della pubblica
Amministrazione al diritto, mediante la devoluzione ai tribunali ordinari delle sue controversie coi soggetti particolari,
relative a qualsiasi tipo di diritto soggettivo. Essa abolì i tribunali ordinari del contenzioso amministrativo (a. 1) – lasciando
tuttavia in vigore (anche per ciò che atteneva ai diritti di cui esse si occupavano) le giurisdizioni amministrative speciali,
quali a es. quella della Corte dei conti e quella del Consiglio di Stato in sede di giurisdizione atipica (a. 12) –, attribuì ai
tribunali dell’ordine giudiziario (con potere di dichiarare illegittimi, ed eventualmente di disapplicare, ma non di annullare,
gli atti amministrativi: aa. 4-5) “tutte le cause per contravvenzione e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un
diritto civile o politico” (a. 2), e lasciò che le autorità amministrative conoscessero invece esse stesse degli altri “affari” (a.
3), e cioè delle questioni non attinenti a diritti, ma ad interessi di minor rilievo giuridico. La risoluzione dei conflitti di
attribuzione tra organi giurisdizionali e amministrativi venne devoluta (anche perché non esisteva allora un’unica Corte di
cassazione) al Consiglio di Stato (a. 10 n. 1 dell’all. D alla legge del 1865)».
Sennonché, ben presto, quasi subito, ci si accorse che la ‘operazione’ non aveva sortito l’effetto
sperato, con essa trascurandosi il fatto che non tutte le questioni insorgenti con la P.A. (avevano ed) hanno
la consistenza di un diritto soggettivo, così finendosi per sottrarre alcune ‘materie’ – quelle, appunto, non
concernenti diritti soggettivi – ad una giustizia che, sia pur insufficiente, perché ‘graziosa’ e legata agli
‘umori’ del sovrano, almeno ne aveva le sembianze; senza, peraltro, che su tali materie potesse avere
giurisdizione il giudice ordinario: quelle materie, insomma, con l’abolizione dei Tribunali del contenzioso
amministrativo, erano state private di un qualsiasi giudice, in modo da renderle quasi una sorta di territorio
franco.
Come chiarisce A. TRAVI, 2012, p. 25, «Il sistema delineato nell’allegato E della legge n. 2248/1865 avrebbe
potuto assicurare, in astratto, una efficace tutela del cittadino nei confronti dell’Amministrazione. Sarebbe stato necessario,
però, attuare in modo adeguato l’art. 3 della legge, sulla tutela del cittadino nel procedimento amministrativo e attraverso i
ricorsi gerarchici. Invece la norma sulla partecipazione nel procedimento non venne applicata, perché fu intesa come una
disposizione programmatica e non immediatamente precettiva, e l’istituto dei ricorsi gerarchici risultò screditato dalla
tendenza dell’Amministrazione a non assumere decisioni imparziali e a lasciarsi condizionare dai suoi particolari interessi.
Inoltre sarebbe stata necessaria un’interpretazione della legge in grado di assicurare al giudice ordinario tutti gli spazi di
tutela che precedentemente erano stati riconosciuti ai tribunali del contenzioso amministrativo. Invece, nell’interpretazione
degli artt. 2 e 3 della legge, prevalse una linea restrittiva, alla quale lo stesso giudice ordinario in sostanza si adeguò, perché
era sulla stessa linea della concezione precedente circa i rapporti fra giudice ordinario e Amministrazione. L’interpretazione
sulla portata degli artt. 2 e 3 era rimessa, in ultima istanza, al Consiglio di Stato, al quale spettava decidere, come giudice
dei conflitti, se una vertenza fosse di competenza dell’autorità giurisdizionale (ordinaria) o fosse invece riservata
all’Amministrazione». Anche A.M. SANDULLI, 1989, pp. 1192-1193, osserva che il sistema della L. 2248, «se diede
disciplina unitaria alle controversie relative ai diritti soggettivi, rivelò ben presto i suoi inconvenienti (che, del resto, non
aveva mancato di evidenziare in Parlamento la minoranza in occasione delle discussioni sulla legge del 1865): tra l’altro
esso lasciava in piena balìa dell’Amministrazione tutte le questioni relative a interessi non protetti come diritti (si tenga anzi
presente che la giurisprudenza del tempo – per la quale assai larga era l’area degli “atti di pura amministrazione” – fu
piuttosto restrittiva nell’ammettere, nei rapporti di diritto pubblico, l’esistenza di diritti); inconveniente aggravato dal fatto
che il sistema devolveva a un organo inserito nella pubblica Amministrazione (il Consiglio di Stato) – subordinando perciò
a esso i Tribunali – quella delicatissima funzione che è la decisione dei conflitti di attribuzione tra giudici e
Amministrazione».
Le ‘materie’ (in senso lato) di cui stiamo parlando possono dirsi definitorie dell’area che oggi
conosciamo come quella propria dell’interesse legittimo: questa situazione giuridica soggettiva finiva così
4
per avere nessuna possibilità di tutela giurisdizionale. Fu per questo che venne istituita la IV Sezione del
Consiglio di Stato, dopo circa un quarto di secolo, durante il quale si era svolto un intenso dibattito sulla
difficoltà di accettare il sistema per come si era venuto a creare per effetto dell’abolizione dei Tribunali del
contenzioso amministrativo.
E infatti, poco oltre, A. TRAVI, 2012, p. 30, precisa che «Gli “interessi” dei cittadini lesi da atti della Pubblica
amministrazione dovevano essere tutelati con strumenti più efficaci dei ricorsi gerarchici: la garanzia di tali interessi era
perciò demandata a una autorità specifica, con un prestigio paragonabile a quello del giudice civile, ma dotata di un potere
di annullamento e perciò non inquadrata nell’ordine giurisdizionale».
Il Consiglio di Stato – come è noto – era preesistente nelle sue prime tre Sezioni (risalenti al 1831);
diversamente dalla terza, che ha di recente assunto funzione giurisdizionale, le prime due hanno conservato
a tutt’oggi la loro competenza originaria, quella consultiva (esprimono ancora il parere obbligatorio in sede
di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica), una competenza che era (ed è) tale da far definire
l’organo, non infondatamente, quale ‘consigliere del Principe’: il Consiglio di Stato costituiva infatti
l’apparato di consulenza giuridica del Sovrano.
In realtà, è recentissima – e nemmeno ancora del tutto pienamente affermata – la convinzione che il
giudice amministrativo sia un vero e proprio giudice. Fino a pochi anni fa, invero, sussistevano non poche
perplessità (che tuttora, almeno parzialmente, permangono), dovute alla circostanza che questi era
considerato come soggetto del tutto omogeneo al Governo, se non proprio una sua parte integrante, visto
che, non solo, sotto il profilo strutturale, i suoi componenti sono formalmente parte dell’apparato
amministrativo e non di quello giurisdizionale, ma anche che molti degli appartenenti al corpo vengono
tuttora di fatto posti alla guida (delle Segreterie, dei Gabinetti, in una:) degli apparati burocratici dei
Ministeri, e quindi non nelle migliori condizioni per svolgere il ruolo di giudice terzo e imparziale nei
confronti dell’operato della P.A.
Inoltre (e fra l’altro), la legge a tutt’oggi non esclude la possibilità per i Consiglieri di Stato, e in
genere per i giudici amministrativi, di partecipare agli organismi collegiali costitutivi di Autorità
indipendenti, nonché di presiederli, di guidare agenzie ministeriali, e così via; senza trascurare quella
(purtroppo largamente praticata) di ‘onorare’ incarichi extragiudiziali (collaudi, consulenze, arbitrati, ecc.)
conferiti dalle PP.AA. in costanza di esercizio del mandato giurisdizionale.
Rimane il fatto, però, – non discutibile – che alle decisioni assunte dalla IV Sezione del Consiglio di
Stato il carattere giurisdizionale è stato esplicitamente riconosciuto sin dalla Legge 7 marzo 1907, n. 62.
Legge che, appunto, – come ricorda A. TRAVI, 2012, p. 35 – «riconobbe formalmente il carattere giurisdizionale
della Quarta sezione (art. 1), introducendo la distinzione fra sezioni “consultive” del Consiglio di Stato (= le prime tre) e
sezioni “giurisdizionali”, e conseguentemente contemplò espressamente la possibilità del ricorso alla Corte di cassazione
“agli effetti della legge 31 marzo 1877, n. 3761” contro le decisioni delle sezioni giurisdizionali (art. 6). Inoltre istituì la
Quinta sezione del Consiglio di Stato, con funzioni giurisdizionali, alla quale erano demandati i ricorsi con sindacato esteso
al merito, mentre alla Quarta sezione erano riservati i ricorsi nei casi generali in cui il sindacato era limitato alla legittimità.
Il coordinamento fra le due sezioni era affidato alle Sezioni riunite (oggi, Adunanza plenaria), composte dai componenti di
entrambe le sezioni».
5
Le perplessità in parola, del resto, sono confermate dal fatto che nel nostro sistema ordinamentale –
come vedremo – persiste un’anomalia di non poco momento: che, proprio per effetto della menzionata
diversa collocazione strutturale dei due apparati giurisdizionali, non v’è un unico Consiglio Superiore della
Magistratura, per i giudici amministrativi esistendo uno specifico organo di autogoverno, il Consiglio di
Giustizia Amministrativa.
Questa differenza può senz’altro ascriversi anche alla diversità di formazione culturale tra giudice
ordinario e giudice amministrativo, tra Corte di Cassazione e Consiglio di Stato. Tale diversità (lo
riprenderemo durante il corso), in poche parole, può sintetizzarsi in ciò: che, nonostante i limiti cui abbiamo
appena fatto cenno, derivanti dalla sua stretta vicinanza al potere, il Consiglio di Stato – ed il giudice
amministrativo in genere –, seppur non senza qualche ipocrisia, ha sempre ragionato (e ragiona) tenendo
presente un paradigma del quale il giudice ordinario fa molta fatica (per un limite, appunto, di formazione
culturale) a tener conto. Questo paradigma è l’interesse pubblico, quel famoso ‘convitato di pietra’ nel
nome del quale – secondo M.S. Giannini – si sono compiuti (e si compiono) i più grandi misfatti, e che però
costituisce il fine di ogni discorso che siamo tenuti a fare quando parliamo della P.A. e della sua azione,
attorno ad esso ruotando tutto l’operato di questa.
Potremmo dire sinteticamente – e per ciò con tutti i limiti di cui soffre anche la sintesi migliore –
che il giudice civile ha, di regola, una forma mentis alla quale sfugge l’idea del bene comune, perché
considera questa come il ‘territorio’ proprio ed esclusivo della scelta legislativa alla quale egli ha il dovere
di attenersi scrupolosamente; la logica che guida il suo operare, insomma, può così riassumersi: che, data la
norma, egli semplicemente la applica – riconoscendo ragione a Tizio o a Caio che stanno questionando fra
loro dinanzi a lui – in relazione ad una fattispecie concreta che trova in quella norma (di relazione) la sua
disciplina giuridica.
Tuttavia – come abbiamo chiarito (nel corso ‘di base’ ed in quello ‘specialistico’) –, quando è
coinvolta l’azione di una P.A., nella gran parte dei casi non si tratta di iuris dicere sul rapporto tra due
soggetti giuridici (uno dei quali potendo essere anche una P.A., che, sotto questo profilo, è a tutti gli altri
assimilabile), ma di stabilire se sia legittimo il ‘dove’ (nel rapporto fra P.A. e frontista e nei confronti
dell’insieme dei consociati) il provvedimento amministrativo impugnato abbia collocato l’interesse
pubblico, e quindi il ‘come’ lo abbia determinato in concreto. Ciò significa che il giudice deve verificare la
legittimità del ragionamento sul bene comune svolto dalla P.A., e cioè, detto altrimenti, capire come (in
ciascuna singola fattispecie della realtà sottoposta alla sua delibazione) sia stato conseguito l’interesse
pubblico specifico fissato in astratto dalla norma (di azione), o ancora – più chiaramente – come è stata
determinata in concreto la dimensione di questo, così generandosi le conseguenti ricadute sulle situazioni
giuridiche soggettive coinvolte dall’esercizio del potere amministrativo.
Al procedimento amministrativo, invero, partecipano Tizio, Caio, Sempronio e tutti coloro che abbiano interesse
nella determinata vicenda amministrativa; alla fine, però, l’interesse pubblico dovrà essere realizzato in concreto dalla P.A.
secondo la logica pubblicistica, e cioè seguendo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, e non per
soddisfare la pretesa di Tizio, Caio, Sempronio e quanti altri vi abbiano interesse, anche se poi la singolare, specifica, scelta
di esercizio del potere determinerà un effetto (favorevole o pregiudizievole, ai presenti fini poco importa) sulle situazioni
giuridiche di tutti costoro.
6
Il passaggio argomentativo può risultare di non semplice comprensione, e perciò merita una ulteriore
precisazione. Non v’è dubbio che la persistente ragion d’essere della giurisdizione amministrativa risieda nella
sua ‘specialità’. Il giudice amministrativo, infatti – che, ormai definitivamente, non può più essere confuso
con l’«ultimo amministratore» (come è stato fatto notare da autorevole dottrina: fra gli altri, A. ORSI
BATTAGLINI e C. MARZUOLI, Unità e pluralità della giurisdizione: un altro secolo di giudice speciale per
l'amministrazione?, in Dir. pubb., 1997, n. 3, pp. 895 ss.; e A. TRAVI, Per l’unità della giurisdizione, ivi,
1998, n. 2, pp. 371 ss.) –, conserva la sua specialità, perché non può in alcun modo sottovalutarsi la particolare
sensibilità richiesta per svolgere il sindacato sull’azione amministrativa.
Abbiamo poc’anzi riferito del definitivo riconoscimento della natura giurisdizionale dell’attività del giudice
amministrativo. È noto, peraltro, che tale attività nel Consiglio di Stato è affiancata da quella espressione della funzione
consultiva; ma è noto altresì che fra le due sussiste una netta distinzione. Con riguardo a detta distinzione va precisato, per un
verso, che non infondatamente la ‘commistione’ fra attività consultiva e giurisdizionale suscita perplessità in ragione
dell’argomento secondo cui mai è opportuno che il ‘consigliere del Principe’ amministri anche la giustizia sugli atti di questo
(come sostiene D. SORACE, La riforma del diritto costituzionale delle amministrazioni pubbliche, in Dir. pubb., 1997, pp. 775
ss., 795, «appare sempre meno accettabile [...] che l’apparato che svolge funzioni consultive nei confronti di
un’amministrazione ne sia anche il giudice»); per altro verso, però, che – restando nel sistema attuale le Sezioni consultive e
giurisdizionali del Consiglio di Stato funzionalmente separate – la distinzione in parola può esser letta come capace di
contribuire a rafforzare l’idea della giustizia amministrativa quale vera e propria giustizia (giacché attraverso la giurisdizione
amministrativa comunque si sindaca la legittimità di atti che disciplinano rapporti fra due soggetti diversi, la P.A. ed i privati),
e non quale mera «giustizia nell’amministrazione», e, quindi, l’idea del giudice amministrativo come vero e proprio giudice, e
non come «giudice-amministratore» (le espressioni tra virgolette sono di D. SORACE, La riforma cit., p. 796). Piuttosto – lo
abbiamo già evidenziato –, sembra inevitabile sciogliere il nodo delle incompatibilità (arbitrati, incarichi professionali e
soprattutto ministeriali): ma questo è problema che affligge l’intero ordine giudiziario.
Naturalmente, si potrebbe anche convenire sulla ipotesi – emersa a più riprese – di prevedere un unico
giudice nel seno della cui organizzazione contemplare sezioni specializzate per le controversie concernenti
l’amministrazione pubblica. Quand’anche, però, così fosse, resterebbe ineludibile la necessità di un giudice
dotato di particolari conoscenze, indispensabili per intelligere sino in fondo l’azione della P.A. al fine di
esercitare sui relativi atti un sindacato pienamente consapevole, che solo il patrimonio di esperienza
accumulato in ben oltre un secolo di giurisprudenza amministrativa appare in grado di garantire. Le fattispecie
sulle quali questo giudice deve svolgere il suo sindacato, infatti, presentano peculiari caratteristiche, quelle
specifiche dell’azione amministrativa: esse, cioè, hanno ad oggetto la determinazione in concreto
dell’interesse pubblico, il che rende impossibile (verrebbe di dire, ontologicamente) utilizzare lo schema
logico-giuridico normalmente adoperato dal giudice civile.
Prendendo in prestito le parole di D. SORACE, La riforma cit., p. 796, si direbbe «giudici non più particolarmente
legati all’amministrazione ma soltanto particolarmente esperti di quest’ultima».
In altre parole, potrebbe anche addivenirsi alla conclusione di un giudice unico, ma a patto che la
diversità del parametro legislativo su cui iuris dicere non sia lo stesso laddove si tratti di giudicare
sull’interesse pubblico. Non perché si vogliano conservare speciali privilegi alla P.A., né dunque perché il
giudice amministrativo debba amministrare, bensì perché giudicare sulla legittimità dell’esercizio del potere,
7
che è funzionalizzato a realizzare l’interesse pubblico, non può esser considerato uguale a giudicare sulla
liceità dell’esercizio di autonomia privata (negoziale e non).
Essendo tale ultima affermazione facilmente equivocabile, è bene precisare che sostenerla non equivale a ritenere che
sia il criterio di riparto fra giurisdizione amministrativa ed ordinaria, fondato sulla situazione soggettiva lesa, a richiedere la
specializzazione del giudice amministrativo, perché anzi ciò, non solo non pare proprio più sostenibile, ma è smentito dal
continuo espandersi dei casi di giurisdizione esclusiva. Anche laddove fosse investito di una giurisdizione ‘per materia’, però, il
giudice mai potrebbe adottare lo stesso schema logico-giuridico quando si tratti di sindacare la legittimità dell’esercizio di un
potere amministrativo – e dunque di render giustizia della eventuale lesione di un interesse legittimo (ossia di una situazione
soggettiva inautonoma, giacché comunque configurabile soltanto in relazione all’esercizio di un potere) –, e quando si tratti di
sanzionare la lesione di un diritto soggettivo, la cui definizione è esaurita dalla previsione normativa.
In definitiva, affinché si possa giudicare della legittimità della pretesa del singolo a conseguire un
bene della vita che non gli è riconosciuto direttamente dalla norma giuridica (che perciò si configura come
‘di azione’), dovendosi passare per il tramite della intermediazione del potere amministrativo, è necessario
‘possedere’ la cultura di siffatta intermediazione, cultura che di solito sfugge alla tipica ‘concettuologia’ del
giudice ordinario.
Viceversa, il giudice amministrativo, proprio per essere da sempre molto vicino al potere (e
nonostante i rischi che ciò indiscutibilmente comporti), possiede per tradizione la cultura dell’interesse
pubblico. Certo non va trascurato – lo abbiamo appena ricordato – che l’interesse pubblico può essere usato
come una sorta di ‘grimaldello legale’ per soddisfare interessi privati (come ammoniva Giannini). Ma
questo è soltanto il profilo patologico della cura dell’interesse pubblico. In via fisiologica, invero,
l’impianto concettuale dell’interesse pubblico, e dunque la concezione della intermediazione del potere
amministrativo al fine di vedersi garantite le situazioni giuridiche soggettive (o, se si vuole, le aspirazioni
sostanziali ad un bene della vita non riconosciuto già dalla norma giuridica come facente capo al soggetto),
resta quello che meglio risponde allo scopo.
Ad una più attenta e meditata riflessione, del resto, ben diverso risulta l’impianto concettuale che sorregge lo iuris
dicere del giudice civile: diversamente dalla norma di azione, infatti – che intrinsecamente presenta un’applicazione di non
sempre facile comprensione –, la norma di relazione si applica con relativa semplicità.
D’altronde, della peculiare sensibilità del giudice amministrativo è prova, in qualche modo, il ruolo
che, nel corso del secolo passato, e soprattutto nella sua prima metà, ha svolto il sindacato che esso ha
esercitato sugli atti della P.A., sindacato che è diventato, poco alla volta, talmente penetrante da consentire
il controllo sull’azione amministrativa anche in assenza di una legge generale di codificazione del
procedimento (intervenuta – come sappiamo – solamente nel 1990) capace di offrire un chiaro parametro
giuridico di riferimento.
È stata la giurisprudenza amministrativa, in buona sostanza, a definire ciò che la P.A. potesse o non
potesse fare per restare entro i confini della legalità, perché l’agire in un certo modo avrebbe potuto
costituire il sintomo di un eccesso di potere, e cioè di un vizio di legittimità dell’atto amministrativo
impugnato. Un’opera siffatta è stata compiuta, lentamente ma inesorabilmente, proprio da quel Consiglio di
Stato che veniva (e ancora viene) guardato con sospetto (anche da parte dei giudici ordinari), la
8
giurisprudenza del quale, tuttavia, ha indubbiamente contribuito in maniera decisiva a ‘creare’ il diritto
amministrativo su due cardini: quello dello Stato di diritto e del principio di legalità, da un lato, e quello
della poc’anzi richiamata ‘concettuologia’ dell’interesse pubblico, dall’altro.
Come magistralmente spiega M. NIGRO, 1976, pp. 23-24: «Nessuno nega il profondo valore liberale degli istituti di
giustizia amministrativa, ma esso non esaurisce il senso di tali istituti: v’è alla base di questi anche una forte componente
autoritativa e, entro certi limiti, si può dire addirittura illiberale […]. Questo profilo non può venir trascurato. Per rendersi
conto di esso, occorre considerare che gli istituti di giustizia amministrativa non sono (o sono solo apparentemente) il frutto
di un disegno razionale, ma sono il prodotto di un ambiente politico e giuridico di cui l’ideologia e le realizzazioni dello
stato di diritto costituiscono un aspetto, mentre l’altro aspetto, non sempre valorizzato, sono l’ideologia e le strutture del c.d.
stato amministrativo. Per questo verso, gli istituti di giustizia amministrativa si presentano come l’integrazione e il
perfezionamento dello stato amministrativo e ubbidiscono all’ideologia propria di questo tipo di stato. Cosicché possiamo
vederli come figli dello stato di diritto, ma dello stato di diritto in quanto anche stato amministrativo; ciò è tanto vero che
laddove vi è stato di diritto, ma non stato amministrativo, come nei paesi anglosassoni, non si trova traccia d’istituti di
giustizia amministrativa fino a quando anche in quei paesi non compaiono elementi propri del c.d. stato amministrativo
[…]. Lo stato amministrativo è lo stato in cui alla p.a. è fatto uno “statuto speciale” attributivo di poteri d’imperio, capaci di
incidere unilateralmente e coattivamente nella sfera giuridica dei cittadini. Detto in sintesi, gli istituti di giustizia
amministrativa perfezionano lo stato amministrativo perché completano lo statuto “speciale” della p.a.: la p.a., oltre che un
diritto “proprio” (cioè ad essa particolare), ha un giudice “proprio” o, più in generale, è termine di mezzi di tutela “propri”
(cioè, diversi da quelli cui sono assoggettati gli altri soggetti giuridici o, quanto meno, se i mezzi di tutela sono gli stessi,
caratterizzati da modalità diverse)».
Quel sospetto, peraltro, oggi può ben dirsi avere sempre meno ragion d’essere, giacché nessuno può
più negare che anche quello amministrativo sia un vero e proprio giudice; e questo nonostante esso non sia
radicato nel medesimo apparato del giudice ordinario (che fa capo al C.S.M.), e cioè nell’apparato del cd.
‘terzo potere’, il potere giurisdizionale.
La Costituzione, del resto – sul disegno della quale in tema di tutela giurisdizionale nei confronti
della P.A. torneremo nel Capitolo III –, riconosce entrambi. E la stessa Legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
nell’istituire i Tribunali Amministrativi Regionali, ha confermato la scelta dei Padri fondatori. La nascita
dei T.A.R., invero, ha di fatto (quasi del tutto) ‘omogeneizzato’ il modello processuale del giudizio
ordinario e del giudizio amministrativo; da allora anche nella giustizia amministrativa abbiamo, oltre al
primo, un secondo grado: il Consiglio di Stato, che (nella pressoché totalità dei casi, salvo quelli in cui è
«giudice dell’ottemperanza» in unico grado, giusta la disciplina di cui all’art. 113 C.P.A.) è ormai giudice di
appello (appello che è caratterizzato dal cd. ‘effetto devolutivo’, riproponendosi in secondo grado tutto ciò
che è ‘venuto fuori’ nel corso della vicenda processuale in primo grado). E nel processo di appello – lo
vedremo – il giudice rivisita il merito della decisione del tribunale di primo grado (comunque sussistendo
poi la possibilità di andare anche in Cassazione – sebbene solo per difetti relativi alla giurisdizione –,
oppure di proporre ricorso per revocazione – nei casi previsti dagli artt. 395 e 396 c.p.c. –, e senza
dimenticare l’altro possibile mezzo di gravame: l’opposizione di terzo).
L’equivoco di fondo, che fu alla base della legge abolitrice del contenzioso amministrativo, e che
tuttora riaffiora quando si discute della sopravvivenza del giudice amministrativo, sta nel fatto che si
considera – ad avviso di chi scrive, erroneamente – che lo Stato di diritto si fondi sulla sua stretta
connessione con l’esistenza di un solo giudice, quello ordinario, giacché quello amministrativo non vanta la
necessaria indipendenza nel giudicare su questioni che involgono l’azione della P.A., essendo di questa,
9
bene o male, una parte integrante: ma ciò ormai, almeno per gran parte, non è più.
E comunque, se pur ancora in parte lo sia, il problema non si risolve certo eliminando il giudice
amministrativo, quello ordinario non mostrandosi in grado – per quanto abbiamo riferito – di assolvere
adeguatamente il compito di ragionare sulla legittimità dell’azione amministrativa in relazione al parametro
dell’interesse pubblico. Occorre, piuttosto, legiferare in modo che il giudice amministrativo venga
definitivamente affrancato dalla opacità dei legami – non sempre trasparenti, a onor del vero – con il potere
politico.
Sembrano, insomma, tuttora ampiamente condivisibili le considerazioni di M. NIGRO, 1976, pp. 26-28, secondo il
quale «La connessione fra stato amministrativo di diritto e giustizia amministrativa […] è, sinteticamente esposta, la
seguente. Il principio organizzativo della separazione dei poteri, che è uno dei dommi del costituzionalismo borghese, non
opera solo nel senso di distaccare il potere legislativo dal potere esecutivo e amministrativo, ma opera simultaneamente nel
senso di distaccare quest’ultimo dal primo e di conferirgli una posizione autonoma: l’autonomia dell’amministrazione è la
faccia rovescia della supremazia della legge. Con ciò, la essenzialità dell’amministrazione e le ragioni della sua autonomia
sono pienamente riaffermate, ma questo non è che il primo passo nella strada che c’interessa. La chiave di volta del sistema
politico-giuridico in cui s’inseriscono gli istituti della giustizia amministrativa è rappresentata da un modo d’intendere i
rapporti fra stato (o apparato di governo e d’amministrazione) e società (i cittadini; la societas civium) – modo tipico (ma
non esclusivo) della concezione liberale – secondo il quale il primo si presenta come nettamente distinto dalla seconda e
consistente in un’entità obiettiva ed astratta, funzionalizzata all’interesse generale, titolare di poteri propri di supremazia,
esercitati attraverso espressioni giuridicamente formalizzate, mediante le quali (e mediante le quali soltanto) l’azione dello
stato entra in contatto e in rapporto con la società. Queste due espressioni sono la legge e l’atto amministrativo. Non si
comprendono le ragioni della giustizia amministrativa se non si colgono il significato e il rapporto di questi due atti nella
complessiva azione dell’amministrazione. La legge è il fondamento e la misura dell’azione amministrativa (principio di
legalità), ma […] il principio di legalità ha, oltre e prima che la funzione individualista che oggi gli prestiamo (la funzione
di preservare dall’arbitrio statale le libertà e le aspettative dei cittadini), anche e soprattutto un’obiettiva funzione ordinativa,
la funzione di limitare e incanalare l’attività dello stato nell’interesse dello stato medesimo; e l’amministrazione si pone
anch’essa come interprete ed attuatrice – subordinata, ma essenziale – dell’interesse generale e obiettivo».
Per completare i brevi cenni di introduzione storica, occorre ricordare le tre principali (e quindi
particolarmente significative) tappe successive alla L. 62/1907, naturalmente oltre quella, già menzionata,
costituita dalla L. 1034/1971, istitutiva dei T.A.R.: a) il R.D. 30 dicembre 1923, n. 2840, al quale seguì il
Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, (che dunque fu
emanato solo sei mesi dopo); b) la Costituzione repubblicana, entrata in vigore il 1 gennaio 1948; e, da
ultimo, c) il Codice del processo amministrativo, approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (in base alla
delega conferita con la Legge 18 giugno 2009, n. 69) – che, per certi versi, dà seguito al D.Lgs. 31 marzo
1998, n. 80, ed alla Legge 21 luglio 2000, n. 205 –, il quale ha dato definitiva (si fa per dire) sistemazione
ad una serie di novità normative (anche derivanti dal diritto della U.E.), che, peraltro, avevano sollecitato
l’intervento della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato, il percorso così segnato meritando
certamente d’esser definito come non poco tormentato.
Quanto al R.D. 2840/1923, dobbiamo ricordare che con esso si realizzarono due innovazioni
determinanti per il futuro della giustizia amministrativa italiana, in relazione al riparto di giurisdizione fra
giudice ordinario e giudice amministrativo. Per un verso, venne consentito al giudice amministrativo di
decidere, in via incidentale, sulle questioni concernenti diritti soggettivi implicate nella soluzione delle
controversie di sua competenza, sempre che dette questioni non avessero ad oggetto lo stato e la capacità
delle persone. Per altro verso, in alcune materie venne introdotta la sua giurisdizione esclusiva, con il che si
10
provò a porre rimedio (fra l’altro) alle difficoltà di individuazione del giudice competente (fra quello
ordinario e quello amministrativo), essendo in quelle materie obiettivamente difficile riconoscere la
consistenza della causa petendi fra diritti soggettivi ed interessi legittimi.
Come spiega A. TRAVI, 2012, p. 37, «al giudice amministrativo, nei giudizi di sua competenza, fu riconosciuta
espressamente la capacità di conoscere ‘in via incidentale’ le posizioni di diritto soggettivo, fatta eccezione per le questioni
riguardanti lo stato e la capacità delle persone e la querela di falso, che furono riservate sempre al giudice ordinario».
Inoltre, «in alcune materie particolari elencate dalla legge, fra le quali il pubblico impiego, al giudice amministrativo fu
attribuita la possibilità di conoscere e di giudicare ‘in via principale’ anche in tema di diritti soggettivi. In queste materie,
pertanto, la tutela giurisdizionale non era articolata fra tutela degli interessi legittimi (demandata al giudice amministrativo)
e tutela dei diritti soggettivi (demandata al giudice ordinario), ma era devoluta interamente al giudice amministrativo (c.d.
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo)».
Quanto alla Costituzione repubblicana – anticipando quel che vedremo in modo più approfondito
nel Capitolo III –, possiamo dire che prevalentemente essa si limitò a ‘costituzionalizzare’ gran parte dei
principi consolidatisi fino ad allora, sia nella produzione legislativa, sia nella elaborazione
giurisprudenziale. In linea di massima, dunque, la Carta sembra aver preso atto, facendolo proprio, del
sistema della giustizia amministrativa per come si era venuto progressivamente formando sin dal momento
della unificazione.
Non sembra perfettamente coincidente l’opinione di A. TRAVI, 2012, p. 40, il quale osserva che «La Costituzione
repubblicana avrebbe potuto avviare una riflessione a tutto campo sull’attualità e sulla compatibilità di molte soluzioni
accolte precedentemente per la tutela giurisdizionale del cittadino nei confronti dell’Amministrazione. Enunciava principi
nuovi sulla funzione giurisdizionale in generale e sulla tutela nei confronti dell’Amministrazione in particolare. Invece, con
rare eccezioni, l’incidenza delle norme costituzionali rispetto alla giustizia amministrativa fu colta solo in un secondo
tempo, e forse neppure in modo completo».
Quanto, infine, al Codice del processo amministrativo, va per ora semplicemente ricordato – lo
riprenderemo fra breve, meno genericamente, nel par. 4 – che esso costituisce, in qualche modo, l’epilogo
di una stagione (sostanzialmente il decennio dal 1998 al 2009) caratterizzata da un impulso riformatore che
può ben definirsi frenetico e, per ciò, poco ordinato.
Ed infatti l’inizio della stagione in parola si può fondatamente datare al D.Lgs. 80/1998 (recante
«Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche,
di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa», emanato in attuazione
dell’art. 11, co. 4, L. 15 marzo 1997, n. 59, conferente la relativa delega), con il quale si ampliò
considerevolmente l’ambito materiale della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Dopo la sentenza della Corte costituzionale (n. 292/2000) che dichiarò illegittimo il decreto per
eccesso di delega, fu emanata la L. 205/2000 (recante «Disposizioni in materia di giustizia
amministrativa»), con l’intento di superare il vizio stigmatizzato dalla Consulta. Ciò nondimeno, questa,
sollecitata nuovamente, ebbe modo di esprimersi (con la sent. 204/2004), per un verso, giudicando
illegittime le previsioni della L. 205/2000 concernenti l’estensione della giurisdizione esclusiva ad intere
materie – o, se si preferisce la espressione che la Corte adopera nella pronuncia, a «blocchi di materie» –
(per intendersi: le materie dei servizi pubblici o della edilizia ed urbanistica intese nella loro interezza); e,
11
per altro verso, chiarendo che nemmeno è materia autonoma (per la quale il Legislatore possa disporre una
giurisdizione esclusiva) quella costituita dalle controversie concernenti il risarcimento dei danni derivanti
dalla lesione di interessi legittimi (la quale invece, secondo alcuni, pur sarebbe configurabile come tale).
La Corte, in effetti, nella sent. 204/2004 si chiese se la tutela risarcitoria rappresentasse una ‘materia’ autonoma da
devolvere alla giurisdizione esclusiva del G.A., concludendo che «il potere riconosciuto al giudice amministrativo di
disporre, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto non costituisce sotto alcun
profilo una nuova “materia” attribuita alla sua giurisdizione, bensì uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello
classico demolitorio (e/o conformativo), da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica
amministrazione», uno strumento, perciò, disponibile in ogni materia, e non solo in quelle devolute alla giurisdizione
esclusiva.
Dal canto suo – come è noto – la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la celebre sentenza
22/7/1999, n. 500, aveva affermato la risarcibilità dei danni causati dalla lesione degli interessi legittimi
pretensivi, con ciò aprendo un annoso conflitto giurisprudenziale con il Consiglio di Stato, avente ad
oggetto, fra l’altro, la questione della cd. ‘pregiudizialità amministrativa’ (e cioè della indispensabile previa
sentenza di annullamento dell’atto amministrativo illegittimo per potersi chiedere il risarcimento dei danni
relativi).
La complessità (per non voler dire: la confusione) generata da questo ‘frenetico disordine’
istituzionale ha finito per rendere – verrebbe quasi di dire: naturalmente – necessario partorire un testo
normativo ‘sistematizzante’, il Codice del processo amministrativo appunto.
Come spiega A. TRAVI, 2012, p. 45, «In seguito a questi interventi legislativi, più o meno articolati, ma sempre
settoriali e spesso incoerenti, si impose con maggiore forza l’esigenza di una disciplina organica del processo
amministrativo. A tal fine il Parlamento conferì una delega al Governo con la legge 18 giugno 2009, n. 69 (art. 44).
Avvalendosi di una facoltà concessagli dalla legge, il Governo affidò la redazione del testo del decreto legislativo al
Consiglio di Stato, anche se poi, in sede di approvazione, non mancò di introdurre modifiche anche sostanziali. La delega fu
esercitata con il d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Col decreto legislativo furono approvati quattro allegati: il primo è il “codice
del processo amministrativo”, il secondo contiene le norme d’attuazione al codice, il terzo le norme transitorie e il quarto
le norme di coordinamento e le abrogazioni. In questo modo è stato introdotto per la prima volta nel nostro Paese un
‘codice’ del processo amministrativo: anche il processo amministrativo è regolato da una normativa unitaria e più puntuale
ed aggiornata».
3. Rimedi amministrativi giustiziali, rimedi giurisdizionali e relazioni fra essi
Dal sintetico excursus storico appena compiuto ricaviamo che il sistema italiano di giustizia
amministrativa, in poche parole, consta di tre, per così dire, ‘sotto-sistemi’: quello che fa capo alla stessa
P.A., cui possono proporsi ricorsi amministrativi, attraverso i quali chiedere (per eventualmente ottenere)
anche una rivisitazione del merito della scelta contenuta nel provvedimento; quello che fa capo al giudice
ordinario, cui sempre (salvo i casi di giurisdizione esclusiva del G.A.) ci si deve rivolgere per la tutela dei
diritti soggettivi; e quello che fa capo al giudice amministrativo, cui ci si deve rivolgere (prevalentemente,
salvo i casi – anche qui – di giurisdizione esclusiva e di quelli di cui all’art. 30 del C.P.A., avente ad oggetto
l’azione di condanna) per la tutela degli interessi legittimi.
Nel Corso ci occuperemo essenzialmente del primo e del terzo sotto-sistema, il secondo essendo per
12
lo più oggetto di studio del diritto processuale civile. Mentre, dunque, non tratteremo del giudice ordinario
ex professo, ma solo nei limiti in cui ciò si renderà, di volta in volta, necessario per meglio comprendere i
confini dell’ambito di giurisdizione del giudice amministrativo (sovente delineati, in negativo, dalla
sussistenza della competenza assegnata dall’ordinamento, caso per caso, alla giurisdizione del giudice
ordinario), affronteremo (peraltro solo) brevemente (nel Capitolo II) la disciplina dei ricorsi amministrativi,
concentrando l’attenzione maggiore sul ‘sotto-sistema’ del sistema italiano di giustizia amministrativa che
si realizza dinnanzi al giudice amministrativo.
In questa sede introduttiva – fatto salvo quanto approfondiremo nei Capitoli seguenti – mette conto
di chiarire, in via generalissima, da un lato, le ragioni della sopravvivenza, accanto a quelli giurisdizionali,
di rimedi amministrativi giustiziali; e, dall’altro, il rapporto che intercorre fra gli uni e gli altri.
I ricorsi amministrativi, i quali costituiscono la ‘prima’, a dir così, e più elementare forma di
giustizia amministrativa (giacché siffatta giustizia si svolge nel seno stesso della P.A., e dunque in buona
sostanza si traduce comunque in una sorta di riesercizio del potere), hanno la loro origine nello Stato
assoluto, rappresentando in questo l’unica forma di giustizia amministrativa concessa ‘graziosamente’ dal
sovrano. L’avvento dello Stato di diritto, radicato – come è noto – sul principio di separazione dei poteri,
ovviamente implicando per ciò lo sviluppo delle garanzie giurisdizionali, ha reso progressivamente
marginale il ruolo della giustizia ‘domestica’, quanto meno per le questioni concernenti la legittimità
dell’azione amministrativa, legittimità la cui tutela è garantita più correttamente (secondo la logica della
separazione dei poteri propria dello Stato di diritto), e meglio, da parte di un giudice (e segnatamente, in
Italia, quello amministrativo).
Ciò nondimeno, il rimedio amministrativo giustiziale – che, del resto, fino al 1971 ha mantenuto la
connotazione di presupposto per la esperibilità del ricorso giurisdizionale – ha conservato, e tuttora
conserva, piena vigenza nel nostro ordinamento, sebbene ad esso (nelle specie del ricorso gerarchico e del
ricorso in opposizione), proprio per quanto appena ricordato, debba riconoscersi la prevalente (se non
addirittura esclusiva) rilevanza funzionale di consentire al soggetto che si ritenga leso da un atto
amministrativo di ottenere, almeno da parte della stessa P.A., la rivisitazione del merito della scelta di
contenuto dell’atto medesimo.
Come spiega A.M. SANDULLI, 1989, p. 1204, «La figura del ricorso amministrativo è tramandata dallo Stato
assoluto. In questo infatti i sudditi non potevano ottenere altrimenti giustizia nei confronti dei pubblici poteri se non dalla
grazia del principe o sulla base delle disposizioni da lui impartite ai funzionari operanti in nome e per conto di lui. Una volta
introdotte poi, nel nostro paese, con l’affermarsi dello Stato di diritto, le garanzie giurisdizionali – culminate dapprima nella
legge del 1865 abolitiva dei tribunali del contenzioso amministrativo e poi nella legge del 1889 istitutiva della giurisdizione
del Consiglio di Stato per le controversie in materia di interessi legittimi, e portate da ultimo alla massima espansione dagli
aa. 24 e 113 della vigente Costituzione –, gli strumenti amministrativi in discorso vennero nondimeno conservati (e altri ne
vennero aggiunti), ma con un ruolo (non più principale, bensì ausiliario e) ridotto. Il quale, quando la previa proposizione
dei ricorsi amministrativi venga dall’ordinamento configurata come un onere da osservare necessariamente per potere adire
in un secondo tempo le vie giurisdizionali (tali erano fino a epoca recente – e sono in taluni casi eccezionalmente rimaste –
le previsioni legislative), si è rivelato, nella nuova realtà, per la parte prevalente, e specialmente per ciò che riguarda i casi di
controversie conseguenti a un comportamento amministrativo illegittimo, più di intralcio che di sollievo per la protezione
giuridica dei cittadini».
Con ciò abbiamo chiarito le ragioni della perdurante sussistenza nell’ordinamento dei ricorsi
13
amministrativi: esse si rinvengono essenzialmente, appunto, nella possibilità – non riconosciuta presso
alcun ordine giurisdizionale – di ottenere la rivisitazione del merito della scelta amministrativa, la
valutazione del quale è preclusa (giusta il più volte richiamato principio di separazione dei poteri) alla
cognizione del giudice, anche di quello amministrativo, cui spetta (lo vedremo nei parr. 3 del Capitolo III e
6 del Capitolo IV) una giurisdizione di merito solo nei pochi casi tassativamente previsti dalla legge.
Quanto al rapporto fra rimedi amministrativi giustiziali e rimedi giurisdizionali, dobbiamo sin d’ora
ricordare che occorre distinguere, nell’ambito dei primi, fra ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica e ricorsi ordinari. Mentre la relazione tra il ricorso straordinario ed il ricorso giurisdizionale è
regolata dal principio di alternatività, in virtù del quale, una volta proposto ricorso giurisdizionale, non è
possibile esperire quello straordinario, e viceversa (sebbene, in questo secondo caso, sia possibile ‘imporre’
la sua trasposizione innanzi al giudice amministrativo); con riferimento ai ricorsi amministrativi ordinari,
invece, la relazione fra essi ed il ricorso giurisdizionale si dice regolata dal principio di prevalenza.
La possibilità della trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario merita una notazione a margine.
Invero, non è pacifico se essa spetti soltanto ai «controinteressati» – come dispone l’art. 10, co. 1, D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199 (recante «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi»), tuttora in vigore –, ovvero
anche alla P.A. convenuta – come ebbe a dichiarare la Corte costituzionale (sent. 148/1982), seppur limitatamente all’«ente
pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l’atto impugnato con ricorso straordinario» –, e come sembra stabilire l’art. 48
C.P.A., che, per definire il soggetto titolare della capacità di trasposizione, adopera l’espressione «la parte nei cui confronti
sia stato proposto ricorso straordinario», in luogo di quella usata nel D.P.R. 1199/1971. La soluzione della questione,
evidentemente, richiede di scegliere in sede ermeneutica se considerare prevalente il criterio della lex specialis (e non v’è
dubbio che, per la materia dei ricorsi amministrativi, sia tale la regolazione legislativa del 1971, e non quella più recente del
C.P.A.), ovvero della lex posterior. Sul punto dobbiamo necessariamente rinviare al par. 8 del successivo Capitolo II.
Sul punto, però, la prudenza è d’obbligo, e il perché risulterà più chiaro dopo le spiegazioni rese nel
par. 6 del Capitolo II: in sintesi, mentre prima della entrata in vigore della L. 1034/1971, per proporre
ricorso giurisdizionale era necessario che l’atto impugnato avesse acquisito il carattere della ‘definitività’,
conseguibile col previo esperimento del ricorso amministrativo ordinario e con la relativa decisione, a far
data da quella legge questo non è più necessario. Ciò fa sì che oggi i due rimedi non sono più posti in
relazione fra loro come l’uno indispensabile presupposto dell’altro; e tuttavia il loro contemporaneo
esperimento comporta, di regola, la sopravvivenza del solo ricorso giurisdizionale, e quindi la sua
prevalenza su quello amministrativo.
Commentando la situazione precedente alla legge del 1971, A. TRAVI, 2012, pp. 32-33, osserva che «nel quadro
della riforma del 1889 […] risultava poco chiara la collocazione del ricorso gerarchico, che non era circoscritto ad alcuno
soltanto dei tre ambiti citati [diritti soggettivi al G.O., interessi legittimi al G.A., e una parte di attività amministrativa
riservata alla giustizia per mano della sola P.A.]: la legge del 1889 introduceva però un rapporto preciso fra il ricorso alla
Quarta sezione e il ricorso gerarchico (art. 7), perché il ricorso alla Quarta sezione era ammesso solo contro un
provvedimento “definitivo”, ossia contro un provvedimento per il quale fossero stati esperiti tutti i gradi della tutela
gerarchica».
Vedremo, però, che – proprio in considerazione di quanto abbiamo poc’anzi riferito circa le ragioni
della perdurante sussistenza dei rimedi amministrativi giustiziali – appare tutt’altro che peregrino sostenere
14
la possibile ‘vita’ parallela dei due rimedi in parola, sempre che, naturalmente, i vizi per i quali essi
vengano esperiti siano, rispettivamente, solo di legittimità (con il ricorso giurisdizionale), e solo di merito
(con il ricorso amministrativo).
4. Le principali modifiche al sistema della giustizia amministrativa a seguito della entrata in vigore
del Codice del processo amministrativo
L’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo (d’ora in poi C.P.A.), contenuto
nell’Allegato 1 al D.Lgs. 104/2010 – emanato in attuazione della delega conferita al Governo dall’art. 44, L.
69/2009 (recante, appunto, «Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo
amministrativo»), «per il riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di
Stato, al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni
superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi
generali e di assicurare la concentrazione delle tutele» (co. 1) –, ha comportato l’abrogazione, pressoché
integrale, delle norme previgenti disciplinanti il processo amministrativo (a farlo è l’Allegato 4 al D.Lgs.
104/2010).
La legge di delega consentiva al Governo di avvalersi dell’opera del Consiglio di Stato per la
redazione del testo, ed il Governo si è avvalso di questa facoltà. Il testo, tuttavia, in sede di approvazione in
Parlamento ha subìto notevoli modificazioni. Ciò spiega, forse, almeno in parte, perché siano state
approvate le prime (con il D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195) e le seconde (con il D.Lgs. 14 settembre 2012,
n. 160) «disposizioni correttive ed integrative», l’introduzione delle quali era stata, prudentemente e senza
(la, di recente, purtroppo consueta) ‘miopia istituzionale’, prevista come possibile dalla legge di delega
medesima (art. 44, co. 4), laddove, entro due anni dalla entrata in vigore del C.P.A., «l’applicazione
pratica» della nuova disciplina le avesse rese «necessarie od opportune».
Come osserva F.G. SCOCA, L’evoluzione del sistema, in F.G. SCOCA (a cura di), 2011, Parte 1, La genesi del
sistema delle tutele nei confronti della pubblica amministrazione, pp. 17 ss., 35, «Tra i principi e i criteri direttivi per
l’esercizio della delega spicca il seguente: disciplinare le azioni e le funzioni del giudice: 1. riordinando le norme vigenti
sulla giurisdizione del giudice amministrativo, anche rispetto alle altre giurisdizioni; 2. riordinando i casi di giurisdizione
estesa al merito, anche mediante soppressione delle fattispecie non più coerenti con l’ordinamento vigente; 3. disciplinando,
ed eventualmente riducendo, i termini di decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei provvedimenti
del giudice; 4. prevedendo le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte
vittoriosa (Art. 44, comma 2, lett. b), legge n. 69/2009). Soprattutto quest’ultimo criterio appare importante, perché consente
di raggiungere la pienezza della tutela nei confronti dell’amministrazione. […] è opportuno segnalare l’importanza del
nuovo testo legislativo, che finalmente, dopo circa 120 anni, reca una disciplina organica del processo amministrativo,
estesa anche a risolvere i problemi di giurisdizione e ad attuare nel modo pieno i principi costituzionali del giusto processo.
Non si tratta di una disciplina pienamente soddisfacente, né pienamente rispondente ai criteri di delega: rimangono alcuni
tratti non condivisibili, ma, in ordine ad essa, complessivamente valutata, si può a ragione parlare di raggiungimento di un
testo di portata storica». Non dissimile è l’opinione di A. TRAVI, 2012, pp. 45-46: «Nel complesso la nuova normativa
appare in stretta correlazione con le disposizioni e gli orientamenti giurisprudenziali pregressi e sembra perciò accogliere
soprattutto esigenze di continuità con l’assetto precedente. Il codice ha introdotto, però, anche numerose innovazioni
sostanziali, non solo per rendere più razionale la disciplina (per esempio, semplificando l’assetto dei riti speciali), ma anche
per ragioni più generali, come la garanzia del contraddittorio».
15
In generale ed oggettivamente – e dunque a prescindere dai rilievi critici, che pur il C.P.A., come
era fatale, ha generato, e che verranno in seguito richiamati e analizzati in riferimento ai singoli aspetti per i
quali sono stati sollevati –, possiamo dire che i principali profili di innovazione del sistema di giustizia
amministrativa introdotti dalla riforma del 2010 sono ricavabili dal dato normativo espresso nella finalità
della delega e nei criteri direttivi per il suo esercizio.
Se gli obiettivi siano stati o meno efficacemente conseguiti (e quali siano i problemi ancora
irrisolti), quindi, lo vedremo di volta in volta. Quel che è certo, però, è che con il C.P.A. si è provveduto a
dare un novellato assetto al processo amministrativo di primo e secondo grado, puntando a: a) recepire
entro il corpo normativo gli indirizzi derivanti, per un verso, dal diritto della U.E., e, per un altro, dalla più
recente giurisprudenza, sia della Corte costituzionale, sia delle «giurisdizioni superiori»; b) realizzare il
coordinamento delle sue disposizioni con quelle del c.p.c.; nonché c) garantire il conseguimento di un
risultato di indiscutibile ‘civiltà giuridica’, e cioè «la concentrazione delle tutele» (art. 44, co. 1, L.
69/2009).
I tre richiamati obiettivi sono stati perseguiti dando seguito ai «principi e criteri direttivi» stabiliti
dall’art. 44, co. 2, dei quali è importante dar conto in maniera pressoché integrale.
In primo luogo, si è operato per «assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela»,
così da «garantire la ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure informatiche e
telematiche, nonché la razionalizzazione dei termini processuali, l’estensione delle funzioni istruttorie
esercitate in forma monocratica e l’individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione
dell’arretrato» (lett. a).
In secondo luogo, si è provveduto a disciplinare «le azioni e le funzioni del giudice» attraverso: 1) il
riordino delle «norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo, anche rispetto alle altre
giurisdizioni»; 2) il riordino dei «casi di giurisdizione estesa al merito, anche mediante soppressione delle
fattispecie non più coerenti con l’ordinamento vigente»; 3) la eventuale riduzione dei «termini di decadenza
o prescrizione delle azioni esperibili» e la definizione della «tipologia dei provvedimenti del giudice»; 4) la
previsione di «pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte
vittoriosa» (lett. b).
In terzo luogo, sono stati rivisti e razionalizzati i «riti speciali» e le «materie cui essi si applicano»
(lett. c); ed inoltre, sono state razionalizzate ed unificate le «norme vigenti per il processo amministrativo
sul contenzioso elettorale», dimezzandone i termini ed introducendosi «la giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le
elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», nonché «la previsione di
un rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili
con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni»
(lett. d).
È stata poi razionalizzata ed unificata anche «la disciplina della riassunzione del processo e dei
relativi termini», che ciò sia conseguenza tanto «di sentenze di altri ordini giurisdizionali», quanto «di
sentenze dei tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato che dichiarano l’incompetenza
16
funzionale» (lett. e).
Ancora: sono stati riordinati, da un lato, «la tutela cautelare, anche generalizzando quella ante
causam», e, dall’altro, «il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per
cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato» (lett. f).
Con riguardo alla tutela cautelare, la riforma ha stabilito in particolare che: «1) la domanda di tutela interinale non
può essere trattata fino a quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito; 2) in
caso di istanza cautelare ante causam, il ricorso introduttivo del giudizio è notificato e depositato, unitamente alla relativa
istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito, entro i termini di decadenza previsti dalla legge o, in difetto di
essi, nei sessanta giorni dalla istanza cautelare, perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela interinale; 3) nel caso di
accoglimento della domanda cautelare, l’istanza di fissazione di udienza non può essere revocata e l’udienza di merito è
celebrata entro il termine di un anno».
Si è infine provveduto al riordino del «sistema delle impugnazioni», da un lato «individuando le
disposizioni applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado», e, dall’altro, «disciplinando
la concentrazione delle impugnazioni, l’effetto devolutivo dell’appello, la proposizione di nuove domande,
prove ed eccezioni» (lett. g).
Al di là delle criticità sulle quali torneremo, si può, in via preliminare e generale, convenire col
giudizio negativo sulla idoneità della riforma a risolvere di per sé il conclamato problema della lentezza
della resa di giustizia amministrativa. La sua soluzione, invero, dipende – come del resto accade per
qualunque riforma (è demagogico parlare di riforme ‘a costo zero’) – dalla carenza di risorse finanziarie da
destinare allo scopo di migliorare il funzionamento dell’apparato organizzativo della giurisdizione
amministrativa, carenza vieppiù acuita dalla attuale, gravissima, crisi economica globale.
In proposito, A. TRAVI, 2012, p. 47, osserva: «All’origine della crisi vi è una carenza di risorse che purtroppo si
perpetua nel tempo e che accomuna oggi la giurisdizione amministrativa e la giurisdizione ordinaria. La risposta a questi
problemi non può essere data neppure dall’aggravamento degli oneri fiscali (si tratta essenzialmente del pagamento del c.d.
contributo unificato) che la parte deve affrontare quando presenta un ricorso: l’accesso alla giustizia non dovrebbe mai
essere scoraggiato da misure del genere. In altri Paesi, per affrontare evenienze analoghe e più in generale per evitare al
cittadino di dover affrontare i costi e i tempi di un giudizio, anche per le vertenze con l’amministrazione sono stati
valorizzati i mezzi alternativi di soluzione delle controversie (c.d. ADR – acronimo dell’espressione inglese ‘Alternative
Dispute Resolution’). Si tratta di strumenti non giurisdizionali, diversi però dai tradizionali ricorsi amministrativi: infatti non
seguono la logica dell’autotutela amministrativa che invece ha condizionato soprattutto i ricorsi gerarchici. I mezzi
alternativi dovrebbero prevedere l’intervento di un soggetto qualificato, ma comunque terzo rispetto alle parti in causa; a
tale soggetto possono essere assegnate funzioni decisorie, ma anche (e particolarmente) di mediazione e di conciliazione».
L’A., peraltro, avverte subito dopo (p. 48) che «L’introduzione di modelli del genere appare più problematica negli ambiti
devoluti alla giurisdizione amministrativa, specie quando siano in discussione interessi legittimi».
17