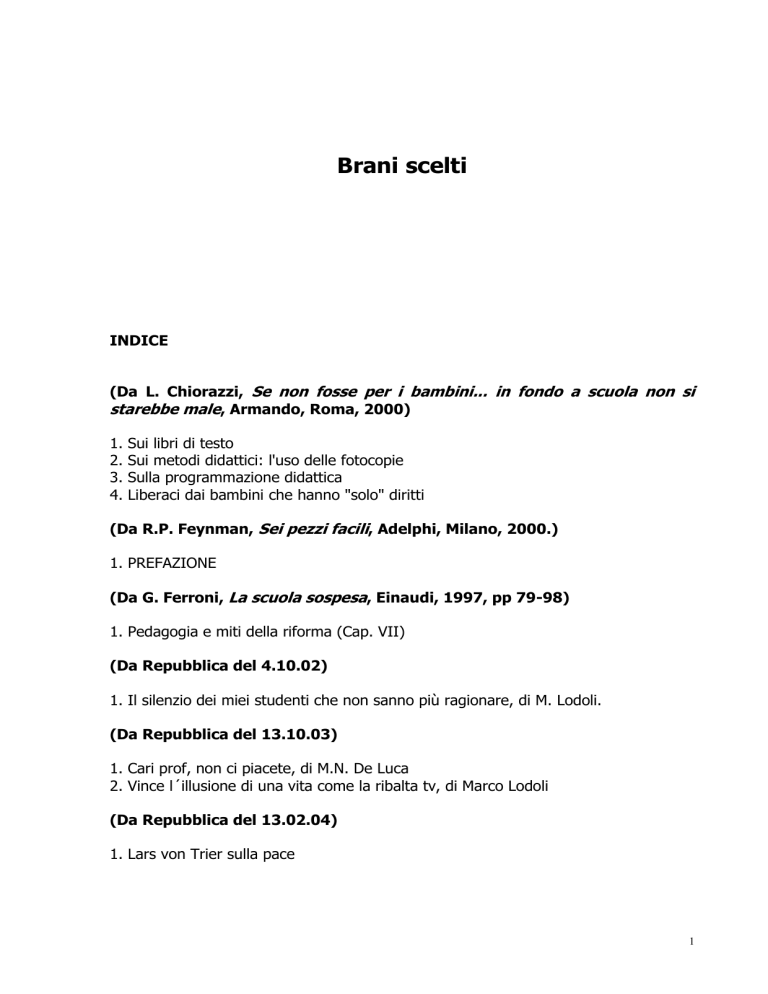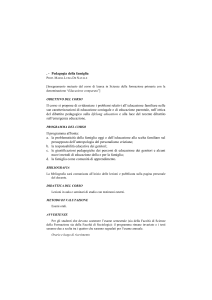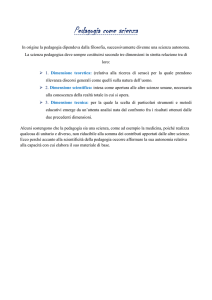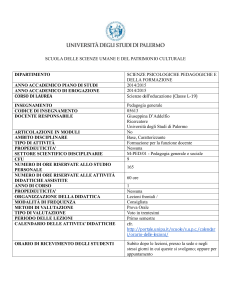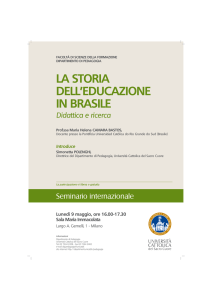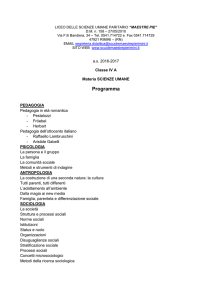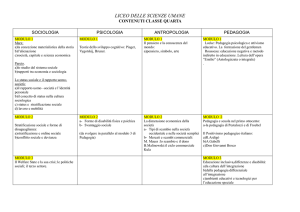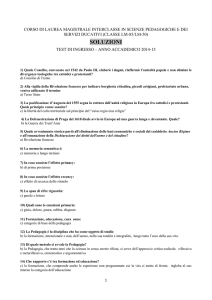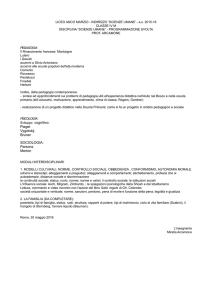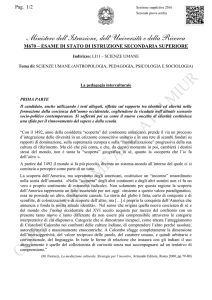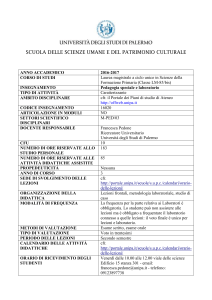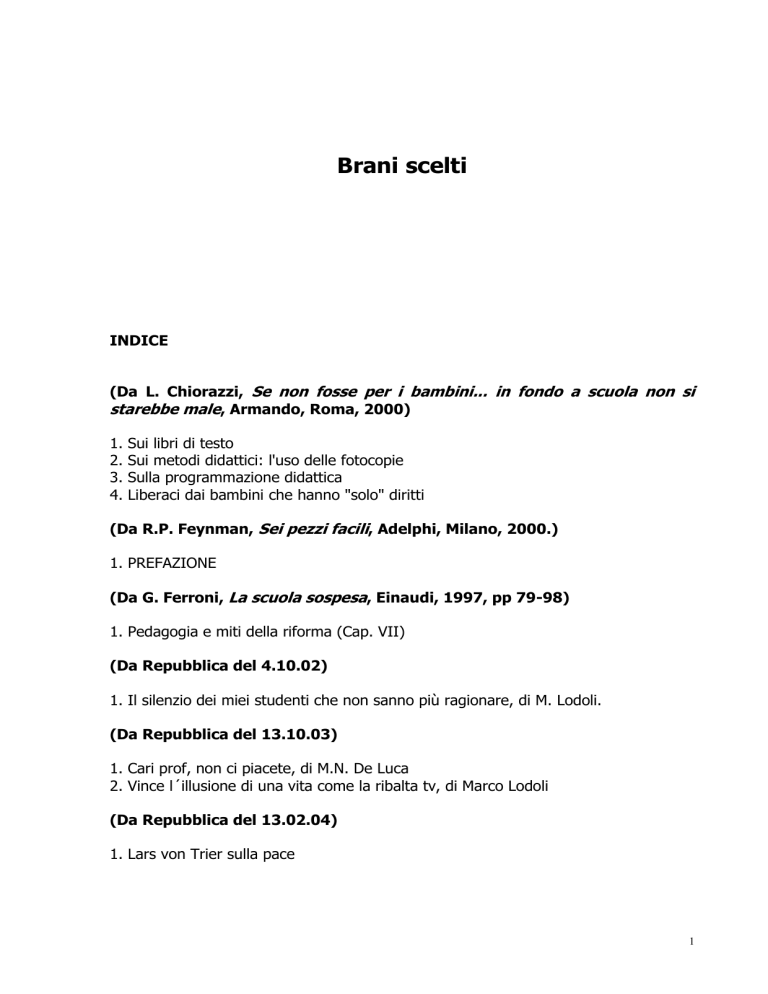
Brani scelti
INDICE
(Da L. Chiorazzi, Se non fosse per i bambini... in fondo a scuola non si
starebbe male, Armando, Roma, 2000)
1.
2.
3.
4.
Sui libri di testo
Sui metodi didattici: l'uso delle fotocopie
Sulla programmazione didattica
Liberaci dai bambini che hanno "solo" diritti
(Da R.P. Feynman, Sei pezzi facili, Adelphi, Milano, 2000.)
1. PREFAZIONE
(Da G. Ferroni, La scuola sospesa, Einaudi, 1997, pp 79-98)
1. Pedagogia e miti della riforma (Cap. VII)
(Da Repubblica del 4.10.02)
1. Il silenzio dei miei studenti che non sanno più ragionare, di M. Lodoli.
(Da Repubblica del 13.10.03)
1. Cari prof, non ci piacete, di M.N. De Luca
2. Vince l´illusione di una vita come la ribalta tv, di Marco Lodoli
(Da Repubblica del 13.02.04)
1. Lars von Trier sulla pace
1
Sui libri di testo
(Da L. Chiorazzi, Se non fosse per i bambini... in fondo a scuola non si
starebbe male, Armando, Roma, 2001, pp. 74-6)
Ma anche oggi. nel famoso "Duemila", la scuola è rimasta biecamente e
anacronisticamente ferma al "libro di lettura", che nella stessa sua definizione si pone
presuntuosamente come "l'oggetto" che detiene l'esclusiva e il segreto primordiale
della lettura. E invece è la negazione della lettura come piacere, incredibilmente
infarcito, com'è il più delle volte, oltre che di un incredibile eccesso di schede di
lavoro che fanno l'autopsia ad ogni rigo letto, anche di brani di una banalità
stomachevole, che oscillano dagli stereotipi più piatti fino alla pubblicità occulta e che
instillano nelle giovani menti la noia e non la gioia della lettura, insieme all'ideologia
del Nulla, non meno pericolosa dell'ideologia fascista che sprizzava da ogni pagina
dei loro predecessori del Ventennio.
Che fine hanno fatto oggi i grandi autori, i grandi capolavori dell'umanità?
Nei libri di testo e nelle bibliotechine di classe imperversano orrende banalità e
insipida "letteratura per l'infanzia".
I Grandi sono superati? E da chi? Ma non si diceva una volta che i grandi
autori, quelli classici, parlano sempre all'animo umano, non importa se bambino o
adulto, in tutte le epoche? O i Grandi in fondo erano piccoli, oppure è appannato
"l'animo umano".
Nel famoso "Duemila" la scuola è rimasta ripiegata sui penosi "sussidiari".
"Sussidiario" forse vuol dire che sorregge, che aiuta.
Ma in cosa ci può ormai aiutare un penoso guazzabuglio di nozioni
arraffazzonate, sorpassate nella forma e nella sostanza, imprecise, insufficienti,
inadatte e addirittura dannose se le fai passare così come sono. Ci occorrono
sempre, immancabilmente, diversi sussidiari del sussidiario che chiariscano,
approfondiscano, illustrino, spieghino in termini modernamente comprensibili al
ragazzo di oggi la Storia, la Geografia, la Scienza e la Matematica.
[...] Siccome mi sono convinto da tempo che uno vale altro, che sono tutti
uguali, tutti brutti e tutti inutili, e dal momento che sono comunque costretto dalla
legge a scegliere, ormai ho preso l'abitudine di firmare una relazione qualsiasi di un
qualsiasi gruppo di colleghe. E sa come si fa la relazione scritta sulla "scelta oculata''
effettuata? Ricopiando inevitabilmente una qualsiasi relazione di un qualsiasi
precedente anno di un qualsiasi libro.
Manco a dirlo, si adatta alla perfezione al "libro nuovo" dell'anno prossimo.
E sa quali sono le "ultime tendenze"? Gli stessi autori dei libri, sapendo bene
quanto noi maestri odiamo ormai le relazioni scritte, si premurano di farci trovare
nelle loro opere delle relazioni prestampate su tutti gli aspetti su cui noi dovremmo
scervellarci. Sperano così che. trovando la relazione già scritta, sia più facile che la
nostra scelta cada sul loro libro, perché ci fa risparmiare un sacco di tempo e di
energia. E sperano bene, perché noi facciamo proprio così.
In questo modo la direttrice è contenta di sentire belle parole in quei disperati
quanto inutili Collegi dei "Dolenti", noi siamo contenti di aver fatto presto, e gli autori
e gli editori sono contenti perché il Ministero butta i soldi sui loro libri grazie alla
nostra scelta.
2
Sui metodi didattici: l'uso delle fotocopie
(Da L. Chiorazzi, Se non fosse per i bambini... in fondo a scuola non si
starebbe male, Armando, Roma, 2001, p. 83)
Senza pretendere, naturalmente, di fare di tutte le erbe un fascio, sono
costretto a dire che. copia e copias. le didattiche "pocket" preconfezionate dalle
guide e dalle riviste la fanno da padroni. Quale grande e fine "professionalità" mi
occorre per scegliere a destra e a manca le schede giuste da fotocopiare a seconda
degli argomenti previsti dalla programmazione (anch'essa precotta) e poi
"somministrarle" (come si usa dire) agli alunni, e poi contare le risposte "esatte" e
dare un voto? Se è solo questo, lo potrebbe fare anche il bidello o. al massimo, un
ragioniere. Tant'è vero che. pagati dal Comune, ho visto che. per alcuni progetti di
educazione ambientale, vengono a fare lezione e ricerca in classe anche gli impiegati
delle Poste, appassionati escursionisti e ambientalisti. e spesso la fanno meglio di
come l'avremmo fatto noi maestri. perché hanno passione per l'argomento (ciò che
spesso manca a noi).
Le fotocopie di tutto e del contrario di tutto impazzano e le fotocopiatrici.
super ubriache di Toner, danno i numeri e si bloccano per protesta due volte alla
settimana.
E quando si blocca la fotocopiatrice tutti noi maestri andiamo in tilt come
accadde alla città di New York durante il famoso black out di alcuni anni fa.
Posso dirlo senza esitazioni perché lo vedo ogni giorno: in classe, cioè nella
trincea quotidiana, sono le fotocopie la vera Rivoluzione "Didattica" degli ultimi anni,
non il computer, non i "Nuovi Programmi". non la Riforma dei Cicli, non l'Autonomia.
Solo le fotocopie hanno influito e hanno cambiato (in peggio, per l'abuso) i metodi
d'insegnamento. Le vostre riforme "rivoluzionarie" sono state, sì. registrate nei
documenti, ma sono tutte passate troppo alte sul tetto della scuola per essere
acchiappate veramente.
3
Sulla programmazione didattica
(Da L. Chiorazzi, Se non fosse per i bambini... in fondo a scuola non si
starebbe male, Armando, Roma, 2001, pp. 103-4)
Quanti tipi di programmazione ci sono in un circolo didattico? Da quella
educativa a quella didattica, dalla bimestrale alla settimanale, dalla Carta dei Servizi
al Pof, dalle relazioni estemporanee fino ai progetti e progettini che ci fate fare anche
per andare al gabinetto. Dai contenuti curriculari alle "educazioni trasversali",
dall'educazione stradale a quella ambientale, dalla convivenza democratica a quella
interculturale, è tutto un continuo fiorire di "cunei" educativi e didattici che da ogni
parte si cerca d'infilare a forza all'interno delle attività cosiddette "normali".
Ma anche queste cose... non dovrebbero già far parte di diritto, oggi come
oggi, di un qualsiasi percorso educativo?
E allora perché cercate di incunearle dal di fuori con una miriade di progetti e
progettini "ad hoc" col risultato di farle sembrare dei veri e propri corpi estranei "in
più" con cui ci volete appesantire il groppone?
Il risultato è che se arrivano da corpi estranei, come corpi estranei vengono
vissuti: con rigetto. E se voi, dall'alto, sentite impellente la necessità di sorreggere
continuamente il programma normale con stampelle di questo tipo, non è forse
perché avete capito che il "programma normale" oggi diventa sempre più "anormale"
rispetto alle esigenze della società moderna? E se lo avete capito, perché continuate
a mettere cerotti invece di affondare il bisturi nel tumore?
Ascolti come in alcuni circoli ci prendiamo per i fondelli: prima l'indicatore
numero uno della scheda ricopiato cinquemila volte, sempre uguale, ossessivamente,
come Charlot alla catena di montaggio di Tempi Moderni. Poi:
- Obiettivo: "conoscere alcuni articoli della Costituzione";
- Contenuti: "alcuni articoli della Costituzione";
- Attività: "conversazioni su alcuni articoli della Costituzione":
- Verifica: "verificare la conoscenza di alcuni articoli della Costituzione".
Non le sembra paranoico? Alla fine, quando lei l'ha scritto, senza alcuna utilità
assolutamente per nessuno, sulla programmazione annuale. su quella bimestrale, su
quella settimanale, sul registro personale. sull'Agenda ufficiale, sul "quadernetto"
giornaliero che (Ereud faccia qualcosa!) alcune direttrici deliranti fanno tenere alle
insegnanti per registrare anche quanti respiri hanno fatto in un'ora... ma non le
viene spontaneo urlare istericamente "abbasso la Costituzione, fatemi scendere,
voglio scappare nella giungla del Borneo tra i cannibali e speriamo che mi divorino"?
Settembre, andiamo, è tempo di programmare.
Ancor prima di conoscere, o riconoscere, gli alunni, a scuola ancora chiusa, ci
costringiamo a fare: prove d'ingresso, programmazione annuale, programmazione
bimestrale,
programmazione
settimanale,
contenuti,
attività,
obiettivi
"individualizzati" per gli "individui" alunni che non conosciamo ancora.
In confidenza, ma perché ci mortificate così? E forse un modo per non farci
pensare?
Capisco: chi sta sopra ha sempre paura di chi sta sotto e i metodi di
rimbambimento non sono mai troppi.
Dopo ore e ore passate a scrivere deliri anche peggiori dei miei esempi, voi lo
4
sapete benissimo che dubitiamo della nostra intelligenza umiliata.
E il vostro lavaggio del cervello funziona. Incontro molte giovani colleghe
talmente imbevute della vostra dottrina che a volte mi fanno paura perché hanno
abdicato al pensiero. Sono diventate delle perfette "calcolatrici" scientifiche: se i
bambini, nella verifica sulle ormai diluvianti. ossessive fotocopie, non sistemano le
sequenze di disegni come loro (le insegnanti) hanno stabilito nelle sacre sedute delle
sacre prove. non va bene, hanno sbagliato. Anche se le sequenze si prestano a
interpretazioni "circolari" e un bambino "mettendole in ordine" escogita una
sistemazione originale, creativa, ma diversa da quella che voleva la maestra, non può
avere il massimo dei voti, perché in qualche modo il bambino "ha sbagliato" a non
leggere nel pensiero della Santa Maestra. Ha sbagliato a usare la propria fantasia
invece che quella dell'insegnante. E "l'errore creativo" tanto predicato da Gianni
Rodari. a cui, per colmo della beffa, magari è pure intitolato l'edificio scolastico. che
fine ha fatto?
Evviva la Scuola della Creatività di cui ci eravamo innamorati scorrazzando
come Huckieberry Finn e Tom Sawyer sulle verdi praterie dei libri di pedagogia!
Ma siccome siamo maestri anche nell'arte dell'arrangiarci, sa cosa faccio io
nella mia Scienza Parapedagogica? Cerco in giro le frasi che piacciono tanto a voi
superiori su riviste e fogli sparsi, o sulle programmazioni di venti anni fa che
riguardavano la scorsa generazione di alunni, cambio qualche parola qua e là e poi le
scopiazzo sui registri, sulle relazioni, sui giudizi, sulle "osservazioni sistematiche dei
processi d'apprendimento", sui progettini per le "strategie individualizzate" e
compagnia bella.
Le carte sono a posto. Voi superiori venite a controllare (se venite). leggete
belle parole e ve ne andate soddisfatti della bontà della scuola "all'avanguardia" che
dirigete.
Io sono giudicato un bravo maestro e vissero tutti felici e contenti.
5
Liberaci dai bambini che hanno "solo" diritti
(Da L. Chiorazzi, Se non fosse per i bambini... in fondo a scuola non si
starebbe male, Armando, Roma, 2001, pp. 113-4)
La retorica sociale sta toccando le punte massime: i "diritti" dei bambini
impazzano su tutti i giornali, in tutte le tavole rotonde e in tutte le relazioni e le
interviste ai super-esperti. Limitandoci alla società occidentale e italiana, quando
eravamo bambini noi sentivamo parlare solo di "doveri" dei bambini. Oggi sentiamo
parlare "solo" di diritti. Il "corpo sociale" ha gli stessi difetti dei singoli individui: il
vero equilibrio è davvero una cosa quasi impossibile da raggiungere. Solo "diritti dei
bambini" sui libri di testo; solo "diritti dei bambini" sui giornali; solo "diritti dei
bambini" nei dibattiti alla televisione; solo "diritti dei bambini" su tutte le
pubblicazioni che vediamo a scuola in tutte le salse. dai fumetti alle guide didattiche.
Capisco che un senso di colpa collettivo per le esagerazioni precedenti possa
provocare facilmente eccessi in senso opposto nei continui corsi e ricorsi storici, ma
veramente siamo tutti convinti che sommergendoli e soffocandoli fin dall'età della
ragione con una montagna di diritti disgiunti da almeno altrettanti "doveri" stiamo
facendo il bene dei bambini e della società?
Prima ancora di nascere li soffochiamo di oggetti accatastati sulla pancia della
mamma; ai compleanni e ai battesimi li strozziamo con una marea di regali
eccezionali, costosi e stupefacenti: e Babbo Natale non gli basta mai: e la Befana non
regge più il ritmo; a casa, spesso, nessuno osa contraddirli più di tanto perché già ci
si sente in colpa per la scarsa e debole presenza a causa del lavoro (sempre più
tiranno) di entrambi i genitori; a scuola a volte noi maestri non gli possiamo dire più
neanche "Ah!" perché se no, poverini, si turbano (come dice la psicologa); sempre
più spesso i genitori vengono a lamentarsi perché abbiamo usato un tono e un
comportamento "troppo duro" con i loro fragilissimi, e nello stesso tempo insensibili,
cocchi di mamma di carta velina superviziati e terribilmente incapaci di sopportare la
benché minima frustrazione o fatica.
In realtà scontano sulla loro pelle il senso di colpa e di malessere di una
società lacerata e vengono avvelenati quotidianamente col veleno del "tutto e subito
senza fatica".
E a diciott'anni. quando capita (ma per fortuna sono eccezioni) che alcuni di
loro accoltellano i genitori perché ormai non gli basta più nulla e vogliono "di tutto e
di più", i discorsi degli esperti in televisione non cambiano: i genitori non "sanno
ascoltarli" abbastanza.
E nessuno si chiede se loro, i figli, sanno "ascoltare" i genitori.
La risposta è che ormai non possono più perché sono stati educati ad
ascoltare soltanto se stessi e i loro desideri e a considerare gli esseri umani intorno a
loro esclusivamente come debitori di "diritti" nei loro confronti.
A mio parere, in questo sta la colpa dei genitori: nel non averli abituati
abbastanza all'ascolto degli altri.
E i primi "altri" dei bambini, quelli con i quali si addestrano a vivere, sono
appunto i genitori. E poi gli educatori, cioè noi maestri e maestre. Alle scuole medie
potrebbe essere già troppo tardi se non siamo intervenuti prima.
Ma oggi come oggi a scuola non abbiamo nessuno strumento per farlo.
6
Ne ci stiamo attivando per costruirne. Non sappiamo da dove cominciare.
Le vecchie armi della sopraffazione e dell'umiliazione degli alunni per fortuna
sono state smantellate, ma al loro posto non è sorto, come sarebbe stato
auspicabile, una struttura educativa fondata sulle due gambe (entrambe
indispensabili) dei diritti e dei doveri. Stiamo facendo crescere spropositatamente
solo la gamba dei diritti. E su una sola gamba si cammina da zoppi e non si va molto
lontano sulla strada dell'equilibrio della persona.
In una scuola "comunità educante", con finalità davvero concertate e
condivise, il bambino dovrebbe essere abituato in una prassi quotidiana a
"conquistarsi" tutto ciò a cui aspira. La "sana e santa fatica" è il vero sale delle
conquiste, per gli adulti come per i bambini. Certamente non eccessiva e
insuperabile, ma sempre leggermene superiore alle proprie presunte forze, così che
si possa "lanciare il cuore" dietro traguardi sempre più alti e andare agevolmente a
raccoglierlo. ma neanche troppo facilmente, affinchè si abbia la possibilità di
sperimentare, assaporare, scoprire e accrescere via via le proprie forze e abituarsi
senza drammi anche a qualche sconfitta che dia la consapevolezza e la misura del
proprio impegno e dei propri limiti umani.
7
(Da R.P. Feynman, Sei pezzi facili, Adelphi, Milano, 2000.)
PREFAZIONE
Queste sono le lezioni di fìsica che ho tenuto nel 1961 e 1962 agli studenti del primo e secondo
anno del Caltech (California Institute of Technologv). Naturalmente non sono riportate parola per
parola: sono state rivedute, a volte in modo sostanziale, a volte no. Le lezioni formano soltanto una
parte del corso completo. L'intero gruppo di centottanta studenti si riuniva in una grande aula due
volte la settimana per ascoltare queste lezioni, e poi si divideva in piccoli gruppi di quindici o venti
studenti per le esercitazioni sotto la guida di un assistente; inoltre vi era una sessione di laboratorio
una volta la settimana.
L'obiettivo principale che ci eravamo prefissi era conservare l'interesse degli studenti che, pieni di
entusiasmo e piuttosto intelligenti, arrivano al Caltech dalle scuole superiori. Hanno sentito parlare
molto di quanto siano appassionanti e interessanti certi campi della fisica: ad esempio la teoria della
relatività, la meccanica quantistica, e altre idee moderne. Capitava invece che al termine del corso
molti di loro fossero scoraggiati, perché avevano visto ben poche idee veramente grandi, nuove e
moderne. Avevano dovuto studiare piani inclinati, elettrostatica e così via, e dopo due anni erano
proprio avviliti. Si trattava quindi di costruire un corso in cui i più bravi e motivati non perdessero
l'entusiasmo.
Queste lezioni non intendono essere in alcun modo una semplice rassegna; sono una cosa seria.
Pensai di prendere come punto di riferimento i migliori della classe, e di far sì che nemmeno loro
riuscissero a comprendere del lutto il contenuto delle lezioni, per esempio suggerendo applicazioni
delle idee e dei concetti in varie direzioni, al di fuori della linea principale di ragionamento. Proprio per
questo ho cercato di formulare ogni asserzione nel modo più accurato possibile, di sottolineare ogni
volta come le equazioni e le idee si integrino nel corpo di conoscenze della fisica, e quali modifiche
sarebbero intervenute una volta che si fosse imparato di più. Sentivo anche che per gli studenti è
importante aver chiaro che cosa dovrebbero essere in grado di dedurre da quanto detto in precedenza
(se sono abbastanza svegli), e cosa invece viene presentato come nuovo. Quando venivano introdotte
nuove idee, io cercavo o di dedurle, se erano deducibili, o di spiegare che si trattava di un concetto
nuovo, che non aveva alcuna base nelle cose che già avevano imparato: non era dimostrabile,
bisognava proprio aggiungerlo.
Nell'iniziare le lezioni presupponevo alcune conoscenze di base da parte degli studenti, cose come
l'ottica geometrica, semplici nozioni di chimica, e così via, che si insegnano alle superiori. Inoltre non
vedevo ragione di presentare il materiale in un ordine preciso, evitando di parlare di una cosa finché
non avessi potuto descriverla in ogni particolare. Al contrario, c'erano continue anticipazioni di
argomenti non ancora trattati: una completa discussione sarebbe venuta a suo tempo, con una
preparazione adeguata. L'induttanza e i livelli di energia, per esempio, vengono dapprima presentati a
livello qualitativo, e solo in seguito diventano oggetto di uno studio approfondito.
Mentre mi rivolgevo agli studenti più attivi, non volevo trascurare il povero studente per il quale i
fuochi d'artificio e le applicazioni collaterali sono semplicemente inquietanti, e dal quale sarebbe vano
aspettarsi che impari molto del contenuto delle lezioni. A questi studenti volevo presentare almeno un
nucleo centrale o spina dorsale della materia che fossero in grado di comprendere. Magari non
avrebbero capito tutto, ma potevo sperare che non si innervosissero troppo. Non mi aspettavo che
capissero tutto, ma solo le caratteristiche centrali e più dirette, Ci vuole, naturalmente, una certa
perspicacia da parte dello studente per capire quali sono i teoremi e le idee più importanti, e quali
invece gli argomenti che si potranno comprendere solo negli anni seguenti.
Nel fare lezione c'era poi una seria difficoltà: per come era strutturato il corso, chi era in cattedra
non aveva modo di capire come stessero andando le cose, dal momento che gli mancava qualsiasi
riscontro da parte degli studenti. Io stesso quindi non ho idea di quanto siano buone queste lezioni. E
stato essenzialmente un esperimento; se dovessi rifarlo (e spero di non doverlo rifare!) non lo rifarei
allo stesso modo. Comunque penso, per quanto riguarda la fisica, che le cose abbiano funzionato
abbastanza bene per il primo anno.
Nel secondo anno non fui altrettanto soddisfatto. In particolare, nel trattare di elettricità e
8
magnetismo, non sono riuscito a trovare un modo veramente unico o diverso di presentare la materia,
alcun modo che fosse particolarmente più avvincente di quello usuale. Quindi non credo di aver fatto
un granché in questa parte. Alla fine del secondo anno avevo intenzione di aggiungere in coda
all'elettromagnetismo un paio di lezioni, per dire qualcosa sulle proprietà dei materiali, e soprattutto
per introdurre i modi fondamentali, le soluzioni dell'equazione di diffusione, i sistemi vibranti, le
funzioni ortogonali, ecc., per fare insomma i primi passi nei cosiddetti metodi matematici della fisica.
Se dovessi, oggi, rifare il corso penso che tornerei all'idea originaria; ma allora, dato che non era
previsto un nuovo ciclo di lezioni, sembrò una buona idea cercare di dare piuttosto un'introduzione
alla meccanica quantistica (che si trova nel terzo volume delle Lectures)
Certo, chi si laurea in fìsica può aspettare fino al terzo anno per imparare la meccanica quantistica, ma molti studenti del nostro corso - si disse - sceglievano fisica solo come materia
propedeutica per altre discipline; e il modo standard di presentare la meccanica quantistica la rendeva
quasi inaccessibile ai più, perché ci vuole tanto tempo per impararla. Eppure, nelle sue applicazioni
reali (specialmente in quelle più complesse, per esempio di ingegneria elettrica e di chimica) non viene
effettivamente usalo tutto il macchinario delle equazioni differenziali. Così ho cercato di darne
un'illustrazione generale che non richiedesse la conoscenza delle equazioni differenziali alle derivale
parziali. Anche per un fisico penso sia interessante sforzarsi di presentare la meccanica quantistica in
ordine inverso, per ragioni che risulteranno chiare dalle lezioni stesse. Ho però l'impressione che
l'esperimento non sia del tutto riuscito, soprattutto per mancanza di tempo (avrei avuto bisogno di tre
o quattro lezioni in più, per trattare con maggiore completezza argomenti quali le bande di energia e
la dipendenza spaziale delle ampiezze). Inoltre, essendo la prima volta, la mancanza di riscontro da
parte degli studenti fu particolarmente grave. Oggi penso che la meccanica quantistica andrebbe
presentata in un secondo momento: forse avrò l'occasione di farlo di nuovo, un giorno, e allora lo farò
nel modo giusto.
Non ci sono, nel corso, lezioni su come risolvere i problemi, perché per questo c'erano le ore di
esercitazioni. In effetti avevo svolto tre lezioni al primo anno sull'argomento, ma non sono incluse in
questa raccolta. C'era anche una lezione sulla guida inerziale, certamente appropriata dopo la lezione
sui sistemi rotanti, ma sfortunatamente è stata omessa, la quinta e la sesta lezione sono state tenute
da Matthew Sands. essendo io fuori città.
La domanda, ovvia, è fino a che punto l'esperimento sia riuscito. La mia impressione - peraltro non
condivisa da quasi nessuno che abbia lavorato con gli studenti - è negativa. Non penso di aver fatto
un buon lavoro, dal punto di vista degli studenti. Se guardo come la maggioranza di loro
Ha affrontato le prove d'esame, devo concludere che il sistema è fallito. Naturalmente qualche
collega mi fa notare che una o due decine di studenti - sorprendentemente - avevano capito tutto in
ogni lezione, avevano lavorato seriamente e avevano affrontato le cose con entusiasmo e inte-resse.
E' presumibile che queste persone abbiano una preparazione di base di prim'ordine in fisi-ca:
dopotutto sono proprio quelli che cercavo di raggiungere. Ma ciò significa, allora, che «di rado
l'insegnamento è veramente efficace, tranne in quei casi felici in cui è quasi superfluo» (Gibbons).
Eppure, non volevo lasciare indietro del tutto nessuno, come invece, forse, è successo. Penso che per
dare una mano agli studenti bisognerebbe mettere più impegno nell'inventare problemi che
chiariscano i concetti presentati a lezione. Esercizi e problemi forniscono una buona opportunità di
completare l'argomento e rendere più reali, più complete, più salde nella mente le idee. A mio avviso,
comunque, non c'è soluzione al problema dell'istruzione, oltre a rendersi conto che l'insegnamento
migliore e quello che si realizza nel rapporto diretto tra lo studente e un buon insegnante: la
situazione in cui lo studente discute le idee, riflette sulle cose, e ne parla. Non si impara molto stando
seduti in un'aula, e neppure facendo i compiti assegnati, ma di questi tempi dobbiamo istruire una tal
massa di gente che è necessario trovare un'alternativa all'ideale. Forse queste lezioni daranno un
contributo in tal senso: forse in qualche oasi felice, dove c'è ancora un rapporto individuale tra
studenti e insegnanti, qualcuno ne potrà trarre ispirazione, o qualche buona idea. Forse si divertiranno
a pensarci su, o a proseguire nello sviluppo di qualche concetto.
Giugno 1963
9
[da Ferroni G., La scuola sospesa, Einaudi, 1997, pp. 79-98]
Capitolo settimo
Pedagogia e miti della riforma
Le didattiche «democratiche», nelle loro varie e contraddittorie tendenze, si sono intrecciate con
gli sviluppi della pedagogia, nei suoi sempre più articolati, invadenti esiti istituzionali e, insieme, con le
istanze e le progettazioni di riforma riproposte più volte negli ultimi anni. Non solo nel nostro paese,
ma in gran parte dei paesi dell'occidente in cui lo sviluppo della scuola si riconduce ad una comune
matrice «pubblica» e illuministica, il tema della riforma è stato consustanziale all'esistenza stessa della
scuola: fattori diversi ma convergenti hanno contribuito a legare ogni discorso, ogni riflessione, ogni
esperienza che riguardasse la scuola alla prospettiva della riforma. Come in parte si è già accennato
nei capitoli precedenti, quello della riforma si è imposto come un vero e proprio mito generale, a cui si
sono aggregati molteplici miti particolari. Discutere sulla riforma, sostenere la necessità della riforma,
progettare riforme, hanno costituito una modalità quasi automatica dell'essere scolastico», un modo di
quasi immediata identificazione della scuola. Per gli operatori del settore, per gli esperti e gli
interessati, la scuola si è concepita quasi a priori come luogo da riformare. E per molte attività relative
alla scuola, il mito della riforma è stato strumento di un rinvio infinito: l'impossibilità e spesso
l'incapacità di operare in modo soddisfacente hanno trovato giustificazione nella critica della cattiva
volontà politica che rinviava le necessarie riforme; l'accettazione di situazioni deprimenti e la
tolleranza verso molteplici forme di degradazione si sono adagiate entro la diffusa convinzione che
solo una vera riforma avrebbe contribuito a superarle e a cancellarle.
I discorsi sulla riforma hanno sostenuto e garantito una generalizzata buona coscienza, un vario
rifiuto di scommettere e scommettersi nella realtà data, una esitazione verso gli strumenti culturali a
disposizione, una inerzia ed indifferenza verso i possibili modi di far valere i propri saperi, di
trasmetterli con convinzione e passione. Insomma, la riforma impossibile, rinviata, attesa, mitica, ha
contribuito a moltiplicare le forme di passività culturale, a ridurre la fiducia dei docenti nel loro sapere,
nell'istituzione scolastica e nella sua funzione; ha tarpato spesso in modo irrimediabile la vitalità
sgorgante da esperienze, da rapporti quotidiani, da incroci disciplinari; ha lasciato sprecare tante
energie nella progettazione di cose diverse da quelle che erano effettivamente a disposizione e che si
sarebbe stati in grado di fare proficuamente. Tutta la vita della scuola è potuta sembrare precaria,
inutile, insufficiente, proprio in ragione della necessità universalmente dichiarata di riformarla, di
renderla diversa da come si trovava ad essere, di orientarla verso altre possibilità e funzioni. E, in
questo contesto, l'attenzione generale della cultura diffusa e dell'opinione pubblica, degli operatori e
degli utenti della scuola, si spostava sempre più dai contenuti scolastici, dal corpo del sapere
circolante nella scuola, alle situazioni e alle strutture, alle funzioni e alle mansioni, agli stati giuridici,
alle forme amministrative, agli aspetti normativi e gestionali: insomma sempre più l'accento si fissava
sui meccanismi istituzionali, mentre finivano in ombra le ragioni vitali dell'istituzione e le cose concrete
da far in esse vivere e coltivare.
Sostegno determinante del mito della riforma è stato costituito dalla pedagogia e dal suo definirsi
in modo sempre più articolato ed ambizioso come scienza e come istituzione; parallelamente allo
sviluppo delle varie scienze umane, la pedagogia si è affrancata da quella funzione di ancella e di
esplicazione pratica della filosofia che in Italia le aveva attribuito la tradizione idealistica, ha
conquistato un vastissimo terreno accademico, ha creato reticoli teorici e programmatici sempre più
complessi. Sia le ricerche di tipo teorico che quelle di tipo sperimentale si sono moltiplicate all'infinito,
con una miriade di pubblicazioni che a uno sguardo d'insieme appare davvero inquietante. Alla
pedagogia stricto sensu si è aggregato tutto un sistema di scienze dell'educazione; ma non è
completamente chiaro se la pedagogia rappresenti una particolare «scienza dell'educazione» o se si
ponga invece come la sintesi e l'orizzonte generale dell'intero sistema delle scienze dell'educazione.
Tra queste hanno assunto rilievo rami particolari di altre scienze umane, rivolte allo studio del mondo
dei bambini, degli adolescenti, o anche degli adulti in quanto soggetti possibili di attività educative: si
sono avute così in prima istanza la psicologia dell'educazione, la psicologia dell'età evolutiva, la
sociologia dell'educazione; ma poi è risultato evidente che qualsiasi scienza umana poteva coniugarsi
con l'orizzonte educativo, permettendo di far posto ad un'antropologia dell'educazione, ad una
10
semiotica dell'educazione, ecc. All'interno del più stretto orizzonte pedagogico, legato alle circostanze
specifiche dell'insegnamento, si è poi sviluppata la didattica, con un'articolazione vastissima di
possibilità, da una didattica «generale» a varie didattiche sperimentali, alla didattica speciale, alle
didattiche extrascolastiche (con il ramo vastissimo dell'«educazione degli adulti» o dell'«educazione
permanente»), alle scienze della valutazione (articolabili in sottosettori specifici), alla inevitabile
proliferazione delle didattiche relative alle singole discipline, dalla didattica delle lingue a quella della
letteratura, della matematica, della fisica, della storia, della chimica, della geografia, e poi, con
ulteriori specificazioni in gradi ulteriori, fino alla didattica della lingua inglese, spagnola, latina, uraloaltaica, ecc., o alla didattica della letteratura italiana, francese, russa, ecc., e poi a possibili didattiche
della didattica e cosi all'infinito.
Questa proliferazione e sottospecializzazione ha avuto anche essenziali ragioni accademiche,
garantendo sempre nuove titolarità di cattedre e posti universitari, come del resto nell'università
italiana è accaduto per moltissimi campi disciplinari (ad esempio con insegnamenti di letteratura
italiana del Rinascimento, di letteratura italiana del Romanticismo, di filologia siciliana, di filologia
lombarda, ecc.): e la funzione accademica, che ha condotto infine alla creazione di specifiche facoltà
di scienze dell'educazione, ha sostenuto e incrementato quella miriade di pubblicazioni a cui già si è
accennato, nel circolo di una interminabile autoriflessione interna a una letteratura rivolta
all'enucleazione di principi, alla ripetitiva definizione di istanze generali, alla teorizzazione cavillosa
degli enunciati più banali, alla elevazione a scienza e alla formalizzazione di istanze ideologiche, di
motivi e richieste della moda, di generiche prospettive comportamentali. Un immenso universo
accademico-libresco si è costruito intorno agli eventi quotidiani della scuola: immenso universo che,
nella sua vastità, ha comportato naturalmente anche progetti importanti, ha visto in azione studiosi di
grande serietà e valore; ma nel suo insieme fa l'effetto di una abnorme superfetazione, ponendosi
come una delle manifestazioni più intricate ed incontrollate di quel delirio quantitativo che aduggia
tutta la cultura contemporanea.
Rispetto a tutte le possibili scienze umane, questo insieme pedagogico, questo vastissimo e
invadente territorio delle scienze dell'educazione, sembra segnato da una assoluta istanza proiettiva:
per esso la conoscenza è sempre, in qualsiasi momento, proiezione verso uno sviluppo ottimale, verso
un nuovo tipo di scambio tra docente e discente, verso una trasformazione dei modi di acquisizione
del sapere, verso una identificazione tra sapere e felicità. La società della pedagogia è spesso una
società del tutto ideale, in cui le regole e le pratiche definite dalla scienza sembrano magicamente
poter dar luogo ad un rapporto trasparente tra le generazioni e ad una gratificante acquisizione di
sapere. Si parte frequentemente dal presupposto secondo cui l'elaborazione di un canone didattico, la
perfetta programmazione dei momenti, delle fasi, delle tecniche del rapporto didattico, sarebbero
destinate a tradursi in diretta, vitale, produttiva esperienza: la scienza dell'educazione, chiudendosi
dentro il proprio punto di vista e prescindendo cosi dal senso della contraddizione, sembra aspirare
alla compiuta «trasparenza» tra il proprio sapere e la realtà, coltivando il disegno di una realtà ideale,
buona e ragionevole, comunque congrua con le previsioni elaborate dagli addetti ai lavori. In questa
trasparenza il valore essenziale non è mai quello dell'acquisizione dei saperi, non si identifica mai con i
punti di vista interni delle discipline da insegnare, ma si risolve nel benessere dell'allievo, o meglio in
una proiezione ideale di questo benessere, di ciò che secondo l'ideologia del pedagogista viene
identificato per benessere: e in ogni caso esso si basa sulla comprensione, sulla disponibilità del
docente ad acquisire il punto di vista dell'allievo, di far si che lo stesso corpo disciplinare si adegui alle
richieste, ai desideri, alle tensioni, alle difficoltà dell'allievo. Di fronte alle istanze rappresentate
dall'allievo il docente deve essere in grado di trasformarsi, di modificare se stesso e il proprio sapere.
Certo ciò accade quasi sempre nell'esperienza concreta, anche indipendentemente da programmi
pedagogici, in ogni autentico rapporto maestro-allievo, nella varietà infinita delle situazioni. Ma
l'insistenza a priori sulla comprensione, la definizione delle sue forme progettuali, la sua teorizzazione,
programmazione e tecnicizzazione, comportano un suo inevitabile scadere nella mera affettività, nella
rinuncia ad ogni distanza, nel deprezzamento dei contenuti dell'insegnamento, nella loro
subordinazione di ogni funzione della scuola all'immediata soddisfazione, alla gioia festosa dello starci
dentro.
Questa pedagogia «progressista», con le sue pretese di scientificità e le sue ossessioni
riformistiche, ha avuto varia diffusione nei paesi più avanzati, assumendo naturalmente aspetti diversi
ed associandosi a diverse prospettive politiche e culturali: ma, pur in questa diversità dei suoi aspetti,
singolarmente omogenei sono stati i suoi principi costitutivi e sorprendentemente analoghi i suoi
effetti, diretti o indiretti, sulle istituzioni scolastiche dei diversi paesi. E si può avere il legittimo
11
sospetto che questi principi pedagogici abbiano la loro parte di responsabilità nella generale «crisi»
dell'istruzione che travaglia i paesi avanzati: nei loro confronti, peraltro, non sono mancate critiche
molto lucide e dure da parte di studiosi e operatori della scuola schierati comunque «a sinistra», giunti
in vario modo a constatare che la pratica di quel corrente pedagogismo viene a scalzare proprio quegli
obiettivi «democratici» che dichiara di promuovere. Soprattutto in Francia e negli Stati Uniti, in
rapporto a tradizioni scolastiche diverse, queste critiche hanno avuto notevole diffusione e non
trascurabile risonanza. Molto più marginali sono state nel nostro paese, per la grande abilità
istituzionale dei pedagogisti e dei vari elaboratori di parole d'ordine riformiste e «progressiste», per
l'atteggiamento spesso passivo e acritico degli insegnanti (pronti a affidare la soluzione dei loro
problemi a modelli imposti da esperti esterni), per la quasi totale indifferenza dell'opinione pubblica,
degli intellettuali «generali», degli specialisti delle discipline «da insegnare», oltre che per le varie
ragioni di ordine politico e strutturale che si sono in parte già indicate.
Tra i pochi esempi di critica alle pedagogie «progressiste» e di denuncia del loro contributo allo
sfascio della scuola si può ricordare un libretto del 1977 passato del tutto inosservato, di Fabrizio
Canfora, Quale scuola?, rivolto contro l'unilaterale insistenza pedagogica su certi principi come
interdisciplinarietà, antinozionismo, convergenza sull'interesse presente, rifiuto della selezione: in esso
si denuncia l'esito distruttivo ed antiegualitario del libertarismo scolastico diffuso dalle ideologie
postsessantottesche e il convergere tra mode pedagogiche e riformismo velleitario, responsabile di
quella «legislazione "per non dispiacere"» che ha prodotto tanti guasti nella scuola italiana sullo
scorcio degli anni '70.
In Francia un intervento particolarmente vivace e complesso è stato quello del linguista JeanClaude Milner, con il libro del 1984, De l'école: qui la critica al pedagogismo si salda ad una riflessione
generale sul senso dell'istruzione, sul pericolo che essa corre nelle società moderne, sulle minacce che
gravano sull'autonomia della cultura e sui docenti come intellettuali. L'ossessione della riforma viene
da Milner ricondotta alla natura stessa della istituzione scolastica, inevitabilmente instabile e
contraddittoria, perché «dà forma istituzionale a qualche cosa che non ha un rapporto evidente con le
istituzioni, cioè ai saperi»: essa è «sempre pronta ad articolare in linguaggio istituzionale ciò che non
si può esprimere integralmente in quel linguaggio. Questa inadeguatezza continuamente risorgente,
ha come sintomo la riforma: rinasce sempre la speranza che si sarà capaci di tradurre in istituzione il
principio non istituzionale. Cosi, l'istituzione contraddittoria passa la maggior parte del suo tempo a
discutere se stessa e la propria modificazione...»; e in tale contesto, «a forza di percepire un oggetto
dal punto di vista della sua riforma, ci dimentichiamo facilmente di chiederci cosa esso sia e cosa
possa essere»1. Milner sottolinea l'orizzonte edificante e «pio» dei discorsi pedagogici, il loro
scambiare le scuole per «comunità ideali», la loro tendenza a mettere fuori gioco i «contenuti» e ad
insistere sui «metodi»2. Alla programmaticità pedagogica, che appare tanto più illusoria e proiettiva,
in un momento in cui non si da nessun valore fisso di riferimento, in cui gli stessi modelli culturali
mutano, si trasformano, si smentiscono incessantemente, Milner oppone la dimensione volontaristica,
di resistenza culturale dell'insegnamento: questo può darsi oggi essenzialmente come «un atto del
soggetto nella sua individualità più assoluta; nessun regolamento amministrativo gli sarà di alcuna
utilità». In questo contesto si dà una calzante critica del «populismo» pedagogico: nel ricoprire «di
disprezzo i saperi astratti e complicati dei borghesi, per vantare i saperi concreti e semplici» delle
classi popolari, questo, al di là dei suoi propositi piamente «democratici», condurrebbe in definitiva
alla conclusione che «le classi popolari hanno diritto solo a ciò che serve alla produzione»3. Nelle
correnti richieste di aprire totalmente la scuola ai saperi esterni, di immettere in essa tutti quei codici,
messaggi, forme di vita, saperi variabili e proliferanti che pullulano nella società attuale, viene d'altra
parte a ripetersi quel richiamo tante volte riproposto al rapporto tra scuola e «vita», che, secondo
Milner, deve rimanere relativamente distante, per il bene sia della scuola che della vita: «Devono
esistere dei saperi di cui la scuola non sappia nulla. Essa deve essere sufficientemente delimitata per
lasciare sussistere, al di fuori del proprio ambito, questi punti di resistenza; tanto affermata da
suscitare, presso coloro che le resistono, forti passioni; abbastanza generosa da dar loro, nel
momento stesso in cui le resistono, un pensiero e un linguaggio» 4.
Questo tema della parziale separazione tra scuola e vita, al di là di tutte le pedagogie
«democratiche» e di tutte le ideologie sessantottesche, è particolarmente sentito dalla tradizione laica,
repubblicana e illuministica francese: come suggerisce Jacques Muglioni, secondo il principio della
laicità, la scuola «n'est pas l'ouverture, cornme c'est la mode de dire: c'est la separation. Préserver
ainsi l'indépendance de l'école par rapport a la société extérieure, c'était préserver l'avenir et mème le
préparer. Il était entendu qu'on sortirait de l'école instruit et assez fort pour affronter un autre monde
12
qui n'est pas toujours conforme a la raison. L'école se proposait ainsi le contraire de l'adaptation; elle
voulait étre le lieu où l'on apprenait a étre lucide et libre par rapport à la société, a ses préjugés, à ses
injustices, le lieu d'où l'on pouvait s'exercer librement à la juger pour la changer quand il fallait».
Questa situazione si è rovesciata dopo il '68, quando la società esterna ha preso d'assalto la scuola
«pour lui imposer ses intéréts, ses passions et ses modes», e ha affermato una sua totale continuità
con la vita: «L'école n'est plus faite pour placer la société a distance d'elle-méme, pour lui enseigner
ainsi les raisons du progrès: c'est la société qui change l'école et la forge a son image afin de ne
trouver désormais en face d'elle aucun pouvoir de contestation»; la rottura della separazione tra
scuola e vita ha cosi portato ad una più profonda chiusura della scuola; l'ossessione della
contestazione ha distrutto ogni autentico spirito di contestazione 5.
In un quadro ambientale molto diverso come quello degli Stati Uniti d'America, percorso in modo
inquietante da ansie per una vera e propria «fine» dell'istruzione (titolo di un libro di Neil Postman),
che diventano addirittura auspici in certo scatenato liberismo tecnologico, un recente volume di Eric
Donald Hirsch, Jr., The Schools We Need, ha messo in luce tutta la responsabilità delle teorie
pedagogiche democratiche e progressiste nel generale collasso dell'istruzione, nella perdita di quei
saperi culturali di base il cui possesso è sola garanzia di una autentica eguaglianza tra i cittadini:
Hirsch mette in evidenza il legame tra il successo e la diffusione di quelle teorie (con tutti i miti
riformistici da esse scaturiti), e l'approfondirsi, sempre più evidente nella società americana,
dell'ingiustizia e dell'ineguaglianza sociale. Riferendosi esplicitamente all'insegnamento di Antonio
Granisci, alla sua difesa del rigore dello studio e dei suoi aspetti anche «meccanici» e «nozionistici» 6,
Hirsch sottolinea l'origine «romantica» delle teorie pedagogiche elaborate e propagate soprattutto
negli anni '20, il cui successo si è affidato ad una serie di slogan di grande agilità ed efficacia, che
sono penetrati in un senso comune dominato da una implicita diffidenza verso la serietà e il rigore
della conoscenza. Questi slogan hanno una natura eminentemente retorica (che Hirsch evidenzia con
acume di studioso della retorica) e si fondano sui due canoni paralleli del formalismo e del
naturalismo.
Per formalismo si intende «the belief that the particular content wich is learned in school... is far
less important than acquiring the formal toois which will enable a person to learn future content»,
insomma il rifiuto dei contenuti e delle nozioni, l'insistenza sui metodi e sulle abilità di accesso al
sapere, la diffidenza pedagogica verso la «trasmissione»; per naturalismo si intende «the belief that
education is a natural process with its own inherent forms and rhythms, which may vary with each
child, and is most effective when it is connected with natural, real-life goals and settings», insomma
l'insistenza sulle motivazioni legate alla situazione particolare, sul piacere e la libera disponibilità
dell'apprendimento, sul rifiuto di ogni sistematicità artificiale. Formalismo e naturalismo costituiscono
una assolutizzazione di mezze verità, di prospettive parziali, che hanno senso solo se fatte giocare
entro la concretezza dell'esperienza, nella verifica dei risultati, nell'acquisizione di saperi e capacità
reali. Così il formalismo che punta sui metodi contro i contenuti, sulle abilità contro le nozioni, si trova
paradossalmente a fallire proprio nell'acquisizione delle capacità metodologiche: «adequate attention
to the transmission of broad general knowledge actually does lead to general intellectual skills. The
paradox is quiet stunning. Our emphasis on formal skills has resulted in students who are deficient in
formal skills, whereas an appropriate emphasis on transmitting knowledge results in students who
actually possess the skills that are sought by American educators skills such as criticai thinking and
learning to learn»7. Ma gli slogan formalistici e naturalistici, nonostante siano contraddetti da studi di
psicologia della conoscenza che Hirsch prende attentamente in considerazione e soprattutto dalla
verifica dell'esperienza, dallo stato effettivo dell'educazione americana, pretendono comunque di
aggiornarsi continuamente, assumono vesti sempre ultramoderne, si presentano come risultati di
ricerche avanzate, si appoggiano sulle più vicine novità tecnologiche: fino a proporre e riproporre
riforme che in realtà mirano a curare i mali da essi stessi causati. Di questi slogan e idées reàues
Hirsch offre alla fine del volume un ricco campionario, Critical Guide to educational Terms and
Phrases, che sarebbe interessante e anche divertente confrontare con tanti termini e formule in uso
nella pedagogia e nel riformismo del nostro paese: e tutte da citare dovrebbero essere le osservazioni
duramente critiche di Hirsch sul project method, tendente ad un hands-on learning o ad un holistic
learning, sostenuto dal mito della integrità dell'esperienza e da ideologie antiverbalistiche, o sul tema
della student-centered education, che è uno di quelli che ricorrono più insistentemente in una scuola a
cui si richiede non tanto la trasmissione di saperi solidi e resistenti, quanto la soddisfazione e il dolce
benessere dei giovani.
13
Queste critiche diverse ma convergenti verso un'ortodossia pedagogica che domina, quasi
incontrastata, in tutti i paesi avanzati non inquietano comunque gran che l'orizzonte disciplinare,
accademico e istituzionale della pedagogia, che sembra spesso sfuggire alla «prova della realtà», al
confronto con il mondo esterno, con le mutazioni che in esso sono avvenute negli ultimi decenni, con
la nuova sostanza antropologica delle giovani generazioni, con le derive che costituiscono la
comunicazione culturale, con la stessa caduta del prestigio sociale della scuola. Se si eccettuano i
pedagogisti dotati di una più ampia coscienza filosofica e di una più lucida sensibilità sociale, la
pedagogia istituzionale tende per lo più a riproporre come nuovi quei modelli democratici che da noi si
sono diffusi soprattutto negli anni '60, che sul piano meramente teorico potevano avere una certa
congruenza con una società tutta rivolta verso un'espansione progressiva, verso l'illusione di una
democrazia «trasparente» sempre più larga e luminosa. L'osservatore esterno resta davvero sorpreso
dal fatto che questa pedagogia si pone ormai quasi come l'unica scienza umana che evita di sottoporsi
a critica, che si sottrae al dubbio epistemologico che insidia oggi ogni sapere: se le scienze (anche
quelle naturali) e le arti vivono in una sempre più lacerata e lacerante dimensione autocritica e
contraddittoria, si proiettano in una conoscenza «sospesa», tanto più rigorosa quanto più sospesa (e
che dire della letteratura?), la pedagogia sembra invece ancora del tutto presa da un empito
imperialistico, da una spinta interna a proporsi trionfalmente come la disciplina guida del presente e
del futuro, a regolare tutti i modi di trasmissione e di comunicazione del sapere e della cultura. Un
imperialismo che in parte sembra fare il paio con quello della semiotica: e del resto è facile notare
certe convergenze tra i discorsi della vulgata pedagogica e quelli della vulgata semiotica, tra
l'insistenza dei pedagogisti sulle regole dell'educazione e la chiacchiera culturale sulle forme della
comunicazione; come tutto è comunicazione, cosi tutto è educazione, e a tutti sembra comunque più
importante insistere su procedure, regole, tecnologie, piuttosto che su contenuti (senza contare
l'inevitabile costruzione di una pedagogia semiotica o di una semiotica pedagogica, di una applicazione
dei modelli semiotici all'analisi del processo educativo)8.
L'imperialismo pedagogico, come del resto quello semiotico, si basa su un variabile ed eterogeneo
proliferare di metafore, su di una illimitata appropriazione e combinazione di modelli ricavati dalle
forme culturali «alla moda», sulla continua dichiarazione della propria tempestività, del proprio pieno
partecipare alle più autentiche esigenze del presente. La convinzione della centralità dell'educazione
per lo sviluppo della cultura conduce fino ad identificare ogni rapporto culturale con un rapporto
educativo e ogni comunicazione di forme culturali con un atto pedagogico: cosi, partendo anche dalle
esperienze più valide, concrete e parziali, dell'educazione degli adulti, l'orizzonte pedagogico può
allargarsi verso l'educazione permanente e verso l'auspicio di una presenza della pedagogia e dei suoi
derivati in tutti gli spazi della vita collettiva e individuale. Il tempo della comunicazione globale, irretita
in un groviglio inestricabile di messaggi e di scambi senza nessuna pausa di silenzio, è anche quello
della formazione totale, a cui ovviamente sono e saranno delegati gli addetti ai lavori, i nuovi sacerdoti
di questo sapere universale dei modi e delle regole della comunicazione del sapere. Il configurarsi di
questa situazione può dare agli esperti una tale ebrezza, un tale compiacimento autogratificante, da
suscitare ottimistiche e trionfali profezie, che per il normale lettore possono risultare addirittura
esilaranti. Può per esempio capitare di leggere, in un saggio su quella «scienza dell'educazione» più
specifica che è la «Didattica» (generale, si presume), la «profezia» secondo cui essa «sarà incoronata
"regina" della formazione», anzi, più in particolare: «Nel cielo tutto azzurro, già sopra di noi, del vicino
duemila si può cogliere nitidamente un titolo in gigantografia: "benvenuti nel secolo della formazione"'
Nel primo secolo del terzo millennio, le età generazionali (l'infanzia come l'adolescenza, l'età adulta
come quella senile) saranno culturalmente attrezzate, per tutta la vita, in modo da poter intraprendere
con successo l'impervio viaggio lungo i sentieri di un mondo nuovo... E se nel cielo del ventunesimo
secolo campeggerà la formazione dell'uomo e della donna (nei paesi ricchi come in quelli poveri), la
sua stella cometa porterà scritto sulla scia luminosa il nome della Didattica... Questo perché
qualsivoglia educazione multigenerazionale chiede l'adozione di metodi e strategie rigorose e
sofisticate, di cui è titolare "unica" la Didattica: che si propone pertanto quale scienza "regina" della
formazione...»9. E poi un proliferare di entusiastiche metafore in cui si afferma l'aspirazione
totalizzante di questa scienza del fare-scuola, che ovviamente è anche una scienza della
comunicazione e «ha diritto all'abito da sera», per sciorinarci tutto il suo bagaglio di parole d'ordine,
dalla riprovazione della vecchia «istruzione scolastica di marca trasmissiva-riproduttiva-nozionistica: in
una parola "pappagallesca"», alle aperture verso un «ecosistema disciplinare», costruito con il «gioco
del "meccano" della trasversalità curricolare», con «tre strategie didattiche: multidisciplinare,
interdisciplinare, transdisciplinare» (o se si vuole «meccano ecosistemico combinabile in direzione
14
multi/inter/transdisciplinare....»)10; e poi programmazioni, collegialità, scuola dei laboratori, aule
didattiche decentrate, alfabetieri ecologici, contratti cognitivi e pacchetti orari, ecc.
II linguaggio della pedagogia associa spesso in frullati turbinosi materiali letterari, terminologie
tecniche desunte
dalle più varie scienze, gerghi massmediatici, anglismi di vario tipo desunti da trattati di pedagogia e
di psicologia, formule politico-burocratiche: i termini più diversi assumono nell'argomentazione
pedagogica un'aura tecnico-scientifica che spesso copre ed esalta riferimenti e realtà piuttosto
semplici e banali. Ecco ad esempio un gran parlare di «ottimizzazione» dell'apprendimento e un vario
schierarsi di funzioni quali «amplificazione, implementazione, distanziamento, globalizzazione,
individualizzazione»11. A leggere molti testi di questo tipo si ha proprio l'impressione di essere presi
nella rete di una ovvietà che si presenta come complessità: cosa che del resto capita anche a tante
altre scienze umane, e in misura notevole anche a discipline come la critica letteraria e la teoria della
letteratura. Ma, rispetto a ciò che capita in quelle altre discipline, l'incongruità risulta qui ancora più
palese ed assurda, perché il gergo tecnico-scientifico pretende di regolare una realtà quotidiana cosi
diretta, corposa, caotica, irriducibile, come quella della scuola, fatta spesso anche di piccole strutture,
di rapporti inafferrabili, di orizzonti casuali ed imprevedibili.
Tra i termini e concetti sacri della pedagogia c'è ovviamente quello di sperimentazione: in essa si
risolve in definitiva la continua proiezione di una scuola sempre possibile, che è sempre al di là dello
spazio e del tempo che sono dati, che conquista continuamente nuovi territori ed orizzonti. Da un
punto di vista teorico la sperimentazione sembra trasferire nella scuola quel principio della «ricerca» e
del movimento verso il «nuovo» che caratterizza il procedere stesso delle scienze e delle discipline
adulte: ma resta spesso incongrua con la posizione dei giovani che, per poter adeguatamente
«sperimentare», devono comunque entrare in contatto con i corpi istituzionali di discipline assestatesi
e definitesi nel tempo; come si possono aprire verso il nuovo i quadri di un sapere istituzionale, se
non si possiede in qualche modo la chiave del suo orizzonte di base, del terreno su cui radicare le
novità o far esplodere le rotture? E d'altra parte, possono aver davvero senso le sperimentazioni che
sorgono non dall'interno sviluppo di una disciplina, ma da presupposti didattici a priori, da
progettazioni aleatorie e fluttuanti? che dire della capacità educativa di una sperimentazione che si
sposta sempre «più in là», che viene intesa come un «fare altro», rivolto a favorire evoluzioni creative
di questo o quest'altro sperimentatore, a condurre fuori dei vincoli istituzionali delle discipline, ad
affacciarsi verso culture erratiche, superficiali e subalterne, verso tutto ciò che ha il sentore dell'ultima
novità?
Questo spostarsi sempre più in là dei programmi e degli obiettivi didattici viene sostenuto e
rafforzato dallo sviluppo tecnologico, dalla stessa velocità con cui si propongono sempre nuove
tecnologie: e in particolare le tecnologie della comunicazione prospettano un processo inarrestabile di
adattamento della scuola e delle sue pratiche, una continua messa a punto di macchine e di
strumenti. Ovviamente le tecnologie sono parte dell'universo culturale contemporaneo e come tali
vanno certamente conosciute e usate anche all'interno della scuola, in rapporto all'utilità che possono
avere per le singole discipline. Appare però del tutto sospetto ed illusorio l'ottimismo pedagogico che
periodicamente si ripropone all'affacciarsi di ogni nuova tecnologia e, come la pretesa di mutare
radicalmente i quadri delle discipline e i metodi didattici in rapporto al rilievo che assumono le
tecnologie più pervasive. Tutto ciò crea una continua messa a punto di tecnologie didattiche di tutti i
tipi, che rendono la scuola assolutamente subalterna ai modelli della comunicazione di massa e al
consumismo tecnologico, anche se in alcuni casi si presume di ricavarne non una adesione cieca, ma
qualche parvenza di conoscenza «critica»12.
A parte i propositi di utilizzazione didattica della televisione, o di insegnamento delle tecniche
cinematografiche, televisive o pubblicitarie, l'orizzonte tecnologico attuale è naturalmente dominato
dall'informatica e dalla digitalità, dai computers e dalle reti telematiche. Forse senza rendersi conto
della rapida obsolescenza a cui tanti strumenti andranno incontro in un brevissimo giro di anni, si
prospetta una immissione indiscriminata di computers e una ubriacatura di Internet nella scuola: alle
nuove tecnologie viene affidata addirittura la capacità di attuare in concreto, nell'orizzonte ambientale
e comportamentale, i fondamenti delle pedagogie «progressiste». Interattività, multimedialità,
comunicazione pluridirezionale, costruzione di percorsi personali, gioco e manipolazione libera di dati
estratti da una memoria artificiale: tutto ciò condurrebbe a superare la tradizionale passività
dell'allievo, renderebbe possibile una autentica individualizzazione dell'istruzione, il vero avvento di
una scuola student-centered e project-based, che tra l'altro potrebbe contribuire anche a superare
certe ineguaglianze e discriminazioni, a favorire (ma non si capisce mai bene come) i più poveri e i
15
meno dotati13. Le svariate e bislacche, ingenue o sofisticate utopie alimentate dal diffondersi
dell'informatica e delle reti, sottoscritte spesso in modo indiscriminato dalla cultura di sinistra, sono
fatte proprie in modo ancor più acritico dalla pedagogia «progressista», certi esponenti della quale
sembrano riconoscere rivoluzioni epistemologiche, soli dell'avvenire, nuove felici possibilità esistenziali,
perfino dalle applicazioni più pedestri ed alienanti dell'informatica stessa 14. Cosa potrà salvarci da
questo accecamento tecnologico, da questo cumulo di illusioni, da questi investimenti mitici, da questa
pericolosa mancanza di coscienza critica e di senso della contraddizione?
Note
1 Cito dalla trad. it., La scuoia nel labirinto, Armando, Roma 1986, p. 21.
2 Con grande acume e non senza ironia Milner individua nella pedagogia una spinta a rimettersi
continuamente «a nuove procedure, sempre nuove e sempre promettenti, per dei domani sempre posticipati: si
parla solo di metodi che sarebbero convenienti se per caso si dovesse insegnare qualche cosa, ma non c'è nulla
da insegnare, perché tutto ciò che si deve insegnare è che dovrebbero esserci dei metodi rinnovati per
l'insegnamento. In breve, nelle scuole medie e nei licei rinnovati dalla buona riforma, agli allievi non si parlerà
d'altro che della scuola media e dei licei rinnovati» (La scuola nel labirinto, cit., p. 90).
3 La scuola nel labirinto, cit., pp, 110-12.
4 Ibid., p. 25.
5 J. Muglioni, La gauche et l'école, in La République et l'école cit., pp, 277-278: l'orizzonte politico (che è
quello di una sinistra che «s'est mise a aimer cette société qu'elle révait, naguère encore, de changer ou, tout au
moins, de rendre meilleure») si salda strettamente a quello pedagogico, con prospettive molto simili in atto nelle
pratiche e nei progetti di riforma italiani: «apprendre une science en commenant par les dernières prouesses
techniques, les moins instructives mais, croit-on, les plus rentables, se livrer à des activités réputées
interdisciplinaires avant d'avoir acquis quelque discipline que ce soit, s'en tenir à la littérature du jour, quand ce
n'est pas au journal, sans la moindre attention pour les chefs-d'oeuvre qui ont fait notre langue et nourri notre
pensée, confondre l'information et l'enseignement, l'image et l'idee. Et surtout refus de considérer le vrai en luiméme».
6 Cfr. nelle già citate Osservazioni sulla scuola, quanto Gramsci osserva sullo studio grammaticale e
«meccanico» delle lingue antiche; «c'è molta ingiustizia e improprietà nell'accusa di meccanicità e di aridità. Si ha
a che fare con ragazzetti, ai quali occorre far contrarre certe abitudini di diligenza, di esattezza, di compostezza
anche fisica, di concentrazione psichica su determinali soggetti che non si possono acquistare senza una
ripetizione meccanica di atti disciplinati e metodici» {Quaderni del carcere, vol. III cit., p. 1544); e ancora, sui
caratteri dello studio appropriato agli adolescenti: «In questo periodo... lo studio deve essere (o apparire ai
discenti) disinteressato, non avere cioè scopi pratici immediati o troppo immediati, deve essere formativo, anche
se 'istruttivo', cioè ricco di nozioni concrete» (Quaderni del carcere, vol. III cit., p. 1546). Proprio tutto il
contrario delle pedagogie «moderne» e «democratiche»!
7 The Schools We Need. Doubleday, New York 1996, pp. 218-19.
8 Milner ha messo in luce in tutta evidenza «l'analogia di struttura fra la pedagogia e i discorsi della
comunicazione»; il pedagogista tende a porsi come «il portavoce» della comunicazione, che riduce il senso della
cultura alla pura forma del suo comunicarsi, perché in fondo «non si ha mai niente da dire, perché tutto ciò che si
ha da dire è che ci sono dei nuovi media». La scuola nel labirinto cit., pp. 88-90.
9 Cfr. F. Frabboni, La didattica, una scienza che già c'è, in B. Vertecchi (a cura di). Il secolo della scuola.
L'educazione nel Novecento cit., pp. 233-70 (in particolare p.233)
10 Ibid., p. 244.
11 Desumo i termini, riferiti alle tecnologie didattiche, da R. Cerri Musso, Tecnologie didattiche, in M.
Gennari (a cura di), Didattica generale, Bompiani, Milano 1996, pp. 171-223 (cfr. p. 205).
12 Cosi «la didattica tecnologicamente configurata» riuscirebbe a «produrre "formazione alla tecnologia
diffusa", ovvero a istituirsi come presidio educativo di fronte al rischio di inconsapevolezza con cui le giovani
generazioni vivono immerse nella tecnologia senza esserne concettualmente e idealmente padrone» (R. Cerri
Musso, Tecnologie didattiche cit., p. 173).
13 Per questa tematica, cfr. l'articolo del sociologo americano P. Starr, Davvero il computer può cambiare la
scuola?, in «Reset», 33, novembre 1996, pp. 47-53 e 34, febbraio 1997, pp, 49-51. Per una proposta di uso
didattico dell'informatica, criticamente orientata, vedi A. Pian, Computer. scuola e formazione. Orientamenti
culturali e percorsi didattici. Centro Scientifico Editore, Torino 1996.
14 Davvero ineffabile questa dichiarazione di Roberto Maragliano, pedagogista «democratico» che tra l'altro
è una delle «menti» del progetto di riforma del sistema scolastico presentato dal ministro Luigi Berlinguer: "II
videogioco è la più grande rivoluzione epistemologica di questo secolo. Ti da una scioltezza, una densità, una
percezione delle situazioni e delle operazioni che puoi fare al loro interno che permette di esaltare dimensioni
dell'intelligenza e dello stare al mondo finora sacrificate dalla cultura astratta» (Maragliano: «La scuola ora si
metta in gioco», intervista siglata L., D., M., in «l'Unità», 5 febbraio 1997), Dato che il Maragliano è stato
nominato coordinatore di una commissione ministeriale per la discussione di quel progetto di riforma, di cui non
16
fa parte nessun «italianista», può essere interessante citare anche la battuta successiva, con cui egli stesso si
rivolge a chi lo intervista: «Lei preferisce che un pilota d'aereo abbia tatto videogiochi o che abbia letto la Divina
Commedia?»; al che, tout se tient.
17
(Da Repubblica 4.10.02)
Il silenzio dei miei studenti che non sanno più ragionare di Marco Lodoli
L’ottimismo, anche se temperato dal dubbio e dal buon senso, è un dovere di ogni insegnante, che
deve comunicare ai suoi alunni sempre e comunque un po' di fiducia nella vita. Dunque anche io cerco
di vedere il bicchiere mezzo pieno, di incoraggiare ogni volontà di miglioramento e di rimarcare gli
aspetti più belli dell'esistenza.
Eppure da un po' di tempo un pensiero atroce si è installato nella mia mente, mi tormenta, mi
perseguita, e ormai sono arrivato al punto di doverlo assolutamente comunicare a chi per età, lavoro,
interessi, è lontano dal mondo dei ragazzi. La cosa è questa: a me sembra che sia in corso un
genocidio di cui pochi si stanno rendendo conto. A essere massacrate sono le intelligenze degli
adolescenti, il bene più prezioso di ogni società che vuole distendersi verso il futuro.
Non dovete prendere questa mia affermazione in modo metaforico, e non dovete neanche pensare
a una delle solite tirate contro i giovani che non hanno voglia di fare niente, che disprezzano i valori
alti e la cultura. Non si tratta di denunciare un certo naturale menefreghismo e nemmeno
l'inclinazione ossessiva al consumo che dimostrano i gruppi giovanili. La mia non è la sparata
moralistica di chi rimpiange i bei tempi in cui i ragazzi leggevano tanti libri e facevano tanta politica. Io
sto notando qualcosa di molto più grave, e cioè che gli adolescenti non capiscono più niente.
I processi intellettivi più semplici, un'elementare operazione matematica, la comprensione di una
favoletta, ma anche il semplice resoconto di un pomeriggio passato con gli amici o della trama di un
film, sono diventati compiti sovrumani di fronte ai quali gli adolescenti rimangono a bocca aperta, in
silenzio. Le qualità sentimentali sono rimaste intatte, i miei alunni amano, odiano, fanno amicizia, si
emozionano, si indignano, arrossiscono, ridono, piangono, tutto come sempre — ma le capacità
logiche, mentali, paiono irreparabilmente compromesse.
In ogni classe ormai ci sono almeno due o tre studenti che hanno bisogno dell'insegnante di
sostegno: voi penserete che si tratti di ragazzi affetti da qualche handicap fisico o da qualche grave
disturbo mentale, ma spesso non è così. All'inizio è persino difficile distinguerli dagli altri, perché nella
classe paiono tutti ugual- mente storditi, come se i cervelli avessero subito qualche lieve
ammaccatura. Questi quindicenni sono sani e pressoché normali, e a me sembrano solamente
l'avanguardia di un mondo diretto verso le tenebre. Semplicemente non capiscono niente, non
riescono a connettere i dati più elementari, a stabilire dei nessi anche minimi tra i fatti che accadono
davanti a loro, che accadono a loro stessi. Ripeto: sono appena più inebetiti degli altri, come se li
precedessero di qualche metro appena nel cammino verso il nulla.
Loro vengono considerati ragazzi in difficoltà, ma i compagni di banco, quelli della fila davanti o
dietro, stanno quasi nelle stesse condizioni. Gli insegnanti si fanno in quattro, cercano di rendere le
lezioni più chiare, più dirette, si disperano e si avviliscono, ma non c'è niente da fare, le parole si
perdono nel vento, sono semi che rimbalzano su una terra asciuttissima che non fiorisce mai.
La cosa più triste è che questo deficit progressivo dell'intelligenza si nota soprattutto nei ragazzi
delle classi sociali più povere. I giovani borghesi hanno in casa libri, dischi e computer, hanno genitori
ambiziosi e fratelli in carriera, hanno cento stimoli in più per andare avanti decifrando in qualche
modo la realtà. I giovani delle borgate sono avvolti da un'ottusità che fa male. Veramente non
capiscono nemmeno chi sono e cosa stanno facendo, spesso non sanno più incollare una parola
all'altra, un pensierino a un altro pensierino. Sono perduti in una demenza progressiva e spaventosa.
Crescono rintronati dalla televisione, dalla pubblicità e da miti bugiardi, da una promessa di felicità a
buon mercato, da mille sirene che cantano a squarciagola, e accanto a loro non c'è altro che riesca a
farsi spazio. E così, poco alla volta, perdono ogni facoltà intellettiva, fino a diventare totalmente ottusi.
Sia chiaro: il problema non è che non sappiano nulla di una guerra imminente o dell'Europa unita o
di chi ha vinto l'ultimo festival del cinema a Venezia; il problema è che non riescono a ragionare su
nessun argomento, perché qualcosa nella testa si è sfasciato. Vi prego di credermi, non sono un
apocalittico, non grido al lupo al lupo solo per creare apprensione. Sono semplicemente un testimone
quotidiano di una tragedia immensa. Il nostro mondo è in pericolo non solo per l'inquinamento, la
violenza, l'ingiustizia, il prosciugamento delle risorse prime. La nostra civiltà rischia grosso soprattutto
perché la confusione sta producendo esseri disadattati, creature che non saranno in grado di
cavarsela, milioni di giovani infelici che strada facendo — la strada che noi adulti abbiamo disegnato
— hanno perduto il pensiero. Dopo essersi spente nelle campagne, le lucciole ora si stanno spegnendo
anche nelle teste.
18
Da Repubblica del 13-10-2003
"Cari prof, non ci piacete" bocciati da due studenti su tre. Insensibili, poco
comunicativi, indifferenti ai giovani"
Lo rivela una ricerca su mille ragazzi dai 16 ai 19 anni, realizzata dal mensile Campus. La
provocazione: prendete esempio dai divi dello spettacolo
"Cari prof, non ci piacete" bocciati da due studenti su tre. Insensibili, poco comunicativi,
indifferenti ai giovani"
"Non sanno nulla di musica tecnologia e droghe leggere"
"Ignorano il nostro mondo, sono trascurati anche nel vestire"
MARIA NOVELLA DE LUCA
ROMA - Bocciati in globalizzazione, moda, tecnologie, piercing, musica e droghe leggere. Trascurati
nel vestire, insensibili ai problemi degli studenti, poco coinvolgenti durante le lezioni, per nulla
informati sul mondo del lavoro e terribilmente lontani dalle immagini levigate dei divi della tv. Che poi
conoscano la loro materia, e siano aggiornati, come sembra, su calcio e sport, non è che cambi molto
il giudizio finale. Cari prof non ci piacete. Così hanno decretato mille studenti tra i 16 e i 19 anni
intervistati dal mensile Campus, un´indagine per capire che cosa manca, davvero, agli insegnanti
italiani per essere considerati dei "maestri". Al primo posto tra le critiche alla scuola i ragazzi hanno
indicato (68%) proprio i professori, poi le condizioni fatiscenti degli istituti. Alla domanda "ti è mai
capitato di parlare dei tuoi problemi con un insegnante?", il 69% ha risposto "no, mai". Oltre la
cattedra, insomma, il silenzio. Dalla ricerca affiora anche l´identikit di un certo modello di studente.
Che critica i prof per il loro modo di vestire (dimesso e trasandato), manderebbe insegnanti e presidi a
scuola dai personaggi delle soap, e soprattutto (ma forse la risposta è ironica) sogna in cattedra Maria
De Filippi, Alessia Marcuzzi, Fabio Volo, Lorenzo Ciompi e Piero Chiambretti.
"Sinceramente non mi ritrovo nei modelli proposti da questa ricerca - commenta Giovanni Salvi, 18
anni, ultimo anno di Tecnico Commerciale e coordinatore dell´Unione Studenti - se non quando si
afferma che i prof sono ignoranti sui temi della globalizzazione. Del loro modo di vestire non me ne
importa nulla, e devo dire che negli anni ho incontrato diversi docenti con cui è stato possibile parlare,
prof che danno quel "qualcosa in più" oltre all´ora di lezione. Il punto vero è un altro: dietro tutte
queste critiche, secondo me, c´è un malessere per la mancanza di spazi di rappresentanza dei giovani
nella scuola". Forse. Ma le affermazioni del questionario sembrano più "personali" che "politiche",
come se gli studenti si sentissero delusi dal disinteresse del mondo adulto per tutto ciò che compone il
loro mondo under. "Difendo la mia totale ignoranza in fatto di mode, tatuaggi e simili - risponde
Massimo Pierro, docente di Storia e Filosofia al liceo Visconti di Roma - gli studenti devono pretendere
da me che io sia preparato in ciò che insegno, non che discuta del loro anello al naso. Non sono
d´accordo nemmeno con le critiche al look dei professori". Già, ma c´è un universo ben definito dietro
quelle risposte. "I ragazzi si lamentano della mancanza di un rapporto personale - dice Pierro - ci
chiedono di parlare del loro stile. Sono richieste che dovrebbero fare ai loro genitori. Per quanto mi
riguarda insegno da anni e sono sempre rimasto in contatto con i miei ex studenti. Quello che mi
preoccupa, invece, sono i modelli di riferimento ai quali noi dovremmo ispirarci: Maria De Filippi, Fabio
Volo, Emilio Fede. Speriamo che sia una provocazione...".
19
La Repubblica: La cultura viene percepita come un ferrovecchio ingombrante e
fastidioso
Vince l´illusione di una vita come la ribalta tv
La cultura viene percepita come un ferrovecchio ingombrante e fastidioso
MARCO LODOLI
Che gli alunni non amino visceralmente i loro professori è cosa talmente nota che forse non serviva un
sondaggio a ricordarcelo. Tutti quanti abbiamo stampati nella memoria i nostri professori di un tempo:
e ce n´erano tanti veramente bizzarri, scorbutici, infelici, prepotenti, a volte sfaticati, spesso noiosi.
Basta rivedere l´inizio di Amarcord, con quella collezione di insegnanti strampalati, persi nelle loro
lezioni ripetute anno dopo anno fino allo sfinimento, e del tutto incapaci di capire cosa accadeva nella
classe. Ora agli insegnanti si chiede giustamente di non essere solo degli esperti nella loro materia,
ma anche di saper cogliere gli umori degli alunni, la debolezza di uno, la crisi familiare di un altro,
l´aria pericolosamente stordita di un terzo.
Ma questo sondaggio ci racconta che nonostante tutti gli sforzi il fossato resta largo e che i ragazzi
considerano quegli adulti in cattedra vecchi babbioni incapaci di aggiornarsi sulle mode giovanili,
sull´evoluzione della musica e del costume, su tutto ciò che conta davvero. Universi opposti
continuano a come sempre scontrarsi, a stridere. Quello che colpisce, semmai, sono le nuove accuse
che i ragazzi muovono, e il tipo di cultura che produce queste accuse. Almeno a dare retta al
sondaggio, i professori vengono rimproverati perché vestono male, perché non somigliano in nulla ai
personaggi vincenti della televisione, perché parlano difficile e non comunicano come i comici e gli
attori più simpatici.
Questi severi appunti ci dicono qualcosa della scuola e parecchio del mondo in cui oggi viviamo. Ci
dicono, ad esempio, che la cultura viene recepita come un ferrovecchio ingombrante o addirittura
fastidioso. Conta poco imparare a leggere un libro, risolvere un´equazione, orientarsi tra i secoli della
storia. Conta niente concentrarsi - e la concentrazione è spesso una pratica dolorosa - per penetrare
un problema filosofico o matematico. Mille volte di più contano la giacca che indossi, la maglia
griffata, la macchina che parcheggi davanti alla scuola. Se sei un poveraccio con i polsini sfilacciati e
una Ritmo ammaccata, oggi non puoi insegnare niente a nessuno, perché evidentemente tu per primo
non hai saputo tradurre quelle conoscenze nelle uniche cose che valgono davvero: il denaro e il
successo.
A fidarsi del sondaggio, le cose stanno esattamente così. Ciò che più dispiace è che queste sono le
posizioni dei giovani, che da sempre immaginiamo portatori di un idealismo magari un po´ ingenuo, di
quell´energia nobile e pura che sa mettere in imbarazzo il cinismo degli adulti. Il mondo è sempre
andato avanti in questo modo: i vecchi si irrigidiscono in un realismo asfittico e i giovani li incalzano
con la bufera delle loro emozioni disinteressate, nobili, spesso incomprensibili, e la vita si rinnova.
Ora pare che la giostra abbia iniziato a girare nel senso opposto. Io arrivo a scuola (scuola di periferia,
lo ricordo sempre, la più lontana dalle ansie culturali, la più vicina al televisore) portando riviste di
musica, i cd dei Radiohead o di Capossela, i libri appena usciti, gettando sul tappeto argomenti
d´attualità che mi paiono vitali, e spesso vado a sbattere su commenti tipo: «Professò, ste cose
interessano solo a lei e a quattro matti come lei, a noi ce piacciono la De Filippi e Gigi D´Alessio, i
tatuaggi e le vetrine del centro commerciale. Quando butta quel catorcio di vespa?».
Bisogna prendere atto della realtà, senza farsi soverchie illusioni. Il consumismo più becero, la
cultura dell´immagine, l´illusione di una vita che sia come un palcoscenico televisivo dove si ride e si
balla, picchia e mena l´hanno avuta vinta. Vinta alla grande. E noi non possiamo far finta di
sorprenderci.
20
Da “Repubblica”
Censurato il suo messaggio di ringraziamento.
Von Trier rifiuta il premio di pace
"Datelo agli amici di Bush"
dal nostro inviato MARIA PIA FUSCO
BERLINO - Un premio per la pace ed è subito guerra (di comunicati). Destinatario del premio
assegnato dal Comitato per il cinema di pace era Lars von Trier, che, assente per tradizione, aveva
inviato in video un discorso di ringraziamento dai toni ironici, video che però nella serata ufficiale per
la raccolta di fondi Unicef - 600 illustri ospiti tra i quali Liza Minnelli e Christopher Lee, la raccolta è
stata di 500 mila dollari - era stato censurato.
Dopo i ringraziamenti di rito, von Trier diceva: "Il popolo del mondo è come due tribù nel deserto, una
tribù vive in un paese con un pozzo, l'altra in un paese senza pozzo. La tribù con il pozzo vuole la
pace, l'altra non vuole la pace, vuole l'acqua! La tribù senza pozzo forse è meno civilizzata, non ha
una parola per dire pace, ma ne ha una per dire sete, che, data la situazione, è più o meno la stessa
cosa. Il Comitato per la Pace nel paese con il pozzo, è buono, saggio, sano, gente bella che non ha
sete, perciò ha tempo ed energia per il comitato. La gente con il pozzo parla molto di premi per la
pace da dare ad altra gente che vive nel paese con il pozzo. Quelli del paese senza pozzo non parlano
molto di premi per la pace...". I collaboratori del regista danese, presenti alla serata, dopo la censura,
hanno restituito il premio: "Lo diano a qualcuno che sia più amico di Bush!".
E' curioso che sia accaduto a Berlino, dove pace, guerra e tragedie piccole e grandi del mondo sono
temi che attraversano molti dei film del festival e dove, proprio ieri, è stato presentato La sorgente del
fiume di Theo Anghelopoulos, prodotto da Amedeo Pagani e dall'Istituto Luce, la cui versione italiana
curata da Carlo Di Carlo uscirà il 27 febbraio. Il film, a cui ha collaborato Tonino Guerra, è il primo
della trilogia con cui Anghelopoulos intende "raccontare il secolo trascorso, attraverso le sue tragedie
e le sue speranze, facendo anche una sorta di riassunto del mio cinema".
(13 febbraio 2004)
21