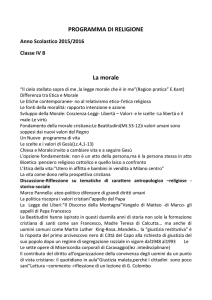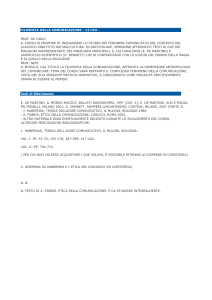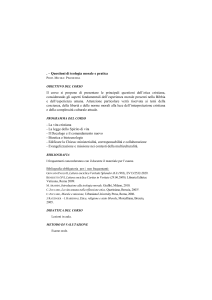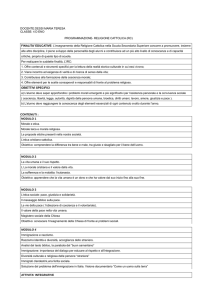Dibattito sul forum con il professor Pierluigi Lecis
All'inizio della sua spiegazione, ha dato per scontato che la genetica in negativo, ossia
levare determinate predisposizioni a malattie genetiche, non crea problemi a livello morale,
in quanto questa genetica in negativo è ben vista da tutti... ma è proprio così?
E se la futura "creatura" invece non fosse d'accordo perchè magari ritiene che soffrire (per
una qualsiasi malattia) sia una cosa necessaria (per esempio, in una persona fortemente
cristiana, in cui la componente della sofferenza è presente)?
Inoltre, sempre ricollegandoci a ciò, chi è l'autorità che può ritenere di sapere e decidere il
volere della futura "creatura"?
Domanda posta da Claudio Andrea Saiu, liceo scientifico A. Pacinotti
Questa prima domanda è molto interessante; posso ribadire che in generale la terapia genica non
suscita obiezioni etiche e controversie di principio. Tutte le posizioni accreditate nel dibattito
bioetico, compresa quella di Habermas, considerano moralmente accettabile la terapia genica
somatica (su cellule somatiche già 'specializzate', per esempio del midollo osseo, presenti
nell'adulto); neppure l'ipotesi di terapia genica per via germinale suscita obiezioni di principio,
nonostante sia assai più delicata, e ben lontana da un livello di sperimentazione che consenta di
applicarla all'uomo. Anche nel mondo cattolico, dal quale provengono le maggiori riserve e cautele,
non ci sono condanne o chiusure pregiudiziali. La terapia genica germinale è quella più carica di
insidie in quanto praticata sulle prime cellule non ancora differenziate dell'embrione (quelle
totipotenti, capaci di generare non solo cellule specializzate dei vari tessuti e organi, ma anche le
cellule germinali, responsabili della riproduzione, dunque atte a trasmettere anche all'eventuale
prole il tratto genetico manipolato a scopo terapeutico). L'etica cattolica, pur tra diverse sfumature e
orientamenti, pone però un vincolo ed un dovere assoluto, il rispetto della sacralità della vita dal
momento del concepimento e la considerazione dell'embrione come persona, soggetto del diritto
inviolabile a non essere manipolato come semplice 'materiale biologico' per esperimenti che ne
mettano a rischio la sopravvivenza o l'identità genetica individuale. Non è lecita la produzione di
embrioni per scopi sperimentali, commerciali o industriali, ma è lecito l'intervento volto a tutelare la
salute o la vita sugli embrioni.
La questione circa il significato cristiano della sofferenza dunque non va posta a questo livello (mi
pare che non lo faccia nessuna delle varianti del pensiero cristiano); qui il problema vero è la
difficoltà di distinguere nei casi concreti la genetica terapeutica da quella migliorativa. Come ho
detto anche nella conversazione, il nodo è molto grosso e le cristalline distinzioni concettuali, di
Habermas o di altri, in questo non sono risolutive. La linea tra genetica negativa e positiva non è
netta né sicura. Questa è una difficoltà obiettiva delle posizioni deontologiche, che vogliono
difendere principi assolutamente vincolanti partendo da concetti generali. Lo stesso problema della
sofferenza assume rilievo se collegato alla domanda su chi ha l'autorità di stabilire, anche per altri,
di giudicare che cosa è una vita meritevole di essere vissuta; non è facile spiegare perché qualcuno
possa interpretare o anticipare la volontà del nascituro a questo riguardo. Il criterio del consenso
virtuale e anticipato in base ai 'nostri' criteri attuali, entro certi limiti più sostenibile per il caso di
malattie gravissime, se applicato alla domanda su che cosa sia una vita meritevole di essere vissuta
(con o senza malattie) è facilmente esposto all'accusa di un paternalismo che certo viola il principio
di reciprocità delle relazioni interpersonali.
Avrei una domanda per il prof. Lecis. Habermas fa suo il razionalismo di Kant. Salva la
moralità kantiana tenendo conto delle critiche. Quali sono queste critiche e in che modo ne
tiene conto?
Domanda posta da Francesca Isola, liceo scientifico A. Pacinotti
La domanda di Francesca è molto 'intrigante'; anche se non è di taglio bioetico, è filosofica a tutto
tondo e porta su questioni molto importanti. Tenterò di fare un quadro sintetico. La morale
dell'imperativo categorico ha subito sollevato obiezioni contro il suo formalismo (le più forti e
sistematiche da parte di Hegel) e il suo fondarsi esclusivamente sull'intenzione del soggetto. La
legge morale è 'vuota', non ci dice che cosa è giusto, doveroso o buono in concreto. Ci dice solo di
agire come se la massima della nostra azione dovesse valere come legge universale. Perciò non può
dare risposte in caso di conflitto tra norme o valori coinvolti nella stessa situazione (come
nell'esempio che ho citato a Villacidro: non mentire, non tradire gli amici, intese come principi
assoluti, da rispettare sempre e comunque, ci porterebbero a situazioni insolubili, in cui qualunque
scelta risulterebbe moralmente criticabile o inaccettabile. Anche l'interpretazione della sacrosanta
norma 'non uccidere' creerebbe forti difficoltà nel quadro di questa concezione). Un altro punto di
discussione e critica ricorrente è il rigorismo kantiano; un'azione è moralmente significativa solo se
condotta con l'intenzione di obbedire ad una pura legge razionale, indipendente da qualunque
inclinazione, motivazione, interesse 'soggettivo'. Non rubare per paura dei carabinieri, non è
un'azione morale (è solo legale, conforme al diritto penale). A molti questa è sembrata una morale
per 'arcangeli', non per uomini concreti, in carne ed ossa, nella pienezza della loro vita ed anche una
forma di falsa autonomia morale; il suo presupposto è una scissione netta ed un conflitto insanabile
tra ragione e impulsi, un dualismo (con radici platoniche) tra il mondo sensibile-fenomenico e il
mondo intelligibile, tra vita naturale e vita morale dell'uomo. Ne deriva l'immagine di un uomo non
integro e veramente autonomo, ma diviso, lacerato tra due 'regni' inconciliabili: alla fine la ragione,
proprio in quanto comanda e impone doveri assoluti, non è che un nuovo padrone dell'uomo, questa
volta interno, non più esterno; essa non fa che 'interiorizzare' la dipendenza dell'uomo da potenze
che lo rendono schiavo e impoveriscono la sua vita. Lo stesso ideale di autonomia del soggetto
morale che Kant teorizzava (nella legge morale io mi autodetermino mediante la ragione)
risulterebbe compromesso da questa nuova forma di repressione interna delle energie vitali
dell'individuo,
e
sconfinerebbe
in
una
forma
mascherata
di
servitù.
Devo sorvolare sulle implicazioni di queste critiche nel pensiero contemporaneo, da Nietzsche a
Freud, per non farla troppo lunga ed arrivare per questa via sino a Habermas. Il quale ha tenuto
ampiamente conto di queste critiche, ma ha dato particolare rilievo ad un'altro carattere e limite
della morale kantiana, il suo fondamentale individualismo. La elaborazione della legge morale e la
giustificazione della sua universalità è descritta da Kant come un processo strettamente
'monologico', cioè non dialogico: la ragione è una facoltà individuale capace per se stessa di
determinare la volontà, il volere razionale che guida l'azione morale può essere costruito in foro
interno. L'interazione tra molti soggetti, la sfera delle relazioni intersoggettive (interpersonali) non è
un fattore costitutivo delle decisioni morali; l'individuo può arrivare da solo alla scelta giusta e alla
scoperta del suo dovere morale, la ricerca del consenso e dell'intesa con altri è semmai una
conseguenza, ma non una condizione necessaria per fondare le norme morali. Ora, come abbiamo
visto dalla distinzione tra agire strategico e agire comunicativo, un ideale dialogico e comunicativo
è alla base dell'etica di Habermas; il quale perciò propone un'interpretazione riformata
dell'imperativo categorico come test di universalizzabilità delle norme morali. Quando una norma o
un'azione sono giuste? quando si fondano sull'intesa comunicativa, cioè sul consenso razionale,
liberamente espresso da tutti gli interessati, da tutti i soggetti coinvolti, attraverso un processo di
comunicazione simmetrica, senza posizioni dominanti e senza inganno reciproco. La ragione non è
una facoltà individuale, ma un processo dialogico e argomentativo in cui si cerca di comunicare per
stabilire intese mediante l'argomentazione migliore (dunque in un processo non compromesso da
differenze di potere e da calcoli egoistici di interesse 'orientati al successo'; non sviluppato secondo
il modello delle azioni 'strategiche', in cui si usano cose, eventi e persone come mezzi utili o efficaci
per realizzare scopi 'privati'). La formazione della legge morale è un processo non interno ad ogni
individuo, ma pubblico e discorsivo (basato sulla regola del discorso pratico: tra tesi rivali 'vince'
quella meglio argomentata e informata).
L'etica del genere umano di Habermas si basa su due punti fondamentali:
- l'idea di poter essere se stessi che ci rimanda alle argomentazioni di Kierkegaard
- l'idea di relazioni interpersonali simmetriche e paritetiche.
E' sufficientemente argomentata? Ed inoltre non potrebbe essere argomentata in un altro
modo più realistico (esempio il più forte sul più debole)?
Domanda posta da Roberta Podda, liceo scientifico A. Pacinotti
La domanda di Roberta può essere, a dire il vero, interpretata in diversi modi, ma in ogni caso apre
un terreno invitante, suddiviso in due aree subordinate. Provo a scegliere la linea che mi sembra
utile per una risposta unitaria. Certo la proposta di un'etica di genere è criticabile e probabilmente
Habermas non la argomenta in modo esauriente o esente da obiezioni. Si può dubitare che esista
un'etica di genere che metta in luce principi validi per tutti gli uomini in quanto tali (e non in quanto
appartenenti ad una certa comunità o contesto storico-culturale). Alimentano questo dubbio tutte le
tesi relativistiche e antinaturalistiche (in gran parte provenienti dal campo delle scienze etnoantropologiche), per le quali norme e valori morali sono strettamente dipendenti dal particolare
ambiente in cui si formano e non possono valere al di fuori dei suoi confini. In questa prospettiva le
differenze etiche (di giudizio e di comportamento morale) sono decisamente più importanti delle
somiglianze tra individui e popoli. La posizione di Habermas è che, al di là delle differenze storicoculturali, l'approccio dialogico dell'etica comunicativa consente comunque di stabilire
razionalmente e in maniera vincolante come meglio giustificati i principi umanistici di un'etica di
genere che tutela l'indisponibilità della vita, anche della vita embrionale, contro usi puramente
strumentali volti a soddisfare scopi e calcoli di interesse egoistico. Mediante un processo
discorsivo-argomentativo pubblico volto a stabilire intese motivate da buone ragioni, non dalla
forza e dall'inganno o manipolazione delle coscienze, si possono stabilire e giustificare
razionalmente principi e diritti universalmente validi ed estensibili a tutti gli uomini. Questa
posizione si contrappone nettamente ad ogni argomento antiegualitario, fosse pure basato sulla
presunta differenza naturale (comunque intesa) tra il più forte e il più debole. Sono molti i
sostenitori della 'legge del più forte' (dal Trasimaco della Repubblica di Platone all'amoralismo di
Nietzsche - che però è una posizione molto complessa e meriterebbe un'analisi a parte, a varie
forme di darwinismo sociale, alle ideologie razziste nel XIX e XX secolo); spesso si appellano ad
una legge di natura che giustificherebbe la disuguaglianza in quanto il più forte è il più adatto alla
sopravvivenza nella lotta per la vita, il più adatto al comando etc. Dalla natura o da situazioni di
fatto come la disuguaglianza politica tra chi governa e chi è governato si ricaverebbe la definizione
di ciò che è giusto o buono e doveroso. Questa tesi nasconde un 'trucco': per stabilire che cosa è
giusto e ha valore, non basta descrivere ciò che avviene in natura o anche nella società. Ciò che
presentiamo come una semplice descrizione contiene già una nascosta valutazione positiva,
un'approvazione di ciò che descriviamo come naturale. Insomma volgiamo solo 'santificare' come
naturale ciò che a noi sembra giusto e positivo. Dire che cosa avviene o anche spiegarne le cause
non è la stessa cosa che 'giustificarlo' o dire che è giusto buono, che incarna un valore. Per stabilire
un valore occorre esibire ragioni e non semplicemente descrivere uno stato di fatto e le sue cause.
Che la capacità di adattamento, la 'forza' biologica o comunque la superiore capacità di
sopravvivenza non siano criteri per giudicare il valore di un'azione o di una persona può essere
argomentato in molti modi. Ne cito uno che mi sembra efficace e interessante, basato su un'ipotesi
realistica: dopo una catastrofe nucleare, gli scarafaggi, per la loro resistenza alle radiazioni nucleari,
risulterebbero certamente più forti e adatti alla sopravvivenza rispetto agli uomini. Credo che non
molti di noi sarebbero disposti a sostenere che questo è un criterio per giudicare il valore degli
scarafaggi rispetto agli uomini. In generale, non è affatto detto che ciò che meglio si conforma a
leggi naturali evolutive sia anche giusto, doveroso e buono, o dotato di valore morale. L'esempio è
paradossale, ma mi sembra molto efficace nel mostrare, contro i 'naturalisti', che la forza e la
capacità di sopravvivenza non sono automaticamente, da sole, un valore; e che per attribuire valore
(morale, religioso, politico, artistico etc.) ad una cosa, ad un'azione, ad una persona, non basta
descrivere come è fatta o come si è formata e sopravvive nel suo ambiente. Bisogna anche prendere
posizione in base ad altri criteri e fonti di giudizio.
vorrei sapere su quali argomentazioni di Kierkegaard si fonda l'idea di poter essere se
stessi di Habermas e perché si fonda su tali argomentazioni.
Domanda posta da Nicole Orrù, liceo scientifico A. Pacinotti
Vorrei anche io chiedere delucidazioni in merito alla trattazione fatta da Habermas alle pp.
9 e 10 dell'etica kierkegaardiana, da lui definita nel contempo religioso-teologica e postmetafisica.
Domanda posta da Ettore Martinez, professore del liceo scientifico A. Pacinotti
Il testo di Habermas (alle pp. 9 e sgg. della prima conferenza, dal titolo Astensione giustificata)
affronta chiaramente la questione del poter-essere-se-stessi in Kierkegaard. Con intuizione teorica
acuta e anticipatrice, il filosofo danese formula un concetto oggi ancora molto influente, in piena
epoca post-metafisica, dice Habermas. In senso stretto epoca post-metafisica è quella in cui la
filosofia e le grandi religioni universali (cristianesimo, islamismo, induismo etc.) non sono più in
grado di fornire un'immagine del mondo che assicura risposte universalmente condivise nel campo
della conoscenza, della morale e dei valori in genere. Viviamo in un'epoca di pluralismo etico e
comunicazione globale, in società multiculturali in cui si incontrano e si scontrano diverse visioni
della vita, della società, della storia. Non ci sono giudici imparziali, istanze o autorità superiori in
grado di dire in concreto che cosa è giusto, bene, bello, vero; meno che mai ha compiti
'fondazionali' così forti la filosofia, che in passato ha invece esercitato questa pretesa sotto forma di
dottrina dell'essere e dei suoi principi ultimi (tradizione aristotelica, per esempio), o sotto forma di
critica della ragione, con i suoi principi universali e necessari (tradizione kantiana). Oggi la 'ragione'
deve essere più cauta e può al massimo indicare le forme procedurali di una discussione in cui
liberamente, per quanto possibile, senza dominio e senza inganno, si confrontano diverse immagini
del mondo, tradizioni culturali, scelte morali. La filosofia può dire come comunicare (discutere)
razionalmente su ciò che è vero, buono, bello etc., come risolvere razionalmente, con la più libera e
spregiudicata discussione pubblica i conflitti, senza l'uso della forza o dell'inganno, con risorse
argomentative e buone ragioni; ma non può asserire direttamente che cosa è concretamente vero,
giusto
o
buono.
Che cosa ha a che fare Kierkegaard con tutto ciò? Le sue tesi sono un tassello importante di un'etica
post-metafisica, anche se avvolte in una forma decisamente teologica e legate alla forza di una
genuina esperienza religiosa, non meramente intellettuale. L'idea del poter-essere-se-stessi è l'idea
che l'individuo possa scegliere se stesso, progettare e costruire la sua storia di vita, assumersi in
prima persona il carico di obblighi e responsabilità verso altri, decidere che cosa vuol essere, fare e
divenire, secondo una sua misura individuale, che lo fa diverso da tutti gli altri. Possiamo
distinguere tre aspetti di questa scelta: 1) la decisione su ciò che vuole essere è autonoma, ma non
meramente conoscitiva, implica un impegno, un mettersi in gioco di tutta la persona, non solo delle
possibilità di comprensione razionale. Conta la dimensione affettiva, le emozioni, il senso di colpa,
la disperazione, l'angoscia; 2) la scelta implica un momento di radicale interiorità e solitudine, un
ritrarsi dell'individuo in se stesso, in cui vengono meno tutti gli appigli esterni, come convenzioni,
tradizioni, costumi, legami comunitari; 3) la scelta non è puramente soggettiva ed arbitraria, non ha
il carattere di un capriccio contingente e mutevole di cui non si risponde che a se stessi. Si tratta di
una scelta responsabile che trova sfondo e forza nell'esperienza religiosa. La relazione creaturale
con Dio, vissuta in questa atmosfera, diversa dall'afferrare razionalmente una verità o una legge, di
impegno totale, emozionale e pratico, rischioso, senza garanzie di riuscita, non diminuisce, ma
garantisce e rende possibile l'autonomia e la libertà della scelta. Conta non tanto il contenuto, ma la
forma, il modo della scelta, che è quello di un'assunzione in prima persona di decisioni e
responsabilità; senza conformarsi passivamente e in modo meccanico ad un ordine o disegno
esterno precostituito, ad un disegno pre-stabilito, ad una forza esterna superiore, la società, le
tendenze del corso storico etc. Dio non offre di queste garanzie, lascia l'uomo libero di fronte alle
sue responsabilità, nell'orizzonte anche drammatico del possibile, di possibilità tra cui dobbiamo
scegliere in modo autentico, cioè autonomo, senza protezioni. Dobbiamo rispondere di persona,
attivamente di ciò che decidiamo di essere.
La scelta etica, tanto più se rafforzata e stabilizzata da un genuino rapporto con il trascendente ha
altre interessanti implicazioni 'esistenziali': essa comporta un salto di qualità radicale nel nostro
modo di essere. La scelta ci fa uscire da una vita dispersa, frammentata e dominata dalle routine, in
cui lasciarsi andare passivamente, conformisticamente alle spinte esterne, agli eventi che si
succedono e ci colpiscono casualmente, alle cose così come vengono; e ci traspone in una
dimensione in cui invece le cose, gli eventi, gli incontri con altri assumono un senso unitario, in
base al piano di vita che ci diamo. La nostra vita non è un'accozzaglia casuale di eventi, ma una
storia in cui le varie parti si raccordano fra loro con una certa coerenza secondo una certa direzione,
una vicenda il cui senso dipende da noi, da come accettiamo, interpretiamo il nostro passato e vi
innestiamo un progetto aperto sul futuro, su che cosa vogliamo essere. Il fattore tempo (la direzione
che collega il nostro passato, il presente ed il futuro tramite le nostre decisioni) diventa molto
importante nello sviluppo di una vita che non ci è imposta, ma al contrario costruiamo attivamente.
Kierkegaard (in Aut Aut, per esempio) delinea così in chiave filosofico-teologica un ideale morale
di autonomia e autorealizzazione della persona che può confluire, secondo Habermas, nella prima
componente di un'etica comunicativa radicata in un'etica di genere: la componente per cui ci
sentiamo 'autori indivisi' della nostra storia di vita, attivi e responsabili, non condizionati da disegni,
decisioni o interferenze esterne, tanto meno da decisioni eugenetiche unilaterali e irreversibili di
genitori o medici che violino la spontaneità del nostro sviluppo biologico prenatale. Naturalmente
Habermas non accetta il fondo teologico dell'etica kierkegaardiana, ma non lo considera
incompatibile con la sua posizione laica circa l'intuizione morale di noi stessi come persone
autonome. Si può laicamente sostenere che l'individuo si trova a dover scegliere se stesso
attivamente e responsabilmente di fronte all'insieme intersoggettivamente condiviso di credenze e
valori che la comunità gli trasmette attraverso i diversi meccanismi di socializzazione, a cominciare
dall'apprendimento linguistico. L'individuo moralmente autonomo deve rilegittimare, fare suoi e
scegliere consapevolmente i contenuti della tradizione, oppure modificarli, criticarli e respingerli:
dipende solo da lui fare scelte autentiche e responsabili e realizzare un suo stile individuale nel
quadro della vita in comune. Nessuna scelta naturalmente avviene in uno spazio socialmente e
culturalmente vuoto; la nostra libertà non è assoluta, e di fronte al quadro della vita comune
abbiamo lo stesso tipo di responsabilità che l'individuo kierkegaardiano si prende di fronte al suo
dio.