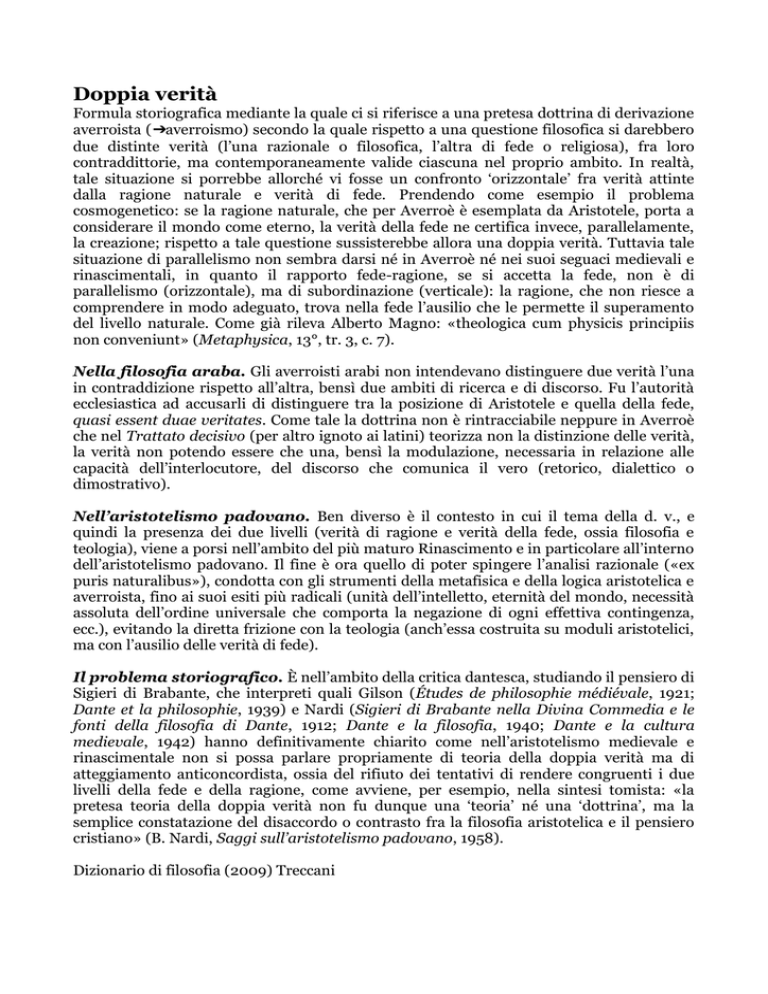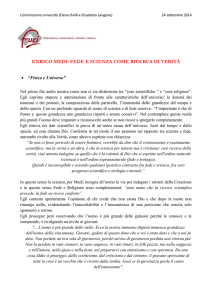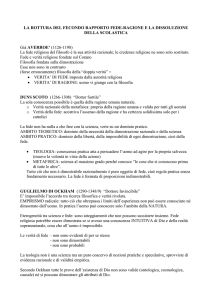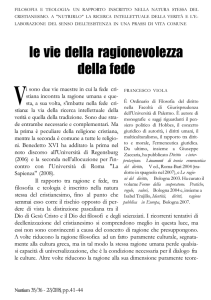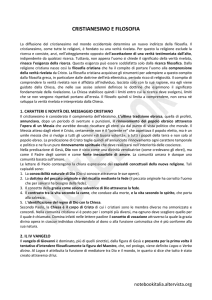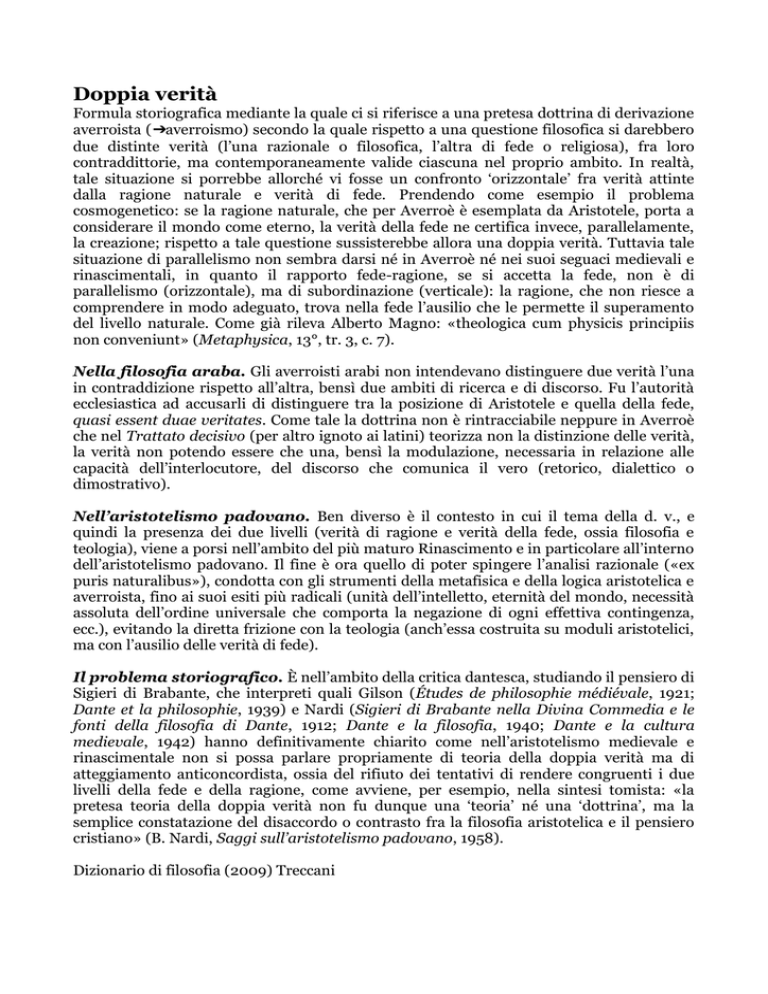
Doppia verità
Formula storiografica mediante la quale ci si riferisce a una pretesa dottrina di derivazione
averroista (➔averroismo) secondo la quale rispetto a una questione filosofica si darebbero
due distinte verità (l’una razionale o filosofica, l’altra di fede o religiosa), fra loro
contraddittorie, ma contemporaneamente valide ciascuna nel proprio ambito. In realtà,
tale situazione si porrebbe allorché vi fosse un confronto ‘orizzontale’ fra verità attinte
dalla ragione naturale e verità di fede. Prendendo come esempio il problema
cosmogenetico: se la ragione naturale, che per Averroè è esemplata da Aristotele, porta a
considerare il mondo come eterno, la verità della fede ne certifica invece, parallelamente,
la creazione; rispetto a tale questione sussisterebbe allora una doppia verità. Tuttavia tale
situazione di parallelismo non sembra darsi né in Averroè né nei suoi seguaci medievali e
rinascimentali, in quanto il rapporto fede-ragione, se si accetta la fede, non è di
parallelismo (orizzontale), ma di subordinazione (verticale): la ragione, che non riesce a
comprendere in modo adeguato, trova nella fede l’ausilio che le permette il superamento
del livello naturale. Come già rileva Alberto Magno: «theologica cum physicis principiis
non conveniunt» (Metaphysica, 13°, tr. 3, c. 7).
Nella filosofia araba. Gli averroisti arabi non intendevano distinguere due verità l’una
in contraddizione rispetto all’altra, bensì due ambiti di ricerca e di discorso. Fu l’autorità
ecclesiastica ad accusarli di distinguere tra la posizione di Aristotele e quella della fede,
quasi essent duae veritates. Come tale la dottrina non è rintracciabile neppure in Averroè
che nel Trattato decisivo (per altro ignoto ai latini) teorizza non la distinzione delle verità,
la verità non potendo essere che una, bensì la modulazione, necessaria in relazione alle
capacità dell’interlocutore, del discorso che comunica il vero (retorico, dialettico o
dimostrativo).
Nell’aristotelismo padovano. Ben diverso è il contesto in cui il tema della d. v., e
quindi la presenza dei due livelli (verità di ragione e verità della fede, ossia filosofia e
teologia), viene a porsi nell’ambito del più maturo Rinascimento e in particolare all’interno
dell’aristotelismo padovano. Il fine è ora quello di poter spingere l’analisi razionale («ex
puris naturalibus»), condotta con gli strumenti della metafisica e della logica aristotelica e
averroista, fino ai suoi esiti più radicali (unità dell’intelletto, eternità del mondo, necessità
assoluta dell’ordine universale che comporta la negazione di ogni effettiva contingenza,
ecc.), evitando la diretta frizione con la teologia (anch’essa costruita su moduli aristotelici,
ma con l’ausilio delle verità di fede).
Il problema storiografico. È nell’ambito della critica dantesca, studiando il pensiero di
Sigieri di Brabante, che interpreti quali Gilson (Études de philosophie médiévale, 1921;
Dante et la philosophie, 1939) e Nardi (Sigieri di Brabante nella Divina Commedia e le
fonti della filosofia di Dante, 1912; Dante e la filosofia, 1940; Dante e la cultura
medievale, 1942) hanno definitivamente chiarito come nell’aristotelismo medievale e
rinascimentale non si possa parlare propriamente di teoria della doppia verità ma di
atteggiamento anticoncordista, ossia del rifiuto dei tentativi di rendere congruenti i due
livelli della fede e della ragione, come avviene, per esempio, nella sintesi tomista: «la
pretesa teoria della doppia verità non fu dunque una ‘teoria’ né una ‘dottrina’, ma la
semplice constatazione del disaccordo o contrasto fra la filosofia aristotelica e il pensiero
cristiano» (B. Nardi, Saggi sull’aristotelismo padovano, 1958).
Dizionario di filosofia (2009) Treccani