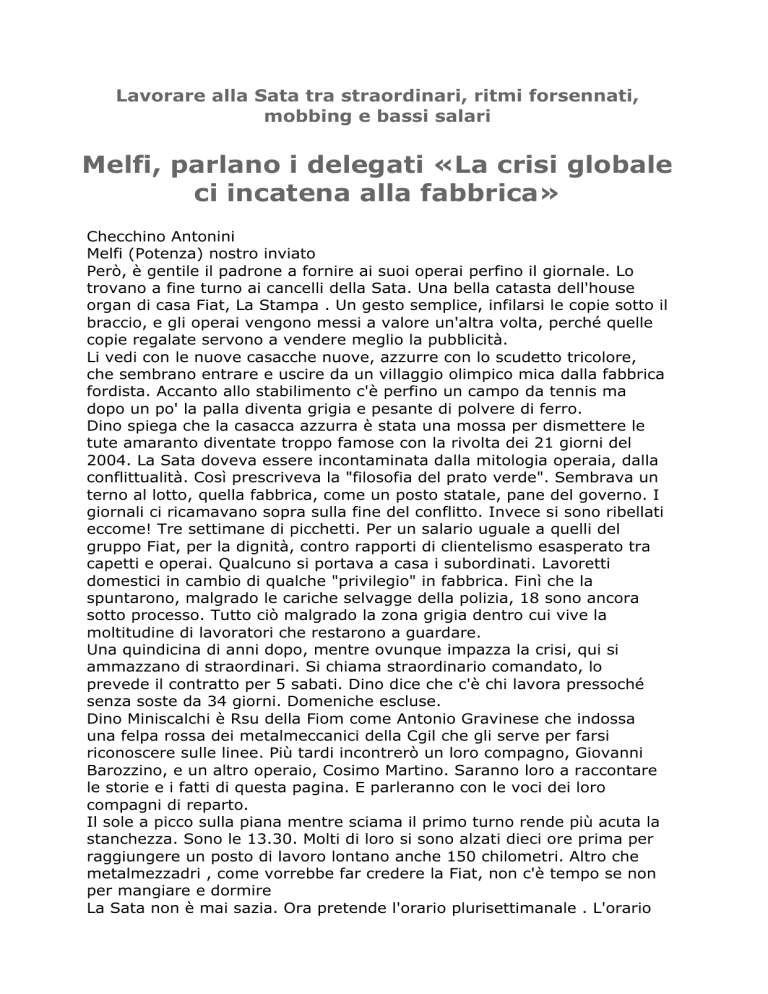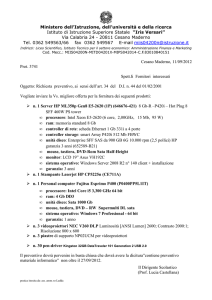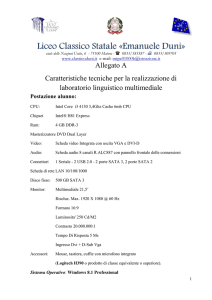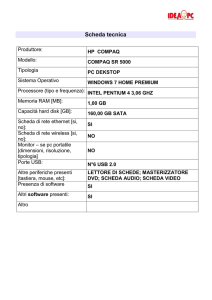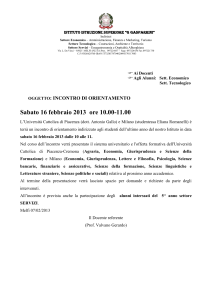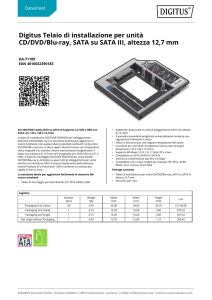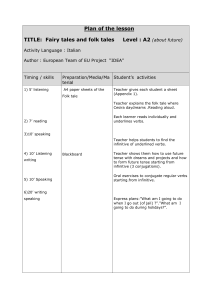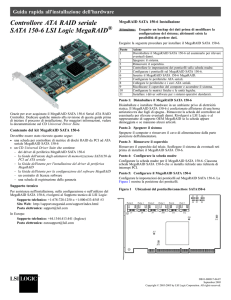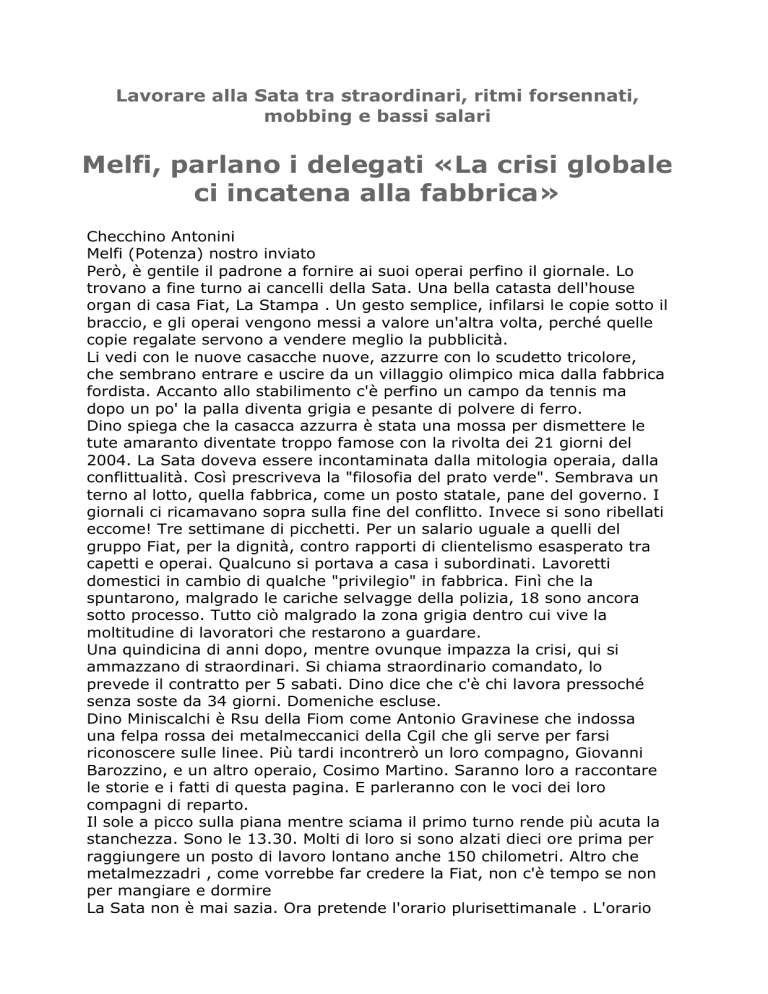
Lavorare alla Sata tra straordinari, ritmi forsennati,
mobbing e bassi salari
Melfi, parlano i delegati «La crisi globale
ci incatena alla fabbrica»
Checchino Antonini
Melfi (Potenza) nostro inviato
Però, è gentile il padrone a fornire ai suoi operai perfino il giornale. Lo
trovano a fine turno ai cancelli della Sata. Una bella catasta dell'house
organ di casa Fiat, La Stampa . Un gesto semplice, infilarsi le copie sotto il
braccio, e gli operai vengono messi a valore un'altra volta, perché quelle
copie regalate servono a vendere meglio la pubblicità.
Li vedi con le nuove casacche nuove, azzurre con lo scudetto tricolore,
che sembrano entrare e uscire da un villaggio olimpico mica dalla fabbrica
fordista. Accanto allo stabilimento c'è perfino un campo da tennis ma
dopo un po' la palla diventa grigia e pesante di polvere di ferro.
Dino spiega che la casacca azzurra è stata una mossa per dismettere le
tute amaranto diventate troppo famose con la rivolta dei 21 giorni del
2004. La Sata doveva essere incontaminata dalla mitologia operaia, dalla
conflittualità. Così prescriveva la "filosofia del prato verde". Sembrava un
terno al lotto, quella fabbrica, come un posto statale, pane del governo. I
giornali ci ricamavano sopra sulla fine del conflitto. Invece si sono ribellati
eccome! Tre settimane di picchetti. Per un salario uguale a quelli del
gruppo Fiat, per la dignità, contro rapporti di clientelismo esasperato tra
capetti e operai. Qualcuno si portava a casa i subordinati. Lavoretti
domestici in cambio di qualche "privilegio" in fabbrica. Finì che la
spuntarono, malgrado le cariche selvagge della polizia, 18 sono ancora
sotto processo. Tutto ciò malgrado la zona grigia dentro cui vive la
moltitudine di lavoratori che restarono a guardare.
Una quindicina di anni dopo, mentre ovunque impazza la crisi, qui si
ammazzano di straordinari. Si chiama straordinario comandato, lo
prevede il contratto per 5 sabati. Dino dice che c'è chi lavora pressoché
senza soste da 34 giorni. Domeniche escluse.
Dino Miniscalchi è Rsu della Fiom come Antonio Gravinese che indossa
una felpa rossa dei metalmeccanici della Cgil che gli serve per farsi
riconoscere sulle linee. Più tardi incontrerò un loro compagno, Giovanni
Barozzino, e un altro operaio, Cosimo Martino. Saranno loro a raccontare
le storie e i fatti di questa pagina. E parleranno con le voci dei loro
compagni di reparto.
Il sole a picco sulla piana mentre sciama il primo turno rende più acuta la
stanchezza. Sono le 13.30. Molti di loro si sono alzati dieci ore prima per
raggiungere un posto di lavoro lontano anche 150 chilometri. Altro che
metalmezzadri , come vorrebbe far credere la Fiat, non c'è tempo se non
per mangiare e dormire
La Sata non è mai sazia. Ora pretende l'orario plurisettimanale . L'orario
schizza a 48 ore settimanali per poi scendere a 32 in altri periodi. Così tra
le 40 ore di straordinario comandato e le 64 di orario plurisettimanale senza la maggiorazione dello straordinario - se ne vanno 13 giornate, un
quarto dei riposi annui. La fluttualità del mercato viene scaricata sui
lavoratori.
Sempre gli stessi gesti
Però, verrebbe da pensare, almeno qui la crisi non si sente. Sbagliato. Si
sente due volte. Intanto perché da ottobre alla prima settimana di
febbraio anche la Sata ha conosciuto la «vessazione salariale» della cassa
integrazione. Da 1300 euro di salario - se si fa il turno di notte - si
precipita a 900 euro. Poi il ritmo forsennato dello straordinario già
all'ultima settimana di febbraio ma con la perdita, ulteriore beffa, dei ratei
di ferie, premi e tredicesima.
Ma in tempo di crisi il padrone prova anche a riscrivere i rapporti di forza.
Anche dove il lavoro non sembra mancare. Alla Sata si traduce con carichi
di lavoro maggiorati. Ormai si lavora oltre il famigerato Tmc2 (Tempi dei
movimenti collegati-seconda versione) il modello cronotecnico per la
produzione di serie che ha seminato così tanti tunnel carpali e tendiniti per sfornare ogni vettura in un minuto e mezzo - che a Mirafiori è dovuto
intervenire un magistrato attento come Guariniello. Ora a Torino la nuova
metrica è studiata assieme ai medici del lavoro. A Melfi, invece, l'alta
frequenza e la ripetitività dei gesti sono infernali. L'azienda vuole sempre
più macchine senza fare un'assunzione. La saturazione media (la quantità
di minuto che diventa profitto) è schizzata dal 65% al 90%, spesso al
99%, per gran parte dei 5000 addetti, 300 dei quali in prestito da
Pomigliano, cui vanno sommati altri 400 dipendenti di una multinazionale
che fornisce i carrellisti. Solo 400 gli impiegati. Due lavoratori e mezzo
per ognuna delle 4500 macchine prodotte ogni giorno. Otto ore con una
sola pausa di 17 minuti per sfornare la Grande Punto che nessuno di loro
si potrà permettere. Infatti, nel parcheggio enorme non se ne vedono
esemplari. I lavoratori non possono comprare le merci che producono:
cos'altro è la crisi, se no?
Guerra a chi si fa male
Nel tritacarne della catena si riallocano operai che s'erano visti
riconoscere delle limitazioni dopo un infortunio o una malattia. L'azienda li
sottopone a revisione e li rispedisce al fronte. In prima linea di una guerra
di mercato drogata dagli incentivi, eco e non.
E in questa guerra la gente si fa male. I carrellisti sfrecciano negli spazi
angusti, i carrelli si scontrano, le macchine feriscono, deformano i corpi,
uccidono. L'anno passato è toccato a due persone. Gli infortuni sono stati
gravissimi ma molti sono occultati da una catena composta dal capo Ute
(l'unità tecnologica elementare), dal capo del capo Ute - il Gestore
operativo - dai medici interni finanche dal presidio dell'Inail che si gira
dall'altra parte. «Ma chi te lo fa fare a denunciare, magari ti prendi un po'
di ferie...». E per un'operaia la catena di comando finisce spesso con un
marito che fa propri i consigli dei capi. Fuori dalla fabbrica non va meglio.
L'ospedale di Melfi sembra una succursale della Fiat. Tribunale,
carabinieri, ispettori della Asl: la Sata sembra controllare tutto e tutti. Una
ragazza viene a lavorare con la stampella, le contestano i ritardi. Un'altra
ha un tumore e la pressano col mobbing. Il 20% di chi lavora alla Sata è
donna, la percentuale più alta del gruppo. Ma l'asilo nido di Mirafiori qui
se lo sognano.
Ecco che passa Cesira. E' un nome di fantasia, perché Cesira non parla
con la stampa. Non parla quasi nessuno, e in pochi si fanno vedere
accanto ai delegati Fiom. E' la zona grigia. Raccontano solo i delegati. Se
avesse potuto prendere parola Cesira avrebbe detto magari che lei
l'operaia non l'avrebbe voluta fare. Ma non è facile trovare altro da queste
parti. Quando il carrello la investe le frattura due costole, l'osso sacro, le
contorce la colonna vertebrale. Quella notte non riusciva a dormire per il
dolore. La mattina prova a tornare al lavoro. Ma è costretta a ricorrere
all'infermeria. Non ce la fa a camminare. La vorrebbero spedire in ferie
forzate. In ospedale scoprirà di aver sfiorato la morte per embolia
polmonare. La Sata le chiede di ritrattare. «Ti faremo fare quello che ti
pare». Cesira resiste. Non andrà in ferie ma sarà 4 mesi a casa per
infortunio. Ora non può stare molto tempo in piedi o seduta, mai più
nuoto né palestra. Da allora nel suo tempo libero c'è quasi solo
fisioterapia. L'azienda le dichiara guerra e la costringe a lavorare in
postazioni che le procureranno altri problemi fisici. La fa lavorare in punta
di piedi. Un'altra operazione, stavolta ai tendini. E quando non ce la fa più
il capetto la costringe a stare seduta in un angolo, la insulta. Saranno le
sue compagne a segnalarla alla Fiom.
La sicurezza non è un optional della Grande Punto. Nessuno forma gli
operai in prestito, si glissa sulla prevenzione, si truccano le fotocellule.
Vietato lamentarsi in Sata. I provvedimenti disciplinari sono ripresi alla
grande e rendono più leggere le buste paga. «Non hai voglia di fare
niente», si sente dire Cesira e tutti quelli che non ce la fanno a reggere i
ritmi. Molti sono depressi, qualcuno se ne va. Altri vengono minacciati di
essere tolti dal turno di notte, senza il quale la busta paga sarebbe ancora
più misera. «La crisi ci incatena alla fabbrica», dicono i lavoratori prima di
risalire sui pullman che li rispargono nel circondario tra Lucania, Puglia,
nord della Calabria. Qualcuno tira fuori un cuscinetto gonfiabile per
provare a dormire.
Una gabbia salariale
Si parla di soldi e di contratto. Qui a Melfi ancora non arriva la
quattordicesima. «Di fatto è una gabbia salariale». Grazie all'accordo
separato il premio di produzione è scaduto col vecchio contratto. Il conto
è in rosso: a luglio meno 1100 euro, meno i mancati aumenti.
«Quest'anno niente ferie». Piove sul bagnato. Il 60% delle tute amaranto
ha dovuto fare la cessione del quinto a un paio di finanziarie per pagare
mutui, rate o affitti che anche qui possono arrivare al 50% del salario.
«Alla terza settimana si chiede qualche soldo ai genitori pensionati».
Quattro anni dopo le ragioni che scatenarono i 21 giorni sono di nuovo
sotto sul tappeto. Il clima è lo stesso di allora. Intanto sono arrivati lo
scippo del Tfr, l'accordo del 23 luglio, gli accordi separati, l'attacco al
contratto, la crisi globale. «La solitudine dell'operaio è evidente, così come
la sua delusione». Il giornale accatastato non racconta queste storie. Lo fa
Liberazione che oggi sarà distribuita in migliaia di copie ai cancelli di Melfi.
26/05/2009