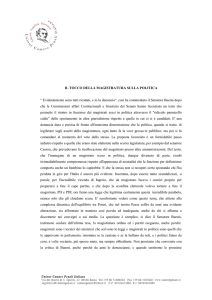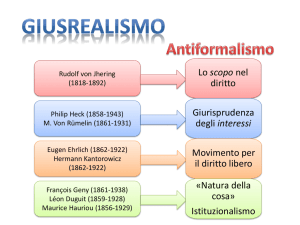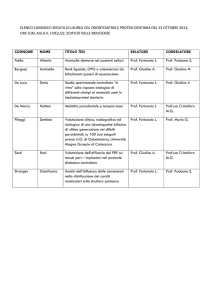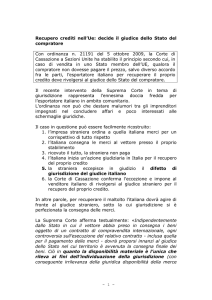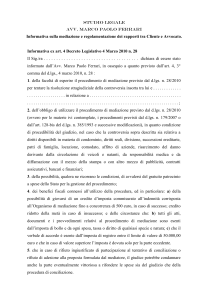LA CATTEDRA
di STORIA in network
Lezione del prof. PAOLO M. DI STEFANO
docente di marketing nell'Università
per stranieri di Perugia
PRINCIPI DELL'AMMINISTRAZIONE
DELLA GIUSTIZIA IN ROMA ANTICA
ED APPLICABILITA' NEL MONDO MODERNO
Sono trascorsi quarant'anni dalla stesura di questo saggio - un intervento al Centro
Magistrati Luigi Severini di Perugia. Sono passati quaranta anni e l'estensore, allora
assistente alla cattedra di Diritto romano e, sopra tutto, giovane e tanto entusiasta ed
ottimista da credere persino alle possibilità di una carriera universitaria basata soltanto su
di un giudizio di eccellenza (e non legata a poteri ed interessi diversi da quelli della cultura
e della società) ha trascorso una vita ad occuparsi di cose diverse, direttamente connesse
con la realtà economica e la gestione degli scambi. Sempre, però, animato dallo stesso
entusiasmo, dallo stesso ottimismo e, perché no?, dalla stessa ingenua speranza che la
così detta società civile riuscisse ad esprimere "magistrati" che contribuissero al suo
miglioramento e, attraverso questo, al miglioramento della vita dei singoli componenti. E
l'aver riletto questo lavoro riscoprendo in esso più di un motivo di attualità, mentre da un
lato
è
stato
ragione
d'orgoglio,
dall'altro
lo
è
stato
di
amarezza.
D'orgoglio, perché mi sembra d'aver correttamente individuato, allora, questioni che sono
tutt'oggi al centro dell'attenzione; di amarezza, poiché molto poco mi sembra cambiato, e,
quel poco, in peggio. Il che conferma la mia sensazione che la Storia non insegni nulla.
Società e Stato sembrano continuare a procedere lungo vie conflittuali, e gli interessi
privati sembrano sempre di più orientati ad affermare strapotere nei confronti di quelli
pubblici. O meglio (forse): a considerare le strutture dello Stato e in particolare la
Magistratura come strumenti per il raggiungimento di obiettivi particolari e la tutela e la
affermazione di interessi di parte, in conflitto con quelli della comunità di riferimento. A me
pare evidente che bisognerebbe, forse, rivedere l'atteggiamento di molti nei confronti dello
Stato il quale, oggi, non è e non può essere visto come un competitore, un estraneo dal
quale occorre difendersi, ma al quale bisogna guardare come al tutore degli interessi di
una società i cui membri delegano la definizione dei bisogni pubblici e il potere della
gestione
della
cosa
pubblica
per
la
loro
soddisfazione
migliore.
E far questo è possibile, a condizione che si rivedano le linee programmatiche di una
formazione - scolastica e non - la quale dovrebbe occuparsi anche (se non in primo luogo)
di istillare nei discenti quel "senso dello Stato" che sembra perduto. Senso dello Stato che
deve essere prioritario, anche rendendo consapevoli gli individui di una loro funzione
primaria all'interno della società: quella di essere essi stessi costruttori di una società
migliore, di una migliore qualità di vita. Che non passa necessariamente - questa migliore
qualità di vita - attraverso l'arricchimento individuale perseguito e raggiunto con ogni
mezzo. Arricchimento che comprende anche, ovviamente, la conquista del potere. Ed è il
guardare al potere come strumento per difendere ed ampliare la propria ricchezza che,
forse, è alla radice dei problemi, in una con la scarsa o nulla consapevolezza della
funzione sociale non tanto e non solo dello Stato, ma anche e sopra tutto dell'individuo.
Perché le linee dell'evoluzione sono senza dubbio le seguenti: l'individuo genera la società
e
questa
dà
vita
allo
Stato.
E lo Stato non è che l'espressione dell'organizzarsi della società "civile" con l'unico scopo
di soddisfare bisogni "pubblici" dei quali la società è portatrice nella sua qualità di soggetto
diverso dai singoli individui che la compongono ma, anche, di soggetto che non può che
esprimersi attraverso le attività dei suoi componenti. E tra i bisogni definiti come "pubblici"
da soddisfare e tra gli interessi "pubblici" da tutelare un posto di tutto rilievo ha, o
dovrebbe avere, l'amministrazione della giustizia. Oggi come ai tempi dei nostri Padri
Romani. Amministrare la giustizia è sempre stata una prerogativa del potere: voglio dire
che, essendo questa attività in sé un potere, chi la detiene è anche titolare di una Potestas
che in qualche modo lo pone al di sopra degli altri, lo distacca dai suoi simili, lo veste
maestà. E cosa altro è la toga, cosa altro il tocco se non un "manto regale"? La
consapevolezza di questa "superiore condizione" ha contribuito a quel distacco del giudice
dalla società civile che lamentavo nel saggio in esame e che nel 1963 appariva uno dei
problemi
più
gravi
della
magistratura
e
del
magistrato
italiano.
Io ho conosciuto giudici che si negavano persino una passeggiata o una cena con
amici e conoscenti, per non correre il rischio di dovere, un giorno, giudicare un amico e
dunque di risolvere quello che è, forse, il maggiore dei conflitti intrapersonali. Ed era,
allora, anche proibito ad un magistrato di occuparsi di politica, sotto qualsiasi forma.
Pensavo, a quel tempo - e tutt'ora lo penso - che il magistrato dovesse riavvicinarsi alla
vita quotidiana armato di tutta la sua preparazione giuridica e morale: il giudizio sarebbe
stato, così, più affidabile. Oggi, a quaranta anni da allora, il problema è forse inverso: il
magistrato (alcuni, probabilmente troppi) è talmente inserito nella vita quotidiana da aver
perduto tutta la "maestà del giudice", gran parte del rispetto della società civile, buona
parte
della
"terzietà"
che
dovrebbe
distinguerlo.
E, almeno a giudicare da certe sentenze e dalle opinioni di buona parte di coloro che
hanno avuto a che fare con la Giustizia, oggi è anche precaria la preparazione giuridica
non soltanto di quanti (e sono troppi!) possono essere definiti "giudici per caso", ma anche
di più di qualcuno dei "giudici togati". Come per tutte le cose, è una questione di misura e,
forse, di consapevolezza: terzietà e imparzialità non significano distanza tale da provocare
l'ignoranza delle situazioni che la vita quotidiana crea e presenta, bensì utilizzare i
parametri di giudizio di cui si dispone in modo quanto più possibile oggettivo, consapevole
degli effetti che ogni sentenza provoca, e non solo tra le parti. E i Padri Romani hanno
qualcosa
da
insegnarci.
Ancora
oggi.
2.
E
questo
è
il
saggio.
"Tutto il diritto di Roma, lungo l'intero arco della sua secolare evoluzione, è caratterizzato
da una costante aderenza alla vita della società, ai rapporti tra i singoli individui ed anche
quando accadimenti di ordine politico - nonché l'ineluttabile processo storico - portarono
all'accentramento nello Stato di tutti i poteri e di tutte le funzioni, a ben guardare non
altro fece lo Stato se non recepire interamente principi nati nel rapporto sociale e cosi
intimamente legati ad esso da assurgere a valore generale; principi elaborati e adattati
alle mutate esigenze, ma riconoscibilissimi ed evidentissimi nella loro origine.
Una origine, a mio parere, di carattere strettamente processuale, poiché la più probabile
scaturigine del diritto deve ricercarsi nella risoluzione pacifica della prima controversia: il
primo arbitro chiamato a giudicare pose la prima norma di legge, destinata a valere non
soltanto tra i due litiganti, ma - ed è qui la particolare importanza del fenomeno - a porsi
come
precedente
di
carattere
generale
e
di
generale
portata.
Non solo, ma fin dal suo apparire, il primo giudice fu ammantato di una dignità
sacerdotale, in parte dovuta alla sua particolare posizione nella comunità - di solito era il
Re ad amministrare la Giustizia - in parte scaturente da un che di mistico che
inconsciamente accompagna qualsiasi azione che si rivolga al giudizio su comportamenti
umani e che miri a fini più alti che non quelli di dar torto o ragione.
Poiché non è da dimenticare che nel momento stesso in cui un giudice dirime una
controversia, nasce la consapevolezza della necessità di una soluzione arbitrale per la vita
attuale e gli sviluppi futuri dell'aggregato sociale: in vista di interessi, cioè, che
trascendono quelli del singolo o dei singoli individui per divenire interessi della società.
Ed è questa consapevolezza che giustifica la religiosità che permea intimamente la
funzione giurisdizionale: una religiosità che si esprime attraverso il formalismo che ha
sempre caratterizzato l'azione del giudice e le strane concordanze che esistono tra questo
ed il Sacerdote; una religiosità che si esprime sopra tutto attraverso il Timor Reverentialis
che ha circondato e circonda la figura del giudice, sia esso espressione di un ordinamento
statuale,
sia
esso
il
giudice
privato.
Non a caso, nel diritto più antico di Roma, la preparazione delle actiones spettava
al collegio pontificale; e non a caso le prime tre delle Dodici Tavole contenevano norme
procedurali di carattere civilistico ed una, la tavola IX, si riferiva al processo penale:
riprova della prevalenza delle caratteristiche religiose su quante altre avrebbero potuto
influenzare l'amministrazione della Giustizia e della importanza che fu sempre attribuita a
questa attività destinata, con l'evolversi dei tempi, a divenire funzione dello Stato.
Poiché in questo senso è indirizzata tutta a storia dell'amministrazione della Giustizia.
Dal periodo primitivo, in cui lo Stato non si ingeriva se non episodicamente attraverso
l'attività del Re-Arbitro e l'amministrazione della giustizia rimaneva un fatto del tutto
privato, si assiste man mano alla progressiva ingerenza dello Stato in questa attività, e, a
ben guardare, il fenomeno non deve apparire singolare : è logico che man mano che lo
Stato sorge e si rafforza e si pone come un aliud rispetto alla compagine sociale, avoca a
sì tutti i mezzi e tutte le funzioni che siano in grado di assicurargli la possibilità di imporre
la propria volontà ai cittadini, e non è chi non veda come, più che la forza delle armi, è la
forza
dell'amministrazione
della
giustizia
che
impone
le
leggi.
E' una forza che agisce capillarmente in ogni angolo del vivere civile e della vita
quotidiana; agisce sul piano della più stretta aderenza alle necessità pratiche di ogni
giorno e di ogni individuo; agisce, nella maggioranza dei casi, con la forza della
persuasione e non disdegna di servirsi, talvolta, della ignoranza e della superstizione della
gente
comune.
Tutto questo alle armi è negato. Quale stupore, dunque, se lo Stato, crescendo e
rafforzandosi, chiama a sé con insistenza il diritto di amministrare giustizia, cioè di
interpretare in pratica le sue leggi e di farle osservare? Anche oggi, nel nostro mondo
moderno, si assiste al fenomeno secondo il quale ogni nuovo ordinamento Statale, ogni
capovolgimento di regime, ogni concezione politica cerca innanzi tutto di procacciarsi
l'appoggio della Magistratura, attraverso mezzi che possono esser più o meno leciti, più o
meno morali ma sulla necessità dei quali per la vita stessa della nuova concezione non c'è
a
mio
parere
discussione.
Ed ecco anche il perché di solito lungo l'arco di storia della funzione giurisdizionale
si scorge un progressivo inasprimento di bardature e di sovrastrutture, destinate
formalmente a garantire una migliore amministrazione della giustizia (e in parte la
garantiscono), ma più probabilmente destinate a garantire una amministrazione più
aderente alle attuali esigenze politiche dello Stato e, in nome di questo, della parte
dominante
della
Società.
II che in linea di principio può esser discutibile e discusso quanto si vuole, ma è
ineluttabile in pratica in quel continuo pulsare ed altalenare che permea la vita delle
società; quello che può al più notarsi è che man mano che le bardature e le sovrastrutture
si moltiplicano, man mano che lo Stato s'ingerisce nell'amministrazione della giustizia, man
mano che la procedura si complica, la saldezza della società si allenta.
Non si può certamente affermare l'esistenza di un rapporto di causa ad effetto, ma è certo
che, osservando anche soltanto di sfuggita la storia del diritto di Roma, non può non
saltar subito agli occhi la concomitanza del progressivo complicarsi della procedura, con la
progressiva ingerenza statale e la decadenza della struttura sociale: le legis actiones, le
formulae e la extraordinaria cognitio segnano rispettivamente il trionfo di una cosiddetta
giustizia privata, la prima ingerenza dello Stato nell'amministrazione della Giustizia, la
definitiva avocazione di questa da parte dello Stato e, rispettivamente, il crescere di un
diritto primitivo verso gli splendori dell'età classica fino alla vecchiaia del periodo postclassico. Ed appare singolare che proprio nella extraordinaria cognitio si debbano ricercare
le basi della magistratura italiana moderna e del suo ordinamento: ancor più singolare
appare quando si pensi che da anni, ad ogni piè sospinto, si parla di crisi
dell'amministrazione della giustizia e dell'ordinamento giudiziario, e non ci si rende conto
che la crisi è dovuta alla concomitanza di una crisi che agita tutto il mondo della cultura e
del diritto e che si esprime, nell'amministrazione della giustizia, attraverso un ordinamento
che, per ragioni diverse, risale proprio a quello che si espresse come segno della definitiva
decadenza
di
un
popolo
e
di
un
diritto
che
erano
stati
grandi.
La crisi dell'amministrazione della giustizia non si risolve, a mio parere, adattando
il sistema vigente, ma modificandolo dalle fondamenta, poiché si tratta di un sistema nato
vecchio ed incapace, per impossibilità costituzionale, di mettersi al passo con i tempi e con
le
mutate
esigenze
della
società.
La quale, oggi, richiede snellezza di forme e celerità di soluzioni: se necessario, anche
capacità di esser superficiali, ma di quella superficialità innocua - a volte proficua - che
permette alla quotidiana fatica di non arenarsi nel sesso degli angeli o nella lana caprina.
Ed occorre, per modificare il sistema, innanzitutto liberare l'ordinamento per quanto è
possibile dalla ingerenza statale, restituendolo per quanto si possa al seno stesso della
società.
Poiché Stato e società - oggi come ai primordi - sono tra loro nettamente distinti, e non
sempre gli interessi di quello coincidono con gli interessi di questa, è da chiedersi se per
caso l'amministrazione della giustizia non sia più un interesse della società che dello Stato
e se, optandosi per la prima soluzione, non si debba conseguenzialmente togliere allo
Stato almeno in parte la sua ingerenza sulla Giurisdizione, pur riconoscendogli il diritto ad
un
controllo
anche
profondo.
A mio parere, l'interesse all'amministrazione della giustizia è prima di tutto un interesse
sociale, poi statale: non dimentichiamo che l'amministrare giustizia è una attività più
antica che porre le leggi, e che le leggi, in gran parte, scaturiscono proprio dalla soluzione
di controversie; e non dimentichiamo, sopra tutto, che è lo Stato ad esser configurato
nell'interesse
della
Società,
e
non
questa
nell'interesse
di
quello.
È perciò la società che deve avere fiducia nei suoi giudici prima dello Stato; è nella società
che la norma è destinata ad operare, cosi come lo è la sentenza, e non sempre una
sentenza giusta in linea di diritto lo è anche per la coscienza sociale.
Occorre perciò porre il giudice nella condizione di creare esso stesso il diritto, di opporsi,
se necessario, alla applicazione di norme poste nell'interesse dello Stato e non in quello
della società: fare della Magistratura un potere a sé ma a sé nel senso più completo della
espressione: una sorta di potere sovrano, anche nei confronti dello Stato.
Non si creda impossibile: qualcosa di simile è già esistito ed ha dato ottima prova
di sé: il procedimento per formulas aveva raggiunto un equilibrio, tra esigenze pubbliche
ed esigenze private, che aveva del meraviglioso e che rispondeva appieno alle istanze
della
società,
senza
sacrificare
granché
quelle
statali.
Il processo di evoluzione è senza praticamente soluzione di continuità: fin dai primordi, in
Roma, fondamento della difesa del diritto è l'atto di parte, di difesa privata, la cui
regolamentazione è da ricercarsi nel costume in base a riti rigorosamente fissati.
L'attuazione di esso non richiede l'ingerenza della pubblica autorità, la quale rimane in
linea di principio estranea a questa sfera di rapporti, fino al momento in cui la competenza
esclusiva a rendere giustizia venne assunta dal Praetor Urbanus, magistrato giusdicente.
La presenza di un Magistrato, di un cittadino in quella particolare relazione con la Res
Publica che è costituita dal ricoprire una Magistratura non si tradusse ancora, però,
nell'amministrazione della Giustizia da parte statale: la civitas si limita ancora, in linea di
massima, nell'imporre il ricorso all'arbitro e nel sorvegliare l'esatta impostazione della
controversia,
Le actiones venivano date esclusivamente dal collegio dei pontefici, e, una volta scelto
l'arbitro, questi ricercava la verità in piena libertà di forme e di vincoli, tranne quello della
rispondenza di quanto affermato dalle parti dinanzi al pretore con quanto i fatti da lui
esaminati
gli
suggerivano.
Come si nota, siamo già ad un processo diviso in due stadi: il primo, in iure, nel quale si
fissano dinanzi ad un Magistrato i termini della controversia; il secondo, apud iudicem, nel
quale si ricerca la verità e si applica il diritto secondo le indicazioni dettate dal Magistrato.
È interessante notare come la divisione in due stadi del procedimento - divisione che,
come vedremo, rimane immutata in un successivo periodo (processo formulare) - non sia
appannaggio esclusivo del diritto romano, ma esistesse anche presso altri popoli.
Non solo, ma è anche da notare che con notevole probabilità tale divisione scaturisse
spontanea, il ché dovrebbe indurre a far pensare se per caso essa non rispondesse ad una
esigenza
innata,
di
carattere
naturale
ed
irrinunciabile.
Ma
su
questo,
più
avanti.
Sui singoli procedimenti delle legis actiones non mi pare sia il caso di soffermarsi:
basterà ricordare che con notevole probabilità i più antichi erano la manus iniectio e la
pignoris capio; il più complesso e tortuoso, la legis actio sacramento; quello previsto per le
controversie che non potevano esser decise con un sì o con un no, la legis actio per iudicis
arbitrive postulationem ; infine, la legis actio per conditionem, il procedimento meno
solenne.
È da mettersi ancora in evidenza come in questo periodo, dopo il 367 a. Cr. N., compaiono
i primi giudizi emessi dal pretore extra ordinem, senza rinviare la questione dinanzi al
giudice.
Tra il 146 e il 126 a. Cr. N. fu rogata la legge Aebutia, che introduce la cosiddetta
procedura
per
formulas.
Eccone le basi generali: nello stadio in iure il Magistrato, che si limitava in antico ad udire
le pretese delle parti ed a cercare di elidere la controversia, oltre che a nominare un
giudice, anche adesso dà un giudice ma, in più, redige per questo una istruzione scritta
nella quale espone succintamente il fatto ed il diritto e con la quale comanda al giudice di
condannare il convenuto o di assolverlo, a seconda della rispondenza a verità o meno di
quanto
affermato
dall'attore.
Un Magistrato (in senso romano naturalmente), quindi, nello stadio in iure; un privato
cittadino nello stadio apud iudicem, e tale giudice poteva esser costituito o da un collegio
stabile di cittadini (centunviri), oppure scelto d'accordo dalle parti tra privati cittadini,
oppure ancora nominato dal magistrato, sempre tra privati cittadini, qualora le parti non si
fossero
trovate
d'accordo.
È su questa nomina del giudice che interessa soffermarsi un attimo: che cosa significa
nella economia della vita del diritto e della vita sociale? Con tale sistema si era a mio
avviso raggiunto il duplice effetto di garantire e rivestire il giudizio con la maestà della Res
Pubblica - maestà profondamente sentita dai romani nel suo aspetto politico cosi come nel
suo aspetto religioso - e, ad un tempo stesso, conservare nella comunità la
consapevolezza che il giudizio scaturiva dalla comunità stessa, e che altro non era se non
un
momento
della
sua
stessa
vita.
I cittadini si presentano di fronte ad un Magistrato, ad un cittadino, cioè, che si
trova con la Res Pubblica in quella particolare relazione che gli permette di esprimersi, di
agire, come se egli stesso fosse lo Stato (il Pretore era infatti dotato di Imperium, potere
di estensione e qualità superiore alla Potestas di cui erano invece forniti gli altri magistrati,
e che si sostanzia appunto nella facoltà di "essere" la Res Pubblica), e gli si presentano
perché questi, in questa sua qualità ed in quanto particolarmente versato in questioni di
diritto, esamini in via preliminare il conflitto di interessi che li divide, e delimiti la
controversia nell'ambito dell'ordinamento, le dia un nome, la fissi entro limiti
giuridicamente
comprensibili.
Ma il Magistrato non fa giustizia: trasforma i fatti in un vincolo contrattuale, impegnando
le
parti
a
non
modificare
quanto
affermato
dinanzi
a
lui.
Questo e non altro è l'humus della formula di nomina del giudice e di rinvio a lui della
controversia: sancire con la maestà della Res Pubblica un preciso impegno delle parti,
impegno necessario perché il giudice possa esattamente sapere entro quale ambito
operare e necessario anche per una più spedita risoluzione della controversia.
L'amministrare giustizia nel senso pratico del termine è riservato invece a persona di cui le
parti abbiano piena fiducia, di solito da ambedue conosciuta, scelta in genere dalle parti
stesse, alla quale il Magistrato comanda di attivarsi assolvendo o condannando a seconda
che
le
cose
stiano
in
un
modo
o
nell'altro.
Il magistrato, cioè, rende edotto del diritto il giudice (e non si dimentichi che spesso il
diritto è fatto dallo stesso Magistrato) riguardo a quella particolare controversia, ma se sia
vero quanto dall'attore affermato o se, invece, sia il convenuto ad affermare la verità o,
nella eventualità, in quale misura sia l'uno che l'altro affermano il vero, è un esame che
sfugge
al
Magistrato,
per
essere
affidato
al
Giudice.
La efficacia psicologica di questo sistema mi sembra di portata incalcolabile, certo non
inferiore alla sua portata politica, e torna a riprova di quanto poco sopra accennato, e cioè
che non sempre c'è coincidenza tra interessi Statali ed interessi della società, tanto è vero
che il Magistrato fa la legge, spesso in contrasto con l'ordinamento statale: e la fa tanto
che lo jus onorarium si pone come altro lato della medaglia del diritto di Roma.
Ma si accennava alla efficacia psicologica del sistema della procedura formulare: le
parti sono esse stesse che consapevolmente collaborano alla amministrazione della
Giustizia, attraverso la collaborazione offerta alla formazione della decisione proprio
attraverso
la
scelta
della
persona
che
dovrà
decidere.
La quale non è vincolata da altro che dalla applicazione di quanto stabilito nella formula:
per il resto, può esaminare i fatti come meglio crede e giovandosi di tutti i mezzi che
possano esserle utili; inoltre, giudica ed esamina non con la mentalità del giurista, ma con
la mente dell'uomo della strada, totalmente immerso nella vita di ogni giorno, con tutti i
suoi problemi e con tutte le mille piccole astuzie che alla risoluzione di quei problemi
concorrono.
Le parti sanno che saranno giudicate da uno come loro, con i loro stessi pensieri,
problemi, desideri: e questo basta da solo a far si che il verdetto venga accettato e quasi
mai discusso dalle parti così come dalla comunità. Anche perché le parti sanno che il
giudice potrà avvalersi di tutti i mezzi per raccogliere le prove necessarie: in questo
periodo, infatti (siamo nell'epoca classica) non esistono limitazioni di sorta circa
l'assunzione delle prove: limitazioni sorgeranno solo con Giustiniano, quasi a riprova che la
progressiva ingerenza statale ed il definitivo «pubblicizzarsi» dei giudici hanno bisogno di
bardature più rigide e più schematiche, man mano che i rapporti stretti con il popolo, con
la
comunità,
si
vanno
diradando.
Si pensi, in fatto di prove, alle presunzioni: il diritto classico non conosceva se non le
cosiddette praesumptiones hominis, ammesse liberamente dal giudice: solo in epoca
giustinianea compaiono le presunzioni iuris tantum e iuris et de iure, anch'esse inquadrate
in quel sistema di sovrastrutture che necessariamente accompagna e sorregge qualsiasi
istituzione
che
si
snaturalizzi
per
astrarsi
e
scientificizzarsi.
Il giudice esaminava la controversia e giudicava entro i limiti, quindi, della formula, nella
quale, dopo l'intentio e in forma di condizioni negative che escludevano la condanna,
venivano inserite le eccezioni: esse dovevano essere proposte in iure.
L'actio iudicati in linea di massima assicurava la procedura esecutiva attraverso la
esecuzione diretta sulla persona del debitore, provata la validità del giudicato.
La sentenza era dunque il portato di una collaborazione tra un organo pubblico e la
comunità, nella quale la comunità stessa aveva, a ben guardare, una parte
preponderante: il Magistrato era già di per sé, infatti, espressione piena della volontà della
società, la quale lo aveva liberamente eletto e dalla quale scaturiva la potestas o
l'imperium che ne costituivano l'essenza ed il fondamento di potere.
Ed accanto al Magistrato, che della comunità godeva la fiducia e che ad essa, in ultima
analisi, rispondeva, il Giudice, ancor più vicino alla società ed ancor più legato alla sua vita
ed alle sue esigenze, non solo, ma in quel particolare rapporto con le parti e con il
magistrato che scaturisce dalla scelta fatta da quelli e da questo sanzionata: una duplice
manifestazione di fiducia verso una persona che evidentemente godeva già di particolare
prestigio non solo nei confronti delle parti, ma di tutta la comunità.
Il tutto, confortato da un sistema, impropriamente chiamato legislativo, che affondava le
sue radici direttamente nel cuore della società, che scaturiva caso per caso, direi caso
dopo caso, in una continua evoluzione per meglio aderire alle nuove esigenze, sempre
pressanti e pressantemente crescenti, senza che, per questo, i principi fondamentali di
diritto - che coincidono poi con i principi fondamentali di morale e di religione - ne
venissero
in
qualche
modo
snaturati.
Né è a credersi che il sistema formulare fosse possibile sopra tutto perché vivente in una
piccola comunità: nella epoca classica Roma era tutt'altro che una piccola comunità e,
d'altronde, il carattere personale del diritto romano non teneva affatto conto di estensioni
territoriali.
Di più, lo sviluppo economico ed i traffici creavano sempre nuovi problemi, esattamente
come accade nel nostro mondo moderno: direi, anzi, che Roma era in quel periodo una
comunità stranamente simile alla nostra attuale, con in più l'eventuale problema della
lentezza
delle
comunicazioni.
Certo, il procedimento formulare, introdotto con la lex Aebutia (146 a. Cr. N. ?)
era destinato a cedere alla extraordinaria cognitio, ma ne abbiamo già accennate le
ragioni: non tanto una insufficienza del sistema, quanto sopra tutto la tendenza generale
della politica economica e sociale di Roma di accentrarsi in un'unica persona, in un unico
punto
a
cui
sempre
ed
in
qualsiasi
circostanza
far
riferimento.
Una tendenza direi fatale in ogni popolo in decadenza, poiché soltanto quando decadono i
valori morali, religiosi, culturali si avverte la necessità di un qualcosa o qualcuno che dia
l'illusione di un legame, di una coesione: ci si rifugia in questo come in un'ultima
possibilità.
E la storia insegna che proprio di un'ultima possibilità si tratta, poiché dopo
l'accentramento infallibilmente giunge la disgregazione, la distruzione di una società per
far posto ad una nuova forma di associazione la quale inizia ex novo il suo processo di
evoluzione
e
di
decadenza.
E che la difesa dei diritti sia la prima a risentire di ogni politica e di ogni decadenza, è, in
fondo,
ovvio.
Qualunque aspirante dittatore, o qualunque Stato accentratore ed illiberale, cerca
innanzitutto di assicurarsi il controllo della applicazione della legge e dell'amministrazione
della giustizia, consapevole com'è che amministrare giustizia significa in realtà legiferare
ad ogni momento, e con molta maggiore efficacia che non attraverso la normazione
generale.
Ciò accadde anche in Roma: la progressiva decadenza dell'epoca classica nell'epoca
imperiale - che si tradusse, nell'ordinamento statale, nel progressivo scivolamento verso
l'assolutismo - si annunziava attraverso il prendere vigore della extraordinaria cognitio ed
il
complicarsi
delle
bardature
procedurali.
La funzione giurisdizionale andò irrimediabilmente allontanandosi dalla sua fonte prima: la
società e la sua vita videro progressivamente una parte di sè proiettarsi in una sfera
diversa, sempre più lontana e sempre più fredda: non più alla comunità serviva
l'amministrazione della giustizia, ma al principe o, quanto meno, a quella parte della
comunità che si presentava, in quel dato momento storico, come dominante.
L'essere, infatti, esclusivamente dei magistrati pubblici che conducevano il
processo nella extraordinaria cognitio, significava anche e sopra tutto che ad amministrare
giustizia era quella parte della compagine sociale che poteva annoverare magistrati nel
suo seno: in parole povere, la parte al potere, essendo ormai pressoché sparita la elezione
dei magistrati o, dove ancora rimaneva, essendo essa ridotta ad una mera formalità.
La consapevolezza di questo fenomeno non poteva certamente giovare ai rapporti tra la
società e la funzione giurisdizionale ed i suoi rappresentanti: il progressivo allontanarsi di
costoro dalla vita quotidiana, la non rara consapevolezza di un totale asservimento ad
interessi distinti da quelli della giustizia, il timor reverentialis che in ogni epoca e presso
ogni popolo circonda sempre gli uomini che hanno in mano una leva del potere, non
potevano che portare ad un regime di "separazione", non di rado prossimo alla sfiducia.
Per questo si accennava più sopra che una delle cause, e forse la principale, della
lamentata crisi dell'ordinamento giudiziario in Italia è proprio da ricercarsi nell'essere,
l'attuale, un ordinamento nato vecchio, poiché recepito da un periodo di piena e totale
decadenza.
Non a caso le prime applicazioni della cognitio extra ordinem in periodo repubblicano
erano state di tipo amministrativo, cioè di quel particolare tipo che caratterizza la più vasta
e la più caotica delle «funzioni" dello Stato moderno; e non a caso la cognitio extra
ordinem trionfò con l'adozione del principio che contro la sentenza di qualsiasi giudice si
potesse appellare al principe: non si dimentichi che con il principato, da Augusto in poi,
non è più il populus ad esser sovrano, se non formalmente, ma il Princeps, a cui fa ormai
capo
ogni
massima
dignità
civile
e
religiosa,
ed
ogni
potere.
Nel princeps come persona e, di riflesso, nella categoria sociale che il principe
rappresentava ed i cui interessi l'imperatore impersonava, anche se la struttura del diritto
privato non viene toccata che in minima parte, si snatura proprio quella amministrazione
della giustizia che, a ben guardare, è l'unica, vera garanzia a tutela dei cittadini e della
società e che ora diviene appannaggio pressoché esclusivo della classe dominante la quale
coincide - ed in linea di massima continua a coincidere - con la categoria sociale più ricca
e,
perché
più
ricca,
più
colta.
È forse in quest'epoca da ricercarsi la diffusa sfiducia che ancor oggi permane in
parte nei confronti della giustizia: una sfiducia non sempre chiaramente espressa, ma sul.
piano della vita quotidiana avvertibilissima sopra tutto nelle classi meno abbienti.
È bensì vero che si tratta, almeno in Italia ed almeno finora, di una sfiducia non sempre
giustificata, ma il fenomeno della sua esistenza, incontrovertibile, non è da sottovalutarsi.
Direi che tale sfiducia si manifesta per ora con una sorta di fatalismo e di diffuso timore,
accentuato anche dalla circostanza che oggi il Giudice vive un po' ai margini della vita
quotidiana della società, non sempre è inserito in essa, in un distacco che la società
avverte e che l'uomo della strada è portato ad identificare con il deposito e la tutela di
privilegi.
Che tale stato d'animo abbia origini lontane mi sembra anche dimostrato dalla circostanza
che esso investe, per lo più, proprio il campo della procedura civile: nel settore del diritto
penale, infatti, in Roma ebbe luogo una evoluzione diversa, sopra tutto perché, seppure il
giudizio scaturiva in origine pur sempre dal seno stesso della società, fu sempre un organo
pubblico
ad
amministrare
giustizia
punendo
i
crimini,
Di fronte al criminale, la società si è sempre posta in difesa attraverso organi organizzati
esclusivamente a quel fine, cominciando dal comizio e finendo ai singoli tribunali,
Quaestiones, competenti volta a volta a giudicare di questo o quel crimine.
Inoltre, soltanto in epoca storica la comunità cedette alla Res Pubblica e quindi allo Stato
la competenza a giudicare di delitti non contro lo Stato stesso, ma contro la persona o il
patrimonio, particolarmente aberranti: parricidio ed omicidio, ad esempio, i cui giudizi,
anche quando lo Stato non interveniva, avevano carattere pubblicistico scaturente dalla
natura stessa della familia romana e del gruppo sociale primigenio, la cui corrispondenza a
veri e propri Stati è stata più volte e da più autorevoli voci messa in evidenza.
Non a caso la diversificazione del diritto penale pubblico da quello privato prese il via dalla
necessità di reprimere le concussioni dei Magistrati provinciali: segno evidente che,
perdutasi in gran parte la pubblicità della familia, si avvertiva la necessità di tutelare la
integrità
di
quel
quid
che
alla
familia
man
mano
si
sostituiva.
Tale concezione si fece strada senza scosse notevoli, e non reputerei azzardato
affermare che la maggior cedevolezza della società come "privato" di fronte allo Stato in
tale settore è dovuta alla minore evidenza o, a volte, alla assenza di danni meramente
patrimoniali: quanto meno, alla minore capacità del privato di avvertire il danno
patrimoniale. Anche oggi, noi non discutiamo nello Stato il diritto di tutelare la nostra vita
e la nostra integrità fisica e morale, ma siamo più cauti e meno fiduciosi quando ci
appelliamo.
ad
esso
perché
tuteli
il
nostro
patrimonio.
Sulla complessa evoluzione del diritto e della procedura penale in Roma, non è questa la
sede più adatta per dilungarci : basti solo notare che dalle quaestiones augustee si passa
in epoca imperiale al trionfo del principio inquisitorio sul principio accusatorio, segno
anche questo di un definito orientamento di ingerenza statale e di avocazione da parte
dello Stato di quanto potesse essere utile alla sua integrità ed al mantenimento dell'ordine
costituito.
Ma, così procedendo, lo Stato si è posto come un aliud di fronte alla società, e, in epoca
moderna, se ne risentono gli effetti non sempre positivi proprio nel settore che all'uno ed
all'altra
sta
maggiormente
a
cuore:
l'amministrazione
della
Giustizia.
In che senso si parla, in Italia, di "Crisi dell'amministrazione della Giustizia e
dell'ordinamento giudiziario"? A mio parere, il senso della espressione acquista valore
quando si intenda tale crisi innanzitutto come non rispondenza della organizzazione
giudiziaria e della amministrazione della giustizia alle esigenze della società.
Tale irrispondenza viene determinata da molteplici fattori, dei quali non possiamo in
questa sede che accennarne alcuni, ed indicare ove possibile i rimedi, attingendo proprio
al
diritto
di
Roma,
unico
nostro
vero
patrimonio
culturale.
Ad un fattore abbiamo già accennato: la frattura che si è creata tra Stato e Comunità
Sociale, e la diffusa opinione che la Magistratura oggi in Italia sia depositaria di privilegi e
tutrice
di
interessi
di
parte.
A parte l'indagine sulla veridicità o meno di tale opinione - indagine che ci porterebbe
troppo lontano e comunque richiederebbe ben altro tempo e ben altri mezzi - a me
interessa notare che tale opinione esiste, e che la sua sola esistenza basta a creare nel
popolo minuto (di cui la società è fatta) sfiducia, e quindi a determinare crisi di un
ordinamento.
È possibile ovviare a tale fenomeno? La risposta è a mio avviso di carattere positivo: il
fenomeno può essere ovviato - ed il discorso è chiaramente sul piano de iure condendo ricreando nella società la consapevolezza che l'amministrazione della giustizia scaturisce
dal suo intimo ed in vista di sé e dei suoi interessi e della sua vita, e per ottenere ciò il
diritto di Roma ci mostra chiaramente la strada, anzi, le due strade che devono esser
percorse
contemporaneamente
per
raggiungere
un
unico
risultato.
Restituire almeno in parte alla Magistratura il carattere privato: ciò può ottenersi in modi
diversi e per diverse strade, ma l'importante è che la comunità abbia l'impressione che la
giustizia venga amministrata da uomini della comunità, e non dello Stato; poi, svincolare
al massimo la Magistratura dai vincoli dello Stato, restituendole la possibilità di fare le
leggi, restituendola cioè alla sua primitiva funzione di tutrice del diritto e produttrice prima
del
diritto
stesso.
L'una senza l'altra non avrebbe senso e, d'altra parte, anche ammesso - ma concesso con
amplissime riserve - che allo Stato sia funzione indefettibile quella giurisdizionale, non
vedo in che cosa lo Stato perderebbe qualora la Magistratura si staccasse ancora di più
dagli
altri
due
poteri.
Parlo naturalmente di uno Stato che non sia espressione di gruppi parziali, ma di uno
Stato onestamente "amministrativo", se così posso esprimermi, di uno Stato estraneo cioè
alle
lotte
politiche
interessate.
La garanzia dello Stato dovrebbe e potrebbe limitarsi alla formazione culturale ed
educativa del Magistrato, attraverso Università realmente funzionanti; ed alla presenza non importa in qual modo attuata - di un funzionario pubblico in dibattimento.
Cosa osta, infatti, che un Magistrato di carriera svolga attività preparatoria (ma
oculata e precisa) al giudizio di un giudice privato? Cosa osta a che a questo giudice lo
Stato chieda garanzie, diverse comunque da quella di essere un funzionario Statale ed
esclusivamente
tale?
O, se non si vuole tornare ai due stadi del processo, cosa impedisce l'adozione del sistema
vigente
attualmente,
per
esempio,
in
Inghilterra
?
Gli argomenti in contrario a mio parere possono tutti raggrupparsi sotto la tendenza,
propria degli Stati moderni, di porsi come espressione di parte e, di conseguenza, di
tutelare
esigenze
di
parte.
Prova, almeno per l'Italia, l'attuale periodo politico e, nel corso dei tempi, la congerie
insulsa
di
leggi
e
leggine.
La Magistratura italiana ha inoltre estremo bisogno di porsi al passo con la convulsa vita
della società moderna: ciò mi pare possibile ottenere soltanto proprio con la possibilità di
formare essa stessa la legge, proseguendo la tradizione del migliore periodo del diritto di
Roma, anche contro l'ordinamento Statale: essa acquisterebbe così in potere e dignità,
venendo a costituire l'unico baluardo contro le mene, tutt'altro che disinteressate, dei
politici. Poi, c'è un altro aspetto della crisi: la chiusura di cui il Magistrato viene
attualmente accusato in Italia: chiusura ai problemi della vita quotidiana, chiusura alla
cultura ed ai più vasti orizzonti di questa. Può darsi che tutto ciò non risponda a verità:
certo, però, il Magistrato - scelto attraverso il discutibile sistema del concorso - è portato il
più delle volte ad isolarsi nel suo tempio, a vivere per l'amministrazione della Giustizia, il
che sotto certi aspetti può essere bello, ma contribuisce indubbiamente ad invecchiare il
sistema ed a rallentarne il funzionamento. Chiusura inevitabile, sembra, allo stato attuale
delle cose: pochi riescono ad inserirsi completamente nella storia delle cose, e non so
come quei pochi siano considerati dai colleghi più anziani: certo, mi sembra che altri
eventuali interessi non sempre giovano alla carriera, e questa è una preoccupazione
purtroppo presente e pressante, da eliminarsi anche essa, almeno nelle forme attuali.
Il Magistrato che, per ipotesi, avesse il compito del Magistrato romano in iure, per
forza di cose sarebbe costretto a tuffarsi nel mondo di ogni giorno, e la sua personalità,
lungi dall'esser mortificata, ne trarrebbe beneficio e fonti di nuova vita intellettuale e
morale, con giovamento anche e sopra tutto della compagine sociale. Poiché la maggior
causa di isolamento del Magistrato, oggi, sembra essere la lodevolissima preoccupazione
di perdere la propria imparzialità, preoccupazione che non avrebbe più ragione di esistere
se non fosse lui stesso ad amministrare direttamente giustizia, e non esisterebbe nel
Giudice, nello stadio in iudicio, perché in massima parte legato ai dettami del Magistrato.
Ciò si otterrebbe anche, se il sistema accennato apparisse macchinoso, con l'accettazione
in Italia del sistema inglese, con un Magistrato pubblico che guida il procedimento e guida
la formazione del giudizio nella Giuria, nella quale peraltro in Italia mi parrebbe opportuno
chiedere adeguate garanzie di preparazione culturale e di sanità morale: una magistratura
pubblica scelta tra laureati in legge, ed una sub-magistratura o magistratura privata scelta
anch'essa tra laureati in legge, con sistemi diversi perché a fini diversi.
Certo è che in Italia una riforma di struttura appare inevitabile, anche in vista di una
lontana ma probabile unificazione delle magistrature in un'eventuale compagine super
statale."
3. Alla fine di questa rilettura, mi sono accorto che si era disegnata, dentro di me, la
repellente figura di un giudice colto in un uno dei suoi tanti momenti di consapevolezza di
sé e della propria funzione. Un giudice che è, forse, anche un magistrato, titolare di una
funzione pubblica che deve essere svolta in nome e per conto di uno Stato pensoso della
morale, dell'etica, della sicurezza dei suoi cittadini e della professionalità di chi svolge
funzioni che hanno una particolare rilevanza nella società moderna. Quando Il dottor
Cacaglio, depositario elettivo di una funzione giurisdizionale, ergendosi in tutta la sua
statura - peraltro, media, sgraziata e piuttosto pesante - ed assumendo una posa
imperiale resa vieppiù comica dagli occhi pallati e da quell'indice teso, declama "io sono il
tuo giudice" ; quando Il Cacaglio si comporta così esprime esattamente quali rischi si
corrono nella scelta delle persone e quale giustizia ci si può aspettare da lui e da quelli
come
lui.
Che sono tutt'altro che pochi, in verità. Ed è proprio questo flash che ha illuminato un
aspetto della rilettura di questo saggio e mi ha costretto a pormi una domanda: di quale
amministrazione della giustizia parlavamo allora e parliamo oggi, e di quali giudici? La
risposta appare semplice: della giustizia e della sua amministrazione quale potere
(almeno per ora) dello Stato e di coloro che dallo Stato sono stati preparati e selezionati
per assolvere questa funzione. Sempre, quando ci occupiamo di amministrazione della
giustizia e di giudici immaginiamo i giudici togati, i magistrati di carriera, le aule dei
tribunali civili e penali (e, per i più informati, quelle della giustizia amministrativa) e, oggi,
anche
le
disadorne
stanze
dei
giudici
di
pace.
Ma a pochi viene in mente che "il fare giustizia" è forse una delle attività più generali e
più largamente praticate dalla maggior parte degli individui. A livelli e su materie le più
diverse, naturalmente, ma tant'è: lo sport più praticato dagli essere umani è sempre stato
e sempre sarà quello di giudicare i comportamenti, in prevalenza quelli degli altri. Di
esprimere, cioè, giudizi di moralità, di eticità, di legittimità: di rispondenza, in altre parole,
dei comportamenti alle norme morali, etiche, giuridiche e questo in base alla sensibilità ed
alle conoscenze di ciascuno. In ognuno di noi vive un giudice severo, inflessibile, alieno
da ogni e qualsiasi compromesso, talvolta persino comprensivo, sopra tutto giusto. E
dentro di noi sono i codici, le norme in forza delle quali emaniamo le nostre sentenze: noi
stessi siamo il parametro del nostro essere giudici. Che non è (soltanto) un'affermazione
più o meno ironica: appare assolutamente vero che ogni individuo assume se stesso
come parametro di tutte le cose e su questa base esprime giudizi. E appare altrettanto
vero che il metro riguarda il comportamento di tutti, ma non il proprio, e si allunga o si
accorcia a seconda del grado di parentela e di amicizia che i giudicandi hanno con il
giudice. Così, la "terzietà" di questo dipende da fattori - la parentela e l'amicizia ed anche
l'interesse e i vantaggi personali e la militanza o la semplice adesione ad una parte
politica- che nulla hanno (dovrebbero avere) a che fare con la serenità e l'obiettività del
giudizio. Dal che una conseguenza, possibile anche se, grazie a Dio, non inevitabile: che
le persone che sono chiamate ad amministrare la giustizia in nome del popolo e sorretti
dall'autorità dello Stato portino con sé i propri personali criteri e, forti di un potere che li
pone in posizione di vantaggio, amministrino una giustizia quanto meno discutibile.
E' fuor di dubbio che amministrare la giustizia concreta l'esercizio di un potere.
Significa che di qualsiasi "giustizia" si parli, coloro che sono chiamati ad amministrarla
dovrebbero disporre della formazione personale corretta eticamente e professionalmente
per farlo. Dal punto di vista etico, quale che siano i principi di riferimento, chi amministra la
giustizia deve farlo nell'interesse della giustizia stessa. Non deve avere altro obiettivo se
non quello di applicare la norma e di esprimere il giudizio relativo sui fatti e sui
comportamenti che sono oggetto del giudizio. E, soprattutto, non deve in alcun modo
permettere che i propri personali interessi interferiscano nella funzione che è chiamato ad
esercitare. E dal momento che - sempre e di qualunque giustizia si parli - amministrarla
significa giudicare la rispondenza dei comportamenti in esame alle norme che li regolano,
è necessario che la cultura e la professionalità del giudice vengano strutturate in modo
proprio - "dedicato", si dice oggi - e allo stesso modo che la sua preparazione e il suo
lavoro vengano sottoposti ad un monitoraggio continuo e attento. Che è, poi, un'altra
forma di amministrazione della giustizia. E allora ecco che, almeno in tutti quei casi nei
quali lo Stato e la società riconoscono la valenza sociale del giudizio, occorre che i giudici
vengano scelti tra coloro che, oltre all'eventuale riconoscimento sociale (che è a sua volta
un giudizio) godano di una preparazione tecnica specifica, siano stati formati ad assolvere
la funzione giurisdizionale e conoscano a livelli di alta professionalità i principi ed i modi
del
lavoro
che
sono
chiamati
a
svolgere.
Il riconoscimento sociale non basta. La circostanza che porta una persona ad essere
riconosciuta e, probabilmente, stimata da un gruppo sociale non dovrebbe essere fattore
sufficiente per assegnare l'adempimento di una funzione giurisdizionale di interesse
generale. Un qualsiasi gruppo sociale - modulo dello Stato - è portato oggi più che mai a
dare riconoscimenti a chi meglio difende i propri (del gruppo) interessi di parte. E il
difendere interessi particolari è proprio ciò che in giudice non deve fare. Non solo. Il
giudice che viene espresso da un gruppo troppo spesso è il risultato di una attività svolta
da una infima minoranza all'interno del gruppo stesso. Abbiamo esempi di "giudici" eletti
da un numero di votanti oscillante attorno al dieci per cento degli aventi diritto e da una
parte a suo favore che a mala pena si avvicina alla metà dei votanti. Diventa allora
importante che lo Stato chiarisca, in modo appropriato e con apposite leggi, cosa debba
essere la "rappresentatività" per chiunque debba esercitare elettivamente una funzione
giurisdizionale. A me pare ovvio che un giudice scelto dal "mondo della società civile"
attraverso libere elezioni dovrebbe sempre e comunque ricevere il consenso della
maggioranza degli aventi diritto al voto e non soltanto della maggioranza dei votanti. Così,
stabilire un paletto alla validità della consultazione (per esempio, che si rechi al voto
almeno il sessanta- settanta per cento degli aventi diritto) potrebbe costituire un buon
passo in avanti. Anche perché - e la cosa mi pare di particolare importanza del caso di
associazioni professionali, ad esempio - se la maggioranza di coloro che fanno parte del
gruppo non si reca a votare vuol dire che non ha alcun interesse alla esistenza stessa
della struttura. Il che pone o dovrebbe porre degli interrogativi circa l'opportunità stessa
della struttura. E l'eventuale abolizione di questa risolverebbe, forse, alcuni problemi non
secondari, tra i quali certamente i costi e l'utilizzo non corretto del potere da parte degli
eletti
non
rappresentativi.
La preparazione giuridica. Ma c'è di più. Sempre, quando si tratti di amministrare
giustizia e questo abbia rilevanza sociale, occorre che il giudice sia preparato
tecnicamente ad assolvere questa funzione. E allora, bisogna che la persona abbia le
caratteristiche culturali che garantiscano il migliore svolgimento di essa. Certo, non sarà
possibile ottenere l'eccellenza, la rimozione totale dei rischi, ma le teorie e la pratica della
gestione degli scambi (del marketing, perché anche la "giustizia" è un prodotto per lo
scambio e in quanto tale deve essere utile, conosciuta e apprensibile) ci insegna che è
probabile che i rischi vengano ridotti fin quasi a divenire trascurabili se si seguono
correttamente metodologie precise e dimensionate agli obiettivi voluti. Così, dal momento
che amministrare la giustizia significa in buona sostanza valutare i comportamenti e le
situazioni alla luce delle leggi vigenti, sarebbe forse opportuno stabilire che chiunque
aspiri ad essere eletto o comunque scelto per essere giudice abbia una corretta e
profonda preparazione giuridica, formata a cura di un sistema a questo orientato e per
questo organizzato, riconosciuta dallo Stato e in qualche modo esercitata nella pratica
quotidiana. In Italia, sarebbe forse il caso di stabilire che nessuno può assumere un
incarico di "giudice" se non sia almeno laureato in giurisprudenza e non abbia svolto un
periodo di praticantato presso uno studio di avvocatura, di notariato o di amministrazione
della
giustizia.
Che è, poi, l'essenza dell'attività giurisdizionale anche secondo il diritto romano. Significa
che gli incarichi, ad esempio, di presidenti degli ordini professionali (strutture comunque
deputate ad esprimere giudizi circa i comportamenti degli iscritti) oppure quelli dei
responsabili degli Uffici del personale delle imprese private e degli enti pubblici se
istituzionalmente chiamati anche ad amministrare giustizia dovrebbero essere riservati a
laureati in giurisprudenza, meglio se con votazione elevata, abilitati alla professione legale
o esercenti la professione di avvocati, notai e giudici di carriera, magari anche dotati di
una congrua anzianità di servizio. Che non vuol dire necessariamente "di nomina statale",
ma soltanto di qualifiche necessarie per la candidatura. Operando come ipotizzato si
garantirebbero meglio i cittadini e la funzione giurisdizionale sarebbe concretamente
affidata a terzi certamente imparziali e privi di interessi personali e di frequentazioni più
che sovente clientelari nell'ambito della professione di riferimento. Si spera.
La capacità di interpretazione delle norme e la conoscenza dei principi che la regolano
integra, poi, quella preparazione giuridica della quale qualsiasi giudice dovrebbe esser
dotato e che dovrebbe essere inserita tra i requisiti essenziali per poter assumere la
funzione di giudice in ogni e qualsiasi materia pubblica o di pubblico interesse. Non mi
pare il caso, qui, di elaborare un trattato sull'interpretazione, ma un cenno alla sua
importanza va fatto. Ed è sostanzialmente questo, mi pare: a seconda di quanto e di cosa
il giudice comprenda della norma, i risultati possono essere (e in realtà, sono) diversi a
volta in modo assolutamente macroscopico. Ovvio. Ecco allora che l'aver ricevuto la
preparazione necessaria alla "lettura" delle leggi e dei regolamenti - troppo spesso non
soltanto oscuri, ma volutamente tali - si pone come elemento essenziale della cultura e
della professionalità di ogni e qualsiasi giudice. Non dovrebbe essere concesso a nessun
interprete di essere autodidatta. L'interpretazione della legge è un esercizio troppo difficile,
troppo nobile e dagli effetti troppo importanti per essere consentita ad orecchianti o
semplici appassionati del diritto. Anche - ma non solo - perché l'hobbista non è stato
preparato a liberarsi di tutti quegli orpelli personali e personalistici, di famiglia, di gruppo
clientelare e quanto altro che quasi ineluttabilmente conducono ad una lettura distorta del
significato della legge. Del suo "spirito" come suol dirsi, spesso ben diverso dalla lettera. E
se anche -animo generoso e nobile! - lo tentasse, quasi certamente si tratterebbe di un
tentativo destinato a fallire, vista la mancanza dei criteri guida per una lettura corretta della
norma. E, naturalmente, non significa che un laureato in giurisprudenza sia di per sé una
garanzia di buona interpretazione della legge: vuol dire soltanto che i rischi di una cattiva
e spesso ridicola e ancora più spesso strumentale interpretazione possono essere ridotti.
Che sarebbe già tanto. Ma in materia mi pare di poter ricordare che un ruolo
assolutamente importante, forse ancor più di un patrimonio tecnico, riveste la figura
"morale" della persona e quindi il suo atteggiamento nei confronti di un'etica della quale
deve conoscere i principi. E condividerli. E praticarli, anche a costo di sacrificio.
Il disporre di valori ai quali fare appello a me sembra di rilievo assoluto per ogni e
qualsiasi attività di amministrazione della giustizia, in qualsiasi materia e di qualsiasi
ordine e grado. Sono i valori i soli in grado di costituire la diga, ad esempio, a quella forma
di "amministrazione della giustizia" che investe nelle imprese i rapporti con il personale e
che determina i richiami disciplinari, i licenziamenti, le promozioni in funzione non della
violazione di norme da parte del soggetto passivo, bensì in vista di una
strumentalizzazione per favorire alcuni e liberarsi di altri. Che è anche la questione di
grande attualità del mobbing. E le imprese (private o pubbliche che siano) e le strutture
dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di tutte le organizzazioni che si fregiano
dell'attributo di pubblico, unitamente al personale che vi lavora sono una realtà imponente
della vita moderna, nella quale il valutare correttamente i comportamenti e l'esprimere
giudizi sulla loro congruità e rispondenza alle norme che li regolano appare sempre di più
assolutamente prioritario. La qual cosa, sia detto per inciso, dovrebbe intanto consigliare
qualsiasi impresa e qualsiasi altra struttura - ripeto, privata o pubblica che sia - ad affidare
la direzione del personale a laureati in giurisprudenza (almeno) e a disegnare un
mansionario relativo a questo ufficio che ad esso affidi in esclusiva la competenza di ogni
e qualsiasi conflitto interno. Ma, fuori dall'inciso, una indagine sui valori ai quali il
candidato si ispira dovrebbe non soltanto essere condotta prima che un eventuale
rapporto inizi, ma essere anche costantemente svolta per monitorare l'attività di cui si
tratta.
Che il potere corrompa non è una novità. E l'esercizio dell'amministrazione della
giustizia è esercizio di un potere. C'è qualcuno che riesce a spiegarmi perché nell'antica
Roma la maggior parte (tutte?) le magistrature erano a tempo, ed oggi è possibile che non
lo siano? Persino il Dictator rei pubblicae servandae aveva un mandato per sei mesi, e sì
che era dotato di pieni poteri! Ed anche il nostro Presidente della Repubblica ha un
massimo di possibilità di essere rieletto. Perché allora ancor oggi, esistono mandati
rinnovabili all'infinito? Forse perché si tratta di "magistrature" inferiori? Se così fosse, non
mi pare ci si trovi di fronte ad una gran logica: i guasti di una gestione scorretta di un
qualsiasi fenomeno e di una qualsiasi struttura sono sempre e comunque fonte di malattia
del gruppo sociale, un vero e proprio fenomeno cancerogeno. Le cellule malate
proliferano, fino ad uccidere. E allora, intanto: da un lato sarebbe il caso di stabilire che
una carica elettiva non deve durare più di un tempo stabilito a seconda della materia;
dall'altro, che colui che è stato eletto per una determinata funzione, risponda del proprio
operato. Vogliamo scommettere che un giudice privato scelto con criteri ineccepibili di
rappresentanza e conscio che dovrà rispondere di come ha esercitato il proprio mandato
garantirà se non la perfezione, certo un miglioramento di quello che al momento sembra
un tumore non operabile? Il giudice privato in Roma veniva scelto dalle parti "per risolvere
quel singolo caso": cosa si oppone "veramente" a ripetere oggi l'esperimento? Forse le
probabilità di farsi corrompere e quindi di dare ragione a chi gli offre di più? Ma se
l'immagine della persona che dovrà giudicare è quella di un uomo profondamente onesto
e dal comportamento irreprensibile (e già il concordare delle parti sul suo nome è una
garanzia) e se la persona stessa, oltre a disporre degli strumenti culturali e professionali
adeguati, sa che il suo comportamento sarà a sua volta oggetto di valutazione, appare
probabile che i rischi di una giustizia "ingiusta" siano abbastanza ridotti.
Privatizzare l'apparato giudiziario dello Stato o in qualche modo cercare di limitarne
l'indipendenza appare, invece, questo sì, un rischio gravissimo. Significherebbe togliere
allo Stato ed alla società forse lo strumento massimo per garantire ai cittadini quella
giustizia sociale alla quale la compagine nel suo insieme ed ogni singolo cittadino ha
diritto di aspirare e ha diritto di attendersi. E non a caso in ogni tempo e sotto tutti i cieli è
apparso qualcuno che ha spinto nella direzione di un asservimento della funzione di
amministrazione della giustizia agli interessi della politica. I quali interessi, così come oggi
si guarda alla politica, sembrano essere sempre più di parte e sempre meno attenti alla
soddisfazione dei bisogni della società nel suo complesso. E a me pare che una
magistratura "pubblica" assolutamente indipendente sia la maggiore e più affidabile
garanzia
per
un
cittadino
ed
una
società.
Con (almeno) una possibile condizione, a mio parere sempre indispensabile ma oggi di
grande difficoltà ad avverarsi: la preparazione tecnica e quella morale dei magistrati, alle
quali, forse, bisognerebbe dedicare maggiori risorse ed attenzione. Rivedere le procedure
è, probabilmente, una ulteriore possibilità Quelle di cui disponiamo oggi sembrano ispirate
più a garantire l'irresponsabilità del giudice che la rapidità e la affidabilità del giudizio. Una
giustizia "giusta" è anche tale in virtù della rapidità con la quale la sentenza definitiva è
emessa. E una giustizia "giusta" è anche in funzione della certezza delle norme e delle
ridotte possibilità di ricorrere a cavilli procedurali per ottenere dichiarazioni che, forse,
sono in linea con i codici ma che di veramente "giusto" hanno ben poco. E tra le pieghe
della procedura si nascondono mille possibilità di "fare giustizia" in modo quanto meno
variegato.
Che
è
come
non
fare
giustizia.
La comunicazione che ha per oggetto la giustizia in genere e le sentenze in
particolare è anch'essa una questione alla quale bisognerebbe prestare attenzione. La
società civile viene a conoscenza dei fatti della giustizia attraverso un a mediazione che
dovrebbe "informare" in modo oggettivo dei "fatti" e, a parte e con le dovute cautele,
anche fornire gli argomenti per una interpretazione ed una valutazione di essi. In questo
lavoro, i giornalisti sono in prima linea. Non voglio addentrarmi nei dettagli di questa (un
tempo splendida) professione. Mi limiterò a segnalare come la "cronaca giudiziaria"
dovrebbe essere affidata a professionisti laureati in giurisprudenza, almeno, oltre che
capaci di fare giornalismo. Il che nella maggior parte dei casi non è. E purtroppo non mi
pare esistano scuole di giornalismo in Italia degne di questo nome e che comunque
selezionino i giovani in base alle specializzazioni che verranno poi insegnate. Voglio dire
che per la cronaca e il commento "giudiziari", non soltanto dovrebbero essere selezionati
giovani laureati in giurisprudenza: a questi dovrebbe essere anche insegnato a fare
"informazione e interpretazione" giudiziaria e/o legale. Così come la cronaca e la critica
musicale dovrebbero prevedere la scelta di giovani musicisti e l'insegnamento dei principi
della professione nel settore specifico. E via dicendo. Senza dimenticare, mi pare ovvio,
che, come per tutti i prodotti destinati allo scambio (e la giustizia lo è) occorrerebbe una
struttura ed una attività di comunicazione propria degli Uffici Giudiziari, affidata a
comunicatori
professionali.
Che
non
sono,
oggi,
i
giornalisti.
Il problema maggiore sembra costituito dai referenti. Io non credo che una società in
buona misura in crisi culturale, corrotta, disattenta, orientata quasi esclusivamente a valori
di profitto e tutt'altro che pensosa degli interessi e dei bisogni dell'umanità (che sarebbe
l'ideale) ma neppure di se stessa - il che è anche stupido e suicida - possa dimostrarsi
aperta più che tanto ad operare su di sè per consentire il raggiungimento di uno status
d'ambiente ideale per lo svolgimento di una attività corretta di amministrazione della
giustizia, fatta (anche) di equilibrio tra "il pubblico" e "il privato". Non lo credo perché è
questa società che dovrebbe preparare i propri componenti a divenire capaci di nuovi
valori e di nuovi comportamenti; ad abbandonare gli interessi esclusivamente privati; a
dare la giusta importanza a quelli pubblici; ad occuparsi delle piccole cose, perché
l'affermare di farlo per quelle "grandi" è uno splendido alibi per continuare a pensare solo
a se stessi, non credo che questa società sia disponibile a fare a meno delle
raccomandazioni; a non assegnare le cariche di prestigio e di potere a chi non sia
disposto a ripagare gli elettori o i promotori della assegnazione; a non fare tutto e il
contrario di tutto per arricchirsi; a smettere di valutare il valore delle persone solo in base
al
patrimonio
accumulato.
E non lo credo, anche, perché l'attuale società italiana sembra considerare la formazione,
l'insegnamento (sopra tutto quello pubblico) un'attività di seconda categoria, alla quale
poter destinare persone i cui meriti sono quelli di essere parenti, amici, clienti di qualcuno
per qualche verso potente e dalla quale attendersi quasi esclusivamente un ritorno
economico, magari sotto forma di uomini pronti ad assumersi compiti esecutivi in azienda,
a
maggior
gloria
dell'imprenditore.
Figuriamoci se questa società è disponibile a guardare alla giustizia come ad un prodotto
destinato allo scambio e quindi adatto a soddisfare bisogni, conosciuto e apprensibile ed a
fare quanto necessario perché sia veramente tale e possa raggiungere nel migliore dei
modi la propria causa. Il tutto, perché "amministrare la giustizia è una professione troppo
nobile per essere considerata un prodotto"! E, quando tutto manca, resta l'argomento
principe della filosofia e della cultura italiana: "lei ha ragione, tutto è prodotto e tutto è
destinato
allo
scambio,
anche
la
giustizia.
Ma
è
tutto
diverso".
Il che è bello ed istruttivo, avrebbe commentato Guareschi.
AVVERTENZA
Dato il carattere del saggio riportato, la bibliografia è stata limitata alla indicazione
dei testi che trattano gli argomenti di carattere generale, ai quali si rimanda per altre
più profonde e dettagliate informazioni
BIBLIOGRAFIA
ARANGIO-Ruiz,
Storia
del
diritto
Romano
Jovene,
Napoli
1957.
ARANGIO-Ruiz,
Istit.di
di
Diritto
Romano
Jovene,
Napoli
1957.
BONFANTI,
Istit.
di
Diritto
Romano
Giappichelli,
Torino
1957.
GUARINO,
Storia
del
Diritto
Romano
Giuffrè,
Milano,
1949.
LONGO-SCHERILLO, Storia del Diritto Romano - Giuffrè, Milano1912
PACCHIONI,
Corso
di
Diritto
Romano
Utet,
Torino
1930
DI
MARZO,
Istituzioni
di
dir.
Romano
Utet,
Torino,
1950.
Le
Istituzioni
di
Gaio
e
di
Giustiniano
SATTA,
Diritto
Processuale
Civile
CEDAM,
Padova,
1959
REDENTI, Diritto Processuale Civile - Giuffrè, Milano, 1957