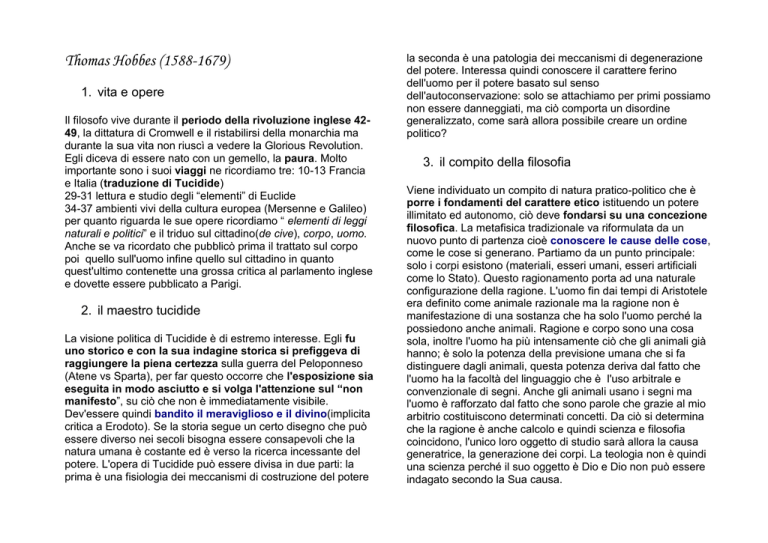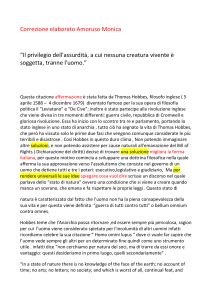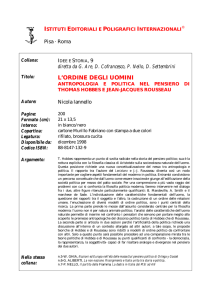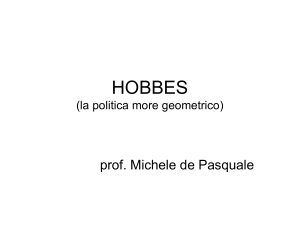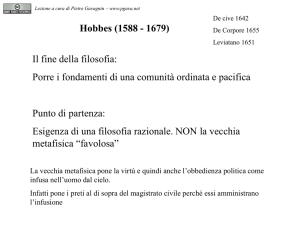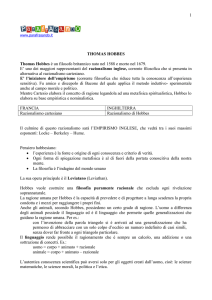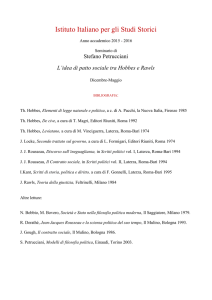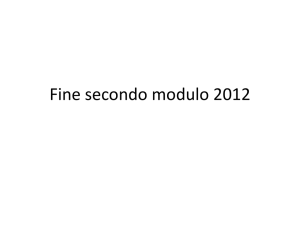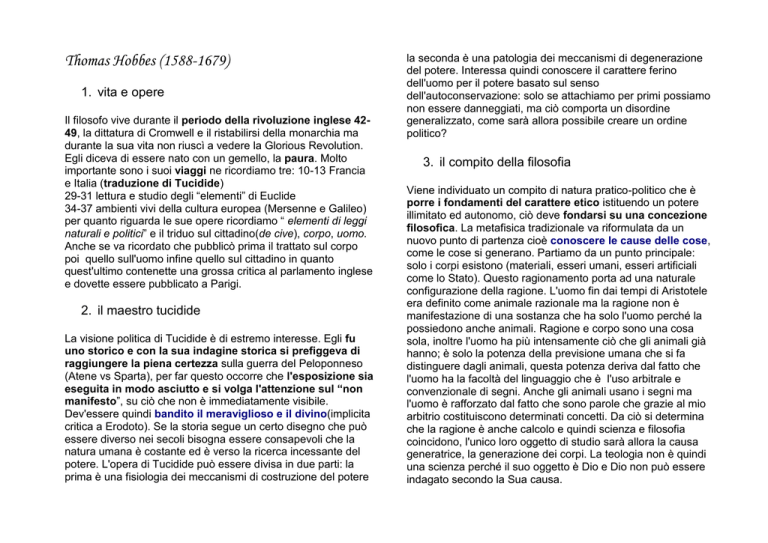
Thomas Hobbes (1588-1679)
1. vita e opere
Il filosofo vive durante il periodo della rivoluzione inglese 4249, la dittatura di Cromwell e il ristabilirsi della monarchia ma
durante la sua vita non riuscì a vedere la Glorious Revolution.
Egli diceva di essere nato con un gemello, la paura. Molto
importante sono i suoi viaggi ne ricordiamo tre: 10-13 Francia
e Italia (traduzione di Tucidide)
29-31 lettura e studio degli “elementi” di Euclide
34-37 ambienti vivi della cultura europea (Mersenne e Galileo)
per quanto riguarda le sue opere ricordiamo “ elementi di leggi
naturali e politici” e il triduo sul cittadino(de cive), corpo, uomo.
Anche se va ricordato che pubblicò prima il trattato sul corpo
poi quello sull'uomo infine quello sul cittadino in quanto
quest'ultimo contenette una grossa critica al parlamento inglese
e dovette essere pubblicato a Parigi.
2. il maestro tucidide
La visione politica di Tucidide è di estremo interesse. Egli fu
uno storico e con la sua indagine storica si prefiggeva di
raggiungere la piena certezza sulla guerra del Peloponneso
(Atene vs Sparta), per far questo occorre che l'esposizione sia
eseguita in modo asciutto e si volga l'attenzione sul “non
manifesto”, su ciò che non è immediatamente visibile.
Dev'essere quindi bandito il meraviglioso e il divino(implicita
critica a Erodoto). Se la storia segue un certo disegno che può
essere diverso nei secoli bisogna essere consapevoli che la
natura umana è costante ed è verso la ricerca incessante del
potere. L'opera di Tucidide può essere divisa in due parti: la
prima è una fisiologia dei meccanismi di costruzione del potere
la seconda è una patologia dei meccanismi di degenerazione
del potere. Interessa quindi conoscere il carattere ferino
dell'uomo per il potere basato sul senso
dell'autoconservazione: solo se attachiamo per primi possiamo
non essere danneggiati, ma ciò comporta un disordine
generalizzato, come sarà allora possibile creare un ordine
politico?
3. il compito della filosofia
Viene individuato un compito di natura pratico-politico che è
porre i fondamenti del carattere etico istituendo un potere
illimitato ed autonomo, ciò deve fondarsi su una concezione
filosofica. La metafisica tradizionale va riformulata da un
nuovo punto di partenza cioè conoscere le cause delle cose,
come le cose si generano. Partiamo da un punto principale:
solo i corpi esistono (materiali, esseri umani, esseri artificiali
come lo Stato). Questo ragionamento porta ad una naturale
configurazione della ragione. L'uomo fin dai tempi di Aristotele
era definito come animale razionale ma la ragione non è
manifestazione di una sostanza che ha solo l'uomo perché la
possiedono anche animali. Ragione e corpo sono una cosa
sola, inoltre l'uomo ha più intensamente ciò che gli animali già
hanno; è solo la potenza della previsione umana che si fa
distinguere dagli animali, questa potenza deriva dal fatto che
l'uomo ha la facoltà del linguaggio che è l'uso arbitrale e
convenzionale di segni. Anche gli animali usano i segni ma
l'uomo è rafforzato dal fatto che sono parole che grazie al mio
arbitrio costituiscono determinati concetti. Da ciò si determina
che la ragione è anche calcolo e quindi scienza e filosofia
coincidono, l'unico loro oggetto di studio sarà allora la causa
generatrice, la generazione dei corpi. La teologia non è quindi
una scienza perché il suo oggetto è Dio e Dio non può essere
indagato secondo la Sua causa.
4. la natura della ragione
A differenza degli animali, l’uomo ha una ragione che
permette di progettare e prevedere.
Può ragionare grazie al linguaggio
Si può soltanto risalire gli effetti determinando cause probabili,
che non sono necessariamente corrispondenti alla realtà.
Anche la teologia perde quindi di significato: NON SI
CONOSCE LA CAUSA CHE GENERA DIO, QUINDI DIO E’
INCONOSCIBILE.
6. il corpo
Il linguaggio è fatto di segni convenzionali che corrispondono
a concetti.
Per Hobbes, i soli oggetti conoscibili sono i corpi estesi, gli
unici che possono avere delle cause produttrici.
se l’uomo può ragionare mediante il linguaggio, il
ragionamento diventa un calcolo:
Anche Dio deve quindi essere corporeo: Hobbes ebbe una
vivace polemica con l’arcivescovo di Bramhall.
per Hobbes il ragionamento è addizione e sottrazione di
sillogismi, proposizioni, periodi: tutto nel più rigoroso
meccanicismo.
Un corpo, Hobbes lo definisce: “qualcosa he non dipende dal
nostro pensiero, ma che coincide con qualche parte nello
spazio”.
5. la scienza
Solo il corpo può agire o subire una azione: i corpi estesi
sono quindi le uniche realtà esistenti.
Con il ragionamento fatto di calcoli, si niene a sottolineare
l‘importanza delle cause generatrici
Anche lo spirito deve essere corporeo: sia l’oggetto che la
sensazione non sono altro che movimenti.
Nella scienza si determina l’effetto partendo da una causa,
esprimendo un rapporto di necessarietà: l’uomo può studiare
quindi gli oggetti dei quali conosce la causa generatrice.
Il movimento è il principio unico di spiegazione dei
fenomeni naturali.
Quindi a priori potrà dimostrare soltanto ciò che è stato prodotto
da lui stesso.
La natura può essere studiata solo a posteriori, poiché è
generata da Dio, e di esso non si conosce la causa.
Anche l’immaginazione è movimento: è l’immagine apparente
del corpo che viene prodotta grazie ai sensi.
Di qui muove la critica al cogito di Cartesio, poiché per Hobbes,
è un movimento di corpi la causa del pensiero.
A. critica di hobbes: “il cogito è indubitabile soltanto
quando si limita ad esprimere la coscienza di pensare
ed esistere. Quando si procede oltre, affermando di
essere una cosa pensante si compie un atto
arbitrario, una scelta: non è detto che la sostanza
dell’individuo sia il pensiero.
B. Risposta di Cartesio: l’esempio della passeggiata
di hobbes (se io passeggio non è detto che sia una
passeggiata) non è corretto: mentre la passeggiata
è una azione che non inerisce a colui che la
compie, il pensiero talvolta indica la facoltà di
pensare, talvolta l’azione, talvolta la cosa in cui
risiede tale facoltà. In definitiva, la cosa si identifica
con l’essenza della cosa.
La filosofia diventa quindi la scienza dei corpi:
7. i corpi naturali
L’ipotesi annichilitoria
È una ipotesi sui corpi. Facciamo il paragone con Cartesio,
Pascal, e Hobbes
X Cartesio: il dubbio svouta tutte le certezze e fa del
cogito il suo punto di archimede
X Pascal: L’esperienza del vuoto che spaura
X Hobbes: se tutti gli enti venissero totalmente
annientati in modo che rimanesse soltanto l’uomo
nell’universo, tramite i suoi pensieri che conserva nella
memoria, ricostruirebbe anzitutto i concetti di:
o Spazio
o tempo
Questi due concetti sono strettamente correlati a corpo e
moto.
Secondo il filosofo inglese, tramite questi concetti tutto
verrebbe ricostruito secondo un procedimento necessario.
8. L’uomo
L’etica di Hobbes
1. fisiologia della sensazione (gnoseologico)
La conoscenza sensibile è prodotta dal moto dei corpi che
premono sugli organi di senso.
Questa pressione produce un movimento intracorporeo che
attraverso i nervi arriva al cervello, poi al cuore, e dal cuore un
contromovimento al cervello e agli altri organi, la reazione allo
stimolo.
Hobbes interrompe il rigido schema meccanicistico per
spiegare il fatto conoscitivo:
il contromovimento produce l’immagine
L’immagine appare all’individuo;
Questo è nettamente un plus qualitativo rispetto alla
pressione dei corpi.
Per gli studiosi, la gnoseologia di Hobbes è una sorta di
equilibrio instabile tra:
Realismo: i corpi esistono realmente e sono causa dei
processi conoscitivi
Fenomenismo: tra le immagini che si creano nella
mente non vi è una necessaria somiglianza con i corpi
La sensazione quindi si divide in:
Dalla cosa all’organo di senso
Dall’organo di senso alla reazione, l’immagine
L’insieme delle immagini forma l’intelletto
2. fisiologia delle passioni e emozioni
(emotivo/morale)
Per Hobbes piacere e dolore nascono dal fatto che il
movimento ostacola o favorisce il movimento vitale del
cuore.
Il movimento vitale interno ha l’istinto di autoconservazione:
ciò che favorisce il movimento è piacere
ciò che lo ostacola è dolore
Tutti i sentimenti sono legati all’istinto di autoconservazione che
ci porta a ricercare il piacere e a fuggire il dolore.
Bene e male: non sono principi assoluti.
Bene = ciò che si cerca
Male = ciò che si fugge
Questo concetto di relativismo di bene e male stravolge le
concezioni che si erano create fino ad allora, da platone alla
scolastica all’umanesimo.
Nel suo rigoroso meccanicismo, Hobbes afferma che anche i
sentimenti che sembrano i più altruistici sono in realtà
condizionati dal nostro egoismo costitutivo, che si muove nel
verso dell’interesse:
La pietà: mossa dall’istinto di protezione perché
potrebbe accadere anche a noi
L’amore che si dà: nasconde il senso di potenza che si
prova nell’aiutare uno in difficoltà.
L’avversione e l’appetizione causati dall’esterno non sono in
nostro potere, e siamo continuamente presi da dubbi,
sentimenti opposti: La scelta di fronte a desideri contrastanti è
la deliberazione, che termina nell’atto di volontà.
L’uomo non potrà mai raggiungere uno stato di quiete: non si
può dunque parlare di sommo bene, poiché se esso fosse
raggiungibile non si desidererebbe più niente e si
staticizzerebbe il movimento.
9. lo stato di guerra / diritto naturale
Per fondare le sue dimostrazioni egli si basa sui seguenti fattori
che caratterizzano l’uomo:
LA POLITICA DI HOBBES
1. gli antichi ed i moderni
Così come la scienza moderna distrugge l’antico modello
aristotelico, anche la politica nega che l’uomo è “zoon
politikon”:
x Aristotele: in principio vi era l’ordine
x Hobbes: in principio c’è il chaos e l’uomo è un animale
che vuole tutto per se
bramosia naturale per la quale ognuno pretende
di godere per se dei beni comuni
ragione naturale per la quale ognuno rifugge dalla
morte violenta come il peggiore dei mali
3. l’uomo nello stato di natura
per Hobbes le società più durature si fondano sul timore
reciproco, più che dalla benevolenza verso gli altri individui.
Le cause di questo timore sono prevalentemente:
Per gli antichi, lo Stato era il termine di una catena, mentre per
Hobbes si deve costruire per arginare il caos creato dagli
uomini stessi.
Hobbes nega l’esistenza dell’amore naturale tra simili: obbietta
che gli uomini non si amano ugualmente tra di loro. L’uomo
ama quando trae beneficio, quando ha interesse.
L’amicizia stessa è fatta di benefici reciproci
2. postulati certissimi della natura umana
Hobbes vuole dimostrare in maniera necessaria l’uscita
dell’uomo dallo stato di natura ed il suo conseguente
organizzarsi in società
Nello stato di natura (che Hobbes concepisce come un
modello) l’uomo ha timore dell’altro uomo.
1. sono uguali: hanno la stessa forza ed ognuno vuole
impossessarsi di tutti i beni
2. scarsità dei beni
La concomitanza di questi due fattori, data la natura dell’uomo
bramoso di possedere il più possibile scatena una guerra tutti
contro tutti (bellum contra omnium).
Nello stato naturale giusto ed ingiusto non sono concetti
assoluti, ma ognuni è riferito al singolo individuo, che vede il
bene in ciò che gli arreca piacere, ed il male in ciò che gli
provoca dolore.
L’unico diritto presente è il diritto di natura, secondo il quale
ognuno ha diritto a fare qualsiasi cosa per avere qualsivoglia
bene.
Nello stato naturale c’è guerra continua.
4. la ragione calcolatrice
Questa guerra continua non piò protrarsi in eterno, perché
l’uomo finirebbe per autodistruggere se stesso.
Una potenziale guerra gli impedirebbe anche lo sviluppo
commerciale, scientifico, ecc..
è la ragione che mostra agli individui le cose più utili al loro
istinto di conservazione:
mostra agli uomini che c’è una contraddizione
tra l’istinto di conservazione e la legge
naturale secondo la quale qualsiasi uomo ha
diritto sulle cose e sulla vita di un altro.
La ragione dice che se tutti gli uomini pretendono
di avere, allo stesso modo rischiano di perdere.
Se la ragione permette di trovare una via di uscita, ciò che la
spinge a fare ciò è un sentimento, una passione: la paura della
morte violenta.
5. la legge naturale
La ragione suggerisce quindi dei principi che devono portare la
pace ed assicurare agli uomini il possesso dei propri beni: le
leggi di natura.
1. pax est querenda: L’uomo deve cercare di conseguire la
pace.
2. ius in omnia est retinendum: ogni uomo deve rinunciare
al diritto naturale e non fare agli altri ciò che non
vorrebbe fosse fatto a se stesso;
3. pactis standum: è necessario stipulare un patto
trasferendo tutti i diritti naturali, tranne quello alla vita, ad
una assemblea o ad una persona che li gestisca con la
forza
10.
lo stato
L’atto fondamentale con il quale avviene il passaggio da stato
naturale a società civile, secondo Hobbes, è il contratto.
Con il contratto la moltitudo rinuncia al diritto di natura e
conferisce ad altri il diritto di amministrarlo.
Dal punto di vista logico non regge il fatto che
manca un arbitro tra la multitudo e lo stato.
Lo stato diventa detentore del potere, conferitogli dai cittadini
stessi. Diventa il soggetto che garantisce i diritti dei cittadini
imponendogli dei doveri, che garantiscono quelli altrui: protego
ergo obbligo.
Lo stato, secondo Hobbes, è il Dio mortale al quale
dobbiamo la nostra pace e la nostra difesa.
1. Hobbes insiste sulla irreversibilità e unilateralità del
rapporto tra stato e cittadini: una volta creato lo stato,
non è più possibile scindere quel patto, poiché lo Stato
ha la forza che l’unione dei cittadini stessi gli hanno
conferito, facendo un patto tra loro, non con lo stato.
Talvolta si torna nello stato naturale, quando si
scatenano le guerre civili. Quindi il rapporto è
irreversibile nel senso che deve essere irreversibile.
2. Il potere dello Stato è indivisibile.
3. Il giudizio sul bene ed il male appartiene allo stato: è
costruttore della legge civile.
4. Liceità del pretendere obbedienza
5. Inammissibilità del tirannicidio
Per locke invece quando lo stato non ha più il consenso dei
governati, è lecita la rivoluzione e la ribellione: si rompe
l’univocità del rapporto che c’è in Hobbes.
Tuttavia il carattere assolutistico dello Stato di Hobbes è in
possesso di una contraddizione: lo stato non deve stare alle
leggi dello stato.
Esso, secondo l’Inglese, non si può obbligare né verso i
cittadini (unilaterale) né verso se stesso (ci si può obbligare
solo verso gli altri).
Si è in presenza di un volontarismo legislativo, si crea una
situazione per cui è assolutamente giusto ciò che dice lo stato,
e errato ciò che vieta.
Lo stato detiene anche l’autorità religiosa.
Hobbes cerca di prosciugare tutte le opportunità di conflitto.
11.
considerazioni
Questo schema potrebbe valere anche per le relazioni
internazionali.
Possiamo fare una politica estera nello stesso modo con
cui gestiamo quella interna?
Gli stati dovrebbero formare un governo mondiale, firmare un
patto, e dovrebbero accettare di spogliarsi del proprio potere,
in particolare di quello militare, formando un esercito unico.
Poiché è sulla forza, in ultima istanza, che si fonda il potere di
uno stato.