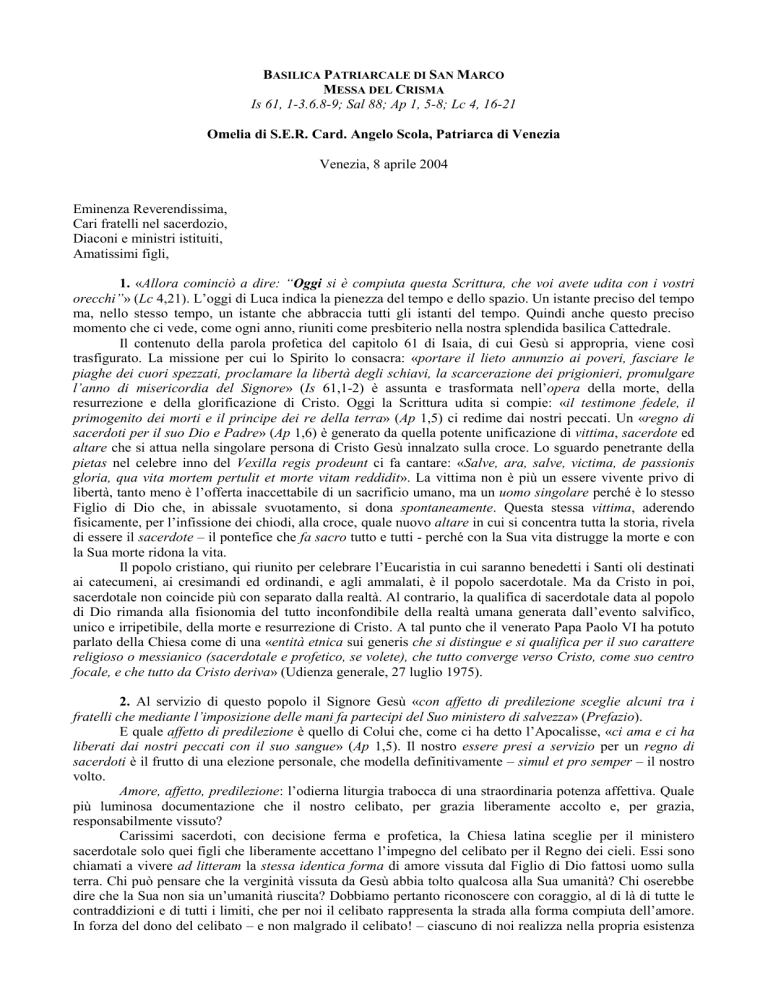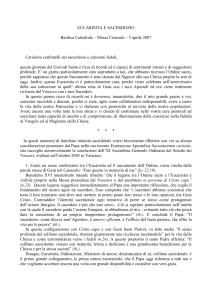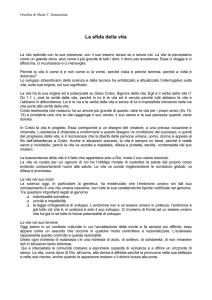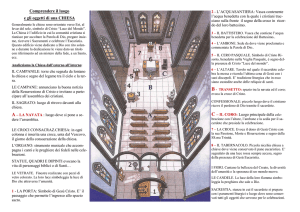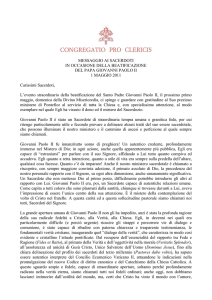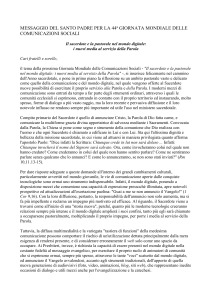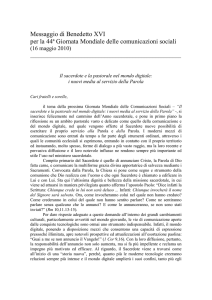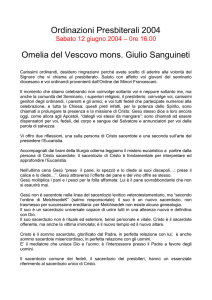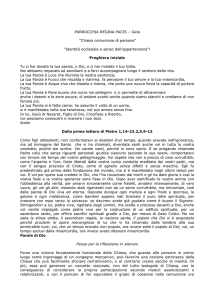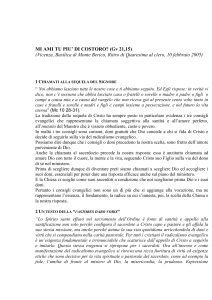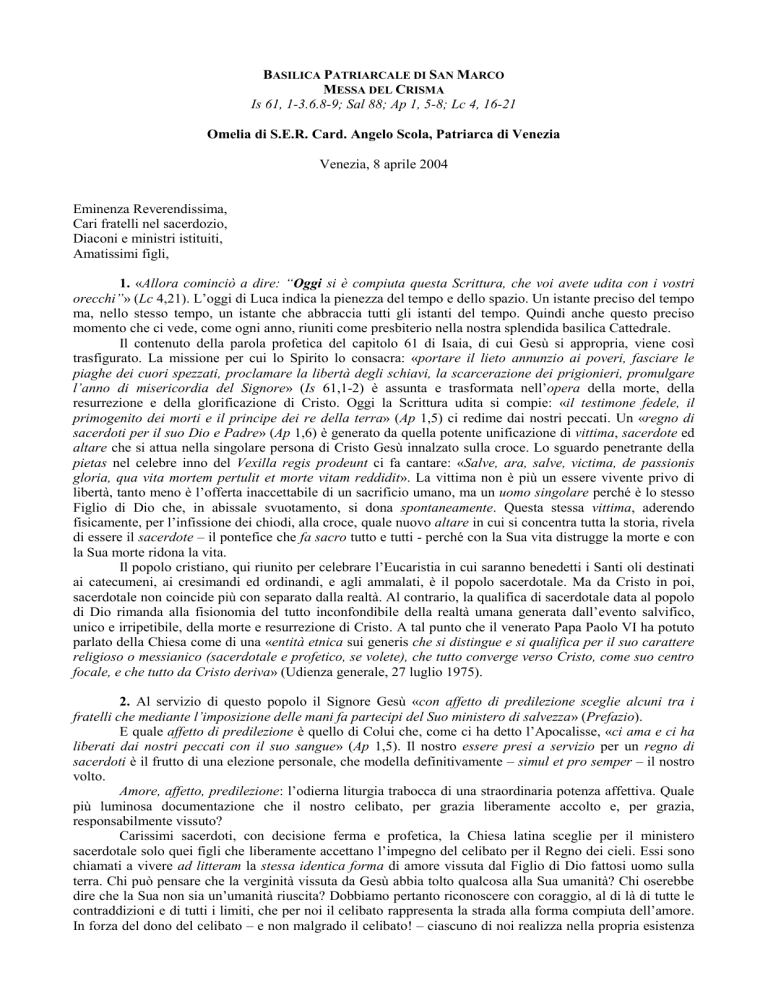
BASILICA PATRIARCALE DI SAN MARCO
MESSA DEL CRISMA
Is 61, 1-3.6.8-9; Sal 88; Ap 1, 5-8; Lc 4, 16-21
Omelia di S.E.R. Card. Angelo Scola, Patriarca di Venezia
Venezia, 8 aprile 2004
Eminenza Reverendissima,
Cari fratelli nel sacerdozio,
Diaconi e ministri istituiti,
Amatissimi figli,
1. «Allora cominciò a dire: “Oggi si è compiuta questa Scrittura, che voi avete udita con i vostri
orecchi”» (Lc 4,21). L’oggi di Luca indica la pienezza del tempo e dello spazio. Un istante preciso del tempo
ma, nello stesso tempo, un istante che abbraccia tutti gli istanti del tempo. Quindi anche questo preciso
momento che ci vede, come ogni anno, riuniti come presbiterio nella nostra splendida basilica Cattedrale.
Il contenuto della parola profetica del capitolo 61 di Isaia, di cui Gesù si appropria, viene così
trasfigurato. La missione per cui lo Spirito lo consacra: «portare il lieto annunzio ai poveri, fasciare le
piaghe dei cuori spezzati, proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, promulgare
l’anno di misericordia del Signore» (Is 61,1-2) è assunta e trasformata nell’opera della morte, della
resurrezione e della glorificazione di Cristo. Oggi la Scrittura udita si compie: «il testimone fedele, il
primogenito dei morti e il principe dei re della terra» (Ap 1,5) ci redime dai nostri peccati. Un «regno di
sacerdoti per il suo Dio e Padre» (Ap 1,6) è generato da quella potente unificazione di vittima, sacerdote ed
altare che si attua nella singolare persona di Cristo Gesù innalzato sulla croce. Lo sguardo penetrante della
pietas nel celebre inno del Vexilla regis prodeunt ci fa cantare: «Salve, ara, salve, victima, de passionis
gloria, qua vita mortem pertulit et morte vitam reddidit». La vittima non è più un essere vivente privo di
libertà, tanto meno è l’offerta inaccettabile di un sacrificio umano, ma un uomo singolare perché è lo stesso
Figlio di Dio che, in abissale svuotamento, si dona spontaneamente. Questa stessa vittima, aderendo
fisicamente, per l’infissione dei chiodi, alla croce, quale nuovo altare in cui si concentra tutta la storia, rivela
di essere il sacerdote – il pontefice che fa sacro tutto e tutti - perché con la Sua vita distrugge la morte e con
la Sua morte ridona la vita.
Il popolo cristiano, qui riunito per celebrare l’Eucaristia in cui saranno benedetti i Santi oli destinati
ai catecumeni, ai cresimandi ed ordinandi, e agli ammalati, è il popolo sacerdotale. Ma da Cristo in poi,
sacerdotale non coincide più con separato dalla realtà. Al contrario, la qualifica di sacerdotale data al popolo
di Dio rimanda alla fisionomia del tutto inconfondibile della realtà umana generata dall’evento salvifico,
unico e irripetibile, della morte e resurrezione di Cristo. A tal punto che il venerato Papa Paolo VI ha potuto
parlato della Chiesa come di una «entità etnica sui generis che si distingue e si qualifica per il suo carattere
religioso o messianico (sacerdotale e profetico, se volete), che tutto converge verso Cristo, come suo centro
focale, e che tutto da Cristo deriva» (Udienza generale, 27 luglio 1975).
2. Al servizio di questo popolo il Signore Gesù «con affetto di predilezione sceglie alcuni tra i
fratelli che mediante l’imposizione delle mani fa partecipi del Suo ministero di salvezza» (Prefazio).
E quale affetto di predilezione è quello di Colui che, come ci ha detto l’Apocalisse, «ci ama e ci ha
liberati dai nostri peccati con il suo sangue» (Ap 1,5). Il nostro essere presi a servizio per un regno di
sacerdoti è il frutto di una elezione personale, che modella definitivamente – simul et pro semper – il nostro
volto.
Amore, affetto, predilezione: l’odierna liturgia trabocca di una straordinaria potenza affettiva. Quale
più luminosa documentazione che il nostro celibato, per grazia liberamente accolto e, per grazia,
responsabilmente vissuto?
Carissimi sacerdoti, con decisione ferma e profetica, la Chiesa latina sceglie per il ministero
sacerdotale solo quei figli che liberamente accettano l’impegno del celibato per il Regno dei cieli. Essi sono
chiamati a vivere ad litteram la stessa identica forma di amore vissuta dal Figlio di Dio fattosi uomo sulla
terra. Chi può pensare che la verginità vissuta da Gesù abbia tolto qualcosa alla Sua umanità? Chi oserebbe
dire che la Sua non sia un’umanità riuscita? Dobbiamo pertanto riconoscere con coraggio, al di là di tutte le
contraddizioni e di tutti i limiti, che per noi il celibato rappresenta la strada alla forma compiuta dell’amore.
In forza del dono del celibato – e non malgrado il celibato! – ciascuno di noi realizza nella propria esistenza
quella piena maturazione affettiva in cui si compie la dimensione nuziale dell’amore. Differenza sessuale,
dono di sé e fecondità si fondano armonicamente in noi, per grazia, se con semplicità ed umiltà obbediamo al
dono del celibato, secondo la forma Christi sacerdotis. Il celibato attua quel possesso nel distacco che è il
nucleo essenziale della verginità in senso largo, cui è chiamato ultimamente anche l’amore coniugale. Essa
urge a crescere oltre se stessi, verso l’amore effettivo. Anche il celibato per il Regno compie il desiderio
costitutivo dell’uomo, impedendogli di essere preda delle sue spinte all’evasione e di precipitare nella babele
delle sue tendenze dissolutrici. In questo dono liberamente assunto come compito si manifesta un aspetto
centrale della nostra quotidiana missione sacerdotale. Come ci siamo detti lo scorso 2 ottobre parlando del
volto missionario della parrocchia, alla radice della nostra missione sta la trasfigurazione degli affetti nella
nuova obiettiva parentela istituita dalla consegna totale e feconda dell’Unico Sacerdote di cui noi siamo i
ministri. È proprio nella testimonianza del nostro celibato che le nostre famiglie potranno trovare una strada
privilegiata per imparare il vero orizzonte dell’amore. Oggi, più ieri, infatti, rappresentano un segno
profetico uomini maschi che rinunciano liberamente e cordialmente, perché chiamati al sacerdozio, al
possesso di per sé naturale di una moglie, ai fini di documentare il dono gratuito dell’agape di Cristo vittima,
sacerdote ed altare.
3. «Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio sarete detti» (Is 61, 6?). Il
sacerdozio vetero-testamentario profilato nel passaggio del profeta è radicalmente trasfigurato dalla
concentrazione operata da Cristo vittima, altare e sacerdote, ma si ripropone profondamente rinnovato, nella
figura neo-testamentaria del ministro ordinato. Esso fiorisce nel grembo materno della Chiesa che rende
concretamente possibile la nostra consegna celibataria al Signore. Nell’orizzonte dell’oggi lucano di pienezza
che è Gesù Cristo tale consegna è resa possibile da quell’amore con cui Egli, come ci ha ricordato
l’Apocalisse, ci ha amato morendo per i nostri peccati e che trabocca in noi per il Suo affetto di predilezione.
Questo amore ha un nome preciso che la Santissima Eucaristia del Giovedì Santo, in cui come perla preziosa
è incastonato il Sacramento dell’Ordine, ci ridice con forza: si chiama comunione. «Siamo nati
dall’Eucaristia» - ci ricorda il Santo Padre nella Lettera che oggi ci ha inviato in occasione del Giovedì
Santo - «non esiste Eucaristia senza sacerdozio, come non esiste sacerdozio senza Eucaristia» (n. 2). Ritorna
qui il compito legato al volto missionario della parrocchia che con i vicari episcopali ho voluto richiamare a
tutti nella Lettera in cui abbiamo annunciato la Visita Pastorale, preparata dall’Assemblea ecclesiale del
prossimo aprile: «dalla casa alla dimora», cioè al luogo in cui la parentela naturale è assunta e potenziata,
perché trasfigurata, nell’oggettivo affetto di coloro che, essendo figli nel Figlio, sono tra loro fratelli.
L’amore celibatario si esprime in modo particolarmente acuto nella comunione del presbiterio
intorno al Patriarca, la quale è prima di tutto un dono che ci precede e della cui forza noi partecipiamo.
Ma un dono non è autenticamente ricevuto se non chiama in causa la nostra responsabilità. Se la
comunione con chi mi sta a fianco nel presbiterio mi costituisce perché mi è stata donata, il rapporto con il
confratello nel sacerdozio diventa un ambito concreto in cui io sono chiamato ad amare come Cristo ama.
Questo implica il dovere di non sottrarsi ai rapporti, anzi di giocarsi personalmente in essi per il solo fatto
che ci sono dati, attraversando ogni diversità di temperamento e di opinione. Il santo popolo sacerdotale deve
vedere in concreto che l’oggettivo affetto di comunione che ci unisce è molto più potente di tutto ciò che ci
distingue. Come potremmo altrimenti proporre ai giovani l’amore fedele e indissolubile del santo
matrimonio cristiano? O invitarli ad obbedire all’eventuale chiamata alla consacrazione? Né riusciremmo
certo ad educare i membri delle nostre comunità a quella pluriformità nell’unità che sola può convincere
l’uomo smarrito ma assetato di oggi. Alla fine ne resterebbe frustrato anche il nostro impegno, spesso
generosissimo, con gli emarginati e con la improcrastinabile necessità di costruire una società dalla vita
buona in cui regni la giustizia e la pace.
Per questo, richiamando i fedeli che ci sono affidati al sacramento della Riconciliazione, dobbiamo
umilmente deciderci a farvi noi stessi ricorso con regolarità. Così come l’impegno assunto il giorno della
nostra Ordinazione, e che oggi rinnoveremo, di celebrare quotidianamente ed integralmente l’Ufficio divino,
rappresenta il primo e più semplice modo di giovare al popolo che ci è affidato e di sostenerlo nel suo
pellegrinare.
4. L’odierna liturgia ci affida alle preghiere del popolo cristiano: «Pregate per i vostri sacerdoti: che
il Signore effonda su di loro l’abbondanza dei suoi doni… E pregate anche per me, perché sia fedele al
servizio apostolico affidato alla mia umile persona». Come faremmo senza la preghiera dei nostri diletti
figli? Allora li esortiamo con forza: carissimi cristiani,
sappiate che dalla vostra invocazione della grazia dello Spirito dipende che noi, suoi ministri,
possiamo «condurre il mondo all’unica fonte di salvezza», Cristo nostro Signore. Amen.
2